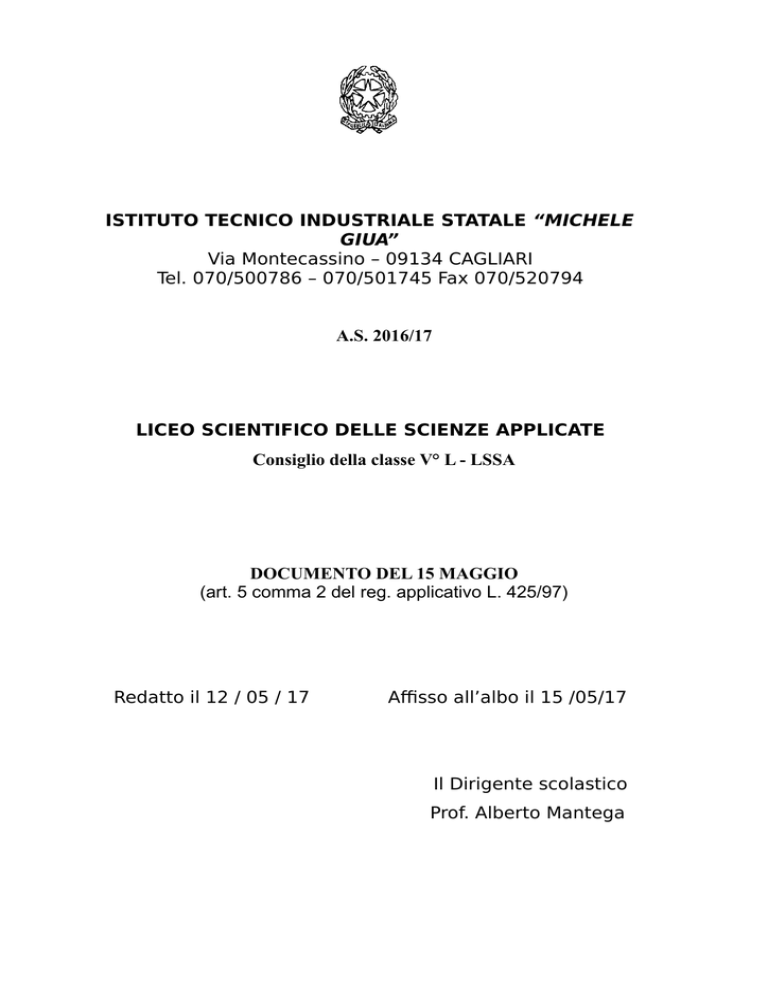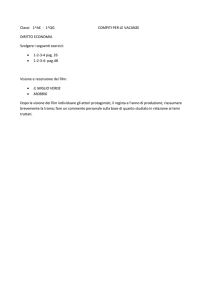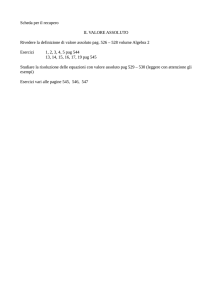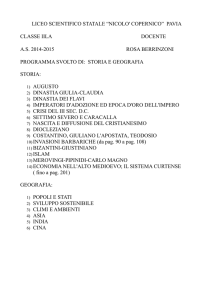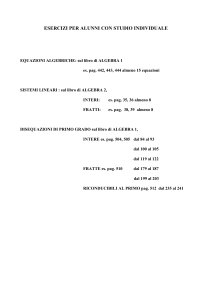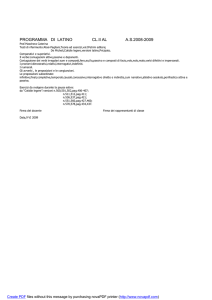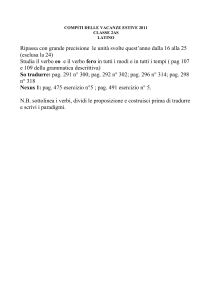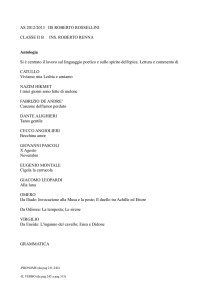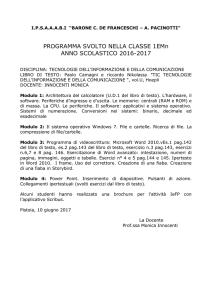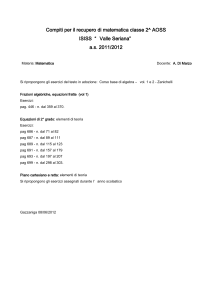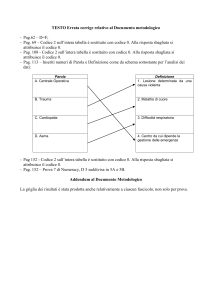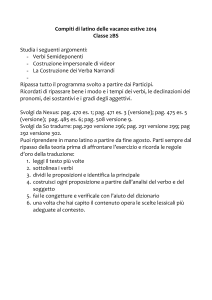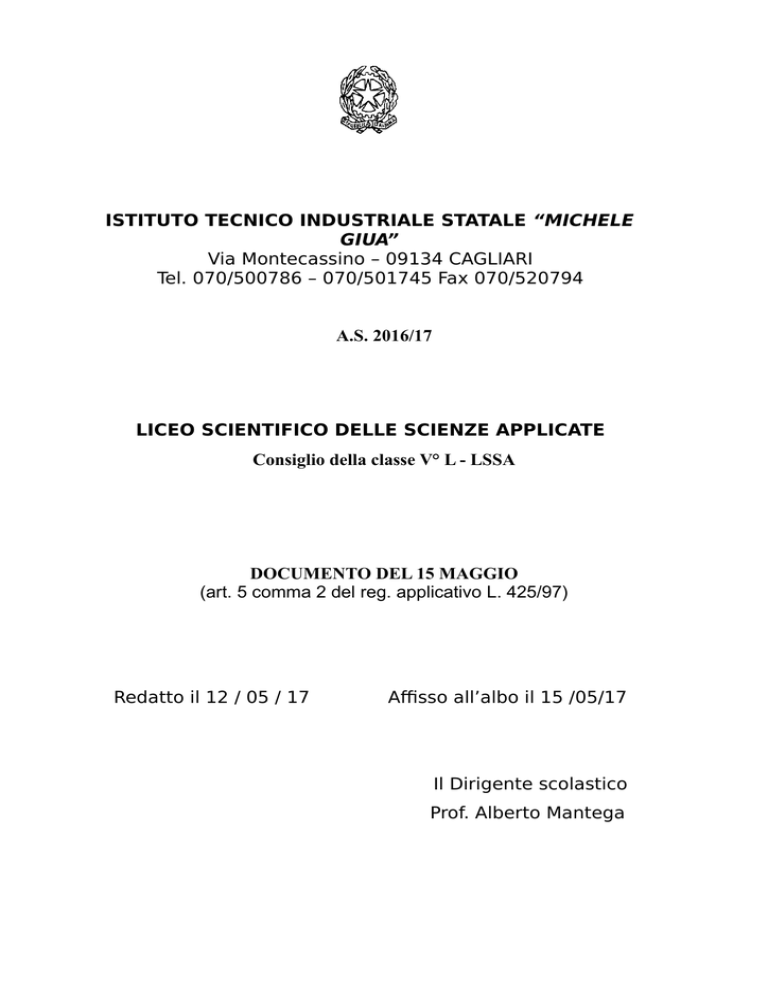
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “MICHELE
GIUA”
Via Montecassino – 09134 CAGLIARI
Tel. 070/500786 – 070/501745 Fax 070/520794
A.S. 2016/17
LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE
Consiglio della classe V° L - LSSA
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
(art. 5 comma 2 del reg. applicativo L. 425/97)
Redatto il 12 / 05 / 17
Affisso all’albo il 15 /05/17
Il Dirigente scolastico
Prof. Alberto Mantega
SOMMARIO
L'istituto nella realtà territoriale
Componenti del Consiglio di Classe
Continuità didattica
Orario delle Lezioni
Elenco alunni
Commissari interni
Presentazione della Classe
Profitto
Obiettivi educativi-formativi
Metodologia insegnamento
Esperienze didattiche e formative di particolare rilievo, attività integrative
ed extracurricolari
Scheda informativa relativa alle prove simulate svolte durante l'anno
ALLEGATI
Programmi svolti.
Relazioni finali.
Elenco libri di testo.
Elenco alunni con curriculum scolastico.
Testo TERZA PROVA SCRITTA – simulazione del 19/03/2016.
Testo TERZA PROVA SCRITTA – simulazione del 03/05/ 2016.
Testo TERZA PROVA SCRITTA – simulazione del 19/03/2016.
Testo simulazione II prova.
Griglie di valutazione I, II e III prova
PDP e relazione relativa all'alunno DSA.
L’ISTITUTO NELLA REALTA’ TERRITORIALE
L’ITIS “Michele Giua” è costituito dalla sede centrale di Cagliari e dalla sezioni
staccata di Assemini.
Sorto nel 1968, con la sola specializzazione di Indirizzo Chimico, fino ad alcuni
anni fa, ha conosciuto nel corso del tempo, periodi di forte espansione e di
decremento dell’utenza, in coincidenza con lo sviluppo e il declino dell’industria
chimica in Sardegna, privilegiato settore occupazionale dei diplomati
dell’Istituto.
Nel corso degli anni, il dibattito legato alla trasformazione del curriculum di
studi, quale necessario adeguamento alla nuova realtà sociale ed economica del
Paese, ha portato alla scelta di ampliare e differenziare l'offerta formativa
dell'Istituto.
Accanto al corso di Chimica, che ne caratterizzava la specificità, sono stati
introdotti successivamente il Biennio Sperimentale (Liceo Tecnico), il Triennio
Ambiente ed il Triennio Informatica. In ultimo, per estendere l'offerta formativa
anche al percorso liceale senza però rinunciare alla vocazione per l'istruzione
tecnica, è stato avviato il quinquennio sperimentale del Liceo Scientifico
Tecnologico divenuto poi, con la riforma Gelmini, Liceo Scientifico delle
Scienze Applicate. Oggi l'Istituto” Michele Giua” presenta una struttura
articolata nel territorio con la sede centrale a Cagliari, situata nella periferia
cittadina, e la sede staccata di Assemini, nell'immediato hinterland. Il bacino di
utenza della scuola è rappresentato da Cagliari e hinterland e risponde alle
aspettative di studenti/esse e famiglie garantendo una Scuola di Qualità con
scelte didattico-metodologiche finalizzate al raggiungimento per tutti del
“successo formativo”.
Il servizio dei trasporti pubblici rende possibili i collegamenti con un esteso
territorio, favorendo il flusso di una notevole quantità di studenti pendolari.
L’utenza si presenta quindi assai eterogenea sia per la provenienza sia per
l’ambiente socio-culturale abitualmente frequentato.
Per quanto concerne le attività lavorative, nel territorio risulta assai diffuso il
terziario ed i settori di tipo artigianale; esigui i settori produttivi industriali e di
indotto. L’Istituto mira ad adeguare la sua offerta formativa a queste peculiarità
del territorio.
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Docente
Materia
FLORIS MARCELLO
RELIGIONE CATTOLICA
FRONGIA ANGELO
FISICA
LOI LAURA
SCIENZE NATURALI
SPINELLI ROSSANA
FILOSOFIA
RACCIS PIERANDREA
MATEMATICA
SETZU MARIA
LINGUA E CULTURA STRANIERA
(INGLESE)
PIRRI MARINA
INFORMATICA
CORDA ALESSANDRA
LINGUA
E
LETTERATURA
ITALIANA, STORIA
SOGOS GIOVANNI
DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
VITELLARO RITA
SCIENZE MOTORIE
Continuità didattica
continuità
DOCENTI
Prof. Laura Loi (Scienze) Coordinatore di Classe
Prof. (Italiano/Storia)
Prof.ssa Maria Setzu (Inglese)
Prof. Pierandrea Raccis (Matematica)
Prof.ssa (Informatica)
Prof. Angelo Frongia (Fisica)
Prof.ssa Spinelli Rossana (Filosofia)
Prof. Giovanni Sogos (Disegno e Storia dell'Arte)
Prof. Rita Vitellaro (Educazione fisica)
Prof. Marcello Floris (Religione)
didattica
III
IV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
L’orario di lezione del 5° anno è articolato secondo lo schema che segue:
5° anno
Orario
Orario
settimanale annuale
Lingua e letteratura italiana
4
132
Lingua e cultura straniera (Inglese) 3
99
Storia
2
66
Filosofia
2
66
Matematica
4
132
Informatica
2
66
Fisica
3
99
Scienze naturali
5
165
Disegno e storia dell’arte
2
66
Scienze motorie e sportive
2
66
Religione cattolica o Attività 1
33
alternative
Totale ore
30
990
V
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
La classe è pervenuta all’attuale configurazione da:
3^
4^
RITIRATI
0
PROMOSSI
NON PROMOSSI
PROMOSSI ex ART.
12
RITIRATI
PROMOSSI
NON
FREQUENTANTE
5
0
12
Iscritti n° 17
Iscritti n° 21
2
10
NON PROMOSSI
1
PROMOSSI ex ART. 8
12
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da 24 alunni di cui 17 maschi e 7 femmine, non tutti
facenti parte del gruppo originario per via dell’inserimento
di uno studente
proveniente da un'altra scuola e di 6 alunni ripetenti. Dei 6 alunni ripetenti una
ragazza non ha mai frequentato e un ragazzo si è trasferito da un'altra scuola a
dicembre. Questo fatto non ha creato particolari problemi di integrazione
all’interno della classe che, infatti, risulta sufficientemente amalgamata. Sedici
alunni si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, gli altri hanno
scelto di non avvalersi di tale insegnamento sostituendolo con l’ingresso alla
seconda ora.
Riguardo al pendolarismo sette alunni risiedono a Cagliari, uno a Senorbì, uno a
Ussana, due alunne a San Sperate e gli altri nei paesi limitrofi: Quartu
Sant'Elena, Elmas, Flumini.
La sua composizione dal punto di vista della
preparazione risulta disomogenea in quanto alcuni alunni presentano delle
notevoli carenze nella formazione di base in termini di capacità, conoscenze e
competenze e non sono ancora in possesso di un metodo di studio adeguato,
mentre altri hanno dimostrato di possedere un sufficiente grado di preparazione
in quasi tutte le discipline. In classe è presente un ragazzo con disturbi specifici
di apprendimento.
La partecipazione al dialogo educativo di una parte della classe non è stata
sempre adeguata e ha spesso costretto gli insegnanti ad intervenire per
interrompere dialoghi inconcludenti o interventi poco pertinenti oltre ad invitarli
continuamente a non fare uso del cellulare; per cui le lezioni sono risultate
frammentarie e conseguentemente poco efficaci. Il basso livello di attenzione,
soprattutto durante le ultime ore di lezione, e l’impegno non adeguato in classe e
la scarsa applicazione a casa, ha ostacolato in parte l’apprendimento corretto dei
concetti fondamentali delle discipline e pertanto non è stato possibile svolgere
tutte le attività programmate e gli obiettivi sono stati raggiunti solo
parzialmente.
Le dinamiche comportamentali, relazionali e didattiche del gruppo classe hanno
anche risentito di un certo disagio in cui la classe si è venuta a trovare per la
discontinuità didattica in alcune aree disciplinari, in cui non si è potuto contare
su relazioni educative e didattiche stabili e consolidate.
Tale fattore ha influenzato in parte la preparazione degli elementi più fragili con
effetti negativi sul rendimento.
Anche se non mancano casi di alunni che hanno frequentato assiduamente, la
frequenza degli allievi in generale non è stata regolare e alcuni studenti si sono
spesso assentati per sottrarsi alle verifiche. Si è potuto registrare anche una certa
tendenza a non rispettare l’orario d'inizio delle lezioni.
Un numero esiguo di studenti tuttavia si è distinto per la partecipazione attiva,
l’interesse e l’attenzione con cui ha seguito le lezioni nei vari ambiti disciplinari,
assumendo modalità di comportamento corretto e rispettoso delle regole di
convivenza.
I docenti hanno dovuto adeguare la programmazione iniziale allo scopo di
supportare gli allievi in difficoltà, guidandoli verso l’acquisizione di metodiche
autonome e ragionate di lavoro e il Consiglio di Classe si è attivato per favorire
lo sviluppo delle loro capacità. Pertanto, alla luce degli interventi prodotti e
tenendo presente la situazione iniziale, ad esclusione di pochi, è oggi possibile
affermare che la classe è pervenuta solo in parte ai livelli previsti di conoscenze,
competenze e capacità relative ai vari ambiti disciplinari. Pertanto il livello
della classe è da considerarsi nella globalità appena sufficiente.
Profitto (gli alunni non scrutinati sono esclusi)
Media del profitto globale della classe nel 3° anno (risultati scrutinio finale):
% Livello Basso
%
Livello
% Livello Alto
(Voti < 6;
Materie
Medio
(Voti > 7)
giudizio sospeso
(Voti 6-7)
o non promossi)
RELIGIONE
100
0
0
CATTOLICA
10
0
90
FISICA
SCIENZE
0
84
16
NATURALI
FILOSOFIA
6
94
0
MATEMATICA
5
68
27
LINGUA
E
CULTURA
5
79
16
STRANIERA
(INGLESE)
INFORMATICA 10
73
17
LINGUA
E
LETTERATURA
0
100
0
ITALIANA,
STORIA
DISEGNO
E
STORIA
5
95
0
DELL'ARTE
SCIENZE
5
95
0
MOTORIE
Media del profitto globale della classe nel 4° anno (risultati scrutinio finale):
Materie
RELIGIONE
CATTOLICA
FISICA
SCIENZE
NATURALI
FILOSOFIA
MATEMATICA
LINGUA
E
CULTURA
STRANIERA
(INGLESE)
INFORMATICA
LINGUA
E
LETTERATURA
ITALIANA,
STORIA
DISEGNO
E
STORIA
DELL'ARTE
SCIENZE
MOTORIE
% Livello Basso
%
Livello
% Livello Alto
(Voti < 6 ;
Medio
(Voti > 7)
giudizio sospeso
(Voti 6-7)
)
100
0
0
0
65
35
0
94
6
12
5
88
80
0
15
5
80
15
6
59
35
0
100
0
30
70
0
65
35
0
Media del profitto globale della classe nel 5° anno (risultati scrutinio fine
trimestre):
%
Livello
% Livello Alto
% Livello Basso
Materie
Medio
(Voti >7)
(Voti < 6)
(Voti 6-7)
RELIGIONE
100
0
0
CATTOLICA
0
18
22
FISICA
SCIENZE
0
32
68
NATURALI
FILOSOFIA
9
59
32
MATEMATICA
5
22
73
LINGUA
E
CULTURA
0
32
68
STRANIERA
(INGLESE)
INFORMATICA
LINGUA
E
LETTERATURA
ITALIANA
STORIA
DISEGNO
E
STORIA
DELL'ARTE
SCIENZE
MOTORIE
18
37
45
0
73
27
0
77
23
14
64
22
27
68
5
Il numero degli allievi con giudizio sospeso a conclusione del 4° anno è stato
pari a dodici, di cui:
Materie
Inglese
Informatica
Scienze
Fisica
n.°
2
6
1
6
Commissari interni
Docenti
Materie
Informatica
Pirri Marina
Matematica
Raccis Pierandrea
Scienze integrate Laura Loi
1. Obiettivi trasversali educativi e cognitivi della programmazione
collegiale
Collaborazione e partecipazione
1. Partecipare in modo opportuno alle discussioni, al lavoro di gruppo, alle
assemblee di classe nella consapevolezza che, nell’apprendimento, è
necessario saper mettersi in gioco
2. Interagire all’interno del gruppo contribuendo alla realizzazione di attività
collettive e all’apprendimento comune, secondo le proprie capacità e nel
rispetto degli altri.
Impegno individuale
3. Rispettare gli impegni assunti con i docenti.
4. Rispettare la puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati.
5. Rispettare i regolamenti (puntualità nel presentarsi in aula all’inizio delle
lezioni e dopo la ricreazione, giustificare puntualmente le assenze, essere
assidui nella frequenza.
6. Rispettare tutte le strutture della scuola (aule, banchi, laboratori, spazi
comuni).
7. Rispettare le persone e le diversità.
8. Porsi in relazione costruttiva con gli altri
9. Essere disposti ad ascoltare gli altri
10. Intervenire e formulare domande o proposte con adeguatezza
11. Accettare o respingere, su base critica, i valori proposti.
Autonomia nell’attività di studio
12. Saper organizzare autonomamente il proprio apprendimento
13. Integrare le conoscenze acquisite in aula con materiali didattici di vario
genere
14. Acquisire capacità di ricerca di fonti di informazione
15. Utilizzare strategie di studio (ascoltare, prendere appunti, tecniche di
lettura…) con la consapevolezza della loro pertinenza nei vari ambiti
disciplinari.
Comunicazione
16. Padroneggiare la lingua per comprendere messaggi orali e scritti afferenti
ai quattro assi culturali
17. Cogliere, interpretare, rappresentare dati e informazioni, produrre testi di
vario tipo in relazione a differenti scopi
18. Organizzare i propri discorsi in modo logico e consequenziale
Argomentazione
19. Sostenere una propria tesi e saper valutare criticamente le argomentazioni
altrui
20. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico
21. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti di diverse
forme di comunicazione.
22. Interpretare un tema da diversi punti di vista
Generalizzazione e astrazione
23. Individuare regolarità e proprietà in contesti diversi
24. Astrarre caratteristiche generali e inserirle in contesti nuovi
Risoluzione dei problemi
25. Individuare il problema
26. Collocare il problema nell’ambito di pertinenza
27. Ricercare, analizzare e riordinare dati
28. Ipotizzare soluzioni
29. Applicare regole
30. Valutare i risultati ed esprimere giudizi
Il Consiglio di classe, individuando tali obiettivi, ha inteso sostenere nel
processo formativo il protagonismo degli studenti, nella convinzione che chi sa
lavorare in modo propositivo e in gruppo, consapevole della necessità
dell’impegno e del rigore, della disposizione ad ascoltare e ad aggiornare le
proprie conoscenze, saprà fare consapevolmente con ciò che sa e ha appreso.
Solo una parte degli studenti ha raggiunto appieno tali obiettivi.
2. Comportamenti comuni assunti dai docenti
I docenti hanno stabilito regole comuni improntate al rispetto reciproco e
all’osservanza delle regole stesse, da condividere e rispettare. Gli alunni hanno
recepito le clausole del contratto formativo, ma non sempre hanno assunto un
comportamento corretto in aula.
Contestualmente i docenti hanno mantenuto la massima trasparenza nella
programmazione e nei criteri di valutazione, rendendo sempre protagonista
l’allievo della relazione educativa; hanno incoraggiato gli alunni e favorito il più
possibile la fiducia nelle loro capacità, cercando di rispettare lo stile cognitivo di
ognuno.
Gli elaborati scritti sono stati riconsegnati, nel complesso, nel rispetto dei tempi
e dei termini concordati in modo da utilizzare la correzione come momento
formativo.
Inoltre i docenti hanno insistito particolarmente sul rispetto delle consegne,
affinché gli allievi non lo intendessero solo come assolvimento di un obbligo
formale, ma anche e soprattutto come momento di crescita umana e culturale.
3. Metodologie, tempi e sussidi didattici
Metodi
I docenti sono intervenuti contestualmente sugli apprendimenti, sulle abilità e
sui comportamenti, coniugando il rigore metodologico con la considerazione
delle implicazioni emotive sempre sottese al processo cognitivo, e avvalendosi
di una pluralità di metodi. In particolare, a seconda della disciplina e tenuto
conto del contesto della classe, gli insegnanti hanno fatto riferimento alle tre
grandi aree metodologiche dell’esperienza (induttivo e deduttivo), della
comunicazione, della ricerca.
Il processo didattico, a seconda degli argomenti trattati e delle discipline
insegnate, è stato articolato in interventi plurimi: lezione interattiva, lettura e
discussione in classe, lezione frontale (tesa ad una esposizione strutturata dei
contenuti e all’acquisizione di abilità fondamentali e allo stimolo dell’analisi dei
risultati), metodo induttivo e deduttivo.
Laddove sono emerse difficoltà si è proceduto ad attività di recupero, singole o
di gruppo, proponendo i contenuti con mezzi e modalità differenti. In alcuni casi
è stato necessario ricorrere all’uso di fotocopie ad integrazione di alcune
argomentazioni di particolare interesse.
L’attività didattica ha avuto luogo principalmente in classe e nei laboratori per le
materie di indirizzo.
Tempi
I tempi stabiliti in sede di programmazione hanno tenuto conto dei livelli di
partenza e dei ritmi di apprendimento della classe, ma hanno subito qualche
variazione nell’ambito di qualche disciplina a causa delle numerose assenze,
delle attività di orientamento, di arricchimento dell’offerta formativa. Non tutti i
docenti hanno potuto rispettare rigorosamente i tempi fissati nel documento
programmatico.
Strumenti e sussidi
1 Libri di testo
2 Slide
3 Manuali di consultazione
4 Documenti storici e saggi critici
5 Fotocopie
6 Appunti del docente
7 Sintesi
4. Criteri e strumenti di verifica
I docenti hanno utilizzato per la verifica formativa (relativa al controllo in itinere
del processo di apprendimento) e per quella sommativa (relativa al controllo del
profitto scolastico ai fini della classificazione) i seguenti strumenti:
1. interrogazione lunga e breve;
2. partecipazione al dialogo educativo;
3. risoluzione di problemi;
4. prove strutturate e semi strutturate, grafiche e pratiche;
5. questionari;
6. relazioni ed esercizi.
Le suddette forme di verifica, simulando le prove d’esame, hanno mirato ad
accertare il rendimento scolastico, la validità degli obiettivi, ma anche la
funzionalità delle metodologie adottate.
5. Criteri di valutazione
I criteri di valutazione, tenendo conto del progresso degli studenti rispetto al
livello iniziale, dell'impegno di studio a casa e della partecipazione al dialogo
educativo, hanno privilegiato nell'ordine:
a) conoscenza degli argomenti;
b) linearità dell'espressione e impiego del linguaggio specifico;
c) coerenza logica;
d) analisi e individuazione dei concetti chiave
La valutazione non è stata fiscale e quantitativa, ma inerente al bisogno-interesse
dell’alunno e nel rispetto del suo stile cognitivo, cioè di quel corredo di modalità
e procedure che ogni allievo adotta nel proprio modo di pensare e di studiare; si
è tenuto inoltre conto dei livelli di partenza, dell’impegno, della frequenza, della
partecipazione alle attività e della volontà dimostrata durante l’intero anno, oltre
che del grado di consapevolezza della responsabilità personale nel processo di
formazione.
Per la definizione dei criteri per la corrispondenza tra voti e livelli di
conoscenza, abilità e competenza ci si è attenuti ai parametri collegialmente
deliberati a livello di Istituto, di seguito riportati
Attività complementari e integrative
Si segnala la partecipazione di alcuni allievi, su base volontaria ai seguenti
progetti:
Attività di orientamento universitario
Masterclass Fisica
Progetto di valorizzazione delle eccellenze.
Viaggio di istruzione a Monaco di Baviera.
6. Attività di recupero e potenziamento
La classe ha usufruito delle attività di recupero e di potenziamento promosse e
realizzate dalla scuola per alcune discipline, per le altre il recupero è stato
effettuato in itinere.
8. SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE PROVE SIMULATE
SVOLTE DURANTE L’ANNO
Criteri seguiti per la progettazione delle prove simulate.
La terza prova coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell’ultimo anno di
corso. Tuttavia, il consiglio di classe – tenuto conto del curricolo di studi e degli
obiettivi generali e cognitivi definiti nella propria programmazione didattica e
delle materie oggetto della 1ª e della 2ª prova scritta, che sono state escluse – ha
individuato come particolarmente significative le seguenti discipline:
Inglese
Informatica
Scienze
Fisica
e su tale base ha sviluppato la progettazione delle prove interne di verifica in
preparazione della terza prova scritta degli esami conclusivi del corso.
Per entrambe le simulazioni è stata scelta una prova della tipologia B: trattazione
sintetica di argomenti (3 domande), in non oltre dieci righe per risposta. La
durata massima è stata prevista in 2 ore. Sono state programmate tre simulazioni
della terza prova, di cui la prima si è svolta mercoledì 01 marzo e la seconda
giovedì 30 marzo e la terza martedì 09 maggio.
In entrambe le simulazioni sono state coinvolte le suelencate discipline. I
quesiti proposti per la prima, seconda e terza simulazione di terza prova e la
griglia di valutazione usata, sono allegati al documento.
Si è inoltre provveduto alla simulazione delle altre prove scritte previste
dall’Esame di Stato.
La simulazione della prima prova è stata svolta il 10/03/17
Per la simulazione della seconda prova, quella di matematica, sono state
proposte le seguenti prove:
- La prima il 1/04/2017.
- La seconda è prevista per il 18/05/2017.
Scheda informativa relativa alle prove simulate svolte durante l’anno
Criterio di sufficienza adottato per le prove:
Livello
di
prestazione Punteggio attribuito
conseguito
Gravemente insufficiente
1-3/15
Insufficiente
4-6/15
Incerto
6-9/15
Sufficiente
10/15
Discreto
11-12/15
Buono
13-14/15
Ottimo
15/15
In particolare, per conseguire una valutazione di sufficienza, è stato ritenuto
necessario che gli elaborati soddisfacessero i seguenti criteri:
1.Comprensione del testo
2.Conoscenza dei contenuti fondamentali inerenti l'argomento
3.Uso del linguaggio specifico essenziale
4.Applicazione delle conoscenze acquisite
Il Presente documento è condiviso in tutte le sue parti dal Consiglio di Classe.
Il Consiglio della classe 5^L LSSA
Disciplina
Docente
RELIGIONE CATTOLICA
FLORIS MARCELLO
FISICA
FRONGIA ANGELO
SCIENZE NATURALI
LOI LAURA
FILOSOFIA
SPINELLI ROSSANA
MATEMATICA
LINGUA E CULTURA
STRANIERA (INGLESE)
INFORMATICA
LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA e STORIA
DISEGNO E STORIA
DELL'ARTE
SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE
RACCIS PIERANDREA
Cagliari 12/05/17
SETZU MARIA
PIRRI MARINA
CORDA ALESSANDRA
SOGOS GIOVANNI
VITELLARO RITA
Firma
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “MICHELE GIUA”
CAGLIARI
RELAZIONE FINALE
A.S. 2016/2017
MATERIA: Letteratura italiana e storia
CLASSE: 5°L LSSA
L’insegnamento dell’italiano ha avuto come finalità
l’acquisizione di una adeguata autonomia, lo sviluppo delle
capacità critiche, il potenziamento delle capacità
espressive.
Per quanto concerne l’autonomia di lavoro ed il
potenziamento delle capacità espressive esse non sono
state pienamente raggiunte, così come lo sviluppo delle
capacità critiche. Il lavoro organizzato in classe con l’ausilio
di supporti audiovisivi e lo svolgimento di prove scritte in
forma di saggio breve hanno permesso ai ragazzi di
raggiungere un livello di preparazione sufficiente.
Per quanto concerne l’interesse e la partecipazione al
dialogo educativo una parte della classe ha preso parte
attivamente a questo, mentre invece, la parte restante non
sempre è stata attenta e costante nella partecipazione.
I livelli di partenza hanno consentito di raggiungere nella
globalità un livello di preparazione soltanto poco più che
mediocre.
La docente
ISTITUTO TECNICO INDUSTIALE “M. GIUA”
CAGLIARI
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017
CLASSE 5°L LSSA
PROGRAMMA SVOLTO
Il Pessimismo Storico, Cosmico ed Eroico da pag.720 a pag.727
Il Romanzo Realista da pag.887 a pag.889. Cenni in generale
G. Flaubert, trama di Madame Bovary
L’età del Positivismo da pag.4 a pag.9
L’età del Positivismo da pag. 12 a pag.17
S. Freud da pag.18 a pag.20
Discorso introduttivo sul Verismo
G. Verga da pag.98 a pag.100
Tecniche narrative
da pag.24 a pag.88 Il Naturalismo Francese, cenni su Bergson,
De Gouncourt, Zolà, Maunpassant, Grazia Deledda
pag.98 Giovanni Verga fino a pag.99
da pag.89 a pag.103 Il Verismo di Giovanni Verga
pag. 117 “La Lupa” lettura ed analisi fino a pag.121
Artifizio della Regressione, discorso indiretto libero, lo
straniamento
pag.102
pag.115 lettura e commento de “Prefazione all’amante di
Gramigna”
pag.134 l’arrivo e l’addio di N’Toni lettura e commento
“La Roba” pag.138 lettura ed analisi
“Mastro Don Gesualdo” trama
pag.153 Mastro Don Gesualdo “L’addio alla roba” lettura e
commento
Pag.157 “La morte di Gesualdo” lettura e commento
I Simbolisti da pag.188 a pag.190
Charles Boudelaire pag.193
pag.193-194 L’Albatro di C. Boudelaire lettura ed analisi
La Scapigliatura pag.222
pag.274-275 Giovanni Pascoli biografia
Il Decadentismo pag.39
Il Decadentismo Italiano pag.223
pag.276-277 Pascoli e la poesia Italiana del Novecento
pag.283-284 La poetica del Fanciullino lettura e commento
pag.286-287 Lavandare lettura e commento
10 Agosto pag.290-291 lettura e commento
pag.300 Uno stile Impressionista
pag.310-311 Il gelsomino notturno lettura e commento
Gabriele D’Annunzio pag.328 vita, opere e il pensiero
da pag.329 a pag.331 L’incontro con Eleonora Duse, Il periodo
Francese
Le imprese belliche ed il ritiro al Vittoriale
il pensiero e la poetica fino a pag.332
pag.338-339 Il verso è tutto lettura e commento
da Il Piacere lettura e commento de “Una guarigione incerta”
pag.341342
pag.347 Laudi del cielo della terra del mare e degli eroi.
Da Alcyone – “La pioggia nel pineto” lettura, parafrasi e
commento
fino a pag.355
La narrativa della crisi da pag.372 a pag.379
da pag.662 a pag.665 Luigi Pirandello biografia
pag.667 Saggio sull’Umorismo
pag.666 L’alienazione e le maschere nude. Il Fu Mattia Pascal,
I Quaderni di Serafino Gubbio. La Rivoluzione Teatrale fino a
pag.677
pag.681 lettura e commento de “La Patente”
pag.687 lettura e commento de “Il treno ha fischiato”
trama de Il Fu Mattia Pascal pag.693
Uno, Nessuno e cento mila pag.703
Così è se vi pare pag.708
Sei personaggi in cerca d’autore pag.714
pag.732 Italo Svevo biografia
da pag.733 a pag.735 Italo Svevo, pensiero e poetica
pag.739 Una vita – Senilità – lettura della trama
La coscienza di Zeno trama pag.750 lettura e commento de
“L’ultima
sigaretta”
pag.755 Un rapporto conflittuale
La letteratura tra le due guerre da pag.490 a pag.491
Nel restante scorcio dell’anno scolastico, tempo permettendo, si
presume di poter sviluppare i seguenti argomenti:
pag.526-527 La Lirica Novecentista – L’Ermetismo
da pag.554 Giuseppe Ungaretti, pensiero e poetica fino a
pag.558
da pag.590 Eugenio Montale biografia e poetica fino a pag.594
La docente
Alessandra Corda
14/05/2017
Cagliari,
ISTITUTO TECNICO INDUSTIALE “M. GIUA”
CAGLIARI
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017
CLASSE 5°L LSSA
PROGRAMMA SVOLTO
Le cause dell’Imperialismo da pag. 391 fino a pag. 398
Il Brigantaggio e la questione Meridionale da pag.408 fino a
pag.417
Progrersso e modernità nel Novecento da pag.6 fino a pag.15
La Bell’epoque e il secolo che nasce
il Novecento a pag. 23, l’Italia all’inizio del Novecento a pag. 35
il governo Giolitti da pag. 35 a pag. 39
l’Italia Giolittiana, la conquista della Libia, le riforme del governo
Giolitti da pag. 41 fino a pag. 47
La grande Guerra da pag. 52 a pag. 56
l’italia entra in guerra fino a pag. 58
la prima guerra mondiale fino a pag. 654
conclusione della guerra da pag. 65 a pag. 69
la Rivoluzione Russa da pag.74 a pag.76
visione del film “Il Dottor Zivago”, Rivoluzione russa
Rivoluzione Russa (2° parte), da Lenin a Stalin fino a pag. 89
Sintesi per punti da pag. 89 a pag. 91
il dopoguerra e la fragilità dello stato liberale da pag. 120 a pag.
121
la vittoria mutilata e la questione di Fiume da pag. 121 a pag.
123
Nascita di una dinastia fino a pag. 126
le cause dello scoppio della rivoluzione Russa
nascita di una dittatura da pag. 26 a pag. 28, il delitto Matteotti
perché il Fascismo vinse a pag. 129
l’economia dello stato fascista e le leggi Fascistissime da pag.
131 a pag. 133
la campagna d’Etiopia e le leggi razziali fino a pag. 139
la crisi economica dopo la grande guerra da pag. 144 a pag.
145
il crollo di Wall Street 1929 da pag. 145 a pag. 151
Politica protezionistica a pag. 152
il Nazismo
da pag. 163 a pag. 167
il Nazismo da pag. 169 fino a pag. 179
la seconda guerra mondiale da pag. 202 a pag. 206
l’invasione della Polonia e la dichiarazione di guerra fino a pag.
209
1942 la ritirata russa e la guerra nel Pacifico
l’armistizio dell’8 settembre fino a pag. 214
da pag. 215 a pag. 217
fine della seconda guerra mondiale da pag. 215 a pag. 226 – la
Shoah
Nel restante scorcio dell’anno scolastico, tempo permettendo, si
svilupperanno i seguenti argomenti:
Il dopoguerra: la situazione europea
La guerra fredda
La docente
Alessandra Corda
14/05/2017
Cagliari,
Lingua e cultura straniera – inglese
Classe 5 L LSSA - anno scolastico 2016-2017
Docente Maria Setzu
Profitto, motivazione, partecipazione
La docente ha insegnato nella 5 L dall’inizio del biennio, lavorando con gli studenti sulle varie
difficoltà che già in partenza sono state rilevanti. Il percorso compiuto nella lingua straniera è stato
una conquista difficile, irta di incertezze e insicurezze. Alcuni nuovi ingressi di studenti all’inizio
del triennio hanno influito sugli equilibri della classe in modo problematico, ma ora risultano ben
risolti. Il percorso di acquisizione della lingua straniera risulta lungi dall’essere soddisfacente per
almeno un terzo della classe. Uno degli studenti presente nel gruppo classe originario riporta una
dislessia in forma grave ed è stato esentato dalle prove scritte. In generale ha sempre mostrato
insormontabili difficoltà nell’inglese, e prerequisiti di base del tutto inadeguati.
Dei cinque studenti che hanno fatto ingresso nella classe da quest’anno scolastico, tre riportano
marcate difficoltà di base.
In generale l’impegno della classe non è stato esattamente adeguato soprattutto per mancanza di
tempestività e continuità nello studio. C’è stato anche un problema di distrazione, uso improprio del
telefono cellulare durante le lezioni, alcuni comportamenti di disturbo, in particolare durante le
spiegazioni, e la tendenza, da parte degli studenti, ad evitare il coinvolgimento nel dialogo didattico;
in vari casi si è riscontrato le indicazioni della docente venivano disattese, malgrado le
raccomandazioni e le verifiche, soprattutto per quanto riguardava l’esecuzione di compiti scritti.
Alcuni (pochi) studenti/studentesse hanno invece svolto le attività richieste traendone vantaggio.
La classe, come si evince, riporta molte differenziazioni al suo interno, sia nei prerequisiti che
nell’impegno e nelle capacità messe in atto.
Obiettivi relativi ai contenuti
I contenuti svolti constano di una parte che propone un limitato approfondimento di esponenti
grammaticali, funzioni e lessico corrente.
L’altra parte riguarda la letteratura inglese. Si è cercato di seguire un filo cronologico evidenziando
alcune opere particolarmente significative, e i loro autori. Si è data importanza ai testi letterari,
accompagnandoli sempre da lettura, traduzione, attività di comprensione del testo, osservazione
degli aspetti formali; si sono svolte le esercitazioni proposte dal testo in adozione in forma sia
scritta che orale; in qualche caso la docente ha fornito estensioni e approfondimenti rispetto a
quanto proposto dal libro di testo. Si sono studiati i quadri generali di carattere storico e culturale
che fanno da sfondo alle opere letterarie prese in considerazione.
Obiettivi relativi alle competenze e alle abilità
La meta a cui la programmazione tendeva sarebbe stata quella di un livello intermedio (B1) del
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); i risultati rimangono
complessivamente un po’ al di sotto di tale obiettivo, ma almeno un gruppetto di componenti della
classe ha raggiunto il livello delle competenze B1.
Un altro gruppo di studenti rimane al di sotto questo traguardo, segnando raggiungimenti più
modesti. Un ulteriore gruppo riporta un livello da cui emergono fragilità evidenti sia
nell’espressione orale (difficoltà di comprensione, di articolazione della frase, povertà lessicale) che
in quella scritta, con non poco disturbo alla comunicazione.
Gli obiettivi sono stati strutturati in modo da condurre lo studente alle seguenti competenze:
Ricezione orale (ascolto)
- ricavare informazioni essenziali da una conversazione; comprendere le domande della docente;
seguire le spiegazioni della docente (chiedendo chiarimenti se qualcosa non risulta chiaro); afferrare
il contenuto di discorsi di carattere descrittivo, narrativo, argomentativo;
Ricezione scritta (lettura)
- capire i punti essenziali di articoli e brani di temi trattati; desumere dal contesto il significato di
singole parole; scorrere velocemente brevi testi e trovare fatti e informazioni importanti (lettura
selettiva),
Produzione orale
- riferire riguardo alle caratteristiche di un’epoca storica, riferire dati biografici riguardanti autori
svolti; descrivere caratteristiche generali di forme letterarie; tradurre brani svolti anche di carattere
poetico (la cui traduzione è già stata svolta in classe), rispondere a domande su un testo esaminato,
esprimere il proprio punto di vista su una questione, parlare di interessi personali.
Produzione scritta
- stendere un riassunto, la trama di una storia; rispondere (anche brevemente) a domande su un testo
letterario; sulle caratteristiche di un periodo storico; su una biografia; esprimere punti di vista
personali; saper svolgere la traduzione di testi studiati in forma analitica (brani di poesia).
Metodologia e mezzi impiegati
La metodologia d’insegnamento è stata di tipo funzionale-comunicativo, basata appunto sullo
scambio di informazioni significative che esercitano interesse conoscitivo e culturale.
Lezioni di tipo frontale si sono alternate a lezioni partecipate, a seconda del contributo che poteva
essere offerto dagli studenti; a volte una lezione che partiva con forma “partecipata” ha finito per
diventare una lezione frontale quando gli interventi degli studenti erano troppo esigui e sporadici.
Si è usato assai poco il laboratorio linguistico perché la classe non è stata inserita nell’orario di
laboratorio (e questo non per volontà della docente), ma più spesso si è utilizzata la LIM, lavagna
multimediale, di cui la classe è dotata.
Le verifiche e la valutazione
Le verifiche sono state scritte e orali, di tipo formativo e sommativo. Oggetto delle verifiche sono
state le abilità di comprensione e di esposizione sintetica: risposta a domande aperte, scritte e orali,
formulazione di sintesi, estrazione di informazioni da un testo e rielaborazione.
Si sono attuate due verifiche scritte di tipo sommativo nel trimestre, e due nel pentamestre
(l’ultima ancora da svolgersi nel momento in cui la presente relazione viene redatta).
Queste ultime consistono in esercizi strutturati e semistrutturati di carattere linguisticogrammaticale, e in domande a risposte aperte a trattazione sintetica sui più recenti argomenti svolti.
Sono stati anche proposti brevi brani di testi letterari studiati da tradurre.
Le verifiche scritte “formative”, che potevano essere esercitazioni da svolgere a casa o durante la
lezione, non portavano ad un voto trascritto nel registro, ma a un giudizio verbale della docente,
contenente consigli e osservazioni sul miglioramento dello studente o sulle difficoltà ancora da
superare.
Le verifiche orali si sono attuate nella forma di verifiche brevi, del tipo domanda e risposta, di
carattere “formativo” a cui poteva seguire un giudizio della docente che non dava luogo al voto; le
verifiche orali di tipo sommativo comportavano interrogazioni più articolate sui recenti argomenti
del programma svolto e venivano seguite da un voto che è sempre stato subito comunicato allo
studente. Ogni studente riporta una verifica orale (di tipo “sommativo”, con voto) nel trimestre, a
fronte delle due programmate. Nel pentamestre si sono programmate dalle due alle tre verifiche
orali, è si è attualmente nel corso della seconda verifica.
Attività di recupero
Per quanto riguarda le attività di recupero, da parte della docente c’è stata la disponibilità ad
aspettare e a rallentare davanti ad argomenti che risultavano particolarmente ostici, anche attuando
esercitazioni di revisione degli argomenti svolti (questo è uno dei motivi per cui il programma
risulta così ridotto) Non è stato svolto alcun corso di recupero extracurricolare, ma si è richiesto
agli studenti di recuperare con impegno autonomo, e in vari casi hanno concretamente mostrato che
ciò era possibile.
In effetti si può affermare che il vero problema della classe sia stata la carenza di studio autonomo
nel corso dell’a.s., e questo malgrado la docente abbia ribadito l’importanza dell’attività
continuativa, “a piccole dosi”. Molti studenti hanno invece preferito affrontare la verifica studiando
“all’ultimo momento”, su limitate porzioni di programma, che nella sua interezza rimane per questi
pieno di lacune.
Un altro problema su cui si è cercato di attuare dei rimedi con molte raccomandazioni e
controllando l’operato degli studenti, è stata la scarsa capacità organizzativa: portare il libro di testo,
tenere un quaderno con le esercitazioni svolte a casa e a scuola, cercare di prendere appunti, sul
quaderno e anche sul libro. Queste buone pratiche in linea di massima non sono state attuate, o non
c’è stata la necessaria continuità.
Il livello minimo di raggiungimento degli obiettivi ha richiesto da parte dello studente capacità
comunicative - produttive e ricettive - in grado anzitutto di comprendere un messaggio e
comunicare una risposta nei contesti affrontati accettando anche un margine di errori e interferenza
della L1 tale almeno da non pregiudicare la comprensione. Si è richiesto che lo studente sia in grado
di leggere e tradurre i brani svolti in classe, riconoscendone le caratteristiche morfosintattiche
fondamentali e dimostrando di conoscere contenuti e nozioni di base trattati attraverso un semplice
dialogo espositivo - interattivo col docente.
Strumenti utilizzati. Rapporti con le famiglie
Gli strumenti utilizzati sono stati: libri di testo, schede fornite della docente, riproduzioni di opere
grafiche e pittoriche, LIM (lavagna interattiva multimediale).
I rapporti con le famiglie si sono limitati a meno di un terzo dei componenti della classe. In qualche
caso la docente ha contattato i genitori di sua iniziativa.
Istituto Tecnico Industriale Statale M.Giua - Cagliari
A.S. 2016/2017
Programma svolto nella Classe 5 L, Liceo Scientifico Scienze Applicate
Materia: Lingua e cultura straniera (Inglese)
Docente: Maria Setzu
Testi in adozione: Paul Radley e Daniela Simonetti, New Horizons volume 2 ed. Oxford University
Press. Class Audio CDs, MultiROM.
Mariella Ansaldo, Savina Bertoli e Antonella Mignani: Visiting Literature. From the Origins to the
Present Day. Ed. Petrini. Digital book, 2 CD audio.
Dal testo New Horizon, vol 2, Unit 6: il Present perfect con for e since. Aggettivi e pronomi each /
every / all. Ascolto p. 54: interview to a fan of Bono Vox, cantante degli U2. Ascolto
della canzone “Sunday Bloody Sunday” e spiegazione degli eventi a cui fa riferimento.
Unit 7: Il Present perfect continuous. Ascolti p. 60. Job skills and personal qualities; parlare di
abilità: adectives + preposition. A job interview.
Dal testo Visiting Literature:
Daniel Defoe, vita e opere. Il romanzo Robinson Crusoe. Lettura e comprensione del testo 21 p.
148,149: Circumstances of the meeting with Man Friday. Contenuto delle “Critical notes” p. 151.
Jonathan Swift, vita e opere. Il romanzo Gulliver’s Travels. The fourth book, text 22: first encounter
with the Yahoos. Lettura e comprensione.
The Industrial revolution.
Romanticism vs Augustan Age (vedi p. 175). The Romantic movement: birth of Romanticism,
influence of the American and French Revolutions, the return to nature, the power of the
imagination and the role of the poet; the solitary. Romantic poetry.
William Blake, vita e opere. The Songs of Innocence and The Songs of Experience. “The Lamb”,
“The Tyger”, “London”.
Opera pittorica di Blake. Data scheda. Critical notes on Blake.
Wordsworth, Coleridge and the ’Lyrical Ballads’. Preface to the “Lyrical Ballads”. Objects of
poetry, language of poetry, what a poet is, what poetry is.
Samuel Taylor Coleridge, vita e opere. ’The Ryme of the Ancient Mariner’ Part 1 (text 32), Part 2
(text 33). Redemption comes: part 4 (text p. 202) I brani sono stati letti e tradotti con contestuale
visione delle relative incisioni di Gustave Doré. Ascolto dell’omonimo brano rock degli Iron
Maiden, 1984. Informazioni sugli Iron Maiden.
Critical Notes on Coleridge: Primary and secondary imagination; Coleridge and Wordsworth; the
“Rime of the Ancient Mariner” and the mediaeval ballad; the supernatural and the suspension of
disbelief; the moral lesson; Coleridge’s contribution to literary criticism.
Dopo il 15 maggio verranno svolti i seguenti argomenti:
The Gothic novel. Mary Shelley, life and works; Frankenstein: narrative structure, themes. Lettura e
ascolto del brano: the creation of the monster.
I testi svolti sono stati letti e tradotti durante le lezioni, e sono state assegnate le attività di
comprensione e analisi.
Agli studenti che hanno preso parte al viaggio d’istruzione sarà chiesto un prospetto delle visite
svolte con informazioni generali e impressioni personali.
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
“Michele GIUA”
Via Montecassino 09134 CAGLIARI
TEL. 070-500786 – 501745 FAX 070520794
E-mail [email protected] Sito www.itisgiua.it
Classe 5° L - A. S. 2016/2017
RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA
Il gruppo, inizialmente composto da 24 alunni di cui 7 ragazze, ha modificato in
parte la sua struttura in quanto un’alunna non ha mai frequentato e un alunno, benchè
regolarmente iscritto, ha iniziato a frequentare con un mese di ritardo.
Per quanto riguarda la classe nel suo insieme, è da sottolineare che
l’avvicendarsi di diversi insegnanti di filosofia nel corso del triennio, ma talvolta anche
durante uno stesso anno scolastico, è stato solo uno dei fattori che non hanno favorito
l’acquisizione di un linguaggio specifico della disciplina, una mentalità riflessiva ed
elastica nell’approccio alle diverse impostazioni filosofiche né una visione storica
dell’evoluzione del pensiero.
Il gruppo, da un punto di vista più generale, ha rivelato un’identità eterogenea
sia per potenzialità di apprendimento che per assiduità e motivazione allo studio. La
maggior parte degli studenti (sei dei quali ripetenti) ha realizzato un rilevante numero
di assenze e di ritardi. Inoltre l’atmosfera di classe, soprattutto nei primi mesi dell’a.
s., non è stata caratterizzata da un comportamento consono a dei ragazzi di quinta
superiore. Solo con difficoltà sono riuscita a ottenere una riduzione dell’uso dei
cellulari e di altre continue distrazioni durante la lezione.
Pochi gli studenti di questa classe che hanno partecipato con più costanza e in modo
attivo alle lezioni.Infine è da ricordare che, nonostante la mia assidua presenza, le ore
di lezione, per varie attività che hanno coinvolto gli studenti durante la mattina, sono
state ridotte rispetto a quelle previste (46 su 66), riducendo di conseguenza il
programma che è stato possibile effettivamente svolgere. Per tutti i motivi suddetti,
gli obbiettivi di capacità, competenze e conoscenze previsti all’inizio dell’anno
scolastico sono stati solo parzialmente conseguiti.
Cagliari, 12 maggio 2017.
Rossana
Prof.ssa Spinelli
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
“Michele GIUA”
Via Montecassino 09134 CAGLIARI
TEL. 070-500786 – 501745 FAX 070520794
E-mail [email protected] Sito www.itisgiua.it
Classi 5°L - A. S. 2016/2017
PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA
A) Argomenti ed esercizi introduttivi: logica; concetti e termini fondamentali;
forme letterarie; comprensione del testo.
B) Kant
1) La critica della ragion pura
A) Fichte e Schelling (cenni)
B) Hegel
1) La fenomenologia dello spirito
A) La critica del sistema hegeliano
1)Schopenhauer
2)Kierkegaard
3)Marx
A) Nietzsche (cenni)
B) Freud e la rivoluzione psicoanalitica
C) Proiezione e commento del film: “Un nuovo mondo”.
Tali attività sono state completate dallo svolgimento periodico del Circle time.
Cagliari, 15 maggio 2017.
Rossana
Prof.ssa Spinelli
RELAZIONE FINALE
CLASSE V L
DOCENTE: Pierandrea Raccis
DISCIPLINA: Matematica
Profilo della classe
Le evidenti lacune nella formazione di base manifestate da una parte
consistente degli studenti e il diverso livello di interesse per la disciplina
manifestato dai singoli allievi, hanno determinato una classe eterogenea sia per
il grado di preparazione che per le capacità e le competenze acquisite.
Motivazione e Partecipazione
La partecipazione poco disciplinata al dialogo educativo di alcuni alunni ha reso
frammentario lo svolgimento delle lezioni. La complessità degli argomenti
trattati e lo scarso impegno nello svolgimento delle esercitazioni e dei compiti a
casa, oltre che il limitato tempo a disposizione (le vacanze si sono susseguite
con una tempistica che hanno sottratto gran parte del mese di aprile alle lezioni)
e la frequenza alterna alle lezioni, ha impedito lo svolgimento di tutti gli
argomenti previsti in sede di programmazione iniziale.
Profitto
Il profitto medio raggiunto è mediocre nonostante i discreti risultati raggiunti da
alcuni studenti che hanno compensato la preparazione approssimativa della
maggior parte degli allievi che si è regolarmente distinta per lo scarso impegno
nello studio a casa e nella episodica partecipazione durante lo svolgimento delle
lezioni. Quest’ultimo gruppo di studenti non ha raggiunto una preparazione
adeguata a causa dei motivi già esposti e soprattutto per le manifeste lacune
nella formazione di base oltre che per l’impegno discontinuo nello svolgimento
delle esercitazioni.
Obiettivi relativi ai contenuti
1
Conoscere gli argomenti trattati e sapere
fondamentali ad essi connessi.
Acquisire un linguaggio formale e specifico.
comunicare
i
concetti
-
Saper applicare correttamente regole e procedimenti di calcolo
Saper leggere e costruire un grafico.
Lo scarso impegno nello studio a casa e le gravi lacune di base hanno impedito
ad una parte consistente di alunni il raggiungimento di tutti gli obiettivi
prefissati.
Obiettivi relativi alle competenze e alle abilità
Comprendere ed analizzare situazioni.
Analizzare dati ed interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni
grafiche.
- Individuare Strategia opportune per impostare e risolvere problemi di vario
tipo, anche contestualizzati.
Solo una parte degli studenti ha raggiunto questi obiettivi.
-
Metodologia e mezzi impiegati
La trattazione degli argomenti è stata approfondita e ha seguito dei criteri
didattici mirati a favorire un approccio orientato alla comprensione dei concetti
fondamentali della disciplina, piuttosto che ad un apprendimento mnemonico e
meramente nozionistico. L’itinerario didattico tracciato ha cercato di coinvolgere
i ragazzi nell’analisi dei problemi, insistendo sui procedimenti logici e sui
concetti generali più che sulle formule. Per favorire una migliore comprensione
degli
argomenti,
le
spiegazioni
teoriche
sono
state
adeguatamente
accompagnate dallo svolgimento di numerosi esercizi.
Verifiche
Una volta che un argomento è stato sufficientemente affrontato sia con lezioni
teoriche che con esercizi pratici ed eventuali ulteriori spiegazioni, hanno fatto
seguito le verifiche, nella forma di interrogazioni orali ma soprattutto di prove
scritte.
Valutazione
Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre che del livello di preparazione
raggiunto, anche dell’impegno dimostrato, del comportamento tenuto in classe
e dei miglioramenti registrati durante l’anno.
Cagliari 12/05/2017
2
L’insegnante:
Pierandrea Raccis
PROGRAMMA DI MATEMATICA-Classe V L Lssa
Testo: Matematica.blu 2.0 di Massimo Bergamini, Anna Trifone e Graziella Barozzi Casa editrice: Zanichelli
Esponenziali e logaritmi
- Le potenze con esponente reale;
- La
funzione esponenziale;
- Le equazioni esponenziali;
- Le disequazioni esponenziali;
- La definizione di logaritmo;
- Le proprietà dei logaritmi;
- La funzione logaritmica;
- Le disequazioni logaritmiche;
-I
logaritmi, le equazioni e disequazioni esponenziali
.
- Generalità sulle funzioni reali di variabili reali
- Intervalli di R (limitati, illimitati, chiusi, aperti, semichiusi a sinistra o a destra.
Intorno destro e/o sinistro di un punto
- Dominio di funzioni composte
- Ricerca del condominio
- Funzioni pari e dispari
- Funzioni periodiche
- Funzioni monotone
- Segno di una funzione
Limiti delle funzioni
- Limiti all’infinito
- Limiti al finito
- Limiti destro e sinistro
- Operazioni sui limiti
- Forme indeterminate
- Limiti notevoli
1
Continuità delle funzioni
- Teoremi dell’unicità del limite
- Teoremi della permanenza del segno
- Teoremi del confronto
- Significato intuitivo di funzione continua
- Vari tipi di discontinuità
- Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo
- Limiti notevoli
- Eliminazione delle forme indeterminate
- Asintoti
Derivata di una funzione e sue applicazioni
- Ricerca del coefficiente angolare della tangente a una curva in un suo punto.
Definizione di derivata
- Derivata delle funzioni elementari
- Derivata delle funzioni composte
- Regole di derivazione
- Continuità e derivabilità
- Studio del segno della derivata prima
- Grafico di una funzione
- Problemi di massimo e di minimo
I teoremi del calcolo differenziale
- Teorema di Rolle
- Teorema di Lagrange
- Teorema di Chaucy
- Teorema di De L’Hospital
Gli integrali indefiniti
- Primitiva di una funzione
- Integrale indefinito e proprietà
- Integrali immediati
2
Gli integrali definiti
- Proprietà
- Il teorema fondamentale del calcolo integrale
- Il teorema della media
- Il calcolo delle aree di superfici piane
- Il calcolo dei volumi
Cagliari 12/05/2017
3
L’insegnante:
Pierandrea Raccis
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“MICHELE GIUA” CAGLIARI
Indirizzo Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
RELAZIONE FINALE Classe 5^L
DISCIPLINA: Informatica
DOCENTE Prof. Marina Pirri
Profilo della classe
Negli anni precedenti la classe aveva un altro insegnante di informatica, quindi il primo periodo è
servito a conoscerci reciprocamente ed a stabilire il metodo di lavoro.
La frequenza alle lezioni è stata molto discontinua per numerosi studenti. l’interesse e la
partecipazione non sempre sono stati adeguati.
Raggiungimento degli obiettivi
In relazione alla programmazione curriculare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali sotto
riportati
Obiettivi generali
- ottenere una soddisfacente partecipazione da parte degli alunni alle lezioni,
- sviluppare la capacità da parte dei ragazzi di applicare correttamente i meccanismi per la
risoluzione degli esercizi proposti,
- far acquisire agli studenti competenze sufficienti a risolvere autonomamente problemi di varia
difficoltà
Contenuti trattati*
Titoli unità didattiche
Database
Modellazione dei dati
Livello concettuale: diagramma ER, Entità, Associazioni binarie 1:1, 1:N, N:N; Attributi
Livello logico: caratteristiche fondamentali
Regole di derivazione dal modello concettuale
Livello fisico
Operatori fondamentali nel modello relazionale: Selezione, Proiezione, join.
DBMS: Microsoft Access
creazione di un database, creazione di tabelle (mediante l'uso dell'interfaccia grafica),
caricamento e visualizzazione dati
Query
Il linguaggio SQL
Le operazioni relazionali (proiezione, selezione e natural join) con il comando Select
Reti di elaboratori
Definizione e scopi principali
Descrizione del funzionamento dell'architettura Client /Server e Peer to peer
Classificazione delle reti in LAN, MAN e WAN
Topologie di rete: a stella, a maglia
Indirizzi IPv4
Metodologie didattiche
Problem solving, cooperative learning
Materiali didattici utilizzati
o
o
o
o
o
o
Libro di testo:
Dispense fornite dal docente.
Presentazioni realizzate tramite il software Power Point.
Postazioni multimediali.
Lavagna Interattiva Multimediale.
Software: Access
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione
Le verifiche sono state prevalentemente scritte con esercizi e domande a risposta aperta. I criteri
adottati per le valutazioni sono conoscenza dei contenuti, abilità e competenze tecniche, progressi
registrati rispetto alle condizioni di partenza.
La parte sottostante deve essere comune a tutto il Consiglio di Classe.
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno:
- la situazione di partenza;
- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;
- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne;
- l’acquisizione delle principali nozioni.
Cagliari 12-05-2017
Firma del docente
( Prof. _______________)
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“MICHELE GIUA” CAGLIARI
Indirizzo Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
RELAZIONE FINALE Classe V L
DISCIPLINA: FISICA
Testo L’Amaldi per i licei scientifici.blu _ U. Amaldi_Zanichelli_ Volumi 2/3_ sec. edizione
DOCENTE Prof. Angelo Frongia
Profilo della classe
Il corso di fisica è stato svolto dall’insegnante attuale dalla prima classe, salvo la discontinuità
didattica avutasi al secondo anno. Una parte degli allievi risentono di lacune nei contenuti non del
tutto colmate negli anni precedenti, mentre la restante parte (minoritaria), a livelli differenziati,
all’inizio del quinto anno possedeva il bagaglio necessario per seguire con sufficiente profitto il
programma svolto.
L’interesse e la partecipazione della maggior parte degli allievi è sufficiente, anche se la frequenza
non è stata molto regolare.
Su alcuni argomenti sono stati fatti degli approfondimenti o delle trattazioni “paralelle” in
laboratorio. In particolare, sugli strumenti di misura e sui circuiti elettrici.
Il livello medio di preparazione degli classe si può ritenere quasi sufficiente.
La parte del programma del quinto anno riguardante la fisica teorica generale, non è stata svolta per
un’assoluta mancanza di tempo. Infatti si sono dovute recuperare varie unità non svolte nell’anno
precedente e il carico orario del quinto anno non è sufficiente per poter affrontare argomenti delicati
e complessi come l’ultima parte dell’elettromagnetismo classico e, soprattutto, come gli elementi di
fisica relativistica, nucleare e quantistica. Un carico orario (puramente teorico) di 99 ore annuali nel
quarto e nel quinto anno, sono decisamente insufficienti per un programma così vasto e complesso.
Raggiungimento degli obiettivi
In relazione alla programmazione curriculare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali sotto
riportati
Obiettivi generali
-
-
Osservare e identificare fenomeni fisici.
Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove
l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle
variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo
di misura, costruzione e/o validazione modelli.
Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi.
Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari
rilevanti per la sua soluzione.
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in
cui si vive.
Contenuti trattati*
Titoli unità d’apprendimento.
1. Il potenziale elettrico (riepilogo e approfondimento dell’uta dell’anno scorso).
2. Fenomeni di elettrostatica.
3. La corrente elettrica continua.
4. La corrente elettrica nei metalli.
5. Fenomeni magnetici fondamentali.
6. Il campo magnetico.
7. L’induzione elettromagnetica
8. La corrente alternata
9. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche (cenni conoscitivi),*
*In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2015.
Metodologie didattiche
Lezione frontale, Lezione partecipativa, lezione in
sperimentazione individuale e in gruppo. Problem solving.
laboratorio,
svolgimento
Materiali didattici utilizzati
o
o
o
o
o
o
Libro di testo:
Dispense/appunti forniti dal docente.
Presentazioni realizzate tramite il software Power Point.
Appunti e mappe concettuali.
Postazioni multimediali.
Lavagna Interattiva Multimediale.
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione
Da sei a nove verifiche scritte/orali per allievo.
Tre simulazioni per la terza prova.
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono:
- la situazione di partenza;
- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;
- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne;
- l’acquisizione delle principali nozioni.
Cagliari 12-05-2017
Firma del docente
Prof. Angelo Frongia
di
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“MICHELE GIUA” CAGLIARI
Indirizzo Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Classe V L
DISCIPLINA: FISICA
Testo L’Amaldi per i licei scientifici.blu _ U. Amaldi_Zanichelli_ Volumi 2/3_ sec. edizione
DOCENTE Prof. Angelo Frongia
Programma svolto
Contenuti trattati*
Unità d’apprendimento.
1. Il potenziale elettrico (riepilogo e approfondimento dell’uta dell’anno scorso).
L’energia potenziale elettrica. Rappresentazione dell’energia potenziale. Lavoro ed energia
potenziale elettrica. Energia potenziale di più cariche puntiformi. Il potenziale elettrico di
una carica puntiforme. Unità di misura. Lavoro e differenza di potenziale. L’elettronvolt. Il
potenziale di più cariche puntiformi. Campo e potenziale. Lavoro, differenza di potenziale e
moto delle cariche. Superfici equipotenziali. La circuitazione del campo elettrico. Esercizi
ed applicazioni.
2. Fenomeni di elettrostatica.
I conduttori in equilibrio elettrostatico. La distribuzione della carica. La densità superficiale
di carica. I conduttori in equilibrio elettrostatico: campo elettrico e potenziale all’interno e
sulla superficie. Il problema generale dell’elettrostatica. Teorema di Coulomb. Il potere delle
punte. Convenzioni sullo zero del potenziale. La capacità di un conduttore. Calcolo della
capacità di una sfera conduttrice isolata. Sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico. Il
condensatore. Il condensatore piano e l’induzione elettrostatica tra le armature. La capacità
di un condensatore. Il campo elettrico di un condensatore piano. La capacità di un
condensatore piano. Il ruolo del dielettrico
in un condensatore. L’elettrometro.
Collegamento di un condensatore. I condensatori in parallelo e la capacità. I condensatori in
serie e la capacità. L’energia immagazzinata in un condensatore. Calcolo del lavoro di
carica. Energia del campo e la densità di energia del campo del condensatore. Esercizi ed
applicazioni.
3. La corrente elettrica continua.
L’intensità della corrente elettrica. La definizione di intensità di corrente elettrica. Il verso
della corrente. La corrente continua. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. Il ruolo del
generatore. Il circuito elettrico elementare. I collegamenti in serie e parallelo. La prima
legge di Ohm. La resistenza elettrica. I resistori. Resistenza equivalente di un collegamento
in serie. Resistenza equivalente di resistori in parallelo. Risoluzione dei circuiti. Gli
strumenti di misura e loro proprietà. Il voltmetro e l’amperometro. Come inserire gli
strumenti di misura in un circuito. Le leggi di Kirchhoff e loro significato, La legge dei nodi.
La legge delle maglie. Il metodo delle correnti alle maglie. L’effetto Joule: la trasformazione
di energia elettrica elettrica in energia interna. La potenza dissipata per effetto Joule. La
potenza di un generatore ideale. La conservazione dell’energia nell’effetto Joule. Il
chilovattora. Il rendimento del sistema elettrotermico ed elettromeccanico. Il generatore
reale e la forza elettromotrice. La resistenza interna e la caduta interna di tensione. La
generalizzazione della leggi del circuito con il generatore reale. Esercizi ed applicazioni.
Lab. 1 Realizzazione di un circuito elementare.
Lab. 2 Inserzione degli strumenti di misura e collegamenti.
Lab. 3 Misure di corrente e di tensione.
4. La corrente elettrica nei metalli.
I conduttori metallici. Proprietà dei conduttori metallici e spiegazione microscopica
dell’effetto Joule. La seconda legge di Ohm e la resistività. Applicazioni della seconda legge
di Ohm. Il reostato a cursore. Il potenziometro. La relazione tra resistività e temperatura. Il
coefficiente di temperatura. Cenni sui superconduttori. Processo di carica di un
condensatore. La costante di tempo. Bilancio energetico del processo di carica. Leggi e
diagrammi i(t), q(t), v(t) del processo di carica. Processo di scarica del condensatore. Leggi
e digrammi i(t), q(t), v(t). Esercizi ed applicazioni.
5. Fenomeni magnetici fondamentali.
Materiali ferromagnetici. Magneti naturali e artificiali. Le forze tra poli magnetici. Il campo
magnetico e linee di campo. Interazione magnetica e interazione elettrica, analogie e
differenze. Il campo magnetico terrestre. Forze tra magneti e correnti. L’esperienza di
Oersted. L’esperienza di Faraday e la forza magnetica. Definizione dell’intensità del campo
magnetico con la legge di Faraday e unità di misura. Il campo magnetico di un filo percorso
da corrente e legge di Biot-Savart. Legge del campo magnetico di una spira e di un
solenoide. Forze magnetiche tra conduttori paralleli percorsi da corrente ed esperienza di
Ampere. Definizione dell’Ampere nel Sistema Internazionale. Il momento torcente
magnetico, esperienza della spira in un campo magnetico e legge del momento magnetico.
Momento magnetico di una spira. Relazione Momento torcente e momento di una spira.
Principi di funzionamento di un motore elettrico a corrente continua. Esercizi ed
applicazioni.
Laboratorio 4. Esperienze di magnetismo
Laboratorio 5. Esperienza di Oersted.
6. Il campo magnetico.
La forza di Lorentz. Legge della forza magnetica su di una carica in moto in un campo
magnetico. Legge di Lorentz generalizzata. Studio del moto di una carica in un campo
magnetico: moto rettilineo uniforme, moto circolare uniforme, moto elicoidale. Flusso del
campo magnetico. Flusso attraverso una superficie piana e spaziale. Teorema di Gauss per il
campo magnetico. Confronto con il caso del campo elettrico. La circuitazione del campo
magnetico. IL teorema di Ampere. Confronto con la circuitazione del campo elettrico.
Studio del campo di un solenoide toroidale. Cenni su materiali ferromagnetici,
paramagnetici, diamagnetici. Esercizi ed applicazioni.
Laboratorio 6. L’elettromagnete.
7. L’induzione elettromagnetica.
Esperienze di Faraday sul fenomeno dell’induzione elettromagnetica. Corrente indotta e
forza elettromotrice indotta. Il ruolo del flusso del campo magnetico. La legge di FaradayNeumann. La legge di Lenz. Il flusso autoconcatenato in un circuito. Relazione tra flusso
corrente e induttanza. Determinazione dell’induttanza di un solenoide. Studio del fenomeno
e legge dell’autoinduzione elettromagnetica. Applicazione alla chiusura e apertura di n
circuito: extracorrente di chiusura e di apertura. Studio del circuito RL e legge della corrente
i(t) in chiusura e apertura del circuito. La costante di tempo induttiva. Energia e densità di
energia del campo magnetico di un solenoide, Generalizzazione. Esercizi ed applicazioni.
8. La corrente alternata
Motori e generatori elettrici. L’alternatore. Flusso, fora elettromotrice alternata e corrente
alternata. Grafici e relazioni, Valori efficaci delle grandezze alternate sinusoidali. La potenza
istantanea e la potenza media. Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata.
L’impedenza. La condizione di risonanza.
9. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche (cenni conoscitivi),*
*In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2015.
Cagliari 12-05-2017
Firma del docente
( Prof. _______________)
RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI
CLASSE V^ L
A.S. 2016/17
DOCENTE : LAURA LOI
TESTO ADOTTATO: “SCIENZE NATURALI Chimica Organica - Biochimica - Scienze della
Terra”- M.CRIPPA, M.FIORANI, A.BARGELLINI,D. NEPGEN, M.MANTELLI.casa editrice
Mondadori scuola.
Ore settimanali : 5
SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE
La classe è costituita da 24 alunni, di cui, 6 ripetenti. Il gruppo classe risulta abbastanza eterogeneo
sia per provenienza che per livello di preparazione e per attegiamento nei confronti delle attività
proposte. Il rapporto con gli allievi è sempre stato cordiale e corretto anche se spesso è stato
necessario intervenire e sollecitarli al rispetto delle regole. Insegno in questa classe da qust'anno,
pertanto il primo periodo è stato dedicato all'accertamento dei prerequisiti e alla conoscenza dei
ragazzi. Sono stete riscontrate lacune che solo in parte sono state colmate .Alcuni allievi hanno
riportato numerose assenze e hanno partecipato alle lezioni con scarso interesse,inoltre
l’applicazione e la costanza nello studio non sono state soddisfacenti, pertanto presentano una
preparazione insufficiente; un' altro gruppo ha raggiunto gli obiettivi minimi solo grazie
all'impegno costante; infine, pochi si sono distinti in positivo per interesse partecipazione e
applicazione nello studio raggiungendo quasi livelli di eccellenza.
Gli alunni che hanno raggiunto un buon livello di preparazione si sono mostrati costantemente
motivati. Per la restante parte la motivazione non è stata sempre adeguata, soprattutto nel primo
trimestre. Un certo miglioramento si ha nella seconda parte dell'anno scolastico, anche se alcuni
alunni trovano ancora difficoltà nello stare al passo con le lezioni.
Metodologia
OBIETTIVOfacilitare la comprensione della materia; agevolare gli alunni nello studio.
METODO: Gli argomenti sono stati trattati procedendo, con gradualità, dai concetti più semplici
verso quelli più complessi; usando un linguaggio chiaro e di facile comprensione; ricorrendo spesso
ad esempi, esercizi, applicazioni.
OBIETTIVO: sviluppare l’autonomia nello studio; mettere gli alunni in grado di dedurre gli aspetti
secondari o particolari della materia come se stessero risolvendo semplici esercizi o applicazioni.
METODO: sono state fornite non solo le conoscenze essenziali, i chiarimenti, i procedimenti
applicativi, ma anche la chiave di interpretazione delle diverse problematiche e dei principi basilari
che la regolano la materia; sollecitando i collegamenti interdisciplinari e i diversi temi della
disciplina.
OBIETTIVO: rendere stimolanti le lezioni; sollecitare il confronto delle interpretazioni e la ricerca
di una soluzione; sollecitare il confronto di posizioni e di opinioni diverse.
METODO: la classe è stata coinvolta in discussioni e dibattiti sulle tematiche trattate, anche con
domande guidate; discutendo sui temi da affrontare in modo da trovare insieme la soluzione dei
problemi; alternando i momenti informativi a quelli di dibattito aperto; lasciando agli alunni la
libertà di esprimersi senza porre schemi predeterminati, pur guidandoli nel lavoro.
OBIETTIVO: far sviluppare le capacità di osservazione, la capacità di analisi dei testi e l’autonomia
nello studio.
METODO: gli alunni sono stati invitati ad effettuare studi approfonditi su particolari tematiche;
OBIETTIVO: provvedere al recupero dello svantaggio culturale, alla piena integrazione, alla
valorizzazione delle eccellenze.
METODO: sono stati stabiliti gli obiettivi minimi per tutta la classe, utilizzando gli allievi più
pronti per l’aiuto ai compagni in difficoltà.
Agli allievi più dotati sono stati proposti lavori di approfondimento ed esercizi nei quali sono stati
costretti ad applicare conoscenze ed abilità in situazioni più complesse di quelle proposte per il
livello minimo.
OBIETTIVO: inserire l’alunno nel processo di apprendimento, rendendolo consapevole di ciò che
sta facendo; permettere agli allievi di focalizzare l’attenzione sui concetti più significativi tra quelli
trattati.
METODO: Gli alunni sono stati sempre informati sui contenuti e sugli obiettivi disciplinari del
corso di studi;
OBIETTIVO: contrarre i tempi del processo di insegnamento-apprendimento, pur rispettando i
contenuti ed il rigore scientifico, in modo da poter dedicare numerose lezioni al recupero ed al
potenziamento delle abilità di base degli allievi.
METODO: I contenuti sono stati presentati in maniera organizzata e funzionale, muovendosi dal
generale al particolare e cercando di spiegare in maniera semplice ed efficace anche i concetti più
complessi.
Obiettivi relativi ai contenuti
Gli obiettivi specifici stabiliti in sede di programmazione sono stati raggiunti solo in parte per
quanto riguarda la chimica organica,in modo soddisfacente e da gran parte degli alunni gli obiettivi
dei contenuti di scienze della terra e ancora da accertare quelli relativi ai contenuti di biochimica
Mezzi impiegati
-Libro di testo.
-Schemi ppt personali.
- Strumentazione presente in laboratorio.
- Audiovisivi in genere.
- Modelli.
-LIM.
Verifica e valutazione
verifica formativa
strumenti di verifica formativa
- Controllo del lavoro svolto a casa.
- Indagine in itinere.
- Test oggettivi.
- Questionari.
- Ripetizione dell’argomento trattato, a fine lezione o all’inizio della successiva.
- Lezione dialogata.
- Colloqui.
-Risoluzione di esercizi.
verifica complessiva
strumenti di verifica sommativa
- Interrogazioni orali.
- Interrogazioni scritte.
- Esercitazioni orali, scritte .
TASSONOMIA PER LA TRADUZIONE DELLA VALUTAZIONE IN VOTO
Si è fatto riferimento a quella riportata nel POF.
VALUTAZIONE DEL PROFITTO
Il giudizio valutativo è scaturito non solo dai risultati delle verifiche ma dall’interazione tra i
suddetti risultati e altre variabili significative relative agli allievi e altre ancora riconducibili
all’ambiente scolastico ed extra-scolastico.
Si è tenuto conto pertanto di ogni elemento utile a definire le abilità e le capacità degli allievi
(capacità di osservazione, di analisi, di sintesi, di argomentazione e di rielaborazione personale,
capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche trattate, ecc.), dell’impegno profuso,
della conoscenza e della capacità di valutazione critica dei dati, della produzione orale e scritta,
dell’attività di laboratorio, delle abilità manuali, della partecipazione assidua e consapevole al
dialogo educativo, dell’attenzione, della puntualità nel lavoro, del contributo personale alle attività
curricolari ed extra-curricolari, dello sviluppo della personalità, della frequenza alle lezioni, dei
progressi effettuati, di condizioni o problemi particolari degli allievi, delle loro famiglie o del loro
ambiente di vita e di ogni apporto che giovi alla maggiore chiarezza e completezza del giudizio
stesso.
Obiettivi generali
Ottenere una soddisfacente partecipazione da parte degli alunni alle lezioni.
Allargare il loro orizzonte culturale
Sviluppare la capacità da parte dei ragazzi di applicare correttamente i meccanismi per la
risoluzione degli esercizi proposti,
Far acquisire agli studenti competenze sufficienti a risolvere autonomamente problemi di varia
difficoltà.
Sono stati raggiunti pienamente solo da una parte del gruppo classe.
Cagliari 12/05/ 17
Docente
Laura Loi
PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI
A.S. 2016/17
CLASSE V^L
DOCENTE: PROF.SSA LAURA LOI
Testo:” Scienze Naturali” M.Crippa,M. Fiorani,A. Bargellini, D.Nepgen,M.Mantelli.A.Mondadori
Scuola.
CHIMICA
Le reazioni redox
Numero di ossidazione. Ossidazione e riduzione. Le coppie redox. Bilanciamento di reazioni redox
in ambiente neutro, acido e basico con il metodo delle semireazioni.
CHIMICA ORGANICA
La chimica del carbonio
Il carbonio. Configurazione elettronica. Ibridazione Sp3, Sp2, Sp. Legami sigma e pi greco.
Classificazione dei composti organici in base alla struttura e ai gruppi funzionali. Nucleofili ed
elettrofili. Rottura omolitica ed eterolitica. Effetto induttivo e mesomerico. Carbocationi e
carboanioni. Classificazione delle reazioni organiche.
Gli idrocarburi
Gli idrocarburi alifatici : classificazione. Gli isomeri conformazionali: la rotazione del legame C-C.
Isomeria di posizione e geometrica.
Alcani e ciclo alcani: nomenclatura, proprietà fisiche. Reattività degli idrocarburi saturi :
combustione, sostituzione radicalica.
Alcheni e alchini: nomenclatura, proprietà fisiche. Isomeria geometrica Il doppio legame C-C. I
dieni. La polimerizzazione dell’etilene. Le reazioni di addizione : idrogenazione,idratazione,
addizione di acidi alogenidrici. Regola di Markovnikov.
Idrocarburi aromatici:concetto di aromaticità, la delocalizzazione elettronica. Nomenclatura dei
composti aromatici. Reattività dei composti aromatici: la sostituzione elettrofila: nitrazione,
alogenazione, alchilazione ed acilazione di Friedel-Crafts.
Alogenuri alchilici: nomenclatura, la sostituzione nucleofila SN1 ed SN2. La deidroalogenazione
come reazione di eliminazione meccanismo E1 ed E2.
Alcoli e fenoli : nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche. Il legame idrogeno negli alcoli e
nei fenoli. L’acidità degli alcoli e dei fenoli. La disidratazione degli alcoli ad alcheni.L’ossidazione
degli alcoli. I polialcoli.
Gli eteri: nomenclatura, proprietà fisiche. Preparazione degli eteri,sintesi di Williams.I reattivi di
Grignard.
Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche. Metodi di preparazione. Il carbonile.
L’addizione nucleofila al carbonile. Formazione di semiacetali e di acetali. La tautomeria chetoenolica la condensazione aldolica semplice e mista.
Gli acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche. Acidi bicarbossilici. Acidità. Metodi di
preparazione: ossidazione degli alcoli e delle aldeidi, ossidazione delle catene laterali dei composti
aromatici, idrolisi dei nitrili.
I derivati degli acidi carbossilici: esteri -nomenclatura ,esterificazione di Fischer, idrolisi basica
degli esteri.
Alogenuri acilici: nomenclatura, preparazione. Anidridi: nomenclatura, metodo di preparazione.
Ammidi: nomenclatura, metodo di preparazione. Reazioni dei derivati degli acidi carbossilici con
alcoli, acqua e ammoniaca.
Ammine: nomenclatura, proprietà fisiche. Classificazione. Reazioni di preparazione delle ammine
alifatiche e aromatiche:alchilazione dell’ammoniaca e delle ammine, riduzione dei nitro composti.
La basicità delle ammine: confronto tra ammine alifatiche e anilina. Le reazioni con acidi
carbossilici : formazione di ammidi; la salificazione delle ammine con acidi forti. I Sali di diazonio:
reazioni di sostituzione e la reazione di copulazione.
Stereochimica
Gli isomeri configurazionali: isomeria ottica, chiralità, enantiomeri configurazioni assolute e
convenzioni R-S, regole di Chan,Ingold e Prelog, proiezioni di Fischer, diastereoisomeri e composti
meso.
Luce polarizzata e attività ottica, il polarimetro e la misura del potere rotatorio, miscela racemica.
BIOCHIMICA
LE BIOMOLECOLE.
Carboidrati
Definizioni e classificazione. I monosaccaridi. Le proiezioni di Fischer e gli zuccheri D e L.Le
strutture semiacetaliche cicliche dei monosaccaridi. Anomeria e muta rotazione. Le strutture
piranosiche e furanosiche. La formazione di glicosidi. I dissacaridi: saccarosio, lattosio,cellobiosio,
maltosio. I polisaccaridi: amido, cellulosa e glicogeno.
Lipidi
Definizione e funzione. Lipidi saponificabili struttura di: trigliceridi, fosfolipidi e cere.
Lipidi insaponificabili terpeni, steroidi e vitamine liposolubili.
Proteine
Definizione di proteina e funzioni nell’organismo. Gli amminoacidi naturali: struttura,
classificazione, comportamento in acqua, il P.I. Il legame peptidico. La struttura delle proteine:
primaria, secondaria, terziaria e quaternaria.Gli enzimi: generalità e funzione.
Gli acidi nucleici
I nucleotidi. Struttura del DNA e dell'RNA
Il metabolismo.
Generalità. Autotrofi ed eterotrofi. Vie divergenti, convergenti e cicliche. Processi catabolici e
anabolici. L'ATP struttura e ruolo nel metabolismo.
I processi metabolici
Glicolisi e respirazione cellulare.Metabolismo dei lipidi. Metabolismo delle proteine.
In laboratorio
Saggi di riconoscimento dei composti organici
Determinazione del punto di fusione.
Saggi d riconoscimento delle insaturzioni: addizione di Br2 e decolorazione del KMnO4.
Saggio di Lucas.
SCIENZE DELLA TERRA
I fenomeni sismici
Lo studio dei terremoti, la distribuzione geografica dei terremoti, le onde sismiche, i sismografi, la
forza di un terremoto (magnitudo e intensità).
I modelli della tettonica globale
La struttura interna della Terra: le teorie fissiste. La teoria della deriva dei continenti.
La struttura della crosta terrestre (crosta oceanica e crosta continentale).
Le anomalie magnetiche dei fondi oceanici. (il campo magnetico terrestre e il paleomagnetismo).
La formulazione teoria della tettonica delle placche. Margini di placca e margini continentali.
Descrizione della placca litosferica e dei margini di placca.
Principali processi geologici ai margini delle placche (attività sismica e vulcanica). Come si
formano gli oceani. I sistemi arco-fossa. I punti caldi. Il meccanismo che muove le placche.
L’orogenesi. La struttura dei continenti.
RELAZIONE FINALE
DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
CLASSE Quinta L LSSA
DOCENTE Giovanni Sogos
Profilo della Classe
Ho insegnato in questa classe per tutto il triennio.
Il gruppo classe risulta abbastanza affiatato per quanto riguarda i rapporti
interpersonali, e se pur evidenziando una certa esuberanza in alcuni alunni e
il loro comportamento non sempre partecipe, le lezioni sono sempre state
svolte regolarmente.
La valutazione è complessivamente positiva, se si tiene conto della necessità
di dover affrontare un programma vastissimo e complesso, in un tempo
relativamente breve, con una preparazione di base non sempre adeguata.
Profitto
Mediamente sufficiente
Motivazione
Non sempre adeguata, soprattutto nel primo trimestre, per gran parte della
classe. Un certo miglioramento si ha nella seconda parte dell'anno scolastico,
anche se alcuni alunni trovano ancora difficoltà nello stare al passo con le
lezioni.
Partecipazione
In accordo con le motivazioni e l'interesse per la materia si è avuta una
partecipazione piena e accettabile solo sul finire dell'anno scolastico.
Obiettivi relativi ai contenuti
Avere la possibilità di comprendere quanto ci circonda con l'aiuto e la
sensibilità degli artisti che si sono via via succeduti nel tempo.
Avere presente la complessità dei periodi storico-artistici, evidenziandone le
diverse tendenze stilistiche.
Arricchire la conoscenza della terminologia specifica della disciplina
attraverso l'introduzione e l'illustrazione di nuovi termini.
Obiettivi relativi alle competenze e alle abilità
Saper affrontare e discutere, con proprietà di linguaggio, un determinato
periodo artistico, nel contesto adeguato, evidenziandone le diverse tendenze
artistiche.
Saper illustrare in forma scritta o anche presentare in formato elettronico un
periodo artistico possibilmente con considerazioni personali.
Raggiungimento degli obiettivi
In relazione alla programmazione curricolare, gli alunni raggiungono solo in
parte gli obiettivi generali riportati nella seguente relazione, stentando
nell’acquisire un metodo di studio proficuo, limitando così le proprie capacità
critiche, non adeguando la consapevolezza nei confronti dello studio,
fermandosi quindi, nel complesso, a livelli sufficienti.
Attività integrative ed extracurriculari
Le lezioni sono state integrate dalla visione di alcuni documentari.
Metodologia e mezzi impiegati
Nell'illustrare i contenuti fondamentali si è fatto sempre uso della LIM, con
presentazioni in formato elettronico.
Sono sempre stati costanti i riferimenti al libro di testo adottato, ad alcune
riviste d'arte e a rilevanti notizie giornalistiche sul mondo dell'arte.
Si è cercato, nei limiti del possibile, di usare un linguaggio semplice e
accattivante, con continui riferimenti alla realtà vissuta dagli alunni e quando
possibile in forma dialogata.
Verifiche
Nel primo trimestre sono state prevalentemente effettuate in forma orale e in
taluni casi con presentazioni di tipo elettronico.
Anche nel pentamestre le verifiche sono state sempre in forma orale.
Valutazione
La valutazione si è realizzata in base ai parametri stabiliti nel quadro del POF.
La valutazione finale tiene conto non solo dei risultati delle prove scritte e
delle verifiche orali, ma anche di altri elementi formativi quali impegno,
capacità organizzativa autonoma del lavoro, comportamento disciplinare.
Programma di Disegno e Storia dell'Arte
a.s. 2016/17
Prof. Giovanni Sogos
L’Illuminismo
- Étienne-Louis Boullée (1728 – 1799)
- Il Museo (17839
- Cenotafio di Newton (1874)
- Biblioteca nazionale (1875)
Il Neoclassicismo
- Antonio Canova (1757 – 1822)
- Teseo sul Minotauro (1781-1783)
- Amore e Psiche (1788-1794)
- Adone e Venere (1789-1794)
- Ebe (1800-1805)
- Paolina Borghese (1804-1808)
- Le Tre Grazie (1814-1817)
- Monumento funebre a Maria Caterina d’Austria (1798-1805)
- Jaques-Louis David (1748 – 1825)
- Il Giuramento degli Orazi (1784)
- La morte di Marat (1793)
- Le Sabine (1794)
- Leonida alle Termopili (1814)
- Marte disarmato da Venere e dalle Grazie (1824)
- Architetture Neoclassiche
- Robert Adam (1728 – 1792)
- Kedleston Hall (1765-1770)
- Biblioteca di Osterly Park (1761-1777)
- Leo von Klenze (1784-1864)
- Walhalla dei Tedeschi (1830-1842)
- Ruhmeshalle (1848-1853)
- Giuseppe Pier Marini (1734-1808)
- Teatro alla Scala (1852)
- Palazzo Belgioioso (1772-1781)
- Cortile Palazzo Greppi (1776)
- Giacomo Quarenghi (1774 – 1817)
- Accademia delle Scienze di San Pietroburgo (1783-1789)
Il Neoclassicismo in Sardegna
- Giovanni Battista Franco
- Villa Pollini o Doloretta, Cagliari (1812)
- Carlo Pilo Boyl
- Palazzina della Polveriera (oggi Galleria Comunale D’Arte), Cagliari (1828)
- Porta Cristina, Cagliari (1835)
- Palazzo Boyl, Cagliari (1840)
- Palazzo Boyl, Milis
- Antonio Cano
Cattedrale di Santa Maria della Neve, Nuoro (1835 – 1853)
- Giacomo Galfré
- Fontana Maggiore, Bitti (1850)
- Chiesa di Sant’Andrea, Orani (1867-1920)
- Gaetano Cima (1805 – 1878)
- Ospedale Civile, Cagliari (1844-1848)
- Chiesa di Santa Maria Assunta, Guasila (1842-1852)
- Villa Santa Maria, Pula (1838)
- Lavatoio Comunale, Sardara (1846)
- Duomo di Ozieri (1846)
- Chiesa di San Francesco, Oristano (1841-1842)
- Giuseppe Cominotti (1792 – 1833)
- Teatro Civico, Sassari (1826-1833)
- Chiesa della Beata Vergine della Consolata, Porto Torres (1826)
- Giuseppe Sciuti (1834 – 1907)
- Decorazione del Salone del Consiglio Provinciale, Sassari (1878-1882)
Il Romanticismo
- Differenze tra Neoclassicismo e Romanticismo
- L’irrazionalità contrapposta alla razionalità
- Il Sublime
- Il Genio
- Caspar David Friedrich (1774 – 1840)
- Abbazia nel querceto (1808- 1810)
- Mare Artico o Il Naufragio della Speranza (1823-1824)
- Viandante sul mare di nebbia (1818)
- Donna al tramonto del sole (1818)
- John Constable (1776 – 1837)
- Studio di nuvole (1822 circa)
- Cattedrale di Salisbury (1823)
- Joseph Mallord William Turner (1775 – 1851)
- L’Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni (1835)
- La valorosa Téméraire (1838)
- Tramonto (1830-1835)
- Ombra e tenebre, la sera del diluvio (1843)
- Rain, steam and speed (1844)
- Jean-Louis-André-Theodore Gericault (1791 – 1824)
- Accademia di uomo nudo da tergo (1816)
- Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia (1814)
- Cattura di cavallo selvaggio nella campagna romana (1816)
- La zattera della Medusa (1819)
- Alienata con monomania d’invidia (1822-1823)
- Il monomaniaco del comando militare (1819-1822)
- Eugéne Dealcroix (1798 – 1863)
- Carica della cavalleria araba (1832)
- La barca di Dante (1822)
- La libertà che guida il popolo (1830)
- La Grecia sulle rovine di Missolungi (1826)
- Il rapimento di Rebecca (1846)
- Eliodoro cacciato da tempio (1854-1864)
- Francesco Hayez (1791 – 1882)
- Aiace d’Oileo (1822)
- La congiura dei Lampugnani (1826-1829)
- Pensiero malinconico (1842)
- Il bacio (1859-1861-1867)
- Ritratto di Alessandro Manzoni (1841)
Camille Corot e La Scuola di Barbizon
-
La Scuola di Barbizon
- Pierre-Etienne-Theodore Rousseau (1812 – 1867)
- Sotto le betulle (1842-1843)
- Charles-Francois Dubigny (1817 – 1878)
- Tramonto sull’Oise (1865)
- Paesaggio con ruscello sotto il sole (1870)
- Camille Corot (1796 – 1875)
- Il Ponte di Narni (1826-1827)
- Baccante con pantera
- Riposo (1860)
- Roma, Isola di San Bartolomeo
- Roma, Castel Sant’Angelo (1826)
- Monte Soratte (1826)
- Giovane con perla (1869)
- Cattedrale di Chartres (1830)
L’architettura degli Ingegneri
- Ponte sul Seven (Iron Bridge) (1775-1779)
- Viadotto ferroviario sul Firth of Forth (1885-1890)
- Burggarten, Vienna (1825-1826)
- Stazione Atocha, Madrid (1888-1892)
- Le Esposizioni Universali
- Cristal Palace di Joseph Paxton (1852)
- Esposizione Universale di Parigi del 1889
- Galleria delle macchine
- Tour Eiffel
L’Impressionismo
- Édouard Manet (1832 – 1883)
- Colazione sull’erba (1863)
- Olympia (1865)
- Le corse a Longchamp, litografia (1865)
- Il balcone (1868-1869)
- La gare de Saint-Lazare (1872-1873)
- Il bar delle Folies Bergére (1881-1882)
- Claude Monet (1840 – 1926)
- Donne in giardino (1866)
- Colazione sull’erba (1865-1866)
- Impressione: sole nascente (1872)
- Honfleur, rue de Bavole (1864)
- La Gazza (1868-1869)
- La Grenouillére (1869)
- Gare de Saint-Lazare (1877)
- Rouen, la Cattedrale in vari momenti della giornata (1894)
- Lo stagno delle ninfee (1899)
- Edgar Degas (1834 – 1917)
- La famiglia Belleli (1858-!867)
- Giovani spartane (1860-1862)
- Manet con la moglie (1868-1862)
- L’ufficio dei Musson a New Orleans (1873)
- Foyer di danza all’opera (1872)
- La classe di danza (1874)
- Ballerina che fa il saluto (1876-1877)
- L’assenzio (1876)
- Ballerina blu (1894)
- Quattro ballerine in blu (1898)
- Tre ballerine con gonna gialla (1891)
- Pierre-Auguste Renoir (1841 – 1919)
- Lise con l’ombrello (1867)
- I fidanzati (1868)
- La Grenouillére (1869)
- Moulin de la Galette (1876)
- Pont Neuf (1872)
- Il Palco (1874)
- La Liseuse (1876)
- Nudo al sole (1875)
- Sulla terrazza (1879-1881)
- La colazione dei canottieri (1880-1881)
- Bagnante bionda (1881)
- Bagnante seduta (1883-1884)
- Le grandi bagnanti (1884-1887)
- Post-Impressionismo
- Paul Cézanne ( 1839 – 1906)
- Il negro Scipione (1866)
- Louis-Auguste Cézanne (1866)
- La casa dell’impiccato (1873)
- Natura morta con cassetto aperto (1877)
- Il ponte di Maincy (1879-1880)
- La montagna Sait-Victoire dal grande pino (1887)
- Saint-Victoire da Bibémus (1897)
- Le grandi bagnanti (1895)
- Le grandi bagnanti (1900-1905)
- La montagna Sait-Victoire vista dai Louves (1902-1904)
- La montagna Sait-Victoire vista dai Louves (1902-1906)
- Vincent Van Gogh (1853 – 1890)
- I mangiatori di patate (1885)
- Notte stellata (Cipresso e paese) (1889)
- Campo di grano con volo di corvi (1890)
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“MICHELE GIUA” CAGLIARI
Indirizzo Liceo scienze sociali applicate
RELAZIONE FINALE
Classe 5^L
DISCIPLINA ed. fisica
Testo Nuovo praticamente sport
DOCENTE Prof Rita Vitellaro
Anno scolastico 2016-2017
Profilo della classe
Profitto
Il profitto raggiunto è globalmente buono, tenendo conto della situazione di partenza, che
evidenziava una preparazione di base discreta.
Motivazione
Gli alunni hanno svolto le attività motorie con interesse.
Partecipazione
La classe ha partecipato attivamente alle lezioni.
Obiettivi relativi ai contenuti
Gli obiettivi relativi ai contenuti si riferiscono ad un perfezionamento delle capacità motorie e
ad un affinamento delle capacità relative allo sport individuale e di squadra.
Obiettivi relativi alle competenze e alle abilità
Dimostrare di saper compiere attività motorie a carattere individuale e di squadra.
Metodologia e mezzi impiegati
Analisi del movimento degli esercizi proposti prima in forma teorica, poi con esercitazioni
pratiche in gruppo e a squadre complete. Verifiche.
Valutazione
Test di carattere motorio, con misure e tempi rapportati alle capacità iniziali di ogni allievo.
Programma svolto:
Ginnastica educativa in traslocazione e sul posto.
Stretching.
Mobilizzazione articolare scapolo-omerale e coxo-femorale
Potenziamento degli addominali; potenziamento dei dorsali
Potenziamento degli arti superiori e inferiori
Elasticità muscolare. Lancio della palla medica. Saltelli con funicella.
Esercizi alla spalliera svedese: specifici e di riporto
Esercizi alle parallele simmetriche: specifici e di riporto.
Salto in lungo da fermi. Elevazione da fermi.
Pallavolo. Basket. Calcetto. Tennis tavolo. Tennis. Biliardino. Body building.
Materiali didattici utilizzati: Grandi attrezzi: spalliera, parallele simmetriche. Campi sportivi
da basket, da pallavolo, da calcetto e da tennis. Attrezzi in sala pesi. Piccoli attrezzi: Palloni da
pallavolo, da basket, da calcetto; funicella; palla medica; racchette da tennis e da tennis
tavolo. Biliardino. Tappetini per l’esecuzione di esercizi di ginnastica educativa.
Il docente
RELAZIONE FINALE DI IRC (Insegnamento Religione Cattolica)
Classe 5a L Liceo Scientifico delle scienze applicate
a. s. 2016 - 2017
DOCENTE: Floris Marcello
PROFITTO
Mediamente buono
MOTIVAZIONE
Funzionamento del gruppo-classe. Buona interazione tra gli studenti ed il docente.
PARTECIPAZIONE
L'attenzione è stata quasi sempre costante ed attiva
OBIETTIVI RELATIVI AI CONTENUTI
Conoscenza del contenuto e del significato delle principali parabole evangeliche;
conoscenza della valore della dimensione onirica, biblica e non;
conoscenza della storia de “Il piccolo principe” e delle analogie con la Bibbia ed il Vangelo in modo particolare;
conoscenza del sistema di “lotta non-violenta” ideata da Gandhi e dei suoi fondamenti evangelici;
conoscenza del significato cristiano del Natale;
conoscenza delle caratteristiche principali del papato di Francesco;
consapevolezza dell'urgenza del problema ecologico e del relativo “Protocollo di Kyoto”;
conoscenza della storia de “L'uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono;
conoscenza dei contenuti principali della lettera Enciclica “Laudato sí” di papa Francesco;
conoscenza del principale messaggio del Cristianesimo: l'amore;
conoscenza delle linee essenziali de “L'arte di amare” di Erich Fromm;
OBIETTIVI RELATIVI ALLE COMPETENZE E ABILITÁ
Distinguere diversi registri linguistici in rapporto alla realtà;
applicare contenuti storico-letterari alla propria vita ed alla società contemporanea;
disporsi positivamente verso il proprio inconscio;
criticare lo scarto esistente tra principi e valori enunciati dal cristianesimo e gli atteggiamenti, le azioni e le scelte della
massa dei credenti;
saper trovare fonti ecclesiali relativamente ad un tema trattato;
dare credito alla dimensione “bambina” del nostro essere;
apprezzare le dimensioni “visionarie”, utopiche e profetiche dell'esperienza religiosa e laica della vita.
ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI
Nessuna
METODOLOGIA E MEZZI IMPIEGATI
Lezione frontale, lezione partecipata, quasi sempre attraverso presentazioni, utilizzando la LIM, lettura di libri, visione
di film e documentari, problem solving, ricerche in classe, dibattito.
VERIFICHE
Esclusivamente empiriche ed estemporanee, relative ad attenzione, partecipazione, approfondimento autonomo.
VALUTAZIONE
Conoscenza essenziale degli argomenti svolti.
Capacità di applicare alcune conoscenze storico-dottrinali-religiose ai problemi odierni
PROGRAMMA SVOLTO
Le parabole evangeliche: stile e contenuto;
Il ruolo del sogno nella bibbia, nella società e nella nostra vita quotidiana;
La figura del mahatma Gandhi. Un modello eroico e rivoluzionario innovativo;
Lettura e commento della lettera Enciclica “Laudato sí”;
il problema politico e culturale dell'ecologia;
l'amore cristiano;
lettura e commento de “L'arte di amare” di Erich Fromm;
lettura e commento de “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry;
analisi del discorso che Steve Jobs ha tenuto nel 2015 all'Università di Stanford.
Cagliari, 12 maggio, 2017
Prof. Marcello Floris
ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
MATERIA
AUTORE
TITOLO
CASA
EDITRICE
Italiano
Sambugar- Salà
Gaot vol. III
La nuove Italia
Editrice
Storia
Baldissara Battilossi
La costruzione del presente
Vol III
Sansoni per la
scuola
Filosofia
Guidetti Luca
Grammatiche del pensiero
Zanichelli
Matematica
Bergamini Massimo
Matematica.Blu
Zanichelli
Scienze integrate
M.Crippa, M.Fiorani,
SCIENZE NATURALI
Mondadori
A.Bargellini,D.
Chimica Organica -
scuola.
Nepgen, M.Mantelli
Biochimica - Scienze della
Terra”-
Fisica
Amaldi Ugo
Amaldi per i licei
Zanichelli
scientificiInduzione e onde
elettromagnetiche, relatività
e quanti
Informatica
Lorenzi Agostino
Informatica Applicazioni
Atlas
scientifiche
Disegno e storia
dell'arte
Inglese
Secchi Rolando
Disegno Architettura e Arte
Cricco Giorgio
Itinerario nell'Arte dall'età
La nuova Italia
editrice
dei Lumi ai giorni nostri
Zanichelli
RADLEY PAUL
NEW HORIZONS 2
OXFORD
ANSALDO
VISITING LITERATURE
MARIELLA
UNIVERSITY
PRESS
Petrini
Educazione fisica
Del Nista Pier Luigi
Nuovo praticamente sport
D’Anna
Religione
Solinas L.
Tutti i colori della vita
SEI
ITI “M.GIUA” LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE
SIMULAZIONE TERZA PROVA
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
CLASSE 5a L LSSA
DISCIPLINE: INFORMATICA/SCIENZE INTEGRATE/FISICA/INGLESE
TIPOLOGIA: B (QUESITI A RISPOSTA BREVE, MAX 10 RIGHE)
NUMERO DI DOMANDE: 12 (3 x 4)
TEMPO A DISPOSIZIONE: 120
minuti.
ALLIEVO
COGNOME: ___________________________________
NOME:
___________________________________
FIRMA:
___________________________________
PUNTEGGIO MEDIO SINGOLE MATERIE
INFORMATICA
SCIENZE
NATURALI
FISICA
STORIA
INGLESE
VOTO
TOTALE
Per la valutazione della prova si utilizza la seguente tabella di conversione:
VOTO IN DECIMI
VOTO
IN QUINDICESIMI
1
1,5
2
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
8
9
10
1*
2*
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
*(
In sede di Esame di Stato e relative simulazioni la valutazione in quindicesimi non ammette i
mezzi voti che devono essere adeguatamente arrotondati per difetto o per eccesso.)
Per quanto riguarda i livelli della valutazione si adotterà la scala da 1 a 10, facendo riferimento
alla tabella d’Istituto.
TERZA PROVA SCRITTA
(Tipologia B: n. 10 quesiti a risposta breve, per un massimo di 10 righe, tempo 2 ore)
GRIGLIA PER LA CORREZIONE E LA VALUTAZIONE
Ciascun docente delle discipline sotto indicate dispone di 15 punti da distribuire su 2 quesiti mirati ad
accertare conoscenze, competenze e capacità secondo la seguente tabella di valutazione:
INDICATORI
Conoscenze
LIVELLI
Lacunose
Frammentarie ed imprecise
Sufficienti
Buone
Ampie ed esaurienti
1
2
3,5
4
5
PUNTEGGI
Competenze
- espressive
- applicative
- rielaborative
- di collegamento
Scarse
Mediocri
Globalmente accettabili
Discrete
Buone
0
2
3,5
4
5
Capacità
- di comprensione
- di analisi
- di sintesi
Molto limitate
Modeste
Accettabili
Discrete
Spiccate
0
2
3
4
5
GRIGLIA PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DELLA PROVA
Informatica
Quesiti
Conoscenze
Competenze
Capacità
TOTALE
Scienze integrate Fisica
n°1 n°2 n°3 n°1 n°2
n°3
Inglese
n°1 n°2 n°3 n°1
n°2 n°3
Media
Voto
VOTO
DESCRITTORE
1
Nullo
2
Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio
Scarsissima conoscenza anche degli argomenti fondamentali. Assenza di comprensione o
3
incapacità di applicazione delle conoscenze acquisite. Gravi e numerosi errori e
confusione nella comunicazione scritta e orale.
Conoscenza carente o frammentaria degli argomenti significativi, difficoltà di esposizione.
4
Comprensione limitata o difficoltà evidente nella applicazione degli argomenti
fondamentali. Numerosi errori nella comunicazione scritta e orale.
Conoscenza incompleta o superficiale, esposizione impacciata degli argomenti
5
fondamentali. Comprensione parziale con incertezze o limitata autonomia
nell’applicazione degli argomenti appresi. Errori nella comunicazione scritta e orale.
Conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali anche se esposti con qualche
6
inesattezza. Capacità di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati.
Comprensione o applicazione corretta dei contenuti fondamentali
Conoscenza abbastanza sicura degli argomenti ed esposizione chiara e corretta. Capacità
7
di cogliere le relazioni tra i contenuti trattati. Comprensione ed applicazione corretta degli
argomenti richiesti.
Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata e
8
personale. Capacità di cogliere in maniera organica le relazioni tra i contenuti trattati.
Comprensione e applicazione corretta ed autonoma degli argomenti richiesti.
Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata e
9
personale. Capacità di padroneggiare argomenti e problematiche complesse e di
organizzare le conoscenze sapendo operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari.
10 Livelli e capacità del descrittore precedente con caratteristiche di eccezionalità.
Anno scolastico 2016/2017
Materia: Inglese
Allievo:............................................................................
Simulazione terza prova
Classe 5a L LSSA
How did the Romantic movement react to the American and French Revolutions ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
-
Why was the contemplation of nature so inspiring for the Romantic poets ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
3) What role did the Romantic poets give to imagination ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Anno scolastico 2016/2017
Materia: Fisica
Allievo:............................................................................
Simulazione terza prova
Classe 5a L LSSA
1) Spiegare il fenomeno della carica di un condensatore e individuare analiticamente e
graficamente le funzioni q(t), i(t) e v(t).
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2) Esperienza di Faraday e legge della forza magnetica.
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3) Esperienza di e legge di Ampere per fili conduttori rettilinei e paralleli, percorsi da corrente.
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Anno scolastico 2016/2017
Simulazione terza prova
Materia: Scienze integrate
Classe 5a L LSSA
Allievo:
1) Descrivi, in generale, l'ibridazione e, in particolare, le caratteristiche dell'atomo di carbonio
ibrido sp3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Dopo aver classificato gli idrocarburi giustifica il loro comportamento fisico.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Descrivi il sismografo e spiega l'utilità del sismogramma.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anno scolastico 2015/2016
Simulazione terza prova
Materia: Informatica
Classe 5a L LSSA
Allievo:...........................................................
1) Il candidato descriva brevemente le fasi di progettazione di una base di
Il candidato descriva qual è il risultato della traduzione di un’associazione uno a molti nello schema
logico
-
Data la tabella Auto(IDAuto, Modello, Prezzo, Cilindrata, Potenza, Combustibile, Consumo)
visualizzare modello, prezzo e consumo delle auto a benzina, con cilindrata maggiore di
1300
ITI “M.GIUA” LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE
SIMULAZIONE TERZA PROVA
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
CLASSE 5a L LSSA
DISCIPLINE: INFORMATICA/SCIENZE INTEGRATE/FISICA/INGLESE
TIPOLOGIA: B (QUESITI A RISPOSTA BREVE, MAX 10 RIGHE)
NUMERO DI DOMANDE: 12 (3 x 4)
TEMPO A DISPOSIZIONE: 120
minuti.
ALLIEVO
COGNOME: ___________________________________
NOME:
___________________________________
FIRMA:
___________________________________
PUNTEGGIO MEDIO SINGOLE MATERIE
INFORMATICA
SCIENZE
NATURALI
FISICA
STORIA
INGLESE
VOTO
TOTALE
Per la valutazione della prova si utilizza la seguente tabella di conversione:
VOTO IN DECIMI
VOTO
IN QUINDICESIMI
1
1,5
2
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
8
9
10
1*
2*
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
*(
In sede di Esame di Stato e relative simulazioni la valutazione in quindicesimi non ammette i
mezzi voti che devono essere adeguatamente arrotondati per difetto o per eccesso.)
Per quanto riguarda i livelli della valutazione si adotterà la scala da 1 a 10, facendo riferimento
alla tabella d’Istituto.
TERZA PROVA SCRITTA
(Tipologia B: n. 10 quesiti a risposta breve, per un massimo di 10 righe, tempo 2 ore)
GRIGLIA PER LA CORREZIONE E LA VALUTAZIONE
Ciascun docente delle discipline sotto indicate dispone di 15 punti da distribuire su 2 quesiti mirati ad
accertare conoscenze, competenze e capacità secondo la seguente tabella di valutazione:
INDICATORI
Conoscenze
LIVELLI
Lacunose
Frammentarie ed imprecise
Sufficienti
Buone
Ampie ed esaurienti
1
2
3
4
5
PUNTEGGI
Competenze
- espressive
- applicative
- rielaborative
- di collegamento
Scarse
Mediocri
Globalmente accettabili
Discrete
Buone
1
2
3
4
5
Capacità
- di comprensione
- di analisi
- di sintesi
Molto limitate
Modeste
Accettabili
Discrete
Spiccate
0
2
3
4
5
GRIGLIA PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DELLA PROVA
Informatica
Quesiti
Conoscenze
Competenze
Capacità
TOTALE
MEDIA
Scienze integrate Fisica
n°1 n°2 n°3 n°1 n°2
n°3
Inglese
n°1 n°2 n°3 n°1
n°2 n°3
Media
Voto
VOTO
DESCRITTORE
1
Nullo
2
Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio
Scarsissima conoscenza anche degli argomenti fondamentali. Assenza di comprensione o
3
incapacità di applicazione delle conoscenze acquisite. Gravi e numerosi errori e
confusione nella comunicazione scritta e orale.
Conoscenza carente o frammentaria degli argomenti significativi, difficoltà di esposizione.
4
Comprensione limitata o difficoltà evidente nella applicazione degli argomenti
fondamentali. Numerosi errori nella comunicazione scritta e orale.
Conoscenza incompleta o superficiale, esposizione impacciata degli argomenti
5
fondamentali. Comprensione parziale con incertezze o limitata autonomia
nell’applicazione degli argomenti appresi. Errori nella comunicazione scritta e orale.
Conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali anche se esposti con qualche
6
inesattezza. Capacità di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati.
Comprensione o applicazione corretta dei contenuti fondamentali
Conoscenza abbastanza sicura degli argomenti ed esposizione chiara e corretta. Capacità
7
di cogliere le relazioni tra i contenuti trattati. Comprensione ed applicazione corretta degli
argomenti richiesti.
Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata e
8
personale. Capacità di cogliere in maniera organica le relazioni tra i contenuti trattati.
Comprensione e applicazione corretta ed autonoma degli argomenti richiesti.
Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata e
9
personale. Capacità di padroneggiare argomenti e problematiche complesse e di
organizzare le conoscenze sapendo operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari.
10 Livelli e capacità del descrittore precedente con caratteristiche di eccezionalità.
Anno scolastico 2016/2017
Materia: Inglese
Allievo:............................................................................
Simulazione terza prova
Classe 5a L LSSA
1. What can you tell about "The Lamb" as a poem belonging to the "Songs of Innocence"
of William Blake
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2) Consider Blake's poem "The Tyger". The powerful creature could be made in the
furnace of a huge creator. What do the questions in the poem suggest about the Tyger's
creator ? What is he like ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
3) What historical events impressed Blake in the course of his youth ?
How did he react to them ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Anno scolastico 2016/2017
Materia: Fisica
Allievo:............................................................................
Simulazione terza prova
Classe 5a L LSSA
1)La legge di Lorentz. Analizzare il fenomeno fisico, scrivere e spiegare la legge. Indicare anche
quella generalizzata.
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2) .Definizione di flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il campo magnetico e per
il campo elettrico. Confronto.
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3)
Momento delle forze magnetiche su una spira percorsa da corrente. Descrizione del
fenomeno e legge del momento magnetico. Relazione con il momento magnetico di spira.
…...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Anno scolastico 2016/2017
Simulazione terza prova
Materia: Scienze integrate
Classe 5a L LSSA
Allievo:
1) Spiega come può essere indagata la struttura della terra e confronta il modello fissista con
l'attuale modello.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Dopo aver brevemente esposto la teoria di Wegener,elenca le prove a favore di tale teoria e i
suoi punti deboli.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Scrivi la formula di struttura generale degli acidi carbossilici, la Ka di un generico acido
carbossilico e spiega la ragione di tale proprietà.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anno scolastico 2015/2016
Materia: Informatica
Allievo:...........................................................
Simulazione terza prova
Classe 5a L LSSA
1) Il candidato descriva cosa sono gli attributi delle entità e quali sono le caratteristiche degli
attributi
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2) Il candidato descriva a cosa servono le operazioni relazionali in generale descrivendo in
particolare solo la proiezione
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3)Data la tabella Auto(IDAuto, Modello, Prezzo, Cilindrata, Potenza, Combustibile, Consumo)
scrivere l’SQL per la seguente query: visualizzare modello, prezzo e delle auto con potenza
pari a 30kW
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ITI “M.GIUA” LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE
SIMULAZIONE TERZA PROVA
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
CLASSE 5a L LSSA
DISCIPLINE: INFORMATICA/SCIENZE INTEGRATE/FISICA/INGLESE
TIPOLOGIA: B (QUESITI A RISPOSTA BREVE, MAX 10 RIGHE)
NUMERO DI DOMANDE: 12 (3 x 4)
TEMPO A DISPOSIZIONE: 120
minuti.
ALLIEVO
COGNOME: ___________________________________
NOME:
___________________________________
FIRMA:
___________________________________
PUNTEGGIO MEDIO SINGOLE MATERIE
INFORMATICA
SCIENZE
NATURALI
FISICA
STORIA
INGLESE
VOTO
TOTALE
Per la valutazione della prova si utilizza la seguente tabella di conversione:
VOTO IN DECIMI
VOTO
IN QUINDICESIMI
1
1,5
2
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
8
9
10
1*
2*
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
*(
In sede di Esame di Stato e relative simulazioni la valutazione in quindicesimi non ammette i
mezzi voti che devono essere adeguatamente arrotondati per difetto o per eccesso.)
Per quanto riguarda i livelli della valutazione si adotterà la scala da 1 a 10, facendo riferimento
alla tabella d’Istituto.
TERZA PROVA SCRITTA
(Tipologia B: n. 12 quesiti a risposta breve, per un massimo di 10 righe, tempo 2 ore)
GRIGLIA PER LA CORREZIONE E LA VALUTAZIONE
Ciascun docente delle discipline sotto indicate dispone di 15 punti da distribuire su 2 quesiti mirati ad
accertare conoscenze, competenze e capacità secondo la seguente tabella di valutazione:
INDICATORI
Conoscenze
LIVELLI
Lacunose
Frammentarie ed imprecise
Sufficienti
Buone
Ampie ed esaurienti
1
2
3
4
5
PUNTEGGI
Competenze
- espressive
- applicative
- rielaborative
- di collegamento
Scarse
Mediocri
Globalmente accettabili
Discrete
Buone
1
2
3
4
5
Capacità
- di comprensione
- di analisi
- di sintesi
Molto limitate
Modeste
Accettabili
Discrete
Spiccate
0
2
3
4
5
GRIGLIA PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DELLA PROVA
Informatica
Quesiti
Conoscenze
Competenze
Capacità
TOTALE
MEDIA
Scienze integrate Fisica
n°1 n°2 n°3 n°1 n°2
n°3
Inglese
n°1 n°2 n°3 n°1
n°2 n°3
Media
Voto
VOTO
DESCRITTORE
1
Nullo
2
Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio
Scarsissima conoscenza anche degli argomenti fondamentali. Assenza di comprensione o
3
incapacità di applicazione delle conoscenze acquisite. Gravi e numerosi errori e
confusione nella comunicazione scritta e orale.
Conoscenza carente o frammentaria degli argomenti significativi, difficoltà di esposizione.
4
Comprensione limitata o difficoltà evidente nella applicazione degli argomenti
fondamentali. Numerosi errori nella comunicazione scritta e orale.
Conoscenza incompleta o superficiale, esposizione impacciata degli argomenti
5
fondamentali. Comprensione parziale con incertezze o limitata autonomia
nell’applicazione degli argomenti appresi. Errori nella comunicazione scritta e orale.
Conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali anche se esposti con qualche
6
inesattezza. Capacità di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati.
Comprensione o applicazione corretta dei contenuti fondamentali
Conoscenza abbastanza sicura degli argomenti ed esposizione chiara e corretta. Capacità
7
di cogliere le relazioni tra i contenuti trattati. Comprensione ed applicazione corretta degli
argomenti richiesti.
Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata e
8
personale. Capacità di cogliere in maniera organica le relazioni tra i contenuti trattati.
Comprensione e applicazione corretta ed autonoma degli argomenti richiesti.
Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata e
9
personale. Capacità di padroneggiare argomenti e problematiche complesse e di
organizzare le conoscenze sapendo operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari.
10 Livelli e capacità del descrittore precedente con caratteristiche di eccezionalità.
Anno scolastico 2016/2017
Materia: Inglese
Allievo:............................................................................
Simulazione terza prova
Classe 5a L LSSA
1. What is the Poet according to Wordsworth’s Preface to the Lyrical Ballads, and what is
the language that he intends to use in poetry ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2) Consider the “Rime of the Ancient Mariner”, by Samuel Taylor Coleridge. Talk about the
events narrated by the Ancient Mariner to the wedding guest up to the ship’s fatal reaching
the equator and being stopped by a tremendous dead calm.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
3) Imagination has got an important role for the Romantic poets. What are primary and
secondary imagination according to Coleridge ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Anno scolastico 2016/2017
Materia: Fisica
Allievo:............................................................................
Simulazione terza prova
Classe 5a L LSSA
1)Induzione elettromagnetica. Analizzare il fenomeno fisico, scrivere e spiegare le leggi.
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2) Flusso autoconcatenato e induttanza di un circuito.
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3) Teorema della circuitazione del campo magnetico. Conseguenze del teorema sulle proprietà
del campo magnetico.
…...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Anno scolastico 2016/2017
Materia: Scienze integrate
Allievo:....................................
1) Definisci i lipidi e spiega come possono essere classificati.
Simulazione terza prova
Classe 5a L LSSA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Definisci un amminoacido, scrivi la formula generale di un α-amminoacido, descrivi la
classificazione e la reazione che porta alla formazione delle proteine.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Descrivi in generale i fondali oceanici e in particolare le dorsali medio-oceaniche.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anno scolastico 2015/2016
Materia: Informatica
Allievo:...........................................................
Simulazione terza prova
Classe 5a L LSSA
1) Il candidato descriva l’associazione 1:1 e faccia un esempio
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2) Il candidato descriva la rappresentazione delle associazioni 1:1 nello schema logico
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
-
3) Descrivere l’operazione di join e fare un esempio.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Verso la seconda prova di matematica 2017 - Prova di verifica
VERSO LA SECONDA PROVA DI MATEMATICA 2017
PROVA DI VERIFICA
3 ore
Risolvi uno dei problemi e rispondi a tre quesiti.
Problemi
1
Facciamo il pieno Il serbatoio del carburante di una barca ha la
forma di un prisma retto avente per base un triangolo isoscele
rovesciato.
Claudio porta la sua barca a fare rifornimento, sapendo che gli
restano solo 15 L di carburante. La pompa versa 2 L di carburante
al secondo nel serbatoio.
5 dm
5 dm
13
dm
a. Scrivi la funzione h(t) che esprime l’altezza del livello del carburante in funzione del tempo e rappresentala graficamente.
b. Dopo quanto tempo il serbatoio è pieno?
c. Disegna il grafico di hl(t) .
1
d. Trova in quale istante il tasso di accrescimento dell’altezza vale 13 e determina l’altezza del livello del
carburante in tale istante.
2
La figura mostra il grafico di una funzione V ^ x h .
y
V(x)
M
O
x
a. Verifica che solo una delle seguenti funzioni può descrivere tale andamento.
y = kx3 ek - x ,
y = kx2 ek - x ,
con k ! R .
b. Individuata la funzione che rappresenta V(x), determina il valore di k in modo che M abbia ordinata 4e-1 .
c. A partire dal grafico di V(x) deduci il grafico di V l^ x h .
d. La funzione V(x) rappresenta, per x 2 0 , il volume di una scatola con base quadrata di lato che misura x
e con altezza che misura h. Le misure sono in decimetri. Determina le dimensioni della scatola di volume
massimo.
Copyright © 2017 Zanichelli editore S.p.A., Bologna
Questo file è una estensione online dei corsi di matematica di Massimo Bergamini, Graziella Barozzi e Anna Trifone
pagina 1 / 2
Verso la seconda prova di matematica 2017 - Prova di verifica
Quesiti
1
Profili architettonici La Città dello sport è una struttura sportiva
y
progettata dall’architetto Santiago Calatrava e mai completata, situa64
ta a sud di Roma. Rispetto al sistema di riferimento indicato in figura
5
(dove l’unità di misura è il decametro), il suo profilo può essere
approssimato dalla funzione:
Z ax + b
x
12
]]
cx + 3 se 0 # x # 12
f (x) = [ 1
,
] 5 2d - x se x 2 12
\
16
con a, b, c e d parametri reali. Il grafico di f (x) passa per l’origine del sistema di riferimento e f l^ 0 h = 3 .
a. Determina i parametri a, b, c, d.
b. Studia la derivabilità nel punto di ascissa x = 12 .
2
Caldo caldo! Un’azienda produce thermos con capacità di 1 L, a forma di cilindro circolare
retto. Il settore Ricerca e sviluppo dell’azienda vuole determinare il raggio di base r e l’altezza h
del thermos che permettano di minimizzare il calore disperso all’esterno. Calcola la loro lunghezza in centimetri.
3
Date le funzioni f e g, i cui grafici sono una retta e una parabola,
rappresentate in figura, calcola:
y
2 f(x)
a. D f ^ g ^ x hh ;
1
g ^x h
b. D ln
;
f ^x h
c. D 6g ^ x h@2 .
4
5
6
g(x)
–1
O
1
x
Trova per quale valore dei parametri a e b le due curve di equazioni
x+b
e
y=
y = ae2 (x - 1)
x2
sono tangenti nel punto P di ascissa 1 e scrivi l’equazione della tangente comune.
Rappresenta le due curve, per i valori di a e b trovati, e la tangente.
2x2 - x
ax3 + bx2 + 2
, trova a, b e c in modo che i loro grafici abbiano due asinDate le funzioni y = 4 - x e y =
x2 + cx
toti in comune.
Demolizioni Una sfera di metallo usata per le demolizioni si sta dilatando a causa di un
aumento della temperatura. Indichiamo con r ^ t h il suo raggio (misurato in cm) in funzione del tempo (misurato in ore) e supponiamo che la funzione r ^ t h sia derivabile per
t 2 0.
All’istante t = 1 h la superficie della sfera è 240 dm2 e il suo volume aumenta con velocità
di 480 cm3/h. Determina, in tale istante t = 1 h :
a. il raggio della sfera e la velocità con cui aumenta;
b. la velocità con cui aumenta la superficie della sfera.
Copyright © 2017 Zanichelli editore S.p.A., Bologna
Questo file è una estensione online dei corsi di matematica di Massimo Bergamini, Graziella Barozzi e Anna Trifone
pagina 2 / 2
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA
CONOSCENZA
(congruenza con la
traccia e conoscenza
degli argomenti)
COMPETENZA
(capacità di applicare al caso
specifico)
CAPACITA’
(saper rielaborare criticamente
le conoscenze, arricchirle,
incrementare le competenze
Non conosce gli
argomenti di studio
Ha conoscenze molto
lacunose
CORRETTEZZA DI
ESECUZIONE
CORRETTEZZA ED VOTO
UTILIZZO DI
TERMINOLOGIA E
SIMBOLOGIA
CORRETTA
1-3
Non compie operazioni logiche
Non sa individuare i concetti Esecuzione incompleta
Non conosce e non
con le conoscenze acquisite e
chiave e non sa collegarli
usa i simboli e la
non le sa applicare
terminologia specifica
Conosce i temi trattati Non autonomo; sa applicare le Sa individuare i concetti chiave Esecuzione imprecisa
Conosce ed usa i
in maniera
conoscenze solo parzialmente
e li collega anche se con
simboli e la
frammentaria e
qualche difficoltà
terminologia specifica
approssimativa
in modo incerto
Conosce solo gli
Sa applicare le conoscenze
Sa analizzare alcuni aspetti
Esecuzione completa
Conosce ed usa i
elementi di base della
alcune completamente altre
significativi e sa individuare i
simboli e la
disciplina
parzialmente
concetti fondamentali e stabilire
terminologia specifica
semplici collegamenti
sufficientemente
Conosce gli argomenti Sa applicare in modo autonomo
Sa analizzare alcuni aspetti
Esecuzione chiara e
Conosce ed usa i
in maniera completa
e adeguato
significativi e rielaborare in
corretta
simboli e la
modo corretto solo in situazioni
terminologia specifica
semplici
Possiede conoscenze
Sa utilizzare le conoscenze in
Sa analizzare e individuare i
Esecuzione corretta e
Conosce ed usa i
complete ed
modo autonomo ed adeguato
concetti chiave e stabilire
precisa
simboli e la
approfondite
anche in situazioni complesse efficaci collegamenti; rielabora
terminologia specifica
le conoscenze anche in
adeguatamente
situazioni complesse
Possiede conoscenze Sa applicare in modo autonomo,
Sa analizzare i vari aspetti
Esecuzione corretta
Conosce ed usa i
complete ed
personale ed efficace in
significativi ed approfondisce precisa in ogni sua fase
simboli e la
approfondite
situazioni complesse
adeguatamente con apporto di
terminologia specifica
idee nuove ed originali; sa
adeguatamente e con
individuare i concetti chiave e
competenza
stabilire efficaci collegamenti
1
4
5
6
7
8
9 - 10
ISTITUTO______________________________________CLASSE 5 sez. _______Candidato:______________________________Data: 01/04/2017
Griglia di valutazione
Sezione A: problema
INDICATORI
LIVELLO
L1
Comprendere
DESCRITTORI
Punti
Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non riuscendo a
riconoscere concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone
individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli opportuni
collegamenti tra le informazioni e utilizza
codici matematici in maniera
insufficiente e/o con gravi errori.
i
i
Analizzare la situazione
problematica, identificare dati,
interpretarli e formalizzarli in
linguaggio matematico.
i
L2
L3
L4
Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo
alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati
tutti, commette qualche errore
nell’interpretarne alcuni, nello stabilire
collegamenti e/o nell’utilizzare codici matematici.
Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando
correttamente concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra queste riconoscendo ed
ignorando gli eventuali distrattori; utilizza con adeguata padronanza codici matematici
grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o errori.
i
i
i
i
L1
Mettere in campo strategie
risolutive attraverso una
L2
modellizzazione del problema e
individuare la strategia più
adatta.
L3
L4
5-9
10-15
i
Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente
concetti chiave, le
informazioni essenziali e le relazioni tra queste, ignorando gli eventuali distrattori;
utilizza codici matematici grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.
Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in grado di
individuare modelli standard pertinenti. Non si coglie alcuno spunto creativo
nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua glistrumenti formali
opportuni.
i
Individuare
0-4
Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco coerente; ed
usa con una certa difficoltà modelli noti. Dimostra una scarsa creatività nell'impostare le
varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore gli strumenti formali
opportuni.
i
Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed
efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed possibili modelli trattati in
classe e li utilizza in modo adeguato. Individua gli strumenti di lavoro formali opportuni
anche se con qualche incertezza.
i
Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. Individua
strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore modelli noti e ne
propone di nuovi. Dimostra originalità e creatività nell'impostare le varie fasi di lavoro.
Individua con cura e precisione le procedure ottimali e non standard
i
16-18
0-4
5-10
11-16
17-21
.
L1
Sviluppare il processo
risolutivo
L2
Risolvere la situazione
problematica in maniera coerente,
completa e corretta, applicando le
regole ed eseguendo calcoli
necessari.
L3
i
L4
Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il
processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di
utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi errori nei
calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con il contesto del problema.
Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa il
processo risolutivo in modo incompleto.
Non sempre è in grado di utilizzare
procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmente corretto e/o con
numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in parte con il
contesto del problema.
Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa il
processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o
regole e li applica quasi sempre in modo corretto e appropriato. Commette
qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è
generalmente coerente con il
contesto del problema.
Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di modelli
e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo,
chiaro e corretto. Applica procedure e/o teoremi o regole in modo corretto e appropriato,
con abilità e con spunti di originalità. Esegue calcoli in modo accurato, la soluzione è
ragionevole e coerente con il contesto del problema.
i
Argomentare
Commentare e giustificare
opportunamente la scelta della
strategia applicata, passaggi
fondamentali del processo
esecutivo e la coerenza dei
risultati.
i
L1
L2
L3
L4
Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la
fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto
impreciso.
Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la
strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio matematico per
lo più appropriato, ma non sempre rigoroso.
Argomenta in modo coerente ma incompletola procedura esecutiva e la fase di
verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa). Utilizza
un linguaggio matematico pertinente ma con qualche incertezza.
Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto
le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima padronanza
nell’utilizzo del linguaggio scientifico.
0-4
5-10
11-16
17-21
0-2
3-4
5-7
8-10
Tot
Problemi
P1 P2
ISTITUTO________________________________________CLASSE 5 sez. I Candidato:____________________________________Data:
01/04/2017
Sezione B: quesiti
Quesiti
(Valore massimo attribuibile 80/150 = 20x4)
CRITERI
Q1 Q2 Q3
COMPRENSIONE e CONOSCENZA
Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
(0- (0- (0-4 (0-4 (0- (04) 4)
4) 4)
Comprensione della richiesta.
Conoscenza dei contenuti matematici.
ABILITA' LOGICHE e RISOLUTIVE
(0- 0-7) 0-7) 0-7) 0-7) 0-7)
7)
Abilità di analisi.
Uso di linguaggio appropriato.
Scelta di strategie risolutive adeguate.
CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO
(0- 0-7) 0-7) 0-7) 0-7) 0-7)
7)
Correttezza nei calcoli.
Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure anche
grafiche.
ARGOMENTAZIONE
(0- (0- (0- (0- (0- (0-2
2) 2) 2) 2) 2)
Giustificazione e Commento delle scelte effettuate.
Punteggio totale quesiti
Calcolo del punteggio Totale
PUNTEGGIO SEZIONE A
PUNTEGGIO SEZIONE B
PUNTEGGIO TOTALE
(PROBLEMA)
(QUESITI)
(SEZIONE A + SEZIONE B)
Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi
Punti
0-4
Voto
1
5-10 11-18 19-26 27-34
2
3
4
5
35- 44-53 54-63 64-74 75-85
43
6
7
8
9
10
Voto assegnato ____ /15
86-97
11
98109
12
Il docente
110-123 124-137 138-150
13
14
15
TERZA PROVA SCRITTA
(Tipologia B: n. 12 quesiti a risposta breve, per un massimo di 10 righe, tempo 2 ore)
GRIGLIA PER LA CORREZIONE E LA VALUTAZIONE
Ciascun docente delle discipline sotto indicate dispone di 15 punti da distribuire su 2 quesiti mirati ad
accertare conoscenze, competenze e capacità secondo la seguente tabella di valutazione:
INDICATORI
Conoscenze
LIVELLI
Lacunose
Frammentarie ed imprecise
Sufficienti
Buone
Ampie ed esaurienti
1
2
3
4
5
PUNTEGGI
Competenze
- espressive
- applicative
- rielaborative
- di collegamento
Scarse
Mediocri
Globalmente accettabili
Discrete
Buone
1
2
3
4
5
Capacità
- di comprensione
- di analisi
- di sintesi
Molto limitate
Modeste
Accettabili
Discrete
Spiccate
0
2
3
4
5
GRIGLIA PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DELLA PROVA
Informatica
Quesiti
Conoscenze
Competenze
Capacità
TOTALE
MEDIA
Scienze integrate Fisica
n°1 n°2 n°3 n°1 n°2
n°3
Inglese
n°1 n°2 n°3 n°1
n°2 n°3
Media
Voto