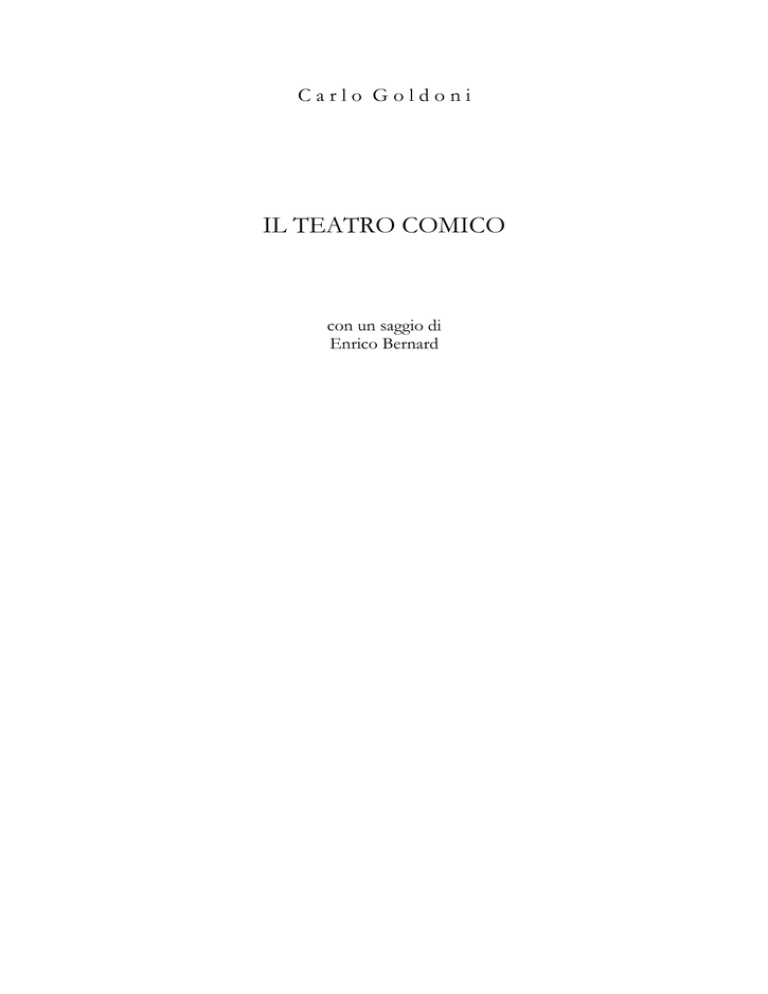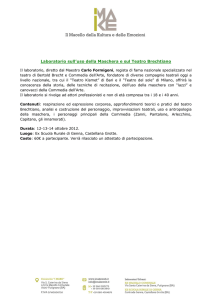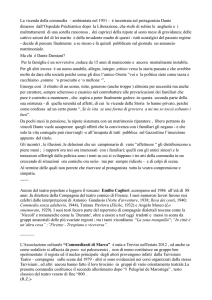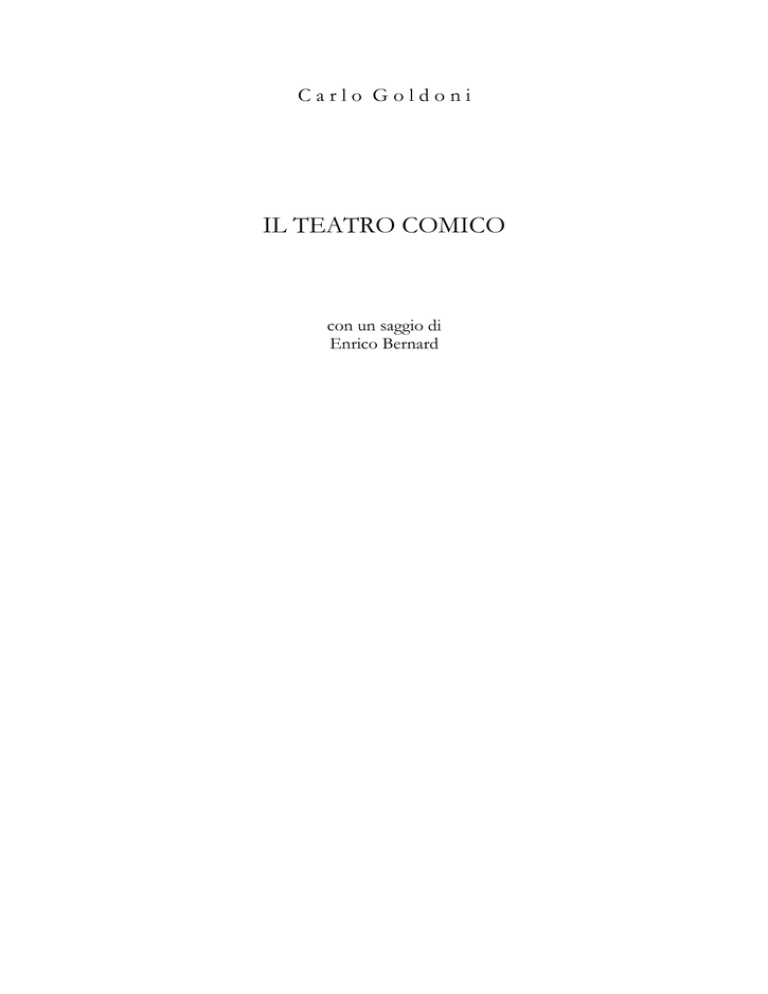
Carlo Goldoni
IL TEATRO COMICO
con un saggio di
Enrico Bernard
TEATRO, LINGUA, LETTERATURA
di Enrico Bernard
Fra qualche decennio la lingua italiana compirà un millennio di vita. Com'è noto
diversi fattori hanno contribuito alla formazione del "volgare" prima, e del "dolce stil
novo" verso la fine del XII secolo e, tra questi, il teatro ha indubbiamente rivestito un
ruolo importante. In particolare mi riferisco alla trasformazione delle Sacre
rappresentazioni tardomedievali nelle laudi teatrali del '200: processo culturale,
spettacolare, e linguistico stimolato dalla necessità di rendere comprensibile, con l'uso del
"volgare", che sostituisce il latino, il contenuto morale e religioso delle sacre
rappresentazioni.
"Perché un autentico dramma sia possibile, è necessario che il latino della liturgia faccia luogo
ad una lingua magari rozza ed elementare ma più in grado di aderire al reale... Sicché l'avvento del
dramma in volgare si delinea come fatto inevitabile e necessario" (Agostino Lombardo, "Storia del
Teatro", Eri edizioni Rai, Torino 1962 pp. 50-51).
Il testo drammaturgico ha dunque una certa importanza non solo nella
formazione del "volgare", ma anche nel processo di affinamento quale lingua "dolce" e
nell'evoluzione della letteratura nazionale. L'italianista Eugenio Ragni, al quale ho
sottoposto queste mie osservazioni preliminari, mi scrive:
"La diffusione del volgare NON letterario (da cui poi deriverà quello letterario) presso un
pubblico che lo parlava quotidianamente, ebbe come veicolo primario una serie di fattori eminentemente
teatrali, che vanno appunto dalle sacre rappresentazioni “volgarizzate” ai Cantari, cioè all’opera
benemerita dei cantastorie che andavano nelle piazze nelle giornate di mercato e non solo diffondevano il
volgare, ma le storie bibliche, gli eroi delle saghe classiche (Enea, Ulisse, le storie “de Troia e de Roma”,
quelle dei cavalieri della Tavola Rotonda, ecc.): il tutto “teatralizzando” la materia non soltanto con la
recitazione delle battute versificate, ma soprattutto con cartelloni su cui erano disegnate le scene relative al
racconto che andava narrando. Senza dire che lo facevano su un palco più o meno grande, ma pur sempre
un palco, anche se ancora poco scenico." (Lettera ad Enrico Bernard del 22 maggio 2009).
Sottolineo con particolare enfasi - data la mia militanza teatrale - questo merito
della drammaturgia italiana che pure fornisce a Dante molti elementi dell'impalcatura
della "Divina Commedia" che innegabilmente presenta una struttura teatrale, "modificata precisa Ragni - ma non estranea a quella delle sacre rappresentazioni".
Va anche detto che l'intuizione della valenza teatrale del poema dantesco non è
mia e non è neppure nuova. E' di Niccolò Machiavelli che nel "Dialogo intorno alla lingua"
(Dialogo, si noti bene, più che discorso) del 1515 cioè pochi mesi prima di iniziare la
stesura de "La mandragola", scrive:
"Ma perché io voglio parlare un poco con Dante, per fuggire "egli disse" ed "io risposi", noterò
gl'interlocutori davanti."
Così Machiavelli imposta un vero e proprio dialogo teatrale sull'origine del "dolce
stil novo". La questione strettamente linguistica (e la polemica di Machiavelli con Dante
sull'origine del dolce stil novo con relativa accusa di "plagio") non è in discussione: qui
infatti sto "solo" cercan-do la radice teatrale della letteratura italiana. E mi par bene che
l'autore del Principe colga appieno la struttura drammaturgica della "Divina Commedia"
sottolineando quel "Egli disse ed io risposi" che sostituisce teatralmente con gl'intelocutori a
recitar battute per meglio comprendere i termini della questione. Luigi Blasucci (in "La
letteratura italiana" vol. 6, pag. 76, Milano 2005) commenta il passo del "Discorso":
"Sottolineiamo quel 'un poco', che è la spia più significativa della metamorfosi concettopersonaggio. Il dialogo che segue non è affatto un espediente didascalico, come si può ritrovare in tanti
trattatisti del tempo, ma ha i caratteri di un vero colloquio tra persone vive".
L'intuizione di Machiavelli ha naturalmente stimolato un'analisi approfondita,
non solo della teatralità di Dante - su cui molto si è scritto, - ma anche sul rapporto di
Dante col teatro del suo tempo. Su questo tema specifico si è espressa un'ampia
letteratura critica ("Dante e il teatro" è ad esempio il titolo di una conferenza del 7
febbraio 2006 di Pier Mario Vescovo dell'Università di Venezia Ca' Foscari incentrato
sulle messe in scena del divino poema) che qui non posso che esemplificare con una
citazione delle fonti a cui attinge Dante stesso.
Mi riferisco ad una delle Laudi delle Sacre rappresentazioni Umbre dell'inizio del
XIII secolo: "La discesa di Cristo all'Inferno": un testo drammaturgico complesso che
tematicamente, figurativamente, metaforicamente e linguisticamente non può non
rientrare nel back ground culturale di Dante.
L'INFERNO, A Cristo:
Chi se' tu, che me descioglie
Quil che, 'l mortal peccato lega?
Chi se' tu, che 'l Limbo spoglie.
Enverso te ciascun sì priega?
Chi se' tu, tal combattetore,
Ch'hai vinto el nostro gran furore?
Chi se' tu, che tanta luce
Daie a quiste scure parte?
Chi se' tu, che mo' conduce
sopra de noi aie tal carte?
La breve citazione bene illustra come in questa "Discesa di Cristo all'Inferno" in
qualità di "estraneo" vi sia teatralmente già l'essenza drammatica della "Divina Com-media"
che quindi è commedia dialogata (come asserisce Machiavelli) sulla base della grande
spiritualità e forza immaginativa espressa dal teatro tardomedievale. Tema, questo del
rapporto tra Dante e il teatro medievale, già trattato comunque dagli studi di Mario
Manlio Rossi ("Il lato drammatico della Divina Commedia" in Atti dell'Istituto Veneto di
Scienze, tomo CXXI, 1962-63, pp. 391-441), di Umberto Bosco ("Dante e il teatro
medievale" in Studi filologici e letterari, Padova, Antenore, 1977 vol. I pp. 135-147)
nonche' di Rino Mele in "Nel giallo della rosa sempiterna, sulla teatralità di Dante" (2006),
nonché da Paolo De Ventura in "Dramma e dialogo nella Commedia di Dante" .
Chiamo in causa la bibliografia poiché un saggio in particolare mi ha incuriosito
per la sua apertura all'attualità, che è il punto cui voglio arrivare in breve. Mi riferisco allo
studio di Peter Armour dal significativo titolo "Comedy and the Origins of Italian Theatre
around the time of Dante" che sta incluso in "Writers and Performers in Italian Drama from the
time of Dante to Pirandello" (The Edwin Mellen Press, 1991, pp. 1-32). In qualche modo
ecco che la teatralità di Dante si pre-senta come un argomento che, al di là dell'interesse
filolo-gico, interviene nella questione della grande drammaturgia italiana il cui filo rosso è
tracciabile attraverso Machiavelli-Goldoni-Pirandello-Eduardo. E per rafforzare la tesi
della teatralità della letteratura, narrativa e poesia, aggiungo Petrarca, che in qualche
forma di sintonia con la "Divina commedia", in cui sono protagonisti Dante e Virgilio,
affida ad un corposo testo teatrale "Il segreto" (Secretum, 1342-43) il suo incontro filosofico,
teologico ed esistenziale con Sant'Ago-stino. Del resto "Il Canzoniere" stesso non è anche
un ideale dialogo con Laura?
Nonostante ciò, il teatro non è più oggetto principe della critica letteraria. Un
rammarico mi accomuna ad altri studiosi e appassionati di drammaturgia come ad
esempio Domenico Pietropaolo che lamenta:
"Purtroppo la disciplina degli studi teatrali fa ancora molta fatica a conquistarsi lo statuto di
autonomia scientifica ed istituzionale che ad essa compete, vedendosi costretta nella maggior parte delle
nostre università a farsi spazio all'interno di rigide strutture concepite per lo studio della letteratura".
(D. Pietropaolo, "Regia e Filologia negli studi teatrali" incluso in p. 1492)
Il discorso di Pietropaolo sulla doppia natura, lette-raria e scenica, del testo
teatrale, può essere a sua volta ampliato sul tema della tetralità del testo letterario. E va da
sé, in quest'ottica, un accenno all'unidimensionalità della critica letteraria che, confinando
spesso e volentieri il testo teatrale in una una nicchia, trascura di fatto l'essenza drammaturgica della letteratura non destinata immediatamente alla rappresentazione.
Di questa trascuratezza si fa ad esempio portavoce un personaggio di Eduardo, il
Capocomico Campese, che ne "L'Arte della commedia" sostiene di sentirsi "escluso" dalla
vita civile e non solo culturale del Paese in quanto, appunto, uomo di teatro. Esclusione
che, alla luce di quanto detto - ossia che il teatro è il motore da cui scaturiscono la lingua
e la letteratura nazionale, compreso il divino poema dantesco - è causa di una lacuna
nella cultura italiana.
La questione della nascita della letteratura e della poesia come forme di
rappresentazione (orale, scenica ecc.) permette di ampliare il discorso di Pietropaolo,
circa la ne-cessità di una analisi non solo letteraria e testuale dell'opera drammatica, ma
pure come forma per la scena, proponendo una piccola rivoluzione copernica: si può
leggere in chiave teatrale un poema o un romanzo? La risposta a questa domanda sarà come vedremo - che la letteratura è di per sé una forma di rappresentazione teatrale. Un
fare teatro con un "medium" diverso: la pagina stampata e rilegata al posto del
palcoscenico o della parola recitata.
Molti dei romanzieri italiani del '900 si sono cimentati col teatro raggiungendo
risultati importanti come Pasolini, Sciascia e Savinio, di buon livello drammaturgico come
Moravia e Bernari, o di non eccelso valore come Za-vattini, Umberto Eco e Camilleri o
più scarsi come Corrado Augias e Claudio Magris. In questi casi tuttavia abbiamo a che
fare sempre con narratori che una, due o tre tantum hanno tentato la drammaturgia come
percorso alternativo, cioé come una forma di "toccata e fuga" in un mondo estraneo alla
propria ispirazione.
Più interessanti sono invece quei fenomeni in cui il narratore si è fuso col
drammaturgo: penso a Pirandello ed Eduardo. Anche qui già mi sento obbiettare: ehi,
passi per Pirandello il cui corpus di opere anche narrative è attraver-ato dalla "forma
drammatica" e viceversa. Ma che c'entra Eduardo che non si mai cimentato nella
narrativa?
Rispondo osservando che la drammaturgia così for-temente teatrale - mi si
conceda il pleonasmo - di Eduardo rimanda ad una forma di romanzo nel teatro,
proprio così come la "Commedia" di Dante è una rappresentazione lirica nell'ambito di
una metafora teatrale. Mario Mignone nel suo saggio su Eduardo (Twayne Publishers,
Boston 1984) indica la presenza di una prima forma neorealista letteraria in "Natale in
casa Cupiello" del 1932. Ma c'è anche il fatto che la stessa forma stliistica delle opere di
Eduardo allude, per esempio nelle didascalie, ad una letterarietà che va oltre la semplice
indicazione per la scena.
L'incipit de "L'arte della commedia" è in questo senso illuminante:
"Fa freddo. Lungo il cortile della Prefettura, ancora immerso nella caligine livida di un' alba
invernale, si intravvede come in un barlume la sagoma di un uomo in età avanzata che cammina avanti e
indietro, battendo il passo e tutto raggomitolato in se stesso per difendersi dal freddo. Di tanto in tanto si
ferma per guardare ansiosamente verso i piani superiori del palazzo, nella speranza che qualcuno si
accorga di lui e metta fine a quella lunga attesa. Non si affaccia nessuno, non una sola testa spunta dai
finestroni, non appare anima viva...
Oreste Campese, tale è il nome del personaggio, è un uomo di circa cinquantacinque anni. Veste abiti
modesti e lisi ma puliti e in ordine. Ha il viso segnato dagli stenti di una vita miserabile, gli occhi però
sono dolcissimi e ancora pieni di speranze. Tanto per ingannare il tempo, introduce la mano infreddolita
in una tasca del vecchio cappotto, fruga e tira fuori una misera borsa di pegamoide giallo, da cui estrae la
pipa e qualche pizzico di tabacco ridotto a polvere dal fred· do secco. Caricata la pipa, si mette a cercare i
fiammiferi e ne trova uno sperduto in un'altra tasca. L'accende stru· sciandolo sotto la scarpa. Due o tre
boccate l'aiutano a darsi l'illusione di poter ancora resistere nell'attesa. Riprende a camminare con
rinnovata energia, contando a uno a uno i passi che muove.
Come si fa, in questo caso, a non parlare di narrativa - anche se siamo alle prese
con un'opera teatrale? Il confine tra i generi è come si vede sottilissimo, e il trapasso
dall'uno all'altra, dal teatro alla narrativa - ossia due generi che hanno il dialogo come
base comune- , non solo dovrebbe risultare automatico, ma intrinseco all'opera stessa.
Poco importa che Dante usi l' "egli disse ed io risposi" al posto della struttura teatrale del
personaggio dialogante: come dice Machiavelli nel "Dialogo" sempre... dialogo è, dunque
teatro. Teatro che è, da sempre, la radice quadrata di ogni forma di espressione artistica
dell'uomo, pittura, canto e danza inclusi. Ad esempio, è proprio nella "teatralità" che
Dante e Giotto trovano e sviluppano, influenzandosi a vicenda, un terreno comune sulla
base della rappresentazione e della "messa in scena" delle vicende umane.
Ma tornando alla modernità, il ragionamento mi porta a dire che Pirandello è
"narratore" quando fa teatro e, al contempo, è drammaturgo quando scrive prosa,
proprio come accade ad Eduardo che è un drammaturgo-narratore per eccellenza.
Nessuno del resto pensa che Eduardo avrebbe avuto la benché minima difficoltà a
scrivere una novella o un romanzo anziché una commedia sull'idea di "Natale"!
Naturalmente non voglio sostenere la tesi estrema che non vi siano differenze
sostanziali tra narrativa e drammaturgia. Il romanzo (e la sceneggiatura, che a sua volta
rappresenta una forma di prolungamento del teatro con altri mezzi) sottostanno a regole
meno rigide rispetto al teatro, ovvero consentono rapidi passaggi di scena, salti temporali
e di luogo, digressioni eccetera, tutti meccanismi insomma che il testo teatrale nato per
la scena può supportare con minor elasticità. Tanto per fare un esempio, il romanzo
solitamente fornisce una serie di dettagli descrittivi che in una commedia, recitati,
sarebbero mortali di noia Ma, ciò nonostante, non è sbagliato attribuire una
drammaturgia ad un romanzo, - oppure una struttura narrativa ad un testo per la scena:
un romanzo può e deve essere tanto drammatico (e drammaturgico) quanto un dramma
od una commedia non possono sottrarsi a regole narrative affini al romanzo: e mi
riferisco alla suspence, la sorpresa, la struttura del "plot" narrativo.
Richiamo l'attenzione anche su una forma di letteratura che è identica ad un
genere drammatico: il monologo. L'intero corpus dell'Ulisse di Joyce è fondato sul
monologo interiore che ha - ovviamente - equivalente scespiariano nel mologo di
Amleto, per fare un esempio semplice. E la tradizione letteraria del monologo interiore
ha avuto nella narrativa italiana una grande e ancor oggi vivissima suggestione e
tradizione.
Di fronte ad un monologo, come si fa dunque a dire se siamo nel campo della
letteratura o in quello teatrale?
Certamente, pochi narratori italiani riescono a tradurre la propria forza
espressiva nell'atto teatrale immediato, così come pochi drammaturghi sono in grado di
tradurre in prosa la lora capacità drammaturgica. Ma ciò non deve distogliere l'attenzione
dal fatto che invece, spesso e volentieri dell'ottimo teatro si fa in prosa e che, altrettanto
spesso la narrativa stessa è una forma teatrale "in essere". Questo perché l'atto originario
creativo è la "Rappresent-Azione", cioé la riproduzione, ripetizione e imitazione di
un'azione per scopi dapprima sacrali e poi ludici.
All'inizio dicevo che la letteratura e la lingua italiane hanno genesi dal teatro delle
sacre rappresentazioni e delle laudi sacre e profane dell'XI, XII e XIII secolo. La
domanda che bisogna ora porsi è se sia possibile forzare ancor di più questa
affermazione sostenendo che in queste forme di teatro viene a costituirsi il genere
romanzesco stesso, - non solo italiano, dato che queste "forme" teatrali sono comuni al
resto d'Europa. Quello che infatti colpisce scorrendo i testi della Sacre Rappresentazioni
e delle Laudi è il piano narrativo che si sovrappone al cosiddetto "recitativo". I
personaggi infatti non sono soltanto nominati all'inizio delle battute come coloro che
parlano, ma ne è evidenziata anche l'azione (come in Dante, si noti bene) che non è solo
didascalica, ma anche appunto narrativa: dice uno di quelli poveri, dice il cavaliere, un altro povero
dice, risponde il povero, la Madre bacia le piaghe del figliolo e dice così, Ora si suona e balla e Uno dice
questa stanza in sul suono... ecc.
Questa caratteristica narrativa del teatro sacro si concentra e si sviluppa in un
nucleo di testi tardomedievali ("La storia del Re superbo", "La rappresentazione di Santa Uliva"
ed altri) che formano la tradizione del Teatro Sacro Ro-manzesco. Scrive Mario
Bonfantini (in "Le sacre rappre-sentazioni italiane", Bompiani, Milano, 1942, p. 619)
"Anche il metro dell'ottava, che domina ovunque, ed era tipicamente narrativo e proprio dei
poemi romanzeschi, è indizio significativo... Chiamiamo più propriamente "romanzesco" quel tipo di
Sacra Rappresentanzione nel quale l'elemento profano ormai predomina: perché il miracoloso è quasi
completamente trapassato in meraviglioso, e l'interesse per gli strani casi dei protagonisti e per le trovate
sceniche viene a soffocare quasi del tutto lo scopo edificante del dramma".
E' nella natura stessa dei testi drammatici dell'XI, XII e XIII secolo essere
destinati alla lettura più che alla rappresentazione - così come da secoli erano destinate
esclu-sivamente alla lettura, non alla recitazione, commedie e tragedie del teatro latino
classico. Il che comporta, come sostiene Agostino Lombardo (cit. p. 54) che essi "appartengono alla letteratura, non al teatro".
Ecco dunque che tutto parte e torna al teatro, come appunto Pirandello che - sia
in prosa che in drammaturgia - opera sempre all'interno di uno stesso percorso narrativo.
Ripetendomi: egli è infatti narratore quando scrive teatro ed è, al contempo,
drammaturgo quando fa prosa. Potrei insi-stere con qualche esempio sulla congenita
"teatralità" d'ogni prodotto pirandelliano, portando ad esempio una novella in paragone
con la commedia che Pirandello ne ha tratto in séguito: tutta la narrativa di Pirandello è
peraltro un dialogo diretto fra personaggi raccontati: e infatti ha fatto quasi sempre
pochissima fatica a trasferire in commedia quello che aveva concepito e pubblicato
inizialmente come scritto narrativo.
S'intende che Pirandello è un caso praticamente uni-co se non eccezionale di
Giano bifronte, cioè un grande romanziere che è nel contempo anche un grande
dramma-turgo. Ma il trucco c'è e sta nel teatro che l'Agrigentino ha nelle vene, sangue
che costituisce l'essenza "drammatica" della sua opera complessiva. Con questo voglio
dire che in Pirandello non avviene mai un passaggio netto da un genere all'altro, dal
teatro alla narrativa, poiché egli resta sempre e comunque fedele al proprio DNA
drammaturgico.
Ecco allora i casi (numerosi) di narratori che, cambiando genere e tentando la
strada del palcoscenico ra-ramente danno vita a frutti sostanziosi drammaturgicamente
parlando. Certo, Pasolini scrive teatro interessantissimo, ma, se non fosse per la narrativa,
per la poesia e il cinema, al "vero" Pasolini che conosciamo mancherebbe qualcosa.
Parimenti l'opera teatrale di Sciascia ("L'onorevole") - sia pur molto valida - passa in
secondo piano rispetto alla sua narrativa. Questo perché Pasolini e Sciascia sono
dramma-turghi (nel senso completo e classico del termine) non tanto quando scrivono
per il teatro, bensì soprattutto quando scrivono teatro nella forma a loro congeniale, la
prosa. Prosa che, come ho cercato di dimostrare, è una forma di pro-lungamento del
dramma, un prolungamento che muta forma ma non la sostanza teatrale.
Tralasciando d'Annunzio, notevole poeta ma dram-maturgo discutibile (è un caso
opposto a Pirandello: continua a far poesia spesso retorica - anche quando si cimenta nel
teatro), non posso non fare retromarcia e parlare in breve di un "caso" teatrale della
letteratura italiana: Italo Svevo. "La rigenerazione", "Con la penna d'oro" e gli altri suoi
drammi sono capolavori del teatro italiano del '900, e solo la morte improvvisa in un
incidente automobilistico ha probabilmente impedito a Svevo di rappresentare un'alternativa validissima allo scrittore Agrigentino, cui sette anni dopo, nel 1934, andrà il Nobel.
Ma è stata mai condotta a tutt'oggi un'analisi critica seria del rapporto fra il teatro e la
narrativa di Italo Svevo? Ha scritto Odoardo Bertani:
"Povero invece è tutt'ora il lavoro critico sull'opera teatrale di Svevo... accenni alla produzione
drammaturgica si trovano in molti - ma non in tutti - gli studi dedicati allo scrittore triestino,
mantenendosi una separazione di ben relativa plausibilità tra i due campi, quasi che l'autore avesse un
doppio e non comunicante cervello creativo". (Odoardo Bertani in Italo Svevo, Teatro, Garzanti
Milano 1986, p. LXIV).
Va da sé che per Svevo vale il discorso fatto per Pirandello a proposito della
capacità drammaturgica innata di inserire il dramma nel romanzo e la prosa nel dramma,
quasi come se - e Bertani lo nota bene - il cervello creativo dell'autore funzionasse sulla
base di una struttura teatrale comune a tutti i generi letterari. Quello che voglio dire è che
in Svevo e in Pirandello è il teatro a smuovere tutta la forza creativa: e quanto più si ha
nelle vene il dialogo, l'essenza del dramma, appunto il teatro, tanto più si è forti narratori.
Anche per la generazione immediatamente succes-siva a Svevo e Pirandello,
quegli autori che in parte ho citato prima (Betti, Pasolini, Sciascia, Savinio, Zavattini,
Moravia, Bernari, Tullio Pinelli e - last but not least - Vincenzo Cerami) la teatralità, la
coscienza del dramma come essenza del racconto, permettono il raggiungimento di
traguardi espressivi non solo (Betti) e non tanto (gli altri) nel teatro stesso, ma
addirittura nell'opera narrativa tutta. Con questo voglio dire che al di là della produzione
drammaturgica in senso stretto (in qualche caso non rilevantissima), questi autori sono
stati drammaturghi (e sceneggiatori, il che significa molto) realizzando opere letterarie il
cui rapporto col teatro - di importanza fondamentale e sulla cui esisten-za non ci sono
dubbi - è e resta da approfondire. Del resto, il fatto che autori teatrali contemporanei
come Dario Fo (il cui teatro assume spesso la forma della narrazione) o di Celestini,
Baliani, Paolini (la cui drammaturgia è sempre affine ad una forma narrativa, tanto che le
loro opere sono anche dei veri e propri racconti) è un ulteriore colpo alla separazione dei
generi e alla riduzione del teatro e della drammaturgia al semplice evento scenico, privo
di valenza letteraria.
Il caso di un autore teatrale affermato come Giuseppe Manfridi, che dopo aver
realizzato una trentina di drammi rappresentati nei principali teatri europei sta per
pubblicare il suo quarto romanzo, è oltremodo esemplare. Manfridi ha infatti nella
letterarietà del proprio teatro un punto di forza: il suo è un teatro non solo di parola, ma
anche un teatro di vere e proprie strutture narrative fondate sugli elementi che teatro e
romanzo hanno in comune: cioé il dialogo e il senso della tragedia. Naturalmente quando
Manfridi passa alla narrativa e si cimenta col romanzo non fa un salto in un genere
nuovo, si tratta sempre sponta-neamente - automaticamente, ecco il pregio della sua
narrati-va - di fare teatro abolendo la funzione rappresentativa del palcoscenico "fisico"
per alzare il sipario su un altro palco-scenico: quello mentale di chi legge. Tuttavia, le
differenze tra i due palcoscenici, quello delle tavole teatrali e quello della mente del
lettore,- ed è questa la forza della dimostrazione di Manfridi che così si iscrive sulla scia
pirandelliana - sono minime. Il risultato infatti, sia che la parola venga detta da un attore
o che venga letta da un lettore, è sempre quello della RappresentAzione drammatica: cioè,
nella mia definizione, di una rielaborazione della realtà attraverso lo strumento della
dialettica, il dialogo. Dialogo che, fin da Platone che lo presecelse come strumento ideale
di analisi critica della realtà e della ricerca del vero e del senso dell'umana tragedia, è
indispensabile all'esercizio della dialettica, che è il fondamento da cui scaturisce il
pensiero filosofico come ricerca del vero.
Ma non fu Eschilo, e dunque ancora una volta, il Teatro ad inventare il dialogo?
Un grande poeta contemporaneo, Antonio Porta, ha scritto:
"Il senso del tragico è alla base di ogni mia possibilità di operazione poetica." (A. Porta su
«Marcatré» 1 gennaio 1964 in un intervento sul Grado Zero della poesia)
In conclusione, il pensiero di Porta sulla natura tea-trale e tragica della sua
poesia può essere esteso ai diversi generi ed epoche della letteratura italiana: il senso del
tragico è alla base di ogni possibilità di operazione poetica.
2 - GOLDONI E LA TRADIZIONE TEATRALE ITALIANA
Goldoni rappresenta il passaggio della drammaturgia italiana dall'epoca moderna
a quella contemporanea. Solo della drammaturgia, oppure anche della letteratura, quindi
della narrativa? Naturalmente l'opera di Goldoni viene presa in considerazione dalla
critica letteraria per la questione della lingua e del dialetto, nonché per l'importanza della
riforma goldoniana - il passaggio dalla Commedia dell'Arte alla Commedia dei Caratteri nell'ambito della formazione di un'idea di "realismo" di cui si avvantaggerà la narrativa
ita-liana da Manzoni, Verga e Pirandello a Moravia e Bernari. Tuttavia il ruolo della
drammaturgia goldoniana, nell'ambito della formazione della letteratura nazionale dal
XIX al XX, secolo è stato ridotto ai minimi termini proprio a causa della teatralità, che
talvolta il critico letterario giudica più come un difetto che come un valore aggiunto.
La verità è invece che non ci sarebbe una letteratura nazionale moderna se non
ci fosse stato il teatro di Goldoni: non sono io a sostenerlo, ma Pirandello che lamenta la
riduzione ai minimi termini del significato storico dell'opera goldoniana, nel quadro della
letteratura italiana. Ecco cosa scive Pirandello:
"Pensate che finanche Goldoni, che oggi a noi sembra quanto di più semplice e accessibile si possa
immaginare; il cui stile ci sembra così schietto e aderente alla realtà dei suoi personaggi tolti proprio di
peso dalla vita del suo tempo; finanche il Goldoni, neppure ai suoi tempi, fu riconosciuto. E quante gliene
dissero! Che scriveva male, subito, e glielo dissero tutti, anche quelli che pur con le debite riserve
accettavano il suo teatro e lo assecondavano. Avevano l'aria di dirgli: «Sì, hai ragione tu; coloro che ti
danno la croce addosso non capiscono niente, ma se tu sapessi scrivere un po' meglio!». E questo è
naturale, se si pensa che lo spirito attua le sue costruzioni sempre con grande e lento travaglio e che ogni
volta che è riuscito a stabilirne una, prova il bisogno di riposarsi per un po'. Si aprono in tal modo, dopo
il riconoscimento d'ogni espressione originale, certi periodi in cui gli spiriti non creano più veramente, ma
si danno alle piccole scoperte del lumeggiare le pieghe della visione della vita che consiste in quel momento,
sicché tutto ne resta impregnato e si viene a costituire, oltre a un poderoso bagaglio di frasi fatte che hanno
senso per tutti in quel momento e non ne avranno più alcuno forse dopo l'avvento d'una espressione
nuova, originale; si viene a costituire, dicevo, un mondo assolutamente determinato forse più che dal
concepire, dall'esprimere, che non è proprio uguale per tutti, naturalmente, ma che è improntato per tutti
dalle stesse caratteristiche. Prendete le lettere degli uomini d'un tempo, anonimi nel senso che non si
chiamarono né Dante né Shakespeare, e potrete riconoscere senza riandare alla data, quelle scritte dai
nostri padri, quelle scritte dai nostri nonni, quelle degli avi. Ce ne sono che scrivono con grande chiarezza
d'espressione, con garbo, con bello studio del periodo. Ecco: questi scrivono bene. E perche Carlo Goldoni
scrive male? Ma perche le sue espressioni, per determinare una nuova visione della vita, dovevano per
forza stonare con quelle che erano negli orecchi di tutti, già composte, già studiate e perciò belle chiare, che
con un po' d'ingegno e di buona volontà, ognuno, santo Dio, poteva dargli un bellissimo garbo. E quello
sgarbataccio d'un Goldoni...
Io credo che ogni creatore, oltre ai peccati grossi, debba sentirsi su la coscienza le segrete afflizioni
dei suoi ammiratori contemporanei, quasi un senso di vergogna per lui a proposito di questo suo
inevitabile scriver male. E Goldoni, per carico di rimorsi, non dovrebbe star sotto a nessuno. Il dialogo di
Carlo Goldoni dovette apparire anche ai suoi ammiratori insipido e sofistico, confrontato col linguaggio
della commedia dell'arte; e scritto male, avvocatesco, sciatto proprio da far cader le braccia, confrontato
con lo stile delle composizioni serie d'allora. La commedia dell'arte, recitata, sì, all'improvviso ma
incapace di lanciarsi veramente nell'estro d'una vera e propria improvvisazione, non era altro in fondo se
non la quintessenza del luogo comune, imbastita su temi generici e su schemi fatti apposta per
inquadrarci lo stesso repertorio di frasi stereotipate, di motti e lazzi tipici e tradizionali, di botte e
risposte sacramentali, protocollate come in un manuale d'etichetta. Era naturale per tutti che su le tavole
del palcoscenico si parlasse così: fatto il gusto alle convenzioni che reggevano quel linguaggio, si andava a
teatro proprio per ammirare le arguzie spiattellate, la falsa naturalezza e la falsa spontaneità; e dunque
sofistico perché psicologico, insipido perche soltanto naturale doveva apparire lo stile del Goldoni, che
scioglieva col suo dialogo la fissità di quelle battute e scomponeva delle maschere disfacendone a poco a a
poco la consistenza ed esprimendola - spettacolo nuovo e ignoto - col giuoco di tutti i muscoli affrancati.
Ma perché Goldoni, che pure ebbe in vita la sorte combattuta dei novatori, non s'è potuto stabilire
in un valore assoluto, tanto che, di fronte a chi ha fatto di lui quasi un feticcio e, con l'intenzione di
lodarlo, esclama: «Ah! Il buon "vecchio" Goldoni!» (e in quel «vecchio» più che un reale riconoscimento
intrinseco pone uno spirito di polemica col «nuovo») c'è chi gli nega addirittura ogni valore per se stesso e
pone la sua produzione come un momento superato nella storia del teatro italiano e nega che possa essere
l'espressione d'un mondo creato e insuperabile nel regno eterno dell'arte?
Anche questo - mi sembra - avviene per gli equivoci ai quali vanno soggette le valutazioni astratte
e sistematiche.
E' naturale che ogni espressione raggiunta, mondo creato, a sé, unico e senza confronti, che non
può essere più né nuovo né vecchio, ma semplicemente «quello che è», in sé per sé in eterno, trovi in questa
sua stessa «unicità» le ragioni: prima, della sua incomprensione; ee poi, e sempre, della sua spaventosa
solitudine: la solitudine delle cose che sono state espresse così, immediatamente, vome vollero essere, e
dunque «per se stesse». E questo solo fatto sarebbero inconoscibili, come sono, se ciascuno, volendo
conoscerle, non le facesse uscire da qull'essere «per se stesse», facendole essere per lui, così com'egli le
interpreta e le intende.
Chi sa Dante, com'era per se nel suo poema! Dante, in quel suo essere per se, diventa come una
natura: noi dovremmo uscir da noi stessi per intenderlo com'è per sé, e non possiamo e ciascuno lo intende
a suo modo, come può. Egli resta veramente solo nella sua solitudine divina. Non di meno, ogni tempo lo
fa suo; ogni tempo riecheggia a suo modo quella sua unica voce.
Ma c'è questo, che la voce di Dante dice cose eterne: parla dalle viscere stesse della terra. Voce
d'una natura, non potrà mai spegnersi nella vita e quel nostro necessario echeggiarla non vuol dire
fraintenderla o non comprenderla. È invece possibile in un tempo fraintendere e non comprendere più la
voce di chi, pure creando, e in forme compiutissime, una sua organica visione della vita, non invalorò con
la sua espressione reali e liberi «movimenti» dello spirito, ma rappresentò piuttosto secondo un
«atteggiamento» dello spirito.
E questo «atteggiamento» in sé, astratto al solito dalla sua espressione, può essere superato, anzi è
necessariamnte superato e diventa a un certo punto, per così dire, storico, non appena le sopravvenute
agitazioni dello spirito abbiano spostato gli elementi di quel panorama contemplato così, da un punto
fisso. Dei movimenti dello spirito non ci si può invece disinteressare mai: il Medioevo di Dante, non
rappresentato secondo un atteggiamento del suo spirito com' è il Settecento del Goldoni, ma nei movimenti
d'uno spirito che non contempla il suo tempo perché ne ha vive in sé tutte le passioni e, anche quando
contempla, non si riposa un attimo, perche lo sguardo non propriamente sul tempo, ma dal tempo gli si
affisa all'eterno e lì subito lo insegue e lo stringe da presso piegandolo ai dubbi, spiegandolo alle
rivelazioni, questo Medioevo di Dante, appunto perché è tutto assunto nel movimento d'uno spirito, non è
più superabile: sarà sempre, in un modo o in un altro, riecheggiato in ogni tempo. È possibile sempre, in
sostanza, a ogni tempo ricevere in sé, comunque, lo spirito di Dante e avvertirne la perpetua presenza e
invece è necessario riportarsi in un certo senso, dai tempi a quei tempi determinati per gustare il valore
dell' espressione d'un atteggiamento dello spirito, che non può esser gustata se non nel suo particolare
sapore, e che non soffre riecheggiamenti: è necessario inomma, riportarci al tempo del Goldoni.
Era un atteggiamento, quello del Goldoni, bonariamente satirico: espressione d'una coscienza morale
assai sveglia, che restava intatta e si serbava tutta propria a se stessa nel riflettere quelle contingenze che
così poteva satireggiare, con la soddisfazione di sentirle superate in lei, pur sapendo staccarle dalle
determinazioni spirituali del suo tempo: e da ciò la bonarietà di questa satira, che può apparire
superficiale in un periodo di travaglio e di sovvertimento fondamentale d'ogni valore costituito.
Per la schiettezza e la trasparenza della sua forma, è e sarà sempre facile riportarsi a Goldoni, a
sentir vive, nella vita della rappresentazione offertaci dal suo atteggiamento spirituale, e l'arguzia del suo
spirito e l'organicità della vita così guardata e rappresentata. La quale è tutta assunta in una forma che
davvero la imbalsama per sempre, insieme con la freschezza e la festevolezza delle proprie espressioni, con
la felicità d'uno spirito che creava per la gioia di creare. Il modo come Goldoni esprime ogni cosa sarà
sempre un modello del gusto di rappresentare, così fluido e scintillante, così nitido e svelto, così accorto e
spontaneo e veramente divertente. La proprietà dello stile, non solo nel dialetto, è assoluta: non c'è mai
cosa detta per approssimazione o in modo che non sia il più schietto e saporito: come non c'è mai nella
concezione sordità o squilibrio di sentimento o d'intelletto; conncezione, elaborazione, espressione, sono
squisitamente accordate a creare un mondo di grazia. La grazia che è uno degli aspetti della natura
umana più simpatici e rari, trova in Goldoni la sua perfetta espressione, mai raggiunta prima di lui;
irraggiungibile certo in un modo così immediato e in tal misura.
Quando questa freschissima espressione di vita balzò su le scene mummificate del teatro italiano e
ridette loro il respiro, il calore e il movimento, si parlò d'una riforma. Era il teatro nuovo. Si può dire
oggi che sia vecchio teatro, perche l'atteggiamento spirituale da cui esso scaturì è in se stesso superato dal
mutamento dei valori nei tempi?
In arte ciò che fu creato nuovo resta nuovo per sempre. Goldoni aveva occhi arguti, occhi vivaci,
coi quali vide nuovo e creò nuovo." (da «Esternamenti» incluso in "Saggi e Interventi", pp. 11671170, Mondandori Milano 2006)
Ora, la critica letteraria ha certo preso in grande considerazione Goldoni per la
questione linguistica del dialetto, confinandolo però per il resto in una zona d'ombra
della letteratura nazionale, - con l'eccezione delle "Memorie" considerate più opera di
narrativa.
Certamente, gli espedienti drammaturgici di Goldoni sono quelli propri del
teatro: i trucchi del mestiere della Commedia dell'Arte vengono da lui assimilati e reinterpretati, nonché piegati alle esigenze di stabilire un contatto con il pubblico, anche ai fini
della sopravvivenza economica, poiché il committente del teatro goldoniano non è più il
Principe, ma lo spettatore pagante e quindi l'impresario (vedi, Maria Pirri, "Goldoni e il
mercato del teatro", in Esperienze Letterarie, XXXII-2007 3-4, pp. 18- 2025 Pisa-Roma 2007,
Serra Editore). Ma questi trucchi del mestiere, gli espedienti ad esempio erotici che
risalgono alla "Mandragola", servono appunto a Goldoni a utilizzare il teatro, sull'esempio di Machiavelli,- ai fini di farne un "palcoscenico morale" della società
italiana (vedi a questo proposito Ezio Raimondi, "Politica e commedia", Il Mulino, Bologna
1972). Possiamo dunque parlare di un uso "dialettico", ossia ideologico e politico, quindi
di una "narrazione" intesa come comunicazione tra scrittore e spettatore e\o lettore?
Come tutti sanno, il tema della "leggerezza" è stato affrontato prima di me da
Italo Calvino che nella "lezione americana" tenuta il 6 giugno 1984 ad Harvard (v. Italo
Calvino, "Lezioni americane", Garzanti 1988) dedicò il primo incontro appunto alla
"leightness".
"Dedicherò la prima conferenza all'opposizione "leggerezza"-peso, e sosterrò le ragioni della
"leggerezza". Questo non vuol dire che io consideri le ragioni del peso meno valide, ma solo che sulla
"leggerezza" penso d'aver più cose da dire. Dopo quarant'anni che scrivo fiction, dopo aver esplorato
varie strade e compiuto esperimenti diversi, è venuta l'ora che io cerchi una definizione complessiva per il
mio lavoro. Proporrei questa: la mia operazione è stata il più delle volte una sottrazione di peso; ho
cercato di togliere peso ora alle figure umane, ora ai corpi celesti, ora alle città; soprattutto ho cercato di
togliere peso alla struttura del racconto e al linguaggio. In questa conferenza cercherò di spiegare perché
sono stato portato a considerare la "leggerezza" un valore anziché un difetto." (Italo Calvino, cit. p.
5)
L'analisi di Calvino prosegue poi con il ricono-scimento di alcuni grandi esempi
di "leggerezza" nel campo della letteratura e della poesia (Ovidio, Dante, Cervantes,
Leopardi ecc.) senza però entrare nell'ambito della dram-maturgia e della letteratura
teatrale che pure, parlando di "leggerezza a doppio senso", tanti esempi a partire da
Aristo-fane e Plauto può fornire all'argomento. L'impostazione letteraria di Calvino può
essere allora estesa al teatro: mi sento così autorizzato a parlare del teatro italiano dal
Rina-scimento ad oggi, la cui "linea rossa", sia pur esemplificata al massimo, cioè
Machiavelli-Goldoni-Pirandello-Eduardo (e chiedo scusa a Pietro Aretino e a Giordano
Bruno), trova nell'uso critico e politico della "leggerezza" (e dell'erotismo, che è un filone
della "leggerezza") un denominatore comune.
Partiamo dalla prima constatazione di Calvino: la "leggerezza", in letteratura (e
nel teatro) non è sinonimo di futilità o stupidità. Un'opera "leggera" può essere ricca di
significati profondi, anche se nascosti vuoi per motivi "politici" vuoi per motivi di
gradimento del pubblico. La "leggerezza", quando non è fine a se stessa, quando cioè
riesce a dare un senso etico o morale al "di-vertimento" (che significa una lettura
paradossale della realtà con tutti i suoi problemi ) è sempre fonte di critica e
conseguentemente di cultura. La "leggerezza", in effetti, è uno strumento stilistico
utilizzato spesso e volentieri nel teatro, nella letteratura (soprattutto rinascimentale e
barocca) per permettere all'opera di divertire il pubblico e allo stesso tempo di
"supportare" - di sostenere - un messaggio più serio. Da Machiavelli , l'Aretino, la
Commedia dell'Arte e Goldoni fino a Pirandello, Eduardo de Filippo, l'arte del
"divertimento" a teatro è sempre stata finalizzata a mascherare un discorso serio, critico,
dietro un intreccio divertente, buffo e appa-rentemente leggero in grado di raggiungere e
"migliorare" il pubblico. In questo senso parlerei proprio di "funzione sociale" della
"leggerezza". Infatti, con lo strumento della "leggerezza", lo scrittore, l'attore o il
drammaturgo possono nascondere un messaggio critico che - proprio perché non viene,
insisto, apparentemente proposto "sul serio" - può essere accettato e compreso da tutti.
Dal momento, infatti, che un'esplicita critica sociale provocherebbe la disappro-vazione
di una parte della società dominante, vediamo che gli autori cercano di prendere per
mano il pubblico conducendolo ad una specie di "catarsi indolore". Uno stratagemma
drammaturgico è, ad esempio, quello di creare una situazione buffa tramite un intreccio
che coinvolge un rapporto tra servo e padrone, dov'è presente l'elemento dell'inganno e
della beffa.
Questi elementi tipici di quella che definirei "leggerezza paradossale", ossia
l'inganno, la critica sociale, la dialettica servo-padrone, si ritrovano in Machiavelli: nella
canzone introduttiva de "La mandragola" l'autore accentua la missione del teatro di
divertire il pubblico. Lo spettacolo dovrebbe essere, nei versi della canzone, una fuga
breve dalla realtà quotidiana con tutti i suoi problemi.
Perché la vita è brieve
e molte son le pene
che vivendo e stentando ognun sostiene;
dietro alle nostre voglie,
andiam passando e consumando gli anni,
che chi il piacer si toglie
per viver con angosce e con affanni,
non conosce gli inganni
del mondo; o da quai mali
e da che strani casi
oppressi quasi - sian tutti i mortali.
Per fuggire questa noia,
eletta solitaria vita abbiamo,
e sempre in festa e in gioia
giovin leggiadri e liete Ninfe siamo.
In questo brano introduttivo Machiavelli spiega che l'opzione della "leggerezza" e
del divertimento è un tentativo di evadere dal quotidiano. Ma il Poeta allude anche alla
solitudine e all'isolamento politico in cui si trova? Machia-velli sta infatti subendo in
questi anni il suo lungo esilio politico: ne consegue che la scelta del teatro come
strumento di comunicazione non rappresenta solo o tanto una fuga dalla realtà, come
recita il testo che vuole "apparentemente" sviare e rassicurare sulle reali intenzioni. Al
contrario, il teatro "leggero" (e aggiungerei erotico) rappresenta il tentativo
"machiavellico" di crearsi un pubblico, una "audience", tramite lo strumento
drammaturgico appunto della "leggerezza" (e, ripeto, dell'erotismo boccaccesco). Tutto
ciò senza perdere di vista la situazione politica italiana sulla quale Machiavelli, anche con
"La mandragola", vuol dire la sua. L'autore si rivolge direttamente agli spettatori per
spiegare che il teatro deve essere leggero per allietare la vita quotidiana, ma al tempo
stesso sembra voler incitare il pubblico a prestare la massima attenzione, poiché nella
commedia, accanto all'apparente "leggerezza", è presente un contenuto serio:
se questa materia non è degna
per esser pur leggeri,
d'un uom che voglia parer saggio e grave,
scusatelo con questo, che s'ingegna
con questi van pensieri
fare el suo tristo tempo più suave,
perché altrove non have dove voltare el viso
ché gli è stato interciso
mostrar con altre imprese altra virtue
non sendo premio alle fatiche sue.
La denuncia di Machiavelli della sua condizione politica è precisa: essendomi
stato impedito ("interciso") di mostrare le mie capacità (politiche) con altre imprese, sono
costretto a servirmi del teatro e delle sue regole dram-maturgiche ("leggerezza" ed
erotismo) per far "passare" il mio pensiero politico senza attirare su di me gli occhi della
censura. La favola - come la chiama Machiavelli stesso - de "La mandragola" non ha
bisogno di essere descritta se non per sommi capi. Un giovane Callimaco Guadagni ricco
(e forse nobile) esiliatosi a Parigi («dove sono stato venti anni... e perché in capo a dieci anni
cominciarono, per la passata di re Carlo, le guerre in Italia... deliberai... di non mi rimpatriare mai»)
rientra precipitosamente a Firenze per amore di una bella scono-sciuta, Lucrezia, moglie
del notaio Messer Nicia. Appro-fittando del fatto che Messer Nicia vuole a tutti i costi un
figlio per perpetuare il proprio patrimonio, e non riesce ad avere eredi, Callimaco con
l'aiuto di due servi, Siro e l'astuto Ligurio, parassita, riesce con un espediente ingegnoso
quan-to fantasioso, appunto la mandragola, e con la compiacenza del corrotto confessore
Fra Timoteo, ad infilarsi nel letto della coscienziosa Lucrezia. Risultato, con grande gioia
di Messer Nicia che è allo stesso tempo ingannatore e ingan-nato, Lucrezia rimarrà
incinta di Callimaco. La fine sarà ancora più lieta per tutti in quanto al finto medico
Callimaco verranno consegnate le chiavi di casa dallo stesso Messer Nicia affinché possa
entrare ed uscire a suo piacimento nel più boccaccesco dei consolidati rapporti a tre. Fin
qui la favola o meglio la commedia erotico-leggera che ha ispirato anche un grazioso film
di Alberto Lattuada nel 1964. Dietro l'apparente veste della commedia erotica, tuttavia,
Machia-velli nasconde - ma neanche tanto velatamente - diversi aspetti di critica sociale,
come pure una sintesi del suo progetto politico. Fin dal prologo l'autore precisa che la
"favola" è una metafora valida per tutta la nazione italiana:
Se voi seguitate di non far romori,
noi vogliamo che s'intenda
un nuovo caso in questa terra nato.
Vedete l'apparato,
quale or vi si dimostra;
questa è Firenze vostra;
un'altra volta sarà Roma o Pisa;
cosa da smascellarsi per le risa.
Dopo aver situato la "favola erotica" in una dimensione geografica nazionale e
prima di alludere ad un'epoca in cui la situazione italiana "marcisce" («Da qui depende,
sanza dubbio alcuno / che per tutto traligna / da l'antica virtù el secol presente»),
Machiavelli fissa bene i caratteri della commedia. Il primo ad essere presentato con tratti
quasi nobiliari è:
Un giovane, Callimaco Guadagni [...] a' segni ed a' vestigi l'onor di gentilezza e pregio porta.
Il secondo personaggio, per importanza attribuita da Machiavelli, è Lucrezia
(forse Lucrezia Borgia che Niccolò pure ammirava?):
Una giovane accorta fu da lui molto amata e per questo ingannata...
Da questa frase sembrerebbe che l'Autore indulga sull'inganno perpetrato "per
amore" da Callimaco, giovane ricco e forse nobile, proveniente da Parigi (quasi come un
Principe) a cui toccherà nel finale della commedia di compiere un miracolo politico,
come vedremo tra poco. Se dunque l'inganno di Callimaco ai danni di Lucrezia appare
non perdonato, ma giustificato nonostante la meschinità del mezzo "machiavellico" in
vista del "fine" ultimo - l'amore e la procreazione di un bambino che sarà il nuovo
soggetto storico con cui finisce la commedia -, gli altri personaggi sono delineati
sarcasticamente:
un dottore poco astuto, (messer Nicia) un frate mal vissuto, (frate Timoteo) un parassito di
malizia el cucco (Ligurio).
Sul parassita Ligurio - e non dimentichiamo il servo di Callimaco, Siro, Machiavelli però ci fornisce una diversa prospettiva fin dalla terza scena che chiude il
primo atto. In questo dialogo il "parassita" si rivela invece un alleato "politico" di
Callimaco contro la goffa e arricchita borghesia impersonata da Messer Nicia.
Ligurio: Non dubitare della fede mia, ché, quando e' non ci fussi l'utile che io sento e che io
spero, ci è che 'l tuo sangue si affà col mio, e desidero che tu adempia questo tuo desiderio, presso a quanto
tu.
Da questo brano apprendiamo che l'intento di Ligurio non è (solo) quello di
approfittare della situazione per un facile arricchimento, bensì anche e soprattutto quello
di realizzare un'alleanza strategica, rivoluzionaria, in grado di far si che dalla bella e
costumata Lucrezia il giovane (Prin-cipe?) riesca ad avere un erede. Ricordo in breve che
il piano politico che stava a cuore a Machiavelli era proprio quella della discesa in Italia di
un Principe in grado di riunificare le classi sociali e realizzare l'unità nazionale. Come
dicevo poc'anzi, il finale della commedia sarà proprio quello dell'unità delle classi (il clero
di Fra Timoteo, la borghesia di Messer Nicia, la nobiltà di Callimaco, la classe subalterna
di Ligurio parassita): non a caso al pranzo offerto da Messer Nicia è invitato ad unirsi
anche Siro, il servo di Callimaco, rappresentante del popolo più basso.
Ligurio: Di Siro non è uom che si ricordi?
Messer Nicia: Chiegga, ciò che io ho è suo.
La commedia erotica raggiunge così nel finale il suo vero scopo: la pace e l'unità
nazionale dove tutte le classi trovano il loro posto e dove anche il popolo è invitato a
sedersi a tavola. La chiusa di Frate Timoteo è teatralmente esemplare in quanto fa
scomparire l'artificio drammaturgico e trasforma la scena in realtà. Apprendiamo infatti
che lui non è un "Frate fittizio" cioè un attore, bensì un personaggio in carne ed ossa, la
storia così nata per gioco, in una metafora del reale, si trasforma in realtà: tutti i
personaggi sono infatti mutati da Machiavelli in persone reali:
Frate Timoteo: Andianne tutti in chiesa, e quivi diremo l'orazione ordinaria; dipoi, doppo
l'uficio, ne andrete a desinare a vostra posta. Voi, aspettatori, non aspettate che noi usciano più fuora:
l'uficio è lungo, e io mi rimarrò in chiesa, e loro, per l'uscio del fianco, se ne andranno a casa. Valéte!
Con un grande colpo di teatro Machiavelli fa scomparire le scene e trasforma il
palco in un luogo reale, in una chiesa vera e propria dove intorno al principe nascituro
verrà realizzato il sogno della pace e dell'unità nazionale. Poco importa se il fine è stato
raggiunto col mezzo dell'inganno, com'è nel principio politico di Machiavelli. Per
l'Autore è altresì fondamentale che l'ideale si realizzi non solo teatralmente, ma anche
socialmente con l'uscita di scena dei personaggi che devono entrare a far parte della vita
quotidiana varcando "l'uscio di fianco". Machiavelli anticipa una forma di teatro che va
oltre la naturale audience formata dal pubblico. Il teatro sembra dunque andare "oltre" il
teatro ed improvvisamente trasformarsi in realtà - non più rappre-sentata dalla fiction ma realtà vera, assolvendo con ciò la sua missione e la sua funzione sociale.
La funzione sociale della "leggerezza" assolve al suo compito nel teatro del '500
anche con La cortigiana (1525) di Pietro Aretino, dove il doppio inganno (sociale ed
erotico amoroso) si risolve nel finale, pedissequamente alla "Mandragola", con un'apertura
alla società intera, cioè al "Gran Teatro del Mondo". La trama de "La cortigiana" è
abbastanza semplice, possiamo dire "leggera": abbiamo a che fare con un figlio di papà
che viene da Siena a Roma per entrare a Corte e magari diventare Papa, ed un nobilotto
napoletano che sempre a Roma - sulla falsariga de "La mandragola" - è sulle tracce di una
bellissima donna da conquistare. Natu-ralmente entrambi finiranno per essere vittime di
truffatori senza scrupoli, ladri, ruffiani, prostitute e preti corrotti. A tal punto che la
commedia diventa - al di là della trama - una grande rappresentazione critica della società
romana dell'epoca. Ma ecco il finale, quando l'epilogo trasforma il teatro in una specie di
piazza totale, anticipando ciò che con Calderon de la Barca nel '600 sarà il Gran Teatro
del Mondo. Il teatro leggero diventa dunque con l'Aretino una forma di teatro inteso
come "piazza totale" - laddove per piazza naturalmente si intende tutto il mondo reale.
La Commedia dell'Arte ha rappresentato - dal '500, ma anche nei secoli
precedenti con la forma del "mimo" - in chiave comica, esilarante eppure drammatica, il
grande assillo delle classi subalterne: la fame. Rimando al bel film di Scola "Capitan
Fracassa", in cui un meraviglioso ed inedito Pulcinella-Troisi impersona la maschera nera
dell'inedia (e non della morte come erroneamente sostiene De Simone, visto che la morte
non fa paura al popolo quanto la fame). Tra le funzioni sociali assolte dalla Commedia
dell'Arte c'è pure quello di "medium", cioè la capacità di mettere in contatto le diverse
piazze d'Europa, fungendo in un certo senso da comunicatore delle realtà, dei problemi e
delle disperazioni dei vari popoli. Con la Commedia dell'Arte il cosiddetto "Teatro oltre il
teatro" di Machiavelli e il "Teatro come Piazza" dell'Aretino, si è trasformato in "Teatro
in Piazza": una forma di rappresentazione in cui spesso veniva a cadere ogni distinzione
tra personaggio e attore, spettatore ed interprete ecc. Il popolo è diventato così il vero
fruitore del teatro - quindi della comunicazione - fino allora riservato ai ceti superiori. È
successo insomma quello che oggi accade con la televisione dove il livello "basso" del
messaggio comporta un ampliamento dell'audience. Tuttavia l'abbas-samento del livello
letterario, artistico, del teatro nella commedia dell'arte in cui non vi era neppure un testo
scritto, poiché gli attori non sapevano leggere, finì per provocare un'eccessiva
volgarizzazione dell'arte drammatica, che dove-va essere sì leggera ma non sguaiata, - con
tutte le eccezioni del caso, come la tradizione della Commedia all'Improvviso della colta
famiglia Andreini.
Da questa riflessione sul senso e sulle possibilità dell'azione drammatica ha
origine il teatro di Carlo Goldoni. Anche in Goldoni la "leggerezza" deve implicare un
senso, una funzione sociale, ovvero l'analisi critica della società. Certo, la "leggerezza" del
gioco drammaturgico è un'arte la cui importanza non sfugge a Goldoni. Teniamo sempre
presente che il distacco dallo stereotipo della Commedia dell'Arte non avviene perché la
Commedia dell'Arte comin-cia a trascendere agli occhi di Goldoni nella volgarità. In
parte vi è anche la questione del gusto; ma la verità è anche che Goldoni si accorge che
gli stereotipi - le maschere con tutte le loro gag programmate - rischiano di sempre più di
essere prevedibili e quindi di perdere tutto il loro effetto comico. Teniamo ben presente
che Goldoni fa infatti dire alla Placida-Rosaura protagonista del suo manifesto "Il teatro
Comico" queste parole in difesa proprio della "leggerezza":
"Se facciamo le commedie dell'arte, vogliamo star bene. Il mondo e' annoiato di veder sempre le cose
istesse, di sentir sempre le parole medesime, e gli uditori sanno cosa deve dir l'Arlecchino, prima ch'egli
apra la bocca [...] sono invaghita del nuovo stile, questo solo mi piace."
Il nuovo stile di cui parla Rosaura è proprio il realismo goldoniano che vuole
raccogliere e rinnovare la grande tradizione della "leggerezza" e della viva comicità della
Commedia dell'Arte trasformando le maschere in personaggi tragicomicamente reali.
Ricordo a questo propo-sito che la prima fonte drammaturgica di Goldoni - che sta
rivoluzionando la "leggerezza del teatro" in "teatro della leggerezza" (la differenza è tanto
sottile quanto deter-minante) - è proprio "La mandragola" di Machiavelli. Goldoni narra
nelle "Memorie" un simpatico aneddoto risalente all'età delle prime letture, 17 anni:
"Io non la conoscevo ("La mandragola"); ma ne avevo sentito parlare, e sapevo che non era
un'opera delle più caste. La divorai alla prima lettura, e la rilessi dieci volte. Mia madre non badava al
libro che leggevo, poiché mi era stato dato da un ecclesiastico. Ma mio padre mi sorprese un giorno in
camera mia, mentre facevo annotazioni e osservazioni su quell'opera. Non ignorava quanto questa
commedia fosse pericolosa per un adolescente diciassettenne: volle sapere da chi l'avessi avuta, e io glielo
confessai. Mi rimproverò acerbamente, e venne a parole con quel povero canonico che aveva peccato
soltanto di storditaggine... Non era lo stile libero né l'intreccio scandaloso della commedia a farmela
trovar buona; anzi la sua lubricità mi ripugnava, e vedevo da me stesso che l'abuso del segreto
confessionale era un delitto atroce davanti a Dio e agli uomini. Ma era la prima commedia di carattere
che mi cadesse sotto gli occhi, e io ne ero affascinato."
A diciasssette anni dunque, Goldoni legge dieci volte "La mandragola" e non è
affascinato - tutt'altro - dal contenuto erotico della commedia, quanto piuttosto dalla sua
struttura, tanto da aggiungere:
"Avrei desiderato che gli autori italiani avessero continuato, sulla scorta di questa, a comporne
altre, ma decenti e castigate, e che caratteri attinti alla natura avessero preso il posto degli intrighi
romanzeschi."
Naturalmente al giovane Carlo Goldoni l'intreccio erotico de "La mandragola" non
doveva dispiacere del tutto, visto che ne "La locandiera" e nel "Servitore di due padroni" vi
sono alcune scene che oserei definire "erotiche". Quello che qui però conta è che nel
giovane autore veneziano si forma l'idea - proprio leggendo e rileggendo per ben 10 volte
il capolavoro di Machiavelli - che proprio grazie all'apparente "leggerezza" della
commedia si può far "passare" un discorso più serio che vada oltre le finzioni leggere,
ridicole ed erotiche per trasformarsi in una critica della società. Insomma per Goldoni lo
scopo del teatro non può essere soltanto quello di far ridere, bensì di di-vertire: la
dramma-turgia è lo strumento con cui la realtà si sdoppia e si vede come in uno specchio,
paradossalmente capovolta e quindi fonte di divertimento. Il tema delo "specchio"
ricorre del resto nell'opera di Goldoni anche in forma teorica: "Teatro specchio della
realtà" - un'affermazione, anzi una formu-lazione che definisce la natura sociale
(politica?), comunque critica del teatro. Un'idea che sarà successivamente ripresa proprio
da Pirandello che in un'intervista parlando di "Come prima, meglio di prima" e "Tutto per
bene", spiega:
"...Le credevo commedie senza specchio. Invece no, ce l'hanno anch'esse. E come! Quando uno
vive, vive e non si vede. Orbene, fate che si veda, nell'atto di vivere in preda alle sue passioni, ponendogli
uno specchio davanti: o resta attonito e sbalordito del suo stesso aspetto, o torce gli occhi per non vedersi, o
sdegnato tira uno sputo alla sua immagine, o irato avventa un pugno per infrangerla; e se piangeva, non
può più piangere; e se rideva, non può più ridere..." (intervista al "Corriere della Sera", 28 febbraio
1920, inclusa in "Esternamenti" op. cit. p 1135-1136)
I contenuti "sociali" e "politici" - critici - delle opere goldoniane evidenti e
molteplici, ne bastano alcuni cenni. Ad esempio, penso alla dialettica servo-padrone,
città-campagna su cui tornerò tra breve. A questo proposito bisogna tener presente che
Goldoni premette sempre una prefazione ai suoi lavori, chiarisce i propri intenti e la
propria posizione "ideologica", solo apparentemente neutrale. Ho chiamato in causa la
dialettica "servo-padrone" che Goldoni ricompone alla maniera di Machiavelli, cioè
proponendo che tutti - anche le classi più umili - partecipino al banchetto e al benessere
della società, se non si vuole che le classi sub-alterne si ribellino con pieno diritto. La
speranza di Goldoni è che la società impari ad essere più giusta ed equanime. Come non
ricordare le parole ammonitrici di Truffaldino?
"Quand ch'i dis, bisogna servir i patron con amor! bisogna dir ai patroni, ch'i abbia un po' de
rispetto pei servitori."
E poi, non aveva forse avvertito proprio Goldoni nella "Trilogia della villeggiatura"
che i borghesi di città che vanno ad ostentare la loro ricchezza in villeggiatura suscitano
l'invidia e la rabbia di chi vive in più umili condizioni in campagna? Sappiamo com'è
andata a finire: con la rivoluzione francese che l'autore veneziano vide realizzarsi proprio
nei suoi ultimi anni parigini. Va anche ricordato che il Consiglio della Rivoluzione trattò
con considerazione il vecchio autore di corte confermandogli il vitalizio che gli era stato
sospeso e di cui poté beneficiare la moglie. Questo per dire che sotto l'apparente
"leggerezza", il teatro goldoniano assolve ad una funzione critica e direi anche sociale,
anticipando la dialettica servo-padrone dell'illuminismo francese, funzione critica di cui lo
stesso Consiglio della Rivoluzione nel lontano 1792 è consapevole.
Vale la pena notare una curiosa affinità tra i finali della "Mandragola" e del
"Servitore di due padroni": entrambi propongono l'esigenza dell'unità sociale e la risoluzione
della dialettica servo-padrone: Silvio nella "Mandragola" e Truffaldino nel "Servitore"
partecipano entrambi al banchetto finale in cui borghesia, nobiltà, clero e classi
subalterne ritrovano ciascuno il suo posto.
Tuttavia, nonostante i presupposti (da Plauto a Machiavelli, dall'Aretino alla
Commedia dell'Arte e a Goldoni) di una drammaturgia nazionale in cui la "leg-gerezza"
diviene dialettica e a doppio fondo - cioè nasconde un contenuto serio -,
improvvisamente alla fine del '700, dopo Goldoni, si trasforma in drammaturgia
"pesante". L'evoluzione dell'opera buffa e del melodramma settecen-tesco nell'opera
lirica dell'Ottocento, più cupa e carica di presagi di morte, oltre che di contenuti
nazionalistici, è l'esempio lampante di una tradizione che comincia a tendere più alla
tragedia e al dramma che alla commedia. Per tornare a parlare di drammaturgia "leggera"
- sempre tra virgolette poiché la "leggerezza" non è appunto sinonimo di disim-pegno
civile o filosofico - bisogna aspettare i primi decenni del '900, cioè Pirandello. Ma come,
si dirà, il pirandelllismo non è forse una forma di "cerebralizzazione" del teatro che passa
dalla rappresentazione del dramma al dramma della rappresentazione? Che c'entra la
"leggerezza" nella dramma-turgia di Pirandello che invece è, se non pesante, certamente
pe-n-sante? Beh, a questa domanda è piuttosto semplice rispondere. Anzi, farò così, darò la
parola a Pirandello stesso, alias al suo personaggio Hinkfuss il direttore del teatro di
"Questa sera si recita soggetto":
"Ma a questo patto soltanto signori può tradursi in vita e tornare a muoversi ciò che l'arte fissò
nell'immutabilità di una forma; a patto che questa forma riabbia movimento da noi, una vita varia e
diversa e momentanea: quella che ciascuno di noi sarà capace di darle. Oggi si lasciano volentieri in
quella loro divina solitudine fuori del tempo le opere d'arte. Gli spettatori, dopo una giornata di cure
gravose e affannose faccende, angustie e travagli d'ogni genere, la sera a teatri, vogliono divertirsi."
Se da un lato è vero che i contenuti scelti da Pirandello (crisi d'identità,
personalità frantumata, crisi attore-personaggio, tanto per dirne qualcuno) non sono
propriamente "leggeri", ma molto più formalistici che in Machiavelli, va anche detto che
la "forma", la drammaturgia, prescelta da Pirandello è propriamente quella del teatro
"leggero" di fine '700. Mi riferisco in particolare al teatro-nel-teatro del romantico
tedesco Ludwig Tieck (vedi il mio saggio "Pirandello e Tieck, alcuni confronti testuali",
in "Studi Germanici" nuova serie, diretta da Paolo Chiarini Anno XLIV, 1 2006, pp. 159170). Fatto sta che la grande intuizione di Pirandello è quella di capire che l'autore
teatrale può anche scegliere contenuti "pesanti", drammatici, ma può farlo solo attraverso
una "forma" drammaturgica che strutturalmente sorregga la pesantezza dei contenuti.
Pena la noia dello spettatore che, come abbiamo appena sentito dalle parole di HinkfussPirandello, rappresenta il vero dramma del teatro: lo sbadiglio.
A proposito de "La mandragola" e del "Servitore di due padroni" parlavo poc'anzi
della dialettica servo-padrone. Ebbene questa dialettica, elaborata sul piano della
tragicom-media un po' farsesca, è presente anche nel pirandelliano "Berretto a sonagli",
dove l'astuto Ciampa, da servo gabbato, diventa il gabbatore, proprio come il Ligurio de
"La mandragola" e il Truffaldino del "Servitore". Alla fine sono sempre i servi a vincere e il
trionfo di Ciampa che condanna al manicomio la sua padrona, togliendosi così di dosso il
peso delle corna, è, al di là del "pirandellismo" della commedia, un capolavoro di gestione
politica e sociale della dimensione teatrale.
Il discorso su Pirandello suggerisce un accenno ad Eduardo de Filippo. Eduardo
si forma artisticamente proprio nel periodo in cui Pirandello riscuote il maggior successo
sui palcoscenici italiani. Il giovane Eduardo si dedica anche ad una regia parodistica dei
"Sei personaggi" che Pirandello fa in tempo a vedere stabilendo anche un rappor-to
personale con l'autore napoletano. In diversi lavori di Eduardo si sente per altro
l'impronta del "pirandellismo", cito soltanto a mo' di esempio "Ditegli sempre di sì", testo in
cui Eduardo affronta paradossalmente e comicamente il tema delle conseguenze sociali
della follia, sulla falsariga ovviamente del pirandelliano "Enrico IV". Il pirandellismo di
Eduardo è un argomento che merita ulteriori ricerche. Mi interessa ora stabilire invece
uno stretto legame tra Eduardo e il grande teatro italiano da Machiavelli e Goldoni a
Pirandello. Tutti e tre questi grandi autori optano, con gradazioni e stili differenti, per un
teatro apparentemente leggero (in Pirandello il contenuto serio diventa spesso farsa
sociale); leggerezza che però ha un doppiofondo, la critica sociale. Gli esempi citati
("Mandragola", "Servitore" e "Berretto a sonagli") hanno nella trama almeno due elementi in
comune: il primo è la costante dell'imbroglio, della truffa; l'altro ele-mento è invece
rappresentato dalla dialettica servo-padrone che si risolve ottimisticamente nella
ricomposizione finale della società che ritrova il suo equilibrio in quanto tutti sono
invitati a partecipare al banchetto e al benessere.
È quanto avviene anche in uno dei capolavori di Eduardo, "Filumena Marturano":
il personaggio di Domenico rappresenta la borghesia che viene ingannata da un servo.
Come Messer Nicia-Ligurio, Truffaldino-Beatrice e Florin-do, Ciampa-Beatrice,
Filumena rappresenta il ceto più umile e servile che solo grazie all'astuzia riesce ad
elevarsi di ceto sociale. E' nota, anche grazie al cinema, la trama della com-media, in cui
Filumena, amante e serva di Domenico, deve fingersi morente per incastrare il ricco
padrone costrin-gendolo a sposarla controvoglia. E di fronte alle astuzie legali dell'uomo
per sciogliere il vincolo nuziale frutto dell'inganno (anche qui come ne "La mandragola" vi
è un prete compiacente) Filumena inventa una storia che solo una mente disperata può
escogitare. Uno dei tre figli è - dice la donna - di Domenico, ma lui non saprà mai di
quale si tratti, costringendo così l'uomo a farsi padre di tutti e tre. Ed ecco che torna il
concetto della ricomposizione sociale servo-padrone: la serva è diventata signora, i figli
orfani ora hanno un padre e la società ritrova il suo equilibrio in questa riunione di classi
sociali.
La costante dell'apparente "leggerezza" della dram-maturgia che nasconde un
doppiofondo critico e social-mente impegnato, è presente anche un altro capolavoro di
Eduardo, "Napoli Milionaria". In questa commedia del 1932 si passa dalla
rappresentazione della farsa del fascismo al dramma del mercato nero e della guerra, poi
dalla tragedia della prigionia nei lager tedeschi si arriva alla tragicommedia nazionale del
primo dopoguerra, un periodo cioè in cui i veri furbi si arricchiscono a scapito della
brava gente. Il pro-tagonista dell'opera Gennaro Jovine, tranviere disoccupato, è in effetti
un personaggio che dapprima ci appare in tutta la sua goffa testardaggine impelagato in
beghe familiari che volgono al comico se non al ridicolo, ma che succes-sivamente
diventa il centro di una vera e propria tragedia sociale. Quale tragedia? L'arricchimento
sfrenato, con ogni mezzo, di una società che sta buttando (o ha già buttato) all'aria gli
ideali pur di fare facilmente quattrini. Ecco allora che l'inizio apparentemente leggero
della commedia, na-sconde un principio di critica sociale che nel finale diventa devastante
e di altissimo impegno morale. Il fatto è che Eduardo de Filippo anche quando scrive
una farsa o una commedia sa bene che il teatro deve avere un "senso" per il pubblico a
cui è rivolta: deve cioè contenere una critica della società e della realtà,- oltre che esserne
la semplice rappresentazione.
L'apparente "leggerezza" del teatro di Eduardo - in cui la comicità è l'elemento
indispensabile che serve non da velo, ma da filtro alla critica - muove l'azione drammatica
che tende alla tragedia e alla rappresentazione di un mondo in rovina, un mondo in cui
l'individuo è solo davanti allo specchio - come in Goldoni, come in Pirandello - della
propria coscienza. La tecnica drammaturgica di Eduardo consiste allora proprio in questa
apparente naturalità della rappresentazione bozzettistica e spesso comica in cui lui, il
Grande Attore-Autore o il suo personaggio, (che si chiami Domenico o Gennaro, o
Gennariè come in "Natale") diventa grazie,anche alla sua maschera teatrale, l'elemento di
disturbo, "il problema", il deus ex machina che farà prendere alla commedia un percorso
tragico e altamente critico. Una delle commedie più esilaranti di Eduardo, "Questi
fantasmi", racchiude la drammaticità dell'esistenza di Pasquale Lojacono che non riesce a
sfamare la moglie che teme così di perdere. Da qui l'elemento dell'inganno e del qui pro
quo che stravolge la commedia in una tragedia tanto farsesca quanto umanissima e
disperata. La drammaturgia di Eduardo è allora definibile come "TEATRO DIETRO IL
TEATRO". Intendo cioè che il bozzetto naturalistico che dà spunto alla commedia è per
Eduardo il vero artificio: la vita reale è apparenza, mentre il compito della drammaturgia
è quello di svelare i retroscena tragici di quella farsa che sembra rappresentarsi sulla scena
quasi da sola, direi "neorealisticamente" come un'istantanea dell'esistenza in un basso di
Napoli. Chi del resto ha presente l'edizione televisiva delle sue commedie, curate dallo
stesso Eduardo, ricorderà la scena degli applausi di un pubblico inesistente e i
ringraziamenti della compagnia, scena ripresa da dietro il sipario: come a voler appunto
dire che la tragedia è oltre la farsa che si è rappresentata. Gli attori alla chiusura del
sipario infatti tornano ad essere "veri", persone reali, permet-tendo così al teatro la totale
apertura alla problematicità della vita quotidiana, al di là e vorrei dire nonostante
l'elemento comico e farsesco di cui il teatro deve far uso per potersi far capire dal
pubblico.
Devo a questo punto citare Dario Fo. Penso che proprio nell'opera del più
recente premio Nobel italiano la commistione di "leggerezza" ed impegno trovi una
subli-mazione drammaturgica "evidente", tanto che il teatro di Dario Fo attinge quasi alle
stesse fonti del Teatro Politico di Brecht (Commedia dell'Arte, Teatro Elisabettiano).
Senon-ché il teatro impegnato di Dario Fo, proprio perché politicamente,
ideologicamente, "evidente", diventa parados-salmente "leggero" senza mai esserlo
veramente. L'Autore e la sua ideologia non si nascondono nel testo, ma si rivelano
esplicitamente provocando una "catarsi", alias una "adesio-ne" del pubblico alla verità e
ai contenuti del testo, aprio-ristica, già data. Non voglio parlare di pregi e limiti del
Teatro Politico; resta il fatto che l'intento propedeutico (quando non didattico) è
dichiarato: il pubblico è già partecipe oppure sa di non poter essere convinto, magari
ammira l'autore-attore, ne è incuriosito e affascinato, ma se ne discosta ideologicamente.
Il che vuol dire che indipen-dentemente dalla piacevolezza e/o profondità del testo, ne
condivide o non ne condivide "i contenuti" fin dall'inizio. Naturalmente non posso qui
occuparmi del Teatro Politico da Brecht a Dario Fo: si tratta di un genere la cui
grandezza e significato necessitano di molto più spazio. Ho voluto solo sottolineare
differenze e analogie tra una drammaturgia "leg-gera" critica della società (Machiavelli,
Goldoni, Eduardo) ed una drammaturgia "leggera" politica (Brecht e Dario Fo, pur con
tutti i necessari distinguo) in cui però il "contenuto" tende a prevalere - magari anche
contraddittoriamente - sulla "forma". Preciso, al fine di non essere frainteso, che che la
contraddizione forma-contenuto rappresenta la forza e non la debolezza di questa
drammaturgia.
A questo punto non si può non riallacciare il tema della "leggerezza" con quella
dell'erotismo. Perché anche l'erotismo, come abbiamo sin qui visto, è una forma di leggerezza di cui si serve l'Autore per "far passare" e accettare dal pubblico un "certo"
discorso più ideologicamente impe-gnato. Perfino un autore privo di "licenze" erotiche
come Goldoni riprende da Machiavelli lo strumento dell'erotismo per insinuare le
tensioni sociali allora incombenti, senza però allertare il pubblico, anzi depistandolo,
tranquillizzandolo con l'elemento comico, nell'intento di ottenere il maggior effetto
possibile: trasformare un'opera leggera basata sul-l'erotismo in un "sottile" benché
efficace discorso politico. Un esempio molto calzante si trova nel "Servitore di due padroni"
- che ovviamente è un manifesto politico camuffato da opera buffa - in cui alla comicità
si aggiunge un elemento di forte erotismo rappresentato dallo scambio di ruoli e dai
travestimenti. Infatti Beatrice travestita da uomo fa girare la testa a Rosaura (e ne è a sua
volta attratta immedesimandosi fin troppo nel ruolo di maschio conquistatore) e la
rivelazione dell'identità nella scena XX non è priva di un ulteriore turbamento:
Beatrice: Ora non mi guarderete più di mal occhio.
Clarice: Anzi vi sarò amica; e se posso giovarvi, disponete di me.
Beatrice. Anch'io vi giuro eterna amicizia. Datemi la vostra mano.
Clarice: Eh, non vorrei...
Beatrice: Avete paura che io non sia donna? Vi darò evidenti prove della mia verità.
Lasciamo scorrere la mano di Clarice nei segreti femminili di Beatrice e
concludiamo con l'augurio che il Trecentesimo anniversario della nascita di Goldoni
riapra prospettive e riaccenda nuovi fermenti e turbamenti nel Teatro italiano, anche sulla
base di un uso "impegnato" dell'erotismo come una delle forme con cui si manifesta la
necessaria "leggerezza" dell'opera.
3 - GOLDONI E LA SPERIMENTAZIONE TEATRALE
Scrive L. P. (Luigi Pirandello) nella "premessa dell'autore ai tre lavori raccolti nel I
volume dell'edizione definitiva del suo teatro":
"...tutti e tre uniti, quantunque diversissimi, formano come una trilogia del teatro nel teatro,
non solo perché hanno espressamente azione sul palcoscenico e nella sala, in un palco o nei corridoj o nel
ridotto d'un teatro, ma anche perché di tutto il complesso degli elementi d'un teatro, personaggi e attori,
autore e direttore-capocomico o regista, critici drammatici e spettatori alieni e interessati, rappresentano
ogni possibile conflitto". (L. Pirandello, in "Maschere Nude", Vol. I, p. 29, Mondadori Milano
1958).
Perché Pirandello scrive "come una trilogia"? Con quel "come" sembra quasi che
voglia mettere le mani avanti di fronte ad una verità incontrovertibile: non sta dicendo
nulla di nuovo. L'idea del teatro nel teatro non è farina del suo sacco e il conflitto di tutto
il complesso degli elementi di un teatro, cui si riferisce Pirandello, è un arsenale che
risale alla seconda metà del '700: cioè al "Teatro comico" (1750) di Goldoni e a "Il mondo
alla rovescia" (1798) di Ludwig Tieck. Non è del resto un caso se uno dei testi della
trilogia pirandelliana, "Questa sera si recita a soggetto", richiami fin dal titolo la tradizione
della Commedia dell'Arte che è il fondamento critico, storico, ideologico e letterario da
cui partono i lavori di Goldoni e Tieck.
Ho già parlato dei "prestiti" di Pirandello ai danni Tieck: a Pirandello si può
imputare non tanto di aver imitato situazioni comiche, impianti drammatici e perfino
battute dall'autore del romanticismo tedesco, - in teatro non si dice mai nulla di
completamente nuovo, - quanto piuttosto di aver occultato le fonti dell'operazione,
anche di fronte ad osservazioni critiche del tempo molto pertinenti, visto che in
Germania se ne erano accorti fin dal 1921, mentre in Italia Bonaventura Tecchi avanzava
a Pirandello stesso alcuni dubbi circa l'originalità del concetto.
A Goldoni, invece, Pirandello riserva tutte le atten-zioni indicandolo giustamente
come un padre della grande tradizione teatrale italiana, purtroppo maltrattato dalla critica.
Ma Pirandello pensa al Goldoni de "Il teatro comico" soprattutto nella stesura di "Questa
sera si recita a soggetto". E lo stesso farà Eduardo ne "L'arte della commedia". In effetti,
queste tre opere rappresentano la vera trilogia del... teatro sul teatro, cui allude Pirandello
nella sua nota introduttiva. I puntini sospensivi sono significativi del motivo per cui i
passaggi da Goldoni a Pirandello e poi a Eduardo sono stati considerati più dal profilo
storico-letterario che da quello strettamente drammaturgico. Ciò è avvenuto anche a
causa di Pirandello che ha definito la sua trilogia "come una trilogia del teatro nel teatro",
premettendo quel "come" quasi compren-dendo di non essere completamente nel giusto
e quindi di fuorviare più o meno coscientemente. La verità è che Pirandello usa il termine
di "teatro nel teatro" fuori luogo. Teatro nel teatro significa sostanzialmente l'apertura del
palcoscenico al gran teatro del mondo sulla base di alcuni elementi della drammaturgia
tardo medievale:
"Il nuovo dramma è in primo luogo autorappresentazione del gruppo che lo rappresenta - con
Cristo al centro. E il luogo deputato di Cristo era perciò... al centro della piazza tra gli spettatori. Ciò
che qui si è individuato è il modello (teorico) di una drammaturgia medievale che si è costituita in stretto
rapporto da un lato con un tipo di spiritualità che si riflette anche nella riattivaione della metafora del
Theatrum Mundi e dall'altro dall'esperienza concreta di un gruppo di uomini". (Johann Drumbl,
"Questioni metodologiche e problematica del gruppo destinatario", in "Biblioteca Teatrale" N. 15-16
1976, p. 9-10, Bulzoni, Roma).
Il teatro nel teatro del romanticismo tedesco, di cui Pirandello si appropria
parzialmente senza darne una giustifi-cazione critica, in realtà sfugge di mano
all'Agrigentino che ha in mente più Goldoni che Ludwig Tieck. Certo che tra la
riflessione metateatrale "sul teatro" di Goldoni e la giocosità del meccanismo del "teatro
nel teatro", Pirandello finisce per fare una commistione dei generi, prendendo battute e
situazioni sceniche da Tieck, ma la struttura ideologica e metateatrale, cioé sul teatro, da
Goldoni. La grande novità de "Il teatro comico" di Goldoni sta, infatti, proprio nella
riflessione critica sul teatro, sull'esigenza di un rinnovamento della scena espresso sotto
forma di riflessione metateatrale che anticipa la sperimentazione di Pirandello, di
Eduardo e - forse - di Carmelo Bene. Siamo infatti alle prese con un "testo-manifesto"
teatrale in cui vera protagonista è la ricerca drammaturgica. Il teatro nel teatro è
propriamente una forma di rappresentazione della realtà attraverso l'allar-gamento del
palcoscenico a tutto il mondo, spettatori inclusi. All'opposto, il teatro sul teatro è la
rappresentazione di una forma, ossia è il teatro che discute su se stesso. Il teatro sul teatro si
sostituisce al discorso critico, serve all'autore per fissare i paletti della propria
drammaturgia, prende forma come enunciazione, come proposta formale, come riforma
della scena. Intenti che Goldoni spiega assai chiaramente nella premessa.
"L'autore a chi legge: Questa, ch’io intitolo Il Teatro Comico, piuttosto che una Commedia,
prefazione può dirsi alle mie Commedie."
E' del tutto evidente che quando Pirandello fa entrare i famosi "sei personaggi", o
quando la compagnia si ribella e decide di recitare a soggetto, il pubblico non è il vero
pubblico della rappresentazione, bensì la rappre-sentazione di un pubblico fatta con
attori. Così, mentre nel teatro nel teatro di Tieck il pubblico è verosimile e presenta tutti
i difetti culturali, fisici e ideologici del vero pubblico, il pubblico di Pirandello è
assolutamente astratto, formalistico, serve solo per discutere sulla funzione del teatro nel
mondo contemporaneo. Si tratta insomma di una forma di speri-mentazione di cui il
vero pubblico non è assolutamente partecipe, né coinvolto, semmai "vittima" passiva di
un discorso metateatrale sulle forme dell'arte scenica.
In conclusione, "Il teatro comico" di Goldoni è il testo-chiave per la comprensione
della drammaturgia italiana che proprio nella discussione "sul teatro" ha una lunga
tradizione da Riccoboni e dall'Alfieri nel '700, a Pirandello, Eduardo e Pasolini nel '900.
Forse sarebbe il caso di tornare sui Testi-manifesti della drammaturgia italiana. Posso
indicare la ricerca di Roberta Turchi "La commedia italiana del Settecento" (Sansoni Firenze,
1985), ma purtroppo non mi risulta una ricerca complessiva che arrivi ai giorni nostri, al
post-Pasolini e Mario Luzi, fino al manifesto del Teatro S-naturalista del 1990. Sarebbe
il caso di far quadrare meglio i conti con la sperimentazione degli Anni 1960-1990 che è
stata considerata come un "semplice" fenomeno "scenico" e così - differentemente da
quanto avvenuto per la sperimentazione nell'ambito della poesia e della narrativa esclusa dalla letteratura nazionale con grave conseguenza per il lavoro dei nuovi
drammaturghi.
La speranza è che la recente pubblicazione (Bompiani) delle opere complete di
Carmelo Bene e la ripresa del "Teatro comico" di Goldoni riportino l'attenzione sulla
drammaturgia italiana da cui scaturisce la nostra stessa letteratura nazionale.
Enrico Bernard