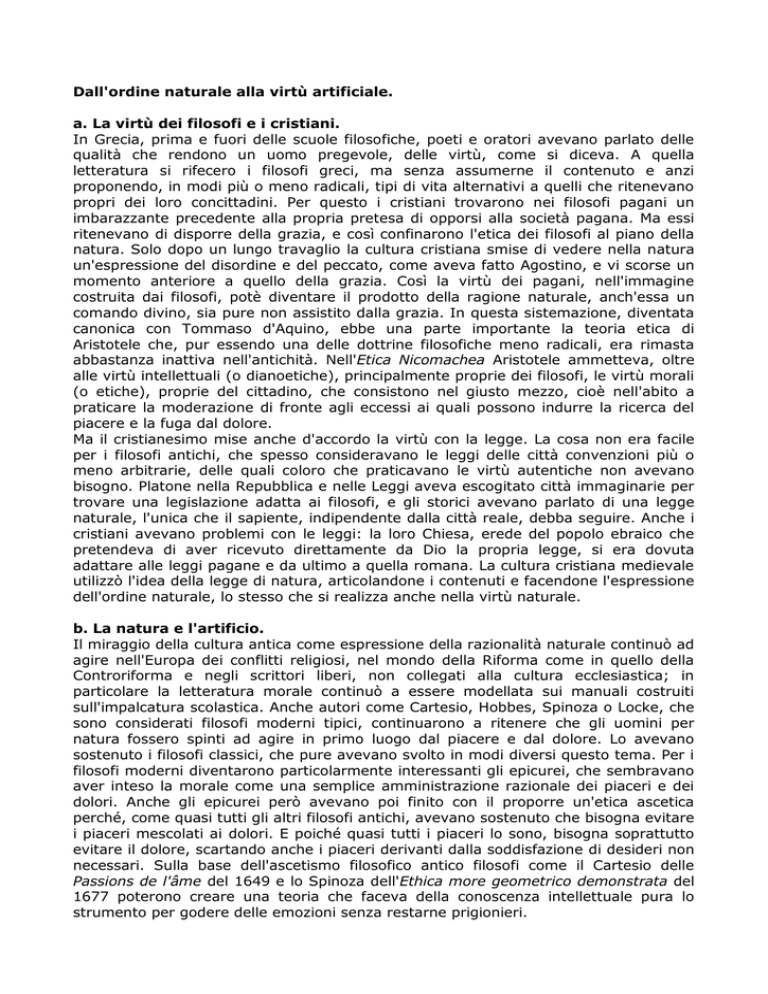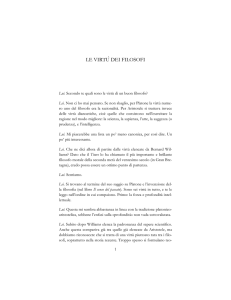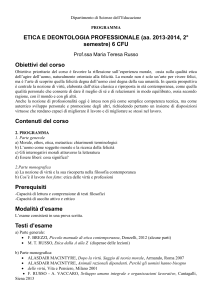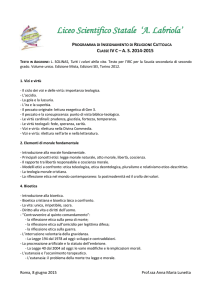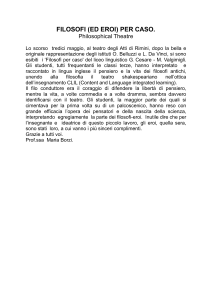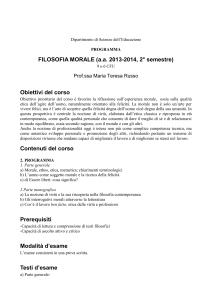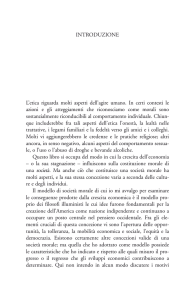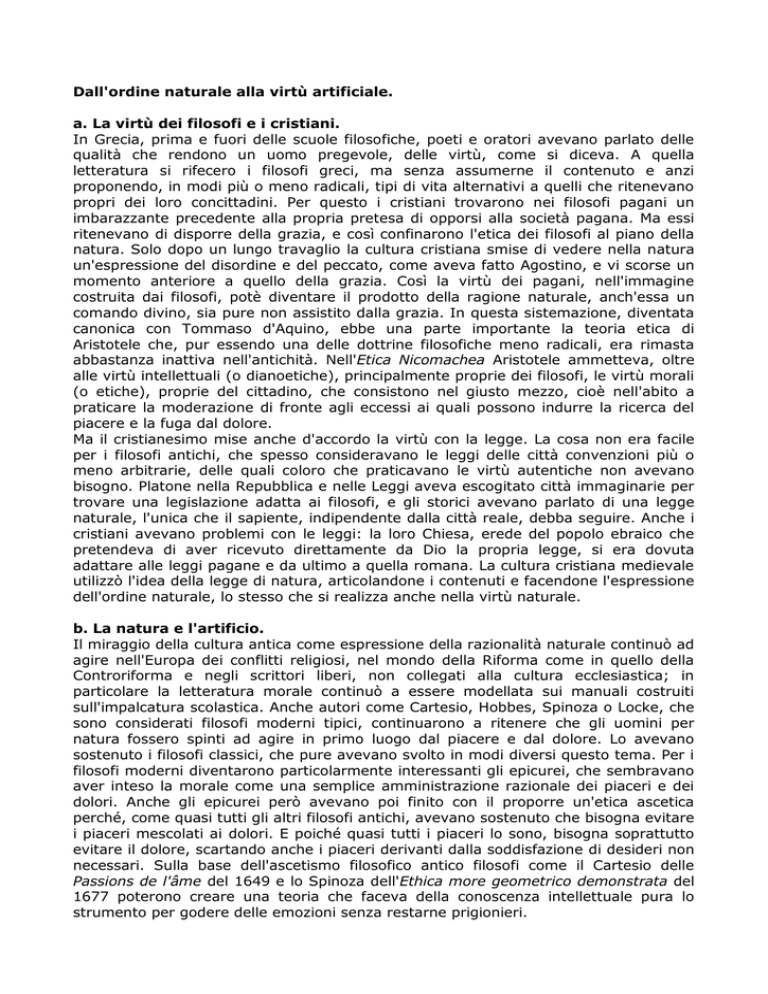
Dall'ordine naturale alla virtù artificiale.
a. La virtù dei filosofi e i cristiani.
In Grecia, prima e fuori delle scuole filosofiche, poeti e oratori avevano parlato delle
qualità che rendono un uomo pregevole, delle virtù, come si diceva. A quella
letteratura si rifecero i filosofi greci, ma senza assumerne il contenuto e anzi
proponendo, in modi più o meno radicali, tipi di vita alternativi a quelli che ritenevano
propri dei loro concittadini. Per questo i cristiani trovarono nei filosofi pagani un
imbarazzante precedente alla propria pretesa di opporsi alla società pagana. Ma essi
ritenevano di disporre della grazia, e così confinarono l'etica dei filosofi al piano della
natura. Solo dopo un lungo travaglio la cultura cristiana smise di vedere nella natura
un'espressione del disordine e del peccato, come aveva fatto Agostino, e vi scorse un
momento anteriore a quello della grazia. Così la virtù dei pagani, nell'immagine
costruita dai filosofi, potè diventare il prodotto della ragione naturale, anch'essa un
comando divino, sia pure non assistito dalla grazia. In questa sistemazione, diventata
canonica con Tommaso d'Aquino, ebbe una parte importante la teoria etica di
Aristotele che, pur essendo una delle dottrine filosofiche meno radicali, era rimasta
abbastanza inattiva nell'antichità. Nell'Etica Nicomachea Aristotele ammetteva, oltre
alle virtù intellettuali (o dianoetiche), principalmente proprie dei filosofi, le virtù morali
(o etiche), proprie del cittadino, che consistono nel giusto mezzo, cioè nell'abito a
praticare la moderazione di fronte agli eccessi ai quali possono indurre la ricerca del
piacere e la fuga dal dolore.
Ma il cristianesimo mise anche d'accordo la virtù con la legge. La cosa non era facile
per i filosofi antichi, che spesso consideravano le leggi delle città convenzioni più o
meno arbitrarie, delle quali coloro che praticavano le virtù autentiche non avevano
bisogno. Platone nella Repubblica e nelle Leggi aveva escogitato città immaginarie per
trovare una legislazione adatta ai filosofi, e gli storici avevano parlato di una legge
naturale, l'unica che il sapiente, indipendente dalla città reale, debba seguire. Anche i
cristiani avevano problemi con le leggi: la loro Chiesa, erede del popolo ebraico che
pretendeva di aver ricevuto direttamente da Dio la propria legge, si era dovuta
adattare alle leggi pagane e da ultimo a quella romana. La cultura cristiana medievale
utilizzò l'idea della legge di natura, articolandone i contenuti e facendone l'espressione
dell'ordine naturale, lo stesso che si realizza anche nella virtù naturale.
b. La natura e l'artificio.
Il miraggio della cultura antica come espressione della razionalità naturale continuò ad
agire nell'Europa dei conflitti religiosi, nel mondo della Riforma come in quello della
Controriforma e negli scrittori liberi, non collegati alla cultura ecclesiastica; in
particolare la letteratura morale continuò a essere modellata sui manuali costruiti
sull'impalcatura scolastica. Anche autori come Cartesio, Hobbes, Spinoza o Locke, che
sono considerati filosofi moderni tipici, continuarono a ritenere che gli uomini per
natura fossero spinti ad agire in primo luogo dal piacere e dal dolore. Lo avevano
sostenuto i filosofi classici, che pure avevano svolto in modi diversi questo tema. Per i
filosofi moderni diventarono particolarmente interessanti gli epicurei, che sembravano
aver inteso la morale come una semplice amministrazione razionale dei piaceri e dei
dolori. Anche gli epicurei però avevano poi finito con il proporre un'etica ascetica
perché, come quasi tutti gli altri filosofi antichi, avevano sostenuto che bisogna evitare
i piaceri mescolati ai dolori. E poiché quasi tutti i piaceri lo sono, bisogna soprattutto
evitare il dolore, scartando anche i piaceri derivanti dalla soddisfazione di desideri non
necessari. Sulla base dell'ascetismo filosofico antico filosofi come il Cartesio delle
Passions de l'âme del 1649 e lo Spinoza dell'Ethica more geometrico demonstrata del
1677 poterono creare una teoria che faceva della conoscenza intellettuale pura lo
strumento per godere delle emozioni senza restarne prigionieri.
Questa teoria reintroduceva il contrasto tra i 'filosofi' e gli uomini comuni, che si
orientano sulle emozioni del momento e che solo premi e punizioni possono sottrarre
alla pressione del piacere e del dolore immediati. Quando aveva scritto il Discorso sul
metodo (1637) Cartesio, dopo aver cercato la verità esercitando il dubbio su tutte le
conoscenze ricevute, aveva trovato qualche difficoltà a ripetere la stessa operazione
con le regole di comportamento; e in attesa di trovare una morale definitiva, si era
accontentato della cosiddetta morale provvisoria. Per il momento avrebbe accettato le
usanze e le credenze del paese in cui aveva scelto di vivere, e le avrebbe seguite con
costanza, cercando di cambiare se stesso piuttosto che le cose. La costanza, una tipica
virtù stoica, era quella che doveva contraddistinguere l'atteggiamento del filosofo
cartesiano da quello degli altri uomini con i quali ha in comune leggi e fede religiosa.
Ma a differenza degli stoici Cartesio non riteneva che ci fosse qualche rispondenza tra
l'ordine della natura e la vita del sapiente. Le virtù dei filosofi antichi rimangono una
buona guida solo perché liberano completamente dalle emozioni e sanciscono il
primato dell'anima sul corpo. Infatti l'ordine dei corpi è completamente diverso
dall'ordine del quale l'anima fa parte, e le emozioni servono in primo luogo soltanto a
mettere in guardia contro i pericoli che minacciano il corpo: perciò è un bene per
l'anima liberarsi da esse. Ma le emozioni possono essere recuperate se vengono
collegate a stati non del corpo ma dell'anima. In questo aiuterà la conoscenza, che
permetterà di andare oltre l'orizzonte ristretto delle cose con le quali si viene a
contatto, e soprattutto rivelerà che l'anima non è messa in pericolo dalle cose che
minacciano il corpo. Il saggio cartesiano perciò non ritiene che le cose rientrino in un
ordine buono, che mira a un fine, ma piuttosto che esse non hanno in se stesse un
significato, se non come occasioni per l'esercizio della superiorità dell'anima.
Si dice di solito che Cartesio abbia sentito l'influenza di una vasta letteratura
rinascimentale, rappresentata in modo esemplare dai Saggi (1580-1588) di
Montaigne, sulla varietà e vanità delle credenze umane. Ma su questa letteratura
Cartesio costruisce una morale che consiste nell'accettazione di un ordine del mondo
non finalistico, un'accettazione che dovrebbe produrre quel piacere intellettuale del
quale erano andati in cerca Platone e Aristotele. Questa idea sarà sviluppata in modo
radicale dall'Ethica di Spinoza. Un'interpretazione delle emozioni analoga a quella
cartesiana, tuttavia, produceva effetti anche nel modo di intendere la vita associata.
Ugo Grozio nel De jure belli ac pacis (1625) aveva cercato di trovare nello stato di
natura l'origine e la giustificazione delle diverse forme politiche. Originariamente gli
uomini vivono in comunità naturali, dalle quali escono dando vita a forme politiche
diverse, che però devono mantenere alcune delle relazioni già presenti nello stato
naturale, rendendole più stabili. Grozio immaginava lo stato di natura soprattutto
attraverso schemi giuridici, derivati dal diritto romano e dal diritto delle genti, cioè il
diritto che regola le relazioni tra uomini che non appartengono alla medesima società
politica. Thomas Hobbes, seguendo un cammino per certi versi parallelo a quello che
aveva portato Cartesio a scorgere nel piacere e nel dolore i moventi fondamentali
dell'uomo e partendo da un netto rifiuto del finalismo, nel De cive (1642) e nel
Leviatano (1651) interpretava lo stato di natura in termini ben diversi da quelli di
Grozio. Nella condizione naturale gli uomini vedono negli altri uomini una minaccia
costante. Ma nello stato di natura tutti gli uomini sono uguali, hanno tutti la medesima
forza e una conoscenza limitata, e non c'è nessuno che possa imporre una disciplina:
per questo lo stato di natura è uno stato di guerra continua ed è ragionevole ritenere
che in esso nessuna intesa è sicura. Solo l'istituzione di un'autorità permette di
costruire una vita ordinata e di dare un significato agli stessi concetti morali: le
valutazioni dei comportamenti sono tutti modi per designare ciò che produce piacere o
dolore, ma danni e vantaggi sono determinabili in modo preciso solo dopo che si è
istituito un ordine politico sicuro abbandonando lo stato di natura. Come Cartesio,
anche Hobbes cercava di recuperare l'etica dei filosofi antichi accolta dalla tradizione
cristiana, ma anche lui la reinterpretava assumendo che piacere e dolore sono gli unici
moventi dell'azione umana e senza supporre che la realizzazione della virtù fosse il
fine di tutta la realtà. Ma a differenza di Cartesio riteneva che gli uomini, più che le
cose, fossero all'origine di ciò che può nuocere o giovare.
Nell'interpretazione hobbesiana dell'etica le norme sono costrutti artificiali,
esattamente come sono entità artificiali le società politiche nelle quali gli uomini
vivono e nelle quali pregi morali e istituzioni giuridiche hanno senso. Il carattere
artificiale di tutti gli apparati normativi era venuto in luce con l'interpretazione
giuridica della società politica data da Grozio, che distingueva l'interpretazione
moderna, giusnaturalistica, da quella medievale della legge di natura. Ma
all'interpretazione giuridica groziana Hobbes aveva sostituito una specie di
“antropologia filosofica”, secondo la quale gli uomini sono ossessionati soprattutto
dalla minaccia rappresentata dai loro simili e subordinano tutto, anche le regole
morali, alla rassicurazione contro questa minaccia. Numerosi saranno i tentativi di
correggere la teoria hobbesiana, accettando la sua antropologia ma evitando di trarne
conclusioni radicali. Per Samuel Pufendorf (De jure naturae et gentium, 1672) come
per John Locke (Trattati sul governo civile, 1690) la società politica è sì una
costruzione artificiale prodotta da contratti, che serve ad assicurare agli uomini il
godimento dei beni esterni, ma lo stato di natura non è quella condizione di guerra
totale, di tutti contro tutti, disegnata da Hobbes. Già nello stato di natura si profila la
possibilità che gli uomini pratichino comportamenti compatibili: e questo permette la
costruzione di società che, pur dovendo tutelare soltanto i beni esterni, sono del tutto
conformi alle regole morali, anche se queste impegnano soprattutto la coscienza degli
individui. E le regole morali sono interpretate in gran parte secondo i canoni della
tradizione filosofica e scolastica.
Dalla discussione sulla legge di natura, dalla reinterpretazione dell'etica antica
attraverso un'antropologia fondata sul piacere e sul dolore e dalla distinzione tra i
compiti della società, deputata a proteggere i beni esterni, e gli obblighi individuali di
coscienza deriva gran parte dell'assetto della teoria etica settecentesca. Da un lato
essa cercherà di sviluppare soprattutto l'idea di artificialità della morale, facendo
regredire l'interesse per la legge di natura e il contratto. Dall'altro riprenderà la
distinzione tra le regole che presiedono le relazioni esterne tra gli uomini e quelle che
vincolano solo la coscienza, approfondendo la distinzione tra le leggi giuridiche e la
virtù morale, lungo una direttiva che condurrà a Kant.
Lungo la prima linea Anthony Shaftesbury (Ricerca sulla virtù e il merito, 1699),
Francis Hutcheson (Saggio sull'origine delle nostre idee di bellezza e di virtù, 1725),
David Hume (Ricerca sui principî della morale, 1751), Adam Smith (Teoria dei
sentimenti morali, 1759) attenueranno l'importanza di stimoli come piacere e dolore e
porranno nel sentimento il principio speciale dell'azione morale. Ma soprattutto meriti
e virtù diventeranno qualità artificiali, assai più vicine alle belle maniere, alla buona
letteratura e alle arti raffinate che alle arcigne virtù filosofiche antiche, alla sospettosa
morale cristiana o all'ossessione per la pace sociale dei filosofi seicenteschi, e Bernard
de Mandeville nella Favola delle api (1705) parlerà del lusso e della ricerca dei piaceri,
che i filosofi antichi consideravano vizi, come di "pubblici benefici", cioè di fattori di
benessere collettivo. Se lo stato di natura, anteriore alla formazione delle società
politiche, poteva essere assimilato alla vita dei popoli 'selvaggi', la società artificiale,
delle belle maniere, della benevolenza e del lusso, era la società civilizzata. Società
artificiali nel grado più alto sono le grandi monarchie moderne, che riescono a farsi
sentire dai loro sudditi solo attraverso complessi apparati simbolici, a differenza dalle
comunità originarie, che sono piccole e sono tenute insieme da rapporti di
benevolenza. Per questo le grandi monarchie moderne possono anche essere intese
come una degenerazione, alla quale occorre porre rimedio con un qualche “ritorno alle
origini”. Oppure, proprio perché sono un corpo artificiale, le monarchie possono essere
riformate, in quanto gli uomini si possono correggere e manovrare, come si fa con una
macchina. Le leggi sono lo strumento delle riforme, leggi efficaci che agiscano sui
moventi reali dell'azione umana, servendosi di sanzioni proporzionate ed effettive,
capaci di generare benefici che tutti possano apprezzare. L'etica e il diritto tendono ad
agire insieme: la morale garantisce il carattere non arbitrario delle leggi e queste
traducono in pratica le indicazioni etiche.