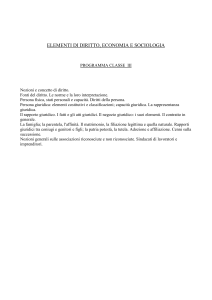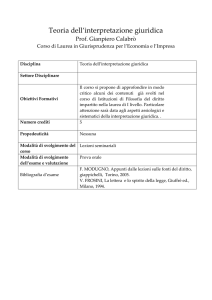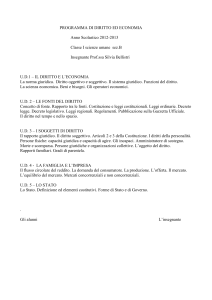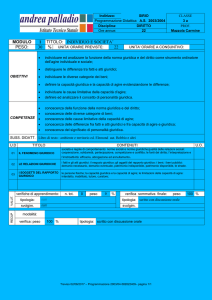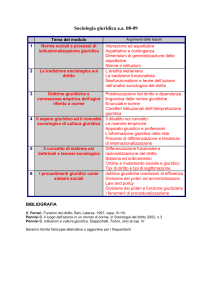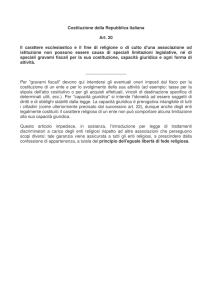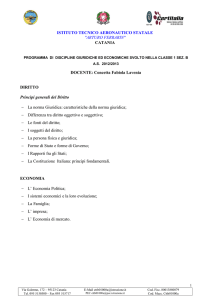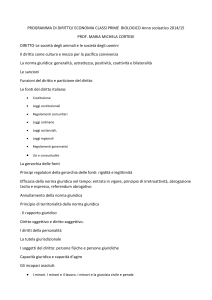Alla ricerca della statualità
Aperture interdisciplinari
della storia delle istituzioni
Convegno della Società
per lo studio della Storia delle istituzioni
Verona, 22-23 febbraio 2012
Aula T1, Polo Zanotto, Università di Verona
Sintesi dell’intervento del prof. Francesco Di Donato
(Ordinario di Storia delle Istituzioni all’Università di Napoli “Parthenope”)
Lo Stato dei giuristi e la statualità dei cittadini (e degli studiosi)
A partire dall’ultimo quarto del XIX secolo la giuspubblicistica tedesca
(culminata nella grande, notissima opera di sintesi di Jellinek, la Allgemeine
Staatslehre uscita nel 1900) seguita poi a distanza nel corso della prima metà
del XX da quella francese (soprattutto con Carré de Malberg) elabora la
nozione giuridica di Stato imperniata su tre elementi strutturali: popolo,
territorio e sovranità. Su questa base, che sul piano storiografico appare però
ancora oggi piuttosto confusa per superficiale scontatezza nei confronti di
questa idée reçue divenuta un luogo comune che quasi tutti gli studiosi
accettano come un dato di fondo indiscutibile, si è costruita tutta la dottrina
giuridica del diritto pubblico e con essa la trasmissione del sapere dei giuristi
contemporanei nell’Europa continentale, influenzando profondamente la
nascita delle costituzioni e la concezione dei diritti e doveri fondamentali dei
cittadini.
Molti dei giuristi formatisi a quella scuola di pensiero e imbevuti di quelle
nozioni riconosciute come un patrimonio comune dei Paesi più avanzati
hanno costituito il nerbo dei gruppi dirigenti nei rispettivi Paesi, assumendo
anche ruoli chiave negli organi giurisdizionali o nelle istituzioni politiche,
ovvero esercitando attraverso il magistero accademico una sensibile influenza
su di esse. Per diversi decenni la dottrina giuridica (costituzionalistica ma non
solo) ha tramandato il nesso concettuale inscindibile tra Stato e Costituzione
(intesa come “carta costituzionale” fondata sostanzialmente sulla
tripartizione suddetta), utilizzando solo concetti tecnico-giuridico-formali e
senza tener conto di reticolati interdisciplinari più complessi.
Ma la crescente complessità interna e internazionale della vita delle
comunità statuali, con riflessi rilevantissimi nel campo economico e
tecnologico, ha determinato ben presto l’asfissia di quel modello teorico
semplicistico. I prodromi di questa stagione di turbolenza intellettuale si
erano già avvertiti in vari campi del diritto nel corso della stessa seconda
metà del XIX secolo. Fu la stagione dei cosiddetti «giuristi inquieti» (da René
Demogue à Édouard Lambert, da Raymond Saleilles a François Gény) sui
quali si è tenuto nel giugno 2011 un interessantissimo seminario
internazionale di studio presso la Law School dell’Università di Harvard
(Franco-American Legal Influences, then and now) che ha mostrato la loro
influenza sui grandi giuristi americani da Oliver Wendell Holmes fino a
Benjamin Cardozo e Jerome Franck. Quella fase si risolse però in un
eclettismo giuridico (esemplare il caso di Gény) che fu il classico rimedio
peggiore del male e che servì soprattutto al «recupero» corporativo del ceto
giuridico (come ha dimostrato A.-J. Arnaud, Da giureconsulti a tecnocrati. Diritto
e società in Francia dalla codificazione ai giorni nostri, Jovene, Napoli 1993).
Come spesso accade la crisi, generata dall’inadeguatezza del modello
teorico a dar conto di una realtà incomparabilmente più complessa, ha finito
invece con il coinvolgere indebitamente anche l’oggetto stesso della
speculazione, in questo caso l’entità statuale in quanto tale (e non solo il suo
correlato concettuale insufficientemente descrittivo). È nata così la
sterminata, monotona, stucchevole e acritica letteratura giuridica sulla “crisi
dello Stato”, con diverse varianti, tipo “declino” o – nei casi più estremi ed
ermeneuticamente violenti addirittura – “epicedio”.
In Italia, ambiente dove sul difetto di spirito analitico s’innesta una diffusa
e generale tendenza a seguire ciecamente le mode e dove si ha una sorta di
piacere innato nel cavalcare le ondate di idee nuove ma non innovative, cioè,
se si preferisce, idee che appaiono “nuove” nella presentazione esteriore ma
che in realtà sono vecchie e insuscettibili di generare piste di ricerca e di vero
avanzamento culturale (vino vecchio e acetato, insomma, travasato in otri
nuovi e luccicanti, buoni solo per impressionare e intorbidare, non certo per
favorire decantazione e limpidezza), in Italia, dunque, questo filone della
“crisi dello Stato” ha avuto un particolare e persistente successo che ha
coinvolto non solo molti ambienti accademici, ma è giunto perfino a
contaminare le linee di tendenza del mercato editoriale. Si è arrivati al colmo
del paradosso nel caso di un libro (S. Cassese, La crisi dello Stato, Laterza,
Roma-Bari 2002) la cui tesi centrale è che lo Stato, pur dovendo «dimagrire»
nell’era del libero mercato, non può essere affatto considerato un modello
obsoleto, quantomeno nell’area occidentale: l’editore, nella convinzione che
ciò favorisse le vendite, ha scelto d’imporre un titolo nel quale campeggia la
fatidica espressione “crisi dello Stato”, il che contraddice frontalmente il
contenuto del volume. In un altro caso – e qui la cosa si fa grottesca oltre
che gravissima sul piano della correttezza del metodo scientifico – un libro di
Rudolf J. Rummel, pubblicato in lingua inglese con il titolo Death by
government, Transaction Publishers, New Brunswick (New Jersey) 1994, è
stato tradotto in italiano con il titolo Stati assassini (Rubbettino, Soveria
Mannelli 2005). Il dato non ha bisogno di commento, se non per il fatto che
è chiaro indice di una mentalità e di una arrière pensée (invero arrière ma anche
arriérée) del tutto anti-scientifica che denota una preconcetta ostilità a una
realtà e a un concetto (nel caso di specie quello di “Stato”), visti a priori come
entità negative e addirittura considerate obbrobriose per definizione. Siamo,
è evidente, agli antipodi della mentalità scientifica che è fondata invece sulla
curiositas e sul desiderio di scoperta senz’alcun apriori. L’unica domanda che
vien da formulare di fronte a casi del genere è questa: che bisogno c’è di
compiere l’improba, faticosa e lunga impresa della ricerca empirico-fattuale
quando la Verità è già evidente ictu oculi per via di rivelazione? Se i risultati
sono anticipati rispetto all’indagine analitica e se il concetto ottunde la realtà
anziché disvelarla e descriverla, si può tranquillamente fare a meno della
ricerca: essa, in quest’ottica, è fastidiosa, inutile e per giunta pure antieconomica. In una parola, nell’ambito del concettualismo logico-formale, del
cognitivismo etico e della dogmatica (giuridica e no) la ricerca è
semplicemente insensata.
I due casi riportati non sono isolati, ma costituiscono esempi lampanti di
una mentalità diffusissima nell’accademia peninsulare, dove al centro
dell’attenzione e della speculazione non vi sono l’impresa scientifica e i suoi
oggetti di studio, bensì fiorisce il culto della personalità degli operatori (in
molti casi) pseudo-scientifici. Questo spiega l’assenza di dibattito o (ciò che è
peggio) l’orgia di dibattiti finti di cui è disseminata la vita accademica italiana,
appuntamenti nei quali un profluvio di parole in libertà soffoca la sobria
durezza del confronto dialettico tra posizioni e linee scientifiche diverse. È
così che in Italia, in quella che Michel Foucault chiamava con sottile e
garbata ironia «la patria della diplomazia», non basta essere ricercatori e
proporre idee, ma occorre prima di tutto essere accreditati dalla e nella
pseudo-comunità scientifica. E va da sé che tale accredito non può avvenire
in base alla sola qualità delle idee proposte, ma avviene di regola in base ad
altri criteri tra i quali campeggiano i rapporti relazionali, la cordialità asociale,
il verbalismo elusivo dei veri problemi. In sintesi: il soffocamento
dell’impresa scientifica in Italia passa attraverso la cooptazione non virtuosa
e l’annientamento del dibattito realizzata attraverso l’eccesso di (finto)
dibattito. È così che all’assenza di vera discussione scientifica corrisponde in
Italia un trionfo dello spirito polemico e una continua personalizzazione dei
confronti, la cui partecipazione è peraltro considerata e vissuta come un
privilegio piuttosto che come un libero diritto di ogni attore sociale nel
campo scientifico di proporre e di trovare ascolto e cooperazione persino
nella smentita e nella confutazione. Partecipare è già insomma un privilegio
accordato, si potrebbe dire octroyé, dai maggiorenti verso i “minorenti”. Prima
di quello stadio (che non corrisponde necessariamente ai gradi della carriera
accademica) c’è il deserto dell’indifferenza e lo snobismo dell’altèrigia che
sempre copre il vuoto delle idee e della vera ricerca. Spesso, troppo spesso si
afferma e riscuote consenso in Italia (così nei circuiti mediatici come nei
concorsi universitari) la brillantezza priva di (vero) talento. Da diversi secoli
nel paese senza statualità l’intelligenza vera e profonda è scavalcata dalla
furbizia e dalla scaltrezza (anche questo è un effetto dell’assenza di «spirito di
Stato»). Del pari l’individualismo sociale è stato completamente fagocitato
dall’individualismo (micro-)feudale. Coperto dall’«invenzione dell’Italia unita»
(così ben descritta nell’omonimo libro di Roberto Martucci), questo spirito
del microfeudalesimo è trasmigrato in ogni manifestazione della vita
pubblica, dai partiti politici alle istituzioni universitarie e si è radicato, per
così dire ‘sublimandosi’, nella forma mentis diffusa e nel disvalore ironico e
disincantato corrispondente a ogni tentativo di far prevalere l’interesse
generale su quelli particolari.
I pochi superstiti del naufragio modaiolo, resisi conto dell’insoddisfacente
definizione dello Stato fondata sui soli presupposti giuridico-formali e
avvertita l’angustia di una definizione pangiuridica del diritto e dello Stato di
diritto, hanno coniato la categoria dottrinale fondata sulla distinzione tra
«Stato-apparato» e «Stato-comunità». Fu già un importante passo in avanti,
ma pur sempre un concetto anch’esso di derivazione logico-dottrinale,
partorito all’interno della forma mentis giuridica tradizionale, concettualmente
innovata, ma ben radicata sull’impianto del linguaggio della vecchia scienza
del diritto. L’idea dello Stato-comunità resta, infatti, eminentemente legata
all’idea di Stato come entità a sé, costruzione spirituale del Giuridico e
termine e misura fondamentale al quale ogni cittadino e la comunità sociale
nel suo complesso non può fare a meno di rapportarsi e – che lo si dica
esplicitamente o no – di essere assorbito. In fondo, si tratta di uno Stato che
si sforza di raccordarsi alla comunità attraverso un suo riconoscimento
giuridico. La comunità è quindi concepita come un’entità a sé, un elemento
che resta ben distinto dall’apparato istituzionale, quand’anche esso ne sia
l’espressione rappresentativa attraverso la fictio juris della rappresentanza
elettorale. Anche quest’ultima, all’interno dell’ordine del discorso costituito
dalle categorie precomprensive determinate dall’ideologia giuridica, è un
fenomeno eminentemente regolato dalla sfera del diritto e dalla sua ipostasi
concettuale e dottrinale ed è quindi destinata a subire la triste sorte
formalistica della normazione ordinaria. In ogni caso, nella concezione dei
giuristi nulla fa pensare alla “comunità” e alle sue complesse articolazioni
psicosociali come al fondamento della statualità. Quest’ultima nozione è nella
mentalità giuridica semplicemente inesistente o identificata con lo Stato toutcourt. Lo Stato-apparato e la sua costruzione idealgiuridica diventano
insomma, nell’ordine del discorso dei giuristi, termine e misura di ogni
dimensione statuale, compresa quella dello «Stato-comunità», una categoria,
non a caso, considerata di recente e senza mezzi termini «erronea» e
sostituita cone quella, senza dubbio più onesta, ancorché del tutto
endogiuridica (anzi in questo caso palesemente endogiuridica), di «Statoordinamento» (S. Cassese, L’Italia: una società senza Stato?, Il Mulino, Bologna
2011, p. 16).
Non è certo privo di significato che la concezione dello Stato fondata sulla
tripartizione (popolo, territorio, sovranità) abbia attecchito maggiormente in
quelle realtà (come la Germania e l’Italia) la cui storia di lungo periodo era
stata tutta all’insegna della pressoché completa assenza della dimensione
aggregativa propria delle aree statualizzate. In queste ultime invece –
specialmente nelle realtà geopolitiche inglese e francese – la riflessione si è
indirizzata piuttosto sui temi assai più concreti del rapporto tra autorità (o
sovranità) e libertà (Hauriou e Duguit: quest’ultimo respingeva apertamente
«la terminologia dei giuspubblicisti tedeschi che distinguono tra il potere
pubblico e la sovranità») e sulla dimensione giuridico-istituzionale intesa
come qualificazione strumentale del Politico (Vedel, Eisenmann, Burdeau),
per pervenire infine a una raffinata definizione dello Stato come del «nome
che si dà al potere politico quando si esercita in una certa forma, la forma
giuridica» (Michel Troper, Per una teoria giuridica dello Stato, trad. it. Guida,
Napoli 1998, p. 170).
Ma queste sintesi sono a loro volta il frutto di un ambiente socioculturale
capace di generare potentissime strutture precomprensive nelle quali la forma
mentis imperniata sull’organizzazione statuale è stata dominante se non
egemone. Le società francese e inglese avevano fin dall’inizio del millennio
trovato potenti forme organizzative di aggregazione e di cooperazione,
sviluppando per un verso i concetti di «cittadinanza» e di «patria» (basti
ricordare al riguardo il bellissimo saggio classico di Ernst Kantorowicz, Pro
patria mori, trad. it. in Id., I misteri dello Stato, Marietti, Genova-Milano 2005,
pp. 67-97; va sottolineato, poiché questo particolare ha grande importanza,
che si tratta del Kantorowicz nella fase americana e non in quella tedesca) e
per un altro sperimentando forme sempre più sofisticate e raffinate di fiducia
individuale e sociale tanto orizzontale (tra individui) quanto verticale (tra
individui e istituzioni e viceversa). Ciò fu reso possibile dal superamento del
provvidenzialismo metafisico e da un deciso processo di laicizzazione,
prodromo del convenzionalismo contrattualistico e di una scepsi non
nichilistica, ma propulsiva (esemplare al riguardo la personalità di Michel de
Montaigne in Francia, che spianò la strada al potente razionalismo
cartesiano). Furono questi i padri nobili del costituzionalismo e, sulla longue
durée, della statualità democratica contemporanea, come seppe genialmente
intuire Tocqueville.
In tal modo si è determinata una costruzione dal basso della statualità
sociale che è del tutto opposta alla costruzione giuridico-istituzionale calata
dall’alto dell’astrazione concettuale, ossia dedotta dalle categorie della teoria
giuspolitica elaborata dalla forma mentis di un gruppo elitario d’iniziati (come
accadde nel mos italicus). Così, dalle radici culturali e antropologiche della
struttura sociale è venuto formandosi quello che Pierre Bourdieu ha indicato
come «l’interesse al disinteresse» quale valore fondamentale per la
costruzione dello Stato inteso «come luogo neutro» nel quale «i valori del
disinteressamento sono ufficialmente riconosciuti» (Sur l’État. Cours au Collège
de France 1989-1992, Seuil, Paris 2012, pp. 13 ss.).
Proprio la presenza di questi assets socioculturali, favoriti da un terreno
religioso propizio ai processi di laicizzazione (perfettamente descritti da J. R.
Strayer all’inizio degli anni ’40 del XX secolo e solo da pochissimo tradotti
per la prima volta e fatti conoscere in Italia agli studiosi di buona volontà,
ahinoi! pochi), ha favorito il sorgere e il radicarsi della mentalità sociale
imperniata sui valori della socialitas. Quest’espressione, usata da Samuel
Pufendorf, fu poi destinata a grande fortuna elaborativa nelle élites
intellettuali più acute d’Europa: si pensi solo al concetto di esprit de société in J.J. Rousseau. Ma l’idea della cooperazione sociale in Francia è molto più
antica, se si pensa a figure come Incmaro di Reims (IX sec.), al Carmen ad
Rodbertum regem di Adalberone di Laon o ai Gesta episcoporum cameracensia di
Gerardo di Cambrai, entrambi, secondo la ricostruzione di Georges Duby,
degli anni venti dell’XI secolo.
Se si vogliono studiare lo Stato e la statualità bisogna andarli a cercare
dove essi sono e non dove essi non sono e non possono essere. È questo, a
mio avviso, il difetto maggiore di quelle interpretazioni che, prendendo a
modello l’area germanica e poggiandosi sulla storiografia tedesca (soprattutto
Hintze e Brunner), hanno inteso espungere da essa gli elementi fondamentali
della storia dello Stato (Schiera, Fioravanti), facendoli diventare strutture
universali applicabili sempre e ovunque, come entità dogmatiche e
atemporali. Eppure tanto Max Weber quanto Carl Schmitt, quando
parlavano dello Stato, avevano in mente la realtà storica francese e
occidentale e non certo quella tedesca e dell’area germanica (è, d’altronde,
proprio questo il motivo della scarsa fortuna iniziale di Weber in Germania e
del suo postumo ‘rimbalzo’ parsonsiano dagli Stati Uniti all’Europa
occidentale).
Inoltre negli studi storico-giuridico-istituzionali peninsulari sullo Stato il
profilo prettamente giuridico è egemone e totalizzante. Maurizio Fioravanti,
che ne è in buona misura lo studioso più rappresentativo e conosciuto, ha
dato una risposta recisamente affermativa al quesito «È possibile un profilo
giuridico dello Stato moderno?» che gli era stato rivolto in un congresso
svoltosi presso la Scuola Superiore di Studi Storici dell’Università di San
Marino. Egli anzi ha rilanciato la posta in gioco, affermando in sede
congressuale che la comprensione dello Stato moderno passa solo attraverso
la delineazione di un profilo giuridico e sviluppando poi questo concetto in
un discorso nel quale il protagonista esclusivo è lo «Stato» così come definito
ex post dai giuristi (prevalentemente tedeschi e/o italiani intedescati) e dalla
loro dottrina. Costruzioni di questo tipo non portano a migliorare la
comprensione del fenomeno statuale in Occidente e realizzano solo una
superfetazione delle categorie dottrinali endogiuridiche, contribuendo a
isolare il diritto e la storia giuridica in un ghetto che solo i suoi prigionieri (gli
storici che la producono) si figurano come una torre avoriata, ma che è in
realtà un non-luogo d’isolamento totale del diritto e del suo sapere storico
dalle scienze sociali. Si tratta, a rigore, di narcisismo illusionistico e anche in
una certa misura di delirio di onnipotenza sotto specie di sindrome di
completezza e autosufficienza (a dispetto del teorema di Gödel). Che cosa ha
tutto ciò da spartire con l’interdisciplinarità di cui la scienza si nutre? Non è
un caso se da anni lo studioso pratese (al pari di altri) si sia chiuso in uno
sdegnoso silenzio e si rifiuti di rispondere a importanti questioni sollevate
dalla sua lettura del fenomeno statuale. L’assenza di dibattito è conseguenza
della scarsa propensione al confronto obiettivo, che invece dovrebbe essere
sempre accettato e anzi favorito in una comunità scientifica.
Se davvero si ha l’obiettivo di sviluppare un’analisi seria e motivata sullo
Stato e sulla statualità, la via metodologica da seguire è, tutto all’opposto
della costruzione idealgiuridica, lo studio dei fattori interattivi che
determinano i legami verticali e orizzontali tra le istituzioni e la società e che
producono nella linfa di quest’ultima quegli elementi che favoriscono per un
verso l’autodisciplina e la capacità d’introiettamento delle regole e per un
altro il senso dell’organizzazione e della cooperazione nel rispetto dei limiti
invalicabili di autodeterminazione di ciascun individuo-cittadino. Questo
discorso ha una molteplicità polisemica incoercibile. Il più importante dei
significati che esso implica è lo studio delle modalità storiche e dei contesti
politico-istituzionali e antropologico-culturali che producono le
determinazioni psicosociali. Senza un adeguato studio «psico-socio-analitico»
(uso qui volutamente la nota espressione di Wilfred R. Bion ripresa in Italia
da Luigi Pagliarani) dei percorsi storici determinatisi in ciascun agglomerato
sociale e politico non si arriverà mai a comprendere di che cosa parliamo
quando parliamo di statualità. Come ha sintetizzato perfettamente Serge
Moscovici, il fondatore della teoria delle Social Representations, «è del tutto
logico tener conto del fatto che i processi sociali e pubblici […] sono stati
gradualmente interiorizzati per divenire processi psichici»; e perciò conoscere
le rappresentazioni sociali e spiegare che cosa esse «significano, costituisce il
primo passo in ogni analisi di una situazione o di un incontro sociale, e
costituisce un mezzo di previsione dell’evoluzione delle integrazioni di
gruppo». In tutte le scienze sociali – e vorrei vedere a chi venga in mente di
mettere in dubbio che la storiografia vi appartenga a pieno titolo – diventa
perciò prioritario «esaminare l’aspetto simbolico delle relazioni e degli
universi consensuali. […] Questo è ciò che distingue il sociale
dall’individuale, il culturale dal fisico e lo storico dallo statico» (Le
rappresentazioni sociali, Il Mulino, Bologna 2005, pp. 98, 93 e 99).
Questa è la nuova frontiera delle scienze sociali che emerge dalla
comparazione, dall’internazionalizzazione dei saperi e dall’interdisciplinarità.
Nel contesto codino e con(trori)formista dei moralisti (di facciata) italiani (si
veda al riguardo il bellissimo recente volume di Amedeo Quondam, Forma del
vivere. L’etica del gentiluomo e i moralisti italiani, Il Mulino, Bologna 2010, che ne
descrive origine e percorsi), permeata dallo spirito compromissorio
medievale e microfeudale di cui i giureconsulti-esegeti furono gl’insuperabili
campioni e dei quali i giuristi contemporanei sono per tanti versi gli eredi
responsabili della paralisi giudiziaria e della rovina della cosa pubblica (oggi
un’evidenza per tutti, ma storiograficamente ben dimostrata già da qualche
anno in un importante studio di Raffaele Ajello, Eredità medievali, paralisi
giudiziaria. Profilo storico di una patologia italiana, L’Arte Tipografica, Napoli
2009, pressoché ignorato dalla comunità pseudo-scientifica peninsulare),
all’assenza cronica e disastrosa di statualità (ossia di organizzazione sociale: si
veda al riguardo il bellissimo e sintetico lavoro di due studiosi non
accademici, P. Pellizzetti e G. Vetritto, Italia disorganizzata. Incapaci cronici in un
mondo complesso, Dedalo, Bari 2006) non poteva che corrispondere
un’altrettanto ignominiosa dismissione critica della storiografia e della teoria
giuridica, che restano abbarbicate alla storia delle norme e delle loro fonti
formali e di regola non si occupano dei rapporti tra evoluzione socioculturale
e formazione mutevole del diritto.
La stessa storiografia istituzionalistica sembra sia stata influenzata da
questo clima caratterizzato dall’esasperazione dei tratti formalistici e
normativistici tipici della storia giuridica more italico. In reazione al quale essa
ha finito con il chiudersi in un feticismo dell’atto documentario inteso quale
unica fonte significativa di riferimento per la ricostruzione della vita
istituzionale (Ettore Rotelli). Come se le istituzioni non “pensassero” (Mary
Douglass, Come pensano le istituzioni, trad. it. Il Mulino, Bologna 19982, 1a ed.
1990) e come se per farle funzionare non occorresse un pensiero sottostante
e préalable, a sua volta nutrito dal ribollire d’interessi, sentimenti politici e
rappresentazioni simboliche dei quali si sostanzia la vita di un agglomerato
sociale. Si assiste, inoltre, a una deriva di parcellizzazione ricostruttiva che
isola le istituzioni e le studia come se esse fossero sospese nell’aere
metafisico e non nel vivo della dura lotta per il diritto (per riprendere la
celeberrima espressione di Rudolf Jhering), ossia per l’affermazione di idee
su altre idee, che operano nella dimensione irrelata delle strutture mentali e
sociali.
Si spiega così come la grande maggioranza (per non dire la quasi totalità)
degli studi italiani che hanno inteso porsi l’obiettivo di descrivere la vicenda
dello Stato abbiano coniato e continuino a utilizzare categorie concettuali
completamente sganciate dalla realtà e di pura fantasia (come la definizione
di «Stato regionale», che serve solo per evitare di chiamare per nome la
microfeudalità subalpina) o abbiano inventato «vie» particolari «allo Stato
moderno», senza mai tener conto dei rilevanti progressi degli studi storici
realizzati oltr’Alpe, tutti rigorosamente attestati, all’opposto, sul metodo della
continua comparazione tra valori e fatti e tutti interessati a scoprire i nessi –
visibili o sotterranei – attraverso i quali le vicende istituzionali della statualità
s’innervano e si embricano con le norme effettivamente vigenti nel quadro
dei comportamenti sociali e delle mentalità collettive (da Colette Beaune a
Jacques Krynen e Albert Rigaudière, per non parlare di studi ormai classici
come quello di Charles Petit-Dutaillis, La monarchie féodale en France et en
Angleterre. Xe-XIIIe siècle, La Renaissance du livre, Paris 1933; o quello di
Marcel David, di recente scomparso, La souveraineté et les limites juridiques du
pouvoir monarchique du IXe au XVe siècle, Dalloz, Paris 1954; o ancora quello di
Michel Mollat, Genèse médiévale de la France moderne, Seuil, Paris 1977; o, più di
recente, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, l’enorme serie di
pubblicazioni coordinate da Jean-Philippe Genet sotto il titolo generale di
Genèse de l’État moderne). In effetti, è impressionante constatare come gli studi
storico-giuridici o istituzionalistici italiani non si confrontino con
quest’ampia letteratura storica e teorica e ruotino invece sempre intorno agli
stessi vecchi testi, invero piuttosto appassiti. Solo raramente le note a pié di
pagina dei libri italiani apportano citazioni bibliografiche contenenti
innovazioni interessanti. Esse si limitano per lo più a citazioni meramente
illustrative, quando non ad pompam o reverenziali, senza discutere quasi mai
criticamente i contenuti dei testi segnalati. Il metodo della citazione ab
auctoritate inaugurato nel medioevo bolognese da glossatori e commentatori è,
tutto sommato, ancora in vigore.
Da questo punto di vista si può concludere che la storiografia italiana sullo
Stato, anche nelle sue manifestazioni più recenti e inizialmente promettenti,
mantiene un’orgogliosa chiusura disciplinare, è caratterizzata da un’incapacità
cronica ad aprirsi al confronto con le ben più avanzate storiografie
transalpine e con i metodi delle scienze psico-sociali, e produce un ‘vanto’
corporativo, che non hanno, né le une né l’altro, alcuna ragion d’essere se
non la difesa di un minuscolo territorio, oramai fertile solo nell’immaginario
onirico, nel quale in realtà la sabbia desertica ha sostituito da tempo l’humus
produttivo.
Parole chiave: Stato e statualità; storiografia giuridica e storiografia
istituzionale; metodo interdisciplinare e metodo comparativo; critica
storiografica e assenza di dibattito scientifico in Italia; crisi della crisi dello
Stato.