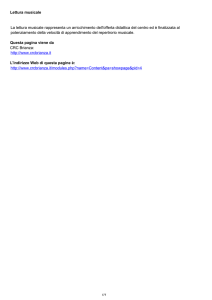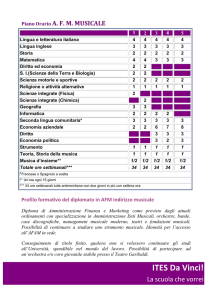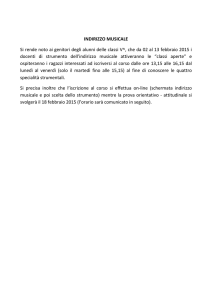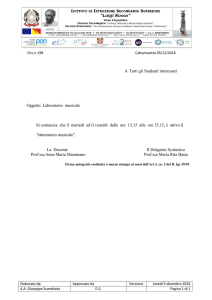Serie speciale della rivista
on-line dell’Associazione
Italiana di Studi Semiotici
www.ec-aiss.it
Direttore responsabile
Gianfranco Marrone
Anno I, n. 1 2007
ISSN (on-line): 1970-7452
ISSN (print): 1973-2716
Mutazioni sonore
sociosemiotica delle pratiche musicali
n1
EC
a cura di Patrizia Calefato, Gianfranco Marrone e Romana Rutelli
contributi di:
Claudia Attimonelli
Guido Ferraro
Felice Liperi
Paolo Peverini
Daniele Barbieri
Francesco Galofaro
Dario Mangano
Maria Pia Pozzato
Nello Barile
Serena Guarracino
Luca Marconi
Lucio Spaziante
Patrizia Calefato
Paolo Jachia
Raffaele Mellace
Eero Tarasti
Francesca De Ruggeri
Stefano Jacoviello
Michele Pedrazzi
Andrea Velardi
Mutazioni sonore
sociosemiotica delle pratiche musicali
EC
a cura di Patrizia Calefato, Gianfranco Marrone e Romana Rutelli
Questa rivista
Questo numero
L’oggetto che avete in mano è la versione stampata e rilegata del
primo numero monografico di “E/C”, rivista generalmente on
line all’indirizzo www.ec-aiss.it. Questa rivista, organo dell’Associazione italiana di studi semiotici (Aiss), dal 2004 pubblica
materiali di vario genere – saggi, ricerche, recensioni, interviste,
preprint, resoconti di seminari e convegni etc. – sui principali temi
teorici e applicativi della ricerca semiotica, italiana e non: dall’alimentazione ai conflitti, dall’arte ai media, dalla moda alla
politica, dalla temporalità alla traduzione e così via (cfr. l’archivio
tematico presente nel sito).
Da qualche tempo è stata avvertita l’esigenza che, accanto a questo
lavoro di testimonianza degli studi già in corso, se ne accompagni
un secondo, più strutturato dal punto di vista tematico, che provi a
stimolare progetti di ricerca ulteriori.
È nata così l’idea di una serie di numeri monografici della rivista,
a partire da specifici call for papers proposti da studiosi di diversa
provenienza teorica e generazionale. E difatti i prossimi numeri
della rivista si occuperanno dei temi della perfomance negli spazi
urbani, del senso del design, delle guide turistiche. E altri ancora
sono già in fase di ideazione, nella speranza che i consigli e le critiche dei colleghi e degli amici semiologi ci spingano a portare avanti
una iniziativa non facile ma, speriamo, utile e gradita.
La musica pervade la vita quotidiana. Il suono, il rumore, il linguaggio musicale articolato scandiscono le
esperienze comunicative, attraversano e modellano le
pratiche sociali. Se la musica ha a che vedere in modo
costitutivo con il linguaggio, caratterizzandosi – come
il linguaggio – in funzione del ritmo, del tempo, dello
spazio e della sensorialità, i segni che compongono il
“paesaggio sonoro” costruiscono “forme di vita” vere e
proprie che delle sonorità si alimentano e che le riproducono. Basti menzionare le tante forme di espressione e contenuto presenti in innumerevoli discorsi, quali
quello cinematografico (colonne sonore), quello teatrale
(accompagnamenti, opere liriche), letterario (romanzi con il tema della musica), pubblicitario (i jingles); e
ancora, l’informazione (la musica nei Tg), la moda (le
sfilate a suon di musica), l’architettura (ambientazioni
sonore in punti-vendita, ma anche in luoghi pubblici), i
videoclip, la TV commerciale…
I testi raccolti in questo fascicolo analizzano secondo
una prospettiva sociosemiotica alcuni modelli, forme,
usi espressivi e comunicativi delle pratiche musicali, con
un occhio particolare rivolto alla contemporaneità, ma
anche con alcune “variazioni” finali rivolte a considerare, attraverso Mozart, alcuni aspetti dell’interferenza
tra classico e contemporaneo.
I contributi provengono per la maggior parte da un
convegno omonimo svoltosi al Dams di Imperia nel
settembre del 2006. Al convegno, organizzato grazie
ai contributi della Provincia di Imperia, dell’Università
di Genova, del Dipartimento di Scienze Linguistiche
e Culturali (fondi Rutelli) e all’appoggio del Polo
Universitario Imperiese, avevano partecipato anche
Claudio Lugo e Luca De Gennaro, i cui interventi (data
la loro particolare fattura mediale) compariranno sulla
versione elettronica della rivista, come anche Federico
Montanari, il cui testo sarà pubblicato in seguito. Il
convegno – che ha un precedente in quello imperiese
del 2004 su Mutazioni audiovisive – ha dato luogo a una
continuità che è suscettibile di diventare un’occasione
abituale. Ci pare per esempio opportuno accennare
che a tale iniziativa ne sta per seguire un’altra: l’istituzione di un Master, realizzato a Sanremo in collegamento con il celebre Festival, sul tema della canzone e
dei suoi risvolti attinenti ai fenomeni di comunicazione.
Poiché la canzone, e in generale l’intera gamma della
produzione musicale giovanile, costituisce un fenomeno
comunicativo di grande rilievo e risonanza, e un tema
importante nell’ambito della sociosemiotica, si prevede
e ci si augura una attenzione e un sicuro coinvolgimento al progetto da parte dei membri dell’Aiss e di tutti i
semiologi interessati a esso.
g.m.
presentazione
p.c. – g.m. – r.r.
E|C - Serie Speciale della rivista on-line dell’Associazione Italiana di Studi Semiotici - www.ec-aiss.it
Direttore responsabile: Gianfranco Marrone
Comitato Scientifico: Nicola Dusi, Guido Ferraro, Gianfranco Marrone, Isabella Pezzini, Maria Pia Pozzato
Redazione: Maria Claudia Brucculeri, Elena Codeluppi, Alice Giannitrapani, Tommaso Granelli,
Dario Mangano, Francesco Mangiapane, Ilaria Ventura
Testata registrata presso il Tribunale di Palermo, n. 2 del 17.1.2005, ISSN (print): 1973-2716, ISSN (on-line): 1970-7452
La rivista adotta un sistema di selezione degli articoli basato su peer-review.
Numeri arretrati possono essere richiesti alla redazione inviando una e-mail all’indirizzo: [email protected]
Progetto grafico: Dario Mangano
p. 3
Presentazione
sezione uno
composizione, ascolto, fruizione
sezione quattro
sinestesie mediali, corporeità
p. 9
Michele Pedrazzi
Oggetti ed effetti sonori. Pratiche della
composizione musicale contemporanea
p. 105 Luca Marconi
Enunciazioni e azioni nella canzone e
nel videoclip
p. 15
Maria Pia Pozzato
Pratiche musicali e identità sociale.
Il caso di Grado
p. 115 Paolo Peverini
Dal bastard pop al mash-up.
Mutazioni in corso
p. 21
Guido Ferraro
Raccontare la perdita del senso.
Per un’analisi della musica dei King Crimson
p. 121 Dario Mangano
Azioni e distensioni.
Ipotesi sul corpo e il tempo nel jazz
p. 31
Andrea Velardi
Che senso ha la musica?
Per una semiotica dei codici monoplanari
p. 133 Francesca De Ruggeri
Requiem for a dream di Darren Aronofsky.
Ritmo e audiovisione
sezione due
ibridazioni, alterazioni
sezione cinque
interferenze mozartiane
p. 43
Felice Liperi
Oltre i margini del suono. L’ibridità fra
tradizione e innovazione
p. 141 Eero Tarasti
Mozart or the Idea of a
Continuous Avantgarde
p. 47
Francesco Galofaro
Tensione e risemantizzazione al cinema. Da
La grande illusione a Casablanca
p. 53
Stefano Jacoviello
Spaghetti country-western, valzerini
e fratture psichedeliche.
Ovvero: come i fantasmi di Spoon River,
quando ebbero la voce, cantarono all’italiana
p. 147 Daniele Barbieri
Quando Mozart faceva piano bar.
Appunti per una sociosemiotica
dello sfondo
p. 67
p. 151 Raffaele Mellace
Interferenze contemporanee. Mozart,
Corghi e Il dissoluto assolto
Paolo Jachia
Anime salve di Fabrizio De Andrè e Ivano
Fossati. Un’analisi semiotica
sezione tre
questioni di genere, questioni di stile
p. 73
Patrizia Calefato
“Due notine d’argento”. Mina, la moda, la
musica e la televisione italiana dei 60
p. 77
Lucio Spaziante
Hip, beat, cool. Culture musicali giovanili
e sistemi di valore
p. 85
Nello Barile
Revival dell’estetica pop-porno
p. 91
Claudia Attimonelli
Techno-gender. Un’analisi sociosemiotica
della nozione di gender in relazione alla
pratica del djing nella techno
p. 97
Serena Guarracino
Un’altra opera. Lirica, femminismo,
postcolonialismo
indice
sezione uno
composizione, ascolto, fruizione
1. Per cominciare: l’oggetto sonoro
Nella grande varietà degli approcci e delle pratiche della composizione musicale contemporanea, è possibile
gettare uno sguardo d’assieme secondo una prospettiva
un po’ periferica, ma ancora non troppo usurata, quella
che chiama in causa le nozioni di oggetto ed effetto sonoro. Molte davvero sono le pratiche legate all’ambito
musicale, sia per l’effettivo numero di attori in gioco,
sia perché molte sono le abilità sviluppate dal musicista-tecnologo contemporaneo, che oggi idealmente può
lavorare in autonomia su ogni fase della creazione, dalla performance fino ai ritocchi finali in sede di missaggio. In questa sede mi concentrerò su una pratica apparentemente lontana da tecnologie ed effetti speciali:
l’ascolto. Come si vedrà, tale pratica fa parte del nucleo
profondo della teoria degli oggetti e degli effetti sonori,
e permette uno sguardo unificante su attività apparentemente lontane.
1.1 Fonofissazioni di un musicista ingegnere
I primi, conclamati oggetti sonori videro la luce nel 1948,
quando il compositore francese Pierre Schaeffer iniziò
a sperimentare la creazione di musica tramite la tecnologia della “fonofissazione”1, utilizzando come materia
prima per le sue composizioni le registrazioni di “rumori, strumenti musicali tradizionali, occidentali o esotici, voci, discorsi, vari tipi di suoni sintetici” (Schaeffer
1966, p.60), in definitiva suoni “preesistenti, presi in
prestito da un qualsiasi materiale sonoro, sia rumore o
musica” (Schaeffer in Gentilucci 1982, p.34). I primi
esempi di simili composizioni erano a tutti gli effetti dei
montaggi altamente elaborati, quando non addirittura
equilibristici, di diversi grammofoni fatti funzionare assieme, secondo un approccio che possedeva certamente
i tratti del gioco e del bricolage, ma che nondimeno rispondeva ad una profonda curiosità intellettuale e speculativa. La definizione concettuale arrivò con gli anni,
e si dovette aspettare il 1966 perché Schaeffer pubblicasse la summa delle sue ricerche, il Traité des objets musicaux, che conteneva la vera e propria grammatica di
questo nuovo linguaggio musicale. Quei frammenti di
fonofissazioni non sarebbero diventati objets sonores senza
che Schaeffer avesse continuato a lavorare come teorico e non avesse creato attorno a sé la scuola del Groupe
de Recherches de Musiques Concrète (GRMC, poi divenuto il
GRM tutt’ora esistente). L’ambiente in cui conduceva
le sue ricerche era un ambiente ibrido, dato che egli,
prima ancora che musicista, era ingegnere: tale carica,
che agli esordi esercitava presso la studio sperimentale
della RTF (Radio Télévision Française), gli dava possibilità
di mettere in atto le pratiche della nuova musica in studi
di registrazione dotati della tecnologia necessaria, allora piuttosto rara. Culturalmente, si trattava comunque
un ambiente di avanguardia musicale, ovvero quello di
una frangia di musicisti che nelle dichiarazioni di intenti originarie – “far saltare le scogliere di marmo del-
E|C Serie Speciale
Anno I, n. 1 2007, pp. 9-14
ISSN (on-line): 1970-7452
ISSN (print): 1973-2716
EC
Oggetti ed effetti sonori.
Pratiche della composizione
musicale contemporanea
Michele Pedrazzi
l’orchestrazione occidentale” – ricordavano in più punti il progetto rumorista del futurismo di Luigi Russolo
(“Beethoven e Wagner ci hanno squassato i nervi e il
cuore per molti anni. Ora ne siamo sazi”).
1.2 Concretamente, la rivoluzione
Per quanto sia a tutt’oggi relegata ad una conoscenza specialistica, la rivoluzione di Schaeffer fu davvero
grande, e ancora oggi rimane fresca e foriera di ispirazione. Fu innanzitutto una rivoluzione del piano dell’espressione musicale. I nuovi usi della tecnologia davano accesso al “tutto” sonoro come mai prima d’allora.
Il discorso musicale, per essere enunciato, era sempre
stato vincolato alla presenza di un interprete intermediario, ovvero l’esecutore, e ad una gamma precisa di
timbri standardizzati, immodificabili dal compositore,
ovvero gli strumenti musicali (inclusa la voce umana).
Anche musicisti come Beethoven o Wagner si ponevano
di fronte alle proprie orchestrazioni in termini di materiale sonoro, ma tutto quello che potevano fare per
operare su di esso era trovare una mediazione musicale.
Là dove un “orecchio sonoro” avesse richiesto di enfatizzare le frequenze alte, l’unica strategia possibile era
di operare sull’arrangiamento ed inserire, ad esempio,
una parte di ottavino ove necessario. Con l’apertura
schaefferiana, il timbro di ottavino diventa solo una delle molteplici possibilità. Il pre-musicale si rivela il piano,
tutt’altro che de-semantizzato, della grana sonora, così
come per Roland Barthes il pre-verbale diviene il luogo
della grana vocale, che attraverso “la grana della gola,
la patina delle consonanti, la voluttà delle vocali, tutta
una stereofonia della carne profonda” rivela “l’articolazione del corpo, della lingua, non quella del senso,
del linguaggio” (Barthes 1973, p. 127 – curiosa la scelta del termine “stereofonia”). Schaeffer era ancora più
radicale in questo: abolendo le “scogliere di marmo”
del linguaggio orchestrale non era assolutamente interessato a rivelare un insieme di corpi vibranti, ciò che
© 2007 AISS - Associazione Italiana di Studi Semiotici
T. reg. Trib. di Palermo n. 2 - 17.1.2005
il suo empirismo, poco efficace per l’affermazione accademica, si ricongiungerà per vie sotterranee con la
popular music e le sue pratiche.
10
gli interessava davvero era far emergere l’articolazione
sonora in sé.
A dispetto degli sforzi del GRMC, la diffusione della
sensibilità “concreta” fu lenta, parziale, e soprattutto
remota. Innanzitutto, già dagli inizi la nuova musica
parigina venne ostacolata dalla querelle con la musica
elettronica tedesca, che stava nascendo in quegli anni a
Colonia2. La posizione degli elettronici era in sostanza
opposta: escludendo dalla tavolozza ogni tipo di suono preesistente, essi lavoravano con suoni prodotti da
generatori elettronici e poi depositati direttamente su
nastro. In apparenza, non vi era più assolutamente
nulla di “preso in prestito”, né dal mondo naturale, né
dal liutaio, nemmeno dal costruttore di sintetizzatori,
perché l’impressione era quella di lavorare direttamente
con un codice genetico, costituito dai numeri del suono.
Una simile razionalizzazione del processo compositivo
apriva un campo di possibilità astratto e asettico, distante anni luce dall’empirismo parigino, e ad esso polemicamente contrapposto. In simile querelle furono gli
elettronici a vincere, inglobando sotto la loro egida la
musica concreta, che pativa un’apparenza troppo disinvolta e naïf rispetto all’austero sperimentalismo tedesco.
“Non mantiene nella maniera più assoluta le promesse
che qualche intuizione teorica lascerebbe sperare” giudica Armando Gentilucci nella sua (faziosa) Introduzione
alla Musica Elettronica del 1982. E così quando nel 1955
il compositore elettronico Stockhausen include nel suo
Gesang der Jünglinge alcune registrazioni concrete, il momento viene salutato come quello della sintesi logica e
artisticamente pregna delle ricerche francesi e tedesche,
la vera rivoluzione, cui viene dato il nome unificante di
“elettroacustica”. I concreti, quindi alla fine degli anni
cinquanta, trovano gli spazi dell’avanguardia occupati
dagli elettronici, o, per meglio dire, dagli elettroacustici,
tanto che persino Schaeffer fa marcia indietro e ritratta le sue posizioni. Ma come avremo modo di vedere,
2. Il prodotto di un particolare tipo di ascolto
Nonostante le alterne fortune dal punto di vista dell’effettiva produzione musicale e della ricezione critica3,
l’apparato teorico dei musicisti concreti si staglia come
prezioso corpus di idee e suggestioni, coordinate da uno
straordinario, seppure a volte dispersivo, intento sistematizzante. Una delle definizioni cardine di questo corpus è ovviamente quella dell’oggetto sonoro.
L’oggetto sonoro è un avvenimento sonoro percepito
come un insieme, come un tutto coerente e udito attraverso un ascolto ridotto (ècoute réduite), che lo riguarda cioé
per se stesso, indipendentemente dalla sua provenienza
o dal suo significato4. Si accede all’oggetto sonoro attraverso un’esperienza che viene significativamente battezzata acusmatica, in memoria delle lezioni della scuola
pitagorica in cui il maestro parlava nascosto dietro una
tenda, per evitare di distrarre i discepoli con il proprio
aspetto corporeo. L’esperienza acusmatica permette di
lavorare sul suono concentrandosi direttamente sulle
sue qualità fisiche percepite, con una chiusura epistemologica che si potrebbe parafrasare con un “fuori
dal suono non vi è salvezza”, facendo eco a quello che
fece la semiotica francese con l’oggetto testuale a partire dagli anni ’60. Il passaggio dal musicale al sonoro,
o meglio il naturale confluire del primo nel secondo,
nella trattazione di Schaeffer doveva aprire la strada
ad un nuovo solfeggio, una nuova grammatica che regolasse le catene (e le sovrapposizioni) delle unità sonore
(Schaeffer 1966, pp. 475-597). Il solfeggio degli oggetti
sonori non ha avuto il successo previsto, oggi le regole
della musica concreta non sono state istituzionalizzate.
Ma la definizione dell’oggetto racchiude una potenza
sottostimata e moderna: l’oggetto sonoro non è un materiale, non è un tratto di proprietà fisiche, ma non è
neanche il prodotto di un’inscrizione o di un gesto produttivo. È innanzitutto il prodotto di un particolare tipo
di ascolto, l’ascolto ridotto. Le implicazioni fenomenologiche di questa prospettiva sono chiare. Gli oggetti sonori
non esistono in sé, non sono le cause della percezione,
ma è vero semmai che ascolto e oggetti si definiscono
mutualmente, rispettivamente come attività percettiva
ed oggetto di percezione. Ascolto e oggetto sono dei
“correlati” (Schaeffer 1966, p.267).
Chiaramente il pensiero di Schaeffer è in più punti accostabile alle teorie di Husserl e di Merleau-Ponty, e lui
stesso vi si riferisce esplicitamente. Ma in quest’ambito ciò che vorrei sottolineare è che l’ascolto descritto
nel nucleo teorico della musica concreta può essere ulteriormente indagato nella prospettiva delle pratiche
semiotiche. L’ascolto ridotto, lontano dall’essere mera
ricezione, travalica i confini di un banale processo di
decodifica per assurgere allo stato di un vero e proprio
agire musicale. Il nuovo ascolto è un fare.
Michele Pedrazzi · Oggetti ed effetti sonori. Pratiche della composizione musicale contemporanea
2.1 Un nuovo tipo di attenzione
Vediamo allora la definizione ufficiale dell’ascolto ridotto. Il riferimento per queste definizioni classiche è
ovviamente il traité di Schaeffer (1966, pp. 270-272), più
agilmente consultabile anche nella versione compilata a
dizionario che ne fece Michel Chion nel 1983, la Guide
des objet sonores. L’ascolto ridotto è ascoltare il suono per
se stesso, come oggetto sonoro, facendo astrazione dalla
sua provenienza, reale o supposta, e dal senso5 di cui
può essere portatore. Ma la definizione è incompleta
se non si tiene presente che l’ascolto ridotto è descritto in più parti come “un’attitudine”, sostanzialmente
come un vero e proprio abito; ovvero come scriveva C.S.
Peirce, “la modificazione della tendenza di una persona
verso l’azione, tendenza che risulta da esperienze precedenti o da precedenti sforzi o atti di volontà” (Peirce
CP 5.476, tr. it. 1980 p.291). Gli abiti in Peirce hanno gradi di forza, che si manifestano come un misto di
prontezza all’azione, mentre il mutamento di un abito
consiste spesso nell’aumento o nella diminuzione della
forza di un abito precedente. Come per le “disposizioni
virtuose” in Aristotele (hexeis), solo la ripetizione delle
azioni che producono mutamenti incrementa la forza
dei mutamenti stessi, costituendo quindi un meccanismo di rinforzo basato sull’efficacia. Come evidenzia
Chion, l’ascolto concreto non è certo dote innata: “l’atto di fare astrazione dalle nostre abitudini di ascolto è
un atto volontaristico e artificiale” (1983, tr. it. p.14).
Furono le prime esperienze con fonofissazioni manipolate – come quella del solco chiuso (sillon fermé, ovvero il
solco di un disco chiuso ad anello) o dalla campana tagliata (cloche coupée, ovvero l’ascolto di un suono di una campana privato dell’attacco iniziale) – a mettere in luce la
possibilità di uno scarto percettivo, rivelando la ricchezza intrinseca del materiale pre-musicale. Esse portarono
i musicisti a cercare un ascolto che si disinteressasse alla
causalità e si concentrasse sul paradigma delle proprietà concrete, ancor prima di averle pensate all’interno
di una composizione. Ma, avverte nuovamente Chion,
“prima di poter accedere all’ascolto ridotto, tuttavia, è
necessario passare attraverso alcuni esercizi di decondizionamento, per mezzo dei quali prendere coscienza
dei propri riflessi d’ascolto “di riferimento” e diventare
capaci di sospenderli al momento opportuno” (1983,
tr. it. p.14). Un compositore di diversa estrazione, ma
pienamente nel solco della lezione di schaefferiana, è
Murray Schafer, che a questo riguardo spiega più praticamente in cosa possa consistere questa “pulizia dell’orecchio”.
“Molti esercizi possono facilitare questa pulizia, ma almeno
all’inizio gli esercizi più importanti sono quelli che cercano
di insegnare il rispetto del silenzio. [...] Talvolta è utile esercitarsi a trovare un suono che presenti determinate caratteristiche, ad esempio, un suono che abbia un’intonazione
ascendente in partenza, o un altro consistente in una serie di
brevi esplosioni non periodiche, o un altro ancora che parta
con un rumore sordo e matto, seguito da un tremolio acuto,
o infine un altro che combini insieme un ronzio e uno stridio
acuto” (Murray Schafer 1977, tr. it. p.289).
Questo esercizio di pulizia, che assomiglia molto all’epoché fenomenologica, mostra come il compositore
concreto necessiti di una incorporazione profonda del
principio schaefferiano (e al contempo quanto sia difficile far accedere questo livello di senso ad un metalinguaggio descrittivo; vedi l’ambiguo “rumore sordo
e matto”). La presa di coscienza delle proprie routine
percettive da sola non è sufficiente: l’esercizio è volto
a portare l’ascolto ridotto al livello di una legge immanente, alla stessa maniera in cui un altro autore fortemente legato alle pratiche, Pierre Bourdieu, identificava
habitus “immanenti alla concertazione delle pratiche”,
che pur essendo basati su routine e poca o nessuna concettualizzazione, prevedono in realtà un alto tasso di
creatività (Bourdieu 1972). Abbiamo un fare interpretativo rieducato, riconfigurato nelle sue soglie semiotiche,
e fondamentalmente antiplatonico: vuole a tutti i costi
guardare le ombre che passano sulla parete della grotta
e non ne vuole sapere niente dei loro proprietari.
Le pratiche di ascolto ridotto si traducono inoltre in un
rimescolamento delle canoniche figure dell’autore e del
lettore. Infatti si tratta di un ascolto in prima istanza
riflessivo di un autore che continuamente interroga il
proprio materiale, che manipola ma che si lascia guidare, perché
“di fatto, l’effetto di una manipolazione su un suono è imprevedibile a priori sulla carta, se non in casi particolari.
Per questa musica […] la fabbricazione del materiale sonoro
non termina che al momento in cui viene dato l’ultimo tocco
alla realizzazione dell’opera. Il materiale non è già esistente
all’inizio; come la materia visiva per il pittore, esso non è il
punto di partenza, bensì il punto d’arrivo, lo scopo. Mentre,
simmetricamente, la composizione inizia con il primo suono
fissato” (Chion 1991, tr. it. p.52).
È abbastanza inusuale immaginare l’attività del musicista concreto, tecnologo e magari “topo di laboratorio”,
attraverso una descrizione più vicina a quella dell’improvvisatore jazz. Ma come per il solista di jazz, qui l’attività creativa è il risultato di una costante apertura a
tutto quello che giunge agli orecchi. Non vi è più ricezione
ma interazione, secondo un operare che, pur potendo pilotare il processo, si mantiene al tempo stesso disponibile
ai suoi imprevedibili sviluppi. Come per le pratiche sostenute da habitus in Bourdieu, la disposizione all’ascolto
ridotto richiede esercizio per poter accedere ad un livello
immanente, dove la regola non viene evocata esplicitamente, a garanzia dell’immediatezza della risposta e del
grado di libertà del sistema. “È richiesto un nuovo tipo
di attenzione, che il compositore mantiene da un capo
all’altro del lavoro in stato di costante disponibilità percettiva e di attività compositiva. Egli non deve pensare al
proprio materiale sonoro come già esistente né allentare
la propria vigilanza uditiva, poiché è sempre nella condi-
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
11
zione di produrlo, viverlo, scoprirlo, fino all’ultimo momento”. (Chion 1991, tr. it. p.54). Questo meccanismo
in sé non è nuovo, sappiamo già che nell’interpretazione
di un testo solo il punto di vista proprio della fine lettura
è in grado di dar luogo ad interpretazioni stabili. Una
vera e propria teoria di semantica musicale è stata costruita a partire dalla natura processuale della fruizione
musicale (Meyer 1956, Barbieri 2004), poiché l’ascolto
è un susseguirsi di inferenze sulla base di ipotetici sviluppi, di interpretazioni “che non necessariamente […]
devono trovare una piena risoluzione nell’interpretazione stabile del tutto”, dato che “ogni punto di vista che
si ponga durante il percorso di fruizione è transeunte
e provvisorio” (Barbieri 2004, p.47)”. Ma tutto ciò vale
anche nella prospettiva autoriale, che si sdoppia e si rimette di discussione di fronte alle emersioni del ribollire
sonoro.
12
2.2 Acusmatica dei giorni nostri
Abbiamo parlato di disposizione ad ascoltare il suono in
sé e a lasciarsi guidare dai suoi sviluppi. Ebbene, oggi,
dietro il vetro della cabina di regia di un qualsiasi studio
di registrazione (novello schermo acusmatico pitagorico), c’è un tecnico che è preposto esattamente a questa
attività, un tecnico che non necessariamente deve conoscere la musica, gli strumenti o chi li ha suonati (né tanto
meno la teoria schaefferiana), ma che ha come unico
compito quello di ascoltare e interagire con il suono. A
tutt’oggi egli deve in sostanza montare tra loro diverse
“fonofissazioni”: in uno studio di produzione odierno le
voci e gli strumenti sono registrati separatamente, per
piccoli frammenti, così da poter controllare, per mezzo
di un missaggio a più piste, le sincronie, le equalizzazioni, i riverberi, la spazializzazione, “ottenendo infine un
suono che è puro prodotto di studio e sarà in gran parte
responsabile del successo del brano” (Delalande 2002).
La figura dietro tutto ciò (che può riassumere in sé oppure scomporsi nei ruoli dell’arrangiatore, del fonico,
dell’ingegnere del suono) è responsabile di quella oggi
viene chiamata produzione di un brano. E da qui sorge il
ruolo del produttore, l’uomo dietro il suono di un artista, in
un rapporto per certi versi simile a quello che ci poteva
essere nella canzone leggera di un tempo tra un autore
e il suo interprete. I produttori sono ben conosciuti tra i
musicisti, e ultimamente il loro nome travalica il campo
degli addetti ai lavori, secondo un fenomeno che assomiglia a quello avvenuto per la visibilità dei registi nell’ambito cinematografico. La pratica del produttore sorge
dal basso, da approcci fortemente empirici, non è teorizzata e in genere poco autorappresentata. Essere buoni
produttori, si dice, “è una questione di orecchio”. E con
ciò il produttore, riduttore del proprio ascolto, si configura
come un novello adepto della musica concreta.
3. Un allegro mescolamento
3.1 Sensi d’effetto
Veniamo quindi al presente, alle mutazioni sonore in
corso, passando per l’entrata in campo degli effetti sonori. Il termine effetto sonoro non è direttamente associato alla ricerca di Schaeffer. Nel linguaggio comune
con esso ci si riferisce a qualche “effetto speciale” audio
o al lavoro di composizione della banda sonora per gli
audiovisivi (dove un effetto sonoro è in sostanza un rumore aggiunto in postproduzione). In un’accezione più
specificamente musicale, l’effetto sonoro consiste nell’alterazione di una sonorità attraverso l’applicazione di
dispositivi meccanici o algoritmi elettronici (vi sono effetti di eco, di sfasamento, di distorsione). E in sostanza
la definizione comune verte sull’effetto di realtà, come
per l’effetto di senso della semiotica generativa, “un’impressione di realtà prodotta dai nostri sensi a contatto con il senso” (Greimas e Courtés 1979), ottenuto in
questo caso con un’organizzazione di unità sonore non
per forza appartenenti al mondo naturale. Nel 1995 il
gruppo di ricerca del laboratorio Cresson di Grenoble
diede alle stampe un repertorio degli effetti sonori, sottoponendo il termine ad una complessa ridefinizione. Il
punto di partenza del gruppo di Cresson è, nuovamente,
quello di cercare di organizzare il campo del sonoro.
Scrive Jean-Francois Augoyard, direttore del gruppo:
“Scopriamo nella nostra esistenza una quantità di comportamenti guidati intuitivamente da indizi sonori così familiari
che la scienza non li percepisce più. Privati di una terminologia precisa che i discorsi eruditi riservano agli oggetti della
musicologia, della fonologia, o classificati come dannosi, i
suoni ordinari penetrano pertanto nella cultura comune dell’agire e del parlare, altrettanto bene nella pratica professionale, quanto nella vita di tutti i giorni. e, come capita spesso,
l’arte ha già colto ciò che il sapere non ha ancora percepito.
La pratica musicale contemporanea mescola allegramente i
suoni” (Augoyard e Torgue 1995, p.XXI).
Il punto di partenza per il gruppo di Grenoble è sicuramente quello di una pragmatica sonora: gli eventi sonori sono visti innanzitutto per la loro forza, per così dire,
perlocutoria, nel senso di condizionamento ad agire.
Ma il gruppo si accorge che non si tratta semplicemente
di studiare “behaviouristicamente” una serie di reazioni
a stimoli sonori. Un repertorio pluridisciplinare degli
effetti sonori non può limitarsi a delineare un’insieme di
condotte d’azione causate da eventi sonori, perché ogni
effetto del sonoro è in sé “un’operazione estetica” compiuta dal soggetto coinvolto, un fenomeno creativo contestualmente determinato, o, per ritornare allo schema
fenomenologico, ad una mutua definizione di soggetto
e oggetto. L’effetto sonoro di Cresson descrive questa
stretta interazione tra ambiente sonoro fisico, il luogo
sonoro di una comunità, e il “paesaggio sonoro interno” a ciascun individuo. E’ chiaro che a questo punto si
perde il verso consequenziale che vuole prima la causa
e poi l’effetto. Si tratta ancora una volta di interazioni
e allora forse possiamo parlare direttamente di pratiche sonore più che di effetti. Lucio Spaziante (2005, p.
41), confrontandosi con la nozione semiotica di effetto
Michele Pedrazzi · Oggetti ed effetti sonori. Pratiche della composizione musicale contemporanea
di senso, propone la nuova formula sensi d’effetto proprio
per liberarci di una prospettiva meccanicistica.
3.2 Ricongiungimenti sotterranei
Ma come “la pratica musicale contemporanea mescola
allegramente i suoni”? Prendiamo la frase di Augoyard
alla lettera e rivolgiamoci alle musiche contemporanee
senza distinzioni di genere. La prima pratica da prendere in esame è quella dei disc jockey. L’esibizione di un
buon dj consiste nel mescolare dischi: sovrapporli, inserire frammenti dell’uno all’interno dell’altro, intrecciare e congiungere elementi diversi per creare una suite
musicale originale. Allo stesso modo, creare o remixare
un brano dance verte di solito sulla medesima attività
di rielaborazione di brandelli sonori (campioni e ritmi
predefiniti) ricombinati per ottenere qualcosa di nuovo.
Lo studio di registrazione garantisce più livelli di complessità, ma in fondo costruire o ricostruire un brano
dance è molto simile a una versione ridotta del djing6.
Una lettura di testi storiografici, come l’interessantissimo Last night a dj saved my life (Brewster e Broughton
1999), permette di legare “l’allegro mescolamento di
suoni” alle pratiche sociali da cui nasce. Ad esempio,
apprendiamo che questo intrecciarsi di fonti, agli albori
dell’hip-hop, consisteva in una tecnica di missaggio estremamente semplice. All’inizio degli anni ’70 il dj pioniere Kool Herc suonava i vecchi pezzi di musica funk e
ripeteva ad libitum le parti contenenti gli stacchi ritmici
adatti al ballo break-dance. Il nome viene proprio da questo: i giovani neri del Bronx compravano di dischi di
cui suonavano soltanto i trenta secondi circa del break
strumentale funzionale al ballo, e Kool Herc li accontentava con un rudimentale montaggio di questi frammenti sonori (ivi, p.269). E prima ancora, vi è l’esempio
del genere dub. Nato in Giamaica attorno alla fine degli
anni ‘60 come derivazione diretta del genere reggae, il
dub che è uno dei primi generi musicali popular a fare uso
intensivo di effetti sonori (come alterazioni della sonorità). Anche qui l’esigenza dei dj (che nel dub si chiamano
selector) è di accontentare un pubblico vorace di novità
discografiche. A fronte di un relativo isolamento discografico e delle fluttuazioni delle mode musicali americane, i disc jockey giamaicani cominciano a riciclare i
brani reggae già presenti nel loro repertorio sfruttando
le possibilità offerte dalla recente tecnologia della registrazione su nastro multitraccia. Il dub lavora allora su
un brano preesistente, separando le tracce e aggiungendo o sottraendo ogni elemento sonoro fino a ottenere
una nuova composizione. E le pratiche di riferimento
sono ancora una volta la performance pubblica e il
ballo: “potenziare la linea di basso fino a renderla una
presenza mostruosa e sconquassante, eliminare tutte le
parti di una canzone eccetto la batteria, applicare a un
frammento di cantato un effetto d’eco, dilatare un ritmo
con un interminabile delay: tutte strategie con cui il dub
riesce a trasformare una canzone piatta in un montuoso
paesaggio tridimensionale” (ivi, p.150).
Oggigiorno i dj più acclamati sono ad un tempo selector,
remixer e produttori. Creare musica propria o rielaborare quella altrui è un allargamento naturale del loro
ruolo, ulteriormente facilitati dalla trasposizione delle
vecchie pratiche nel dominio digitale. “Oggi, grazie al
concetto di collage musicale […] e all’attrezzatura che
permette di crearlo, quello che un produttore fa in studio è quasi identico a ciò che farebbe per realizzare un
remix e leggermente diverso da quanto fa un dj in un
locale” (Brewster e Broughton 1999, p.417).
Gli esempi potrebbero essere molteplici: siamo al cospetto di un fronte multiforme di stili musicali legati dal
comune approccio all’unità sonora7. Dietro ognuno di
questi stili diversissimi (e in gran parte ancora musicali in
senso tradizionale) rimane l’importanza imprescindibile
e non più puramente strumentale della figura che ascolta e plasma il suono agendo direttamente su di esso.
La sovrapposizione di queste tendenze è particolarmente affascinante prendendo in considerazione il settore della musica “commerciale” (ovvero legato ad un
mercato vero e proprio) oggi chiamato musica elettronica.
L’electronic music (in tutti i suoi sottogeneri) non è una
continuazione dell’elettronica colta della Colonia degli
anni ‘50, ma deriva essenzialmente dal genere techno,
genere di musica dance nato a Detroit alla fine degli anni
’80, a sua volta come costola della house di Chicago. Nel
1990 la techno si sposta in Europa esplorando più a fondo il modello robotico/computeristico del gruppo dei
Kraftwerk, che era tra le sue fonti di ispirazione. E infine, nel terzo millennio, Aphex Twin, artista elettronico della Warp Records, compone pezzi per pianoforte
preparato alla maniera di John Cage, pezzi che sono
stati poi eseguiti nel 2005 dalla London Sinfonietta in un
programma che mescolava senza soluzione di continuità Edgar Varése, Squarepusher, Steve Reich, Plaid lo
stesso Cage. Il ricongiungimento è avvenuto8.
4. Conclusioni
Il nastro magnetico, tanto caro a Schaeffer è pressoché
scomparso. Il disco, padre della musica concreta e feticcio della cultura dj, è relegato ad usi sempre più settoriali e tendenti al nostalgico. I supporti musicali oramai
sono incorporei o comunque fisicamente inattingibili
(si pensi alla rivoluzione dell’mp3). Ma l’oggetto sonoro
rimane intatto. Se ne sono presi cura legioni di nonmusicisti che, proprio in ragione della loro estraneità
ad un percorso istituzionalizzato, hanno avuto minori
difficoltà a decondizionare e ridurre il proprio ascolto,
aprendosi ad una forma dell’espressione che operasse
direttamente sul sonoro, sul pre-musicale. E poiché non
è facile modificare un abito particolarmente inveterato,
sono ancora pochi i musicisti che riescono a passare con
successo da un ascolto all’altro.
Negli anni ’50 la nuova forma dell’espressione trovata
da Pierre Schaeffer si isolava sotto le accuse di “poca
sostanza” all’interno del panorama colto, orientandosi
sempre più verso la teorizzazione musicologica. Nelle
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
13
piccole rivoluzioni sonore popular invece il percorso fu di
segno opposto e vide pratiche sociali come il ballo o la
performance pubblica fornire lo stimolo per inseguire
nuove sonorità, che si affermarono attraverso bricolage
espressivi resi possibili dalla tecnologia che si rendeva
disponibile, ricongiungendosi infine all’idea schaefferiana.
Da un certo punto di vista potrebbe sembrare fuorviante o superfluo scomodare nuovamente gli oggetti sonori
per descrivere le nuove pratiche, poiché la stessa esperienza acusmatica, oggi, in una società costantemente
irrorata di suoni “fonofissati” e diffusi attraverso amplificatori ubiqui, non desta più particolari sorprese. Ma
ciò che rimane, a latere di un percorso di analisi che
passi con cura attraverso le teorizzazioni della musica
concreta, è una nozione di ascolto che si pone innanzitutto come una pratica compositiva. L’ascolto ridotto
(potremmo forse chiamarlo anche ascolto sonoro) non
serve ad interpretare un’opera, né ad apprezzarla di
più, ma è innanzitutto un vero e proprio strumento di
creazione, assolutamente contemporaneo.
Note
1
14
Ovvero la registrazione del suono su supporto fisico. Così
chiamata ancora oggi dal compositore e saggista Michel
Chion, all’epoca di Schaeffer la fonofissazione avveniva con
l’incisione di dischi in gomma morbida e poi, non appena fu
possibile, tramite il più malleabile nastro magnetico.
2
Su impulso di Erbert Eimert e dell’allora ventenne Karlheinz
Stockhausen.
3
Per ulteriori dettagli e per una più estesa bibliografia, cfr. l’articolo di Francois Delelande sul primo volume dell’Enciclopedia della Musica Einaudi (2002).
4
La teoria semiotica soggiacente al traité, complessa e idiosincratica, meriterebbe uno studio a parte. Per certi versi l’approccio sembra invitare ad una sovrapposizione con la teoria
di C.S. Peirce. In Schaeffer il significato è sens, e consiste nel
rinvio di tipo arbitrario e culturalmente mediato, proprio del
simbolo peirceano. Invece, il rinvio per riferimento causale (la
provenienza) è per entrambi proprio dell’indice.
5
Anche per Chion “senso” sottintende l’aspetto culturale di
un segno musicale, che rinvia a contenuti e giudizi associati
per convenzione, quindi secondo una modalità simbolica.
6
Non a caso oggi Schaeffer (e non Stockhausen) è spesso invocato come padre spirituale di molti musicisti dell’area sperimentale. “Il turntablism era stato concepito molti anni prima
che i dj hip hop lo trasformassero in realtà. […] il compositore francese Pierre Schaeffer […] sperimentò principalmente usando la nuova tecnologia di registrazione su nastro
magnetico, ma si dilettò anche con i giradischi (che lui ovviamente conosceva con il nome di “grammofoni”)” (Brewster e
Broughton 1999, p.310).
7
Andrebbero citate qui almeno le esplicite influenze concrete nella musica pop. Valgano le più famose, come Revolution
n.9 dei Beatles (1968), l’intro di Re-Make/Re-Model dei Roxy
Music (1972), il montaggio che chiude l’album We’re only in it
for the money di Frank Zappa (1968). O anche il finale di Bike
(1967), così come il brano Alan psychedelic breakfast (1970), en-
trambi dei Pink Floyd, nonostante spesso i fini siano più aneddotici che concreti.
8
Non volendo qui includere (impossibili) trascrizioni su pentagramma o poco leggibili visualizzazioni sonografiche, non
posso che rimandare all’ascolto, possibilmente ravvicinato e
comparativo, di Pierre Schaeffer, Études des Casseroles (1948),
Michel Chion, Coup de soleil sur un vitrail, 1er mouvement (1975),
Autechre, Scose Poise (2001), Radiohead, Pakt like sardines in a
case (2001).
Bibliografia
Augoyard, J.F., Torgue, H., 1995, A l’ècoute de l’environenement.
Répertoire des effets sonores, Marsiglia, Parenthèses; trad. it.
Repertorio degli effetti sonori, Lucca, LIM, 2003.
Barbieri, D., 2004, Nel corso del testo. Una teoria della tensione e del
ritmo, Milano, Bompiani.
Barthes, R., 1973, Le plaisir du texte, Paris, Seuil; trad.it. Il piacere del testo, Torino, Einaudi, 1975.
Bourdieu, P., 1972, Esquisse d’une théorie de la pratique precede de
Trois etudes d’ethnologie kabyle, Parigi, Seuil; trad.it Per una
teoria della pratica, Milano, Cortina, 2003.
Brewster, B., Broughton, F., 1999, Last night a dj saved my life.
History of the disc jockey; trad.it. Last night a dj saved my life,
Roma, Fazi, 2005.
Chion, M., 1983, Guide des objets sonores, Parigi, Buchet/Castel;
trad. it parziale Guida agli oggetti sonori, Milano, 2005
(users.unimi.it/mozart/GuidaOggettiMusicali.pdf).
Chion, M, 1991, L’art des sons fixés ou La Musique Concrètement,
Fontaine, Metamkine; trad. it. L’arte dei suoni fissati o La
Musica Concretamente, Roma, Edizioni Interculturali,
2004.
Chion, M, 1994, Musiques, Médias et technologies, Paris,
Flammarion; trad. it. Musica, Media e Tecnologie, Milano,
Il Saggiatore, 1996.
Delalande, F., 2002, “Il paradigma elettroacustico” in
Enciclopedia della musica, vol. I, Torino, Einaudi.
Gentilucci, A., 1982, Introduzione alla musica elettronica, Milano,
Feltrinelli.
Greimas, A.J. e Courtés, J., 1979, Sémiotique. Dictionnaire raisonné
de la théorie du langage, Paris, Hachette; trad. it. Semiotica.
Dizionario ragionato della teoria del linguaggio, Firenze, La
Casa Usher, 1986.
Meyer, L., 1956, Emotion and meaning in music, Chicago, The
University of Chicago Press; trad. it. Emozione e significato
nella musica, Bologna, Il Mulino, 1992.
Schaeffer, P., 1966, Traité des objets musicaux. Essai interdisciplines,
Paris, Seuil.
Schafer, M., 1977, The tuning of the world, Toronto, McLelland
and Stewart; trad.it. Il paesaggio sonoro, Lucca, Ricordi/
LIM, 1985.
Spaziante, L., 2005, “Vedere suoni: musica e psichedelia”
in Marrone, G. (a cura di), Sensi alterati. Droghe, Musica,
Immagini, Roma, Meltemi.
Michele Pedrazzi · Oggetti ed effetti sonori. Pratiche della composizione musicale contemporanea
0. Introduzione
La realtà che indagherò è quella dell’Isola di Grado,
nella laguna omonima, in provincia di Gorizia. Il fatto
che si tratti di una porzione di territorio così ben delimitata non garantisce che si tratti anche di un corpus di
facile delimitazione. Tutti coloro che hanno tentato di
studiare semioticamente “testi” architettonici o urbani
sanno quanto sia complesso, e in un certo senso inesauribile, un oggetto di studio come questo. L’analisi che
espongo in questa occasione, e che fa parte di un’indagine più omnicomprensiva su Grado, riguarda solo le
pratiche musicali che vi si tengono annualmente, e in
particolare nella stagione turistica, dato che si tratta di
una nota località balneare. A questo proposito do subito
una serie di dati che sono utili per capire che tipo di
ambiente è quello in cui avvengono le manifestazioni
di cui parleremo. Secondo i dati statistici aggiornati al
dicembre 2005, Grado ha 8.783 residenti stanziali, la
cui età media è di circa 46 anni. Nella stagione estiva, si aggiungono 1.385.974 “presenze turistiche”, cioè
persone che arrivano e si fermano almeno una notte.
Di queste, 783.605 sono italiani e 602.369 stranieri.
Fra questi ultimi, 268.645 austriaci, 218.390 tedeschi
e 28.544 dall’est Europa. Specifico la provenienza dei
turisti stranieri perché vedremo come sia importante,
anche in alcune pratiche musicali, la tradizione filoaustriaca di questa località che, nell’Ottocento, era la
spiaggia ufficiale dell’Impero.
Altri elementi molto importanti per capire le tradizioni
musicali di Grado sono: una secolare tradizione di esecuzione di musica sacra, con un coro molto rinomato
che si esibisce anche in altre città delle Venezie; il turismo di massa che da alcuni decenni porta con sé i propri
rituali di intrattenimento ormai simili in tutto il mondo;
la grande devozione mariana degli abitanti stanziali,
che la prima domenica di luglio di ogni anno vanno per
esempio, con una processione di barche, nella vicina
isoletta di Barbana, sede di un santuario dedicato alla
Madonna; infine, nell’isola è molto viva una tradizione
di musica popolare in dialetto giuliano, tanto che ogni
anno, in agosto, si tiene un vero e proprio Festival della
canzone gradese, con canzoni sempre nuove e un vincitore
finale, come ogni festival che si rispetti.
Le pratiche musicali a Grado sembrano quindi attraversare e collegare fra loro i diversi ambiti della religione, delle tradizioni storiche, delle produzioni folcloriche
e del loisir estivo. E soprattutto, nel loro nome, avviene
una conciliazione provvisoria ma importante fra la comunità residente e la comunità passeggera dei turisti.
1. La costruzione del corpus
I casi che propongo sono stati da me osservati in loco e
successivamente studiati in base alla documentazione
filmata da me stessa realizzata. Io credo che l’aver potuto assistere direttamente alle pratiche in oggetto sia stato
importante perché mi ha permesso di cogliere l’effettivo
E|C Serie Speciale
Anno I, n. 1 2007, pp. 15-19
ISSN (on-line): 1970-7452
ISSN (print): 1973-2716
EC
Pratiche musicali e identità
sociale. Il caso di Grado
Maria Pia Pozzato
contesto del fenomeno e altri elementi cruciali, come il
tipo di partecipazione emotiva delle persone. Sono convinta infatti che sia proprio la musica, più di ogni altra
pratica collettiva, a tenere miticamente insieme le varie
anime sociosemiotiche di Grado e questo proprio per
la specificità intercorporea, oltre che intersoggettiva,
che caratterizza la produzione e la fruizione musicali.
Soprattutto in un luogo di vacanza, dove il corpo riemerge con diritti di cittadinanza che non possiede nella
quotidianità routinaria e lavorativa, la musica assume
un ruolo da protagonista e fa cadere le barriere in un
modo che, in altri contesti, sarebbe impensabile.
2. Madonnina del mare, tra sacro e profano
Il primo caso che illustrerò è costituito da una canzone che si sente cantare spessissimo a Grado, sia in feste famigliari, all’interno delle case; sia in chiesa, ogni
domenica alla fine della messa delle 11; sia per strada,
per esempio durante la festa dei patroni Ermacora e
Fortunato in luglio, dove capannelli di privati, magari
accompagnati da una chitarra, si riuniscono spontaneamente per cantare canzoni tradizionali; sia in occasioni più turistiche, come l’annuale Festival di cui si è
detto. Come si dice in una antologia di testi di canzoni
gradesi, tra le dieci grandi canzoni del XX secolo decretate dagli abitanti di Grado in un referendum del
1999, Madonnina del mare risulta prima anche se è in lingua italiana e non è originaria di Grado ma proviene,
probabilmente, dall’area campana.
Questa canzone è un caso emblematico di creazione
folclorica perché è stata scelta, adottata verrebbe voglia
di dire, dalla popolazione gradese.1 Quali sono i motivi di tanto successo? Come al solito, quando si tratta
del gusto di una collettività e dell’adesione della stessa
a parametri di tipo formale, è impossibile trovare delle ragioni certe, e del resto non è nemmeno compito
del semiotico o dello studioso di folclore ricostruire una
© 2007 AISS - Associazione Italiana di Studi Semiotici
T. reg. Trib. di Palermo n. 2 - 17.1.2005
catena causale. Quello che si può oggettivamente rilevare è che la melodia di Madonnina del mare è semplice ed
orecchiabile e che il testo parla di cose famigliari per il
gradese il quale, prima dello sviluppo turistico dell’isola, viveva poveramente di pesca; centrale inoltre, nella
canzone, il tema della devozione mariana.
Vediamo il testo della canzone:
Madonnina del mare
Al primo sole si desta / la cittadella marina
E in un bel giorno/ risuona la dolce campana vicina.
Mentre sul mare d’argento/ va il pescatore contento,
passa e si inchina alla sua Madonnina
dicendole piano così:/ Madonnina del mare
Non ti devi scordare di me!/ Vado lontano a vogare
Ma il mio dolce pensiero è per Te!
Canta il pescatore che va:/ Madonnina del mare, con Te /
questo cuore sicuro sarà!
L’ultimo raggio di sole / muore sull’onda marina
E, in un tramonto di sogni, /lontano la barca cammina.
Fra mille stelle d’argento/ va il pescatore contento,
Sente nel cuore un sussulto d’amore/ sospira pregando
così:
Madonnina del mare, ...
16
Si nota nel testo un tenore patemico euforico (“va il
pescatore contento”, ripetuto due volte) che conferisce
alla canzone uno statuto di “preghiera fiduciosa”. Le
scene descritte tratteggiano una iteratività serena e una
sostanziale accettazione delle proprie condizioni di vita
da parte del pescatore. Infine, una sorta di generico
romanticismo (“sente nel cuore un sussulto d’amore”)
diventa inestricabile rispetto al sentimento religioso. In
parole povere, non si capisce se il pescatore, nello scenario un po’ di cartapesta fatto di raggi solari morenti e
stelle nascenti, sospiri d’amore per la Madonna o per la
fidanzata che ha lasciato a riva.
Quest’ultima caratteristica colloca Madonnina del mare
perfettamente a metà strada fra due generi popolari gradesi, la canzone d’amore, come la celeberrima
Mamola (che vuol dire “ragazza”) e il canto religioso,
come quello che si esegue durante le messe e le processioni. Non c’è invece, in questo testo, nessun cenno
alle asprezze della vita del pescatore né ai conflitti della
modernizzazione, così centrali invece nella produzione
di canzoni popolari dagli anni Settanta in poi. Ne do
un esempio:
Cinzia
Che fa in testa a sti graisani
che par zente malcontenta,
i rifiuta la polenta
e i favela per ’talian.
Che darìe per ste contrade
co i se sforsa de esse fini,
i ruvina i fantulini
favellando per ’talian.
Maria Pia Pozzato · Pratiche musicali e identità sociale. Il caso di Grado
(rit.) Oh Cinzia, sei matta,
non mangiare la frutta tacolata,
da bravo Ottone
non colegarti di nuovo sul sabbione,
stai buono Moreno, altrimenti
altrimenti ti mazeno.
Babe duto ’l giorno in auto
le trascura la cusina
le consuma la binzina
le favela per ’talian.
Le se incarga de campari,
le favela comò i siuri,
ma i marì fa i muraduri
o i xe a cocia in mezo al mar.
Co scuminsia i primi coldi
i se fita ogni logo
i te vive leto e fogo
e i fa cache in bucalìn.
I se missia coi turisti
i se veste in gabardin,
cu xe nato in Culdemuro
e cu xe nato in Strunsulin.
Cinzia (traduzione italiana)
Cosa hanno in testa questi gradesi
che sembrano gente scontenta,
rifiutano la polenta e parlano l’italiano.
Che ridere per queste contrade
quando si sforzano di essere fini,
rovinano i bambini
parlando italiano.
Cinzia, sei matta,
non mangiare la frutta ammaccata,
da bravo, Ottone,
non sdraiarti di nuovo sulla sabbia,
stai buono Moreno,
altrimenti, altrimenti ti macino.
Le pettegole tutto il giorno sono in auto
trascurano la cucina
consumano la benzina
parlano italiano.
Si riempiono di Campari,
parlano come i signori,
ma i mariti fanno i muratori
o sono a pescare in mezzo al mare.
Quando cominciano i primi caldi
affittano ogni stanza
e vivono con letto e fornello
e fanno la cacca nel vasetto da notte.
Si mescolano con i turisti
si vestono di gabardine,
chi è nato in Culodimuro*
e chi è nato in Stronzolino*.
*piccoli rioni di Grado vecchia
Il testo di Cinzia dimostra come la pratica della canzone
a Grado sia tuttora viva e potente veicolo del sentimento comune, sia per quanto riguarda l’ancoraggio alla
tradizione sia per una registrazione collettiva dei cambiamenti di costume apportati dal turismo e dalla “modernità”. La funzione di Madonnina del mare sembra invece
quella di sospendere questo realismo critico per consegnare esecutori e ascoltatori a una dimensione talmente
atemporale e mitica da non avere nemmeno bisogno
di un ancoraggio linguistico. L’italiano di Madonnina del
mare, anziché renderla estranea ai gradesi, garantisce
un salto rispetto alla quotidianità disforica; una lingua
meno locale e sentita come letteraria, “alta”, è adatta a
veicolare un contenuto altrettanto alto e epurato dalle
brutture del reale. Il gradese ride di se stesso con Cinzia
ma se deve sentirsi parte di una comunità solidale (in famiglia, in chiesa o in piazza) canta Madonnina del mare.
Come ho detto, questa canzone viene eseguita molto
spesso ma con assoluta regolarità alla fine di ogni messa
delle 11 la domenica mattina, e questo tutto l’anno. Ho
registrato due esecuzioni di Madonnina del mare alla fine
della messa, a distanza di un anno esatto (agosto 2005 e
agosto 2006). La registrazione del 2005 dopo la messa
è stata seguita, la stessa sera, dalla registrazione in piazza della canzone, nell’ambito profano del Festival della
Canzone Gradese. Questa contiguità mi ha permesso
di confrontare due produzioni e due ascolti molto diversi fra loro anche se vicini sia temporalmente, come
si è detto, sia spazialmente poiché l’esecuzione “sacra”
e quella “profana” si effettuarono al di qua e al di là
dello stesso muro della veneranda basilica bizantina di
Grado. La contiguità spaziale non è un fatto banale: la
manifestazione festivaliera potrebbe avvenire in molti
altri luoghi a Grado, per esempio nella grande, scenografica e recentemente restaurata piazza Biagio Marin;
o nel Parco delle Rose, teatro consueto di eventi spettacolari. La scelta della piazzetta della basilica fa pensare
invece a una continuità simbolica fra le canzoni profane
e i canti sacri che le hanno precedute in un’altrettanto radicata tradizione. Si sa, per esempio, che Grado
vanta ancor oggi, nell’esecuzione di musica sacra, un
canone tutto suo, la cosiddetta “calata” o “inflessione
patriarchina”, legata più all’Oriente di Bisanzio che all’Occidente di Roma.
La contiguità spazio-temporale dell’esecuzione sacra e
dell’esecuzione profana di Madonnina del mare ci permette di vedere in compresenza due strati antropologici e
storici molto diversi fra loro. Se, come afferma Algirdas
Greimas, si può parlare di ‘degenerazione folclorica’ di
una prassi sacra antecedente, l’esecuzione di Madonnina
del mare al Festival della Canzone Gradese, con un arrangiamento jazzato e virtuosistico, adattato ai gusti
commerciali della canzone mainstream, potrebbe costituirne un buon esempio. Il semiotico francese di origine
lituana oppone infatti il sacro (e mitico), inteso come
relazione con la trascendenza, alle forme de-semantizzate che identifica con il folclorico, fino alle forme
contemporanee di tipo estetico-letterario dove di nuovo
viene tematizzato il sistema dei valori ma in chiave individualistica (Cfr. Greimas 1976, p. 176).
Tuttavia anche l’esecuzione/ascolto della canzone in
chiesa è assai difficile da collocare interamente entro
un ambito sacro. Per quanto riguarda in particolare le
modalità di ascolto in chiesa, l’osservazione sul posto
e, in seguito, l’attenta analisi del breve filmato, hanno
messo in luce, nel pubblico dei fedeli, un interessante
miscuglio di atteggiamenti devozionali e di pratiche decisamente spettacolari come ad esempio lo scroscio di
applausi che segna la fine della canzone. Gli altri canti
eseguiti durante la messa, rigorosamente in latino, sono
accompagnati da una modesta partecipazione vocale
da parte del pubblico e da gesti strettamente religiosi
come il segno della croce, l’abbassamento della testa,
l’inginocchiarsi, e così via. Al momento di Madonnina del
mare, invece, i fedeli assumono atteggiamenti vari, legati
più a scelte personali che a regole rigidamente fissate:
alcuni rimangono in piedi, altri inginocchiati con le
mani giunte in atteggiamento di preghiera, altri seduti;
altri attentamente in ascolto, altri intenti a chiacchierare fra loro. E soprattutto moltissimi partecipano vigorosamente al canto. Vediamo dunque che sussistono
differenze notevoli fra il canto liturgico vero e proprio e
l’esecuzione di questa canzone, anche e soprattutto per
le diverse modalità di ascolto.
Ho fatto alcune interviste a persone che vivono tutto
l’anno a Grado e la loro tendenza è quella di attribuire
ai turisti l’atteggiamento meno rispettoso e più “televisivo”. Non ho avuto la possibilità di verificare direttamente questo dato ma, esattamente un anno dopo, ho
ripetuto la registrazione dell’esecuzione e il confronto
fra i due filmati è stato per certi versi sorprendente:
non solo la canzone veniva eseguita nello stesso posto,
allo stesso modo (come prevedibile), ma alcune persone
dell’anno precedente apparivano nello stesso identico
punto della chiesa, e con una postura analoga a quella assunta un anno prima. Tutto questo fa pensare a
un’altissima grammaticalizzazione della pratica e a una
altrettanto radicata funzione sociale e individuale della
stessa.
2. Le altre pratiche musicali a Grado
Vediamo ora altre pratiche musicali che si tengono con
regolarità nell’isola. Lo sfruttamento intensivo del luogo
in chiave turistica, e la conseguente presenza periodica
di un massiccio contingente di non residenti, fanno sì
che la vita musicale a Grado sia composta di tanti momenti ciascuno dei quali sembra collocarsi o ai due poli
estremi della /vita tradizionale degli stanziali/ e del
/puro intrattenimento turistico/, o in posizioni intermedie. È facile individuare pratiche di intrattenimento
a cui gli abitanti di Grado sono totalmente estranei: i
balli con animatori sulla spiaggia, per esempio, sono ad
uso esclusivo dei turisti e si ritrovano identici a Grado
come in tutte le altre spiagge italiane. Non è facile dire
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
17
18
se qualche gradese si mescoli alle folle sudate e transgenerazionali che si agitano sotto il sole estivo, su incandescenti piattaforme di cemento, “animate” da giovani
ballerini messi a disposizione dall’azienda di soggiorno. In ogni caso, questo tipo di intrattenimento, che si
sposta sotto un apposito tendone del Parco delle Rose
in caso di pioggia, è pensato per allietare un fruitoremodello in vacanza, momento dell’anno in cui tutta la
famiglia, dalla nonna al nipotino, dall’adolescente al
signore di mezza età, può dimenarsi congiuntamente
sulle note del tormentone musicale dell’estate.
Ci sono però manifestazioni, come quella evocata poco
sopra in Chiesa, o quella che occupa ogni anno la serata di Ferragosto, che sono di difficile collocazione. Il
concerto di Ferragosto vede protagonista l’orchestra
per fiati e percussioni di Gorizia con un repertorio
composto quasi esclusivamente di walzer viennesi. I
musicisti sono alloggiati in un barcone ormeggiato nel
Porto Canale di Grado. Gli spettatori possono seguire
il concerto da terra e da diverse prospettive poiché il
canale è a forma di ipsilon e si addentra in profondità
nell’abitato di Grado.
Il turista trova, in questa manifestazione musicale seguita dai fuochi d’artificio, uno svago classico. Ma viene
evocato anche il passato mitteleuropeo di Grado, dichiarata da Francesco Giuseppe “Küstenland dell’impero
austro-ungarico”, cosa di cui i gradesi vanno ancor oggi
particolarmente orgogliosi. Se nella duplice esecuzione di Madonnina del mare si trovava una conciliazione fra
il culto sacro, l’elemento folclorico, i ricordi d’infanzia
nella vita famigliare e, negli applausi finali, elementi di
logica spettacolare televisiva; qui, ad essere esaltato in
chiave autocelebrativa, è un passato eroico, un’epoca
d’oro, che il gradese porge al turista come una sorta di
versione migliorata del suo Sé collettivo. Rimane ben
poco di austriaco a Grado, fatta eccezione forse per le
Ville Bianchi, complesso turistico dei primi del novecento che evoca uno stile architettonico decisamente
alpino. Ma l’evocazione musicale della Grande Vienna
serve sia come presentificazione di un passato che non è
più, sia come elemento d’attrazione per i turisti austriaci in rapido e costante calo di presenza.
Anche nel caso del concerto di Ferragosto, l’osservazione diretta prima, e i filmati in seguito, mostrano nel
pubblico delle modalità di fruizione diversificate ma decisamente euforiche, dove momenti di partecipazione
ritmica (battito delle mani, dei piedi, accenni di canto e
di ballo), con attenzione solipsistica verso il barcone, si
alternano a momenti di comunicazione all’interno dei
gruppi, con scambi di risa, di battute di dialogo e soprattutto di sentimenti di partecipazione divertita all’evento. Si potrebbe dire quindi che si alternano momenti
semplicemente significativi per il soggetto, a momenti
più comunicativi, con circolazione di informazione ed
emozione fra soggetti.
Del resto, come si è anticipato, sembra proprio il coinvolgimento corporeo in tutte queste pratiche di frui-
Maria Pia Pozzato · Pratiche musicali e identità sociale. Il caso di Grado
zione musicale a far sì che esse divengano il terreno
più fertile per una rappresentazione complessa delle
identità individuali e collettive. Dato che il timismo, la
propriocettività sono il luogo aurorale del senso, esse si
configurano anche come sede privilegiata di traduzione
fra diversi significati, attraverso dinamiche di unione e
di partecipazione intercorporee oltre che intersoggettive. Nella fattispecie, la mia ipotesi è che le pratiche musicali a Grado siano un punto di ri-articolazione della
complessa realtà storico-ambientale dell’isola, sospesa
fra una radicazione antichissima di epoca romano-bizantina; un passato ottocentesco aureo, sotto l’Austria;
e un presente economicamente ricco ma anche rischioso per la “figurabilità” del luogo.2 Se il canto sacro, con
la tradizionale calata bizantina, rappresenta l’ancoraggio più antico, la sua traduzione folclorica (soprattutto
le canzoni in dialetto) diventa dispositivo di narrazione
dei cambiamenti sociali; quando infine, attraverso una
ulteriore pratica traduttiva, la musica popolare “graisana” si conforma a generi decisamente commerciali (cfr.
Madonnina del mare jazzata, i balli sulla spiaggia, ecc.),
viene pagato un tributo esplicito alla realtà speculativa
del villaggio-vacanza.
Ma, come si è detto, ci sono pratiche che approdano a
realizzazioni complesse3, con una giustapposizione di
elementi eterogenei. È il caso dell’esecuzione in chiesa
di Madonnina del mare e del concerto viennese sul barcone, entrambi evocatori di identità e di valori diversi,
miticamente e precariamente conciliati. Mi sembra di
poter sostenere che è soprattutto attraverso questo tipo
di pratiche auto-rappresentative “miste” che la comunità
elabora (in modo sicuramente inconsapevole) una propria strategia identitaria. La semiotica della cultura ha
studiato queste realtà in cui personaggi stanziali, appartenenti al luogo, si contrappongono a personaggi mobili,
che eseguono un “percorso” temporaneo all’interno dello stesso luogo. Per esempio, in un saggio di Jurij Lotman
(1969) particolarmente significativo per il caso di Grado,
troviamo il concetto di “collisione narrativa” che sembra
attagliarsi particolarmente bene alla migrazione stagionale turistica. La frontiera naturale dell’isola diventa, da
questo punto di vista, una figura della frontiera fra diverse culture. In realtà, le direzioni dello spostamento sono
sempre due, una che dall’interno va verso l’esterno e una
che, viceversa, vede intrudere degli elementi esterni.
Sarebbe semplicistico e ingenuo pensare a una perfetta
comunità isolana che solo periodicamente viene a contatto con invasori stagionali. Anche anticamente Grado
è sempre stata aperta ed esposta culturalmente sia verso
l’entroterra aquileiano, sia verso l’oltre mare veneziano e
bizantino. Oggi, come qualsiasi altro luogo, è in più soggetta agli infiniti e continui scambi comunicativi di una
società postindustriale matura. E tuttavia si possono ancora rilevare delle differenze specifiche, fra un /interno/
composto dagli isolani, ancorati a radici storiche e linguistiche, alle tradizioni religiose e lavorative, dolorosamente memori dalle condizioni umili del passato; e un /ester-
no/ eterogeneo, composto da persone che misconoscono
il luogo in cui vengono ospitate, che portano ricchezza
ma anche superficialità e sradicamento. Da questo punto
di vista, i non gradesi che possiedono una seconda casa a
Grado, costituiscono una sorta di “comunità di mezzo”,
con funzione traduttiva fra le due comunità estranee degli stanziali, da un lato, e dei turisti “effimeri”, soprattutto stranieri, dall’altro.4
Tutte queste direzioni centripete e centrifughe, conservative e contaminative che interessano la cultura gradese,
compreso il radicale decentramento proprio delle culture
massmediatiche attuali, fanno sì che le pratiche musicali
riflettano, e a volte raccordino miticamente, dimensioni
antropologiche e identità collettive diverse. Naturalmente
sarà poi importante confrontare queste pratiche con altri aspetti della vita collettiva sull’isola 5, dato che nulla,
nella vita sociale, può essere isolato senza venire frainteso
e snaturato.
Note
1
Per una trattazione delle problematiche folcloriche, vedi Del
Ninno 2007.
2
Prendo a prestito questo termine dall’urbanista americano
Kevin Lynch il quale, nel suo celebre L’immagine della città, diceva che ogni luogo urbano ha parti che lo caratterizzano,
che gli conferiscono una sua ‘figurabilità’. Sono in particolare
i centri storici a svolgere questa funzione, e anche a Grado,
come in molte realtà urbane della nostra epoca, l’edificazione
selvaggia mette a repentaglio la fisionomia tradizionale e irripetibile del luogo. (Cfr. Lynch 1960).
3
‘Complesso’ nel senso semiotico del termine, cioè che unisce
due unità semantiche che si trovano in partenza in relazione
di contrarietà. In altri termini, la realizzazione di un metatermine complesso equivale all’affermazione contemporanea di
due termini contrari.
4
In realtà, i gradesi si lamentano del fatto che tutto il centro
storico sia stato acquistato da austriaci e tedeschi e che le giovani coppie locali siano costrette, per ragioni economiche, a
comprare casa nell’entroterra. Se questo fenomeno sarà confermato, come è facile prevedere, Grado diventerà sempre di
più un villaggio-vacanza e sempre meno un borgo di pescatori
dalle tradizioni millenarie.
5
Come quelle per l’approvvigionamento dei beni primari, o
inerenti alle modalità di spostamento, o ai rapporti di vicinato. Per una classificazione delle pratiche che definiscono la
vita sociale di un luogo, cfr. ad esempio Hannerz 1980.
Bibliografia
19
Del Ninno, M., 2007, a cura, Etnosemiotica, Roma, Meltemi.
Greimas, A.J., Sémiotique et Sciences Sociales, Paris, Editions du
Seuil ; trad. it. 1991, Semiotica e scienze sociali, Torino,
Centro Scientifico Editore, 1976.
Hannerz, U., Exploring City. Inquiries Toward an Urban
Anthropology, New York, Columbia University Press;
trad. it. 1992, Esplorare la città. Antropologia della vita urbana,
Bologna, Il Mulino, 1980.
Landowski, E., 2004, Passions sans nom, Paris, Presses
Universitaires de France.
Lotman, J., 1969, O metayazike tipologicˇeskich opisanij Kul’turj, in
«Trudy po znakovym sistemam», IV, pp. 460-477, Tartu;
trad. it. Il metalinguaggio delle descrizioni tipologiche della cultura
in Lotman J. Uspenskij B., Tipologia della cultura, Milano,
Bompiani, pp. 145-179, 1975.
Lynch, K., 1960, The Image of the City, Chicago, Massachusetts
Institute of Technology; prima trad. it. 1964, ultima
edizione L’immagine della città, Venezia, Marsilio Editori,
2004.
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
0. Premessa teorica
In questo piccolo studio sulla musica dei King Crimson
vorrei anche provare a offrire qualche contributo per la
messa a punto di strumenti utili a una semiotica della
musica. Si tratta, com’è noto, di uno dei settori più difficili per l’applicazione degli strumenti semiotici, tanto
che non di rado esso fa emergere posizioni francamente anti-semiotiche, come nel caso dei ricorrenti dubbi
su una “assenza di significati” nella musica e sul suo
conseguente statuto di anomalo sistema semiotico “monoplanare”. Mi sembra che l’affiorare di tali dubbi sia
comunque indicativo, anche se questi contrastano con
l’evidenza dei dati di fatto culturali, dal momento che
la musica è percepita dai più come dotata, al contrario,
di forti capacità nella generazione di effetti di senso e
di intense configurazioni emozionali, e anzi quale uno
degli strumenti che più di altri contribuiscono a dare significato alle nostre esperienze. Sull’idea di una musica
“astratta” mi sembrano esserci vari equivoci; personalmente, trovo comunque particolarmente emozionanti
e significativi proprio taluni tipi di musica che vengono
frequentemente classificati come casi di musica “astratta” – ciò vale ad esempio per certe opere dell’ultimo
Beethoven, dello Strawinsky “neoclassico” o, appunto,
per certi brani dei King Crimson (di qui, almeno in parte, il motivo di tale scelta). Il problema non mi sembra
dunque consistere nell’assenza di senso dei fatti musicali, bensì nelle nostre persistenti difficoltà nell’elaborare
modelli concettuali capaci di cogliere le effettive modalità di questo modo specifico di “aver senso”.
In termini generali, possiamo dire che la musica si colloca all’interno dei sistemi a significazione iconica, pur
in un modo assai particolare. Vi sono stati molti autori
che, sia pure in termini e a partire da prospettive differenti, hanno ritenuto che la musica poggi su relazioni
analogiche che legano, in termini semiotici, le sue strutture significanti al piano dei significati. Tra gli altri, può
essere però opportuno segnalare qui gli scritti di Michel
Imberty (in particolare 1979 e 1981), per una prospettiva interessante che tocca piani profondi, collegando
problematiche semiotiche e concetti psicoanalitici, e
aprendo spazi importanti di riflessione, che tuttavia non
è possibile affrontare in questa sede.1
In ogni caso, i modelli correnti concernenti i meccanismi iconici appaiono oggi insufficienti, prospettando
la necessità di ripensarli in termini diversi da quelli, tipicamente filosofici, della tradizione risalente a Peirce.
Innanzi tutto, parlare di segni che mostrano connessioni “analogiche” è troppo vago, perché qualsiasi tipo
di segno – e verosimilmente qualsiasi tipo di rappresentazione di esperienze o di emozioni umane – fa uso
di nessi analogici. Non è questa la sede per esporre i
princìpi di una qualche teoria generale, ma chi vuole
avventurarsi nelle strutture semiotiche di un’opera musicale dovrebbe tener conto del fatto che la musica è
costruita tipicamente per riprese e variazioni, ove ci
sono riproposte occorrenze in qualche modo “simili”, e
E|C Serie Speciale
Anno I, n. 1 2007, pp. 21-29
ISSN (on-line): 1970-7452
ISSN (print): 1973-2716
EC
Raccontare la perdita del senso.
Per un’analisi della musica
dei King Crimson
Guido Ferraro
riconoscibili, di una certa struttura melodica (o anche ritmica, ecc.). Questo fenomeno va considerato per certi
aspetti parallelo al fatto che noi riconosciamo tra loro
simili i modi in cui un vecchio adirato e una fanciulla
sognante pronunciano, ciascuno a suo modo, la parola “trippa”, o anche al fatto che nuvoloni dalle forme
più diverse valgano come analoghi di una probabilità di
pioggia. Come si vede, non importa affatto che il primo
caso rientri nell’area dell’iconismo, il secondo in quello
dei segni arbitrari, e il terzo in quello dei segni indicali.
Per tutti i tipi di formazioni segniche vale un principio
fondante, per cui il lato significante va pensato estensionalmente come una classe contenente un ampio numero di occorrenze tra loro equivalenti e dunque, nella
nostra soggettiva percezione, tra loro “simili”. Poiché
tali elementi – per esempio tutte le grosse nuvole scure
– sono analoghi in quanto equivalenti nelle loro capacità di rinvio semantico – io li dico co-analoghi.
Un brano dei King Crimson può così ad esempio proporci più volte, anche insistentemente e in forme ogni
volta variate, una struttura musicale che proprio grazie a
tale ripetizione assume il carattere non immediato, e diciamo meta-discorsivo, di una configurazione significante.
L’identità del costrutto musicale dipende così dal gioco
della sua moltiplicazione. Come la pioggia conseguente
all’apparizione di una singola nuvola scura non determina la formazione di un segno, ma la connessione semiosica si forma solo quando raduniamo n nuvole scure
in una classe significante, correlandola alla probabilità di
pioggia, così in musica il meccanismo della ripetizione variata conduce l’ascoltatore a cogliere, al di là di
quanto concretamente tocca le sue orecchie, una sorta
di forma astratta – quella che possiamo dire “forma dell’espressione” – disponibile alla correlazione con una
struttura di senso. Il riconoscimento del type, indispensabile, avviene tipicamente a partire da una molteplicità di tokens.
© 2007 AISS - Associazione Italiana di Studi Semiotici
T. reg. Trib. di Palermo n. 2 - 17.1.2005
22
Pur non escludendo affatto che in certi casi una tale
struttura significante astratta possa essere identificata a
partire dall’incontro con una singola, e assai forte, occorrenza, non c’è dubbio che la musica, con la sua (costitutiva?) tendenza all’iterazione e al gioco delle simmetrie
e delle correlazione variate, sta a renderci evidente il
preponderante agire di un opposto principio di moltiplicazione, o “disseminazione” (concetto molto efficace, di derivazione greimasiana): un principio che può agire non
solo all’interno di ciascun brano musicale ma anche
nella definizione di un “modo di fare musica” che può
consolidarsi a livelli ben superiori a quelli della singola
composizione.
La significazione iconica, a differenza delle altre forme,
è caratterizzata dal fatto che essa aggiunge un altro tipo
di analogia che non lega più tra loro i membri di una
classe di varianti equivalenti (sul piano del significante),
ma pone in relazione la configurazione significante
con un correlativo piano di significato. Certo, in questo
non bisogna assumere punti di vista semplici o banalizzanti; il rinvio iconico proprio all’ambito musicale non
assume in effetti carattere di “figuratività”, se non in
casi marginali. Per chiarire a cosa questo potrebbe in
concreto corrispondere, possiamo citarne un esempio
anche a proposito della musica dei King Crimson, dal
momento che è stato affermato che, nel brano intitolato
Pictures of a City, le brusche ascensioni cromatiche verso l’alto starebbero a evocare lo skyscape dei grattacieli
newyorkesi. Un esempio è sufficiente, mi pare, a rendere evidente lo scarso interesse di questa dimensione.
La musica è insomma da considerare sostanzialmente
“astratta” nel senso in cui intendiamo che lo sia la pittura non figurativa: il rimando iconico avviene su basi
di natura plastica (concetto che per altro ancora manca
a mio parere di una precisa definizione), anziché figurativa. Ovviamente, le categorie “plastiche” pertinenti al
sistema musicale saranno diverse da quelle cui siamo
abituati nel campo della comunicazione visiva. Avremo
per esempio a che fare nel nostro caso tanto con cate-
gorie distintive di validità molto generale, come quella
che può opporre sonorità continue e discontinue, quanto
con opposizioni da sempre specifiche al linguaggio musicale, come quella tra crescendo e diminuendo, ma anche,
per fare qualche altro esempio, a categorie che possono
opporre impasti musicali che si presentano semplici (riconosciamo un unico strumento e un’unica linea monodica) ad altri che si presentano viceversa complessi, o
ancora – caso decisamente rilevante per la musica dei
King Crimson – a categorie che oppongono sonorità
tenui ed aeree ad altre che percepiamo come pesanti e massicce, e così via.
1. King Crimson: tra “rock progressivo” e
“musica colta”
Veniamo ora al gruppo musicale di cui tratto; il gruppo
ha caratteristiche davvero molto particolari, che rendono indispensabile citare alcune informazioni di riferimento. Attivo tutt’oggi, ma in formazioni sempre rimaneggiate, suona a partire dal 1969, anno in cui esce il
primo disco, In the Court of the Crimson King, da molti considerato in effetti quale manifesto e punto di partenza
del cosiddetto progressive rock. Il gruppo si colloca infatti
all’interno di quest’area di incerta definizione: il “progressive rock” non si presenta come un vero indirizzo
musicale bensì come un più generico orientamento, che
possiamo dire centrato soprattutto intorno agli anni ’70
del Novecento, in Inghilterra, quando un certo numero
di musicisti ha proposto un uso più complesso, più raffinato, più intellettuale della musica rock. Qualcuno lo
considera in qualche modo il versante “musica colta”
del rock, talvolta spingendo anche molto – e forse troppo – il parallelo con la musica classica, com’è il caso di
Edward Macan (1997), nel libro che si intitola appunto
Rocking the classics.
In alcuni casi si è trattato dichiaratamente di un “uso”
delle forme della musica rock per fare altro; in questo senso vanno ad esempio le dichiarazioni dei musicisti del
gruppo precursore United States of America, i quali, confessando di fare in effetti fatica a suonare in stile rock,
poiché avevano una formazione musicale di tutt’altro
genere, affermavano di voler appunto introdurre in un
contesto rock le tecniche dell’avanguardia.2 Sappiamo
che di fatto, quanto meno, il progressive rock è stato spesso
percepito come una sorta di deviazione, sostanzialmente estranea alla tradizione della musica rock, e per molti
versi abnorme (si pensi a fenomeni come l’abbandono della forma canzone a favore di brani puramente
strumentali, o al fatto che si tratta di musica che non si
presta ad essere ballata). Nel caso dei King Crimson,
per quanto la maggior parte di coloro che hanno fatto
parte del gruppo avessero alle spalle una formazione e
un gusto musicale “rock”, risulta certo legittimo chiedersi se questo è stato usato per fare o per dis-fare musica
rock, se questa grammatica musicale di base sia stata
praticata o invece usata, se vi si sia rimasti dentro o la si sia
lasciata alle spalle. Secondo molti, tra i critici che si sono
occupati di questo genere di musica, i King Crimson si
distaccano dalla tradizione e dalle forme comuni della
musica rock, in quanto le impiegano consapevolmente come un linguaggio in cui esprimere idee musicali
che non appartengono al genere. Certamente la figura
personale di Robert Fripp, che è fondatore e anima del
gruppo, e unico ad averne costantemente fatto parte,
presenta ben pochi dei tratti tipici del musicista rock:
incurante delle mode, intellettuale, distaccato, professionale, interessato a una musica “destinata alla testa e
non ai piedi”, con un’evidente tendenza a flirtare con
la musica classica di cui possiede un’indiscutibile competenza… Scrive ad esempio Michele Chiusi, in una
presentazione del gruppo: “Robert Fripp è uno di quei
personaggi che hanno salvato il rock da sé stesso, ma
per farlo hanno dovuto accompagnarlo verso la senescenza e, lentamente, impercettibilmente, ucciderlo”.3
A proposito dei King Crimson, sono stati diffusamente
citati, oltre all’imparentamento con le correnti musicali minimaliste, almeno due principali riferimenti nella
musica colta, vale a dire Bela Bartok e Igor Stravinsky
– due autori da cui Fripp riconosce di essere stato decisamente influenzato. È ovvio pensare in particolare
a innovazioni sul piano della complessità ritmica, e a
certe forme di ripresa di modi della musica folclorica,
fino a una sorta di “primitivismo”; ci sono però altri
aspetti significativi. In particolare, per quanto riguarda
le affinità con Bartok, a un livello che possiamo dire
più facile si possono individuare delle assonanze, soprattutto in certe parti per violino solo, ma a un livello più
tecnico e meno visibile è stata indicata una vicinanza
concernente talune concezioni nell’uso dell’armonia e
della struttura della scala musicale, e altro. 4
Per quanto riguarda Stravinsky, è particolarmente significativo, per la nostra analisi della musica dei King
Crimson, il riferimento a una tendenza a citare, a rifare,
a parodiare i modi della musica classica. Dunque, non
è rilevante solo lo Stravinsky del Sacre du printemps, con
i suoi ritmi frenetici e irregolari, che certamente hanno
un preciso parallelo in taluni micidiali brani strumentali
crimsoniani, ma è forse ancora più rilevante l’imparentamento con lo Stravinsky “neoclassico”. Esempi di tratti comuni significativi sono l’uso dell’ostinato, l’impiego
di frasi musicali costruite con insistenti ripetizioni della
stessa nota, la costruzione dei brani talvolta giocata non
su forme di sviluppo lineare bensì su una contrapposizione tra blocchi omogenei. Ho già ricordato come tanto per Stravinsky quanto per i King Crimson si sia usata l’espressione “astrattismo musicale”; rilevo ora che il
neoclassicismo di Stravinsky dà a molti la sensazione di
un distacco, di un uso intellettuale delle forme musicali,
di una loro messa a nudo, di un dominio sulla musica
che frena la sua attitudine immediata all’espressione di
senso. Può essere, questo, pertinente anche nel caso del
gruppo rock di cui qui ci occupiamo?
Certamente paralleli significativi possono essere indicati; un esempio a mio parere di particolare interesse può
essere visto nell’uso che Stravinsky faceva del crescendo
defunzionalizzato: di un crescendo cioè che, al contrario
di quanto ci attendiamo dal suo impiego tradizionale,
finisce nel nulla, non porta l’ascoltatore da nessuna
parte. Questo, nella musica dei King Crimson, diventa
addirittura una struttura costruttiva portante, in certo
senso quasi un loro marchio di fabbrica. E già questo
può avviarci verso considerazioni che collegano tali
configurazioni espressive a strutture concettuali poste
sul lato del significato. Ma, per chiudere con questi cenni
all’imparentamento con autori di musica classica, non
si può non ricordare un altro parallelo, quasi obbligato
eppure tutt’altro che superficiale, con il Bolero di Ravel:
un parallelo citato anche da comuni recensori dei dischi
del gruppo, tanto che si è diffusa l’espressione “Il Bolero
di Fripp”.
2. Alcune caratteristiche formali
Cerchiamo ora di sintetizzare un po’ più ordinatamente
almeno alcune delle principali caratteristiche della musica dei King Crimson (pur avvertendo che alcune non
sono, ovviamente, loro esclusive). Si è già detto della frequenza, o addirittura della prevalenza di parti strumentali prive di componente vocale, e di brani interamente
strumentali – carattere comune a tutto il progressive rock,
ma che acquista un maggior peso nel caso di questo
gruppo. Alcuni brani presentano in effetti una complessità di struttura musicale, e una corrispettiva difficoltà
di ascolto (ma si tratta anche proprio di scoraggiare un
“consumo” superficiale…), che difficilmente ha paralleli in altri gruppi di rock, per quanto “progressivo”.
La tonalità si presenta spesso instabile e ambiguamente
definita. Non mi fermo qui sul problema specifico costituito dall’uso insistente di relazioni armoniche particolari come il “tritono”, a mio parere eccessivamente enfatizzato da alcuni musicologi. Più particolare ai King
Crimson è l’elaborazione di un tessuto sonoro spesso
molto intricato, risultante dal sovrapporsi di diversi piani che compongono un insieme assai denso e compatto,
ispessito tanto dalla complessità dell’impasto timbrico
quanto dalla sovrapposizione di piani musicali disomogenei. A questo si aggiunge l’uso frequente di poliritmie
piuttosto complesse, talvolta con la suddivisione degli
strumenti in gruppi che seguono scansioni metriche differenti e che sembrano contrapporsi e rincorrersi tra
loro. Leggiamo ad esempio, in una recensione dell’album Thrack, che per comprendere ciò che accade in
quest’opera musicale bisogna “immaginare due band
complete (chitarra, voce, basso di qualsiasi natura e
batteria) armate di partiture separate che suonano per
la supremazia”; un “mixaggio abilissimo” permette di
“distinguere perfettamente chi sta suonando e che cosa,
un gioco molto serio di armonie e fughe, contrappunti e
infernali sovrapposizioni di metriche differenti”.5
Il rinvio analogico a forme concettuali traspare assai
facilmente. Notiamo inoltre che questo tipo di brani è
spesso costruito per grandi blocchi sonori compatti, giustap-
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
23
24
posti o concatenati tra loro. Si parla in quanto senso
di una musica che si presenta “fortemente strutturata”,
dotata di una sorta di prevedibilità dichiarata quanto artefatta, forse simulata: una concatenazione inesorabile
che testimonia la forza della regola, per quanto questa
risulti arbitraria. Questa sensazione risulta confermata
anche dall’occasionale comparsa, come in sovrapposizione sullo sfondo musicale, del battere del metronomo.
Non è difficile intendere come questo corrisponda a un
ben preciso progetto espressivo, e dunque a strutture
di senso.
A questo tipo di brani se ne contrappongono altri, o
loro parti specifiche, dal tessuto sonoro invece molto
esile, cantati anche con una voce fievole, talvolta incerta, quasi come abbandonata a se stessa… e non di
rado poi le melodie, vocali o strumentali, si sgretolano finendo nel silenzio. Tipico dei King Crimson è in
effetti sia il poderoso impatto sonoro di certi brani sia
uno stile di “ballata”, garbato ed elegante, di grande
attrattiva melodica, talvolta anche con tocchi arcaici,
rinascimentali.
Non si può non citare l’uso di strumenti elettronici, il
“mellotron” in particolare, talvolta con effetti vagamente “fantascientifici” ma più spesso evocativi di un tessuto orchestrale classicheggiante. Il mellotron si presta in
effetti a una stratificazione, con imitazione di differenti
strumenti orchestrali, poiché è uno strumento fondato
sul campionamento musicale, e che dunque può produrre
l’effetto di una sorta di citazione degli strumenti tradizionali. In alcuni casi – tuttavia non frequenti né particolarmente significativi, a mio parere – sono da segnalare
brani che alludono palesemente alle forme, agli impasti
strumentali e alle atmosfere musicali della tradizione
classica – celebre in questo senso il “Preludio” Song of
the Gulls nel disco Islands. Un caso particolare è il lungo
pezzo intitolato Devil’s triangle nell’album In the Wake of
Poseidon, costruito su uno dei movimenti che compongono la suite Planets di Gustav Holst: si tratta di una
costruzione intertestuale piuttosto complessa, ove nella
parte finale si moltiplicano le citazioni e le sovrapposizioni tra generi musicali.
Infine, un altro aspetto decisamente tipico, specie del
primo periodo dei King Crimson ma in qualche modo
presente anche nelle evoluzioni successive, è quello delle cosiddette grandi “ballate epiche”, brani dal tono
maestoso, secondo alcuni addirittura “pomposo”, con
effetti sinfonici e corali: un modo di fare musica che può
ricordare anche certa musica barocca di corte, e che
non a caso fa il suo debutto nel primo disco del gruppo, con un brano dal titolo, appunto, “Alla corte del
re Crimson”. Un carattere “epico” è comunque riconosciuto costantemente alla musica dei King Crimson,
anche fuori di queste composizioni che stanno tra la
musica da corte e la musica religiosa: a questo proposito
possiamo ricordare – perché legato innanzi tutto proprio a tale carattere “epico” – il già citato e frequentissimo uso del crescendo, quasi emblematico nella musica
dei King Crimson ma, secondo le osservazioni del musicologo americano John Sheinbaum,6 estraneo invece
alle convenzioni musicali del rock.
Più complicato è l’ultimo punto di questo elenco, concernente la tendenza dei King Crimson a operare per
variazione – sia a livello micro che macro, poiché in effetti
anche nella sua globalità la storia del gruppo può essere vista come un affascinante tornare all’infinito sugli
stessi temi, ripensati e riforgiati – fatto anche questo
Guido Ferraro · Raccontare la perdita del senso. Per un’analisi della musica dei King Crimson
del tutto inusuale nell’universo del rock (più presente,
semmai, in quello della musica jazz). È d’altro lato evidente nei King Crimson la convinzione che i temi non
siano oggetti musicali definiti nella loro identità e nei loro
valori semantici, ma che principale portatrice di senso
sia invece l’elaborazione che se ne opera, la loro esibita
trasformazione: un principio che si è presentato prepotentemente nella storia della musica con la produzione più
matura di Beethoven, e che è alla base delle riflessioni
di un autore fondamentale, che dal nostro punto di vista
fa da ponte tra analisi della musica e teoria della narrazione, vale a dire Claude Lévi-Strauss.
3. Dalla forma espressiva alle strutture
di senso
Se quelle citate sono caratteristiche che descrivono in
qualche modo aspetti rilevanti del piano espressivo, o
significante, esse ci guidano al tempo stesso verso alcune
ipotesi di connessione con il piano del significato. Può essere utile innanzi tutto notare che molti brani – in primo
luogo ovviamente quelli centrati su una melodia cantata – presentano un tono nettamente narrativo, anche
al di là dei loro testi, dunque a prescindere totalmente
dal senso delle parole. I comuni ascoltatori tendono in
effetti a percepire, nelle opere dei King Crimson, un
grado di narratività che appartiene alla loro musica in
quanto tale.
Volendo definire, sia pur molto grossolanamente, quali indirizzi patemici principali corrispondano a questa
percezione di narratività, si può dire che si registrano immediatamente due indirizzi espressivi facilmente contrapponibili: da un lato, la ricorrente espressione di una
dolce malinconia, di un senso infinitamente nostalgico
del tempo passato, e se vogliamo un senso della fragilità
delle cose, un’impressione di incertezza e di perdita; dal
lato opposto, una grande sensazione di energia e di potenza, ma di una potenza che viene percepita come in
qualche modo non umana, e sovrastante.
Viene anche spesso evidenziato, da critici e ascoltatori,
un senso di ossessività, si parla di toni “oscuri” e quasi
“minacciosi”, di effetti “ipnotici”, dovuti spesso al complesso gioco di permutazioni che costruisce ciascuno dei
blocchi musicali di cui parlavo prima. E c’è non di rado
ossessività nella stessa costruzione melodica: si pensi ad
esempio alla ripetizione di diciassette volte la stessa nota
nel tema principale di Catfood. Il violinista David Cross,
che ha partecipato alla registrazione di alcuni dischi del
gruppo, parla di un’espressione di “orrore e panico”.
Ma, come si è detto, questo va coniugato con il lato
epico, grandioso, corale, e insieme a questo la percezione di una componente religiosa, talvolta del resto anche
apertamente dichiarata, pur se forse non così fondante
come in alcuni album del solo Fripp.
Va notato che la relazione e il passaggio tra le diverse
componenti è spesso sorprendente, inatteso, anche nel
senso che temi che si presentano molto dolci subiscono
variazioni verso effetti di grande asprezza, o viceversa
che sequenze di rock inizialmente assai duro si aprono
all’improvviso in momenti giocosi di grande dolcezza
– questo anche, ovviamente, sulla base di un uso magistrale e talvolta assai intricato delle variazioni metriche.
La stessa struttura globale che organizza i vari pezzi degli album è caratterizzata dal fatto che con una certa
frequenza i brani si interrompono e si intersecano l’uno
con l’altro, regalandoci per esempio il ritorno di una
bellissima melodia al di là di una vicenda di suoni oscuri
e violenti.
Se dunque parliamo di una costruzione in qualche
modo “narrativa”, questa è ottenuta attraverso il complesso intrecciarsi – e non la semplice giustapposizione
– di componenti contraddittorie. Nei brani più tipici,
che percepiamo assolutamente staccati da una tradizione melodica e, più tecnicamente, da quella forma
canzone che comunque domina l’universo della musica rock, possiamo riscontrare una sorta di assai significativa inversione del rapporto figura-sfondo: l’ascoltatore
avverte che quello che normalmente funge da base di
accompagnamento giunge a prendere il primo piano,
in taluni casi con una tale decisione, con una tale prepotenza, da non lasciare alcuno spazio per altro che
non sia questa compatta e ossessiva macchina sonora,
in altri casi invece aprendo spazi inattesi. La perdita del
primo piano, dell’effetto di figura, ci suggerisce il rinvio
analogico all’angosciosa messa in dubbio di un qualche
“Soggetto cartesiano”, staccato dal contesto e disegnato
in forma autonoma, capace di prendere la parola e con
questa oggettivare l’ambiente in cui si scopre collocato.
Per esempio, in uno dei brani più riusciti di questo tipo,
che porta il significativo titolo FraKtured, parte dell’album
The ConstruKction of Light, si alternano sezioni che, pur
essendo tutte fondate su ostinati arabeschi della chitarra, mettono però in sequenza parti differenti dal punto
di vista timbrico ed emozionale, dando vita a un’inesorabile, gelida alternanza da spietato ordigno musicale, o
se si vuole da perverso e disperato carillon: una formula che paradossalmente, proprio per la sua dichiarata
estraneità alla logica delle successioni emotive, sortisce
di fatto un grande effetto di patemizzazione, attribuendo eccezionalmente un grande potere espressivo tanto
alle parti più pesantemente ordite quanto alle sezioni in
cui gli arabeschi si fanno più trasparenti e soavi.
La ripetizione – variata – di questo alternarsi dei blocchi
di diverso carattere vale come in molti altri casi a generare un effetto di co-analogia: l’ascoltatore è cioè condotto a riconoscere che dietro il succedersi di queste parti,
ripetuto più volte in modo simile, si pone una struttura
più astratta, un intuibile principio d’organizzazione del
piano del significante. In questo caso, il modo ossessivo
in cui tale alternanza si ripete, così insolitamente priva
di motivazioni o connessioni logiche, prospetta un definito effetto di senso – o se vogliamo di sua assenza. È in
effetti a questa alternanza impietosa, senza possibilità
di uscite e di sviluppi, di risoluzioni o di punti di arrivo,
che allude l’espressione “perdita del senso”contenuta
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
25
26
nel titolo di questo articolo: è un po’ come quando a
teatro vengono presentati gli attori del dramma, vengono messi a confronto, viene imbastita la scena… e poi
si torna a ripresentare gli attori del dramma, e così via,
finché è chiaro che nulla accadrà mai. Se questi cenni
possono ricordare il teatro di Beckett, credo che in effetti un’analogia ci sia, tutt’altro che banale, con gli effetti
semantici proposti da certi brani dei King Crimson. Per
questi ultimi come per Beckett, l’apparente e ricercato
esaurimento del senso si tramuta in un’ancor più forte
carica di pensiero e di emozione.
Per citare un altro esempio, diverso da questo, posso
ricordare che nello stesso album, The ConstruKction of
Light, c’è una sorta di suite, piuttosto lunga (circa tredici
minuti) e piuttosto impegnativa: una lunga serie di episodi dal sound pesantissimo e molto ossessivo, che poi si
apre insensibilmente, e inaspettatamente, a una “coda”
confusamente melodica, in cui interviene poi la voce
del cantante che, pur sommersa in questo gorgo di suoni caotici e di ritmi incoerenti, intona una melodia resa
disperata dal crescere delle tensioni armoniche. Questa
coda, che si intitola I have a dream, realizza anch’essa una
forma di inversione tra figura e sfondo, ove la voce umana è annegata in un metallico oceano sonoro. Difficile
non riconoscere in questa struttura musicale un analogon
di una parallela struttura concettuale, se vogliamo ideologica, che ripropone con una sua speciale evidenza, e
con una tutta sua rielaborazione musicale, un pattern
che nelle sue linee generali riconosciamo ben attestato
nella cultura dei nostri tempi.
4. Violini narranti e Destinanti gelatinosi
Introduco a questo punto l’esempio che vorrei considerare un po’ più in dettaglio, per giungere a qualche
conclusione teorica: si tratta di Larks’ Tongues in Aspic,
contenuto nell’omonimo album di cui occupa quasi la
metà del tempo, essendo costituito da due lunghe parti
collocate all’inizio e alla fine del disco, per circa venti
minuti e mezzo totali. A parte la comparsa in sottofondo di alcune voci umane, tuttavia non cantate, il brano
è puramente strumentale.
Tra i motivi che mi hanno condotto alla scelta di questo esempio vi è il fatto che della composizione esistono ben due analisi dettagliate. Una è quella di Andrew
Keeling, compositore e musicologo, originale anche per
la confezione in forma multimediale (è pubblicata come
cd-rom contenente anche una parziale partitura eseguibile in forma midi).7 Si tratta di un’indagine interessante, accurata dal punto di vista della forma musicale e
in modo particolare da quello della struttura armonica,
ma a mio parere piuttosto debole sul lato interpretativo.
Keeling vede in questa composizione la struttura del rito
di passaggio, con la morte (nella prima parte) e la rinascita (nella seconda) di una vittima sacrificale, e sottolinea
le affinità con il rito primaverile cui rimanda il Sacre du
printemps strawinskiano.
Io farò piuttosto riferimento alla più convincente analisi
offerta dal musicologo Gregory Karl (2002). Egli sostiene tra l’altro una sua ipotesi – a mio parere interessante,
pur se discutibile nei termini in cui viene posta – che si
rifà al concetto biologico di “evoluzione convergente”,
per sostenere che, pur se la complessità di certe opere
del progressive rock può ricordare per molti versi aspetti
della musica classica, questo avviene come risultato di
un’evoluzione interna e non di un’imitazione o ripresa che in qualche modo voglia ricalcare le forme della musica classica. Più in particolare, a proposito della
composizione di cui parliamo, egli sottolinea come essa
esibisca una sofisticata forma narrativa e una conseguente strutturazione che per certi aspetti la avvicina
a quella della musica d’arte strumentale del XIX e XX
secolo (Karl 2002: 122). L’idea di un’evoluzione indipendente si fonda su un’analisi dello sviluppo interno
della musica dei King Crimson: un’analisi che mostra
come in opere più avanzate si possano ritrovare riprese
e sviluppi di princìpi organizzativi presenti già nei primi
album. Questo permetterebbe di mettere in luce una
“pratica”, o paradigma narrativo, comune alle opere
dei King Crimson.
Non possiamo ovviamente ripercorre la sua analisi dettagliata, ma è opportuno sintetizzare il percorso musicale e narrativo che ne risulta. La composizione si apre
con un lungo preludio “ipnotico”, che Keeling dice ispirato ai modi delle orchestre gamelan dell’Indonesia. Il
brano è basato sulla ripetizione di una cellula melodica
molto semplice, a effetto tipo carillon, suonata da una
kalimba che, attraverso una serie di piccole variazioni,
conduce verso una sorta di allargamento, ove si ha la sensazione di un progressivo moltiplicarsi di campanelle
che riempiano e dilatino l’ambiente musicale: come il
lento aprirsi del sipario su una grande scena epica.
Il primo tema presenta subito l’effetto di un crescendo,
e viene scambiato tra una chitarra fortemente distorta e il violino: un crescendo molto teso e emozionato,
che spinge il violino verso l’alto, verso una maggiore
luminosità, mentre la chitarra inizia la sua discesa verso
il basso. Apro qui una piccola parentesi, nel tentativo
di rendere più forte questa analisi: come scrive Robert
Hatten (professore di teoria musicale all’Università
della Pennsylvania), in un affascinante libro intitolato
Musical meaning in Beethoven, il movimento verso l’alto è
iconicamente collegato con l’idea di volontà, ambizione, sforzo
verso…, e il movimento verso il basso con un senso di
rassegnazione (Hatten 1994: 57).
Tornando al nostro brano, a questa fase iniziale segue
subito l’esposizione del secondo tema, molto ritmico e
molto metallico, pesante, ossessivo e meccanico. E voilà,
i personaggi della storia sono presentati. A mio parere si
tratta in effetti, se vogliamo considerarli così, non di due
ma di tre personaggi: un violino che appassionatamente
si leva verso l’alto, una chitarra che in modo inquietante
si aggira verso il basso, e un pieno orchestrale sinistro ed
oscuro. Personalmente, mi sembra che questa struttura
sia superiore a quella che comunemente contrappone
Guido Ferraro · Raccontare la perdita del senso. Per un’analisi della musica dei King Crimson
il solista all’orchestra, poiché ci consente di avere due
entità che possiamo dire “personalizzate” – una con valore più positivo, l’altra con valore più negativo – e una
terza entità definita in forma più collettiva e imperiosa.
A uno sguardo narratologico, può essere facile riconoscere la struttura ben nota che da un lato contrappone
Soggetto a AntiSoggetto e dall’altro lato separa questi
ultimi dal piano – collettivo, più oggettivato e superiore
in termini di forza – del Destinante. Ma non si pensi
a nulla di schematico: poiché tali ruoli appaiono qui
dinamicamente mutevoli, sfumati, capaci di molteplici
avvicinamenti e ricombinazioni.
La riesposizione del primo tema assume a questo punto
un carattere patemicamente molto diverso, perché sotto
il suono baldanzoso del violino la chitarra fa avanzare
dei suoni bassi e minacciosi, che si fanno ora preponderanti… ed ecco che la vicenda incomincia, e si complica secondo una modalità tipica della musica dei King
Crimson: le due parti, il violino e quello che in termini
tradizionali chiameremmo il suo “accompagnamento”,
vanno fuori fase, seguendo percorsi ritmici differenti (che sovrappongono battute in 6/8 e 10/8), con un
effetto di spaesamento e di ansia, che termina con la
riaffermazione del secondo tema e la cancellazione del
crescendo del violino.
Segue una cadenza per la chitarra, caratterizzata da una
continua ambiguità tonale, e poi di nuovo l’elaborazione del secondo tema, con caratteri di molto maggiore
complessità ritmica, cui si accompagna, dice Gregory
Karl, una sorta di “ferocia” musicale, tale da portare a
un crescendo senza meta, che alla fine collassa e come
muore. Possiamo aggiungere che l’effetto particolare di
queste sezioni si fonda anche su una tipica irregolarità ritmica impiegata dai King Crimson: battute in 8/8
o in 10/8 asimmetriche – gli otto ottavi sono ottenuti
come 3+3+2 e i dieci ottavi come 3+3+2+2, una struttura irregolare che ricorda il Sacre di Strawinsky.
Qui si colloca la lunga parte del violino solo, un interludio in cinque sezioni, un soliloquio triste e pensoso, che
talvolta si ferma nel silenzio e che, dice Karl, ci trasporta come in un “reame magico”. Il suono è esile, accompagnato solo da un effetto-campanelle che riprende il
preludio del brano. Difficile non percepire la solitudine
di questo lamento che si svolge in un improvviso deserto sonoro (e difficile anche, per chi la conosca, non
coglierne una matrice bartokiana).
Il nostro Soggetto è ora solo, ma nella sua solitudine non
sa elevarsi, non sa uscire dalla sua malinconia. Ed infine
il violino si ferma: un silenzio, poi dal nulla riemerge il
primo tema, inquieto ed aereo, reso ora pura inflessibile
macchina ritmica, e questo riprende a crescere, sempre
più forte, sempre più appassionato, ora accompagnato
anche da voci umane sullo sfondo, di cui non si intendono le parole. Il crescendo arriva questa volta a una soluzione: una nuova melodia, come un ricordo infantile di
una serenità perduta… e questo termina la prima parte
della composizione.
La seconda parte ha inizio circa ventisei minuti più
avanti, collegata direttamente al brano che precede da
una sorta di lancinante grido metallico, e aperta dal
meccanico ostinato di quello che abbiamo detto “secondo tema”. Ricompare poi il violino, che riprende la
gioiosa corsa del suo crescendo, è interrotto, riprende
da capo, si blocca di fronte a un tremendo ostinato degli
strumenti a corde, riprende ancora, sempre più timido
e più emozionato, finché, dice Karl, s’ingaggia la battaglia finale: ora il crescendo del violino e la meccanica
ossessiva degli strumenti a corde si sovrappongono o
addirittura si fondono, il violino prende sempre più forza, sale sempre di più in una sorta di “volo di trascendenza”: si ha la sensazione di una gioia quasi fisica, poi
il violino con uno sforzo di volontà si eleva in un suono
che sembra sfumare in alto verso l’infinito, mentre il
motivo ossessivo della sezione ritmica riemerge sì, ma si
trasforma e cede, celebrando anch’esso la festa gioiosa
del crescendo e sfociando in una coda che appare come
un’orgia di abbandono ritmico.
Raccontare un’opera musicale – una pratica utilizzata
in altri casi da illustri musicologi – può essere un’operazione che, al di là dei suoi molti ed evidenti limiti,
rompe l’apparente intangibilità dei fatti musicali. L’idea
è, s’intende, quella d’introdurre delle possibili relazioni
co-analogiche con fatti extra-musicali. Se può essere utile
immaginare per un momento possibili vicende e possibili personaggi, non è perché questi stiano in quanto tali
nel testo musicale, ma perché una struttura costruita in
musica e una struttura narrativa manifestata in parole
possono presentare – al di là dei diversi modi specifici
d’espressione – alcune comuni configurazioni portanti.
Sotto questo punto di vista, l’una e l’altra possono rinviare a strutture di senso – strutture logiche, concettuali, patemiche – in certa misura comuni. Certo, questa
sorta di “narrazione” di un’opera musicale è fatalmente
riduttiva; bisognerebbe tra l’altro corredarla di molti
altri particolari, come quelli relativi alla fondamentale elaborazione ritmica, difficilmente rappresentabile
in parole. Queste ultime, è ovvio, irrigidiscono ciò che
nella musica è espresso con molte più sottigliezze, e le
parole non tentano neppure di riferire il succedersi di
tensioni e di viluppi patemici che hanno invece un ruolo
centrale nell’esperienza d’ascolto. Tuttavia, non è senza
interesse il fatto che la lettura di Karl si presenti in una
forma decisamente narratologica. Egli parla della rappresentazione musicale di una persona, un Soggetto,
assalito e devastato da forze esterne, e si riferisce alle
parti del violino nei termini di un disperato desiderio di
scappare alla violenza meccanizzata dell’ostinato – una
tematica del resto diffusa in ampia parte dell’opera dei
King Crimson. Karl sottolinea però che non siamo
affatto di fronte a un caso di “musica a programma”,
bensì a una rappresentazione della vita e dei conflitti
interiori in “un senso astratto” (Karl 2002: 122).
Si possono come sempre leggere nel testo delle storie
un po’ diverse, ma quello che ci importa sottolinea-
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
27
28
re è che la “storia”, così come l’abbiamo schizzata, e
inevitabilmente enfatizzata per ragioni espositive, non
corrisponde a nulla che si sovrapponga ai puri fatti musicali. Stiamo parlando, invece, di una struttura che è
costruita ed esposta, e fatta percepire nell’esperienza
dell’ascoltatore, in termini appunto di puri fatti musicali,
o per dirla in termini semiotici di pure relazioni “plastiche”. Questo vuol dire tra l’altro che le cose sono più
complesse di quanto una parafrasi narrativa verbale
può far apparire; il rapporto che nell’opera via via avvicina e allontana la voce del violino dagli strumenti che
in certi momenti gli si contrappongono e in altri momenti lo accompagnano è un rapporto complesso – di
cui andrebbero considerati tutti gli aspetti armonici,
ritmici e melodici; l’esperienza musicale è certamente
più sottile, più ambigua, più affascinante e più unica di
quanto possono dire le parole.
Ma, al di là della lettura sequenziale di Karl, possiamo
ora precisare meglio il senso di questa analisi in termini di teoria semiotica, muovendo dall’osservazione di
quanto nella musica rock può corrispondere al piano
che possiamo riferire al “Destinante”. Dobbiamo avvertire che parliamo qui, più che di un semplice ruolo
sintattico in un racconto, di un’entità che si pone a un
livello più profondo: di un sistema di norme, di un ambiente
che stabilisce le regole del gioco e la griglia di riferimento per gli individui, dunque di un’istanza nei confronti della quale i Soggetti devono definire i modi e il
senso del loro agire. Nella musica rock – o comunque
nella musica dei King Crimson – questo sistema è rappresentato in primo luogo dalla definizione del quadro
armonico e dalla gabbia della disposizione ritmica: due
funzioni che in questa tradizione musicale sono tipicamente nelle mani della cosiddetta “sezione ritmica” (la
batteria e il basso, cui la chitarra può dare man forte). È
chiaro che in questa luce tanto l’incertezza tonale di cui
si è detto quanto l’irregolarità delle strutture ritmiche
assumono ulteriori, e definiti, valori semantici.
Si incomincia a comprendere, spero, che non stiamo
andando alla ricerca di analogie più o meno forzate
tra il campo musicale e quello narrativo; stiamo invece
iniziando a riconoscere i differenti (sottolineo questo termine) modi di presentarsi di qualcosa che è presumibilmente costitutivo della sensibilità umana e ineliminabile
dalle forme di modellizzazione delle nostre esperienze
– o come si suole in effetti dire, delle nostre “storie”
– di vita. E potremmo anzi forse pensare che non sia
tanto la teoria narratologica a poter essere spostata in
ambito musicale, quanto la semiotica della musica a poter offrire un contributo prezioso alla teoria della narrazione. Forse soprattutto perché l’iconismo musicale,
essenzialmente votato alle modalità di tipo “plastico”,
rende meglio visibili le sue strutture organizzative e,
facendoci diventare ben più immuni da ogni sorta di
“illusione referenziale”, ci pone di fronte a un discorso
che con evidenza ci parla di entità puramente concettuali.
A differenza di quanto può accadere nella lettura di un
romanzo o nella visione di un film, ci è qui facile cogliere – anche al di qua di una consapevole riflessione
teorica, dunque anche a livello di un’esperienza fatta
in primo luogo di suggestioni e di emozioni immediate
– quali siano la logica e il senso per cui degli strumenti
musicali cozzano contro la gabbia armonica e ritmica
che dovrebbe costituire il loro naturale “ambiente”, che
dovrebbe cioè assicurare, e controllare, i loro percorsi di
evoluzione espressiva.
La musica ci aiuta forse anche a renderci conto di una
certa sopravvalutazione della dimensione processuale del
narrare, a discapito di quanto a ben guardare può risultare piuttosto strumentale all’esposizione di una dimensione sistemica. Allontanandoci ora in parte dalla lettura
di Karl, possiamo proporre che l’essenziale non sia in
effetti cosa “accade” nella musica dei King Crimson
ma cosa definisce l’architettura profonda che regge, e
genera, questo “accadere” musicale. Ciò che regge e
genera, per esempio, un modo preciso e specifico in cui
un violino disegna una struttura melodica che da un
lato lo disgiunge dallo strumento che dovrebbe “accompagnarlo” e dall’altro lo estranea rispetto a una macchina ritmica che non potrà mai imprigionarlo definitivamente, ma che al tempo stesso lo definisce e lo sovrasta.
Sì, la musica sembra possedere talvolta la capacità di
approfondire tutte le sottigliezze di una relazione che
nei suoi aspetti più interessanti non necessariamente si
risolve in un accadere: una relazione tra l’aspirazione a
dar voce alla nostra sensibilità e il fatto che non possiamo che parlare con la grammatica scandita e normata
dal sistema in cui siamo immersi: per dirla con i King
Crimson, siamo Larks’ Tongues in Aspic, appunto: siamo
come melodiose lingue d’allodola, affondate nella gelatina del sociale.
Guido Ferraro · Raccontare la perdita del senso. Per un’analisi della musica dei King Crimson
Note
Bibliografia
1
Chiusi, M., 2004, King Crimson. Nel regno del progressive in “Onda
Rock”,www.ondarock.it/rockedintorni/kingcrimson.
htm
Hatten, R. S., 1994, Musical Meaning in Beethoven, Bloomington,
Indiana University Press
Holm-Hudson K., 2002, The “American Metaphysical Circus” of
Joseph Byrd’s United States of America, in Holm-Hudson K.
(a cura di) 2002, pp. 43-62.
Holm-Hudson K., a cura, 2002, Progressive rock reconsidered,
New York, Routledge.
Imberty, M., 1979, Entendre la musique, Paris, Dunod; trad. it.
parziale Suoni Emozioni Significati, Bologna, Clueb, 1986.
Imberty, M., 1981, Les écritures du temps. Sémantique psychologique
de la musique, Paris, Bordas; trad. it. Le scritture del tempo.
Semantica psicologica della musica, Milano, Unicopli, 1990.
Karl, G., 2002, King Crimson’s Larks’ Tongues in Aspic. A case
of convergent evolution, in Holm-Hudson (a cura di) 2002,
pp. 121-142.
Keeling, A., 2002, Musical Guide to “Larks’ Tongues in Aspic” by
King Crimson, CD-ROM, Spaceward Graphics, London.
Keeling, A., 2004, Musical Guide to “In the Wake of Poseidon” by
King Crimson, CD-ROM, Spaceward Graphics, London.
Macan, E., 1997, Rocking the Classics: English Progressive Rock and
the Counter-culture, New York, Oxford University Press.
Nobile, M., 2003, King Crimson, Thrak, in “RockLab”, www.
rocklab.it/recensioni.php?id=270.
Sheinbaum, J.J., 2002, Progressive rock and the inversion of musical
values, in Holm-Hudson (a cura di) 2002, pp. 21-42.
Ringrazio Luca Marconi per avermi segnalato l’interesse di
questa prospettiva.
2
Cfr. Hold-Hudson 2002.
3
Chiusi 2004.
4
Si parla di un “sistema assiale delle tonalità”, e dell’impiego
dei rapporti della cosiddetta “sezione aurea”, per determinare la durata degli episodi interni a un brano: aspetti di cui qui
non parleremo, e per il quale rinviamo a Keeling 2002.
5
Nobile 2003.
6
Sheinbaum 2002.
7
Keeling 2002. Lo stesso autore ha dedicato anche un altro
cd-rom, a mio parere meno interessante, all’analisi di In the
Wake of Poseidon, altro album importante dei King Crimson;
cfr. Keeling 2004.
29
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
1. Il problema del codice musicale
Un codice musicale è monoplanare, cioè non ha una
corrispondenza biunivoca tra significante e significato. In un codice biplanare sappiamo che se vogliamo
esprimere un significato per denominare, descrivere o
comunicare un oggetto, un concetto o anche un semplice messaggio tra quelli inseriti in un numero limitato di
esigenze comunicative soddisfatte dal codice medesimo,
avremo a disposizione almeno un significante che codifica quel significato e che lo trasmette ad un soggetto in
grado di decodificarlo facendo capo alla struttura del
codice. Allo stesso modo, messo davanti ad un qualsiasi
significante del codice, sono sicuro di possedere le istruzioni precise per decodificare il messaggio e per trarre
dal significante il suo esatto significato1. Se ho un significante x questo corrisponderà ad una precisa classe di
sensi y e se ho il significato y questo avrà certamente
una classe di significanti x che lo esprimono nel codice
in questione.
Partendo dalla proprietà della biplanarità per definire
un codice semiotico, Hjelmslev aveva garantito una prerogativa fondamentale alla nozione di semiosi. Aveva
evitato che il processo della semiosi potesse diventare
così vasto da includere anche tutte quelle espressioni di
semiosi naturale che non hanno a che fare propriamente con l’esperienza culturale dell’uso e della decodifica
di un codice socialmente condiviso. In questo modo si
evitava di cadere nella morsa in cui ogni materia o sostanza dell’espressione presente nel mondo avesse diritto “per natura” di entrare dentro il gioco della semiosi.
Se così fosse, anche un piatto o un candelabro sarebbero segni per due motivi possibile: perché la loro denotazione
implica già che essi servano per un uso e abbiano una
funzione all’interno della comunità, o perché in certi
contesti possono possedere significati culturali o connotazioni sociali particolari. E’ indubbio che questi contesti ci siano, ma il problema delle due prospettive è da
una parte quello di attribuire alla sostanza dell’espressione piatto e candelabro, cioè al piatto e al candelabro
in quanto oggetto, una funzione semiotica che essi non
hanno in quanto tali. Infatti di per sé il piatto e il candelabro non vogliono dire nulla e non posseggono quella
proprietà di rimando di un significante ad un significato
che è, appunto, la caratteristica dei codici biplanari. Se
commettessimo l’errore di allargare l’idea di segno e di
funzione semiotica di rimando agli oggetti in quanto tali
la nozione di segno si amplierebbe in modo forzoso fino
a perdere di compattezza e a rarefarsi. Come si sa un
esponente di questa idea estensiva del segno è Sebeok,
ma anche la teoria dell’interpretante di Peirce potrebbe
portare ad una simile deriva pansemiotica. Su questo
problema non possiamo attardarci in questa sede anche
se esso costituisce uno dei capitoli fondamentali della
fondazione di una teoria del segno. Quanto detto però
ci ha fatto comprendere l’importanza di una nozione
come la biplanarità.
In questo contributo cercheremo di mostrare come se
E|C Serie Speciale
Anno I, n. 1 2007, pp. 31-39
ISSN (on-line): 1970-7452
ISSN (print): 1973-2716
EC
Che senso ha la musica?
Per una semiotica dei
codici monoplanari
Andrea Velardi
la prospettiva pansemiotica è assolutamente da evitare, è opportuno riconsiderare, al di fuori della disputa
sul segno naturale, la funzione semiotica che possono
avere sostanze dell’espressione che non posseggono di
per sé un contenuto all’interno di un codice strutturato.
Nonostante l’importanza della fondazione della teoria
dei codici, la tradizione strutturalista finisce col relegare
nel limbo dei codici monoplanari linguaggi come quello della musica, dei colori e della pittura, delle forme
grafiche. Non solo questa tradizione ma anche tutta
una musicologia precedente ha compiuto questa rigida separazione. A dimostrarlo è il seguente brano di
De Schloezer: “Il linguaggio è un sistema di segni che
noi decifriamo per giungere al loro significato, nel quale
soltanto consiste per noi il valore delle parole. Noi le
attraversiamo senza arrestarci per così dire con lo scopo
di afferrare quell’oggetto di cui esse non sono che il segno e l’espressione. Invece se ci sforziamo di ‘decifrare’
il significato di un pezzo musicale, se lo vogliamo trattare come un sistema di segni e lo attraversiamo nella
speranza di intravedere qualcos’altro, non ascoltiamo
più la musica: ci lasciamo sfuggire i suoni e altro non
troviamo”2.
Che significato ha un codice monoplanare? Molti studiosi hanno cercato di rispondere a questa domanda
all’interno di una teoria del linguaggio musicale. Essi
sono pervenuti all’idea che la musica esprimesse soltanto la musica, che fosse una sostanza dell’espressione che esprimesse soltanto la medesima sostanza dell’espressione, seguendo in questo una tradizione che ha
i suoi riferimenti principali nei saggi di Schuman, ne
la Poétique musicale di Strawinsky, ne Il bello nella musica
di Hanslick (1854), negli Elemente der musikalischen Astetick
di Riemann (1900), in Comprendere la musica di Boris
De Schloezer (1931), nel Mila di L’esperienza musicale e
l’estetica, fino al Meyer (1954) dell’embodied meaning e a
Jankélévitch (1961).
© 2007 AISS - Associazione Italiana di Studi Semiotici
T. reg. Trib. di Palermo n. 2 - 17.1.2005
32
Mi sembra che la sociosemiotica possa fornire una risposta al problema della significazione della monoplanarità trovando nuove prospettive di interpretazione
differenti da quelle della tradizione strutturalista. Per
fare questo dovremo riapprofondire le tesi fortemente
monoplanari presenti negli autori sopra citati, ridiscutere il problema della relazioni tra immagini uditivo-visive e musica, quello della significazione dei sentimenti
e delle emozioni da parte dei temi musicali e mostrare come seguendo i percorsi di manipolazione dei testi sincretici con forti componenti musicali (le colonne
sonore dei film, i temi sinfonici di vario tipo e le loro
citazioni nelle sigle di trasmissioni televisive) si possano
identificare alcune possibilità di attribuzione di senso
al linguaggio musicale. In quest’ultimo livello mostreremo l’esistenza di variazioni molto pregnanti, tra cui
alcune sottolineate dal meccanismo della citazione, e di
una diversificazione delle possibilità espressive del tema
musicale.
Il nuovo panorama musicale che intreccia in modi imprevisti i codici verbali con quelli non verbali ha permesso di capire che la vecchia idea secondo cui un
codice musicale è monoplanare, cioè non ha una corrispondenza biunivoca tra significante e significato, è una
idea giusta che però non dà ragione delle mille interpretazioni patemiche e timiche che possono essere riferite
a questo codice. L’intervento si propone di vedere come
attraverso lo studio di colonne sonore e di videoclip si
possa comprendere da dove provenga l’attribuzione di
senso emotivo ai testi musicali superando la contrapposizione strutturalista fra codici monoplanari e codici
biplanari. Distinguendo fra senso dizionariale e senso
emotivo ci si sforzerà di delineare le premesse teoriche
per la costruzione di una nuova teoria della semiotica
del codice musicale e quindi, indirettamente, dei codici
monoplanari.
2. Le tesi monoplanari radicali
Nella sua opera sulla relazione tra musica ed emozioni
Geoffrey Madell (2003) ha notato la mancanza di teorie
che spieghino perché e come la musica esprima emozioni. Questa lacuna dipende da due fattori: l’influenza
delle tesi di Hanslick e la esclusività dell’approccio cognitivista che studia le emozioni a partire da dati sperimentali sui giudizi e le credenze delle persone. Madell
rifiuta l’approccio cognitivo e riprende una concezione
della emozione come sentimento e la sua connessione
con la sfera del desiderio, del pathos, del piacere e della
motivazione.
A mio avviso la premessa del discorso di Madell è corretta. Mi sembra invece che l’enfasi nella critica agli
studi cognitivi sull’emozione non faccia giustizia delle
reali cause della penalizzazione subita dal linguaggio
musicale. E’ vero che il cognitivismo tradizionale ha
commesso l’errore di espungere l’emozione dal dominio della intelligenza e della conoscenza, ma non si può
non ricordare come in tempi recenti l’opera di studiosi
come Damasio (1995), Le Doux (1996) e altri, abbia
riportato l’emozione al centro dell’attenzione e le abbia
attribuito un ruolo mai avuto prima nella interpretazione dei processi mentali.
Secondo me l’utilizzo degli studi cognitivi per la semiotica del testo musicale sarebbe molto utile per costruire una più adeguata teoria (cfr. Juslin, Sloboda 2001;
Zentner et al. 2005). E’ sintomatico che un accanito
difensore dell’assenza di senso emotivo nella musica
come Meyer (1956), abbia intuito che se si vuole trovare una strada per ridiscutere la teoria dell’espressione
musicale non si può non fare riferimento alla moderna
prospettiva cognitiva, in cui il rapporto fra emozioni e
intelligenza è stato rivisitato alla luce di una visione di
maggiore interrelazione. Egli sottolinea al proposito la
“mancanza di fondamento della tradizionale dicotomia
tra emozione e intelletto” (ivi, 70).
La causa vera della penalizzazione di cui parlo è dovuta
al primo fattore individuato da Madell e cioè in quelle
tesi fortemente monoplanari che hanno in Hanslick il
loro fautore principale, ma che hanno una storia molto
più complessa. E’ nei saggi sulla musica di Schuman
(1942) che emerge con forza questo atteggiamento.
Schuman (1942, 53) immagina le persone del pubblico “seguire col programma alla mano ed applaudire”
Berlioz perché ha indovinato così bene la corrispondenza fra temi musicali e immagini e dice con una certa
asprezza che “della musica in sé, poco importa loro”.
Nella prima parte del saggio vengono affrontati gli
aspetti tecnici della sinfonia. In termini semiologici si
potrebbe dire che tutta la discussione si concentra sugli
elementi plastici della sinfonia: “Abbiamo visto dapprima come la forma di quest’insieme non si stacchi molto dal tradizionale, come le diverse parti si muovano
per lo più in nuove figurazioni, come periodi e frasi si
differenzino dagli altri per i loro rapporti inconsueti.
Riguardo alla composizione musicale abbiamo rivolto
l’attenzione sul suo stile armonico, sull’ingegnoso lavoro del particolare, dei rapporti e delle movenze, sulla
caratteristica delle sue melodie e, incidentalmente, sull’istrumentazione e sulla riduzione per pianoforte” (ivi,
51).
Schuman (1942–1952, 54) pronuncia una conclusione
netta secondo cui “ si sbaglia di certo , se si crede che i
compositori si mettano innanzi penna e carta nel misero proposito di esprimere , descrivere e colorire questa
cosa o quella”. Questa tesi viene innalzata a principio
estetico generale: “Il bello musicale non consiste perciò
nell’espressione di sentimenti, nè, tantomeno, nei sentimenti e nelle fantasticherie che la musica può suscitare
negli ascoltatori, ma in un armonioso gioco di richiami,
di simmetrie, di equilibrati contrasti, che danno norma
e proporzione all’ ‘arabesco musicale’ (ivi, 14).
Questa diffidenza verso la verbalizzazione psicologica
del dato musicale raggiunge il suo apice con Hanslick
(1854) secondo il quale le emozioni non possono essere
espresse attraverso la musica e il valore estetico di que-
Andrea Velardi · Che senso ha la musica? Per una semiotica dei codici monoplanari
sto linguaggio è puramente formale. Il suo profilo emotivo è irrilevante ai fini della sua percezione, decodificazione e sopratutto della sua produzione. Gli argomenti
di Hanslick sono tutti di natura filosofica e concernono la relazione che sussiste fra un codice espressivo e
elementi intenzionali presenti in esso. La musica non
possiede l’attitudine a rappresentare pensieri che sono
elementi intenzionali. Dal momento che le emozioni
implicano pensieri o comunque una aboutness, la musica
non può avere alcun contenuto emotivo3.
Anche Mila (1956) è fautore di una posizione radicale:
“Capire una sinfonia di Brahms non significa nient’altro che rendersi conto del perché a determinati suoni
ne seguano determinati altri....E abbiamo escluso con
insistenza l’ipotesi che aldilà dei suoni ci sia qualcos’altro da capire-un’idea, un’immagine, o una storia composta d’immagini e d’idee- di cui la musica sia soltanto
simbolo, il mezzo per arrivarci, così come avviene del
linguaggio nei suoi scopi pratici di comunicazione” (p.
61); e ancora: “Nell’espressione artistica, come tutti sappiamo ma non è male riconfermare, non esiste alcun
rapporto tra un contenuto e una forma distinti l’uno
dall’altra” (p. 62). A questo proposito Mila riprende la
terminologia usata nelle descrizioni dei codici biplanari
e fa notare come il termine “espressione” sia pericoloso
perché “induce a pensare di una duplicità della cosa
e del ‘mezzo’ per esprimerla. Duplicità che non esiste
affatto e che ridurrebbe la musica a una mera funzione
strumentale” (p. 62).
Dal punto di vista della sua produzione è vero che la
musica non abbisogna di emozioni. D’altra parte il
ragionamento di Hanslick sembra davvero radicale.
Possiamo citare una frase tratta dal film Fragola e cioccolato di Tomás Gutiérrez, dove ad un certo punto il protagonista, interpretato dall’attore Jorge Perugorría, ascolta da un vecchio grammofono un’opera di Beethoven e
dopo un po’ riflette sul fatto che quella musica possiede
elementi disforici molto intensi. Il suo commento ripreso testualmente dalla sceneggiatura è il seguente: “Questa
musica è triste! Ma chi me lo ha detto?”. L’alternanza di affermazione e di domanda in questo commento esprime
i termini della nostra discussione in modo più vicino
alla esperienza percettiva dei soggetti. Il problema della
origine del significato emotivo della musica è davanti a
noi, noi lo percepiamo come un fatto cui non riusciamo
a dare una interpretazione cognitivamente coerente e
sensorialmente continua, ma questo non vuol dire che
la musica non possa possedere un significato emotivo.
Epperò notiamo anche come vi sia troppa disinvoltura
nei critici musicali, o nella comune interpretazione, nel
dire che una musica è cupa piutosto che gioiosa o che
una sua sequenza è struggente piuttosto che esaltante.
Non solo il vocabolario delle emozioni è vago, ma vaga
e senza fondamento è la corrispondenza fra l’emozione e l’espressione musicale. Ma su questa vaghezza la
critica musicale e l’approccio naturale alla musica fondano gran parte della loro pregnanza e comunicabili-
33
tà. Volendo trovare qualche remota traccia di questo
fondamento dovremo certamente affrontare il tema dei
qualia. Ma è chiaro che non possiamo farlo qui in modo
sistematico. Lo facciamo discutendo le tesi di coloro che
negano l’esistenza del senso emotivo musicale, i cui ragionamenti assomigliano in qualche modo a quelli che
negano l’esistenza dei qualia.
Di grande importanza a questo proposito è la nozione
di embodied meaning definita da Meyer (1954) per distinguere un senso della musica indipendente dal contesto,
puramente edonistico e fondato solo su variazioni della
stimolazione sonora, da un significato referenziale che
ha invece un suo radicamento contestuale e grammaticale in cui si può trovare riflessa una rete di collegamenti semantici fra il codice, i suoi elementi e il mondo
esterno degli oggetti4.
Per Meyer il dibattito sul senso emotivo della musica ha
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
34
focalizzato in modo eccessivo la relazione fra l’espressione musicale e il mondo delle immagini, delle parole, dei
concetti e degli stati emotivi generali. E’ chiaro che non
si può negare che la musica sia capace talvolta di produrre contenuti intenzionali che hanno referenti di questo tipo, ma è fuor di dubbio che i principali fenomeni
di tipo affettivo rientrano dentro il linguaggio della musica stessa, cioè della sua struttura e caratura espressiva.
Se i sostenitori del senso referenziale hanno ragione a
dire che a volte la musica ha un potere di designazione di denotati, anche i più radicali non referenzialisti
come Hanslick, Rieman, Jankélévitch, Stravinsky e altri
hanno ragione a dire che la musica non possiede alcun
denotato fuori dal proprio linguaggio.
Per Meyer le due visioni non sono incompatibili (ivi,
33), ma egli si schiera dalla parte dei non referenzialisti
duri cercando di descrivere il processo di costruzione
di un significato non-denotativo e non referenzialista in
cui anche l’espressione delle emozioni può trovare una
sua giustificazione. Questo processo non denotativo è
quello che produce l’“embodied meaning” (ivi, 35) che è
molto più importante del “designative meaning” (significato denotativo): “quello che uno stimolo musicale o una
serie di stimoli ci indica o ci riferisce non sono concetti e
oggetti extramusicali ma altri eventi musicali che stanno
per venire fuori. Dunque un evento musicale sia esso un
tono, una frase o una intera selezione ha significato perché indica e ci offre un altro evento musicale” (ibid.).
Come ho ricordato prima Meyer riprende gli studi cognitivi sulle emozioni. Essi servono a distinguere di quale dominio psicologico possa essere espressione la musica. Un primo passo nella indagine di Meyer è quello
di distinguere le emozioni sulla base della loro relazione
più o meno forte con la psiche dei soggetti. La distinzione fra emotion e mood si rivela molto utile. L’emotion
ha un carattere “temporaneo ed evanescente”. Il mood
ha un carattere “relativamente permanente e stabile”.
La parola traduce in inglese il termine italiano umore e
quello più tecnico di stato psicologico. Secondo Meyer
quasi tutti gli studi sulla presenza delle emozioni nella
musica si sono focalizzati sul mood. Per l’autore invece il
fine della ricerca riguarda le emotion : “Motivi di dolore
o gioia, di rabbia o disperazione, hanno trovato nei lavori dei compositori barocchi o le qualità affettive e morali, attribuite a modes speciali o ragas nella musica araba
o indiana sono esempi di tali segni denotativi convenzionali. E può ben essere che quando un ascoltatore riporta di aver sentito questa o quella emozione, egli sta
descrivendo l’emozione che crede che quel passaggio
sia supposto a indicare, nient’altro di cui egli stesso ha
avuto una esperienza” (ivi, 8). E ancora: “L’ascoltatore
riporta nell’atto della percezione alcune credenze determinate sul potere di effetto della musica. Anche prima di sentire il primo suono, queste credenze attivano
disposizioni a rispondere in una modalità emotiva” (ivi,
11). Queste considerazioni di Meyer sembrano riecheggiare la discussione fornita da Mila (1956, 60-65) sulla
irrealtà del sentimento musicale. Mila afferma di non
voler negare che esprimendo solo se stessa la musica
abbia “una portata spirituale che va bel oltre la semplice definizione leibniziana di calcolo inconsapevole”
(ivi, 62). Questa portata spirituale ha a che fare con la
tesi della irrealtà dei sentimenti e della realtà di singole
esperienze individuali del sentimento. La gioia, il dolore, la speranza, il timore sono solo “oggettivazioni e
generalizzazioni” che sono state costruite dalla scienza
naturale della psicologia per una mera convenienza terminologica. In realtà dice Mila: “L’allegria non esiste.
Esistono solo persone allegre. E l’allegria di ognuno è
talmente diversa dalle altre, condizionata come è dalle
più varie circostanze di tempo e di luogo, e sopratutto
modificata dalle caratteristiche individuali del soggetto, che non rimangono in piedi elementi sufficienti per
giustificare una generalizzazione che sia ancora dotata
d’esistenza reale” (ivi, 63).
In questa prospettiva la domanda del protagonista del
film Fragola e cioccolato dovrebbe rispondere a se stesso
che la sua domanda è sbagliata, perché non è la musica
a essere triste o non triste, ma è la sua percezione a sentirla in quel dato momento secondo quella variazione
dello stato emotivo. Questo ragionamento paradossale
ed estremo porta ad una considerazione che sembra essere più accettabile della tesi radicale da cui discende:
“La cosiddetta espressione dei sentimenti nell’arte (...)
è espressione musicale in musica, espressione pittorica
in pittura, mentre la terminologia con cui designiamo
pretesi sentimenti è il residuo cristallizzato della loro
espressione letteraria” (ivi, 64).
Ora non si vede perché la correttezza di questo corollario debba discendere da un ragionamento così forzato
come quello che tende ad escludere la realtà dei sentimenti e a separare nettamente il dominio della espressione letteraria, dove questa irrealtà prenderebbe forma
in una nomenclatura precisa e abusata del lessico dei
sentimenti, dal dominio dell’espressione artistica che
non può assolutamente comunicare con il primo, né
mutuare da esso una enciclopedia delle emozioni socialmente condivisa. Sarebbe opportuno a questo punto
introdurre gli argomenti di Wittgenstein sul linguaggio
privato per scalfire la perentorietà della tesi di Mila. Ma
per adesso ciò che ci interessa maggiormente è mostrare come molte tesi radicali abbiano indagato l’ontologia
dei sentimenti e il problema della loro verbalizzazione,
portando inconsapevolmente a delle interessanti teorie
che possono essere riutilizzate, a mio avviso, proprio
contro le loro stesse tesi radicali.
Meyer condivide con Mila la tesi della inesistenza delle
emozioni e della loro individuazione tramite i soggetti
che le percepiscono: “Alla luce della conoscenza presente sembra chiaro che sebbene riaggiustamenti fisiologici
sono probabilmente aggiunte necessarie di risposte affettive esse non si mostrano cause sufficienti per queste
risposte e sono state infatti capaci di gettare una molto piccola luce sulla relazione tra risposte emotive e gli
Andrea Velardi · Che senso ha la musica? Per una semiotica dei codici monoplanari
stimoli che le producono” (ivi,12). Le emozioni hanno
un deciso carattere individuale e cambiano da persona
a persona e da contesto a contesto: La differenza sta
nella relazione fra lo stimolo e la risposta individuale”
(ivi, 13). “Non ci sono emozioni piacevoli o sgradevoli,
ci sono solo esperienze emotive piacevoli o sgradevoli”
(ivi, 19). Se da una parte il singolo suono può generare
cambiamenti fisiologici generali, questi cambiamenti
devono essere interpretati in senso cognitivo e in ordine all’emergere di emozioni delineate e specifiche che
vengono percepite e riferite dai singoli soggetti. In questo passaggio dal generale allo specifico vi è uno scarto
che confermerebbe nel suo radicale capovolgimento la
distinzione operata sopra tra mood e emotion e la sottodistinzione di una emotion come denotatum definito facente
parte di un dizionario patemico e di una emotion come
experience del soggetto. E’ importante precisare che per
Meyer l’emotion come denotatum non ha un carattere
meno sfumato e ambiguo della emotion come experience.
Una nozione interessante che emerge è quella per cui
le emozioni sono “essenzialmente indifferenziate” (ivi,
18), intrinsecamente indeterminate e quindi sottoponibili a processi di verbalizzazione e di riverbalizzazione
che non sono affidabili rispecchiamenti linguistici della
essenza dei sentimenti e delle emozioni dei soggetti.
A mio avviso un errore compiuto dentro queste prospettive radicali è quello di presumere la distinzione
fra senso referenziale e senso non referenziale e poi di
schiacciare dentro la prima distinzione quella fra senso
referenziale e senso emotivo. Le considerazioni offerte
da Mila e Meyer sulla soggettività dei sentimenti, lungi
dal portare conferme alla tesi radicale spingono verso
una riconsiderazione della opposizione biplanarità vs
monoplanarità che non coincide con la dicotomia presenza di senso vs assenza di senso.
3. Il recupero del senso emotivo
A mio avviso gli strumenti di analisi del linguaggio e di
conoscenza della mente che possediamo oggi possono
farci apprezzare sotto una luce diversa le considerazioni che abbiamo passato in rassegna cercando di sfatare
alcuni pregiudizi strutturalisti. Un modo migliore per
approcciare il tema del senso emotivo è quello perseguito da due autori come Stephen Davies (1994a, 1994b)
e Peter Kivy (1980, 1994). Il primo ha distinto due usi
della parola emozione. Uno primario in cui essa è applicata solo agli esseri dotati di sensazioni (sensibile sia
nel senso di provare sensazioni sia nel senso di provare
emozioni) e un senso secondario in cui il termine emotivo viene attribuito a entità che non hanno sensibilità,
ma le cui proprietà possono diventare espressioni di un
contenuto emotivo attribuito dall’esterno in modo arbitrario. C’è differenza fra il dire: “Questa persona ha
una faccia triste” e dire “Questa persona è triste”. E’
così se vedo una persona che disegna una faccia triste
in un foglio io potrò dire che: “La faccia disegnata nel
foglio appare triste” ma non che “Quella faccia è tri-
ste”. Per dire che la figura che sta nel foglio è triste,
io dovrò effetturare dei passaggi la cui legittimità mi è
data da evidenze che non si possono esaurire o circoscrivere alla mia percezione soggettiva del disegno della
faccia. Come fa notare Davies, spesso questo tipo di frasi vengono identificate in modo illegittimo attraverso un
uso estensivo del termine emozionale per cui le caratteristiche che sono tali solo nell’apparenza della forma
vengono tipizzate e collegate direttamente ad una emozione percepita. L’autore ribadisce che non è la stessa
cosa dire che una faccia ha l’apparenza di essere triste e
dire che la persona disegnata o quella reale è veramente
triste. Non sono le facce, ma le persone a essere tristi e
ad avvertire e attribuire il sentimento della tristezza.
In continuità con questo ragionamento Kivy fa l’esempio della faccia del San Bernardo da tutti ripresa come
icona della melanconia e della tristezza. La faccia del
San Bernardo non esprime la tristezza in modo necessario. Tra il significante “faccia di san Bernardo” e il significato “essere triste” non vi è nessuna corrispondenza
biunivoca, nessuna relazione biplanare suffragata dall’esistenza di un qualsiasi codice in cui facce canine e
emozioni sono ordinatamente correlate le une con le
altre. Con grande raffinatezza Kivy comprende che
questa distinzione non esclude che si possa far ricorso
a immagini monoplanari come significanti di emozioni.
La distinzione da operare in questo caso è quella fra
significanti expressing X e significanti being expressive of X.
Nel primo caso una forma o un’immagine esprimono
in modo necessario, grazie alla struttura intrinseca del
codice e al contesto, il significato X. Nel secondo caso
esse vengono usate dai soggetti per esprimere un X in
modo creativo. Kivy afrronta questa distinzione analizzando le varie visioni presenti in leteratura sulla possibilità di esistenza di espressioni emozionali standardizzate e codificate. In questa prospettiva esistono una
visione scettica moderata, una visione scettica estrema,
una visione criteriologica. La prima distingue tra caratteristiche che permettono di attribuire con certezza una
emozione solo sul momento e che sono being expressive
di quelle emozioni. La visione moderata prevede che
noi non possiamo sapere se una persona è realmente
triste o allegra o se esprime solo apparentemente questo sentimento. Nella visione moderata tutto il codice
delle emozioni è being expressive e non è necessariamente
denotativo. La visione scettica nega che possiamo usare
altro che espressioni designanti senza un collegamento
certo con la realtà. La visione criteriologica pensa che i
soggetti posseggano modi sicuri di attribuzione relativi
ad una sorta di grammatica psicologica fondata sulla
conoscenza e sulla competenza relativa ai concetti delle
emozioni.
La discussione e il dibattito innescato da Davies e
Kivy ha come sfondo la contrapposizione fra iconismo
e arbitrarietà del segno ed è legato al principio della
onnipotenza semantica secondo cui qualsiasi ente presente nel mondo può diventare segno di un qualsiasi
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
35
significato. L’esempio del San Bernardo e del Kivy ci
dicono anche che questo processo di semantizzazione
ha una qualche radice iconica e che vi è un forte iconismo patemico e emotivo di alcune immagini o forme
presenti nel mondo o nei testi prodotti dalla creatività
umana. Se rispettiamo la griglia di queste distinzioni e
inseriamo le immagini acustiche e le forme sonore in
questo ambito di richiami e di corrispondenze, allora
non v’è ragione per escludere l’espressione musicale dal
senso referenziale e dal senso emotivo, a patto che si
dica che la musica può essere espressione di questi sensi solo nella seconda accezione di Kivy cioè in quanto
being expressing of X. In questa prospettiva, afferma Kivy,
possiamo avere una descrizione delle emozioni significate dalla musica in un modo compatibile sia a quello
ingenuo e familiare cui siamo abitutati, sia fondato dal
punto di vista intellettivo.
36
4. La contaminazione dei linguaggi
Le teorie che abbiamo analizzato sopra ci fanno comprendere come sia ampio e acceso il dibattito sulla
espressività emozionale del linguaggio musicale. Le
analisi meno radicali hanno mostrato come la lettura
psicologica della musica si debba svolgere in un continuo e raffinato feedback con il linguaggio verbale. Al
posto di mantenere una rigida contrapposizione tra i
due codici, facendone esempi monolitici l’uno della biplanarità e l’altro della monoplanarità, si può imboccare la strada di una analisi ancora più complessa in cui
si mostrino le determinazioni e le variazioni di senso di
cui è suscettibile il codice musicale quando si intreccia
con il linguaggio in testi sincretici di svariata natura,
tra cui hanno particolare interesse le moderne colonne
sonore.
Nei suoi studi sulla musica Tarasti (1994, 2002, 2006)
ha fatto notare come la partitura musicale si contamina spesso con il sistema di modellizzazione primaria
costituito dal linguaggio verbale. Così ci troviamo davanti a particolari sequenze musicali del Seicento e del
Settecento che sono dedicate ad eventi peculiari della
vita aristocratica come mostra l’esistenza del cosiddetto
tema della caccia. Inoltre possiamo avere degli input interpretativi di tipo biplanare forniti dallo stesso autore
come nel caso del Vivaldi de Le Quattro Stagioni in cui
alcune sequenze musicali sono esplicitamente onomatopeiche e sono associate al rumore di insetti come succede nel famoso tema del calabrone. La stessa situazione
troviamo nel celeberrimo Carnevale di Saent Sens tutto fatto di riproduzioni dei suoni del mondo animale.
In questi casi noi diamo senso alla musica leggendo in
essa una narratività intrinseca che essa di per sé non
possiede. Noi non riconosciamo soltanto nei suoni delle onomatopee, ma ci creiamo delle immagini mentali
suscitate dal nome dato alla sequenza e unite in una
tessitura articolata.
In questi casi la significanza del codice musicale è decisa attraverso un ricorso preciso e puntuale al codice
linguistico verbale. Le note assumono un significato
grazie alla interpretazione che un altro testo, di natura
verbale, fornisce riguardo al testo musicale. In particolare un elemento paratestuale come il titolo del tema o
del movimento diventa una sorta di cursore interpretativo per l’attribuzione di senso e crea un testo secondo
quel processo ben descritto da Greimas (1966) per cui
dentro un semema, in questo caso il termine principale
del titolo (caccia, calabrone etc.), è contenuto in potenza
un intero testo, ovvero un intero setting o script dentro
cui il semema trova una sua dimensione di ampiezza
narrativa. La possibilità di tramutare il semema in un
testo nasconde però il rischio di infrangere i limiti della
monoplanarità dando un significato narrativo a gruppi
di note che di per sé non vogliono significare alcun segmento particolare della narrazione. Diciamo che lo sviluppo dal semema al testo è bloccato nel caso della musica e si potrebbe dire più semplicemente che il semema
contenuto nell’elemento paratestuale del titolo funge
soltanto da interpretante cruciale per l’attribuzione di
un senso al codice monoplanare. Esso è infatti un interpretante di matrice biplanare, verbale, appartenente
ad un codice socialmente condiviso che si inserisce in
una catena di interpretanti a-significativi. L’uso della
nozione di Peirce si dimostra utile in questo caso per
far comprendere come il processo della semiosi musicale può ottenere una fluidità e una narratività indiretta,
diversa dalla protonarratività di cui parla Garofalo nel
suo contributo, mutuata dalla prospettiva della semantica biplanare del linguaggio verbale. Questo flusso si
arresta in modo più o meno breve a seconda dei casi
proprio riguardo all’espansione del semema in un testo garantita dalla presenza di un interpretante cruciale
o da più interpretanti cruciali come il titolo del tema.
Come si vede, nella ricerca di come i codici monoplanari possono acquisire un senso, di natura linguistica
o emotiva, le tradizioni semiotiche interpretative più
importanti (Peirce e Greimas) possono trovare un piano comune di incontro. Anche la semiotica di Lotman
trova un suo posto imprescindibile legato alla nozione
del linguaggio come sistema di modellizzazione primaria che
trova una ennesima forte conferma proprio nel processo di attribuzione di senso di cui stiamo parlando.
5. L’ambiguita del senso emotivo.
Colonne sonore e sigle televisive
5.1. Tropismi e sintagmatica delle passioni
In diverse opere la scrittrice Nathalie Sarraute (1939,
1956, 1983) ha analizzato con precisione i tropismi ovvero
quei moti della psiche che si concretizzano in sentimenti fuggevoli e brevi dotati di una particolare intensità e
corposità. Una delle loro caratteristiche è quella di essere mutevoli, di essere soggetti facilmente a ribaltamenti
che li fanno tramutare nel loro sentimento contrario.
A mio avviso le analisi letterarie di Sarraute su questa
qualità del sentimento e delle emozioni sono assai interessanti ai fini del nostro discorso. Esse possono essere
Andrea Velardi · Che senso ha la musica? Per una semiotica dei codici monoplanari
applicate alla individuazione del senso emotivo nella
musica mostrando come nel percorso di attribuzione di
senso la musica si comporti in maniera ambigua, multivalente, inafferrabile in una denotazione precisa.
Il tema del tropismo ha delle connessioni interessanti
con la semiotica delle passioni di Greimas (1986) autore
di uno studio sul sentimento della nostalgia in cui mostra quanto sia variegata la semantica di questo termine
e quanto si presti a delle vettorializzazioni di campo che
possono sembrare idiosincratiche. Greimas (1986, 235)
mostra che la nostalgia è uno stato d’animo complesso rappresentabile come un concatenamento di stati in
cui le due dimensioni opposte della timia si trovano a
intrecciarsi5: “ La base dell’incasellatura che è lo ‘stato
di deperimento’ – che di fatto non è uno stato, ma un
processo durativo, è il luogo di un assillo iterativo, effettuato da un soggetto di fare disforico, emerso dalla
disforia intensa che connota l’operazione cognitiva di
confronto, compiuta dal meta-soggetto, che mette faccia a faccia la posizione narrativa del soggetto colta nel
suo hic et nunc con il simulacro narrativo convocato, portatore di un’euforia originaria”.
La nostalgia deriva da uno stato disforico ma contiene
una euforia interna pronta ad emergere nel corso dello
sviluppo del programma narrativo (PN) insito nella semantica della nostalgia: “ Questo PN – presente nell’ultima
definizione di nostalgia sotto forma di notazione succinta di ‘desiderio insoddisfatto’6 – comporta una connotazione euforica: il soggetto del volere, avendo tracciato
un progetto di vita e d’azione, si trova in uno stato di
attesa gioiosa. Il programma euforico, pur scontrandosi
contro il non potere o il non-sapere della congiunzione con
l’oggetto di valore auspicato, conserva ugualmente le
tracce della felicità intravista e manifesta, nella formulazione di un ‘rimpianto melanconico’, il termine complesso /euforia+disforia/, dove si coniugano il desiderio vivificato, l’impotenza della realizzazione e il dolore
dell’incompiutezza” (ibid.).
Su questa strada possiamo allora mettere insieme dei
dati pregnanti per una sociosemiotica del senso emotivo musicale attuata nel campo delle mutazioni sonore
contemporanee.
5.2. Dal tema di Tara di Via col Vento
a Porta a porta.
Per mostrare questa peculiarità del senso emotivo cercheremo di mostrare come esso sia ampiamente presente nelle mutazioni sonore contemporanee e nell’intreccio di contaminazioni e di citazioni compiute
nel mondo della cinematografia e della televisione.
Concentreremo la nostra attenzione su due colonne
sonore famose come quella del Dottor Zivago scritta da
Maurice Jarre nel 1965 e quella di Via col vento creata dal
compositore Max Steiner (1888 – 1971) nel 1939.
La colonna sonora del Dottor Zivago è ben nota per la
presenza del suggestivo tema di Lara che fa da commento continuo al film e che emerge un innumerevole
numero di volte nei contesti più diversi. Il tema non è
per nulla legato al personaggio di Lara in quanto riferimento testuale, ma si riferisce al personaggio femminile solo in modo vagheggiante e astratto. Nel libretto
di un CD di colonne sonore edito da Johansson (1988
– 2000) troviamo scritto che il tema di Lara “ha una
qualità nostalgica, lievemente triste”. Quando andiamo
ad analizzare tutti i passaggi del tema nel corso della
pellicola ci accorgiamo che questo tema triste ed elegiaco emerge nelle scene più impensate e, a seconda dei
casi, assume delle connotazioni elegiache, nostalgiche,
struggenti ma anche romantico-passionali se non addirittura gioiose. La qualità peculiare di questo tema fa sì
che esso possa essere usato per commentare delle scene
assai crude e desolanti come quella del ritorno a casa di
Zivago in un paesaggio freddo e innevato e con le mani
e i piedi intorpiditi e consumati dal gelo. In questo caso
la lieve nostalgia del tema si tramuta oggettivamente in
una stonata stucchevolezza quasi ridicola che contrasta
fortemente con il contenuto della scena.
Da queste brevi considerazioni possiamo dedurre che il
tema di Lara è solo una colonna sonora che accompagna il film come commento a-semantico, con un valore
emotivo che si caratterizza in modi complessi a seconda della sua collocazione all’interno della narrazione.
Esso non ha un significato emotivo stabile e può essere
suscettibile di attribuzioni di senso contrastanti e anfiboliche. Esso può essere avvertito come “nostalgico e
lievemente triste” e contemporaneamente come gioioso
ed esaltante, contaminando dentro di sé entrambe le
dimensioni timiche. Queste dimensioni timiche vengono modulate in modi variegati e diversificati nella loro
molteplicità.
Analizziamo adesso il tema di Tara. Steiner scrive per
Via col Vento più di tre ore di musica, di cui solo due ore
e 36 minuti sono ripresi nel film. La colonna sonora
possiede otto motivi principali che hanno una loro relazione con alcuni personaggi e situazioni della trama.
Ci sono due temi d’amore dedicati rispettivamente alla
storia tra Ashley e miss Melanie e alla travolgente passione e gelosia di Rossella O’Hara (Scarlett) per Ashley.
Ci sono 16 sottotemi e molte citazioni di sequenze musicali della epoca della Guerra di Secessione amalgamati
e miscelati in un continuo originale. In tutta la colonna
sonora emerge con forza il famoso Tema di Tara che è
divenuto il logo musicale del film, assumendo i caratteri
di una riconoscibilità e di una paradigmaticità timica
straordinari.
La sua relazione col film è complessa, perché esso segue
in qualche modo quel misto di enfasi e di frivolezza, di
eccesso e di realismo che attraversa la trama in cui si
passa dalla romantica elegia per il declino del Sud, al
tono melodrammatico delle scene d’amore, al carattere da soap-opera della seconda parte del film costruita
attorno al matrimonio di Scarlett, alla altisonante magniloquenza delle sequenze di carattere storico come
la famosa scena in cui la macchina da presa scopre la
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
37
38
massa sofferente dei feriti nella piazza di Atlanta o alle
scene dell’incendio della città.
Secondo alcuni critici Steiner ha posto come dominante il tema di Tara perché questo gli pareva realizzare
nello spettatore la contraddittorietà del personaggio di
Rossella in cui la sincerità passionale e amorosa si scontrano con la avarizia, il suo narcisismo, la sua incapacità
a instaurare relazioni vere.
In qualsiasi testo di presentazione o critica musicale al
tema di Tara, come anche al tema di Lara cui abbiamo
accennato, vengono attribuiti significati emotivi e evocativi legati alla sua epicità, alla sua areosità, alla sua
potenza sonora. E’ molto interessante compiere una
analisi di tutti i momenti in cui il tema di Tara emerge
durante la trama del film. In questa sede presenteremo solo qualche citazione per mostrare quella anfibolia
della semia timica di cui stiamo parlando.
Il tema di Tara fa da colonna sonora ai titoli di inizio
e viene poi ripreso nelle scene iniziali della giornata
passata nella piantagione dei Wilkes denominata Dodici
Querce. Il tema accompagna questo preludio sereno e
per nulla presago degli orrori della guerra civile. Da
questo punto di vista il tema musicale di Max Steiner
può far emergere le proprie connotazioni “euforiche” accompagnando momenti di gradevole e romantico fluire
della vita.
Tutt’altro accade nella più famosa scena madre del
film, quella dove Scarlett rientra a Tara dopo essere
fuggita dall’incendio di Atlanta. Insieme a Melania e
al suo bambino trova la piantagione distrutta, la madre
morta e il padre esausto in preda ad un incipiente declino mentale. Scarlett si aggira per la casa e poi in preda
allo sconforto esce nei campi abbandonati e pronuncia
il famoso monologo: “As God is my witness, as God is my
witness, they’re not going to lick me! I’m going to live through this,
and when it’s all over, I’ll never be hungry again – no, nor any
of my folks! If I have to lie, steal, cheat, or kill! As God is my
witness, I’ll never be hungry again”.
Appena terminato lo sfogo la cinepresa estende il campo, la silhouette buia della nostra eroina viene contrapposta allo sfondo delle luci del tramonto e il tema di
Tara viene fuori col suo crescendo a sigillare quel momento di desolazione e di rivalsa.
In questi fotogrammi il tema di Tara è associato ad
una dimensione più disforica connessa a quella elegia
nostalgica che percorre tutto il film. Ma come si vede
questa sequenza sonora si presta ad una doppia interpretazione del senso emotivo o timico che ne fa una
sequenza epica e trionfale in alcuni casi, romantica e
leggera in altri ed elegiaca nostalgica in altri.
Questa analisi si può completare aggiungendovi il ruolo assunto dal tema di Tara quale sigla televisiva del
programma Porta a Porta condotto da Bruno Vespa su
Rai Uno. A questo proposito ci riferiamo alla puntata
andata in onda la sera dell’11 Settembre 2001 dedicata
interamente all’attacco terroristico compiuto contro le
Torri del World Trade Center. Il programma cominciava
inesorabilmente con la sua sigla tratta da Via col Vento
mandata in onda sulle immagini del crollo delle due
Torri gemelle. L’effetto di questa combinazione era dei
più paradossali. La colonna sonora, trionfale e magniloquente, del film sul declino degli stati del Sud, sulla
guerra civile americana, sugli amori e sulle rivalse di
Scarlett O’Hara si associava ad un evento dalla portata
tragica e sconvolgente provocando un indubbio sentimento di idiosincrasia e di stonatura.
A bene vedere il tema di Via col vento non viene utilizzato
dagli autori di Porta a porta con un richiamo testuale al
film. L’intertesto è bloccato e la citazione non oltrepassa il limite di semplice richiamo della memoria ad un
film celeberrimo e pluripremiato. Come sigla di Porta
a porta il tema di Tara è solo e semplicemente una sigla televisiva, le cui isotopie non possono sovrapporsi
o coincidere con quelle peculiari della pellicola e della
narrazione cinematografica.
In questo caso assistiamo ad una negazione di quel loop
citazionale continuo che è una delle principali caratteristiche della semiosi tecnologico-mediatica post-moderna. La trasmissione Porta a Porta mentre cita e rievoca
Via col vento, non intende citare Via col vento, ma usa una
musica di grande successo decontestualizzandola completamente dal suo dominio isotopico e prosciugandola all’interno di una isotopia puramente metatestuale
e metalinguisitca per cui la musica è semplicemente la
musica che fa da sigla e dunque è incondizionata e sorda ai contenuti dei temi e delle immagini dei temi della
serata, fosse pure quella drammatica dell’11 settembre.
In questo breve spaccato mediatico possiamo vedere
come il processo delle determinazioni di senso della
musica sia estremamente variegato. A complicare il
quadro delineato nei primi paragrafi è intervenuta la
sottolineatura e la esposizione dell’ambiguità e mutabilità di segno del senso emotivo insieme con le idiosincrasie o le rotture dei percorsi semiotici attuabili dentro
i meccanismi postmoderni della citazione e della contaminazione.
Nella scena contemporanea assistiamo a mutamenti sonori, ad un gioco di decontestualizzazioni e ricontestualizzazioni di mutamenti di prospettiva che rimettono in
gioco l’antica diatriba: che senso ha il codice semiotico
della musica? E quale sia la semiotica più adatta per
interpretare queste variazioni è la sfida che la musica
pone alle teorie dei codici più accreditate dalla lunga
tradizione strutturalista, peirciana etc.
Non è un male quindi che pensando al dominio circoscritto della musica la semiotica si possa interrogare sul
proprio stesso dominio generale: quello della produzione di senso e delle strutture di significazione.
Andrea Velardi · Che senso ha la musica? Per una semiotica dei codici monoplanari
Note
1
Sulla esattezza del significato si può discutere, ma non intendo parlare qui del fenomeno della vaghezza dei codici ma solo
mettere in luce le prerogative di un codice biplanare.
2
De Schloezer (1931) citato in Mila (1956), 33.
3
Per un approfondimento di Hanslick si veda la prima parte
del libro di Marconi (2001) che poi prende decisamente la
strada di una interpretazione emotiva della musica fondandosi su considerazioni di matrice semiotico-filosofica.
4
Su questi temi si confronti il recente studio di Zhu e MeyersLevy (2005).
5
Ringrazio Maria Pia Pozzato per avermi suggerito questo
colleamento greimasiano nel corso del convegno di Imperia.
Federico Montanari mi ha indicato anche la sintagmatica delle passioni presente in Spinoza, ma ho preferito rimandare ad
altre sedi la discussione di questo altro luogo filosofico.
Bibliografia
Damasio, A., 1994, Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the
Human Brain, New York, Avon Books; trad. it. L’ errore di
Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, Adelphi, Milano,
1995.
Davies, S., 1994a, Musical Meaning and Expression, New York,
Cornell University Press.
Davies, S., 1994b, “Kivy on Auditors’ Emotions” in Journal of
Aesthetics and Art Criticism, Vol. 52, No. 2, 235-236.
De Schloezer, B., 1931, “Comprendere la musica”, in Rassegna
Musicale, n. 1, Milano, Feltrinelli, pp. 141-152.
Greimas, A.J., 1966, Sémantique structurale, Paris, Larousse;
trad. it. Semantica strutturale, Roma, Meltemi, 2000.
Greimas, A.J., 1986, De la nostalgie. Etude de sémantique lexicale, Actes sémiotiques – Bulletin, XI, 39,; trad.it. “Della
Nostalgia”, in Fabbri P., Marrone G. (a cura di), Semiotica in
nuce, vol. II, Roma, Meltemi, pp. 231-236, 2001.
Hanslick E., 1854, Von musikalisch Schonen, Leipzig, Barth; trad.
francese, De beau dans la musique, Paris, Bannellier , 1877.
Hjelmslev, L., 1943, Omkring Sprogteoriens Grundlaeggelse; trad. ingl.
Prolegomena to a Theory of Language, Madison, Wisconsin
University Press, 1961; trad. it. I fondamenti della teoria del linguaggio, Torino, Einaudi, 1968.
Kivy, P., 1980, The Corded Shell, New Jersey, Princeton
University Press.
Kivy, P., 1994, “Armistice, But No Surrender: Davies on
Kivy”, in Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 52, No.
2, pp. 236 – 237.
Jankélévitch, V., 2001, La musique et l’ineffable, Paris, Armand
Colin, 1961; trad. it. La musica e l’ineffabile, Milano
Bompiani.
Johansson, (series editor), L., 1988 = 2000, The Classical at
the Movies, CD della HNH International Ltd, 8.556804
DDD.
Juslin, P.N., Sloboda, J.A., (eds.), 2001, Music and Emotion:
Theory and Research (Series in Affective Science), OxfordNew York, Oxford University Press.
Le Doux, J., 1996, The Emotional Brain: The Mysterious
Underpinnings of Emotional Life, New York, Touchstone
Editino; trad.it., Il cervello emotivo. Alle origini delle emozioni,
Baldini Castoldi Dalai, 2003
Madell, G., 2003, Philosophy, Music and Emotion, Edinburgh,
Edinburgh University Press.
Marconi, L., 2001, Musica Espressione Emozione, Bologna,
CLUEB.
Mila, M., 1956, L’esperienza musicale e l’estetica, Torino,
Einaudi.
Meyer, L. B., 1956, Emotion and meaning in music, Chicago,
University of Chicago Press: trad. it. Emozione e significato
nella musica, Bologna, Il Mulino, 1992.
Riemann, H., 1900, Elemente der musikalischen Astetick, Berlin,
W. Spemann.
Sarraute, N., 1996, Œuvres complètes, a cura di Jean-Yves Tadié,
Paris, Gallimard.
Schuman, R., 1942, La musica romantica, Torino, Einaudi.
Schuman, R., 1942, “Una sinfonia di Berlioz”, in La musica
romantica, Torino, Einaudi, 1950, pp.32-56.
Stravinsky, I., 1946, Poetics of Music in the Form of Six Lessons,
New York, Vintage Books; trad. francese, Poétique musicale,
Paris, Plon, 1952.
Tarasti, E., 1994, A Theory of Musical Semiotics, Bloomington
and Indianapolis, Indiana University Press.
Tarasti, E., 2006, La musique et les signes. Précis de sémiotique musicale, Paris, L’Harmattan, edizione aumentata di Signs of
music, Berlin-New York, Mouton de Gruyter, 2002.
Zentner, M., Scherer, K., & Grandjean, D., 2005, Which
emotions can be induced by music?. Paper presented at ISRE
2005, Bari.
Zhu, R., Meyers-Levy, J., 2005, Distinguishing between the meanings of music: When background music affects product perceptions, Journal of marketing research, vol. 42, no3, pp.
333-345.
39
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
sezione due
ibridazioni, alterazioni
0. Figli di Annibale
Nel 1993 il gruppo napoletano Almamegretta lancia
“Figli di Annibale”, un brano dedicato all’origine ibrida del popolo italiano raccontata attraverso un suono
anch’esso contaminato e mediterraneo: il brano in
breve si trasforma in un vero e proprio manifesto della
nuova ibridità della musica leggera italiana.
In realtà fino a quel momento decine di musicisti italiani si erano già cimentati nell’incontro fra stili e linguaggi sonori diversi. Accantonando per un momento i lontani tempi dello swing, è a partire dalla seconda metà
degli anni ’60 che l’incontro con la musica folk porta
ad una decisa contaminazione della canzone: in questo
modo canzoni e ritmi, da sempre legati alla tradizione
melodica italiana, intrecciano il loro percorso con l’influenza delle musiche popolari soprattutto provenienti dal Sud d’Italia. Il lavoro di ridefinizione degli stili
musicali operato da Roberto De Simone, con la Nuova
Compagnia di Canto Popolare, e le sue produzioni di
teatro musicale, provocano la paradossale conseguenza
di “contaminare” le canzoni napoletane con l’innesto
di elementi tipici dello stile popolare, attraverso il canto
prima di tutto ma anche con tutta la strumentazione folk
che entra negli arrangiamenti delle canzoni. Esempio
eclatante di questa trasformazione stilistica è la celebre
“Tammurriata nera”, una canzone d’ “autore”, scritta
nel 1944, e non nel 1974 quando venne reinterpretata
dalla NCCP, dal duo formato da E.A.Mario, gigante
della canzone napoletana classica, come autore della
musica, e da Edoardo Nicolardi invece responsabile del
testo. La canzone nella interpretazione della NCCP
prende le forme della tammurriata popolare ma, a dispetto delle sue nuove forme “folk”, di non immediato
consumo, ottiene un enorme successo fino a raggiungere i primi posti della classifica discografica. E’ un fatto
clamoroso per il folk, musica non costruita con logiche
commerciali ma per essere consumata in modo collettivo e, soprattutto, nella dimensione dal vivo. A rendere ancor più forte l’exploit di “Tammurriata nera”
avviene che il brano si trasforma nel titolo simbolo del
folk-revival, il movimento culturale che, a partire dalla
seconda metà degli anni ’60, aveva rilanciato la musica
popolare sul piano nazionale.
Il caso “Tammurriata nera” è un esempio eclatante
per comprendere come il processo di ibridazione – in
questo caso fra tradizione popolare e canzone – porti
ad una innovazione delle forme musicali. Una pratica
che si ripeterà sempre più spesso nel corso degli anni
in Italia con risultati di grande interesse, basta pensare ancora alla scena napoletana che metteva insieme
progressive rock – il genere musicale di origine inglese
continuamente in bilico fra rock e musica classica – con
il jazz, il funk e la musica popolare, attraverso il lavoro
di formazioni come Osanna, Napoli Centrale, Albero
Motore.
Nello stesso periodo anche la scena romana vedeva
E|C Serie Speciale
Anno I, n. 1 2007, pp. 43-45
ISSN (on-line): 1970-7452
ISSN (print): 1973-2716
EC
Oltre i margini del suono.
L’ibridità fra tradizione
e innovazione
Felice Liperi
crescere una serie di produzioni che univano la ricerca
al cosiddetto folk “progressivo”, in modo particolare il
Canzoniere del Lazio, complesso partito dalla ricerca
sulla musica popolare e poi via via approdato a territori sonori più attenti all’innovazione proprio contaminando il suono folk con forme e suoni tipici del jazz,
del rock, della musica sperimentale. E poi, soprattutto, gli Area che nel corso degli anni ’70, dal 72, anno
del primo album, fino al ’79, anno della scomparsa di
Demetrio Stratos, voce e leader del gruppo, sono stati
la formazione che ha portato alle estreme conseguenze
il discorso sulla sperimentazione dei suoni proprio mettendo insieme elementi musicali anche molto diversi fra
loro: il rock, la musica afro/americana e quelle popolari mediterranee ed extra europee anticipando tutto
il percorso successivo della world music che emergerà
solo nella seconda metà degli anni 80, cioè dieci anni
dopo la morte di Stratos! Proprio il grande performer
è stato uno dei pochi casi, se non l’unico, in una realtà
molto provinciale come l’Italia a far convivere il pop
leggero nel gruppo dei Ribelli con pindariche ricerche
sul campo vocale.
I progetti degli Area e del Canzoniere del Lazio, pur con
forme diverse, erano destinati ad incontrarsi, fatto che
puntualmente avvenne proprio nel ’79 nel complesso/
laboratorio dei Carnascialia di cui fecero parte alcuni
elementi di entrambi i gruppi oltre a Mauro Pagani. Il
multistrumentista nel frattempo aveva lasciato la PFM
proprio per dedicarsi ad un lavoro di ricerca sul suono, lavoro che ben presto lo porterà all’incontro con
Fabrizio De Andrè e poi, via via, ad una serie di progetti musicali nei quali l’elemento popolare, proprio nella
sua dimensione di massima alterità, si proporrà come
arricchimento e innovazione del progetto sonoro.
Rimanendo alla riflessione su questa fase attraversata
dalla musica italiana, va sottolineato come le innovazioni apportate dai progetti appena citati finirono con
l’incidere relativamente sulle nuove prospettive della
© 2007 AISS - Associazione Italiana di Studi Semiotici
T. reg. Trib. di Palermo n. 2 - 17.1.2005
44
musica italiana perché arrivati in una fase in cui l’attenzione del pubblico di massa verso il folk e le musiche
extra era in fase di calo evidente. Alla fine del decennio
’70 si assiste da parte del pubblico ad un crescente disincanto nei confronti di tutta la musica di tradizione
popolare e folk di pari passo alla profonda crisi dell’impegno politico giovanile e di massa al quale era profondamente legato. In particolare il progetto del primo
Canzoniere del Lazio era stato vissuto come applicazione delle teorie di Gianni Bosio che teorizzava l’uso
politico, “progressivo”, del folk, un’idea che recuperava
su un terreno diverso, quello dell’impegno politico, la
funzionalità della musica popolare, elemento fondante
di questo mondo culturale.
La crisi della politica spazzò via nei primi anni 80 quel
progetto che avrebbe potuto valorizzare la memoria
musicale della tradizione come elemento di modernizzazione e di conquista identitaria del patrimonio musicale italiano.
Al contrario si avviò un decennio – gli anni 80 – che
aprì le porte ad una trasformazione completa della
musica leggera italiana, sempre più provincia del pop
internazionale e nel quale la musica popolare venne totalmente rimossa. Il paradosso è che questa rimozione
aprì la strada ad una identità aliena per la musica italiana nella quale era assente anche l’elemento contaminante, fosse rock, jazz o musica elettronica. Si faceva
largo una musica anodina e senza identità – non necessariamente di cattiva qualità ma di rara originalità
– per lo più ispirata ai modelli pop inglesi e statunitensi. Per queste ragioni nel 1984 l’entrata in scena di
“Creuza de ma” si rivelò un fatto “rivoluzionario” perché fece apparire le musiche mediterranee a cui si ispirava il progetto Pagani/De Andrè come elementi nuovi
e sconosciuti, e il dialetto come un linguaggio tutto da
riscoprire. Erano stati sufficienti 5 anni per spazzare via
un’intera generazione di esperienze e progetti musicali
e ora le voci, gli strumenti, i suoni dei porti e dei luoghi genovesi, tunisini, greci, i loro dialetti, arrivarono
come fonti prodigiose di contaminazione e innovazione
per l’asfittico panorama musicale italiano che proprio
nel 1984, con l’avvento di Video Music, segnava il definitivo orientamento della musica italiana verso i modelli internazionali dominanti. Anche per lo stesso De
Andrè quel lavoro si rivelò un passaggio decisivo per
la sua carriera soprattutto sul piano più propriamente
stilistico, non solo perché i lavori successivi “Le nuvole”
e “Anime salve” contenevano e sviluppavano l’idea musicale nata con “Creuza de ma”, ma perché nell’attività
dal vivo anche il catalogo precedente dell’artista subiva
una sorta di contaminazione stilistica da parte di quell’esperienza. Sembrò che dall’uscita di “Creuza de ma”
in poi, pur non ottenendo il disco immediata popolarità e successo commerciale, tutta la musica leggera italiana dovesse tener conto di quel lavoro discografico.
L’importanza e il ruolo di “Creuza de ma” vengono
sottolineati dallo stesso De Andrè in un’intervista di
Giacomo Pellicciotti realizzata nel 1994.
“Ancora oggi considero l’esperienza di Creuza de ma, un
miracolo frutto di misteriose e felici coincidenze, prima fra
tutte la scoperta quasi casuale di una sintonia di gusto con
Mauro Pagani.Le nostre memorie storiche, letterarie e musicali del mondo mediterraneo si sono alleate per l’esigenza
di esprimerci attraverso canzoni che ci rassomigliassero, ma
anche per una comune presa di distanza dalla travolgente
e routiniera colonna sonora d’importazione nor-americana
che volenti o nolenti, ci aveva presi a bersaglio. Già da prima
dell’inizio degli anni Ottanta, la quasi totalità dei disc-jockey nazionali ci bombardava di musica elettrica per lo più
fracassona e d’importazione oltre atlantica, peggio, di nostrana emulazione. Restano le eccezioni relative soprattutto
ad artisti di grande personalità e capaci di metabolizzare
le fonti di ispirazione, per dar luogo a un loro preciso stile
espressivo. Basta ricordare Peter Gabriel di ‘So’, il Prince
di ‘Sign ‘o times’ e lo stesso Michael Jackson precomputerizzato di ‘Thriller’. Da parte nostra erano anni che accumulavamo esperienze in viaggi estivi e invernali in quella
parte del continente a noi più vicina. Sto parlando del nord
Africa islamico e dei viaggi in quel brevissimo percorso che
è già soltanto un frammento della nostra vita. Ma la gente
di casa nostra questi itinerari e questi contatti li aveva compiuti e li aveva avuti per secoli. Erano perciò presenti nella
nostra memoria non solo storica, ma in molti casi genetica.
Bastava solo rinfrescarla.Nello stesso periodo dei vergognosi
episodi delle Crociate, le Repubbliche marinare, che pure
avevano pelosamente aderito al traghettamento delle truppe cristiane, avevano instaurato una vera e propria politica
filo-islamica. Non certo perché fossero illuminati relativisti,
ma evidentemente per ragioni di mercato. D’altra parte una
cultura multietnica e multirazziale pacifica la si può formare
soltanto per aree e per ragioni di convenienza mercantile.
In fin dei conti ‘Creuza de ma’, ammesso che sia stato un
lavoro importante, credo lo sia stato soprattutto per la sua
funzione di ricollegarci al nostro passato anche recente che
spesso dimentichiamo che è pericoloso dimenticare”.
1. L’elettronica
Successivamente sono state numerose le avventure che
hanno praticato un incontro fra generi musicali diversi,
ma la novità è stata l’avvento alla metà degli anni 80
dell’elettronica come ingrediente nuovo della musica
pop italiana. Ad aprire la strada nel 1985 “Africana”, il
disco di Teresa De Sio dove a fianco alle passioni folk
dell’artista napoletana si inseriscono le contaminazioni
sonore di Brian Eno che partecipa alla realizzazione dell’album. Così, su tutt’altro terreno, emerge il lavoro dei
CCCP che si costruisce mettendo insieme rock, elettronica e recitativi poetici, una ricerca sonora influenzata
dalle esperienze del rock tedesco che è la chiara dimostrazione della progressiva perdita di identità del messaggio musicale italiano nel decennio anni 80.
Questa perdita di identità è ancor più evidente quando
nel 1986 esce “Don Giovanni”, il primo lavoro realizzato da Lucio Battisti con Pasquale Panella che segna una
sterzata imprevedibile verso l’elettronica minimale del
padre del pop italiano moderno.
Comunque ciò che alla lunga si afferma è la lezione di
Felice Liperi · Oltre i margini del suono. L’ibridità fra tradizione e innovazione.
“Creuza de ma”: che sia cioè possibile utilizzare il dialetto
come “lingua” della musica italiana. Basandosi su questo
progetto si afferma una serie di musicisti che rilancia le
lingue locali di cui è ricca l’Italia e i il Mediterraneo circostante. I primi sono, naturalmente, musicisti che vengono dalla ricerca sulle tradizioni popolari: Ambrogio
Sparagna, Elena Ledda, Riccardo Tesi, Antonello Ricci
seguiti da artisti attivi in campo pop che riscoprono anche i suoni nei quali quelle lingue locali sono nate. Così
i Mau Mau, con i suoni occitani, i Tazenda, nelle vocalità sarde, perfino i leggeri Pitura Freska inaugurano una
moda di interpretare il ritmo reggae, in seguito il rap, in
dialetto, nel loro caso il veneto.
Il definitivo salto nei confronti di una musica di forte
contaminazione sonora arriva con il passaggio agli anni
’90, quando anche in Italia arriva il rap con il celebre
esordio dell’Onda Rossa Posse “Batti il tuo tempo”.
Se infatti il suono della cultura Hip hop si propone di
per sé come un ibrido miscuglio di parole e ritmo, in
Italia apre le porte ad una nuova “canzone politica”
legata ai luoghi dell’impegno giovanile, spazi urbani,
centri sociali dove l’elettronica si sposa con il rock italiano e il folk si tinge di impegno politico. Proprio in
questo clima creativo emerge il lavoro di gruppi come
Almamegretta, 99 Posse, Sud Sound System che nascono come formazioni in bilico fra tradizione e modernità
pop. Da qui prende le mosse la nuova scena musicale
italiana che trova ampia attenzione nel pubblico delle
nuove generazioni, sempre più aperte alla dimensione
globale e multi/etnica della cultura musicale. Gli anni
Novanta accentueranno questa tendenza a dare crescente attenzione al mondo delle culture, soprattutto,
extra/europee spesso indicate sotto il nome di World
Music. Un segno importante di passioni verso linguaggi
differenti da diversi paesi che non cancella l’equivoco
sull’autenticita’ della World Music, ovviamente inesistente, ma chiaro indicatore di possibile intreccio fra
culture acustiche ed elettriche tra Nord e Sud.
2. Il rinascimento della Pizzica
Da questo punto di vista l’apparentemente “inspiegabile” e impressionante popolarità della “pizzica tarantata” nella scena nazionale è invece il logico terminale del
percorso musicale che intende far convivere tradizione
e innovazione attraverso un processo di ibridazione.
Il successo della pizzica e’ infatti il risultato della sua
straordinaria universalità che si esprime in una funzionalità ludica, ritmica e melodica particolarmente evidente. Solo tammurriate e tarantelle possono vantare
un apparato ritmico simile – per altro si tratta di ritmi
fortemente imparentati alla pizzica – in grado di arrivare in modo diretto e immediato al pubblico dei fruitori/esecutori; proprio questa universalità giustifica anche
l’incredibile aumento degli esecutori partecipanti al
fenomeno pizzica cioè gli appassionati del tamburello,
strumento principe del ritmo talentino e della tradizione musicale del Meridione in genere. L’altro elemento
45
che giustifica il successo di questo ritmo tradizionale risiede nel forte senso di identità che esprime; le ricerche
avviate a partire dalla Terra del rimorso di De Martino in
poi coincidono nell’affermare con forza il senso di alterità e nel contempo il radicamento nella cultura contadina salentina di questo rituale estatico, radicamento
talmente appassionato da sostanziarsi in un’ esecuzione
possessivamente partecipata.
La sparizione della tarantola, del ragno protagonista,
per ragioni legate all’inquinamento ha poi aumentato
il fascino del tarantismo come teatro di una possessione ritualizzata, qualcuno fra cui lo studioso Georges
Lapassade si è spinto a dire demoniaca, o comunque
di performance psico-fisico-musicale. Una specificità
che ritroviamo nei rituali liturgici popolari e in quelli
della musica tecno, un fatto che spiega il legame forte fra esponenti provenienti dalla nuova elettronica e
formazioni di pizzica tarantata come l’Officina Zoé e
il dj Ominostanco. Un intreccio che svela l’anima profondamente contaminata della pizzica, così fortemente
identitaria eppure sfuggente, e forse ne spiega una volta
di più il successo travolgente.
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
0. Oggetto dell’indagine
In Casablanca di Curtiz si cela una citazione musicale dal
film La grande illusione, del maestro Jean Renoir. Questo
è solo uno dei rimandi tra l’opera di Renoir e la memorabile scena in cui Victor Lazlo (Paul Henreid) dirige
la Marsigliese, sovrastando il canto patriottico dei nazisti
Die Wacht am Rehin. Quello che attrae la nostra attenzione è il modo in cui i due film, contraddistinti dalle medesime scelte musicali, le fanno interagire con la colonna
visiva, ottenendo effetti di senso opposti.
0.1 Cinema e propaganda
Entrambi i film possono essere considerati “di propaganda”. E’ necessario chiarire che, nella nostra accezione del termine, “propaganda” non va inteso come un
giudizio negativo. Il cinema di propaganda mira infatti
ad un massimo di persuasione ed efficacia da ottenere con ogni mezzo cinematografico. In questo senso,
quando raggiunge tale fine, può essere considerato cinema per eccellenza, un cinema totale. E’ appena il caso
di ricordare quanto Ejzenstein fosse fiero del successo
dei propri film nel corrotto e decadente occidente borghese. Quando giudichiamo spregiativamente un film
come “propaganda”, solitamente si tratta di cattiva propaganda.
0.2 Casablanca e la propaganda di guerra
Le riprese di Casablanca cominciano il 25 maggio
1942. In quel periodo gli USA erano già entrati in guerra col Giappone, ma il lavoro teatrale da cui è tratto il
soggetto, Everybody comes to Rick, fu acquistato dagli studios prima della guerra1. Casablanca è dunque un film
interventista post eventum: in una scena Rick - Bogart
accenna al fatto che i newyorkesi “dormono” mentre in
Europa avvengono i fatti tragici narrati; più in generale
Rick, cittadino americano, con il proprio cinico “farsi
gli affari propri” rappresenta metonimicamente il popolo americano. Alla fine del film Rick, rinunciando a
Ilsa Lund – Ingrid Bergman, si ricongiunge ai propri
valori, valori che aveva accantonato, spara al maggiore Strasser (Conrad Veidt) e raggiunge la resistenza.
Dunque, l’effetto di senso “ci spiace di non essere intervenuti prima” sorge solo a causa delle circostanze
di fruizione, a guerra già iniziata. Pure, racconta di un
uomo che accantona i propri rancori e le proprie debolezze individuali sacrificando gli affetti per un ideale
più alto: un ottimo film di propaganda; per di più, come
molti film di propaganda riusciti, evita di essere didascalico grazie alla mobilitazione di collaudati dispositivi di natura passionale, contrapponendo l’umanità dei
protagonisti alla disumanità dei nazisti, secondo una
formula ben teorizzata e praticata da Ejzenstejn2.
0.2.1 La colonna sonora in Casablanca
Testimonianze quali le varie biografie di Bogart o della Bergman sono chiaramente operazioni mitografi-
E|C Serie Speciale
Anno I, n. 1 2007, pp. 47-51
ISSN (on-line): 1970-7452
ISSN (print): 1973-2716
EC
Tensione e risemantizzazione
al cinema. Da La grande
illusione a Casablanca
Francesco Galofaro
che, indifferenti al fine di una analisi testuale, a meno
che nel testo non esistano corrispondenze rispetto alla
ricca aneddotica proposta. Nonostante il mito insista
sulle vicissitudini che caratterizzarono la lavorazione,
le indecisioni, i ritardi, una sceneggiatura ineguale cui
cooperarono un numero imprecisato di persone, il film
si presenta in realtà come un ottimo esemplare della
perfezione tecnica raggiunta dalla Hollywood di quegli
anni. In particolare, se anche fosse vero che il compositore della colonna sonora Max Steiner3 non condividesse l’idea di fare di “As time goes by” il leitmotiv del
film, le scelte musicali della colonna sonora restano in
ogni caso semioticamente coerenti e costituiscono due
isotopie ben precise: quella che appunto sfrutta “As time
goes by”, che rinvia come tutta la musica in 4 eseguita da
Sam (Dooley Wilson) alla dimensione dei rapporti privati tra i protagonisti, e quella che sfrutta come leitmotiv
i diversi inni nazionali francese e tedesco, armonizzati
in modo minore e con largo impiego di dissonanze, che
rinvia alla cupa situazione internazionale.
0.3 La grande illusione e la propaganda
pacifista
Prima del suo esilio americano Renoir fu un compagno
di strada del Partito comunista francese, per il quale firmò anche dei documentari. La sua appartenenza alla
sinistra impegnata nei diversi fronti popolari contro il
nazismo trova corrispondenza nei suoi scritti settimanali per il quotidiano comunista Ce Soir5.
Renoir era fiero del successo ottenuto da La grande illusione al festival del cinema di Venezia:
“Anche nell’Italia fascista, in cui il film era proibito, abbiamo ottenuto a Venezia la coppa della giuria internazionale,
premio appositamente inventato per evitare di doverci dare
la coppa Mussolini6”
E’un’ironia che negli USA il film sia giunto integro,
© 2007 AISS - Associazione Italiana di Studi Semiotici
T. reg. Trib. di Palermo n. 2 - 17.1.2005
dopo la guerra, grazie ad una copia ritrovata dall’esercito americano a Monaco, nonostante il film fosse vietato nella Germania nazista.
L’impegno politico di Renoir per la pace è rispecchiato
ne La grande illusione, in cui, con il pretesto di raccontare
i tentativi di fuga di un gruppo di prigionieri francesi
durante la prima guerra mondiale, viene costruita una
simmetria continua tra usi, costumi, valori rispettivi di
prigionieri e secondini, ciò che li rende simili e contrapposti solo dalle circostanze belliche. In questo la musica
curata da Joseph Kosma7 e il sonoro (De Bretagne) giocano un ruolo molto importante.
0.3.1 La colonna sonora ne La grande illusione
48
La musica in fornisce un contributo al senso la cui importanza è pari alla regia di Renoir, che con grande
virtuosismo costruisce le scene nei campi di prigionia
come altrettanti Tableaux Vivants in cui ogni personaggio
è in movimento ed è bene caratterizzato senza eccessiva subalternità ai protagonisti del film. Penso alle scene
in cui la vita del campo è resa dal punto di ascolto dei
prigionieri alla finestra grazie al suono dei pifferi, che
costituiranno poi l’escamotage grazie al quale il capitano
De Boeldieu (Pierre Fresnay), il tenente Maréchal (Jean
Gabin) e Rosenthal (Marcel Dalio) riescono a sfuggire
al capitano Von Rauffenstein (Eric Stroheim). La colonna sonora costituisce un tutto organico di anticipazioni e retrospezioni, che discretamente governano le
aspettative e le passioni dello spettatore8 e mantengono
l’unità organica dell’opera. Non solo: in quanto musica in è essa stessa impiegata per costruire la simmetria
tra sorveglianti e sorvegliati; così se nel circolo ufficiali
francese si ascolta musica popolare francese, in quello
tedesco si ascolta musica tedesca; e quando in isolamento Maréchal si lamenta di non poter parlare francese
con un secondino esclusivamente germanofono, questi,
impietosito, gli regala un’armonica: grazie a questo linguaggio emozionale minimo condiviso i due finiscono
per fraternizzare.
1. Douamont Gefallen
Cominciamo la nostra analisi delle scelte di colonna sonora nella lunga sequenza de La grande illusione
cui fa riferimento Curtiz in Casablanca. Nel campo di
prigionia tedesco manifesti a caratteri cubitali annunciano, tra il suono delle campane, che la cittadina di
Douamont è caduta - sono i luoghi della battaglia di
Verdun, tra le più sanguinose del primo conflitto mondiale. Comprensibilmente i tedeschi fanno festa: la sera,
allo spaccio, cantano Die Wacht am Rehin, osservati dai
prigionieri francesi ancora una volta alla finestra.
1.1 Die Wacht am Rehin
Il canto patriottico fu composto da Max Schneckenburger
nel 1840. Il testo della prima strofa – quella citata – recita:
1. Es braust ein Ruf wie Donnerhall,
Wie Schwertgeklirr und Wogenprall:
Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein,
Wer will des Stromes Hüter sein?
|: Lieb’ Vaterland, magst ruhig sein, :|
|: Fest steht und treu die Wacht am Rhein! :|
Scopo dell’inno è incitare il soldato tedesco a far la
guardia al Reno, confine ultimo del sacro suolo tedesco:
ovviamente l’invasore ipotetico è francese. Il riferimento va alla storica contesa franco-tedesca per l’AlsaziaLorena che data almeno ai tempi di Luigi XIV. E’ dunque anche un inno antifrancese.
1.2 Douamont è libera
Durante uno spettacolo di Vaudeville in cui i prigionieri recitano travestiti arriva la notizia: i soldati francesi
hanno ripreso Douamont. Per simmetria, se i tedeschi
festeggiavano col loro inno patriottico, i francesi intonano immediatamente la Marsigliese. Vi è dell’ironia
tragica nella serietà e nelle emozioni espresse dai volti
dei prigionieri, che cozzano con il carattere buffonesco
dei loro travestimenti da donna. La colonna sonora sottolinea questo grazie al mutamento del punto d’ascolto
in funzione del lungo piano-sequenza che si sposta a
inquadrare gli attori del dramma. Si tratta di primi piani
sonori che ritroveremo anche in Casablanca.
In seguito, Douamont verrà ripresa ancora una volta
dai tedeschi, ma questa volta senza feste, senza campane e senza musica – a sottolineare il carattere assurdo
della guerra di trincea in particolare, in cui si muore per
avanzare pochi passi quando non ci si ritira.
2. Suonate la Marsigliese!
La scena di Casablanca che prendiamo in considerazione comincia proprio con la musica. Rick e Lazlo sono
nell’ufficio di Rick. Discutono dei visti che permetteranno a Lazlo e signora di espatriare; Rick fa delle difficoltà, chiede a Lazlo di chiederne ragione alla moglie
Ilsa. Lazlo è sorpreso, ma i due non hanno tempo di
chiarirsi: sono interrotti dal canto intonato dai nazisti
nel locale, che è, guarda caso, Die Wacht am Rehin.
Lazlo è indignato, a grandi passi arriva presso l’orche-
Francesco Galofaro · Tensione e risemantizzazione al cinema: da La grande illusione a Casablanca
stra, e chiede di suonare la Marsigliese. Per un breve
periodo, Die Wacht am Rehin e la Marsigliese suonano in armonia9, ma ben presto la seconda sovrasta il
primo, tra i canti generali. Come in Renoir, anche qui
abbiamo una serie di primi piani sonori in cui ascoltiamo la voce del personaggio di volta in volta inquadrato
sovrastare il coro10. Questa scelta è fondamentale per
mostrare come le diverse individualità si riconoscano in
una struttura di valori comune trasformandosi, grazie
alla musica, in un attore collettivo contrapposto all’altro attore collettivo, costituito dal coretto di nazisti. Ad
esempio Ivonne, che aveva sedotto un soldato tedesco
per fare ingelosire Rick, recupera la propria dignità gridando tra le lacrime “Viva la libertà”. La citazione è
in parte reperibile anche tra le scelte che regolano la
colonna visiva. Qui non abbiamo un unico piano sequenza come in Renoir; tuttavia Curtiz impiega il piano sequenza di Renoir come paradigma, all’interno del
quale trasceglie le inquadrature che Renoir di volta in
volta sottolinea col movimento di macchina e la messa
a fuoco11.
3. La costruzione dei diversi effetti di senso
Se sul piano dell’espressione ritroviamo chiarissimo il
riferimento di Curtiz a Renoir, possiamo dire che sul
piano dei contenuti espressi dalla musica i due film si
collocano agli antipodi; che poi è quel che ci si aspetta,
dato che l’uno sta alla guerra come il secondo alla pace.
C’è da chiedersi a questo punto come la stessa musica
porti a contenuti assiologicamente contraddittori.
3.1 Musica come sistema semi-simbolico
E’ essenziale qui chiarire alcune caratteristiche che la
musica esibisce in quanto sistema semi-simbolico. Per
molto tempo la musica è stata considerata con Hjelmslev
un sistema monoplanare12, in cui la descrizione formale del piano dell’espressione coincideva con quello del
piano del contenuto13. Ma piuttosto che presentare isomorfismo tra elementi del piano dell’espressione e del
contenuto, la musica mostra isomorfismo tra categorie
di elementi dei due piani. Una opposizione categoriale su di un piano14 (es. profilo melodico ascendente Vs.
discendente) si rende così disponibile per veicolare una
opposizione simile sull’altro piano (pensiamo ad esempio a “maschile” Vs. “femminile”, oppure “celeste” Vs.
“terrestre”). Tutto questo a condizione che sia il testo a
stabilire quale sia l’opposizione pertinente, per evitare
due errori tipici dell’analista: il primo è quello di generalizzare all’universo dei testi un particolare caso di semisimbolismo reperito in una singola opera15; il secondo di considerare qualsiasi opposizione categoriale sul
piano dell’espressione come se necessariamente dovesse
rinviare ad una opposizione equivalente sul piano del
contenuto. La nostra citazione esemplifica benissimo il
carattere di costruzione testuale del semisimbolismo.
3.2 Cinema come semiotica sincretica
La colonna sonora è negli ultimi due decenni al centro di una serie di studi divenuti ormai dei classici.
Considerando tuttavia la storia della critica cinematografica e con la notevole eccezione costituita da
Ejzenstejn16, il ruolo della colonna sonora non è stato
eccessivamente considerato dai teorici ed è spesso ignorato dai critici. Riprendendo Ejzenstejn, possiamo dire
che oltre al montaggio orizzontale esiste nel cinema un
montaggio verticale, tra colonna visiva e sonora. Entro
ciascuno dei due piani possiamo reperire funzioni
omoplane che ne reggono la dimensione processuale e
fanno sì che un film non sia fruito come una semplice collezione di inquadrature ma come un tutto retto
da una logica narrativa17. Prendiamo poi in prestito da
Hjelmslev il termine funzione eteroplana per descrivere
le funzioni che si reperiscono tra piani diversi. E se la
semiotica considerata da Hjelmslev, il linguaggio, era
semplicemente biplanare (espressione e contenuto non
mutuamente riducibili), al cinema abbiamo una struttura multiplanare18, in cui come abbiamo detto sono
compresenti diverse componenti, che vanno a comporre colonna visiva e sonora19.
Come avremmo potuto aspettarci, una serie di effetti
di senso sul piano del contenuto filmico non sono imputabili né alla colonna visiva né alla colonna sonora,
ma si creano per così dire dal nulla quando diversi piani
semiotici entrano in contatto sovrapponendosi. Possono
essere dunque esclusivamente analizzati in termini di
funzioni eteroplane, come del resto si può apurare con
una banale prova della commutazione azzerando la colonna sonora o girando le spalle al video.
3.3 Sulle differenti funzioni eteroplane della
musica patriottica nelle due scene
Naturalmente in entrambe le pellicole la musica assolve
alla medesima funzione di costituire alcune individualità in attori collettivi; ma solo in Casablanca tali attori
sono semi-simbolicamente contrapposti anche da un
punto di vista della funzione attanziale, come soggetto e
antisoggetto:
(Espressione)
(Contenuto)
Marsigliese : Die Wacht am Rehin
Soggetto : Antisoggetto
La disseminazione costante lungo tutto l’arco filmico
di due isotopie musicali contrapposte – il tema della marsigliese e quello dell’inno tedesco – rafforza la
contrapposizione attanziale. Ancora, fondamentale è la
sovrapposizione tra i due inni e il fatto che l’uno prevalga sull’altro, cosa che manca ne La grande illusione. In
quest’ultimo film prevale invece la simmetria tra i due
attori, tanto in termini ideologici quanto dal punto di
vista delle azioni che ne discendono: l’intero co-testo rafforza questa lettura, penso ad esempio alle affinità in
termini di visione del mondo ed adesione ai valori della
cavalleria tra i nobili Boeldieu e Von Rauffenstein. Qui
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
49
i tedeschi non sono anti-soggetti, si limitano piuttosto ad
incarnare il non poter fare dei protagonisti, caratterizzandosi così come opponenti.
4. Conclusioni
Sappiamo che i critici sono discordi rispetto alla reale
efficacia del pacifismo di Renoir ne La grande illusione. Si
tratta di un film molto complesso, che in molte situazioni mostra contrasti ideologici notevoli non solo tra
francesi e tedeschi, ma anche tra le varie classi sociali
che compongono rispettivamente i prigionieri francesi
e i secondini tedeschi. La scena della Marsigliese per
alcuni rivelerebbe una simpatia dell’autore verso questa
forma di patriottismo nonostante i tentativi del film di
farlo passare in secondo piano. Per quanto ci riguarda
questa lettura è da escludere, non solo perché nulla nel
film ci autorizza ad attribuire all’autore tale preferenza,
ma anche e soprattutto per la conclusione della sequenza che caratterizza come assurdo il gioco ad espugnare
e riprendere Douamont. Vero è piuttosto che lo spettatore, l’enunciatario, è costantemente manipolato dall’enunciatore, sia in termini cognitivi che passionali.
Livello enunciazionale:
Enunciatore
Enunciatario
50
Spazio della manipolazione
Effetti passionali
Attante
Antiattante
Negantiattante
Negattante
Tale categoria protoattanziale precede, presiede e giustifica l’organizzazione delle grandi forme musicali21.
Essa rende conto anche del motivo per cui la musica
costituisce sistemi semisimbolici e si rende disponibile nelle semiotiche multiplanari alla costruzione della
componente narrativa anche in termini di ruoli attanziali, come avviene in Casablanca22: parliamo allora di
pro-attanzialità della musica stessa.
Una analisi contrastiva de La grande illusione a paragone
con Casablanca rivela molto bene come la musica giochi un ruolo non solo nella costituzione di strutture che
reggono l’intero film, ma anche nella costituzione occasionale di strutture che reggono scene, strutture che poi
vengono dissolte o smentite dal resto del film. E’ proprio
nella dimensione processuale che l’enunciatario risulta
così manipolato, costituisce aspettative che poi vengono
alimentate, disattese, smentite o confermate solo con
molto ritardo. Crediamo sia questo il legame tra passioni provocate nell’enunciatario e strutture testuali: un
legame che si presta in generale ad essere bene esemplificato nel cinema in quanto semiotica sincretica.
Note
1
Cfr. Coe (1991).
Cfr. “Lezioni di regia” in Ejzenstejn (1958), tr.it.pp.169-198.
Si veda anche Galofaro (2005).
3
Tra i massimi esponenti del sinfonismo hollywoodiano. Tra
le tante collaborazioni, ricordiamo gli esordi con John Ford,
i molti lavori con Curtiz, la colonna sonora di Gone with the
Wind con Fleming, The Big Sleep di H.Hawks, e poi ancora The
Treasure of the Sierra Madre e Key Largo con Huston, e poi ancora
Cukor, Vidor, e tanti tanti altri. Cfr. Comuzio (2004).
4
Nel cinema di Hollywood i tre piani musicali descritti da
Chion 1990 (in/on the air/off) come pure il percorso che li lega
sintagmaticamente si trovano sempre rigidamente ben distinti, non lasciando quasi mai spazio al livello intermedio tra in
e off descritto da Miceli (2000).
5
Raccolti in italiano in Renoir (1996).
6
Renoir (1996:160).
7
Cantore della pariginità, oltre che con Renoir lavorò con
Queneau e Prévert scrivendo canzoni per Yves Montand,
Edith Piaf, Juliette Gréco. Cfr. Comuzio (2004).
8
Sul legame tra strutture di anticipazione/retrospezione e
passioni si vedano Galofaro 2004:156-159), Barbieri (2004)
e Marconi (2001).
2
Ricordiamo che in Greimas tale spazio della manipolazione si trova piuttosto al livello della coppia attanziale
destinante/destinatario; tuttavia per quel che riguarda
la musica una estrapolazione del modello ai rapporti tra
enunciatore ed enunciatario funziona egregiamente a
rendere conto degli effetti di senso passionali. Ecco spiegata la grande efficacia della scena della Marsigliese:
deve essere necessariamente efficace, perché contrasti
maggiormente con la scena seguente in cui Douamont
cade ancora una volta in mano tedesca.
Ancora, difficilmente in musica si troveranno i ruoli
attanziali tipici del livello semio-narrativo; Tarasti al
riguardo mette in guardia dal volerli ricercare a tutti i
costi in musica prima dell’apparizione in essa della narratività intesa come sistema modellizzante20. Tuttavia,
resta la possibilità di reperire, in musica, posizioni attanziali non antropomorfe, puramente sintattiche, secondo il modello della proto-attanzialità sviluppato da
Greimas:
Francesco Galofaro · Tensione e risemantizzazione al cinema: da La grande illusione a Casablanca
9
Si tratta di un’altra dimostrazione della perfezione tecnica
raggiunta dal cinema di Hollywood e della scelta, esteticamente rilevante, di non costruire in nessun caso reali cacofonie. E’ il volume e non il piano armonico ad essere pertinente
per l’effetto di senso della lotta tra i due temi. Analogamente
nelle una scazzottate e nelle sparatorie dei film dell’epoca non
abbiamo mai eccessiva confusione né sul piano degli eventi
filmati né da un punto di vista del montaggio e della messa a
fuoco delle inquadrature, né dell’enunciato né delle scelte di
enunciazione. L’estetica del periodo era chiaramente improntata alla piena intelligibilità, rispetto alla quale il dinamismo,
il ritmo, l’espressione di soggettività e il carico passionale delle
scelte enunciazionali rappresentavano altrettante variabili.
10
Scelta antinaturalista, come ben sa chi ha cantato in un
coro.
11
Crediamo che i motivi per questa differenza di scelte consistano nella necessità per Curtiz di intercalare le inquadrature
delle persone coinvolte nel canto con i primi piani del volto
della Bergman, per la verità non proprio espressiva in questa sequenza. L’aneddoto vuole che durante le riprese ci fosse
ancora incertezza sul finale, e dunque sulle emozioni che la
Bergman avrebbe dovuto esprimere. Tuttavia in un film di
questo livello tecnico l’aneddoto, fosse anche vero, non costituisce una scusante.
12
Ma Hjelmslev lasciava agli esperti l’ultima parola in merito.
Cfr. Hjelmslev (1942, tr.it.p.121).
13
Idea errata, visto che la musica non esibisce alcun tipo di
isomorfismo tra piano dell’espressione e contenuti, per di più
presentando caratteristiche tipiche della doppia articolazione;
si pensi al ruolo dell’intervallo nella musica tonale (Cfr. Stefani,
Marconi e Ferrari 1990). Il successo di questa teoria è spiegabile grazie all’influenza del formalismo di Hanslick (1854)
rilanciato da Stravinskij (cfr. Stravinskij 1983), dall’idea di asemanticità della musica cara a Lévi-Strauss (cfr. “Ouverture”,
in Lévi-Strauss 1964), e dal successo del serialismo integrale,
costituendo una pericolosa confusione tra estetica e semiotica
di cui si era reso conto già Eco (1968:303 e ssg.).
14
Si tratta di opposizioni plastiche, a volte complesse, ottenute
grazie a trasformazioni geometriche. Cfr. Galofaro (2004b).
15
Operazione che può tuttavia essere autorizzata in casi di
ipecodifica, penso ad es.alla teoria degli affetti.
16
Cfr. Ejzenstejn (1940).
17
Che sfrutta meccanismi più basilari di Induzione semantica
(Cfr. Metz 1972, tr.it.p. 51), una riformulazione dello humeano Post hoc ergo propter hoc. Metz rende conto in termini hjelmsleviani del concetto chiamato originariamente da Mitry
Logica d’implicazione (Metz 1972, tr.it.p. 21).
18
Né è il cinema l’unico caso. Siamo in gran parte debitori nei
confronti di Zinna (2004) per quel che riguarda una fondazione teorica hjelmsleviana delle semiotiche multiplanari.
19
La colonna sonora consta ovviamente di due semiotiche
molto differenti, dialoghi e musica; anche la colonna visiva
non è necessariamente un unico piano: pensiamo alle didascalie del cinema muto.
20
Tarasti (1996:41)
21
Non è il caso di approfondire oltre questo modello per cui
rimandiamo a Galofaro (2004).
22
Ma anche in altre semiotiche sincretiche, quali la musica
vocale e l’opera, in cui abbiamo anche la componente drammaturgica.
Bibliografia
Barbieri, D, 2004, Nel corso del testo, Milano, Bompiani.
Chion, M., 1990, L’audio-vision. Son et image au cinéma, Nathan,
Paris ,tr.it. L’audiovisione. Suono e immagine al cinema, Torino,
Lindau, 1997.
Coe, J., 1991, Humphrey Bogart – take it & like it, London,
Bloomsbury Publishing Limited; trad. it. Humphrey Bogart
– Suonala ancora Sam, Roma, Gremese editore, 1992.
Comuzio, E., 2004, Musicisti per lo schermo, Roma, Ente dello
spettacolo.
Eco, U. , 1968, La struttura assente, Milano, Bompiani.
Ejzenstein, S.M., 1940, “Vertikal’nyi montaz”, in Iskusstvo
Kino nn. 9 1940, 12 1940, 1 1941; trad. it. “Il montaggio verticale”, ne Il montaggio, Pietro Montani , Venezia,
Marsilio.
Ejzenstein, S.M., 1958, Na urokach rezissury S. Ejzenstejna,
Iskusstvo, Moskva; trad. it. Lezioni di regia, Torino,
Einaudi, 1964, n. ed. 2000.
Galofaro, F. , 2004, “Protonarratività in Schönberg”, in VS
98-99, Milano, Bompiani.
Galofaro, F., 2004b, “Sullo spazio in musica”, in Ocula 5,
www.ocula.it.
Galofaro, F., 2005, “Il nemico. La costruzione del conflitto nel
cinema di propaganda: il caso Alexandr Nevskij” in Guerre
di segni. Semiotica delle situazioni conflittuali, G. Manetti, P.
Bertetti, A. Prato, Torino, Centro Scientifico Editore.
Greimas, A.J. e Courtés, J. , 1979, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris: Hachette ,trad. it. Semiotica.
Dizionario ragionato della teoria del linguaggio, P. Fabbri,
Firenze, La casa Usher, 1986.
Greimas, A.J. e Courtés, J., 1986, Sémiotique. Dictionaire raisonné
de la théorie du langage II, Paris, Hachette.
Hanslick, E., 1854, Von Musikalisch-Schönen, Leipzig, trad. it.
dalla 15° edizione 1922 Il bello musicale, Milano, Aldo
Martello Editore, 1971.
Hjelmslev, L., 1942, Omkring sprogteoriens grundlasggelse, Ko/
benhavn: Munksgaard; nuova ed. Prolegomena to a Theory
of Language, Madison, University of Winsconsin Press,
1961; trad. it. I fondamenti della teoria del linguaggio, Torino,
Einaudi, 1968.
Lévi-Strauss, C., 1964, Le cru et le cuit, Paris, Libraire Plon;
trad. it. Il crudo e il cotto, Milano, Mondadori, 1966, poi
Milano, Il Saggiatore, 1990.
Marconi, L., 2001, Musica Espressione Emozione, Bologna,
Clueb.
Metz, Ch., 1972, Essays sur la signification au cinéma, Paris,
Klincksieck; trad. it. La significazione nel cinema, Milano,
Bompiani.
Miceli, S., 2000, Musica e cinema nella cultura del novecento,
Milano, Sansoni.
Renoir, J., 1996, Il passato che vive, Roma, Bulzoni.
Stefani G., Marconi L., Ferrari F., 1990, Gli intervalli musicali,
Milano, Bompiani.
Stravinskij, I., 1983, Poetica della musica, Pordenone, Edizioni
studio tesi.
Tarasti, E., 1996, Sémiotique musicale, Limoges, Pulim.
Zinna, A., 2004, Le interfacce degli oggetti di scrittura, Roma,
Meltemi.
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
51
Sono troppo giovane per aver imparato ad ascoltare De
André prima di Creuza de mä. E i miei genitori, che sono
stati giovani prima che fosse stata creata per loro una
categoria sociale, erano già troppo vecchi quando De
André cantava del suonatore Jones. Mi scuso con i lettori per questo inizio autobiografico, di poco interesse
se non per l’utilità di collocare il mio personale punto
di vista, o meglio di ascolto, sulle musiche di cui parlerò
tra breve.
Ha ragione R. Cotroneo quando ricorda che “in
Fabrizio De André la fusione completa tra testo e musica è stata sempre lievemente inficiata, come fosse una
aritmia creativa che diviene cifra”.1 È sempre stata diffusa la strana convinzione che nell’arte di De André la
musica non fosse tanto importante quanto le parole. La
schitarrata da spiaggia, mezzo di diffusione di oralità
secondaria che ha fatto la fortuna di molti fra i cantautori italiani, ha fatto sì che invece, fra una “pennata”
e l’altra, si perdesse il lavoro compositivo geniale, ma
spesso poco appariscente, delle celebri ballate dell’autore genovese. In quelle felici occasioni conviviali anche i
testi, i cui versi pieni di meravigliosi giochi ritmici e fonici sono a volte di una bellezza straziante, diventavano
spesso delle filastrocche da portare avanti fino alla fine.
Così ho conosciuto la maggior parte delle canzoni di
De André, e ho perso molto tempo prima di ascoltarne
attentamente le versioni originali e spalancare le orecchie ad universi sonori eccezionali, fatti di mille timbri
scelti ed intrecciati appositamente per colorare il flusso
ordinato del tempo, la musica, su cui scandire tutte le
sillabe di ogni parola.
Quella fra parole e musica appare, così, come una sinergia quasi irrinunciabile nell’opera di De André. Ciò
è vero soprattutto a partire da Non al denaro, non all’amore,
né al cielo, quando nel percorso artistico del cantautore
“riguardo al lavoro musicale cambia tutto; si accentua
fortemente un suo atteggiamento ricettivo e si circonda
di musicisti con delle idee importanti”2.
Sembra che De André abbia sempre speso molte energie nella creazione di un universo sonoro che conferisse
coesione ad ogni singolo album: il materiale musicale
scelto, a volte anche disparato, si incontrava nella costituzione di un orizzonte sonoro da cui potessero fuoriuscire i brani, come se fosse l’unico fusto di un’infiorescenza, per recuperare l’immagine rinascimentale del
florilegio musicale. L’atto di interpretazione di questi
universi sonori costituisce i piani isotopici che fanno da
sfondo all’immaginario degli ascoltatori: si producono
così, con i suoni, i mondi fantastici dove le storie narrate
accadono.
Se per immaginario musicale si intende “l’insieme di
immagini che vengono associate ai timbri degli strumenti o alle melodie”, oppure, più precisamente, “le
porzioni di cultura che l’ascoltatore richiama ogni qual
volta incontra un suono e dona ad esso un senso che
sembra appartenergli naturalmente”, allora i mondi inventati da De André sono immaginari “musicati”. Qui
E|C Serie Speciale
Anno I, n. 1 2007, pp. 53-66
ISSN (on-line): 1970-7452
ISSN (print): 1973-2716
EC
Spaghetti countrywestern,valzerini
e fratture psichedeliche.
Ovvero: come i fantasmi di
Spoon River, quando ebbero la
voce, cantarono all’italiana*
Stefano Jacoviello
non si ascolta mai banalmente il suono di ciò che viene
detto con la parola, ma si costruisce con i suoni un discorso che racconta a suo modo ciò che sta accadendo
nel mondo narrato in versi.
La costruzione di un universo sonoro che possa giocare
con l’immaginario musicale, e contemporaneamente
influisca fortemente su di esso, è evidente ad esempio in
album come Creuza de mä, o Anime Salve, ove prorompe
l’idea di un Mediterraneo “allargato”, che diverrà in
seguito ideologia e mitologia per certa world music italiana: in virtù di alcune sincopi rassomiglianti, il Brasile,
Capo Verde e il Maghreb diventano territori idealmente
sconfinanti, mentre le polifonie sarde tendono la mano
a quelle dell’Africa Occidentale. E in questo paesaggio
sonoro la moglie di Anselmo e il pescatore di acciughe
e stelle marine vivono le loro storie3.
Questo tipo di operazione creativa caratterizza fortemente anche Non al denaro, non all’amore, né al cielo4.
Tuttavia in questo caso specifico siamo costretti a fare i
conti con un’operazione altrettanto culturalmente creativa: la traduzione.
L’ipotesi di base è che De André, con Nicola Piovani,
accanto alla traduzione/trasposizione delle poesie di
Masters, che costituisce la parte linguistica del lavoro
inerente alle canzoni in oggetto, abbia operato una traduzione musicale. Una traduzione bizzarra però, perché non individua un preciso testo di partenza, chiuso
e definito da confini facilmente individuabili. Ciò che
si tenta di tradurre è una porzione di cultura musicale
popolare americana: il suono dell’America.
Se nei testi delle canzoni le tracce di americanità delle
storie raccontate scompaiono per creare dei tipi universali, i resti rientrano nella musica, per narrare ancora
un’epopea della lontana America.
Eppure non è più la sconosciuta America rurale in sé
ad essere nei suoni, ma la sua rappresentazione nell’immaginario degli italiani. D’altra parte come potrebbe
essere altrimenti?
© 2007 AISS - Associazione Italiana di Studi Semiotici
T. reg. Trib. di Palermo n. 2 - 17.1.2005
Con questo saggio si vuole mostrare la meccanica del
processo di traduzione del “suono dell’America” mediante la costituzione di un universo sonoro, e scoprire
come questo possa configurarsi come immaginario musicale. Infine si vuole osservare come quest’ultimo possa
diventare la base di partenza per musicare un immaginario proveniente da una narrazione letteraria, donandogli il suono: ovvero in che modo De André fa appello
ad un immaginario musicale per crearne uno musicato.
Vedremo inoltre come i nuovi elementi musicali acquisiti, accanto a quelli costitutivi dello stile proprio del
cantautore genovese, interagiscono gradualmente con
il testo verbale fino a provocare la frattura e la metamorfosi della forma strofica, generalmente funzionale
alla narrazione, favorendo la scaturigine di espansioni
narrative e mutamenti del punto di ascolto.
La metodologia e gli strumenti che utilizzerò nell’analisi sono quelli elaborati dalla semiotica strutturale5:
mi riferirò fondamentalmente agli scritti dedicati alla
musica da N. Ruwet, a quelli di J.M. Lotman sulle dinamiche culturali, e alla mia elaborazione dei concetti
della semiotica di A.J. Greimas per la loro applicazione
all’analisi del testo musicale, con la speranza di rendere
facilmente comprensibile il metalinguaggio semiotico,
anche a costo di qualche semplificazione.6
Proveremo così a capire come fu che i muti defunti della
collina ebbero in dono la voce per raccontarsi alle orecchie del mondo, e lo fecero cantando “all’italiana”.
54
1. Musica e parola: la canzone come
testo sincretico
Ho forse esagerato un po’ attribuendo alla schitarrata
da spiaggia la colpa per cui il valore più specificamente musicale dell’opera di De André sia generalmente
misconosciuto, in favore di una maggiore attenzione
ai versi delle sue canzoni. Eppure è innegabile che in
ciò sia riconoscibile un atteggiamento proprio della
critica musicale italiana e della stampa che si occupano di musica leggera: di fronte a una canzone, si tende
spesso a spostare l’attenzione sulla parola, capace più
della musica di esprimere un messaggio. Probabilmente
l’importanza attribuita al messaggio da comunicare, al
“cosa ci vuol dire l’autore”, al suo valore politico che si
trasforma in valore estetico, ha fatto sì che si affermasse l’attitudine a considerare i cantautori come dei poeti contemporanei, di cui difendere la nobiltà artistica
supponendo che questa venisse rigettata dalla cultura
“alta” per motivi di classe7.
La stessa attitudine preferiva lasciare più comodamente alla musica il senso dell’ineffabile, riservando così la
possibilità di saper spiegare come, differentemente dalla
poesia colta e difficile da interpretare, le canzoni potessero essere ad un tempo così semplici e così profonde.
È certamente questo atteggiamento della critica italiana che ha favorito, a partire dagli anni ’70, di seguito
agli esordi di De André, la grande diffusione di “autori
cantanti” che concentravano i loro sforzi nell’elabora-
zione di un testo poetico, relegando la musica, almeno a
livello formale, alla mera funzione di accompagnamento. A livello sociale invece la musica diventava per loro
soprattutto la porta per accedere ai canali di comunicazione di massa - la radio, la televisione, e ovviamente
la discografia - che cominciavano già ad essere preclusi
alla poesia tradizionalmente intesa.
Ciò detto scagiona la conviviale schitarrata da colpe
non sue, e la riporta al rango di antico e umano mezzo
di diffusione della musica popolare.
La posizione più condivisa fra i critici e i giornalisti
italiani, per cui il senso di una canzone sia fondamentalmente nelle sue parole, è curiosamente simmetrica a quella proposta da estetologi come Susannne K.
Langer8, secondo cui la musica assorbirebbe il senso
delle parole, o Boris de Schloezer9, per il quale la condizione ottimale di ascolto di una musica vocale sarebbe
quella dell’ascoltatore che non comprende la lingua in
cui è scritto il testo cantato. Le parole sarebbero quindi indifferenti, dato che il senso è tutto racchiuso nella
musica che viene eseguita attraverso la loro vocalizzazione.
Sembra evidentemente necessario cercare una mediazione fra queste due posizioni. Altrimenti se fosse vera
la prima ipotesi, quella che abbiamo identificato con
la critica e la stampa italiana, De André non avrebbe
deciso di scrivere canzoni e avrebbe potuto più semplicemente pubblicare una raccolta di poesie frutto del
gioco stilistico della trasposizione, o trascrizione, delle
originali composizioni di E.L. Masters: avrebbe insomma fatto lo scrittore10.
Se invece fosse vera la seconda ipotesi, allora non si capirebbe il motivo per cui per secoli e in tutte le culture
del mondo l’uomo si sia messo a cantare delle parole,
invece di evitare complicazioni metriche, vani sforzi
nella ricerca del libretto giusto o del salmo da musicare.
Non si comprenderebbe l’inutile desiderio di narrare
un fatto di cronaca della comunità cantandolo, affinché
venisse ricordato in modo efficace come se riaccadesse
ogni volta “davanti alle orecchie” degli ascoltatori.
Si può acutamente osservare che, nella musica vocale,
musica e parola interagiscono come due sistemi che
possono addirittura parlare uno dell’altro. Per Ruwet
la musica vocale “può apparire come un mezzo di cui
l’uomo dispone per poter esprimere, altrimenti che mediante le parole, certe attitudini emozionali che sono
le sue in presenza del linguaggio considerato come un
tutto, dal disprezzo – “Parole, parole, parole” – alla glorificazione – “Honneur des hommes, saint langage!””11. In senso
inverso “molte forme musicali arrivano a costituire tutti
organici, esteticamente parlando, solo se si tiene conto
del testo verbale”: questo succede per quei generi che
considerano come carattere costitutivo l’articolazione
linguistica dei versi che vanno a musicare, come ad
esempio il mottetto o il madrigale, la polifonia fiamminga rinascimentale come le chansons di Josquin Desprez.
Lo stesso succede con le canzoni di De André dove la
Stefano Jacoviello · Spaghetti country-western, valzerini e fratture psichedeliche. Ovvero: come i fantasmi di Spoon River, quando ebbero la voce, cantarono all’italiana.
forma strofica del testo verbale informa l’articolazione
ritornellare della musica.
Per capire i modi di questa interazione, possiamo cominciare provando ad isolare strutturalmente musica
e parola come due sistemi linguistici12. La musica e il
linguaggio strutturano il continuum sonoro per mezzo
di dispositivi diversi: la lingua usa sistemi di opposizioni
distintive fra tratti fonetici, mentre la musica organizza gerarchie di altezze, durate, intensità e, ad un livello
più superficiale, di timbri. Questi dispositivi, per dirla
con N. Ruwet, “si situano a livelli differenti e possono
essere attuati simultaneamente” - sul continuum sonoro - “senza che si creino interferenze. Perché un’opera
vocale costituisca un tutto organico sul piano musicale,
non è dunque necessario che le parole si riducano alla
musica”13, e viceversa.
Possiamo quindi analizzare la musica e le parole separatamente: si possono isolare le parole dalla musica, come
ha fatto Cotroneo curando la raccolta di tutti i testi di
De André14, purificandole così da tutte le componenti
emotive che con il senso del suono legano noi, che un
tempo siamo comunque stati ascoltatori, alle canzoni
della nostra vita, quelle che fanno da richiamo sonoro
ai ricordi15. La canzone si riduce così a ciò che se ne
può leggere.
Viceversa la musica può essere analizzata separatamente dalla parte verbale, rintracciandone l’articolazione
della melodia, la struttura armonica, la scelta dei timbri
per l’orchestrazione: ridurremmo così la canzone a ciò
che se ne può ascoltare.
Non bisogna però mai dimenticare l’origine di queste
due componenti: né musica, né poesia, ma canzone.
“In via di principio, non vi è alcuna incompatibilità fra
musica e linguaggio, è sempre possibile alle strutture
musicali funzionare […] senza interferire con le strutture linguistiche: o, se interferenze si producono, esse non
sono mai indifferenti: la relazione musica-linguaggio è
sempre pertinente”16.
Tuttavia, finché continueremo a concepire musica e
parola come sistemi linguistici differenti, con le loro
proprie strutture generali, che si oggettivano in processi particolari nelle singole opere in cui compaiono uno
accanto all’altro, non potremo mai andare oltre l’analisi
dei singoli casi: potremmo studiare come il senso di un
verso si intreccia con quello di una frase musicale, ma
non avremmo mai la possibilità di raggiungere una visione globale della canzone.
Per questo è necessario risolvere un problema di metodo, considerando la canzone, da un punto di vista
semiotico, come un testo17: un universo chiuso di senso,
costituito dall’insieme di relazioni sintattiche e semantiche degli elementi che lo compongono, articolabile su
due piani – uno dell’espressione, e uno del contenuto.
Sul piano dell’espressione andremo ad indagare l’articolazione della forma che individua la sostanza significante, attraverso cui il senso “viene al mondo” nella sua
manifestazione. Sul piano del contenuto, invece, trove-
remo le forme in cui il senso si articola per omologia
con quelle che si interdefiniscono sul piano dell’espressione. Il concetto è complesso, ma possiamo provare a
spiegarlo più semplicemente con un esempio.
La superficie ghiacciata di uno specchio d’acqua è perfettamente piana ed indistinta, tanto da non poterla descrivere. La comparsa di una crepa su questa superficie,
collocando un punto di vista, ci permette di distinguere
una parte a destra ed una a sinistra della crepa, una più
vicina al bordo dello specchio d’acqua e una orientata verso il centro. Queste opposizioni, che individuano
solo posizioni logiche senza necessariamente richiamare alcun senso al di là di ciò che sono, costituiscono
l’articolazione del piano dell’espressione. Ora, in base a
dove il punto di vista è collocato, potremmo capire dove
si trova colui che guarda questa crepa, e distinguere se
può starsene tranquillo a guardare, nel caso in cui fosse
a un passo dalla riva, oppure se nel caso contrario deve
considerarsi in pericolo. Ecco che quelle che erano due
anonime parti di piano, individuando l’articolazione
della forma sul piano del contenuto, cominciano a vestirsi di aspetti relativi all’esperienza del mondo naturale (la riva, il largo), possono rimandare ad una situazione
positiva o negativa, e cominciano a colorarsi dello stato
d’animo che caratterizza la calma o il pericolo, fino a
raccogliere in potenza il nucleo narrativo della storia di
una tragedia, oppure della curiosa scoperta di un fenomeno naturale.
Infine, chi va alla deriva stando in piedi sulla lastra di
ghiaccio potremmo essere noi! Questo effetto di senso
può essere descritto con l’analisi delle strategie di enunciazione, quelle che presiedono alla “messa in discorso”
delle articolazioni più profonde del senso. Facendo attenzione all’esempio dato, risulterà chiaro che, per far
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
55
56
scaturire il senso, la materia di cui è fatta la superficie che si rompe è del tutto indifferente, poiché siamo
in grado di pensarla come forma che attraverso la sua
struttura individua una sostanza.
Tornando ai nostri argomenti, la struttura di un testo
narrativo vede il piano dell’espressione articolato secondo le forme del linguaggio verbale che articolano le forme della cultura sul piano del contenuto, permettendo
così la generazione del senso.
Nel caso della canzone le cose si complicano un po’:
non ci sono più solo le forme del linguaggio verbale
ad articolare il piano dell’espressione, ma anche quelle
della musica. Ciò significa che la canzone è quello che
in semiotica strutturale si definisce testo sincretico: diverse
semiotiche, costituite da forme che individuano delle
sostanze, articolano il piano dell’espressione, in relazione ad un’unica articolazione del piano del contenuto.
Quale sarebbe quindi il passo in avanti?
La prospettiva teorica delle semiotiche sincretiche non
considera più gli oggetti di analisi in relazione alla materia che li costituisce e ai canali percettivi impiegati per
la sua trasmissione comunicativa, ma li definisce in base
alle forme che articolano le diverse semiotiche sul piano
dell’espressione del testo. Perciò una canzone, anche se
è fatta di suoni e interessa solo il canale uditivo, non è
più soltanto “musica”.
Come faceva già notare Ruwet, i suoni vengono articolati secondo due forme, due strutture diverse che ne
organizzano i tratti distintivi secondo diversi sistemi di
relazione: abbiamo quindi da una parte la musica, e
dall’altra il linguaggio verbale, ognuno con la sua fonologia, la sua sintassi, la sua grammatica, le sue funzioni
semantiche. Ambedue convergono però verso un’unica
articolazione del piano del contenuto, un’unica forma
del senso. La semiotica greimasiana ha prodotto uno
strumento logico-analitico, il percorso generativo, in
grado di evidenziare tutte le fasi di articolazione della
generazione del senso: il processo che, partendo dall’articolazione delle strutture più profonde, sintattiche e
semantiche, e passando per quello del discorso, porta il
senso “in superficie”, al livello della manifestazione.
Il lavoro del semiologo sta nel capire la dinamica per
cui le articolazioni di un piano dell’espressione, fatte di
intervalli melodici, configurazioni ritmiche, timbri, possano essere in relazione con le articolazioni del piano
del contenuto, a vari livelli di profondità, costituendo
così il senso della musica. Non dobbiamo scoprire “cosa
significa” il testo, operazione lasciata al buon savoir faire
di ogni analista, ma “come significa”.
Per fare questo, dopo aver ridato alla musica la possibilità teorica di avere un senso, riservandogli lo stesso trattamento di ogni fatto di cultura18, e dopo aver concepito
la canzone in quanto testo costituito da un complesso
meccanismo composto di musica e parole interrelate a
livello locale e globale, c’è bisogno di fare ancora un
passo in più nel percorso teorico. È necessario arrivare
a pensare che la musica possa essere analizzata semioti-
camente secondo le categorie del “discorso”, intendendo questo termine nell’ottica teorica greimasiana.19
È a questo livello che gli intervalli, le configurazioni
ritmiche, i timbri, le progressioni armoniche cominciano a rendere effetti spaziali, cambiamenti del punto di
ascolto, e iniziano a “vestirsi” di elementi interpretabili in quanto somiglianti ad oggetti dell’esperienza di
un mondo naturale. Nascono così le figure del discorso musicale, che non sono ascrivibili ad un dizionario
delle forme, fissato convenzionalmente e culturalmente
condiviso, ma vengono a formarsi nell’ambito di ogni
testo, attraverso la relazione degli elementi sui due piani. Nei testi sincretici le relazioni fra le varie semiotiche
sul piano dell’espressione istituiscono un dispositivo di
rimandi e ridondanze tale che è più facile investire di un
senso figurativo anche le configurazioni più astratte del
piano dell’espressione.
Le figure del discorso musicale garantiscono la semantica della musica. Inoltre, prese singolarmente nella loro
complessità strutturale, le strategie discorsive che producono queste figure sono in grado di costituire uno
stile, capace di viaggiare da un testo all’altro, nello stesso o in più ambiti culturali, laddove si sottopongano ad
un processo di traduzione. In questo modo le figure del
discorso musicale di un testo diventano elementi di un
immaginario musicale culturalmente condiviso.
2. La traduzione: da universo di suoni ad
immaginario musicale
Nel 1968, a De André capita di rileggere l’Antologia di
Spoon River, e ne rimane ancora colpito: “riscontrai in
quei personaggi qualcosa di noi, mi parve che in quella collina popolata di morti si parlasse il linguaggio di
una verità che i vivi non possono esprimere”20. Quindi
De André cerca e trova due compagni, Nicola Piovani
e Giuseppe Bentivoglio, per imbarcarsi in un’entusiasmante avventura artistica: tradurre in una serie di canzoni quel “linguaggio della verità” parlato dai fantasmi
letterari di quei morti americani.
È ovvio che qui, con il termine “linguaggio” non ci
stiamo riferendo semplicemente al modo di esprimersi
linguisticamente, ma al modo di esprimere linguisticamente un sistema di valori, di conoscenze: una cultura.
Intendiamo il linguaggio come strumento di espressione e, allo stesso tempo, risultato dell’articolazione della
cultura.
Tradurre significa riuscire a descrivere con il proprio
linguaggio il sistema culturale altrui. È condizione necessaria quindi che ci siano almeno due sistemi culturali,
definiti da un confine che li divide, e che si riconoscano
come uno “l’altrui” dell’altro. La traduzione è dunque
il processo per cui gli elementi di un sistema passano
attraverso il confine e si integrano nell’altro sistema secondo nuove regole: il sistema ospite descrive l’oggetto
acquisito per mezzo delle sue categorie, le stesse che costituiscono la sua articolazione e lo definiscono in quanto sistema. Così l’elemento estraneo diventa familiare, si
Stefano Jacoviello · Spaghetti country-western, valzerini e fratture psichedeliche. Ovvero: come i fantasmi di Spoon River, quando ebbero la voce, cantarono all’italiana.
trasforma da extrasistematico in sistematico. Dopo quest’operazione il sistema ospite è mutato: acquisendo un
elemento in più ha cambiato i suoi equilibri interni.
Ogni volta che avviene un incontro fra culture si costruisce un’immagine dell’altro in cui ritrovare il riflesso utopistico di noi stessi; e il processo è reciproco. Costruiamo
l’immagine dell’altro con il nostro linguaggio, e quindi
con i nostri modi di organizzazione del senso, con le
categorie del nostro sistema culturale.
Secondo Lotman: “Nella comunicazione fra un ricevente e un trasmittente che non si identificano, le ‘personalità’ dei partecipanti all’atto comunicativo si possono
considerare come un complesso di codici non adeguati,
che hanno però dei tratti comuni. La sfera di intersecazione di questi codici assicura il livello necessario di
comprensione minima. La sfera di non intersecazione
determina la necessità di stabilire un’equivalenza fra
elementi diversi e pone le basi per la traduzione”21. Il
livello di traducibilità possibile fra i due sistemi culturali
ci permette di prevedere le trasformazioni che avverranno22.
Se la traduzione è quindi un processo destinato a ciò che
dell’ “altro” non possiamo esprimere con i nostri mezzi,
la condizione necessaria perché questo si realizzi è che
ci sia una sfera di intersecazione, un piccolo insieme di
tratti comuni che funzioni da pietra angolare, o da vivaio
germinale per ricostruire il sistema altrui con le proprie
categorie, modificandole in corso d’opera e adattandole
agli elementi culturali che vengono ospitati.
Bisogna però considerare che
l’interpretazione di un
oggetto extrasistematico da parte di un’altra
struttura pensante presuppone una quasi abolizione della sua
informatività interna. Proviamo
a pensare a quando si
ascolta una lingua
straniera di cui si
sa pochissimo:
si tenta di
riarticolare
i suoni in
base alle
poche
conoscenze
di cui
si è
provvisti per rintracciare le parole di cui si conosce il
senso. Finché il nostro vocabolario rimane limitato, non
ci rimane che tentare di intuire il senso dei suoni che si
ascoltano, inventandolo. Allora, ragionando in termini
semiotici, l’attività di traduzione consiste nel sistematizzare il più rigidamente possibile l’elemento estraneo
acquisito, descrivendone la struttura più elementare del
senso, per poi aggiungere gradualmente nuova informatività (ciò che si indica abbastanza largamente con
il termine “connotazione”, le varie accezioni e i sensi
figurati con cui il nuovo elemento viene utilizzato per
esprimersi). Anche se la struttura della significazione
musicale è ovviamente diversa da quella specifica delle
lingue naturali, la dinamica generale della traduzione
è analoga.
Posto quindi che la musica abbia un senso legato al
grado di sistematicità di ogni sua articolazione all’interno del testo musicale, possiamo supporre che la sua
traduzione possa avvenire prima riducendola alle sue
strutture più “vuote” (sequenze di intervalli, di accordi, configurazioni ritmiche e metriche, timbri, natura
fricativa o percussiva della produzione sonora), per poi
rivestirla di un senso nuovo attraverso la nuova messa
in discorso.
Secondo questa dinamica, le figure del discorso musicale di una cultura di partenza, da considerare come oggetti asistematici costituenti un universo di suoni, possono passare in un altro sistema culturale e guadagnare
un senso nuovo, a volte anche perdendo quello originale. La sistematizzazione dei nuovi elementi tradotti
andrà a costituire l’immaginario musicale che rimanda
alla cultura altra: potremmo dire “il suono degli altri”.
Al semiologo non rimane allora che sedersi a cavalcioni
sul confine e, con un piede di là e uno di qua, stare lì
fermo a guardare le cose che passano.
3. Tradurre l’America: l’invenzione di un
immaginario musicale
Per tradurre in canzoni il mondo di Spoon River, la sua
cultura e il suo sistema di valori, a De André, Piovani e
Bentivoglio le parole non bastano: per rendere simbolicamente efficaci i discorsi dei fantasmi della collina,
per farli parlare come se fossero eternamente vivi, c’è
bisogno di riportarne anche il suono. E bisogna farlo
“in italiano”, affinché il pubblico possa intenderli e lasciarsene conquistare23.
Per farlo è necessario fare appello a quella sfera di intersecazione di cui parla Lotman, costituita dagli elementi
dell’immaginario culturale italiano che rimandano ai
suoni dell’America, dell’epopea dei suoi padri fondatori, responsabili di quei valori e quel modo di vivere di
cui le lapidi di Spoon River sono testimoni.
Proprio in quegli anni c’era qualcuno che aveva già descritto in italiano l’epopea americana, riscuotendo un
notevole successo: i film di Sergio Leone Per un pugno di
dollari (1964), Per un dollaro in più (1965), Il buono, il brutto e
il cattivo (1966), e infine C’era una volta il West (1968) rac-
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
57
58
contavano in italiano il mito di fondazione americano,
costruendone una rappresentazione culturale popolare,
fatta di panorami, di volti, di nomi comuni che diventavano nomi di persona (il Biondo, Sentenza, l’Indio,
Harmonica, Cheyenne, ecc.), di situazioni e, non secondariamente, di suoni.
È curioso che, accusato dalla produzione giapponese di
A. Kurosawa di aver copiato illegalmente il plot di La
sfida del samurai (Yojimbo, 1961) per il suo primo film del
filone spaghetti-western, lo stesso Leone abbia dichiarato che il suo voleva essere un tentativo di tradurre in
italiano la storia del film giapponese. “Si diceva che il
film era stato ispirato da un romanzetto ‘giallo’ americano24. Kurosawa lo aveva plasmato e rimodellato con
maschere grottesche e una cadenza marziale: ecco i
samurai. Vidi il film e subito mi venne la voglia di spogliare quei ‘burattini’ e dopo averli reinventati cow-boy,
rifar loro attraversare di gran fretta l’oceano e riportarli
in patria. Era quella la provocazione. Ma c’era un’altra cosa. Dovevo trovare una ragione in me stesso – non
essendo mai vissuto in quell’ambiente. Dovevo trovare
una ragione all’interno della mia cultura”25.
Quando Leone pensava al personaggio del cow-boy non
si riferiva all’equivalente dell’eroe mitico di John Ford,
incarnato da John Wayne in Ombre Rosse (Stage Coach,
1939). “L’eroe fordiano è un eroe demonico, un distributore di destini, proteso verso una certa meta, ritornare a casa o in patria, compiere una lunga e perigliosa
ricerca, o raggiungere la Città Celeste, o la terra promessa”26. Questo modello di eroe, secondo G. Deleuze,
definisce per il cinema classico americano la “grande
forma dell’immagine azione” (SaS1) 27: dal punto di vista
formale della narrazione, questo eroe è colui che con il
suo agire è in grado di riportare la situazione all’equilibrio rotto da un precedente danneggiamento, e condurla ad un livello progredito rispetto allo stadio iniziale,
proiettando la storia verso un futuro migliore. L’eroe
dell’epica americana è un soggetto definito dall’azione
sentita come un obbligo trascendente, un dovere mitico
da adempiere, un grande fine da perseguire: ad esempio, la costruzione di una nuova Patria, lo spostamento
in avanti della frontiera fino al Pacifico28.
Gli eroi di Leone invece sono solo dei vagabondi sconclusionati, destinati prima o poi alla morte. Come
le maschere della Commedia dell’Arte, le loro azioni
hanno corta gittata e sono sottomesse alle pulsioni corporee: nei film della “trilogia del dollaro” il Cattivo e
il Biondo si lavano nelle vasche che trovano a disposizione, a volte dopo aver tirato fuori il morto rimastovi
a bagno, e in C’era una volta il West il bandito Cheyenne
entra in ogni luogo prima di tutto per bere o per mangiare a scrocco.
Se nei film di Ford gli eroi si definiscono Americani per
mezzo dell’azione, i personaggi di Leone ritornano ad
essere legati alle loro radici, di fronte alle quali oscillano fra il desiderio e la repulsione, quando non sono
state loro definitivamente negate: sono spesso “figli di
puttana”, se ne intuisce l’etnia ma non se ne conosce la
provenienza, e quasi mai i cognomi. Gli unici ad avere
un nome e una provenienza sono gli irlandesi McBain
di C’era una volta il West, di cui la protagonista Jill, exprostituta di New Orleans, prende il nome e con esso il
progetto di costruzione di una stazione ferroviaria. Jill
diventa così l’eroina della nuova America, fondata sulla
democrazia e l’investimento del capitale, e la sua azione
relega l’epica dei cow-boys ad un passato da narrare.29
Il “codice virile” degli eroi fordiani li fa apparire integerrimi come quelli omerici. I personaggi di Leone
invece si comportano secondo una caricatura del codice
virile, e la trasgressione delle sue norme mostra tutta la
debolezza che rende umani gli eroi. L’amore è meschina pulsione sessuale per i cattivi, mentre per i buoni è
qualcosa di impossibile da realizzare, non per lasciare
però il passo ai “grandi fini”, ma perché lo si smaschera
nella sua miseria di passione umana. L’amore mitologico, che negli eroi americani esiste a volte tramite la sua
interdizione, nei film western italiani scompare, lasciando il posto ad un più schietto e ingenuo affetto, che vive
fugacemente nell’occasione di ogni incontro.
Ed è lo stesso amore istantaneo che, sulle rive dello
Spoon, si esaurisce per Fiddler Jones nel fruscìo delle
gonne, o finisce sulle labbra del malato di cuore; l’amore rimirato dal chimico, sognato e teorizzato ma mai
esperito: un amore che può diventare eterno solo nel
ricordo inventato di un mito, o nella testimonianza di
una lapide.
Piuttosto che dall’epica classica americana, per i suoi
cowboys Leone trae spunto dai personaggi di Howard
Hawks: gli sceriffi incarnati da John Wayne, Dean
Martin e Ricky Nelson in Un dollaro d’onore (Rio Bravo,
1954). Applicando al western il modello della commedia, i cattivi non sono più davvero tali, e quando li si
incontra non è più necessario arrivare alla loro eliminazione fisica: se qualcuno muore ciò dipende solo dalle
circostanze. Riprendendo Deleuze, per questi personaggi ogni azione non è mai risolutiva, e la situazione che
da essa deriva li costringe ad un’azione successiva30.
Alla reiterazione dell’azione, propria della commedia,
Leone aggiunge un senso di degenerazione31: ogni azione scandisce ritmicamente un percorso ineluttabilmente rivolto verso la morte.
Lo stesso senso di terminatività lo si ha leggendo le
poesie dell’Antologia, in cui il silenzio che succede alla
lettura dell’ultimo verso di ogni pagina ripresenta ritmicamente l’idea della morte come fine del tempo raccontato, per poi farci tornare indietro, alla pagina seguente,
di nuovo ad un passo dall’attimo terminale: quelle scritte sulle lapidi sono sempre “le ultime parole”.
A livello narrativo, nel cinema western classico il duello è la prova decisiva, quella finale, che determina la
risoluzione delle controversie con l’eliminazione del nemico, e con essa la soppressione ontologica del Male:
l’eroe e l’antagonista sono posti uno di fronte all’altro,
agli estremi di una linea immaginaria, e la caduta di
Stefano Jacoviello · Spaghetti country-western, valzerini e fratture psichedeliche. Ovvero: come i fantasmi di Spoon River, quando ebbero la voce, cantarono all’italiana.
uno dei due permetterà a questa linea del destino di
estendersi all’infinito verso l’orizzonte.
Nei film di Leone i duelli avvengono in un’arena, sotto lo sguardo di tutti coloro che vi partecipano, solitamente disposti in modo circolare. Non sono più prove
decisive poiché non risolvono niente, ma fungono da
preludio ad altri duelli senza che si lasci intravedere una
meta finale. Il duello nel cinema di Leone diventa una
danza della morte, a cui assiste, per una volta, anche
una tribuna di lapidi e croci32. E da prova decisiva per
i personaggi della storia narrata, i duelli si trasformano in prova qualificante per lo spettatore, il quale, nel
guardarli, apprende tutti i codici di rappresentazione
dell’epopea del West. Sergio Leone lascia lo spettacolo
grottesco della fine del mito del West allo sguardo dello
spettatore in tribuna, come se gli eroi ormai degenerati
fossero dei gladiatori destinati comunque a morire, portando via con sé tutto il loro mondo.
Anche a Spoon River la morte non risolve nulla, e spesso alcuni personaggi osservano la morte di altri, come
se questa avvenisse nell’arena del villaggio. La reiterazione di ciascun racconto di morte, però, ci serve a ricostruire il mondo immaginario dove sono trascorse le
vite di coloro che sono deposti sotto le lapidi.
Negli stessi modi, la rappresentazione del West allestita
nei film di Leone, e concentrata nell’attimo del duello,
crea nella più larga cultura popolare italiana l’immaginario che descrive il passato mitico e perduto della
storia americana.
In ogni duello girato da Leone la morte viene danzata, dilazionata in mille spasmi e sguardi scanditi dalla
musica: è questo il momento in cui il suono si aggiunge
alle immagini della storia senza testimoni dell’America
raccontata agli italiani; è questo il luogo dove si viene
a creare l’immaginario sonoro dell’America che si può
solo ricordare.
Tanto più perché Leone, nel racconto di immagini e
suoni, tende a usare lo stile del melodramma. Dice Clint
Eastwood, protagonista di tre dei suoi film: “Sergio
Leone sentiva che il suono era molto importante, circa
il 40% del film… Leone mette una colonna sonora molto operistica, un sacco di trombe, e poi all’improvviso,
‘boom’! Fa piombare il silenzio e restano i cavalli che
sbuffano, e cose così. È molto efficace”33.
Ed è efficace proprio perché degli elementi extrasistematici, provenienti da un universo sonoro che non ci
appartiene, vengono messi a sistema in un testo, acquisendo un senso e diventando figure che rimandano a
un unico mondo immaginario in cui i suoni degli altri si
mescolano ai nostri. Basti pensare che dopo questi film
anche il marranzano, strumento popolare tipico della
cultura siciliana, riesce a dare l’idea del West, se unito
ritmicamente e armonicamente ai suoni degli spari, ai
borbottii del coro, alla chitarra elettrica, alla steel guitar, al banjo, al charleston, e ai timpani suonati come se
fossero gli zoccoli di un cavallo al galoppo.
L’artefice di quest’operazione di traduzione-invenzione
è il celebre compositore Ennio Morricone: il successo
mondiale di queste colonne sonore anche una volta separate dalle immagini a cui sono legate è testimonianza
del loro potere evocativo, della loro capacità di descrivere qualcos’ altro, che bizzarramente in realtà non esiste. In altre parole della coerenza del testo musicale che,
grazie alla pertinenza delle relazioni fra gli elementi che
compongono i suoi piani isotopici, è responsabile della
sua efficacia simbolica34.
Poste le premesse teoriche esposte sopra, proviamo ad
osservare da vicino il processo di traduzione, partendo
proprio dal brano più celebre, quello che potremmo
considerare la pietra angolare per la costruzione della
struttura dell’immaginario sonoro: il solo di tromba che
accompagna il duello finale fra il cowboy e il criminale
messicano in Per un pugno di dollari. Da questo momento
in poi il modello melodico infarcito di melismi che articolano nel tempo le tensioni di un intervallo di quinta,
suonato da una tromba, sarà associato inseparabilmente all’immagine del duello fra pistoleri.
Il punto di partenza di questa traslazione/traduzione
è proprio un tema della colonna sonora che Dimitri
Tiomkin scrisse per il film di Hawks Un dollaro d’onore:
un gruppo di mariachi suona questa melodia alla tromba accompagnandola con le chitarre. È un lamento funebre dedicato allo sceriffo Chance (J. Wayne) e ai suoi
aiutanti a guardia della prigione cittadina. Colorado,
uno dei vicesceriffi, interpretato da R. Nelson, spiega
ai suoi compagni: “Si chiama il deguello, il canto della
morte. I messicani la suonarono per quelli del Texas,
dopo averli imbottigliati ad Alamo”35.
Già Tiomkin trae spunto da un tema mariachi per scrivere una melodia originale arrangiata usando le forme
musicali tipiche di quella cultura tradizionale: e questa è
già una prima forma di traduzione. Morricone in seguito prende questo “oggetto sonoro” che è già diventato |
il canto funebre messicano |, ne mantiene la scansione
ritmica e gli elementi distintivi della struttura melodica
(pur riempiendola di melismi), lascia intatta quella armonica, lascia la parte del canto al timbro della tromba
e aggiunge il coro, gli archi e le percussioni per modulare la tensione dell’ascolto con un crescendo di intensità. Gli elementi melodici, ritmici, armonici e timbrici,
rilevati come forme del piano dell’espressione musicale
e raccolti in un unico fascio36, costituiscono con le loro
configurazioni le condizioni strutturali per la manifestazione dell’identità di una figura del discorso musicale.
Questa identità sarà tanto forte che Morricone dovrà
tornare ad utilizzare gli ottoni per eseguire il tema che
indica il duello finale persino in C’era una volta il West,
le cui partiture sono caratterizzate da ben altri timbri.
Il compositore italiano si sentirà per anni schiavo del
deguello. Ciò che qui ci interessa, però, è la dinamica
del processo di traduzione del senso della musica: un
elemento che appartiene ad un’altra cultura musicale,
il tradizionale messicano, è stato ridotto alla sua struttura melodica, armonica e timbrica; una volta ospitato
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
59
60
nell’universo culturale italiano è stato sistematicizzato,
ridotto alle norme della nostra grammatica musicale
per poterlo descrivere, per poterlo ospitare, e di conseguenza utilizzare per esprimere le passioni nel modo in
cui la nostra cultura le articola.
La musica dei western classici era piena di suoni sinfonici, grandi temi orchestrali melodizzati dalle sezioni
dei corni. Morricone, sotto la spinta di Leone, cancella
questi connotati e ricrea per il West una musica concreta, fatta di rumori che hanno lo stesso diritto di cittadinanza delle melodie popolari. Queste, a loro volta,
mantengono il loro senso originale e identificano i personaggi: Maurine McBain canta il tradizionale irlandese Danny Boy prima di essere uccisa all’inizio di C’era una
volta il West.
A livello processuale, la musica americana diventa uno
stilema, che viene svuotato e nuovamente riempito di
senso secondo la struttura della cultura musicale italiana. È interessante notare che la traduzione non avviene
soltanto trasportando “al di qua” del confine alcuni elementi extrasistematici, ma anche lanciando “al di là” di
esso alcune forme tipiche della nostra cultura musicale.
Concentrandoci sul film del 1968, non solo possiamo
rilevare il dispositivo narrativo tipico del melodramma
che associa ad ogni personaggio una melodia, che si
unirà alle altre nel contrappunto del coro sul finale dell’ultimo atto (è quello che succede nel duello fra Frank
e Harmonica). Ma possiamo anche notare che il tema
principale del film, As a judgment, è formalmente concepito come un italianissimo adagio barocco per archi e
strumento solista37, per poi diventare il roboante tema
del duello finale con coro, orchestra e chitarra elettrica
dal suono saturato a fare da solista. Per non parlare poi
della cantabilità del Tema di Jill affidata alla voce soprano di Edda Dell’ Orso, che Piovani e De André terranno come riferimento fondamentale per il loro lavoro.
È proprio questo brano musicale ad accompagnare
lo schiudersi degli occhi della donna di New Orleans
prima sulla stazione di Flagstone, piccolo villaggio di
frontiera brulicante di gente, e poi sui panorami della
Monument Valley. L’introduzione del Tema di Jill, accennata da una melodia armonizzata per terze e suonata all’unisono da un clavicembalo e una celesta su un
pedale di archi, sarà un ottimo spunto per Piovani e De
André per la scelta dei suoni con cui introdurre Il suonatore Jones, e porre il finale epitaffio musicale all’epopea
degli abitanti di Spoon River.
E il Tema di Jill ha già fatto da epitaffio all’epopea americana sul finale di C’era una volta il West, accompagnando verso l’orizzonte, in profondità di campo, l’ultimo
eroe destinato a svanire, mentre in campo medio la
ferrovia è arrivata nel punto in cui nascerà il villaggio
di Sweet Water. Mentre “il West” scompare e i sepolcri
del ricordo immaginato si richiudono, la musica suona
trionfale, con le vertiginose altezze del canto del soprano, per rimanere impressa come memoria sonora di un
mondo remoto.
4. Dare la voce ai fantasmi:
un immaginario musicato
Veniamo dunque all’oggetto centrale della nostra analisi. Che De André e Piovani per dare il suono al villaggio
di Spoon River si siano riferiti alle musiche che avevano narrato il West, facendogli da lapide, è un’ipotesi
che viene supportata non solo da citazioni e riferimenti
disseminati lungo tutti i brani del disco. C’è anche il
fatto storico: fra i musicisti chiamati per la sua realizzazione c’è anche lo stesso coro diretto da Alessandro
Alessandroni, l’uomo del celebre fischio dei temi di
Morricone, oltre che chitarrista per la colonna sonora di Per un pugno di dollari, insieme alla voce “feticcio”
di Edda Dell’Orso. Da parte di De André c’è anche il
precedente della Ballata degli impiccati38, scritta già con
G. Bentivoglio, che si richiama nell’arrangiamento al
sound degli spaghetti-western morriconiani, con la
tromba mariachi, le chitarre folk e le particolari configurazioni ritmiche ai bongos.
Chiaramente i nostri autori non si fermano qui, ma pescano a piene mani dal sound originale di certa musica
americana: prima di tutto il country, nella sua versione
blue grass e honky tonk, e in quella riletta da un gruppo
come i Byrds, affacciatisi anche alla psichedelia per
merito del loro componente David Crosby. E poi c’è il
folk, con i suoi timbri e il tipico stile delle sue ballate. E
ancora i suoni del progressive rock degli anni ’60, con i
suoi esperimenti di sovraincisione e spazializzazione del
suono, gli assolo di batteria e organo, le digressioni che
crescono sulle fratture della classica forma canzone.
A questi stilemi si aggiunge ciò che già aveva caratterizzato i precedenti lavori di De André, soprattutto gli elementi della antica ballata di derivazione anglo-irlandese, ascoltabili ad esempio in Leggenda di Natale39, e quelli
della tradizione popolare italiana che contrassegnano
l’album Vol. 340.
Stefano Jacoviello · Spaghetti country-western, valzerini e fratture psichedeliche. Ovvero: come i fantasmi di Spoon River, quando ebbero la voce, cantarono all’italiana.
Non si tratta però qui di suonare “in stile”, o di fare un
disco che suoni come un progressive rock italiano. Una
bonne distance separa questi suoni dai compositori, che
si permettono di utilizzarli come tessere di un mosaico
per farli diventare altro da loro.
L’aspetto interessante del lavoro creativo di De André e
Piovani sta, infatti, nel raccogliere in un unico universo sonoro questi suoni dalle provenienze più disparate;
metterli a sistema creando così, attraverso la procedura di testualizzazione, un immaginario sonoro; infine,
utilizzare il senso di questi suoni per costruire dei testi sincretici, le canzoni, in cui la musica costituisce la
scenografia sonora su cui gli attori, divenuti tipi astratti
rispetto agli originali di Masters, parlano attraverso i
nuovi versi per raccontare un’esistenza esemplare.
È così che Piovani e De André donano il suono all’immaginario di Spoon River, musicandolo. Il discorso dei
suoni garantisce anche la coesione testuale dell’intero album, che assume la forma della suite. Escluso il
Suonatore Jones e Un Ottico, che mostrano in modi diversi
una coesione testuale interna molto forte, gli altri brani del disco necessiterebbero di un altro arrangiamento
per uscirne: è successo così a Un Giudice, ad esempio.
Con l’analisi ci accorgeremo facilmente che gli arrangiamenti originali perderebbero la loro funzione discorsiva qualora i brani venissero isolati, ed è per questo
che probabilmente De André non li inserì nelle scalette
dei suoi concerti: questi brani vanno suonati in ordine
e senza interruzione dall’inizio alla fine. Questa caratteristica peculiare ci suggerisce che, pur essendo per le
categorie del mercato un disco “pop”, questo lavoro è
davvero qualcosa di più.
Nell’introduzione di Dormono sulla collina, si ascoltano
subito i timbri “western”: i mandolini, la chitarra elettrica, il cluster in tessitura alta degli archi in crescendo che commenta tutte le scene di tensione nei film di
Leone, il rullante, le campane. Mentre il clavicembalo
modula il tema secondo le successioni armoniche in cui
è riconoscibile lo stile compositivo di Piovani: Do minore/Mi bemolle minore/Re minore/La minore.
Come l’introduzione di qualsiasi suite di brani, la prima
canzone allestisce lo strumentario necessario all’ascoltatore per comprendere il discorso del testo musicale.
Non vengono presentati soltanto elementi timbrici, cui
si affida gran parte delle funzioni evocative che rimandano ad un mondo esterno ai confini del testo; ma anche elementi sintattici e grammaticali, come ad esempio la progressione armonica di terza minore, che ritroveremo più avanti in altri brani, con funzione anaforica
che garantisce la coesione del testo nella sua globalità.
In Dormono sulla collina accompagnano la voce di De
André i timbri della steel guitar, della slide guitar, e poi
l’oboe, i flauti diritti e traversi, gli arghilofoni, l’armonica: tutti suoni di strumenti a fiato che avevano un loro
senso proprio nel mondo sonoro di Morricone, e che
riescono a mantenerlo perché, nel processo di traduzione, gran parte delle relazioni sistemiche che li legano
sul piano dell’espressione del testo rimangono intatte.
Ogni suono mantiene più o meno il suo ruolo originario nella costruzione della partitura e, di conseguenza,
dell’immaginario.
Un matto (dietro ogni scemo c’è un villaggio), con il suo tempo binario, ci trasporta subito nelle atmosfere country,
utilizzate nei film western per rendere l’ambiente dei
villaggi, come nel titolo, con i bar dove la gente si incontra intenta in mille attività. Gli strumenti musicali
sono quelli tipici delle band di blue grass: la steel guitar,
il banjo, il mandolino, il violino suonato alla maniera
dei fiddlers e una tastiera elettrica che mima il suono di
un honky tonk piano. Lo stile di questo brano richiama
molto il country-rock dei Byrds41.
La forma è quella tipica della country ballad: dividendo
la strofa di sei versi in tre distici, ad ognuno di essi viene
assegnata una frase musicale di otto battute, secondo lo
schema A-B-BI 42.
Ad ogni strofa segue un intermezzo strumentale che la
distingue, e dopo la seconda delle quattro strofe la tonalità sale di mezzo tono (dal Si bemolle maggiore al
Si maggiore): ciò dimostra che l’impianto strofico della
canzone narrativa viene rigidamente rispettato.
Un giudice comincia con un arpeggio di chitarra a dodici corde caratterizzato da una legatura e una configurazione ritmico-melodica che richiama fortemente
il tema di testa di Per un pugno di dollari. Al fischio di
Alessandroni qui però si sostituisce un’ocarina. Il pitch
bending della chitarra, così come il suo fraseggio articolato su scale pentatoniche, rimanda ancora allo stile country, mentre la canzone si sviluppa inaspettatamente su
un ritmo di polka. Il bridge strumentale, che riprende
la melodia del flauto dell’introduzione, divide ancora a
metà le quattro strofe distinguendo le prime due, in cui
il personaggio si presenta, dalle altre due in cui narra
la vicenda della sua vendetta. Tuttavia l’articolazione
musicale della strofa comincia a complicarsi rispetto
a quella tradizionale della country ballad ritrovata nel
brano precedente: armonicamente, una serie di cadenze sospese spinge la tensione in avanti verso per verso,
fino alla cadenza perfetta che chiude la strofa (secondo
lo schema A-B-C-B-C-B-A).
Il brano successivo, introdotto da un tamburo funebre,
si presenta come una tipica murder ballad inglese. De
André gioca però con il modello stilistico: mentre nell’antico originale si riportano usualmente le ultime parole del condannato a morte che racconta il suo crimine
ed esprime il pentimento con una massima morale sul
valore della vita, il Blasfemo invece non ha nulla di cui
pentirsi, e va inevitabilmente a morire denunciando la
vanità del giardino in cui siamo costretti a sognare. La
forma è quella strofica pura della ballata tradizionale
nord-europea, caratterizzata dalla ripresa dell’ultimo
verso a chiusura di ogni stanza per tornare armonicamente sulla tonica.
Le strofe si susseguono melodicamente uguali una all’altra, mentre gli strumenti si aggiungono ad uno ad
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
61
62
uno in stile concertante: la chitarra, i mandolini, il clavicembalo, gli archi, l’oboe, l’arghilofono, contrappuntano il tema al canto accompagnandolo con una variazione ciascuno.
In Un malato di cuore la forma della folk ballad americana degli anni ’60 si sviluppa su una metrica complessa
che alterna battute di 4/4 ad altre di 2/4, adattandosi a
quella dei versi. La forma strofica ritornellare, che fino
ad ora si è mantenuta più o meno fortemente coesa,
qui cede per la prima volta all’inserimento di una parte
intermedia, eseguita in rubato. È un passaggio simile
ad una cadenza di un’aria da melodramma, che serve
ad avvicinare il personaggio sulla scena allo spettatore,
come per potergli dare del “tu”.
Alla orchestrazione tipica di un gruppo folk-rock della costa californiana (basso, chitarra, piano e batteria)
si aggiunge in background per la prima volta il timbro
da soprano della voce di Edda. Ritroviamo ancora il
clavicembalo, suonato però secondo gli stilemi della
musica pop rock usati da Piovani come da molti altri
contemporanei compositori per il cinema43, e l’organo
elettrico.
Al termine di questo brano troviamo il primo intruso
musicale. Non mi sono soffermato sul riconoscimento
dell’identità e della provenienza degli elementi di origine eurocolta che cominciano ad apparire da qui in
poi. Non è importante ricercare filologicamente cosa
siano, anche perché non penso che siano vere e proprie
citazioni con la necessità di un rimando extratestuale.
La leggera differenza di intonazione della chitarra che
esegue il brano barocco fa presupporre addirittura che
il materiale non sia stato suonato per l’occasione del disco, ma che sia stato missato in seguito a partire da materiale registrato. Basta quindi riconoscere gli “intrusi”
in quanto frammenti grazie al loro basso grado di sistematicità: porzioni di altri testi che si vanno ad installare
nelle crepe del nostro testo che, pur avendo mostrato
finora una grande coesione strutturale, si avvia alla consunzione che terminerà nel silenzio dell’ultimo tocco di
clavicembalo.
I gruppi di terzine del frammento pianistico scandiscono in 12/8 il tempo di giga di Un Medico. Anche qui le
ascendenze anglo-irlandesi si fanno sentire, ma vengono subito offuscate da un gran lavorio armonico e dall’intermezzo di forte impatto retorico che nei primi due
versi, che espongono il punto di svolta nella narrazione
(E allora capii, fui costretto a capire, che fare il dottore è soltanto
un mestiere…), presenta uno stilema ritmico e armonico
tipico della song da musical: la scansione ritmica ciclica
in terzine dell’arpeggio di chitarra si ferma e lascia il
posto a quella per semiminime in 4/4 degli accordi al
pianoforte, mentre l’attenzione dell’ascoltatore si sposta
sui suoni senza decadimento dell’organo e degli archi,
che invadono lo spazio e hanno qui l’effetto di fermare
il tempo. Un vero trattamento teatrale!
La ripresa del gioco pianistico introduttivo si tronca
sulla dominante per introdurre prontamente la tonalità
del brano successivo, ricordandoci che i brani sono tutti
legati fra loro in un unico testo. Non si può certo dire
che l’impianto tonale in Non al denaro non all’amore né al
cielo sia articolato con la stessa complessità di una raccolta romantica di lieder, tuttavia tale dispositivo retorico è rilevabile soprattutto nella sequenza degli ultimi
quattro brani.
Per Un Chimico ritroviamo ancora il tempo in due della ballata “west coast”, la sua tipica forma strofica, i
classici strumenti musicali del genere. Al di là dello
stupore per la bellezza solare del brano, qui dobbiamo
notare l’entrata in scena di un protagonista: mentre De
André pronuncia i meravigliosi versi della quinta strofa
(Primavera non bussa, lei entra sicura, / come il fiume lei penetra in ogni fessura, / ha le labbra di carne, i capelli di grano, /
che paura, che voglia, che ti prenda la mano. / Che paura, che
voglia, che ti porti lontano) in sottofondo entra la voce di
Edda Dell’Orso, cui viene affidato il tema che ricomparirà al canto alla fine del disco, come lapide sulla fine
del tempo raccontato, così come era stato per il film
di Sergio Leone. Anche se in modo più debole che nel
vero Finale, la comparsa della voce del soprano segna
anche qui una fine: con la coda di Un Chimico termina
anche la suite “country”, quella legata ai suoni dell’immaginata America della frontiera.
Sullo sfumare delle chitarre irrompe dunque l’orchestrina del valzerino campagnolo italiano44, che trasporta il
banco di Un Ottico nel bel mezzo di una fiera di paese,
facendolo assomigliare al carretto di un ciarlatano, venditore di elisir e pozioni come il precedente medico. Ma
se Dippold, l’ottico di Spoon River, celava l’ingenuo
sogno di riuscire a fabbricare occhiali che facessero vedere il mondo migliore di quel che è, la voglia di vedere
la luce nell’ottico di De André si trasforma in desiderio
di raggiungere mondi paralleli, varcando le porte della
percezione.
Qui si fa interessantissima la relazione fra parole e musica per la costruzione di universi finzionali, che si susseguono uno all’altro grazie alle strategie enunciative,
oltre che alle selezioni timbriche. La voce del primo dei
clienti, che parlano in prima persona, viene reverberata e sovraincisa, e il suo attacco viene disposto sull’asse
temporale in modo che si ottenga l’effetto di uno spostamento del punto di ascolto. È come se l’ascoltatore si
trovasse ad avere due suoni che indicano ritmicamente l’accento forte, ma che sono perfettamente uguali,
pur non rispettando la ciclicità ritmica della battuta.
L’effetto viene coadiuvato dalla poliritmia ottenuta grazie agli anticipi sincopati della figura ritmica scandita
dal piano elettrico, e dagli accenti della linea di basso.
La prima sezione viene chiusa da una specie di cadenza
per chitarra elettrica che ricorda quelle violinistiche vivaldiane dei Concerti delle Stagioni.
La seconda sezione presenta tutto un altro universo sonoro: un violoncello suona su un arpeggio di pianoforte,
mentre il coro dispiega le parti dell’armonia che oscilla
su un intervallo di III minore fra il La minore e il Do
Stefano Jacoviello · Spaghetti country-western, valzerini e fratture psichedeliche. Ovvero: come i fantasmi di Spoon River, quando ebbero la voce, cantarono all’italiana.
minore, riprendendo il modulo armonico suonato dalle
trombe nella sezione precedente. La voce del secondo
cliente viene filtrata con un effetto eco, e l’elaborazione
ritmica del canto crea degli effetti di fono-iconismo: le
terzine che articolano la parola “cercano” riferite allo
scorrere delle acque, e la reiterazione di “cieli” riproducono l’effetto di duplicazione ottenuto con mezzi artificiali nella prima sezione, aggiungendovi un rimando
ad oggetti del mondo naturale. Attraverso l’organizzazione dei suoni in relazione alle parole si riescono a
visualizzare così delle immagini di mondi totalmente
fantastici.
La terza sezione riprende da capo la prima, aggiungendo
le frasi sottovoce del coro, distribuite sui canali stereo.
La sezione termina in un duetto di batteria e organo
che improvvisano un assolo, coperti gradualmente dal
cluster in tessitura acuta degli archi, che cresce fino
a segnare, con il suo arresto, il passaggio alla sezione
successiva. Qui la voce viene duplicata e sovrapposta,
recuperando un effetto tipico della psichedelia californiana di quegli anni. L’organo elettrico è in linea con
quel sound, e accompagna il canto fino alla ripresa del
tempo di valzer, chiuso irruentemente dal fraseggio dei
mandolini.
Il lavoro sul suono operato in questa canzone rimanda
generalmente allo stile della musica beat, e potrebbe riferirsi ai Byrds di Younger than yesterday (1967), al Frank
Zappa di Chunga’s revenge (1970), ai Deep Purple di The
Book of Taliesyn (1968), o ai Beatles di Sergent Pepper’s
(1967). Gli effetti di senso dati dalla duplicazione della
voce ci mandano dritti agli esperimenti di Steve Reich
con la celebre composizione per nastro Come Out (1966).
Ma non serve a niente cercare le filiazioni, poiché la
cosa interessante è che Piovani e De André usano questi
suoni in un’ottica da compositore, considerandoli come
oggetti sonori dotati di un senso da manipolare, per
renderli strumenti espressivi al proprio servizio. I testi
di partenza potrebbero essere ricercati solo al fine di
scoprire quale sia stata la loro struttura del senso prima
della traduzione, ma ciò non aggiungerebbe nulla sulla
conoscenza del testo che si sta analizzando.
Dopo il colpo di charleston che chiude il ritmo di valzer dell’Ottico, sul fondo rimane il pedale di archi su cui
andranno ad esporre la melodia, come abbiamo già
detto, gli stessi timbri dell’introduzione del Tema di Jill,
per farci presagire il finale prima di introdurci all’ultima
canzone che, guarda caso, ritrae la fine di chi ha suonato fino all’ultimo istante.
Il suonatore Jones è una canzone che appartiene totalmente allo stile di De André, il quale forse ha voluto lasciare
per sé il canto del personaggio a cui potersi sentire intimamente legato.
Forse per questo motivo la musica del brano è completamente al servizio della parola, tanto da rendere
presente, quando viene enunciato, il suono del flauto
con un trio di flauti dolci e tin whistle, lo strumento che
Jones suona nella versione del cantautore genovese.
E mentre la vita del suonatore finisce con “un ridere rauco,
e ricordi tanti e nemmeno un rimpianto” la tonalità modula
dal Mi minore al La maggiore, lasciando spazio alla
voce del soprano, che con il tema dà il saluto in proscenio all’ultimo personaggio scomparso, come una soave
pietra tombale su un passato che oramai non potrà essere mai più narrato.
5. … e finirono tutti cantando all’italiana
È ovvio che il Western classico americano non è il West,
tanto quanto Spoon River non è Petersburgh, Illinois.
Ma ambedue sono esempi di un modo di ricostruire il
passato con una narrazione, creando un sistema dell’immaginario attraverso un processo di traduzione.
Esistono certo delle analogie fra l’Antologia e i film di
Leone nel modo di raccontare la morte, scandendo il
suo tempo come una danza. Ed è analoga anche la funzione del racconto di morte attraverso il quale, rispettivamente per il lettore e per lo spettatore, si descrive il
mondo in cui sono trascorse le esistenze intrecciate di
coloro che vanno a morire. Così Masters descrive il passato della sua gente, gli Americani, attraverso le categorie culturali e i sistemi di valori che da quel mondo provengono e che sembrano irrimediabilmente destinati a
sparire. E allora lo scrittore tenta di riaprire le tombe,
per carpire l’ultimo afflato di ognuno dei suoi progenitori, per scoprirne la misera e commovente umanità:
non ci sono gloriosi inni ai defunti, ma solo compianti.
Leone tenta di descrivere lo stesso passato della storia
americana ma, non avendo vissuto quei luoghi e quella
cultura, è costretto come novello Salgari a descriverlo all’italiana, utilizzando le categorie del suo sistema
culturale. Leone traduce in italiano l’immaginario già
costituito del western americano, perdendo ormai qualsiasi relazione con la Storia.
De André, pur sentendo vibrare ancora le parole dei
defunti di Spoon River, si accorge delle costrizioni che
imbrigliano i ricordi, e della difficoltà di condividere
la memoria con chi si sente vicino al di là delle radici culturali. Con l’approccio di un artista, il cantautore
decide allora di sfidare i lacci della traduzione dei versi
di Masters, e sceglie di farne delle canzoni. A De André
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
63
64
però non basta tradurre le parole, che muoiono nella
voce di singoli individui, ma pensa, attraverso il potere
della canzone, di poter tradurre un intero mondo. E se,
per avvicinare gli ascoltatori alle coscienze dei defunti
americani, sceglie di cancellare dalle parole ogni traccia di America, in modo da far guadagnare ai fantasmi
di Spoon River l’universalità dei personaggi di una fiaba morale, per la musica decide di partire proprio dai
modi in cui, con suoni immaginifici, l’America era stata
raccontata.
Con Non al denaro non all’amore né al cielo De André riapre
per un’ultima volta il processo di traduzione. Riduce le
poesie di Masters alle loro strutture narrative profonde,
per poi rivestirle, tramite la messa in discorso, di nuove
figure del mondo, creando non solo nuovi personaggi,
ma aprendo la strada a nuovi percorsi interpretativi.
Per la musica invece, colloca il suo punto di partenza
all’interno del sistema dell’immaginario musicale delineato dal lavoro di Morricone, per poi allargare i suoi
confini con acquisizioni disparate che danno frutto a
nuove traduzioni. Lo fa fino a rendere autonomo il nuovo sistema ottenuto, pur riuscendo a mantenere espliciti
gli elementi di identità del testo originale che permettono di riconoscere ancora il risultato del suo lavoro
nei termini di una traduzione. Tuttavia, nel frattempo,
attraversando i progressivi slittamenti di senso delle ripetute traduzioni, la testimonianza del passato è andata
disperdendosi irrimediabilmente, ed è rimasta lì, sotto
le lapidi della collina.
Alla fine restano solo le voci donate ai fantasmi, che
non poterono far altro che cantare. All’italiana.
Note
*
Questo saggio è stato elaborato originariamente per la giornata di studi inaugurale del “Centro di Studi F. De André”,
presso l’Università di Siena, il 13/12/2004, dedicata al disco Non al denaro, non all’amore, né al cielo, e alle sue relazioni
con l’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters. Ringrazio
quindi Gianfranco Marrone per aver accolto all’interno della
presente pubblicazione questa versione lievemente modificata. Mi scuso in anticipo con i lettori semiologi per le brevi
parti teoriche, che potranno essere saltate agevolmente senza
rimanerne annoiati, ma che ho deciso di non eliminare per
fornire tutti gli altri lettori di espliciti riferimenti teorici che
sono alla base delle analisi.
1
Cotroneo, Roberto, saggio introduttivo a: De André, F.,1999,
pag. VIII
2
Idem, XII
3
Raccontate rispettivamente in “Dolcenera” e “Le acciughe
fanno il pallone”, testi e musiche di F.De André e I. Fossati, da
Anime Salve, BMG-Ricordi,1996; TCDMRL 74321-392352
4
Produttori Associati, 1971; PA/LPS 40
5
Per esplicitare maggiormente il mio riferimento possiamo
identificare sotto il termine ombrello della “semiotica strutturale” la linea storica del pensiero strutturalista che, attraversando il Novecento, parte dalle teorie di F. de Saussure e di
E. Benveniste, passa attraverso la linguistica di L. Hjelmslev
per arrivare alla sua riformulazione in una teoria semiotica
da parte di A.J. Greimas. A questa linea immaginaria bisogna
affiancare altri due rami che ne hanno decisamente intrecciato il percorso: da un lato l’esperienza dei formalisti russi, la
linguistica strutturale di R. Jakobson e le teorie della cultura di
J.M. Lotman, e dall’altro l’antropologia di C. Lévi-Strauss.
6
In ogni disciplina con la vocazione ad una epistemologia forte, il metalinguaggio si costituisce tramite i continui processi
di analisi ed è il punto di arrivo dell’intera riflessione teorica.
Mi si permetta il paragone, fatti i dovuti distinguo di rilevanza
scientifica, ma privare la semiotica strutturale del suo metalinguaggio equivale a privare l’algebra del potere di esprimere
un concetto mediante un’equazione. Il bello della semiotica
strutturale è che, come l’algebra, è uno strumento che porta
ad una visione del mondo, e come l’algebra si può imparare,
discutere, falsificare.
7
Nell’introduzione a De André, 1999, pag. VI, Cotroneo sostiene gli stessi argomenti a partire da presupposti diversi: “attraverso una lente fatta di sudditanza verso la cosiddetta cultura ‘alta’ ci si è prima inventati un contenitore ‘basso’ dove
mettere i cantautori e altro ancora. E poi si è polemizzato
dicendo che quel genere ‘basso’ inventato, guarda un po’, dai
suoi estimatori, aveva tutte le carte in regola per affiancarsi al
genere ‘alto’”.
8
S.K. Langer, Feeling and Form,Scribner, New York 1953, (tr.it.
Sentimento e forma, Feltrinelli, Milano 1965, vedi il capitolo “Il
principio dell’assimilazione”, pagg. 169-189)
9
“Le sens des paroles chantées n’est plus le même que celui qu’avaient ces mêmes paroles avant leur mise en musique… mais celui que leur confère la phrase musicale”, B. de
Schloezer, Introduction à J.S. Bach, Bibliothèque des idées, NRF,
Paris 1947, pag. 273, cit. in Ruwet 1972, pag. 42
10
“Sono stato definito “il poeta dei giovani”, ma non sono
d’accordo. Un conto è la canzone, un conto la poesia. Ho cominciato a scrivere canzoni per esprimere qualcosa, ma anche
per divertire e per divertirmi”. De André 1999, pag. 23.
11
Ruwet 1972, pag. 38
12
Ci riferiamo qui al concetto di linguaggio come sistema
suscettibile di infiniti processi, espresso da R. Jakobson, ed
esposto in maniera organica in italiano nel suo Saggi di linguistica generale, Feltrinelli, Milano 1966. Il pensiero sulla musica
e sulla poesia di N. Ruwet prende le mosse proprio dalle idee
di Jakobson.
13
Ruwet, N. 1972, pag. 35
14
De André 1999.
15
Come per J. J. Rousseau, secondo cui il segno musicale è
segno memorativo. Vedi la voce “Musique” in Dictionnaire
de Musique (1768), in Œuvres complètes, vol.5, Gallimard, Paris
1995, pag. 924.
16
Ruwet 1972, pag. 37
17
Da ora in poi non useremo più il termine testo per indicare
la parte verbale della canzone, ma lo considereremo nella sua
accezione semiotica.
18
Mi riferisco qui all’inveterata convinzione di stampo estetologico che la musica non possa significare che se stessa, essendo un “sistema chiuso” che non rimanda ad altro che alle sue
forme. Accettare radicalmente tale posizione significherebbe
escludere la musica dai fatti di cultura, poiché la si considererebbe non interpretabile, in contrasto con l’evidenza che la
musica ha sempre un senso per chiunque, anche se non è mai
lo stesso.
19
In J. J. Nattiez, uno dei più importanti semiologi della mu-
Stefano Jacoviello · Spaghetti country-western, valzerini e fratture psichedeliche. Ovvero: come i fantasmi di Spoon River, quando ebbero la voce, cantarono all’italiana.
sica, il termine “discorso musicale” si riferisce, coerentemente
con la sua teoria, al discorso sulla musica che, cercando di essere
un metalinguaggio nel descrivere in termini semiologici il fatto musicale, è suscettibile a sua volta di un’analisi semiologica.
“La semiologia dei parametri musicali è dunque semiologia
degli oggetti trattati e semiologia del discorso che li descrive”
(Nattiez 1987, pag. 6).
Altrove, soprattutto in etnomusicologia, si usa a volte il termine “discorso musicale” per riferirsi sinonimicamente alle regole della grammatica che descrivono l’organizzazione della
musica praticata all’interno di una cultura musicale.
Nell’ottica greimasiana, invece, il livello del discorso è quello
più superficiale del percorso generativo, e rende conto degli
effetti di senso che seguono all’atto di enunciazione. La categoria del discorso è relativa quindi al testo, e il discorso musicale è discorso della musica, e le sue categorie ne descrivono
l’articolazione sintattica e semantica. Per un esame più approfondito del concetto di discorso musicale in relazione alla
musica vocale, vedi Jacoviello 2004. Per una teoria semiotica
strutturale del discorso musicale, Jacoviello 2007.
20
Note di copertina al disco Non al denaro, non all’amore, né al
cielo, riportate in De André 1999, pag. 114.
21
Lotman 1974, pag. 24
22
Per una rapida spiegazione della teoria lotmaniana della
traduzione culturale, vedi Lotman 1994, il capitolo “Il dialogo
plurilingue”, pagg. 29-34
23
È vero che un’opera artistica non viene quasi mai concepita
specificamente per un target preciso. Tuttavia Non al denaro…
è evidentemente una traduzione, operazione familiare per De
André, che aveva già tradotto Brassens in modo interlineare.
Non bisogna inoltre dimenticare che è un disco, quindi un
prodotto legato alle necessità del mercato discografico, e allora come oggi l’Italia non era solita esportare. Perciò possiamo
pacificamente pensare che il lavoro di De André, per quanto
tendente all’astrazione dei tipi ritratti, fosse eminentemente
rivolto ad un pubblico di ascoltatori italiani.
24
Red Harvest, di Dashiell Hammett, pubblicato nel 1929, e
tradotto in italiano con il titolo Piombo e sangue, (coll. Narratori
della Fenice, Guanda, Milano 1994)
25
Introduzione all’intervista con Leone per: Frayling, C., Un
pugno di dollari, Cappelli, Bologna, 1979, cit. Frayling 2000,
pag. 138. Fa al caso nostro ricordare anche che una prima giustificazione (falsa) che Leone diede per scagionarsi dall’accusa
di plagio fu data nel dichiarare di aver trasposto nel suo film
la stessa struttura narrativa di Arlecchino servitore di due padroni,
di C. Goldoni (1746): un elemento sistematico della cultura
italiana la cui struttura narrativa si trova all’intersezione fra la
sfera culturale americana e quella giapponese, permettendo la
traduzione dei vari aspetti da uno all’altro universo culturale.
26
Ferrini 1974, pag. 105.
27
Deleuze, G., L’Image-mouvement, Éditions de Minuit, Paris
1983, (tr. it. L’immagine movimento, Ubulibri, Milano 1984),
cap. IX, in particolare pagg. 167-177. Lo schema SaS1 sta per
Situazione-azione-Situazione conseguente.
28
Franco Ferrini, relativamente alla funzione del cinema di
John Ford scrive: “Quale poteva essere la risposta alla domanda fatale: che cos’è un Americano? L’unica risposta parve
essere nell’azione. Sarebbe stato costruendo il paese che gli
Americani avrebbero definito se stessi. Quel luogo sarebbe
stato riaperto di continuo e avrebbe perso il suo nome di frontiera, un fatto di geografia e di storia non meno che un mito”,
Ferrini 1974, pag. 118
29
Lo stesso titolo, esplicativo con il suo “C’era una volta”, appare solo alla fine del film, stagliandosi sulla linea dell’orizzonte della Monument Valley verso cui Harmonica, l’ultimo eroe,
si avvia per scomparire nel nulla, portando con sé il corpo già
cadavere di Cheyenne. In C’era una volta il West la fine del mito
viene rappresentata anche attraverso la consunzione e la marcescenza dei corpi, dalle morti lente, cadenzate o rimandate
dei suoi personaggi.
30
Questo è il modello caratteristico della “piccola forma dell’immagine azione” (a-S-a1: azione-situazione-azione conseguente): vedi Deleuze, G., 1984, cit., cap. X, in particolare
pagg. 187-191
31
Già presente nel cinema di Hawks, ad esempio nei personaggi di Il grande sonno (The Big Sleep, 1946). Applicando la
degenerazione alla piccola forma dell’immagine azione si
individuerebbe, secondo Maurizio Grande, la struttura del
genere noir.
32
Mi riferisco alla scena finale di Il buono, il brutto, e il cattivo.
33
Frayling, C., Clint Eastwood, Virgin, Londra 1992, pag. 6162, cit. in Frayling 2000, pag. 163.
34
Per il suo quarto ed ultimo film sul West, Sergio Leone era
riuscito per la prima volta ad organizzare le fasi della realizzazione in modo che la musica fosse già pronta prima di cominciare a girare. Il regista preparava gli attori, ed evidentemente
la troupe, a girare ogni scena facendo ascoltare la musica che
vi sarebbe stata montata. Ciò conferma l’ipotesi che la musica
di C’era una volta il West sia stata scritta già con l’intenzione di
diventare un modo per narrare un mondo, facendolo all’italiana, utilizzando le proprie forme espressive per descriverlo.
35
L’ascolto di questa musica permette al personaggio interpretato da D. Martin di superare i tremori datigli dal passato
di alcolista, e ritornare a sparare con precisione.
36
Nel metalinguaggio semiotico (vedi Greimas 1984) questi
elementi costitutivi del piano dell’espressione vengono definiti “formanti plastici”, e si raccolgono nella struttura di una
“configurazione plastica”. Questa struttura è logicamente precedente al senso figurativo, di cui la configurazione si riveste
dopo che i formanti hanno svolto il loro ruolo di funtivi nella
relazione che presiede alla semiosi fra il piano dell’espressione
e quello del contenuto.
37
La configurazione discendente dei bassi in tonalità minore, alcuni frammenti della condotta melodica degli archi, ma
soprattutto la scansione ritmica cadenzata (la cui configurazione può essere reputata una trasformazione), ci rimandano
suggestivamente ad uno dei più celebri e affascinanti duelli
della storia della musica: quello mozartiano fra Don Giovanni
e la Statua del Commendatore (Don Giovanni, 1787, Scena
XV, in Mozart, W.A., Neue Ausgabe sämtlicher Werke, Bärenreiter,
Kassel 1991, vol. VIII, pag. 425-426). Non è certo il caso di
porre il problema dell’autenticità, a mio avviso del tutto privo
di interesse in questi casi, quanto invece sembra importante
rilevare l’importanza dei meccanismi di trasposizione nella
costituzione dell’universo musicale di una cultura.
38
In Fabrizio De André, Tutti morimmo a stento, Bluebell records, 1968
39
In Fabrizio De André, Tutti morimmo a stento, Bluebell records, 1968. Il testo di questa canzone è già un primo tentativo
di trasposizione, essendo ispirato a Le Pére Noël et la petite fille di
G.Brassens, ma non una consueta traduzione.
40
Bluebell records, 1969
41
Sweetheart of the Rodeo, Columbia, 1969
42
Assomiglia un po’ alla forma antifonale tripartita del blues,
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
65
dove ad una chiamata segue una risposta e ad esse segue una
terza frase a mo’ di conclusione. Questa organizzazione sintagmatica vale sia per la musica che per le parole.
43
Si ricordano in quegli stessi anni, per il tipo di timbri utilizzati e per l’uso di forme che provengono prettamente dal genere pop, le musiche che Fiorenzo Carpi scrisse per il celebre
Pinocchio di Luigi Comencini (1972) e per Diario di un maestro, di
Vittorio De Seta (1972). Per il folk, preso dal vero e riportato
nel cinema italiano, ancora il solito Morricone con La Ballata
di Sacco e Vanzetti (1971), cantata da Joan Baez per il film di
Giuliano Montaldo. Per uno sviluppo di queste sonorità in
ambito progressive rock si rimanda a Frank Zappa, Hot Rats
(1969)
44
La forma musicale popolare del valzerino toscano è la
stessa già utilizzata da De André per S’I’ fosse foco, in Vol. 3
(1969), solo che qui, per compensare la funzione di costruzione dell’immaginario che la musica ha in questo lavoro, c’è
un’enorme attenzione al realismo: gli strumenti ci sono tutti,
dal clarinetto al flauto al bombardino, dalla fisarmonica alla
chitarra al violino, dalla grancassa ai piatti, con i mandolini
che la fanno da padroni e chiamano alla danza.
Bibliografia
66
De André, F., 1999, Come un’anomalia, (saggio introduttivo e
cura dei testi di R. Cotroneo) Torino, Einaudi.
Ferrini, F., 1974, “John Ford”, Il Castoro Cinema, IX, Firenze,
La Nuova Italia.
Frayling, C., 2000, Sergio Leone. Something to do with death,
London-New York, Faber and Faber Limited; trad.
it. Sergio Leone. Danzando con la morte, Milano, Editrice il
Castoro, 2002.
Greimas, A. J., 1984, “Semiotica figurativa e semiotica plastica”, in Corrain L.; Valenti M. (a cura di), Leggere l’opera
d’arte, Dal figurativo all’astratto, Bologna, Esculapio, 1991,
pp. 33-51.
Jacoviello, S., 2004, “Dichterliebe/Love Fugue: fuga di un
poeta innamorato”, in Carte Semiotiche, Nuova Serie, 6-7,
Firenze, Le Monnier, pp. 51-66
Jacoviello, S., 2007, Suoni oltre il confine. Verso una semiotica
strutturale del discorso musicale, tesi di dottorato di ricerca,
Università di Siena
Lodato, N., 2003, Howard Hawks, Milano, Il Castoro.
Lotman, J. M., 1974, “Dinamiceskaja model’ semioticeskoj
sistemy”, (pubbl. in opuscolo) Mosca; trad. it. “Un modello dinamico del sistema semiotico”, in Strumenti Critici,
vol.2 n.2, Bologna, Il Mulino, 1987.
Lotman, J.M., 1994, Cercare la strada, Venezia, Marsilio.
Masters, E. L., 1936, Spoon River Anthology, New York, The
MacMillan Company; trad. it. a cura di F. Pivano,
Antologia di Spoon River, Torino, Einaudi, 1963.
Nattiez, J.J., 1987, Il discorso musicale, Torino, Einaudi.
Ruwet, N., 1972, Langage, musique, poésie, Paris, Seuil; trad. it.
Linguaggio, musica, poesia, Torino, Einaudi, 1983.
Stefano Jacoviello · Spaghetti country-western, valzerini e fratture psichedeliche. Ovvero: come i fantasmi di Spoon River, quando ebbero la voce, cantarono all’italiana.
Per iniziare a riflettere su questo LP di Fabrizio De
André e Ivano Fossati – le nove canzoni sono firmate,
testo e musica, da entrambi – può essere utile riferirsi
preliminarmente ad un’affermazione di De André che
coinvolge anche Fossati: “Non ce lo siamo mai detto
però... (questo disco) era un concept album sul tema
della solitudine” (La Repubblica, 19 sett. 1996).
Detto ciò, una seconda illuminazione viene dal ricordare che “anime salve” – secondo De André – significa
etimologicamente “anime solitarie” e per estensione
“spiriti liberi” (cfr. Musica del 17 maggio 1997).
Sinteticamente poi possiamo dire che ai temi della solitudine e della libertà si lega, in maniera tutt’altro che
estrinseca, quello del conflitto tra destino e salvezza, tra
destino e libertà, tra destino imposto e scelte individuali, tra poteri “forti” e minoranze resistenti e renitenti.
Per comprendere tutto questo è utile ricordare in prima
istanza i versi di “Smisurata preghiera”, la canzone che
chiude il disco. Qui infatti si dice in forma quasi riepilogativa delle varie storie raccontate nel disco e forse
dell’intero canzoniere di De André: “Ricorda Signore
questi servi disobbedienti / alle leggi del branco / non
dimenticare il loro volto / che dopo tanto sbandare /
è appena giusto che la fortuna li aiuti” e si prega che
questo miracolo pietoso avvenga proprio “per chi viaggia in direzione ostinata e contraria / col suo marchio
speciale di speciale disperazione”, per chi “tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi / per consegnare
alla morte una goccia di splendore, / di umanità, di
verità”.
A questi “servi disobbedienti alle leggi del branco”, alla
loro ricerca di una propria verità, in nulla arrogante
ma vissuta con preziosa dignità umana si contrappone,
come sempre in De André, la “maggioranza” che detiene il dominio e il potere: “Alta sui naufragi / dai belvedere delle torri / ... / a guidare la colonna di dolore e
di fumo / ... / coltivando tranquilla / l’orribile varietà /
delle proprie superbie / la maggioranza sta”.
È da precisare che la parola “maggioranza” è intesa
da De André in modo particolare: “Oggi maggioranza ha un significato numerico, ma deriva dal termine
latino maior, che al plurale fa maiores. I maiores nel
mondo latino erano coloro che detenevano i privilegi
ed esercitavano l’autorità e il potere. Oggi questi maiores sono diminuiti di numero, ma la loro diminuzione è
direttamente proporzionale all’aumento in loro favore
dei privilegi, dell’autorità, del potere, (ormai) pressoché
illimitati [...]. I minores... saremmo tutti noi al di là del
mestiere che facciamo... Credo che la gente si sia per
questo identificata con le minoranze emarginate, le protagoniste di Anime salve”. È per questo che oggi, secondo
De André, “una larga parte di popolazione comincia a
sentirsi minoranza” (cfr. Musica del 17 maggio 1997).
Non stupisce pertanto trovare, ancora in questa ricchissima canzone, ancora tra questi servi disobbedienti, ancora fra queste minoranze, Cristo che ad “Aqaba curò
la lebbra con uno scettro posticcio”, un Cristo vestito di
E|C Serie Speciale
Anno I, n. 1 2007, pp. 67-69
ISSN (on-line): 1970-7452
ISSN (print): 1973-2716
EC
Anime salve di Fabrizio
De André e Ivano Fossati.
Un’analisi semiotica
Paolo Jachia
stracci eppure capace di fare miracoli, di contrapporre
a costo della vita il suo “vasto programma di eternità”
e di universale pietà, alla rabbia meschina di coloro che
detengono il potere e lo usano per i propri miserabili
vantaggi.
Sinteticamente credo sia giusto dire che in questa canzone non solo viene descritto in termini di fuoco questo insanabile contrasto, ma si ritrovano tutti i termini
chiave di De André: fortuna, destino, potere, umanità,
Dio, fede...
A proposito di tutto questo – in un intervento scritto
del dicembre 1996 – dice apertamente De André: “C’è
chi è toccato dalla fede e chi si limita a coltivare la virtù della speranza [...]. Il Dio in cui, nonostante tutto,
continuo a sperare è un’entità al di sopra delle parti,
delle fazioni, delle ipocrite preci collettive, un Dio che
dovrebbe sostituirsi alla così detta giustizia terrena in
cui non nutro alcuna fiducia alla stessa maniera in cui
non la nutriva Gesù, il più grande filosofo dell’amore”
(cfr. Buscadero , n. 175, dicembre 1996).
Dettati così i confini ideologici del mondo poetico di
questo disco di De André e Fossati – il potere e chi al
potere sfugge o tenta di sfuggire o si contrappone per
le più varie ragioni personali o politiche – è facile intuire perché tutto il disco, come si vedrà una canzone
dopo l’altra, sia un racconto di solitudini e di libertà,
un susseguirsi di storie di emarginati e di minoranze,
raccontate con un fortissimo impianto realistico e un
altrettanto forte slancio lirico, descritti sempre in termini di solidarietà e “medesimezza” umana: ognuno dei
protagonisti dei loro racconti in versi e musica è infatti
un volto di cui sono date ragioni e dignità.
Non può stupire in questo contesto che una canzone sia
dedicata al popolo Khorakhané, tribù rom nomade ma
di origine serbo–montenegrina, che ha fatto della libertà, dell’essere vento, del non avere proprietà né terra, la
propria religione. De André e Fossati, con la straordi-
© 2007 AISS - Associazione Italiana di Studi Semiotici
T. reg. Trib. di Palermo n. 2 - 17.1.2005
68
naria presenza di Dori Ghezzi, cantano la loro immane
tragedia, il momento in cui “un uomo ti incontra e non
si riconosce”, il momento in cui “ogni terra si accende e
si arrende la pace”, il momento in cui “i figli cadevano
dal calendario / Jugoslavia Polonia Ungheria / i soldati
prendevano tutti / e tutti buttavano via...”.
Questo dunque il credo di De André, poeta anarchico
e libertario: il riconoscere in ogni uomo e in ogni storia
la propria storia e il proprio volto, e quindi il porre a
fondamento del senso dell’esistenza un sentimento di
fratellanza universale e di consanguineità esistenziale.
Fuori da questo patto di pietà fraterna, per usare ancora le parole di questa canzone, vi è solo chi crede “di
raccogliere in bocca il punto di vista di Dio”.
Qui è da osservare, in primo luogo, che De André uomo
poeta e narratore recepisce l’altro e il diverso come ricchezza e, quindi, non come minaccia, ma come parte
imprescindibile di se stesso.
Poi va rilevato che questa sua fortissima capacità di immedesimazione, che questo suo sapersi riconoscere nell’altro, nel diverso, non rimane una mera considerazione etica, ma dà origine a un’altrettanto forte capacità
fantastica e fabulatoria.
Vi è dunque un duplice perno – a un tempo etico e
fantastico – che sostiene tutto il raccontare poetico-musicale di De André.
Con la stessa pietosa attenzione si passa dunque dalla immane tragedia di un popolo – in un’intervista De
André ricorda che l’olocausto degli zingari, contemporaneo a quello degli ebrei, ha fatto non meno di mezzo
milione di vittime – a quella personale, ma non meno intensa, di un viado brasiliano chiamato, in arte, Prinçesa
(questo il titolo, oltre che della canzone a lei dedicata,
di un romanzo autobiografico edito per la casa editrice
di Renato Curcio, Sensibili alle foglie).
Non può stupire, alla luce di questa ribadita fratellanza,
che se la chiusa di Khorakhané (a forza di essere vento) era
in lingua romanes, qui sia invece in brasiliano, la lingua
madre del nostro viado, uomo mancato e anima in croce, quasi che, in un caso e nell’altro, solo il farsi carico di
una lingua “altra” possa essere l’origine di un’autentica
compartecipazione esistenziale...
A questa volontà di essere contro e di identificarsi con
gli ultimi si può far risalire la scelta di De André di usare
nei suoi ultimi dischi i più vari dialetti e le lingue delle
minoranze etniche: questo perché il dialetto e le lingue
“altre” rispetto all’italiano sono già intrinsecamente le
lingue della resistenza al potere che usa sempre una lingua “colta”.
Se, dopo il racconto di “Fernandino-Prinçesa” che si
ribella al suo destino e che corre “all’incanto dei desideri e... a correggere la fortuna”, prendiamo “Ho visto
Nina volare” troviamo, nascosto nelle pieghe di quella
che potrebbe sembrare una favola, un altro aspetto del
conflitto radicale che segna la vita dell’uomo: l’urgenza
del desiderio di contrasto con la legge e la norma, il
passare del tempo e la caducità della vita. Se appena
ricordiamo che anche Freud ha raccontato tutto questo
parlando di Es e Super-Io, parlando della tragedia di
Edipo e del conflitto con il padre, può non stupire il trovare anche qui un figlio e un padre in conflitto. Da sottolineare invece che il contrasto con la legge del padre
è talmente forte e radicale che la scissione la troviamo
nell’animo di chi vede e sogna Nina volare. Vediamo infatti crearsi nell’animo del protagonista – scosso dall’urgenza conflittuale del desiderio e del fatto che questo
desiderio sia illecito – una doppia identità, un’ombra,
un alter ego malvagio ma irresistibile... Sua, del doppio,
la cantilena, dolcissima e terribile, che ripete “mastica e
sputa, da una parte il miele / mastica e sputa, dall’altra
la cera, / mastica e sputa, prima che venga neve”, ossia
gioca le tue carte prima che sia tardi. Inutile mostrargli
il coltello, inutile cercare di sfuggire al proprio destino...
un giorno – dice, senza scampo, il protagonista –“prenderò” Nina “come fa il vento alla schiena... e se lo sa
mio padre... mi imbarcherò lontano... dovrò cambiar
paese”. Resta la domanda, senza risposta, su chi distribuisce le carte, su chi decide i destini, su di chi sarà “la
mano che illumina le stelle... la mano che ti accende e
ti spegne”, ossia, fuori di metafora, su chi ti dà la vita
e la morte.
Ancora una volta De André si accosta ai destini degli
uomini, alle loro disperate solitudini e abissali disperazioni, con grande rispetto lasciando il giudizio a “chi
sa di raccogliere in bocca il punto di vista di Dio” e
dunque anche per il figlio colpevole vale un’altra, ormai antica, smisurata preghiera di De André: “se giudicherai da buon borghese / li condannerai a cinquemila
anni più le spese / ma se capirai, se li cercherai fino
in fondo”, capirai che “anche se non sono gigli / son
pur sempre figli, / vittime di questo mondo” (da “Città
vecchia”, rielaborazione di De André di una poesia di
Umberto Saba intitolata anch’essa “Città vecchia”).
Il ricordo di questa canzone, con i suoi “quattro pensionati mezzo avvelenati”, così centrali in De André
– Prinçesa e l’innamorato della piccola Nina sono a
pieno titolo “abitanti della Città vecchia” – può farci
rilevare che in questo disco manca completamente un
registro che pure era stato spesso presente in altri suoi
lavori, il registro comico o almeno sarcastico... Anche il
sorriso con cui accompagniamo la storia della Cúmba,
della colomba “malmaritata”, è un sorriso amarissimo.
Infatti la canzone intitolata “Â cúmba” ancora una volta, più che una favola, è in realtà il racconto di una disillusione, uno scherzo di quei tanti che fa la vita (per usare
le parole di un amico di De André, Francesco Guccini).
Dopo tante promesse, dopo tanto parlare tra il pretendente e il padre (“la terrò a dondolarsi sotto una pergola
di melograni / con la cura che ha della seta la mano
leggera del bambagiaio”) la verità è che “il marito va a
zonzo” e la “colombina” è diventata “una serva a lavare a terra”. Un destino assurdo, ridicolo – per usare il
titolo del romanzo scritto da De André con Alessandro
Gennari e intitolato appunto Un destino ridicolo... Ma di
Paolo Jachia · Anime salve di Fabrizio de André e Ivano Fossati. Un’ analisi semiotica
fronte al precipitare della bianca colomba, spento e
bruciato in fretta il suo sorriso, viene da chiedersi se
esiste un destino che non sia, in fondo, ridicolo, assurdo.
Se esiste cioè, per usare le parole di un’altra canzone
di De André e Fossati – “Disamistade” – “un modo di
vivere senza dolore”, un modo di fermare “questa corsa
del tempo a sparigliare destini e fortune”.
Se su questa domanda torneremo in sede di precaria
conclusione, intanto è importante notare che il tema
del destino, della fortuna, della sorte, è presente in
tutto il disco. Infatti, oltre che in “Ho visto Nina volare” il ragionamento sul destino che guida la nostra
vita, sulla possibilità di cambiare la sorte della nostra
vita, lo troviamo, oltre che nelle canzoni sopra citate, in
“Dolcenera” dove il cataclisma improvviso muta l’acqua da benedetta in acqua di mala sorte, un momento
proprio e d’amore in qualcosa che spezza definitivamente una vita.
Ancora alle leggende e alle cronache popolari si rifà la
canzone “Le acciughe fanno il pallone”, dove troviamo
oltre al tema della fortuna – recitato dalla bocca di un
giovane pescatore – un verso di rara sensualità, dove è
il non detto a dare, assieme alla scossa del desiderio, la
sensazione dell’esclusione e della marginalità: “Passano
le villeggianti / con gli occhi di vetro scuro / passano
sotto le reti / che asciugano sul muro / e in mare c’è
una fortuna / che viene dall’oriente / che tutti l’hanno
vista / e nessuno la prende... se prendo il pesce d’oro /
ve la farò vedere / se prendo il pesce d’oro / mi sposerò
all’altare”.
Detto tutto questo credo sia ora giusto parlare di
“Anime salve”, una canzone tanto importante da dare il
suo nome all’intero LP, e al tempo stesso molto enigmatica. Se infatti sul fronte delle scelte etiche e politiche,
in senso lato e alto, le posizioni di De André e Fossati
sono molto chiare e molto determinate, sul piano delle
scelte esistenziali tutto, e giustamente, diviene molto più
sfumato. “Anime salve” parla di questo ed è una canzone fatta sì di immagini luminosissime, ma anche di forti
“zone d’ombra”.
Se dunque non è possibile ricostruirne il senso – il senso è l’emozione fortissima che lascia questa canzone, la
sua magia fatta delle voci e delle musiche di De André
e Fossati: ed infatti la canzone è sempre, in termini semiotici, un testo sincretico, un testo in cui, come precisa
Jakobson, giocano codici e sistemi espressivi diversi e il
valore del testo scaturisce, dunque, dalla loro compenetrazione reciproca – questa credo che sia la trama
logica: anime salve sono le persone che hanno accettato
e vivono con esatta lucidità - spietata ma anche gioiosa
– la vita come una condizione ontologica di solitudine:
“Che bello il mio tempo... che grande questo tempo...
che solitudine, che bella compagnia”. Dunque anime
salve perché anime solitarie (De André in un’intervista
– già prima ricordata – dice che salve, secondo una sua
personale interpretazione etimologica, vuol dire proprio solitarie); salve pertanto perché capaci di “illudersi
e fallire”, di guardarsi piangere e ridere, di arrivare e
partire, di vincere e perdere nel gioco alterno della vita
e della fortuna... Ossia, di vivere questo tempo (“che
grande... che bello questo tempo”) nella sua fugace ma
straordinaria bellezza: “sono state giornate di finestre
adornate, canti di stagione... sono state giornate furibonde, senza atti di amore... solo passaggi... passaggi
di tempo”).
Ancora e per finire, se di parlare di una canzone come
questa si può finire, anime salve perché capaci di sapere
quello che i poeti sanno sempre, che, nonostante ci siano stati e ci saranno mille “incontri... cacce... rincorse...
scontri”, siamo soli e che ogni altra verità è un inganno;
che è quanto ci ha detto in maniera lapidaria il poeta
Salvatore Quasimodo: “Ognuno sta solo sul cuor della
terra / trafitto da un raggio di sole / ed è subito sera”.
Ma sia chiaro che essere consapevoli di questa solitudine esistenziale non vuol dire isolarsi, credere che “il
dolore degli altri / è un dolore a metà”.
Al contrario per De André e Fossati questa solitudine
“buona” è la premessa ad un incontro libero e maturo
con gli altri, ad una lotta per la libertà di ogni “minoranza” e contro lo “strapotere” di ogni sedicente “maggioranza”.
Perché se come vuole la sapienza ebraica in ogni istante
può giungere il messia, se “in mare c’è una fortuna che
viene dall’oriente che tutti l’hanno vista e nessuno la
prende”, ogni istante è buono per gettare la rete. Fuor
di metafora: la partita non si chiude, il gioco continua,
bisogna ancora una volta scegliere da che parte stare.
De André e Fossati, con questo disco e con la storia che
ci sta dietro, la loro scelta l’hanno fatta.
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
69
sezione tre
questioni di genere, questioni di stile
1. Incipit
Questo mio intervento propone, in forma necessariamente abbozzata, alcuni elementi attraverso cui interpretare la figura di Mina in chiave semiotica, secondo
una prospettiva che potremmo collocare entro l’ambito
incrociato degli studi culturali e della fashion theory. Gli
studi culturali offrono infatti gli strumenti per potere
considerare un caso, una figura, un personaggio della
scena musicale, come Mina, quale emblema e catalizzatore di passaggi importanti nella “cultura di massa” e
nella storia dei mezzi di comunicazione, prima tra tutti
la televisione. La fashion theory offre invece da parte sua
una prospettiva che mette insieme stili di vita e visioni
del mondo, permettendo di affidare al costume – nel
senso letterale di abito e nel senso più generale di atteggiamento e condotta sociale – il ruolo di segno forte che
vede la moda come il luogo dove si manifesta una complessità di tensioni, di significati e di valori – non solo
relativi alla dimensione vestimentaria. La semiotica si
concentra sulle trasformazioni dei segni, sui momenti
di valorizzazione, di patemizzazione, sulla spazialità,
sui linguaggi, sulle narrazioni che certi segni generano,
sui limiti e sui confini tra i testi, sulle interconnessioni
tra forme diverse della sensorialità. L’aspetto musicale
riveste un ruolo essenziale nello “sguardo semiotico”: la
musica si pone infatti come una pratica sociale che ne
coinvolge altre, come un luogo complesso della testualità, e – cosa che mi preme particolarmente – come un
processo di produzione di senso al quale il corpo partecipa profondamente.
Mina è un concentrato di passioni, narrazioni, trasformazioni: è mutazione sonora in tutti i sensi, soprattutto
nel senso che collega la mutazione sonora alla mutazione del corpo, a quella sociale, alla mutazione dei gusti,
a quella delle figure e delle forme della comunicazione.
Il caso-Mina mi sembra emblematico di una cultura del
corpo e, consustanziale a questa, del genere sessuale,
che caratterizza un momento storico cruciale. Preciso
a questo proposito che mi occupo qui di Mina nel periodo che va dal 1959 ai primi 70, un periodo in cui la
sua figura s’innesta in modo necessario con il ruolo e la
funzione della televisione in Italia e con le grandi trasformazioni che il paese andava vivendo in quel decennio. Tralascio quindi i decenni successivi, fino a oggi, e
mi occupo di Mina nella cultura visuale televisiva, non
parlando qui né della radio né del giornalismo su carta
stampata né del cinema, che pure hanno costituito e costituiscono aspetti importanti della sua attività pubblica,
soprattutto la radio. Corpo, moda, musica, gender sono
in questi anni nella figura di Mina costruiti in funzione
della televisione; ma viceversa, allo stesso tempo, è la televisione italiana – o per lo meno una parte importante
del suo palinsesto, quella dello spettacolo e dell’intrattenimento – a costruirsi in funzione di Mina, nei suoi
tempi, spazi, modalità comunicative, figure spettatoriali. Cercherò di illustrarlo in questo intervento, che si
motiva in un mio desiderio antico di portare avanti una
E|C Serie Speciale
Anno I, n. 1 2007, pp. 73-76
ISSN (on-line): 1970-7452
ISSN (print): 1973-2716
EC
“Due notine d’argento”.
Mina, la moda, la musica e la
televisione italiana dei 60 1
Patrizia Calefato
ricerca semiotica su Mina. Il desiderio si radica in me
nella memoria di sabato sera infantili in cui il permesso
strappato di potere andare a letto anche oltre Carosello
aveva in Studio Uno la sua celebrazione; si radica nella
rievocazione delle domande che ritualmente ogni settimana e ogni anno ci ponevamo con mia madre: “come
si vestirà?”, “come sarà pettinata?”, “sarà più magra
o ingrassata?”. Memorie, ancora, di discorsi rubati ai
grandi che avevano al loro centro “paciughini” illegittimi; di adolescenziali tentativi di depilare le sopracciglia,
mai però osando quanto lei; di testi di canzoni che immaginavo potessero contenere il senso di passioni mature, per me ancora misteriose: “Questa stanza non ha
più pareti, ma alberi infiniti”, “È l’uomo per me”, “Mi
sei scoppiato dentro il cuore”, “La voce del silenzio”,
“Se telefonando io potessi dirti addio”...
2. Lo spazio, le figure, i luoghi
Due filmati possono essere messi a confronto per affrontare il tema dello spazio: nel primo tratto da Il musichiere
© 2007 AISS – Associazione Italiana di Studi Semiotici
T. reg. Trib. di Palermo n. 2 – 17.1.2005
74
del 1959, vediamo comparire Mina da dietro un juke
box e cantare, alla maniera degli urlatori del tempo
Nessuno. Nel secondo, da Canzonissima del 1968, Mina
entra in scena cantando E sono ancora qui, come se fosse
su una passerella in cui si mostra l’intero studio televisivo. Iniziare da questi due filmati mi sembra emblematico per definire quello che mi sembra essere stato
una specie di obbligo della televisione di quegli anni, e
a maggior ragione del personaggio-Mina: costruire uno
spazio pubblico in grado di entrare nello spazio privato spettatoriale. Oso dire che questa operazione, nella
storia della televisione italiana, è stata scandita da tre
modelli: il modello “Studio Uno” di Mina negli anni 60
nella formula di Antonello Falqui – o il teatro che entra
nello studio televisivo, ci torno tra un minuto più dettagliatamente; successivamente, dagli anni ’80, il modello
talk-show, Costanzo in testa – o il salotto teatralizzato in
TV; infine, più di recente, il modello “Grande fratello”
– ovvero l’era della toilette come luogo pubblico.
La relazione tra momenti e luoghi prima separati della
comunicazione – teatro, casa e televisione – trova nei
60 spettatori come voyeur meravigliati e timidi, a volte
diffidenti: la TV è palcoscenico, è teatro, è portento, è la
possibilità di vedere come funziona: ricordo qui che fu
proprio Falqui a rendere visibili le giraffe, le telecamere, la struttura stessa dello studio che si mostrava man
mano che una delle telecamere seguiva i movimenti di
Mina. La Tv è divismo certo, ma divismo addomesticato, reso vicino e manipolato nei discorsi quotidiani.
È intorno a Mina che si crea questo spazio, soprattutto con Studio Uno, nelle edizioni 1961, 1965, 1966 e
1967 (quando il titolo fu però “Sabato sera”) cui partecipò (dal 62 al 64 di fatto fu esiliata dalla RAI per il
suo legame con Corrado Pani e il suo “figlio illegittimo”
Massimiliano) quale modello che venne poi riprodotto in altre due trasmissioni che la videro protagonista:
l’edizione di Canzonissima del 68 e Teatro 10 nel 72
(entrambe firmate sempre da Antonello Falqui).
Nel caso di Mina si tratta di uno spazio costituito di
televisione e musica, ovviamente, ma allo stesso modo
costituito di discorsi, di valori proposti per una condivisione sociale, si tratta di una “moda” in definitiva, intesa al di là del vestiario e del trucco – ma che di questi
elementi pure si alimenta. Una moda concepita come
modalità dell’essere corpo (corpo rivestito potremmo
dire), corpo socializzato e manipolato, in cui si esplicitano apertamente le forme di questa socializzazione e
manipolazione.
Mina è stata sempre consapevolmente artefice di questa
spazialità istituita dalla sua prorompente, amabilmente
goffa, ironica, corporeità. Dalle arruffate movenze urlatrici del primo filmato allo spazio-passerella del secondo, in cui si propone l’intera gamma delle figure di cui il
suo spazio consta: l’orchestra, il direttore (ricordo tra gli
altri, Bruno Canfora, Pino Calvi), il pubblico, eventualmente il balletto, eventualmente l’ospite con cui interagisce, e poi lei stessa e i suoi “voi”, in un’interpellazione diretta ai suoi fan, spettatori, destinatari, pubblico,
come bene mostrato nella canzone Brava, per esempio
nell’edizione di Canzonissima del 1968.
Al di fuori della televisione, lo spazio pubblico di Mina,
oltre al gossip giornalistico, vive nella stagione estiva
alla Bussola di Viareggio, dove aveva esordito nel 1958
e dove ritorna stabilmente dal 1968 al 78. La Bussola è
il luogo degli eccessi consentiti, della moda esagerata,
dell’abbronzatura e delle sudate, dell’esibizione live che
diviene il presupposto per alcune incisioni discografiche. La Bussola è l’altro luogo rispetto alla televisione,
ma la televisione se ne alimenta come se ne alimenta
l’intera società. È l’antipiper, se al Piper di Roma è
possibile dare il senso di uno spazio “giovane e alternativo”, mentre alla Bussola quello di luogo fatto più
per un pubblico adulto e benestante. Nel 1965 Dino
lancia al Cantagiro “Il ballo della Bussola”, nel tentativo di popolarizzare anche presso un pubblico giovane
questo locale, per lo meno il suo nome. La Bussola a
San Silvestro del 68, fuori dall’estate di Mina, fu il luogo dove avvenne la contestazione degli studenti verso
i ricchi che andavano a festeggiare il Capodanno: gli
studenti gettarono uova sui visoni delle signore, come
già avevano fatto alla Scala, le forze dell’ordine spararono, ferendo gravemente lo studente pisano Soriano
Ceccanti (divenuto poi schermidore e campione olimpico alle Paraolimpiadi). Tra le canzoni che ricordano
quell’episodio, la “Ballata della Bussola” di Pino Masi.
3. La lingua
Ma torniamo a Mina nei suoi spazi e nei suoi luoghi. C’è
un uso della lingua italiana che caratterizza il suo personaggio, a cominciare naturalmente dai testi delle canzoni. Come sottolineato da molti studiosi, la canzone italiana introdusse negli anni 60 modificazioni importanti
nella storia della lingua, che andarono di pari passo con
l’unificazione linguistica che la televisione tesseva, sebbene le canzoni si proponessero però spesso come testi
Patrizia Calefato· “Due notine d’argento”. Mina, la moda, la musica e la televisione dei 60
provocatori e poco convenzionali, ma proprio di questa
dimensione si arricchiva la lingua, quella quotidiana e
soprattutto quella delle nuove generazioni.
I 45 giri da un lato e le trasmissioni televisive dall’altro si ponevano come luoghi della testualità da cui il
linguaggio traeva a piene mani usi, modi di dire, neologismi, modalità enunciative. Per Mina penso a “Le
mille bolle blu”, accompagnate dal suono egressivo
in cui un movimento delle dita sulle labbra modula la
fuoriuscita dell’aria: “Blll”; il surrealismo della “zebra
a pois”; “Sacundì sacundà”, dalla canzone brasiliana
“Nem vem que nao tem”, la formula che esorcizza il
diavolo sacundì sacundà sacundi cundì cundà; il fonosimbolo “Ta-ra ta” nella canzone dallo stesso titolo; “E
se domani” con le sue incidentali insolite nei testi delle
canzoni italiane “mettiamo il caso”, “e sottolineo se”. E
naturalmente penso al testo metalinguistico per eccellenza “Parole parole parole” di Gianni Ferrio, rimasto
anche nell’uso dell’italiano come refrain esemplare e
ricorrente.
Parole che s’incrociano nella dimensione costitutivamente dialogica non solo dei testi delle canzoni, ma
anche e in modo speciale della figura di Mina come
presentatrice-conduttrice-intrattenitrice-diva-personaggio complessivo che ospitava nel suo spazio figure
illustri del tempo, personaggi come Totò, Mastroianni,
De Sica, Panelli, Walter Chiari: a tutti Mina fece da
“spalla” in modo personalissimo. Con molti di loro la
forma “dialogo” si realizzò in duetti dall’apparenza
estemporanea, ma divenuti poi esemplari: ricordo qui
– oltre a quello con Alberto Lupo che costituiva la sigla di Teatro 10, del 1972, quindi in epoca “matura”
– quelli con Luttazzi, Dorelli, Gilbert Becaud, Caterina
Valente, Lucio Battisti, Astor Piazzolla.
Un’altra notazione sulla questione della lingua riguarda il nome proprio, segno di identità nel quale sono
però racchiuse maschere, narrazioni, modi d’essere
che travalicano l’identità e la frantumano. Il vero nome
di Mina è Anna Maria Mazzini: iniziò la sua carriera
come
Baby Gate cantando in inglese, secondo la moda degli
“urlatori” della fine degli anni ’50. Cambiò però presto
il suo pseudonimo in Mina, senza cognome, e tale è
rimasta. Nome d’arte di suo fratello, cantante anche lui,
da lei sostenuto e lanciato in televisione, morto prematuramente in un incidente d’auto con grandissimo dolore di Mina, fu Geronimo, come il capo Apache. E tra
i nomi, va menzionato anche il celebre soprannome, “la
tigre di Cremona”, che si dice le sia stato attribuito da
Natalia Aspesi e che però lei non amava, pur essendo
la Aspesi una sua amica, che ha scritto grandi e intelligenti cose su di lei.
4. La moda
Possiamo parlare di uno “stile Mina” caratterizzato da
due tensioni opposte: da un lato Mina è nei 60 una figura esteticamente in mutazione costante: del peso, della
pettinatura, del colore dei capelli, del look; dall’altro lato,
però, esiste in lei un’unità stilistica forte permanente nel
tempo che ha come suoi elementi caratterizzanti innanzi tutto la voce e le sue modulazioni, poi il trucco – con
la scelta a un certo punto di depilare completamente le
sopracciglia – infine la gestualità, quella gestualità consapevole del sabato sera, raffinata e solo apparentemente goffa, sexy e familiare allo stesso tempo. Nel volto,
volta a volta più tondo o scavato a seconda delle diete e
delle gravidanze, il naso la identifica e lei lo porta con
grande orgoglio, come pure i due nei nella parte bassa
della guancia destra. Il trucco è pesantissimo, in alcune
fasi eccessivo. È probabilmente questa una delle ragioni
per cui Mina è da tempo un’icona gay.
Certamente lei fece la moda e determinò lo stile Mina
nella versione in cui la ricordiamo prevalentemente:
capelli corti con la riga al lato e le basette, abito lungo
scuro con scollatura a V profonda e spalle nude, scarpe col tacco alto e massiccio. Ma le varianti sono state
diverse.
Nel 1961 al Festival di Sanremo la casa discografica
volle che indossasse un abito ridicolo con gonna a palloncino e tessuto stampato a grandi pois blu: cantava
“Le mille bolle blu”, “accoppiata” con Jenny Luna, ma
quell’abito non era certo il suo genere.
La versione procace in minigonna vertiginosa la rese
“ragazza” del suo tempo. Quella magrissima e fatale
con i riccioli ossigenati fu una maschera quasi irreale.
In Conversazione, da Sabato sera del 1967, viene realizzato un antesignano del videoclip, basato su giustapposizioni del gioco bianco/nero con Mina che indossa
abiti Capucci e cita visibilmente nel trucco e nelle pose
la modella Benedetta Barzini.
Sempre nella stessa trasmissione, una parodia sul lusso
e l’abbigliamento settecentesco sulle note del “Valzer di
un minuto” di Chopin, “Questo Settecento”. Un anno
prima aveva cantato la stessa aria Barbra Streisand, ma
non così bene, né sul piano musicale né su quello spetta-
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
75
76
colare e coreografico. Mina gioca con i suoi nei sul viso,
che diventano tre – due veri e uno finto; gioca a sedersi
con la crinolina sotto la gonna, come farà molti anni
dopo la protagonista di Orlando nel film di Sally Potter,
e si muove in una Reggia vera, mentre la Streisand si
accontenta di scene dipinte.
Nel suo modo di essere alla moda entra profondamente
la sua vita privata: per esempio la gravidanza, che la
ingrassa. Le sue scelte di vita furono “scomode” nel clima rigido della Rai dei primi anni 60, con il codice di
Filiberto Guala ancora imperante. Ma allo stesso tempo la televisione si riempiva delle istanze e dei “rumori”
provenienti dalla società, e Mina ne fu anche un tramite. In questo senso, interagiscono nel suo personaggio
due tensioni contrapposte: la moda – non solo quella
vestimentaria, ma la moda come modo di essere, come
stile, appunto – che ne fa un modello da imitare, o che
comunque la rende personaggio pubblico, sottoposto
alla approvazione sociale, da un lato; un vero e proprio
dandismo al femminile che la rende unica, irripetibile, e
con il quale si motiva probabilmente anche la sua scelta
di “sparire” dalle scene, dall’altro. In questo dandismo
si struttura anche una modalità assolutamente unica di
realizzare il genere sessuale come performance – per
riprendere Judith Butler –, come mascherata pubblica
che però trova radici profonde nel vissuto individuale.
La costruzione del mito si produce anche nella indistinzione del confine tra l’immagine pubblica e il privato, in
un andirivieni intessuto anche nei testi delle sue canzoni
in cui molte donne si identificavano.
Mina è la prima e forse l’unica diva della televisione
italiana, e in quanto tale preannuncia, attraverso indizi,
alcuni tratti di una postmodernità che ha dimensioni
non più solamente “italiane”.
testualità visuale, che prefigurano generi nuovi, come
il videoclip, secondo una via che veniva sperimentata
in quel periodo anche in altri contesti culturali internazionali.
Abbiamo già detto delle prove di videoclip realizzate
da Falqui. Prove che si riproducono nella serie di spot
pubblicitari realizzati per la Barilla dal 1965 al 71 nella forma breve del genere creato appositamente per lo
spazio di Carosello.
Successivamente Mina fa da testimonial per la cedrata
Tassoni, in spot nei quali vengono riprodotte situazioni
del “canone televisivo” di Mina, oppure le atmosfere
della Bussola, o infine, fino al 1978 per Tassoni, vengono realizzate delle riprese in esterni che hanno la struttura vera e propria dei primi videoclip.
Dopo il 78, il corpo di Mina scompare fisicamente da
ogni manifestazione pubblica, anche dalla pubblicità,
nella quale resta però per molti anni la sua voce, per
spot Tassoni, Wind e Fiat.
Per concludere, un cenno all’operazione di citazione
che in questi ultimi anni ripropone la Mina dei 60: la
voce di Nicky Nicolai. Cito dunque creo, come dice
M.R. Dagostino: la citazione musicale – strategia frequentissima nella storia della musica – nel caso di Nicky
Nicolai riproduce lo stile, l’accento, finanche le inflessioni vocali e i vezzi fonologici di Mina, facendone rivivere, come accade nella moda del vintage (che vuol dire
vendemmia d’annata), l’assoluta unicità, come un vino
di ottima annata, appunto.
Note
1
Filmati, immagini e notizie bio-disco-bibliografiche su Mina
sono rinvenibili sul suo sito ufficiale www.minamazzini.com.
Per vedere alcuni dei filmati cui si fa qui riferimento, andare
su quel sito, cliccare su <apri Juke Box> poi <video>, e poi
<televisione> oppure <pubblicità> a seconda del genere citato: scegliere infine il filmato di cui si parla nel testo. Altri
filmati sono presenti nella playlist da me creata nello spazio
di condivisione video “You tube” all’indirizzo www.youtube.
com/my_playlists?p=CA487CD7AC6BA9FF.
5. Intertesti
Proverò a indicare alcuni di questi indizi. A cominciare dalla reciproca interferenza tra diverse forme della
Patrizia Calefato· “Due notine d’argento”. Mina, la moda, la musica e la televisione dei 60
Il susseguirsi delle culture musicali giovanili del
Novecento è cadenzato dalla presenza di entità che aiutano a leggere questi fenomeni sotto il profilo dell’aggregazione collettiva: generi, estetiche, stili, atteggiamenti,
movimenti. Queste tipologie possiedono confini spesso
labili ma tutte svolgono una indubbia funzione metatestuale, sia proveniente dall’interno delle stesse culture
sia derivante da una narrazione osservativa esterna.
Eric Landowski (1989) riguardo alla questione della successione temporale fra generazioni ne sottolinea il
carattere graduale e continuo, il “gioco di ‘influenzÈ
reciproche e di accavallamenti”, la necessità di ricercarne “opposizioni qualitative tra ‘generazioni’ sociali”
invece che “meri rapporti di successione” cronologica
(ivi, p. 62, trad. it.). Per Landowski, costanti, variabili e forme intermediarie informano l’intero panorama
permeabile delle “unità generazionali” (ivi, p. 63, trad.
it.); può essere allora proficuo tentare di riconnettere
alcuni di questi oggetti metatestuali anche attraverso
un filo cronologico, allo scopo di evidenziare identità e
differenze sul piano culturale. La trasformazione di un
lessema (ivi, p. 70, trad. it.) lungo i diversi adattamenti
contestuali, fornisce, come vedremo nel caso del cool, interessanti indizi sui tratti profondi che lo costituiscono.
Andando a rileggere le pagine che Jurij Lotman (2006)
dedica all’evoluzione culturale, vi si legge che quest’ultima si differenzia dall’evoluzione naturale per il ruolo
che vi giocano le autodescrizioni e le rappresentazioni
che vengono date di una cultura (ivi, p. 152). Un rappresentante, un membro di una cultura, si sente tale
perché avverte la presenza di un sistema di valori che
egli assume e assieme determina. Lotman aggiunge
che una cultura da una parte manifesta un’ “ossatura”,
un’invarianza strutturale, e dall’altra parte prevede un
dinamismo superficiale che le consente di evolvere e
trasformarsi. L’ossatura assume la funzione di una memoria culturale di una collettività ma diviene anche un
modello utile a rilevare, nella diversità delle occorrenze
testuali, elementi unitari che consentano di dare conto
di una visione unificante (ivi, p. 153). D’altro canto, una
descrizione culturale, sia essa di un concetto, di una lista di proprietà, delle modalità del gusto, dei caratteri
di una moda, avviene frequentemente, e in particolar
modo nelle culture musicali giovanili, per opposizione.
Lotman al riguardo afferma che, data la natura “chiusa” del concetto di cultura, quest’ultima presuppone
l’esistenza di qualcosa che le sia in netta opposizione:
una non-cultura o qualcosa rispetto alla quale essa in ogni
caso si contrapponga. Ed è esattamente ciò che avviene
nei primi esempi dei movimenti giovanili contemporanei, in qualche misura legati alle relative culture musicali nascenti (cfr. Spaziante 2007). Se ne osserviamo
l’evoluzione, rileviamo come la costituzione dei valori
abbia proceduto, appunto, per opposizioni tra macrocategorie valoriali, al di sotto delle quali è possibile rilevare una sorta di opposizione profonda.
Una categoria che si ritrova in modo ricorrente nelle
E|C Serie Speciale
Anno I, n. 1 2007, pp. 77-83
ISSN (on-line): 1970-7452
ISSN (print): 1973-2716
EC
Hip, beat, cool. Culture musicali
giovanili e sistemi di valore
Lucio Spaziante
manifestazioni culturali giovanili, al di là delle singole
occorrenze superficiali, è l’opposizione tra autentico e fittizio (o commerciale). Questa forma di valore o dis-valore ha assunto di volta in volta forme diverse, diventando
la difesa dell’autenticità popolare contro la volgarizzazione industriale, oppure dell’impegno politico contro il
disimpegno (cfr. Marconi, 2007, pp. 701-702).
1. Bohemians
Risalendo all’indietro lungo i fili del discorso sull’autenticità, scopriamo che ciò che possiede in nuce molti
elementi valoriali, tra quelli che andranno ad informare le manifestazioni culturali giovanili a venire, è
la formazione discorsiva originatasi attorno alla bohème1. L’atteggiamento culturale bohèmien nasce, secondo
Elizabeth Wilson, in seno alla società industriale, originandosi dalla tensione che si manifesta attorno alle
comunità artistiche (1999, p. 12), le quali, proprio per
questa situazione di incomprensione, tendono a separarsi dal resto della società borghese e dalle sue convenzioni. Nei comportamenti bohèmien la sfida alla
morale dominante si manifesta nell’uso di droghe e
alcool, nella devianza erotica, nell’estremismo politico.
Sono i quartieri urbani a fornire il supporto per una
realizzazione concreta del progetto di vita bohèmien e
assieme per la sua messa in scena rappresentativa: da
Montmartre al Greenwich Village, a Soho.
Il bohèmien si può definire come un “dissidente-artistaribelle” (cfr. Wilson, 2000, p. 2, trad. dell’autore) per
il suo comportamento anticonformista e anti-borghese,
ma bohèmien può essere anche un “artistoide” da non
confondersi con il “vero” artista. Il tutto si gioca, appunto, su un discrimine di valori basati sull’autenticità.
Il bohèmien è assieme eroe ed anti-eroe e nella società
occidentale il suo percorso è, ancora secondo Wilson,
indissociabile dallo stesso pubblico che lo osserva e lo
colloca in un ruolo definito. Sin dal suo apparire sulla
© 2007 AISS – Associazione Italiana di Studi Semiotici
T. reg. Trib. di Palermo n. 2 – 17.1.2005
scena urbana, il bohèmien ha infatti infatti goduto di
un ampio seguito di consumatori-osservatori, desiderosi
di poter vivere a distanza storie di individui dissoluti e
talentuosi, dediti all’alcool e alla droga, e di osservare la
loro pararabola di ascesa e caduta.
“La figura del bohèmien impersona l’ambivalente ruolo dell’arte nella società industriale; la Bohème è un mito culturale relativo all’arte nella modernità, un mito che cerca di
riconciliare l’Arte con il capitalismo allo scopo di assegnare
ad esso un ruolo nella società dei consumi” (ivi, p. 3, trad.
dell’autore).
78
Se per Roland Barthes (1957) un mito emerge nella
società moderna grazie alla sua funzione di riconciliare gli opposti incociliabili, in questo caso il bohèmien
rappresenta una soluzione immaginaria al problema
della collocazione dell’arte all’interno, e assieme al di
fuori, delle logiche commerciali e di consumo. Egli è,
allo stesso tempo, proiettato verso il cambiamento e
custode delle tradizione; rappresenta un momento di
drammatizzazione che converge in una forma di vita (cfr.
Greimas, Fontanille, 1993). “Non è un semplice individuo creativo bensì crea ed assume su di sé un’identità
che in breve tempo diviene stereotipo” (Wilson, 2000,
p. 3, trad. dell’autore). Il bohèmien rappresenta così
un insieme di pratiche e regole di comportamento, riconoscibili soprattutto a partire dal momento in cui il
discorso sociale inizia a descriverle attraverso la forma
estetica della letteratura e della pittura. A partire da una
descrizione definita dello stereotipo, nuove generazioni
di “praticanti” hanno potuto farvi riferimento e assumerlo come proprio, diventando bohèmien anch’essi.
Il bohèmien fa propria una ricerca di identità interna
alla stessa società in cui vive, proiettandosi però idealmente al suo esterno in un insieme di fuga e redenzione,
in alcuni casi sviluppando la nostalgia di un’autenticità
perduta. Conflitto, dunque, sull’autenticità, ribellione,
rottura degli schemi, fuga, spettacolarizzazione, ottica
sociale, trasformazione di un immaginario in una forma
di vita, sembrano tutti essere gli ingredienti valoriali, e
le componenti, di un vero e proprio schema narrativo,
non solo dell’estetica bohèmien ma anche di molte delle
culture musicali giovanili che saranno protagoniste del
tardo Novecento.
2. Hip Vs Square
Spostandoci negli Stati Uniti ritroviamo un ambiente
che presenta carattersitiche similari alla scena bohèmien europea. Parliamo degli hipster e della hipness legata
alla musica jazz tra gli anni Venti e Quaranta. Prima di
precisare di cosa stiamo parlando, partiamo proprio dal
risolvere progressivamente il problema della sua definibilità. Come per la definizione del jazz, alcuni musicisti dicono: “se non sai già cos’è, lascia perdere” (Ford,
2002, p. 49, trad. dell’autore) alludendo ad una sorta di
dono naturale e ad una sintonia con un modo di essere,
necessari a poter comprendere l’universo hip. In base
Fig. 1 – Cab Calloway indossa uno Zoot Suit
a definizioni tratte da testimonianze dell’epoca, essere hip vuol dire essere “in the know” (Monson, 1995, p.
399), ovvero trovarsi in una sorta di stato di “comprensione naturale”. Segnali esteriori di cosa sia un hipster
possono derivare da modalità verbali, come il vernacolo
personale (“vout” language) del jazzista Slim Gaillard basato sull’interpolazione di sillabe nonsense all’interno
di parole comuni (“French fries-o-rooni”) (ib.), oppure
derivare da aspetti vestimentari, come il cappello e gli
occhiali be-bop di Thelonious Monk o Dizzy Gillespie,
o gli zoot suits3 indossati da Cab Calloway (cfr. Fig. 1),
ovvero vestiti composti da giacca e pantalone, ampi e
fuori misura, che rompono con la regolarità del vestito
da uomo tradizionale e con l’eleganza convenzionale
dressing up.
Howard Becker nel celebre Outsiders (1963), saggio dedicato alle culture “devianti”, osserva che nella parola
square (“inquadrato”), adoperato dai musicisti hip per
riferirsi agli “outsiders”, agli Altri da sé, è riassunto il
sistema di credenze relativo alla differenza tra musicisti
jazz e pubblico. La differenza tra hip e square si riferisce a
un modo di pensare, di sentire, di comportarsi, e anche
agli oggetti materiali rappresentativi di un certo mondo.
Va aggiunto che la gran parte dei musicisti jazz degli
anni Quaranta era nero, e dunque questa contrapposizione tra sregolatezza e inquadramento, tra arte e banale normalità, tra energia sessuale e apatia, è stata di
fatto associata alla blackness, all’ “essere nero”. I musicisti
neri, dal canto loro, vi hanno costruito attorno un insieme identitario, mentre il pubblico bianco vedeva in essa
la liberazione politica, la profondità emotiva, l’intensità
sensuale. Un insieme di elementi di fascinazione e diversità da imitare, ma anche un modello maschile vincente
la cui stereotipizzazione sottintendeva una certa ideologia razzista e maschilista che individuava, comunque,
nell’essere nero, un elemento “selvaggio”. Questa visione della blackness conduce tra l’altro allo storico legame
tra primitivismo ed esotismo dell’Altro (Monson, 1995,
pp. 398-404; cfr. anche Spaziante 2007b).
Su questa materia (cfr. Ford, 2002, p. 50), due celebri
saggi sono serviti a costituire l’identità culturale hip-
Lucio Spaziante· Hip, beat, cool. Culture musicali giovanili e sistemi di valore
ster dal punto di vista bianco: “The White Negro” di
Norman Mailer (1957) e “Portrait of the Hipster” di
Anatole Broyard4 (1948). Mailer basa la propria argomentazione su una contrapposizione che diventa tale
anche sul piano del genere: “un uomo o è Hip o è Square
(…) è un ribelle o un conformista” (Mailer, 1957, p.
355, trad. it.). Egli racconta che la “filosofia hip” arriva
nella cultura americana attraverso il jazz, e attecchisce
facilmente in un mondo che era uscito sconvolto dalla
guerra e che era oppresso dal senso di morte derivante
dalla paura atomica. Tre differenti soggetti: bohémien,
delinquente e afro-americano, adoperando la marijuana come “anello matrimoniale”, danno alla luce l’universo hip (ivi, pp. 355-357).
“[Il nero] nella sua musica diede voce al carattere e alla
qualità della sua esistenza, alla sua rabbia come alle infnite variazioni di gioia, lussuria, languore, grugniti, crampi,
strette e grida di disperazione del suo orgasmo. Perché il jazz
è orgasmo, buono o cattivo che sia, e come esso parlò ad una
intera nazione.” (ivi, p.357, trad. it.).
Lo hipster per Mailer è uno “psicopatico”, ovvero, adoperando le parole di Robert Lindner, autore del libro
Rebel Without a Cause5 – The Hypnoanalysis of a Criminal
Psychopath (1944, citato in Mailer, 1957, p. 361, trad.
it.), un “ribelle senza causa, un’agitatore senza uno slogan, un rivoluzionario senza un programma”. Mailer
descrive lo hipster come un nuovo tipo di uomo rivoluzionario, modellato sul jazz, anticonformista, contro
ogni tradizione e obbligo sociale, proiettato sul momento presente e istantaneo (cfr. Ford, 2002, p.50). La descrizione degli hipster che emerge invece dagli scritti di
Broyard (1948) è essenzialmente concentrata sull’ambiente del Greenwich Village e sulle consuetudini legate
ad un consumo di droga, musica, libri, moderato e non
così sfrenato come emerge dalla dostojevskiana mitologia del Beat. Mentre Mailer legge la hipness come un
momento di formazione rivoluzionaria, Broyard legge
il fenomeno come un “testo” (Ford, 2002, p. 52, trad.
dell’autore).
“Come se fosse il figlio illegittimo della Lost Generation, lo
hipster di fatto non stava da nessuna parte (nowhere). E, come
gli amputati che spesso sembrano localizzare le loro più forti
sensazioni nel lembo mancante, così lo hipster ha cercato, sin
dall’inizio, di stare da qualche parte. Era come uno scarafaggio rovesciato sulla schiena: la sua vita consisteva in uno
sforzo di rimettersi diritto. (…) Questo significò la nascita di
una filosofia – una filosofia dello “stare da qualche parte”
(somewhereness) chiamata jive da jibe: accordarsi o armonizzare. (…) Di fatto, la funzione dello hipster era questa: ri-assemblare (re-edit) il mondo con nuove definizioni (…). Tutto
era dicotomico (…) [con un] frequente uso da parte dell’hipster di metonimie e gesti metonimici (fregarsi le mani al
posto di stringere le mani, sollevare un indice, senza alzare
il braccio, come forma di saluto, ecc.).” (Broyard, 1948, pp.
721 e sgg., traduzione dell’autore)
“Conoscere lo spartito” è ciò che contraddistingue la
hipness: possedere una innata consapevolezza. La gestualità hip è, secondo Ford (2002), una scorciatoia
per il significato e, ciò che più è rilevante, sopravvive
alle traduzioni in un altro contesto culturale, proprio
in quanto forma di consapevole deformazione del gesto. Un tratto semantico profondo, assimilabile ad una
“riduzione ironica”, implicitamente traducibile dal linguaggio verbale a quello gestuale fino a quello musicale,
come è rilevabile ad esempio in brani come Misterioso di
Thelonious Monk (Genius of Modern Music Vol. 2, Blue
Note, 1952) e So What di Miles Davis (Kind Of Blue,
Columbia, 1959), brani che Ford definisce come vere
e proprie deformazioni hip delle tradizionali strutture
jazz. Ecco perché a suo parere, questi brani sono adoperati come veri e propri tropi, segni di un processo di
riduzione minimale che come tali vengono reinterpretati e campionati nel pop e nell’hip-hop contemporanei
(cfr. Dusi, Spaziante, 2006).
3. Essere Beat
I saggi, i manifesti e le analisi che si sono occupati di
micro-sistemi semiotici come l’hipness o il beat (entità
culturali, stili, mode, movimenti, generazioni…) hanno avuto un ruolo determinante nel costituirne la loro
stessa natura. Gli scritti coevi all’emergere dei fenomeni hipster e beat (termini che a seconda dei casi si
comprendono vicendevolmente) piuttosto che semplicemente osservarli li hanno addirittura determinati, seguendo un principio paradossale di indeterminazione.
Ciò è particolarmente evidente nel caso del beat e degli
scritti che Jack Kerouac (2001) ha realizzato allo scopo
di definirne o ri-definirne le caratteristiche. Gli scrittori,
i poeti, i musicisti della “Beat Generation” hanno dunque consapevolmente contribuito a costruire la mitologia della loro stessa generazione. L’ambiente culturale
del Greenwich Village era particolarmente funzionale a
determinare una consapevole rinascita identitaria, estetica e finzionale, più che sociale, per cui si diceva che
nel Village nessuno possedesse più una famiglia di origine. Nel dopoguerra, in Europa, è la Francia ad assumere un ruolo centrale quando l’esistenzialismo divenne
un modo di pensare che influenzò l’intero mondo occidentale (al punto che nel giugno 1946 un movimento
filosofico guadagnò anche le colonne di Life Magazine).
La Beat Generation raccolse il testimone del vivere
bohèmien negli Stati Uniti, a New York, tra l’Upper West
Side e il Lower East Side di Manhattan, grazie, tra gli
altri, a scrittori e poeti come Allen Ginsberg, William
Burroughs (apertamente omosessuali, politicamente radicali, consumatori di droghe) e Jack Kerouac stesso.
Nell’ottobre 1955 Ginsberg tenne un reading poetico a
San Francisco che suscitò uno scandalo tale da divenire,
per l’epoca, un evento mediatico6 (cfr. Wilson, 1999, p.
19). Fu però Kerouac con il racconto Sulla Strada (1957)
a realizzare la Bibbia della nuova generazione e ad as-
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
79
Fig. 2 – Miles Davis, Round About Midnight, Columbia,
1955, copertina.
sumersi la responsabilità di incarnare su di sé il beat e
dunque di ridefinirne i caratteri identitari.
“La cosiddetta beat generation era un gruppo di persone, di
ogni tipo di nazionalità, che giunse alla conclusione che la
società faceva schifo.”
Amiri Baraka (The Source, USA, 1999)
80
Beat era il battito del cuore, la battuta del be-bop, ma
era anche beatitudine, era essere vinti e “battuti”, era
essere “fuori” come una navicella spaziale, come uno
Sputnik, dunque beatnik.
“Jack stava seduto impassibile circondato da prostitute. Neal
ricurvo sul volante, fece piegare tutti dal ridere vantandosi
di quell’ infermiera che si era fatto mentre guidava per il
Nebraska e di quando quella venne suonando il clacson.”
Tom Waits, Jack and Neal7
(Foreign Affairs, Asylum, 1977 in The Source, USA, 1999)
Kerouac modellò la propria prosa attorno a un’idea
musicale di narrazione e attorno al tempo musicale del
suonare jazz, il che consisteva a suo parere nell’annullare, nel momento creativo, ogni distanza tra intenzione
e realizzazione, dando massimo spazio al momento improvvisativo, soprattutto sul palco di una performance
(cfr. Noferi, 1997, p.12). Naturalmente questa visione
ingenua dell’improvvisazione sarebbe forse sconfessata
dai musicisti jazz, ma servì in ogni caso come modello
di ricerca creativa.
sa di coscienza della propria condizione sociale subordinata (cfr. Broyard, 1948). Una sorta di convergenza
tra il disagio della cultura nera e della cultura giovanile
bianca, pone qui le basi per una forma di alleanza e
di continuo interscambio, traduzione e assieme sfruttamento, e che si può dire continuino tuttora. Kerouac
racconta (2001, p. 1524) che la guerra di Corea annientò di fatto una prima generazione beat, finita in galera,
in manicomio, o ridotta al silenzio dal conformismo.
Gli hipster erano, appunto, divisi in hot e cool: i primi
sono mossi da un’energia sfrenata al ritmo del jazz tradizionale, i secondi con atteggiamento scostante: ascoltano Miles Davis e Lennie Tristano, gli inventori del cool
jazz; parlano “in tono basso e la loro ragazza sta zitta e
veste di nero” (ib.). Subito dopo la guerra di Corea, con
circa dieci anni di ritardo rispetto all’uso che i musicisti
neri ne facevano, improvvisamente spuntò una vera e
propria “gioventù cool e beat”, identificabile ad esempio nell’icona (cfr. Fig. 4) di James Dean (ivi, p. 1525),
accompagnata da “visioni bop” le quali da patrimonio
elitario divennero patrimonio comune della cultura popolare di massa. Kerouac osserva che “il modo di vestire ‘hipster beat’ ” è passato alla nuova generazione
rock’n’roll “attraverso Montgomery Clift (giubbotto di
pelle), Marlon Brando (T-shirt), e Elvis (basette lunghe)
(…) Forse la Beat Generation, che è il parto della Lost
Generation, è solo un altro passo verso l’ultima pallida
generazione che a sua volta non saprà le risposte” (ib.).
Il cool, la freddezza, termine riferito al controllo delle passioni o all’assenza di uno stato patemico attivato
e manifesto, è un uso metaforico diffuso in numerose
lingue naturali, in differenti epoche, dalle popolazioni
indigene del Brasile al cinese mandarino (cfr. Moore,
2004). Dagli anni Trenta assume però una connotazione positiva all’interno della cultura afro-americana, integrandovi significati relativi al distacco, alla ribellione
e alla consapevolezza. La knowingness, come già detto,
è una qualità centrale del termine e si riferisce ad una
“conoscenza” (knowledge) più interna, un accesso privilegiato al sapere che si possiede. Amiri Baraka, alias
4. Hot e cool
All’interno dell’estetica hipness, oltre l’opposizione hip
vs square si è venuta affermando un’altra attitudine
riferita ad un sistema di valori sullo sfondo, di diretta
emanazione della cultura musicale jazz afro-americana. Si tratta della contrapposizione tra hot (caldo) e cool
(freddo), dove il cool assume il carattere di un momento
di presa di distanza e di auto-osservazione della propria
identità culturale e assieme un momento di fredda pre-
Lucio Spaziante· Hip, beat, cool. Culture musicali giovanili e sistemi di valore
Fig. 3 – Il cosiddetto Rat Pack in una scena di Ocean’s Eleven,
(USA, 1960)
LeRoi Jones, insiste proprio sull’essenza di una forma
di reazione all’ambiente e al mondo, espressa però attraverso la calma e una scarsa impressionabilità; una
difesa contro il razzismo e un disgusto verso la cultura
dominante; qualcosa di affine alle pose di Miles Davis
di quel periodo (ib.): maschere impenetrabili sul volto,
occhiali da sole neri a coprire lo sguardo, eleganza creativa nel vestire (cfr. Fig. 2).
Un atteggiamento minimale sia nel comportamento sia
nell’estetica, che esprime il rifiuto di un eccesso di coinvolgimento emotivo. Quasi una consapevolezza adulta
da contrapporre ad una pregressa fase identitaria infantile: l’individuo cool “parla poco, si muove poco ed
esprime poco” (Moore, 2004, p. 73, trad. dell’autore).
Come è avvenuto più in generale per il beat, anche il
cool diviene una posa di massa di cui si trovano tracce:
in Elvis (Jailhouse Rock, USA, 1957), come già detto; più
ampiamente nel cosiddetto Rat Pack (cfr. Fig. 3), gruppo di attori/cantanti composto, tra gli altri, da Frank
Sinatra, Sammy Davis jr. e Dean Martin; nel personaggio di Holden Caulfield di Catcher in The Rye (Il giovane
Holden) di H. D. Salinger (1951), così come nel succitato
James Dean (Rebel without a Cause, USA, 1955) in onore del quale gli Eagles realizzarono un brano intitolato
James Dean (On The Border, Asylum, 1974) il cui ritornello intonava “You were just too cool for school”, “Eri semplicemente troppo fico per la scuola”.
Per gli adolescenti degli anni Cinquanta che ereditarono il bagaglio di valori del beat, l’atteggiamento di
opposizione che si incarnò nell’essere cool rivelava un
rifiuto di tipo generazionale piuttosto che una consapevole posizione politica anti-razzista o anti-sistema,
come invece era avvenuto per i beat stessi. Nell’essere
cool c’era anche l’idea di essere “nel giusto” e dunque
sentirsi cool per questo; sentirsi la persona giusta al momento giusto, nella giusta collocazione sociale.
5. Cool oltre il cool
Negli anni Sessanta chi adottava il sistema di valori
giovanile aveva il vento dalla propria parte e questo
aspetto, ovvero il rappresentare la novità positiva, fu poi
sfruttato anche dal discorso pubblicitario per effettuare
uno shift e spostare la posizione del cool nella mappa dei
valori sociali. È quanto emerge da The Conquest of Cool,
uno studio di Thomas Frank (1997) che rilegge la relazione tra valori controculturali e l’intero ambito discorsivo pubblicitario comprendente marketing, business e
pubblicità. Secondo Frank, gli scritti sugli hipster come
quello di Mailer (cfr. supra, PAR. 2) hanno “democratizzato” ed esteso i valori bohèmien da una ristretta élite di
artisti, studenti e intellettuali all’intera cultura giovanile.
C’era, a suo parere, una generica richiesta di trasformazione dei valori sociali che venne affidata all’energia del
cambiamento giovanile, inteso come un’avanguardia
cui fu poi agganciato anche il sistema dei valori di consumo. Frank cambia la prospettiva e invece di guardare,
come solitamente è stato fatto, al discorso della contro-
Fig. 4 – James Dean in una scena di Gioventù bruciata
(Rebel Without a Cause, USA, 1955)
cultura, osserva testi e metatesti pubblicitari, singole
pubblicità, libri e riviste di marketing e advertising, dove
egli rileva questa volontà di agganciarsi alle spinte al
cambiamento generazionale. Dunque, invece di seguire
la narrazione consueta che vede contrapposta la controcultura al capitalismo, Frank individua l’esistenza di
una narrazione comune che influenzò reciprocamente i diversi ambiti del discorso sociale. La coolness era
diventata il valore di tendenza proprio perché l’intera
società borghese si stava adattando al cambiamento, e il
discorso pubblicitario se ne servì sin da subito. Esempi,
tra questi, sono: quello della casa automobilitisca Buick,
rappresentativa dei valori della classe media americana per eccellenza, che nel 1970 realizzò una pubblicità
basata sul claim “Light Your Fire”, ispirato al celebre
brano dei Doors, il gruppo simbolo della trasgressione
controculturale; oppure un’altra pubblicità che recitava “1968 Buick. Ora parliamo il vostro linguaggio”.
Anticonformismo, fuga, resistenza, differenza e persino
devianza (pensiamo a quanto suddetto per la bohème, supra PAR. 1) erano ormai i valori di riferimento positivi
con cui era stato polarizzato il linguaggio pubblicitario
degli anni Sessanta negli Stati Uniti. Ciò riguarda in
modo palese il settore della moda e dell’abbigliamento
giovanile ma non solo: se la bibita 7Up presentava nel
1969 una pubblictà con un lay-out psichedelico, l’intero
settore delle bibite giovanili come Coca-Cola, Pepsi e
affini, fu investito e ridefinito dalla trasformazione dell’immaginario giovanile. Un settore per il quale si può
parlare di una vera e propria guerra commerciale basata su un reciproco posizionamento “controculturale”.
La Pepsi lanciò nei primi anni Sessanta la campagna
della Pepsi Generation che presentava un mondo di consumatori quasi “insurrezionalisti”, cosicché le altre marche furono costrette ad adeguarsi. La stessa campagna
fu alla base di una progressiva conquista di segmenti del
settore, ancora sino agli anni Ottanta, durante i quali
Pepsi si proponeva, ancora con successo, come la “scelta di una nuova generazione”.
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
81
82
Il cool diventa così sinonimo di successo, il che sopravanza in modo irreparabile le connotazioni originariamente oppositive del termine. Con il crollo delle ideologie
controculturali l’universo giovanile rimane in ogni caso
al centro del mercato, ma le trasformazioni dello sfondo
valoriale di riferimento creeranno un disorientamento
nella capacità degli analisti di marketing nel comprendere il nuovo scenario. Il cool esiste ancora ma non è
più bene chiaro, ancora una volta, a cosa si riferisca.
Essendo una modalità discorsiva sempre più ad appannaggio delle nuove generazioni, lo sforzo continuo è
proprio nel capire cosa sia cool e cosa non lo sia. E se,
come sin dall’inizio abbiamo visto, esso consiste in una
sorta di conoscenza implicita, ovvero un’essere “in the
know”, è sempre difficile capire da dove venga. La stessa domanda su cosa esso sia è già sintomo del non esserlo e del non essere in grado di comprenderlo, e spesso il
motivo è di ordine cronologico e generazionale.
Alla relazione tra culture giovanili, marche e cool è dedicato un intero capitolo8 di No Logo di Naomi Klein
(2000), la quale osserva che le culture alternative, o
underground, erano oramai divenute un patrimonio acquisito della cultura occidentale. Un patrimonio che,
però, passati gli anni Sessanta, non era più visto dal
mercato come centrale ma come marginale. A parere
di Klein la cultura del riflusso, a partire dalla disco-music
fino all’intero universo preppy9, era composta da valori
edonistici e di consumo, basati sulla cura del corpo e
della bellezza, marche e griffe, in modo tale da relegare
le culture popolari a fenomeni sorpassati e poco interessanti. Il marketing, il mondo delle marche, aveva altri
e nuovi punti di riferimento stabiliti in modo parallelo
all’invecchiare della generazione del baby-boom. Erano i
quarantenni degli anni Ottanta, novelli yuppy, a dettare
apparentemente la tendenza. Negli anni Novanta però
furono marchi come Mtv, Nike, Hilfiger, Microsoft,
Netscape e Wired a determinare le nuove tendenze (ivi,
p. 97, trad. it.): la generazione di Internet giocò le proprie carte di nuovo sull’essere cool, ridefinendone però
i punti di riferimento. Innanzitutto le marche sono il
punto di partenza e non il punto di arrivo: essere cool vuol
dire anzittutto indossare, bere, giocare con quella marca, non più intesa come puro indice di status, ma come
sintomo dell’appartenenza ad un universo. Anche l’Inghilterra del cambiamento voluta da Tony Blair viene
ad esempio definita Cool Britannia (ib.).
È l’osservazione dei comportamenti giovanili, ma soprattutto delle loro pratiche d’uso quotidiane, a determinare cosa è cool. Per questo motivo nasce l’esigenza
da parte delle imprese di avere a disposizione cool hunter,
cacciatori delle tendenze emergenti, che diano suggerimenti su come orientare le proprie strategie di mercato (cfr. Proni, 2007). È di nuovo dalle culture musicali giovanili che arrivano le nuove idee, e ancora dalle
culture afro-americane. L’hip-hop accoglie i marchi e li
trasforma in entità concettuali, amplificandoli. Adotta
la pratica di fare proprie determinate marche ridefinen-
done l’uso a livello locale, ad esempio indossando senza stringhe le sneakers, le scarpe da ginnastica. C’è poi
il caso del marchio Adidas, rivalorizzato dal brano My
Adidas (Raising Hell, Profile, 1986) realizzato dal gruppo
hip-hop Run-DMC, i cui fan sono diventati automaticamente anche acquirenti di scarpe; oppure il caso del
marchio Hilfiger, presidio di uno stile preppy elegantesportivo, pensato per i bianchi benestanti, marchio che
proprio per questo diventa un modello di acquisizione
ed esibizione di status per i neri. Da qui diventa a sua
volta un “marchio hip-hop” e come tale diviene modello per i giovani bianchi o asiatici che vogliano essere
cool. Da qui si intuisce che gli street style (cfr. Polhemus,
1994) e le marche non si associano più casualmente ma
tramite sinergie dedicate.
L’analisi del cool da parte di Klein si conclude sottolineando che un’idea troppo stereotipa di cool, come
mainstream di tendenza, conduce anche al suo opposto,
ovvero ad un cool basato sul proprio opposto, cioè sul
fuori moda. È così che nei primi anni Duemila ritroviamo la tendenza al lo-fi, al country alternativo e al neo-hippie, così come al fuori-moda rilaborato come kitsch, così
da poter dire, citando il brano di Huey Lewis & The
News (Chrysalis, 1986): “It’s hip to be square”.
Note
1
La dizione bohèmien deriva dal libro di Henry Murger (1851),
Scene della vita di bohème, in cui si descrive lo stile di vita degli artisti parigini concentrati nel quartiere di Montparnasse
laddove si registrava un’alta presenza di zingari, provenienti
appunto dalla Boemia. Il bohèmien assume comportamenti
non dissimili da quelli che nella storia sono stati assunti già
nel Medioevo o nel Rinascimento da artisti che “rifiutavano
di accettare convenzioni e che appartenevano, secondo una
pubblica visione, ad una classe separata” (Wilson, 2000, p. 2,
trad. dell’autore).
2
I Zooties, che prendono il nome dal vestito stesso, furono
artefici dello sviluppo di un’identità afro-americana che rinegoziava la propria identità non-bianca, nera o ispanica,
decostruendo il rigore formale dell’abito in direzione dell’ampiezza, dell’irregolarità, dell’eccesso, dell’ironia, della comodità (sullo Zootie style e sugli hipster cfr. anche Calefato, 2001,
pp. 497-498).
3
Va segnalata a margine una sconvolgente vicenda legata all’identità “bianca” di Anatole Broyard, accademico e per decenni brillante critico letterario del New York Times. In punto
di morte, avvenuta nei primi anni Novanta, Broyard rivelò
agli ignari figli un segreto che già circolava nelll’ambiente letterario newyorchese. Egli era figlio di genitori creoli, di madre
nera, e, grazie ad un colore di pelle che era più bianco che
nero, ripudiò la sua origine vivendo un’intera vita da bianco
che studia le culture dei neri. La sconvolgente vicenda è alla
base del racconto di Philip Roth, La macchia umana.
4
Rebel without a Cause è il titolo originale di Gioventù bruciata,
film di culto generazionale di Nicholas Ray (USA, 1955) con
James Dean (cfr. Fig. 4) basato appunto sul libro di Lindner.
5
Il beat era una moda e una posa talmente diffusa da divenire
oggetto di stereotipizzazione, e dunque di derisione, da parte
Lucio Spaziante· Hip, beat, cool. Culture musicali giovanili e sistemi di valore
della società di massa. Persino Totò in Italia realizzò un esilarante sketch comico chiamato “Il contrabbasso esistenzialista” (Totò a colori, Italia, 1952). Il beat è stato forse il primo
movimento giovanile a matrice fortemente letteraria, assieme
bianco-bohèmien e afro-americano, ad essere inglobato nella
cultura di massa e trasformato in etichetta di moda, e come
tale volgarizzato e ridicolizzato dalle copertine dei magazine
fino ai talk-show e ai cartoni animati.
6
Brano dedicato a Jack Kerouac e a Neal Cassady, il quale
servì da modello per il Dean Moriarty di Sulla strada.
7
Ringrazio Gianfranco Marrone per la preziosa segnalazione.
8
Definizione gergale che sta per “fighetto” WASP.
Bibliografia
Barthes, R., 1957, Mythologies, Paris, Seuil ; trad. it. Miti d’oggi,
Torino, Einaudi, 1974.
Becker, H., 1963, (nuova ed. 1973), Outsiders: studies in the
sociology of deviance, New York, The Free Press; trad. it.
Outsiders: saggi di sociologia della devianza , Torino, Edizioni
Gruppo Abele, 1997.
Broyard, A., 1948, “Portrait of the Hipster”, Partisan Review,
15, 6, pp. 721-727.
Broyard, A., 1951, “Keep Cool, Man”, Commentary, 11,
pp.359-362.
Calefato, P., 2001, “ ‘Light my FirÈ: Fashion and music”,
Semiotica, 136, 1/4, pp. 491-503.
Connor, M.K., 1995, What Is Cool? Understanding Black Manhood
in America, New York, Crown.
Danesi, M., 1994, Cool: The Signs and Meanings of Adolescence,
Toronto, Univ. of Toronto Press.
Dusi, N., Spaziante, L., 2006, (a cura di), Remix-Remake. Pratiche
di replicabilità, Roma, Meltemi.
Ford, P., 2002, “Somewhere/Nowhere: Hipness as an
Aesthetic”, The Musical Quarterly, 86, 1, Spring, pp. 4981.
Frank, T., 1997, The Conquest of Cool: Business Culture,
Counterculture, and the Rise of Hip Consumerism, Chicago,
Univ. of Chicago Press.
Gold, R.S., 1957, “The Vernacular of the Jazz World”
American Speech, 32, pp. 271-82.
Greimas, A.J., Fontanille, J., 1993, «Le beau geste», Recherches
sémiotiques/Semiotic Inquiry, 13; trad. it. «Il bel gesto» in
M.P. Pozzato, a cura, Estetica e vita quotidiana, Milano,
Lupetti,1995.
Kelley, M., 2000, “Cross Gender/Cross Genre”, PAJ: A Journal
of Performance and Art, 22, 1, pp. 1-9.
Kerouac, J. (1957), On the road, New York, New American
library (trad. it. Sulla strada, Milano, A. Mondadori,
1959).
Kerouac, J., 2001, Romanzi, I Meridiani (a cura di Mario
Corona), Milano Arnoldo Mondadori.
Klein, N., 2000, No logo: no space, no choice, no jobs. Taking aim
at the brand bullies, London, Flamingo; trad. it. No logo,
Milano, Baldini & Castoldi, 2001.
Lindner, R.M., 1944, Rebel without a cause: the hypnoanalysis of a
criminal psychopath, New York, Grune & Stratton.
Landowski, E., 1989, La société réfléchie, Paris, Seuil; trad. it. La
società riflessa, Roma, Meltemi, 1999.
Lotman, J.M., 2006, Tesi per una semiotica delle culture, a cura di
Franciscu Sedda, Roma, Meltemi.
MacAdams, L., 2001, Birth of the Cool: Beat, Bebop, and the
American Avant-Garde, New York, Free Press.
Mailer, N., 1957, “The White Negro: Superficial Reflections
on the Hipster”, Dissent, 4, 3, pp. 276-293, poi in
Advertisements for myself, New York, G. P. Putnam’s Sons;
trad. it. Pubblicità per me stesso, Milano, Bompiani, 1978.
Majors, R., Mancini-Billson, J., 1992, Cool Pose: The Dilemmas
of Black Manhood in America, New York, Macmillan.
Marconi, L., 2007, “Autenticità e artisticità rock” in U. Eco et
alii (a cura di), Historia: la grande storia della civiltà europea,
Il Novecento, vol. II, Milano, Federico Motta, pp. 701702.
McRae, R., 2001, “ ‘What is hip?’ and Other Inquiries in Jazz
Slang Lexicography”, Notes, 57, 3, March, pp. 574-584.
Monson, I., 1995, “Music Anthropologies and Music
Histories”, Journal of the American Musicological Society, 48,
3, Autumn, pp. 396-422.
Moore, R.L., 2004, “WÈre Cool, Mom And Dad Are Swell:
Basic Slang And Generational Shifts In Values”, American
Speech, 79, 1, Spring.
Murger, H., 1851, Scènes de la vie de Bohême, Paris, M. Lévy
frères; trad. it. Scene della vita di Boheme, Milano, Rizzoli,
1952.
Noferi, M., 1997, “Jazz and the Beat Generation: The Musical
Model in Literature”, Jazz and American Culture, 3, Fall.
Polhemus. T., 1994, Street style: from sidewalk to catwalk, New
York, Thames and Hudson.
Pountain, D., and ROBINS D., 2000, Cool Rules: Anatomy of an
Attitude, London, Reaktion.
Proni, G., 2007, (a cura di), Leggere le tendenze: nuovi percorsi di
ricerca per il marketing, Milano, Lupetti.
Roszak, T., 1969, The making of a counter culture: reflections on
the technocratic society and its youthful opposition, Garden City,
N.Y., Doubleday; trad. it. La nascita di una controcultura:
riflessioni sulla società tecnocratica e sulla opposizione giovanile,
Milano, Feltrinelli, 1971.
Salinger, J. D., 1951, The Catcher In The Rye, Boston, Little,
Brown; trad. it. Il giovane Holden, Torino, Einaudi, 1961.
Spaziante, L., 2007a, Sociosemiotica del pop. Identità, testi, pratiche
musicali, Roma, Carocci.
Spaziante, L., 2007b, “La musica popular e gli studi culturali”
in C. Demaria, S. Nergaard, (a cura di), Studi culturali.
Temi e prospettive a confronto, Milano, Mc Graw-Hill, pp.
255-292.
Stearns, P.N., 1994, American Cool: Constructing a TwentiethCentury Emotional Style, New York, New York Univ. Press.
Thomas, L., 1992, “ ‘Communicating by Horns’: Jazz and
Redemption in the Poetry of the Beats and the Black
Arts Movement”, African American Review, 26, 2, Summer,
pp. 291-298.
Wilson, E., 1999, “The Bohemianization of Mass Culture”,
International Journal of Cultural Studies, 2, 11, pp. 11-32.
Wilson, E., 2000, Bohemians: the glamorous outcasts, London,
New York, I.B. Tauris.
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
83
Nietzsche ha molto insistito sul rapporto tra la vita
mentale di ogni filosofo e le sue esperienze più umane e mondane. Se nella maggior parte dei casi si può
riscontrare una chiara affinità tra il loro profilo biografico e quello teorico, in altri più sporadici, la scissione
tra il loro vissuto e il loro pensiero è disarmante. Accade
così che uno sperimentatore di pratiche sessuali estreme
quale era il Michel Foucault della biografia di J. Miller,
potesse rivolgere alla concezione moderna della sessualità una critica tanto radicale da farlo avvicinare alle
posizioni di un bigotto moralista. Ne La Volontà di sapere,
opera dedicata del rapporto tra forme di potere, linguaggio e piaceri, il filosofo francese giunge a mettere
in discussione quella “ipotesi repressiva” che aveva contrassegnato buona parte del pensiero filosofico e psicanalitico novecentesco. Al suo opposto, si delinea invece
un’idea dirompente: la dispersione e la moltiplicazione
di pratiche sessuali non-convenzionali sarebbero direttamente prodotte, e non ostacolate, dallo sviluppo della
società borghese e dai nuovi stili di vita da essa imposti.
Si parla di “produzione del piacere” o di “piacere della verità di piacere” per indicare come i registri della
scienza, della medicina e della giurisprudenza abbiano
approntato formule e strumenti d’esortazione e d’induzione del desiderio che la Società dello spettacolo, in
una fase più avanzata, è riuscita sapientemente a sublimare. Il recente sviluppo della cultura occidentale sarebbe dunque segnato da questa tremenda distonia che
tenta di rimuovere ciò che in realtà è ingenerato, dalle
sue invenzioni più eminenti, nel corpo stesso del sociale.
Questa cultura, sperimentando nuovi discorsi per estorcere o produrre la verità del desiderio, ha trasformato
l’uomo moderno in una “bestia da confessione”.
Sappiamo che il legame tra scienza, progresso e sessualità solo recentemente ha confermato l’idea di una
sostanziale convergenza sul tema della liberazione sessuale. Agli albori della modernità, invece, si dava un
disgiunzione netta nel senso che vigeva una sostanziale
scissione tra il progresso della scienza, la morale consolidata e informata dai precetti della Chiesa, e la problematica sessuale. Nella Nuova Atlantide di Bacone, ad
esempio, i mirabili progressi in campo scientifico non
determinano una trasformazione in senso laico dei costumi, anzi sono la premessa per il consolidamento di
una società più giusta, in cui la castità è il valore essenziale al contrario di quel che accadeva in Europa, dove
proliferavano, secondo l’autore, lupanari e prostitute.
Senza voler ricostruire la dinamica evolutiva del rapporto tra sessualità, scienza e linguaggi della cultura,
potrebbe esserci utile una breve riflessione su quelle che,
a tutti gli effetti, rappresentano vere e proprie “fratture
epistemologiche”.
Al di là della grande epoca della rivoluzione sessuale,
che è deragliata verso il cliché iperconsumista della
pornografia anni Ottanta, l’effetto collaterale di quella trasgressione istituzionalizzata è stato il saper occultare i reticoli di relazioni di potere che governavano
E|C Serie Speciale
Anno I, n. 1 2007, pp. 85-89
ISSN (on-line): 1970-7452
ISSN (print): 1973-2716
EC
Revival dell’estetica pop-porno
Nello Barile
il campo della sessualità. Tanto che, per dirla ancora
con Foucalut, la tremenda ironia di questa “messa in
linguaggio” del sesso è farci credere che “ne va della
nostra liberazione”.
Ora vediamo come, a più di vent’anni di distanza dalla
sua morte, quelle tesi si rivelano ancora più valide e al
passo con i tempi. Ciò è riscontrabile a partire dall’analisi di vari discorsi mediatici, nuovi dispositivi tecnologici e pratiche di consumo a essi associate, che avrebbero
socializzato le estetiche della pornografia trasformandone profondamente il significato.
Flesh è il formidabile video di animazione 3D presentato nella sezione short one del Resfest 2004. Il filmato
realizzato da Eduoard Salier utilizza la perfezione dell’estetica digitale per mettere in scena una singolare rilettura dell’innominabile 11/09. È importante ragionare su questi prodotti visuali perché oggi, ancor più dei
video musicali, sono capaci di cogliere ed esprimere le
trasformazioni dello spirito del tempo. Sin dalle prime
sequenze le superfici dei grattacieli di New York sono
schermi pubblicitari che trasmettono immagini dinamiche a una città deserta, spettrale, da cui l’elemento
umano è rimosso e l’architettura spicca nella sua totale
autosufficienza. Ma il tratto distintivo ed esasperato di
questo onanismo onirico è dato dalle superfici-schermo dei palazzi sui quali l’unica forma di vita concepibile, esibisce la sua più profonda oscenità. Immagini
gigantoscopiche e ologrammatiche di masturbazioni
femminili, di orgasmi al rallentatore, di orge lesbiche
si susseguono in una temporalità dilatata che ne amplifica l’effetto surreale. La superficie esterna dei palazzi,
la stessa pelle della metropoli, è in realtà il principale
strumento di promozione di un’estetica pornografica.
Il panorama spettrale della metropoli è tutto rivolto
alla contemplazione di quella forma di vita, ogni altra
attività è marginale, insignificante, epifenomenica rispetto a quel sentire profondo che irrora e ossessiona
© 2007 AISS – Associazione Italiana di Studi Semiotici
T. reg. Trib. di Palermo n. 2 – 17.1.2005
86
la nuda carne. Da Oriente a Occidente, sospeso tra il
disprezzo e la passione, tale sentire è il fulcro di uno
scontro culturale generalizzato, che non investe tanto
raggruppamenti o dottrine, ma la stessa interiorità dei
soggetti, dilaniati dalle forze contrarie della repulsione e
della fascinazione. Come dire che, nel bene o nel male,
tutto è pornografia. Così, l’eternità senza fine della riproduzione del desiderio, è infranta solo da un’azione
irruente e inattesa. Un oggetto alieno, completamente nero si staglia dallo sfondo colorato, e seguendo la
direttrice del nostro punto di vista, si scaglia contro il
suo obiettivo. Il 747 irrompe nel paesaggio metropolitano infrangendo un grattacielo che esplode come fosse
un cristallo rosso. A esso segue una sinfonia seriale di
suoi simili che si scaraventa sulla totalità degli edifici
mentre in sottofondo suona un brano lento, vagamente
psichedelico. L’effetto videogame amplifica quel senso
di colpa collettivo nei confronti di un atto così tremendo
ed esorbitante – che per Baudrillard, l’Occidente stesso
ha sognato – ma allo stesso tempo produce un torpore
estetico che narcotizza il ricordo. La scorribanda concepita come rivendicazione del primato della tattica
contro la strategia, di Davide contro Golia, ora invece
si riproduce nella moltiplicazione seriale dell’impatto,
come montaggio digitale della miriade di riprese trasmesse dai media, come immediata predisposizione
dell’evento (anche il più irriducibile e impensabile) nella
routine dello spettacolo globale.
L’accumulazione ossessiva di scene sull’impatto, in effetti, hanno trasformato tale tragedia in un’immagine
familiare, in un appuntamento fisso che ha addomesticato lo sguardo dell’audience mondiale. In quella riproduzione standardizzata di un evento singolare, irriproducibile, c’è forse una denuncia, oppure un presagio.
L’idea che forse quell’azione dipinta come la quintessenza dell’agire tattico non lo era affatto, che forse c’era
una certa interdipendenza tra gli aggressori e le vittime,
o addirittura che l’azione tattica era solo un espediente: la semplice messa in scena di una visione cinica per
pianificare la politica globale dei prossimi cent’anni e
più (come del resto denuncia il video Confronting the evidence Jimmy Wlater). Volendo prescindere dalla visione
politica che ha stimolato il creativo, mi soffermerei sull’idea semplice, immediata, onnipresente che ne riassume tutto il contenuto. La pornografia come fulcro,
come ideale, o semplicemente come perimetro simbolico entro cui si edifica l’identità occidentale. Nel parallelo, piuttosto banale, tra architettura e pornografia
si annida certamente un’idea troppo ovvia per essere
sostenuta. L’esibizione della potenza dell’Occidente è
passata anche e soprattutto per l’edilizia civile che ha
spesso riproposto il mito di una Babele fallocentrica
nelle sue torri ascensionali. E quando tale passione si
e moltiplicata in Europa e Asia, quella sottesa allegoria
diventa sempre più esplicita; basti vedere la Swiss Re
Tower di Norman R. Foster a Londra (chiamato dai
cittadini Dildo o “cetriolo erotico”), oppure la morfolo-
Nello Barile · Revival dell’estetica pop-porno
gia ancora più allusiva della torre Agbar di Barcellona.
La metropoli con il suo paesaggio è un perfetto punto
di raccordo tra il mainstream e le culture alternative, tra
le regge pensili dei grattaceli e le vite gettate per strada.
Ecco perché l’idea di utilizzare le pareti degli edifici a
mo’ di schermi – seguendo ormai una pratica diffusa
dai pubblicitari – risulta significativo ai fini del nostro
discorso.
Fino a qualche anno fa l’estetica pornografica connotava circuiti alternativi di produzione e di distribuzione,
specifici contesti culturali, scene artistiche o sottoculturali. Con gli anni Settanta, il fenomeno si estende notevolmente ma persiste grazie a una serie di rivoluzioni
culturali che provengono in parte dal mondo della contestazione e della trasgressione giovanile. Ma quasi tutte
le sottoculture, tra cui quelle del Glam Rock e del Punk,
hanno esibito i segni della provocazione pornografica
attraverso un metalinguaggio capace di differire l’immediatezza dell’atto, surrogandola attraverso molteplici
simboli o situazioni. Dalla visione delle sequenze più
scabrose di Jubelee di Derek Jarman, è davvero difficile
estrarre immagini etichettabili come “pornografiche”.
La cultura underground americana dei primi anni
Ottanta, che proprio dal punk prendeva piede, interviene in modo più esplicito sull’utilizzo dell’immaginario pornografico. La scena dello psichobilly trash, da
cui proviene la celebre band The Cramps, ammicca
all’estetica degli anni Cinquanta e delle pin up, traducendola nei cliché dell’estetica porno che negli anni
Ottanta registrava una netta espansione. La musica
hard core, che non a caso riprende la definizione di uno
specifico genere, e la cultura underground newyorkese lavorano molto su tale concetto trasformandolo in una sorta
di critica ideologica esasperata. Nelle opere audiovisive
di Richard Kern, del resto, si mescolano eminentemente la violenza concettuale e quella visuale di una certa
scena underground (Sonic Youth, Lidia Lunch, Henry
Rollins). Il problema di una sostanziale liberalizzazione
dell’estetica porno era avvertito dalla moralità comune,
soprattutto in rapporto alla profusione di immagini altamente seducenti che da ogni parte ammiccavano allo
sguardo dello spettatore. “La superficie delle immagini
provocanti”, come la chiamò Stuart Ewen, ammaliava
e spaesava, con l’intento di convincere lo spettatore a
comprare o a servirsi. Il processo era già in atto, ma la
pletora di intellettuali di turno non potevano ammettere
che nella continua sollecitazione dello sguardo messa in
atto dai media, si annidasse la svolta verso una radicale
esplicitazione del linguaggio erotico. In quel passaggio
però, il meccanismo di sanzione dell’ovvio, già descritto nell’introduzione, agiva come mezzo per occultare e
rimuovere l’evidenza di un processo che si dava come
troppo scontato e banale, dunque altamente improbabile. Nel decennio successivo, quella sorta di sguardo
antropologico diffuso, che trapelava da una letteratura
dedicata all’argomento, da una serie di dibattiti culturali
e da nuovi prodotti mediali posti al confine tra industria
culturale di massa e pubblici indipendenti, fecero sfumare il timore collettivo nei confronti della porno-epidemia. E quel decennio rappresentò un punto di svolta.
Non che il numero di immagini proposte dalla Tv, dalla
pubblicità e dai nuovi media fosse meno ammiccante
e più pudica. Ma la retorica attraverso cui erano proposte, aveva assorbito parecchio intellettualismo proveniente dalla controcultura. Dosi massicce di autoironia
riuscivano così a sdrammatizzare il culto delle superfici
lucide, l’ossessione tecnica per il dettaglio, come anche
il voyeurismo dilagante. La stessa oscenità presunta dei
reality, che sin dall’esordio promettevano rivelazioni
scottanti, era in realtà velato proprio dall’esposizione
permanente degli spettatori alle telecamere che avvolgeva la loro intimità di una nuova patina, quella offerta
dal dubbio fondamentale: “ma recitano se stessi oppure
fanno sul serio”, oppure fanno sul serio fingendo di recitare, oppure…
Nell’arco degli anni Novanta si consacra il successo
diffuso di un’estetica fetish nella comunicazione e nella
moda, nell’arte e nello spettacolo, che finalmente regalava a un pubblico di massa (che già s’andava demassificando), i contenuti e i cliché di un culto segreto fatto di
pratiche poco ortodosse ma tutto sommato facilmente
notiziabili. Il feticismo di massa difatti nascondeva l’atto sessuale dietro un metalinguaggio fatto di oggetti e
atteggiamenti che lo surrogavano o lo differivano verso un pubblico più esteso. Il tutto quindi era giocato
sull’opacità dei simboli sessuali, sull’abuso della comunicazione ironica che sdrammatizzava ogni pretesa di
seriosità. In altri termini si tendeva a intellettualizzare
l’atto sessuale, moltiplicando le allusioni, le ambiguità,
i punti di vista e le chiavi interpretative. Una polisemia
che appunto inizierà nuovamente a schiacciarsi sul dato
brutale della rappresentazione fine a se stessa, quando
si passerà al nuovo corso. Quando cioè l’abuso di ironia da parte del fetish preparerà l’avvento di una nuova
ondata di porno visioni, molto più vivide, impattanti e
soggioganti.
Negli anni Novanta Philippe Breton riduceva all’osso
il funzionamento dell’estetica pornografica basandola
su due caratteristiche fondamentali: l’attivazione immediata del desiderio, la riproduzione tecnica della performance. Ma se il successo di tale formula, cavalcava la
travolgente utopia della comunicazione e del suo potere
simulacrale, oggi le cose stanno in modo affatto diverso.
Pensatori come Mario Perniola – che dieci anni or sono
esaltavano i concetti come il Sex appeal dell’inorganico
– oggi hanno rimodulato la loro vena critica contro lo
stesso concetto che in precedenza celebravano. Il suo
Contro la comunicazione cerca infatti di mettere in discussione il potere contemporaneo di tale sistema. Se lo
“scopo della comunicazione è favorire l’annullamento
di ogni certezza e prendere atto di una trasformazione
antropologica che ha mutato il pubblico in una specie
di tabula rasa estremamente sensibile e ricettiva, ma incapace di trattenere ciò che è scritto su di essa oltre il
momento della ricezione e della trasmissione” l’estetica invece “deve seguire una strategia opposta allo spin:
essa sta dalla parte delle gabbane, cioè degli habitus,
delle forme, dei rituali, i quali permangono nella loro
esteriorità come qualcosa di stabile e di condiviso anche quando il loro significato è scomparso o è diventato
inconscio o non è mai esistito”. Sebbene questa visione paia fortemente reazionaria rispetto alle traiettorie
seguite dalla modernità globale, essa è certamente in
linea con i diversi punti di crisi che abbiamo evidenziato. Si tratta dunque di una constatazione coraggiosa
che coglie con puntualità alcune fluttuazioni dello zeitgeist contemporaneo ma che svaluta eccessivamente il
ruolo della comunicazione. L’idea che la “permanenza
dei valori” sia appannaggio esclusivo dell’estetica deriva da una concezione strategica dei linguaggi mediali,
che sarebbero strumenti governati dalla mutevolezza e
dalla “logica dello spin”. A ben vedere il presente ci sta
insegnando a riconoscere l’importanza di un’interpretazione tattica della comunicazione che fa leva su – e si
rivolge a – corpi “reali”, valori forti, esperienze autentiche. Dunque l’estetica dovrebbe cogliere il modo in cui
la comunicazione assomma queste distinte modalità,
piuttosto che limitare il tutto a una vecchia “strategia”
di comunicazione.
L’approdo massivo di miriadi di frammenti della scena
underground americana nel cuore dello show biz mondiale, ha sdoganato definitivamente tale sensibilità nel
cuore della cultura ufficiale e si potrebbe addirittura
sostenere che il generale processo di compenetrazione
tra mainstream e culture alternative (il fatidico underground
becoming overground) si realizzi in un territorio delimitato dall’estetica porno. Il connubio tra arte e comunicazione degli anni Novanta ha contribuito a delimitare il perimetro entro cui è andata consolidandosi tale
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
87
88
sensibilità. L’immaginario criptoamatoriale di Therry
Richardson ha in effetti disarcionato l’idea apollinea di
una pornografia patinata, sterilizzata, glamour. Le sua
fotografia richiamava più direttamente quelle pratiche
dilettantistiche di esibizionismo, di oscenità domestica
che giocava sul cliché dell’autoproduzione. Ancor di
più nell’estetica di Templeton il discorso si fa più esplicitamente collegato alla realtà della strada e delle sottoculture, alla rivendicazione di una diversità culturale
e di un atteggiamento “confrontational” che ribadisce
l’ostentazione del corpo come rivendicazione di una diversità culturale.
Una volta Roland Barthes ha detto che “…il sesso è
ovunque tranne che nel sesso”. Ma oggi, proprio perché è ovunque, esso risiede ancora più estremamente
nel sesso stesso. Le particelle elementari, diretto da Oskar
Roehler sulla sceneggiatura del celebre libro di Michel
Houellebecq, ha denunciato la mancata utopia flower
power che ha tentato di liberare il sesso senza poterne
controllare la potenza occulta. Nella figura della madre
ex “fricchettona” si condensa il senso di una mancata rivoluzione sessuale che s’inginocchia al cospetto di
una fallocrazia spettacolare. Allo stesso modo uno dei
figli, intrappolato in una sorta di rigetto postedipico,
esprime tutto il suo odio sciovinista nei confronti della
madre, della generazione che lei rappresenta, dei valori
“di sinistra”. Ma anch’egli è costretto, proprio quando
incontra l’unica donna disposta ad amarlo, a inseguire la medesima lussuria della madre, moltiplicandola
all’ennesima potenza. La scena soave e tremenda dell’ammucchiata in cui i due innamorati incrociano il
loro sguardo mentre copulano con partner occasionali,
mostra il traguardo di un totale sganciamento dell’amore dal sesso e collega tale problematica con altre di scottante attualità.
Del resto la pratica dello swing enuclea completamente, o quasi, la sessualità dalla coppia e induce a concepire quest’ultima come un legame opportunistico di
mutua assistenza o come un legame amicale, affettivo
o di mutua assistenza, che però prescinde dall’attività
sessuale. Anche il film Shortbus di John Mitchell tocca
alcuni aspetti della questione, ma lo fa intervenendo
sulla differenza di sensibilità tra il mondo etero e quello gay. Secondo uno dei protagonisti, che è geloso e
turbato dalle proposte poligamiche del partner, “…la
monogamia è una cosa da etero”. Nel film si esibisce surrettiziamente il punto di contatto tra una pornografia
omosessuale e una etero. Tra le due ovviamente trionfa
la prima dato che presuppone l’altra. Il regime di permutabilità incondizionata tra i corpi; la possibilità di
ragionare nei termini di corpi-segno equivalenti e intercambiabili; l’impostazione tecnica del rapporto; l’eccitazione incondizionata e permanente che si concretizza nella scena della auto-fellatio, attraversano il film
senza incidere su un’umanità profonda, talvolta leggera e scanzonata, oppure irrimediabilmente disperata.
Se la protagonista proverà tutte le strade per vivere il
Nello Barile · Revival dell’estetica pop-porno
suo orgasmo, la coppia di gay rappresenta una sorta
di modello di riferimento ed è continuamente spiata,
seguita e registrata dal loro vicino di casa che ne vive le
vicende come fosse un reality autoprodotto. Lo spione
si trasforma, a seconda dei casi, in voyeur, in paparazzo,
in stalker. Il film si pone al di là dei cliché tipicamente
pornografici e tende a sublimare i contenuti espliciti attraverso una leggerezza sentimentale che oscilla tra il
farsesco e il tragico.
In un seminario organizzato dalla Iulm di Milano e
dalla Iuav di Venezia sulla teoria dell’estetica, Paolo
Fabbri ha inaugurato i lavori esaminando il rapporto
tra distanza critica dell’osservatore e funzione simbolica
degli oggetti, sostenendo che l’oggetto ha incorporato
la concezione della critica divenendo così inattaccabile.
In effetti è vero che dall’epoca delle avanguardie e del
ready made duchampiano sino a quella del feticismo di
massa, gli oggetti hanno subito questo processo di sovra
intellettualizzazione che li ha resi più autocritici della
critica stessa. Ma è anche vero che nelle più recenti manifestazioni essi hanno perso quella componente autoironica degenerando nella pura esibizione oscena. Così
il nuovo status sociale dell’estetica porno, nell’arte, nei
media, nella vita quotidiana, è quella di riproporre una
radicale resistenza all’azione della critica senza proporre alcun contenuto alternativo ai suoi valori, alla sua
stessa “messa in scena”. Non si può pertanto criticare
tale dispositivo senza essere tacciati di bacchettonismo,
passatismo, moralismo ecc. e tutto ciò s’inscrive eminentemente in una prospettiva neototalitaria. Anche
qui funziona il “meccanismo di sanzione dell’ovvio”, in
quanto sarebbe troppo facile esprimersi contro tale egemonia che ormai gioca sul doppio livello della trasgressione e della istituzionalizzazione, della devianza e della
norma, del trash cosmopolita e di quello folcloristico.
Senza alcuna pretesa di ricostruire una storia della sensibilità porno, è interessante notare come tale prospettiva si rafforzi nell’affermazione di un sistema di valori
e di estetiche condivise tra la cultura mainstream e le culture alternative. Se in passato il porno come trasgressione, come ribellione o come semplice scostamento da
uno stile di vita bigotto e ipocrita, esprimeva una sua
propria specificità culturale che rimarcava il profondo politeismo dei valori occidentali, oggi invece capita
esattamente l’opposto. La presenza ingombrante, capillare o modulare della comunicazione pornografica,
dimostra come all’interno dell’Occidente contemporaneo, e di qualsiasi altro estremo Occidente, non esista
più alcuna dialettica tra sistema e sottosistemi, tra cultura dominante e culture subalterne. Ci sono semmai
infinite variazioni sul tema che però non costituiscono
certo violazioni della regola. Se dal punto di vista della cultura ufficiale, il ricorso a un’estetica pornografica
rappresenta il tentativo di discostarsi dall’ovvietà di un
immaginario generalista, attraverso un’immagine trasgressiva e borderline, al contrario le culture alternative sfruttano tale estetica come punto di contatto, come
raccordo con un audience più estesa, come trampolino
di lancio per l’approdo al successo. Da un lato abbiamo i diversi video porno di Pamela Anderson oppure
quello più recente di Paris Hilton che, con la purezza
scintillante della sua icona pop, ha colpito persino l’immaginazione dello stesso Richardson, assolutamente
interessato a volerla ritrarre ad ogni costo. Dall’altro,
i beniamini provenienti dai sottoscala, dai garage, dai
centri sociali. Le regine dell’odierna cultura pop che
utilizzano la circolazione on line delle loro performance intime come il principale strumento di affiliazione
e di fidelizzazione del loro pubblico al loro nome, che
nel frattempo si è trasformato in un brand globale. Al
di là della pubblicità con la P maiuscola, delle kermesse e delle premiazioni, lo strumento di un marketing
virale che contagia gli spettatori nel passaparola masturbatorio è una delle frontiere più avanzate dell’odierno marketing delle celebrità. All’inverso, l’adozione
di uno stile porno da parte dei contesti sottoculturali
cerca di interpretare quell’atteggiamento confrontational
e antagonista, come biglietto d’ingresso nella cultura mainstream: come un salto nel cuore pulsante dello
spettacolo globale. Il processo di estetizzazione della
vita quotidiana, che ha investito le società moderne a
partire dagli anni Cinquanta, ha mostrato le sue punte
più avanzate al centro e ai margini della società. Da un
lato la storia del divismo ha creato una nuova mitologia
moderna fatta di figure esemplari che si ponevano al
di là delle convenzioni sociali. Dall’altro il bacino delle
sottoculture giovanili, vera e propria prosecuzione del
progetto delle avanguardie novecentesche, andava sperimentando linguaggi di resistenza che repellevano la
cultura ufficiale. Oggi, dalla generale implosione delle forme spettacolari sulla vita quotidiana, emergono
nuove figure capaci di coniugare tratti tipici del divismo
“mondano” con elementi caratteristici della storia delle
sottoculture. E così oggi le ragazze suicidio si cimentano in prove tecniche di divismo “fai da te”. Attraverso
la promozione offerta da alcuni siti web, queste figure,
al contempo piccole star e grandi fan, sono in grado di
affermarsi in circuiti indipendenti e, talvolta, di conseguire un consenso che va al di là delle loro stesse ambizioni. L’estetica alla quale fanno riferimento è quella
dell’Indie porno, che a partire dagli anni Ottanta ha caratterizzato molteplici espressioni della cultura underground statunitense. L’iniziativa nasce nel 2003 a opera
di Piggy Suicide. In quel periodo, la fotografa statunitense
inizia a raccogliere sul suo sito immagini di ragazze che
condividono una medesima passione per i linguaggi
più disparati dello stile punk, goth, pervs, mixati con
un palese ammiccamento all’epoca d’oro delle pinup, agli anni Cinquanta e all’icona di Betty Page. Nel
processo di sfaldamento delle sottoculture giovanili che
ha accompagnato gli anni Novanta, i pezzi d’identità
che contraddistinguevano i singoli gruppi, sono entrati
nel sistema di circolazione globale delle informazioni e
hanno dato vita a quello che Ted Polhemus ha chiama-
to anni fa sampling&mixing. Ora il sito conta più di mille
iscritte: giovani cantanti, aspiranti attrici, performer o
DJ. L’etichetta Suicide Girl è divenuta un brand commerciale che opera come agenzia di booking per modelle e
cantanti. Nella descrizione politicamente corretta che
solitamente accompagna queste operazioni, non poteva
mancare un ammiccamento alle teorie post-femminste
e sex positive. Tra i fruitori a pagamento della nudità
tatuata e “pirsata” delle ragazze, che ammiccano all’atto senza metterlo “in atto”, il 40% è di sesso femminile.
Se in SG, la grana stessa delle immagini dichiara inequivocabilmente il contenuto, in altri strumenti d’interazione o di autopromozione – mi riferisco a MySpace
– la pornografia è più sul background, sullo sfondo biografico ed emozionale dei protagonisti. Nel desiderio
ossessivo di spostare il piano della propria identità dalla
sfera quotidiana a quella globale, il vettore più semplice, immediato, condiviso, è quello di un metaregistro
porno, molto semplice da adottare. Del resto, che la
pornografia fosse uno dei motori principali del web lo
si sospettava da tempo. L’attenta ricerca del DJ italiano
Sergio Messina sul fronte delle produzioni amatoriali
che pullulano in rete, ha destato il profondo interesse
da parte di Mark Dery che ha deciso di definirlo come
la Margaret Mead del Net porno: un antropologo che
studia le più avanzate pratiche di affermazione della
nuova sessualità. Secondo Messina, mentre l’industria
musicale ha colto con netto ritardo le opportunità offerte dal web, quella del porno ha invece sfruttato sin dall’inizio tutte le potenzialità del nuovo mezzo. Dunque
dal luogo della metropoli tale interazione si sposta nel
luogo “virtuale” del web che, nella riflessione di Alberto
Abruzzese, è il luogo della continuazione del progetto
comunicazionale della metropoli, ma anche del suo superamento. Lo stesso sociologo, in un indimenticabile
convegno a Roma nel 1996, evidenziava la compatibilità tra questi due mondi, addirittura evidenziando come
la fruizione pornografica avesse anticipato o preparato
l’avvento della cultura digitale.
Oggi il web rappresenta il territorio di massima affermazione della logica neototalitaria entro cui l’immaginario generalista e pop si va spogliando della sua vocazione egemonica per relazionarsi allo spettatore in
modo diverso, disinibito e più autentico. Di contro – ma
lo si è ampiamente dimostrato – il web è anche lo strumento promozionale di realtà occultate nei meandri
dell’esistenza quotidiana, oppure di culture alternative
che, grazie a questo strumento, possono espandersi su
scala globale: passando da una visibilità tattica a una
strategica.
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
89
A differenza dei ritmi della house music, della drum’n
bass o dell’electro, per citare tre fra i più noti generi di
musica elettronica dance, le sonorità della musica techno – in virtù, dell’assenza dell’elemento verbale, della
lunga durata delle tracce e del rincorrersi fra il fattore
deterritorializzante e quello ripetitivo – risultano sensibilmente vicine alle composizioni del repertorio della
musica classica occidentale.
Con questo assunto intendiamo indicare un’omologia
diretta fra l’oggetto “techno” e la musica “senza parole”
per excellance, la musica classica, al fine di fugare sin dal
principio l’ormai obsoleto bando con il quale il genere techno è stato sbrigativamente bollato da parte di
certa critica musicologica colta o dai fanatici del rock
che l’accusavano di essere una musica incomprensibile, superficiale o inautentica. La mancanza di parole e
la natura sensuale e cerebrale della musica elettronica
hanno suggerito a Reynolds la definizione di techno
come musica erogena (Reynolds, 2000).
La techno comunica direttamente con il corpo nella
danza, attuando una connessione in virtù della significanza slittata sul senso del ritmo e dei bassi, piuttosto
che sull’ascolto delle canzoni e dei significati che esse
trasmettono. Il e la musicista che suona techno lavora
con materiali che il mondo del rock – artisti e critici
– per lo più tralascia: il ritmo in relazione con lo spazio,
il timbro, la tensione.
Sin dagli inizi della techno – cioè fine anni Settanta nella città di Detroit – era presente una ferma volontà teoretica volta a sistematizzare i procedimenti e i concetti
sui quali questo genere musicale si fondava, ad esempio,
le teorie sulla pratica del remix, del loop, del djing e
il movimento detroitiano sociofilosofico dell’afrofuturismo. La paura di fronte al puro musicale, le cui strutture appaiono sfuggenti perché fanno appello alla percezione sensuale, è quel piano del divenire–musica che
Deleuze e Guattari descrivono fra le possibili derive del
Corpo Senza Organi, indicando nel ritornello – ciò che, ritornando sempre, si ripete ugualmente: l’annuncio della morte. Sulla scorta dell’interpretazione che analizza
la ripetitività del ritornello si basava la messa in guardia
da parte dei teorici francesi circa il rischio fascista della
ricezione musicale connaturato con il fascino esercitato sulla collettività dalla musica. Scrivono Deleuze e
Guattari che i musicisti più dei pittori “trattano una forza collettiva infinitamente superiore” – l’identità unica
del coro (Deleuze, Guattari, 1996, p. 248) o, nel nostro
discorso, la massa unica dei raver.
La consolidata posizione del dj e della dj, ad oggi un
nuovo prototipo di star, si basa su strategie enunciative,
tecniche e nomiche: colui/lei il/la quale suona i dischi
per far ballare la gente detta legge, crea e, essenzialmente, cerca il consenso. La pratica del djing finisce,
così, per avvicinarsi sempre di più ad una pratica della
seduzione attraverso un linguaggio allusivo. A questo riguardo Jankélévitch, nel saggio poetico La musica e l’ineffabile, si domanda se la musica non sia la dimensione
E|C Serie Speciale
Anno I, n. 1 2007, pp. 91-96
ISSN (on-line): 1970-7452
ISSN (print): 1973-2716
EC
Techno-gender. Un’analisi
sociosemiotica della nozione di
gender in relazione alla pratica
del djing nella techno
Claudia Attimonelli
dell’ambiguità, risolvendo il quesito con l’introduzione
del concetto di charme per descrivere il “non–so–che”,
l’ineffabile della musica (Jankélévitch, 2001, pp. 50–54).
Dunque, suonare i dischi per far ballare delle persone
significa misurarsi con la propria capacità di sedurre attraverso i suoni, essi devono muovere i corpi alla danza;
seducere è nel djing realmente condurre a sé qualcuno. Su
questa base si è ricostruita negli anni la figura del dj, alchimista dei suoni ed ammaliatore dei sensi. Chambers,
durante un convegno a Bari sulla musica elettronica nel
2004, sostenne che l’orecchio del dj offre ospitalità all’alterità, lasciando spazio al non ancora sentito, il dj è
un maître à penser della contemporaneità.
Insieme a quello artistico, il fattore tecnologico, a partire
dalla rivoluzione apportata in questo senso storicamente dalla house music con le macchine, software e hardware, adoperate per campionare, mixare e suonare, ha
reso alla portata di molti un’arte quale la musica, da
sempre nell’ambito della composizione, caratterizzata
dai lunghi tempi di studio e apprendimento, nonché
dalla frequente mortificazione della creatività a favore
dell’esercizio accademico.
La techno, nomen omen, è segnata dal fattore tecnologico.
Esso è anche il tratto distintivo nell’approccio musicale
di genere. Infatti, se, nel corso degli anni Novanta le
donne hanno consolidato la propria presenza in qualità di musiciste in tutti i generi musicali, dall’indierock
al pop mainstream e di recente anche nella produzione
elettronica – andando aldilà delle posizioni postfemministe emerse dal punk negli anni Settanta e da allora
perseguite in seno ai gruppi delle Riot Girl e Girrrl Power
– dunque cimentandosi come producers, dj e fondando
etichette elettroniche secondo un trend che non sembra
destinato a fermarsi, è pur vero che, a ben guardare,
la presenza delle musiciste dj all’interno di importanti festival (non orientati sul tema del gender) così come
nella programmazione dei club (che non siano women
© 2007 AISS – Associazione Italiana di Studi Semiotici
T. reg. Trib. di Palermo n. 2 – 17.1.2005
92
only) rimane nettamente inferiore a quella dei colleghi
dj, raggiungendo, secondo alcune stime, un rapporto
di 1 a 10. Qualche anno fa sullo stesso tema ebbi a dire
che in virtù dell’evidente presenza discreta – nonché
talvolta invisibile – delle donne alla consolle, si potrebbe parlare di musica elettronica come gender oriented, cioè
specificatamente intesa per un solo genere sessuale, in
questo caso quello maschile. Ebbene un’analisi intorno a questo fenomeno deve tener conto di almeno due
aspetti, il primo inserito all’interno della questione della
tecnologia connessa al gender e il secondo più programmaticamente incentrato sul fattore della rappresentazione e della visibilità. In questo contesto tralasciamo
l’aspetto della visibilità più strettamente legato alle strategie di esposizione mediatica.
Nel percorso che intendiamo delineare la techno riflette
in maniera più vistosa l’apice del fenomeno, dal momento che nei suoi luoghi distintivi – la consolle del dj
eletto a idolo – vi è un’inconfutabile assenza di donne a
fronte di un visibile aumento delle produzioni ad opera
delle dj. Nelle numerose interviste alle dj e musiciste,
come negli scritti di respiro sociologico e di critica musicale, la spiegazione del ritardo con cui le donne giungono ad interessarsi alla tecnologia in ambito artistico,
è volta primariamente a fugare, anche con ironia, l’ovvietà che tale ritardo sia motivato da una fobia e che gli
uomini nascano tecnologicamente più dotati.
Secondo un rapporto redatto nel 2005 dall’University
of Music di Salford sul tema Gender Segregation in Music
Technology (da cui è nato il progetto Equality in Music che
promuove workshop di djing e seminari per tecniche
e ingegnere del suono) esisterebbe una tendenza che
spiegherebbe la scarsa rappresentanza femminile in alcune occupazioni considerate culturalmente importanti
quali il djing e quella di ingegneri del suono Secondo la
categoria della naturalità di genere, le donne risultano
naturalmente meno interessate alla tecnologia, ad acquisire competenze necessarie alla pratica del djing a favore
di interessi più orientati verso il sociale.
Buona parte di questo studio è incentrato sulla difficoltà
di accesso e utilizzo delle tecnologie usate per manipolare la musica elettronica e sull’individuazione dell’ambiente scolastico quale luogo dove nascono gli stereotipi
di genere relativi alla composizione, alla creatività e al
talento. Dalle interviste ai docenti si comprende come
la monopolizzazione degli strumenti tecnologici da
parte dei ragazzi sia in un certo senso sostenuta dagli
stessi insegnanti che tendono a basarsi sullo stereotipo
secondo il quale le ragazze siano tradizionalmente più
meticolose e conservatrici nelle composizioni musicali, più attente ai risultati ma meno innovative, creative
e istintive dei ragazzi. Si ritiene che essi abbiano più
slancio ed estro creativo, siano più avventurosi e meno
timorosi di commettere errori. Questa disinvoltura maschile farebbe appello alla hipness, l’accumulazione di
conoscenze e abilità in campo musicale dal sapore quasi
esoterico, poiché tramandate e presentate come innate,
istintive piuttosto che frutto di apprendimento libresco.
Il processo di acquisizione tecnica sarebbe gelosamente
custodito dai ragazzi al fine di ostendere le suddette conoscenze come se fossero naturali. Per contro il risultato
femminile, frutto di arduo lavoro, riduce la possibilità di
acquisire credibilità poiché ritenuto pur sempre dovuto a conoscenze posticce, acquisite attraverso lo studio.
Aldilà del fatto che queste analisi siano eccessivamente
tese a voler restituire uno scenario male oriented only, non
va trascurata la componente storico–sociale che ha determinato una differenza di genere nell’accostamento
alla tecnologia musicale. Allorchè Bourdieu nell’opera
La distinzione. Critica sociale del gusto, si occupò di quello
che egli definì capitale culturale e che in questa sede definiremo capitale sottoculturale – filogicamente ripreso dal
termine subculture (cfr. già in Hebdige e Thornton, fra
gi altri), mettendo, dunque, fra parentesi la questione
legata alla nozione di sottocultura e al suo superamento
tuttora oggetto di discussione – egli intendeva la conoscenza frutto di educazione e istruzione che attraversa
il verticalismo sociale e conferisce a chi la possiede un
nuovo status, operando secondo criteri di distinzione ed
esclusione. Nel nostro discorso il capitale sottoculturale
afferisce alle pratiche culturali urbane, nella fattispecie
il djing, la club e rave culture. Si tratta “dell’essere a conoscenza” ad esempio, di uno slang, di nomi di dj e etichette sconosciuti ai profani, di dischi white label e di edizioni limitate di 12 pollici, la cui dépense semiotica, – in
questo senso la nozione del lusso (Calefato, 2003) – sciorinata “senza strafare”, come suggerisce la Thornton
(Thornton, S., 1995), decreta il capitale sottocuturale
del parlante che però non deve mai avere l’aria di chi ha
studiato e appreso di recente. In molti studi (cfr. Frith,
1998, Thornton 1995 e Bayton 1998) le teenager risultano avere meno soldi, tempo, spazio e mezzi di trasporto
per accedere all’equipaggiamento necessario per suonare. Va anche sottolineato quanto il controllo dei genitori e le restrizioni ad uscire per incontrarsi fuori della
cameretta privata (Frith, 1987) abbiano rallentato per le
ragazze il procedimento di fruizione e condivisione della musica, oltre ad averle private dell’esperienza formativa scolastica di creare una band con le amiche. Questo
scenario, a partire dagli anni Cinquanta in maniera
evidente, ma naturalmente anche da prima, ha determinato sia gli orizzonti del mercato discografico sia la
rappresentazione del gender nell’ambito musicale. Le
conoscenze musicali femminili sono state lungamente
circoscritte all’ambito del fanatismo da groupie dal quale
le donne si emanciparono alla fine degli anni Settanta
con il punk, o, se fidanzate dei musicisti dj, dovute a conoscenze di riflesso derivate dall’assorbimento acritico
delle informazioni apprese da altri.
Facendo un salto indietro è utile soffermarsi sulla tradizionale distinzione occidentale tra compositore e performer, colpevole di aver lasciato un solco notevole nel
panorama musicale femminile. Le donne, infatti, sono
state accettate da sempre nella musica colta ed extra-
Claudia Attimonelli · Techno-gender. Un’analisi sociosemiotica della nozione di gender in relazione alla pratica del djing nella techno
colta nel ruolo di performer, cioè esecutrici di musiche
altrui: nell’alveo borghese come ancor prima in quello
aristocratico seguivano lezioni di musica e canto al fine
di allietare la famiglia e gli ospiti, diventare insegnanti
di musica, organizzatrici di eventi musicali quali concerti per compleanni e anniversari, senza mai essere incoraggiate a studiare per diventare artiste né compositrici, ruoli mai favoriti né previsti dalla società nei primi
del Novecento.
L’approccio allo strumento di chi performa è segnato dal
principio di più o meno fedele esecuzione e interiorizzazione delle norme acquisite, cosicchè l’apprendimento di uno strumento rappresenta uno svantaggio nel
passaggio dall’esecuzione pedissequa di un brano altrui
al tentativo di trasferire le proprie abilità misurandosi
nella composizione di brani propri. Diversamente i ragazzi, da sempre non soggetti a una rigida introduzione
alla musica, si sono esercitati da soli ascoltando i dischi
preferiti e leggendo le novità discografiche sulle riviste
specializzate, acquisendo una familiarità che è primariamente tattile, supportata anche dal riconoscimento
sociale nell’approccio allo strumento e alla composizione. Si delinea in questo modo un’intimidazione di
genere che andrebbe ricercata, secondo i gender studies,
nell’esposizione sin dall’infanzia alle macchine tecnologiche e che impedirebbe la confidenza tattile.
I gender studies hanno indagato la possibilità del rinvenimento di una semiosi tecnologica segnata dal maschile,
responsabile di una programmazione ab origine differente, tanto del funzionamento dei tools quanto dell’estetica
e dei contenuti dei software. Su questa base è stato posto il quesito, se sia, cioè possibile tradurre il linguaggio
maschile tramite il quale sarebbero state programmate
le macchine – cfr. videogame – e produrne uno che abbia un approccio più di genere. Tralasciando gli studi
femministi e queer che a fine anni Settanta indagarono
il pregiudizio sugli strumenti (la celebre chitarra elettrica che performa una sessualità fallocentrica), citiamo
brevemente la descrizione di genere delle differenze ritmiche fornita da Richard Dyer nel saggio In Defence of
Disco:
“Il rock con la sua struttura lineare e il beat che spinge
duro, costituisce una musica essenzialmente fallocentrica.
La disco, invece, rifiuta il contenimento lineare poiché la
frase conclusiva di una traccia è solitamente messa in loop
[e in definitiva si dissolve in un’altra traccia all’interno di un djset].
L’aumento ritmico e crescente anche nelle tracce di disco
music più semplici restituisce l’erotismo all’intero corpo e
per entrambi i sessi senza confinarlo solo nel pene” (Dyer,
1992).
Questo riferimento trovava riscontro anche nella
voce dello Harvard Dictionary of Music citato dalla
McRobbie, laddove si dice che:
“la fine di una frase musicale è detta maschile se l’accordo
finale è una battuta forte, mentre se ad essa ne succede una
debole allora è detta femminile. (...) La finale femminile viene preferita negli stili più romantici” (McRobbie, 1984).
Questa definizione trova il suo corrispettivo oggi sulle
riviste di musica elettronica nell’uso dell’aggettivo girlie,
entrato nel vocabolario internazionale per le recensioni, per descrivere una traccia mielosa, troppo house,
orecchiabile e mainstream.
Posto che sia esistita e perduri una distribuzione sessuale
degli strumenti – le donne storicamente pianiste, arpiste
e chitarriste acustiche e gli uomini chitarristi elettrici,
batteristi e dj – è plausibile monitorare il genere sessuale assegnando specifiche tecnologie e strumentazioni a
determinati generi? Intercorre realmente una relazione
fra la produzione di musica elettronica e il maschile che
potrebbe far pensare ad una semiosi maschile vs una
femminile?
Evidentemente non si possono reperire tracce di mascolinità nelle composizioni elettroniche o nell’hardware e
software adoperati per suonare. Allora forse è più produttivo riflettere sulla differenza di genere accordandosi
in prima istanza sulla nozione stessa di “gender” in relazione alle pratiche musicali. Questa nozione è relativamente recente, risale cioè alla formulazione del concetto
di gender elaborato in seno ai Gender Studies fra gli Ottanta
e i Novanta. Il termine gender, tradotto in italiano con
l’ormai accreditato genere, non si risolve nella semplice
descrizione della differenza sessuale: genere maschile o
femminile, bensì riguarda la rappresentazione del sè anche a dispetto dell’identità sessuale individuale, (Butler,
1990). In questo senso, l’evento musicale, dall’opera lirica alle popstar, fino alle attuali pratiche del djing, è stato
il veicolo della costruzione e rappresentazione pubblica
delle relazioni fra i generi, della negoziazione dei ruoli e
della ridefinizione dell’immaginario culturale che ruota
intorno al genere sessuale. I Gender Studies, derivando dagli studi femministi degli anni Settanta, hanno a lungo
prediletto questa prospettiva sulle altre, successivamente
hanno iniziato a farsi strada anche studi di genere maschile, lesbico, omosessuale, transgender: i Queer Studies.
Attualmente, adottando una prospettiva sociosemiotica
diventa urgente richiedere a questi studi un’osservazione del musicale secondo una categoria fenomenologica
di rappresentazione del genere e come luogo della messa in
opera di particolari tropi del gender, cioè come modalità di espansione e di intensificazione dei temi, elaborati
anche in altri contesti culturali, che riguardano l’identità sessuale.
L’universo musicale, osservato performativamente allorchè rappresenta l’identità, si configura all’interno della
difficile dialettica tra costruzione sociale e realizzazione
personale. Alcuni quesiti chiarificatori, ad esempio, potrebbero essere: “In che modo la musica contribuisce
alla costruzione di un’identità di genere?”, si pensi al
fenomeno delle Riot Grrls; o, viceversa, “In che modo il
genere contribuisce alla costruzione di un’identità musicale?”, e questo è il caso del glam rock. Dichiarata pro-
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
93
94
vocatoriamente, a tratti allusa o nascosta per ragioni di
privacy o di carriera, la sessualità nella musica contemporanea è il fulcro attorno al quale ruotano le tendenze
musicali; il corpo, nella sua performatività, diventa testo
politico e sociale dove inscrivere le pratiche di cross gender. Nel Ventunesimo secolo è decisamente anacronistico promuovere un’estetica della differenza dei generi,
che giunge fuori tempo rispetto alle riflessioni ad opera
del cyborgfemminismo, eppure dal numero di seminari e
conferenze dal titolo Women in Music, si evince la volontà
di fornire percorsi interpretativi alternativi alla rappresentazione del mondo musicale elettronico e non solo,
tuttora prevalentemente di segno maschile e a maggioranza bianco.
Se accettiamo temporaneamente l’idea che esista una
semiosi maschile, data a partire dalla destinazione dei
primi linguaggi tecnologici con cui si ha a che fare da
bambini, dai videogame alle tastierine giocattolo, potrebbe farsi strada la prospettiva che inaugura una semiosi che sia femminile e maschile, secondo l’ormai celebre nozione anni Ottanta di Haraway: cyborg, che con
essa intende proprio, metaforicamente, il superamento
della teoria del genere binaria (Haraway, 1991). Molte
artiste dj intervistate sulla possibile pratica di attraversamento del genere che ha luogo alla consolle auspicano,
infatti, non tanto la proliferazione di un discorso femminile vs maschile, quanto il confronto con il reale processo
esperito nelle pratiche culturali elettroniche, all’interno
delle quali sta già accadendo una ridefinizione di genere. E questo anche per il timore di restare intrappolate
nella stretta categorizzazione di female dj, che distoglie
l’attenzione dalla qualità della musica prodotta.
Dunque come sostenere un’analisi delle pratiche culturali elettroniche, capace di leggere i segni di cui esse
sono portatrici e i meccanismi da esse innescati? Le pratiche vanno intese come quegli atti–eventi nel corso dei
quali viene teorizzata e fondata la pratica stessa, teoria
della pratica come ermeneutica. La pratica è il deposito
di tutti gli usi precedenti fatti di un tale oggetto, questi,
sedimentati, costituiscono il bacino cui attingere per gli
usi collettivi. Ad esempio, nel djing, la prassi è costituita
dall’uso che in un periodo di tempo i/le dj hanno fatto
delle macchine, siano esse giradischi, laptop, sintetizzatori, software, mixer etc., pertanto nel djing è la pratica a
generare regole e non il contrario. Con Spaziante possiamo affermare che:
a convogliare musica, immagini, file d’ogni tipo non si
trova solamente accanto ad esse manipolandole, bensì
processa la propria identità rinegoziandola di continuo,
allorchè maneggia testi e discorsi, perché li sceglie e li
seleziona, attinge a quel collettivo che, oltre a costituire
l’humus rizomatico da cui si originano nuove pratiche in
virtù dei nuovi usi, permette l’ibridazione della soggettività attraverso la prassi della performance. Così accade
che una “soggettività femminile o maschile è, insieme, uno
stereotipo e il risultato di una lotta” (Calefato, 2001, p.
97), ciò che Judith Butler definisce performance, “non
[de]la registrazione di uno status, ma [di] un processo
continuo” (ibidem). Nell’analisi della Butler il dualismo
maschile/femminile si discioglie nell’atto momentaneo della performance, poiché essa chiama in causa
il gender, la rappresentazione del sé e non le identità
sessuali predefinite degli individui. Il genere risulta essere pertanto intrinsecamente performativo, contesta la
nozione di soggetto individuale sessuato e si concentra
sulla performatività in quanto atto discorsivo capace di
produrre, attraverso ripetizione e recitazione, ciò che
esso nomina.
Proviamo, dunque, a considerare la pratica discorsiva
del djing attraverso diverse strategie enunciative in funzione di una riflessione sugli stereotipi del genere.
Da più parti nel corso degli anni, all’interno delle differenti teorizzazioni intorno alla techno, è stata avanzata
la proposta di elevarla a veicolo di espressione postgender,
in grado, cioè, di descrivere stati ibridi, instabili, inaspettati ed eterogenei. Nella predilezione per la teoria
e la pratica di software e hardware per suonare, nella
scarsa propensione a veicolare l’immagine dell’artista
a tutto vantaggio della musica in sè, si è guardato alla
techno come a un luogo di attraversamento del genere
sessuale e non solo di strumento per l’affermazione di
donne, gay e transgender. Una musica ontologicamente
capace di stare sulla soglia del genere, nell’hic et nunc instabile della sua esecuzione, nel puro piacere edonistico
della danza e del godimento sensoriale.
La dj producer tedesca, fondatrice dell’etichetta elettronica B–Pitch Control, Ellen Allien, in un’intervista del
2002 ha dichiarato:
“La relazione tra soggetti e apparati tecnici non si intende
come una relazione tra entità separate che subiscono passivamente reciproci condizionamenti, ma come una relazione
fondata sull’ibridazione” (Spaziante, 2003).
“Per esempio la questione del gender nella techno: non è
importante se sei donna o uomo; a differenza ad esempio
dell’hip hop o del rock, dove esistono ancora ruoli sessuali
fissi (...), la techno è stato il primo movimento nella musica dance dove il gender non era più così fondamentale. (...)
Ciò che interessa di più se sei dj, più che essere uomo o
donna, è l’abilità nel sentire la musica e nel sentire le gente. Naturalmente poi il djing è un mestiere: solo con una
Se consideriamo l’ibridazione come una trasformazione
di tipo semiotico, allora, relazioni e mutazioni nelle pratiche elettroniche tra soggetti e apparati sono costituite
da una semiosi che innesca processi di interpretazione
e rimediazione in grado di reinterpretare anche le relazioni di genere. Il soggetto che pratica le tecnologie atte
Come è già accaduto nell’ambito della comunicazione mediata dalle tecnologie – email, chat, forum, blog
e vetrine di presentazione come myspace – l’identità di
genere è rappresentata più che reale e le possibilità di na-
buona tecnica puoi essere un/a brav/a dj” (Ellen
Allien, 2002)
Claudia Attimonelli · Techno-gender. Un’analisi sociosemiotica della nozione di gender in relazione alla pratica del djing nella techno
scondersi dietro nickname che celano la propria identità sessuale nella comunicazione e rappresentazione
del sè contribuiscono alla comprensione della nozione
di gender come performance fluida e dipendente dal
contesto, al punto da aver canonizzato pratiche sociali
quali il gender switching.
Il fattore tecnologico – l’abilità tecnica – se continua
ad essere la fondamentale discriminante nell’approccio gender alla pratica del djing nonché alla composizione vera e propria, si rivela sempre più uno strumento
strategico di ridefinizione dei ruoli, poiché si muove sul
terreno degli usi e delle pratiche, stimolo perché siano
decostruiti i clichés di genere ricercando una sorta di
trascendenza attraverso la tecnologia.
In conclusione vorrei fornire un breve esempio di una
prima strategia enunciativa nell’ambito del djing techno, utile a suffragare la tesi di una semiosi transgender,
ed è quella della voce.
La dj e producer techno tedesca M.I.A., rispondendo
in un’intervista sull’utilizzo della voce nelle sue tracce,
dichiara che, sebbene nella techno la voce non serva,
qualora la si renda suono, oltre il suo essere voce maschile o femminile, si costituirebbe il soggetto incarnato laddove sembra che vi sia solo algida tecnologia.
Successivamente, evocando una metafora gender oriented
M.I.A. sostiene:
“La struttura fondamentale sulla quale lavorare è la base ritmica minimale. Ma poi la si veste, come una bambola, con
dei vestitini con centinaia di piccoli accessori. Per me questo
abbigliamento è fondamentale perché porta tutto l’insieme
ad un livello più alto” (M.I.A. 2001).
Nella techno, dal momento che non vi sono versi forieri di significato, viene a mancare la prassi di interpretazione delle canzoni – i brani, infatti, si chiamano
tracce. Accogliendo l’assunto di Jankélevitc secondo il
quale “la musica non significa niente” (Jankélevitc, 2001,
p. 63), possiamo affermare nello specifico, che la techno
non significa niente, con questo intendendo la sua autonomia, in quanto opera1 da un’ideologia2, cionondimeno
è naturale che non si tratti di una musica insignificante
in quanto scevra da parole a cui dare senso, altrimenti
lo stesso varrebbe per il repertorio di secoli di musica
classica.
Secondo Deleuze e Guattari “la musica è anzitutto una
deterritorializzazione della voce, che diviene sempre
meno linguaggio, così come la pittura è una deterritorializzazione del viso” (Deleuze e Guattari, 1996, p. 248).
La voce è da intendere, secondo Deleuze e Guattari,
come sonorità dovuta ad un processo di “macchinazione”. Per la musica elettronica la “macchinazione della
voce” è un fatto ontologico come per le musiche dei
compositori analizzati nel capitolo sul divenire–musica:
Mozart, Schumann, Stravinsky, Cage, Berio, Debussy,
Varèse. Infatti, la techno, avvalendosi delle tecniche di
campionamento e sintesi, conferisce alla voce la stessa
funzione di uno strumento, non lasciandole traccia al-
cuna che riconduca al senso delle parole da cui è stata
originariamente campionata3, si crea così un suono non
musicale che fa blocco con il divenire–musica del suono
e con esso scontrandosi e avvinghiandosi, realizza le sue
tracce in un flusso sonoro. Philip Tagg, nel suo lavoro
From Refrain to Rave. The Decline of Figure and the Rise of
Ground, spiega:
“Il campionatore permette alla composizione di interagire
con il mondo esterno al proprio discorso, non nel modo
usuale che consiste nell’utilizzare i testi per dare forma a
qualche idea che non sia necessariamente musicale, ma incorporando suoni non necessariamente musicali nel discorso
musicale” (Tagg, 1994, p. 145).
Per Deleuze e Guattari il primo segno di questa deterritorializzazione va scorto nell’abbandono delle categorie
di genere: essi affermano che “in musica non si è più
uomo o donna” (p. 250) bensì occorre che la voce sia
disposta a divenire–donna, divenire–bambino, divenire–uccello4: “lo strumento macchina la voce, (...) la voce
e lo strumento sono portati sullo stesso piano, in un rapporto ora di scontro, ora di supplenza, ora di scambio e
di complementarità” (ibidem).
L’incredibile quantità di musica che s’ispira alla riflessione del filosofo francese testimonia della radicale
deterritorializzazione della voce, un chiaro esempio è
l’esperienza dell’etichetta Mille Plateaux (con la sublabel
Ritornell) fondata da Achim Szepansky che realizzò, in
seguito alla scomparsa di Deleuze, la compilation In
Memoriam Gilles Deleuze, preceduta di poco da un tributo, postumo ma concepito quando Deleuze era ancora
in vita, dal titolo Folds & Rhizomes for Gilles Deleuze5 per
la Sub Rosa, che accoglieva la sfida per una ricerca intorno alla nozione di remix, sviluppata poi l’anno seguente, con la produzione di Double Articulation: Folds and
Rhizomes Remix Project. Questi differenti progetti musicali sono raccontati in un interessante volume dal titolo
Millesuoni edito da Cronopio.
La deterritorializzazione della voce è un procedimento
che non conduce al silenzio né alla negazione dell’umano; semmai è proprio la disorganizione della voce fra gli
altri strumenti/organi del corpo sonoro che funge da
punto di partenza nell’analisi delle pratiche elettroniche
connesse a tematiche quali il gender, poiché tale voce
richiede una prassi dell’ascolto atta a fruire la musica
diversamente. Scorgendo piani dell’essere localizzati lì
dove non ce li aspetteremmo perché sfuggono al programma sociale restrittivo a cui siamo stati da sempre
esposti e di conseguenza abituati. E così l’ascolto della
techno conduce a sentire altri suoni, conduce a sentire il
suono dell’altro.
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
95
Note
1
96
In realtà, secondo Lévinas nessun’opera d’arte è mai, né mai
può essere, dell’autore. Essa si trova fuori dalla sfera del soggetto ed esprime un movimento verso l’altro senza ritorno a
sé / per sé, garantito dal fatto che la parola è sempre altrui ed
estranea a chi la scrive (Lévinas, 1982).
2
“Da quanto si è detto, la musica ha inevitabilmente un orientamento ideologico, che può essere anche di mantenimento e
conservazione dell’ordine sociale esistente e della sua modellazione del mondo. Ma a noi questo aspetto qui non interessa.
Interessa invece l’ideologia della musica come movimento di
oltrepassamento, di fuoriuscita dall’ordine costituito e dall’ideologia dominante” (Ponzio, 1997, pp. 139–140).
3
In tal senso Gaillot suggerisce che nella techno le parole
sono a tal punto musicali che, “sometimes one cannot even
understand what they mean” (Gaillot, 1999).
4
Sono stati, infatti, giudicati anacronistici e conservatori i
tentativi di Verdi e Mozart di risessualizzare la voce, restaurando il sistema binario voce maschile/femminile (Deleuze e
Guattari, 1996, p. 256).
5
Si tratta di una compilation di remix prodotta da Guy
Marc Hinant, fondatore della Sub Rosa; costui volle fare della
pratica del remix un piano concreto di riflessione deleuziana,
leggiamo direttamente dagli intenti della label: “After having
conceived folds and rhizomes, the very first time we listened to
it, we had the idea of re–creating another plateau – another
little quantum sculpture called a cd – sending out lines of
departure in order to remodel the material as it appeared
to us then elsewhere and in different fashion. We asked the
participants to remix among themselves and what emerged
was more engaging than anything we had imagined – Oval
remixing himself, Mouse On Mars remixing the whole...The
notion of remix is fascinating in itself in that it offers a new
vision – never definitive – of what is, a new space where two
styles interpenetrate, two ways of doing things which, instead
of canceling each other out, reinforce each other, resulting at
best in – something else”. (Folds & Rhizomes for Gilles Deleuze,
1995) Il cd è ormai fuori catalogo.
Bibliografia
Attimonelli Petraglione, C., 2007, “Generando musica elettronica”, in Futura, Roma, Meltemi.
Bayton, M., 1998, How Women Become Musicians, London,
Routledge.
Bourdieu, P., 1979, La distinction, Paris, Minuit; trad. it., La distinzione. Critica sociale del gusto, Bologna, Il Mulino, 1983.
Butler, J., 1990, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of
Identity, New York, Routledge; trad. it., Scambi di genere.
Identità, sesso e desiderio, Milano, Sansoni, 2004.
Calefato, P., 2003, Lusso, Roma, Meltemi.
Deleuze, G. & Guattari, F., 1980, Milles Plateaux – Capitalisme et
schizophrénie, Paris, Minuit; trad. it., Capitalismo e schizofrenia, Come farsi un corpo senz’organi, Millepiani sez. II, Roma,
Castelvecchi, 1996.
Dyer, R., 1979, “In Defense of Disco”, in Gay Left, 8, London;
attualmente reperibile in, Dyer, Old Entertainment,
Routledge, New York 1992.
Ellen Allien, 2002, Raw Music Material, Electronic Music Djs
Today, Zurich–Berlin–New York, Scalo.
Frith, S., 1987, Sound Effects: Youth, Leisure, and the Politics of
Rock’n’roll, London, Constable and Company.
Frith, S., 1998, Performing Rites, On the Value of Popular Music,
Harvard, Harvard University Press.
Gaillot, M., 1999, Multiple Meaning: Techno, An Artistic and
Political Laboratory of the Present, Paris, Editions Dis Voir.
Haraway, D., 1991, Simians, Cyborgs and Women: the Reinvention
of Nature, New York, Routledge; trad. it., Manifesto Cyborg,
Milano, Feltrinelli, 1995.
Jankélevitc, V., 1983, La musique et l’ineffable, Seuil; trad. it., La
musica e l’ineffabile, Milano, Bompiani, 2001.
Levinas, E., 1982, La réalité et son ombre, in Revues des Sciences humaines, 185; trad. it., Nomi propri, Genova, Marietti, 1984.
McRobbie, A., 1984, “Dance and Social Fantasy”, in
McRobbie and Nava, Gender and Generation, London,
MacMillan.
Paci Dalò, R., Quinz, E., (a cura di), 2006, Millesuoni, Deleuze,
Guattari e la musica elettronica, Napoli, Cronopio.
Ponzio, A., Lomuto, M., 1997, Semiotica della musica, Graphis,
Bari.
Reynolds, S., 1998, Generation Ecstasy: into the world of techno
and rave culture; trad. it., Generazione ballo/sballo. L’avvento
della dance music e il delinearsi della rave culture, Roma,
Arcanamusica, 2000.
Spaziante, L., 2003, “Musica e nuovi media. La testualità
sonora dalla fonografia al digitale”, Versus, n. 94/95/96,
2003.
Tagg, P., 1994, “From Refrain to Rave: the Decline of
Figure and the Rise of Ground”, in Popular Music, 13/2,
Cambridge University Press.
Thornton, S., 1995, Club Cultures. Music, Media and Subcultural
Capital, Cambridge, Polity; trad. it., Dai Club ai Rave, musica, media e capitale sottoculturale, Milano, Feltrinelli, 1998.
Discografia
Singoli
Ellen Allien, 2003, Trashscapes, B–Pitch Control.
M.I.A., 2006, Safe Night, Substatic.
Villalobos Ricardo, 2003, Dexter, Playhouse.
Album
Mills Jeff, 2005, Exhibitionist, React/Audioglobe, dvd.
Compilation
Double Articulation: Folds and Rhizomes Remix Project, 1996, Sub
Rosa.
Folds & Rhizomes for Gilles Deleuze, 1995, Sub Rosa.
In Memoriam Gilles Deleuze, 1996, Mille Plateaux.
Claudia Attimonelli · Techno-gender. Un’analisi sociosemiotica della nozione di gender in relazione alla pratica del djing nella techno
Guarda ben fiso, fiso
di tua madre la faccia
che t’en resti una traccia…
(Madama Butterfly, atto II)
0. Ouverture
La traccia di Butterfly, la giovane geisha che si uccide per
amore dell’ufficiale americano B.F. Pinkerton, è quella
che, a partire dalla voce di Maria Callas, questo contributo tenta di seguire in questo breve percorso attraverso
l’opera e le sue incarnazioni contemporanee. Questa
traccia, traccia di una voce di donna tanto più potente
nel momento della morte, attraversa la storia dell’opera
occidentale, genere che segna “la disfatta delle donne”
ma anche, nella celebrazione della loro voce, il loro
trionfo. È questa alterità subalterna, non solo femminile
ma spesso anche marcatamente “nera” o non-occidentale che si appropria dello spazio performativo dell’opera, quello stesso spazio che la offre come spettacolo al
pubblico occidentale, trasformandolo in luogo aperto
problematicamente al suo stesso “dar voce”.
Per la giovane geisha dell’opera pucciniana, la voce incarna l’appello a non dimenticare, rivolto non all’amante perduto ma al figlio biondo che sta per essere portato
“al di là del mare”. Appello che è stato di recente raccolto dal compositore Shigeaki Saegusa e dal librettista
Masahiko Shimada, che nella loro opera Junior Butterfly
(2004) reinventano il mito coloniale di Butterfly dal
punto d’udito del Giappone del secondo conflitto mondiale.1 In questo modo, l’opera contemporanea decostruisce e allo stesso tempo rende omaggio alla geisha
dalla voce “giapponese” come solo l’opera romantica
avrebbe potuto immaginarla.
1. Questioni di genere
L’opera lirica potrebbe oggi apparire del tutto fuori luogo, in tempi di teoria postcoloniale e “politically correct”. Il genere è ben rappresentato da questa “tragedia
giapponese”, che celebra l’osmosi dell’impresa coloniale con quella sessuale del soggetto maschile occidentale
(Pinkerton) mediante la potente metafora della farfalla
infilzata dal suo conquistatore “perché non fugga più”.
Catherine Clément, nel suo excursus sull’opera romantica, così descrive il duetto del I atto tra il luogotenente
americano e la geisha:
“[Pinkerton] tiene Butterfly tra le braccia e le dice queste
parole su quelle ali spiegate che Puccini sa mettere alle voci
di tenore; è un duetto d’amore, e voi ascoltate, rapiti, trasportati…Così l’americano annuncia il pugnale che fisserà
per sempre Butterfly, donna farfalla, sul tavolo anatomico
dell’occidente bianco” (1979, p. 57).
Così scrive Clément, nota ai più come voce storica del
femminismo francese (e non solo), un po’ meno come
E|C Serie Speciale
Anno I, n. 1 2007, pp. 97-101
ISSN (on-line): 1970-7452
ISSN (print): 1973-2716
EC
Un’altra opera. Lirica,
femminismo, postcolonialismo
Serena Guarracino
commentatrice d’opera. Eppure è proprio suo il testo
da cui partire per esplorare la possibilità di un’”altra”
opera.
Il libro di Clément, dal titolo inequivocabile L’opera lirica, o la disfatta delle donne, pubblicato nel 1979 e quasi
contemporaneamente tradotto in italiano, si basa quasi
esclusivamente sul repertorio operistico sette- e ottocentesco, riletto da un punto d’udito femminile ed esplicitamente femminista, che non può quindi che identificare l’opera come uno strumento che con i suoi incanti
musicali è in grado di far godere masochisticamente le
donne della propria disfatta. Prendendo una posizione
piuttosto radicale, Clément scrive:
“la tragica morte delle eroine più o meno colpevoli di aver
trasgredito alla norma patriarcale è il fine simbolico e narrativo dell’opera, il fulcro della sua rappresentazione: le donne, sulle scene dei teatri lirici, cantano, immutabilmente, la
loro eterna disfatta.” (pp. 11-12)
Da un lato, quindi, Clément critica l’opera lirica in
quanto strumento di una politica di genere che punisce
senza appello ogni violazione della legge patriarcale.
D’altro canto, però, è proprio questo reiterato movimento di trasgressione, di attraversamento dei confini
socio-culturali del femminile che ispira Clément: “nell’istante in cui la loro musica s’inscrive in quelle ossessionanti melodie, passa da loro a me il fermento con
una rivolta che tumultua” (p. 207), scrive l’autrice in
chiusura del suo testo, celebrando un’osmosi che offre
l’opera lirica ad un altro punto d’udito, quello di un genere “al femminile”.
Questa parabola, dalla critica decostruttiva alla riscoperta della voce femminile dell’opera, offre in nuce lo
sviluppo recente degli studi musicologici sull’opera, a
cui ha dato inizio proprio la traduzione in inglese del
© 2007 AISS – Associazione Italiana di Studi Semiotici
T. reg. Trib. di Palermo n. 2 – 17.1.2005
98
testo di Clément, pubblicata nel 1989. La prima a raccogliere questa provocazione, nonché figura fondante
di quella che oggi viene definita new o critical musicology,
è Susan McClary, la prima ad aver introdotto le basi
teoriche del femminismo nell’analisi dei fenomeni musicali. Attraverso questo intreccio di approcci disciplinari
la musica viene inscritta nella cultura in cui si radica
sia nel momento della concezione che in quello, sempre
rinnovato, della performance. La sua attenzione è equamente distribuita tra musica classica strumentale e opera, così come tra musica cosiddetta “classica” e “pop”
(la sua prima monografia, Feminine Endings, si chiude
con un capitolo sulla “material girl” Madonna); tuttavia la sua prospettiva femminista si incarna anch’essa
in un’eroina d’opera, ossia Carmen, che già Clément
aveva definito come “la più femminista di tutte, la più
testarda tra tutte le morte … un po’ puttana, un po’
ebrea, un po’ araba, del tutto illegale, sempre ai margini
della vita” (p. 62).
L’opera Carmen, scritta da George Bizet nel 1875, presenta infatti una protagonista che rifiuta qualsiasi compromesso con l’eterosessualità normativa, e che mette
la propria libertà (incarnata dall’ideale di vita gitano)
prima di qualunque “innamorato” che potrebbe offrirle una stabilità sociale e armonica all’interno del contesto narrativo e musicale dell’opera. La sua vicenda
rappresenta in maniera esplicita il principio alla base
di molta parte dell’opera romantica, ossia la rappresentazione di un’anormatività (la “trasgressione” di cui
parla Clément), la cui minaccia rientra in conclusione
della vicenda, in genere con la morte dell’elemento di
disturbo. Il fatto che questa spinta trasgressiva sia incarnata nella maggior parte dei casi nel corpo femminile
della protagonista non fa che confermare l’alterizzazione dell’elemento femminile all’interno delle narrazioni
patriarcali: come nota Adriana Cavarero,
“c’è il dramma che, come ogni dramma del macrotesto occidentale, sembra narrare le molte varianti della solita storia
patriarcale: innamorata, tradita, beffata, ingannata, impazzita, una donna muore. … Donne che vivono al di fuori dei
ruoli familiari, figure trasgressive e spesso capaci di indipendenza, esse non si limitano a morire ma devono morire perché
tutto torni a posto” (2003, p. 38; corsivi nel testo).
Allo stesso modo l’analisi di McClary, riprendendo e
sviluppando quella di Clément, ritrova nell’elemento musicale dell’opera la stessa spinta epistemologica
verso la morte dell’eroina che Clément aveva trovato
nell’elemento narrativo. Lo svolgersi della trama assume infatti tutte le caratteristiche di una necessità: scrive
McClary che “[Carmen] è l’altra dissonante necessaria
alla motivazione e allo sviluppo della trama” (1991, p.
57).2 Gli eccessi cromatici e le melodie esotiche che caratterizzano il canto di Carmen si risolvono nel Fa diesis
che chiude l’opera sulla morte dell’eroina che, grazie
all’incanto delle strutture tonali occidentali, non è solo
necessaria, ma desiderata:
Serena Guarracino · Un’altra opera. Lirica, femminismo, postcolonialismo
“Le strategie musicali di Bizet creano una tensione quasi insopportabile, che induce l’ascoltatore [e l’ascoltatrice; “listener” in inglese non è marcato in termini di genere, N.d.T.]
non solo ad accettare la morte di Carmen, ma a desiderarla (p.
62; corsivo nel testo).”
Carmen è però anche l’eroina che più di ogni altra, o
almeno più esplicitamente di ogni altra, avoca a sé il
canto come espressione di una soggettività che non dipende dallo sguardo maschile. Al suo carceriere, futuro
amante e assassino Don José, Carmen canta: “Io canto
per me sola!...E penso! Non è certo vietato pensare”.
Queste parole, che sono allo stesso tempo affermazione
di libertà e arma di seduzione, esprimono un potere che
McClary nega, sostenendo che la musica di Carmen è
composta da Bizet, e che quindi in Carmen non c’è voce
di donna, ma solo la costituzione di un femminile alternativamente mostruoso e seducente (p. 59). Ciò nonostante, chiunque ascolti o assista ad una rappresentazione di Carmen (compresa quella, affollatissima di ballerini
e comparse “gitane”, diretta da Zeffirelli nel 2006 per
l’Arena di Verona) non può fare a meno di notare che
l’opera risuona di voci di donne: le voci delle sigaraie e
delle zingare, ma soprattutto la voce di Carmen.
Carolyn Abbate, nel saggio scritto in risposta al testo di
Clément dal titolo “Opera; or, the Envoicing of Women”
(dove “envoicing” si potrebbe tradurre appunto come
“dare voce”), concentra la sua attenzione appunto sulla
voce della cantante, il luogo della non significazione e
dell’emergenza del represso: “il testo è la voce della can-
tante” (1993, p. 228). La cantante è l’autrice del suono,
in concorrenza con l’onnipotente, eppure silente, voce
autoriale teorizzata da McClary. È importante notare
che Abbate, in un movimento ripreso in maniera ancora più radicale da altri studiosi e studiose della nuova
musicologia, identifica nella voce un principio di agency
“dal margine”, definito attraverso uno dei concetti più
noti del femminismo francese, l’écriture féminine: “possiamo forse identificare quella che potrebbe essere chiamata una écriture féminine musicale in una voce femminile
autoriale che parla attraverso un testo musicale scritto
da un compositore [rigorosamente maschio: in inglese
“male composer”, N.d.T.]?” (p. 229).
Il fatto che Abbate utilizzi l’écriture féminine suggerisce che
la sua argomentazione è in debito rispetto a Clément
più di quanto sembrerebbe ad una prima lettura. Non
credo sia azzardato avanzare l’ipotesi che l’aspetto più
rivoluzionario del testo di Clément, se visto all’interno
della scrittura accademica e della musicologia in generale, non sia l’approccio femminista, che pure ha attirato molto l’attenzione ma anche critiche che si sono rivelate, come nel caso di Abbate, a loro volta portatrici di
nuovi spunti di riflessione. Tuttavia, la caratteristica più
interessante del testo di Clément è il modo in cui l’autrice dà voce nella lingua alle proprie riflessioni, e alle
diverse figure di donna che attraversano il suo testo. In
questo modo Clément ha introdotto un modo diverso
di scrivere e parlare di musica che rompe la tradizione
della scrittura accademica, come credo sia emerso dai
brani citati in questo saggio. Si tratta di mettere a frutto
la portata emozionale dell’opera, e di farne strumento
critico sostenuto da approfondite analisi socio-culturali
e raffinati strumenti teorici. Così l’opera svela il proprio
essere inevitabilmente compromessa con le politiche di
alterità ben prima del suo assurgere a genere della rappresentazione coloniale.
2. Questione di voce
In realtà, la funzione dell’opera come luogo di rappresentazione dell’altro, ma anche voce “altra” risale alle
sue prime manifestazioni, a partire dal primo sbarco
nella Londra settecentesca di cantanti italiani tra cui il
noto castrato Nicolini. E questo non solo perché prevalentemente l’opera è in lingua straniera (prima di tutto
l’italiano, ma anche più tardi il francese e il tedesco),
ma anche perché i suoi protagonisti, i cantanti e le cantanti, sono a loro volta soggetti migranti. I primi furono
i castrati provenienti per la maggior parte dai paesini
del Sud Italia, ma anche le loro contemporanee primedonne Faustina Bordoni e Francesca Cuzzoni, che
divisero i palcoscenici londinesi con Farinelli; passando
poi per Maria Malibran, che dalla Spagna attraversò l’Atlantico nel 1825 al seguito della compagnia del
padre Manuel Garcia per apparire nella prima opera
lirica mai rappresentata a New York; fino alla Grecia
da cui venne (o tornò, essendo nata in realtà a New
York) Maria Kalogeropoulos, meglio nota come Maria
Callas, la cui voce ha aperto queste riflessioni (vedi
Christiansen 1995).
Quindi in particolar modo per le culture di lingua anglosassone, l’opera è voce “dal Sud”, e l’alterità della
protagonista si interseca con quella della diva. È Wayne
Koestenbaum, l’autore che ha aperto la nuova musicologia ad un ulteriore panorama, quello dei queer studies,
a porre in relazione diretta la problematica di genere e
una possibile lettura dell’opera dal punto d’udito postcoloniale:
“ruoli come Carmen si basano sull’idea del “sangue latino”
della diva. Laddove le dive venivano truccate per sembrare
asiatiche o africane in ruoli come Aida o Butterfly, si trovavano ad esprimere l’insistenza della cultura operistica sulla
natura “scura” [in inglese “dark”; N.D.T.], che può essere
soggetto a sua volta a varie interpretazione) della diva, ma
anche a sottolineare, in una mascherata alquanto problematica, la divisione della diva bianca dalle donne di colore che
impersona (p. 106).”
Questo aspetto della performance dell’altro/a emerge
tuttora in maniera evidente nelle produzioni dell’opera,
compresa quella curata nel 2004 da Franco Zeffirelli
per l’Arena di Verona, dove sul corpo dell’italiana bianca Fiorenza Cedolins si iscrive con il trucco ed il costume l’immagine “giapponese”, lo stereotipo di Butterfly.
Questa forma di travestimento, che si iscrive nella storia
dell’orientalismo occidentale, assume però, se non altro
per il suo carattere eccessivo, anche le caratteristiche di
quello che Judith Butler definisce il “drag”: se infatti per
Butler “imitando il genere, il drag rivela implicitamente la struttura imitativa del genere stesso nonché la sua
contingenza” (Butler 2004, p. 193), allo stesso modo la
performance operistica svela, nel tentativo di produrre
un’alterità “originale” (o quantomeno verosimile), la
natura culturalmente costruita di quello stesso soggetto/oggetto “altro”.
Il travestimento in questo caso non riguarda il genere,
quanto piuttosto un’intera cultura, presentandosi allo
stesso tempo come ibridazione, perversione se vogliamo, degli aspetti rassicuranti di quella stessa tradizione.
Ed è proprio di questa perversione, questo sfruttamento
degli aspetti meno rassicuranti della rappresentazione
operistica che le voci dal margine dell’impero possono
appropriarsi per rinegoziare le politiche di identità che
stanno alla base dell’ipotetica “originalità” africana da
ritrovarsi in un’opera come Aida, le cui implicazioni con
le politiche coloniali europee sono state già esplorate già
da Edward Said in Cultura e imperialismo (vedi Said 1998,
pp. 136-157), o dell’”identità giapponese” di Madama
Butterfly.
In particolar modo, il rapporto del mondo giapponese (per utilizzare una definizione colpevolmente generica) con Madama Butterfly è stato nel tempo alquanto
contraddittorio. In alcuni casi l’opera è stata in parte
“adottata” in quanto unica opera lirica con una protagonista giapponese; in altri casi invece, come ricorda
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
99
100
Clément, “il Giappone ribelle … in lei uccise l’occidente” (p. 56). Tuttavia, c’è chi ritiene molto attuale la sua
esplorazione dei rapporti contemporanei tra Giappone
e Stati Uniti, ascoltando in Butterfly la voce del soggetto coloniale la cui unica aspirazione è quella di vivere in
“casa americana”, come la stessa protagonista definisce
la propria casa di Nagasaki. È in base a questa lettura che il compositore Shigeaki Saegusa e il librettista
Masahiko Shimada hanno voluto rispondere all’appello
di Butterfly di ricordare la “traccia” della geisha, confrontandosi sia con l’opera di Puccini che, più in generale, con il ruolo del personaggio nell’immaginario
collettivo. E questo attraverso una nuova opera, Junior
Butterfly, rappresentata per la prima volta in Europa nell’ambito del programma 2006 del festival pucciniano di
Torre del Lago.
L’opera narra la storia del figlio di Butterfly, il bambino
biondo che alla fine dell’opera di Puccini viene portato negli Stati Uniti per essere cresciuto da Pinkerton e
dalla sua moglie americana. Se la richiesta di Butterfly
nell’addio al figlio era di guardare il viso della madre,
perché “t’en resti una traccia”, uno dei temi principali
dell’opera è il viso del protagonista, JB (Benjamin Junior,
come Pinkerton, ma per tutti Junior Butterfly): come si
legge nel libretto, “Vedendo la mia faccia, tutti quanti mi
chiedevano: “Da dove sei venuto?” (p. 32).3 Il movimento
di appropriazione di Saegusa e Shimada parte proprio
da qui, dalle fattezze di Junior Butterfly che in Puccini
ha “gli occhi azzurrini” e “i ricciolini d’oro schietto”, caratteristiche che testimoniano la paternità di Pinkerton,
mentre qui viene fatto portatore di quei segni d’alterità
che sono l’eredità della madre: “I segni di mia madre
erano incisi su questa faccia” (p. 32).
Junior Butterfly è rappresentato come un soggetto postcoloniale, “un pipistrello nato in mezzo a due paesi” (p. 30).
Tuttavia, il ritorno di Junior Butterfly alla terra della
madre non si svolge sotto i migliori auspici: JB è infatti
inviato in Giappone come parte dello sforzo di intelligence che precede il secondo conflitto mondiale, e
questo impedisce all’opera la celebrazione di un innocuo multiculturalismo. Tuttavia, JB s’innamora (come
il padre, ma diversamente dal padre), di una giapponese, Naomi. Un amore dalla conclusione tragica: alo
scoppio della guerra, infatti, JB viene rinchiuso in un
campo di concentramento, e Naomi, con il loro figlio
Chame, va ad attenderlo a Nagasaki, nella casa che una
volta era stata di Butterfly. La bomba atomica la ferisce
gravemente, dandole appena il tempo di attendere il ritorno di JB prima di morire.
Certo, è triste constatare che anche l’opera contemporanea si costruisca narrativamente sulla morte delle
donne; ma è proprio il modo in cui l’opera di Saegusa
riprende le convenzioni del genere a mostrare le potenzialità di questo tipo di opera contemporanea. L’opera
riprende molti temi musicali della Madama Butterfly,
a partire dalle prime note che riecheggiano proprio
l’aria di Butterfly al figlio; lo stesso uso dei temi, inclu-
Serena Guarracino · Un’altra opera. Lirica, femminismo, postcolonialismo
so l’onnipresente inno nazionale americano, è a metà
tra l’opera e il cinema hollywoodiano, che dall’opera
imparò come usare la musica per sottolineare i momenti più drammatici della storia. In confronto ad opere
contemporanee che si ispirano alle tradizioni più varie
(ultima, in ordine di tempo, l’opera rap Gaddafi. A Living
Myth del gruppo Asian Dub Foundation, che ha aperto
nel settembre 2006 all’English National Opera), Junior
Butterfly suona più tradizionale dell’opera, più pucciniana di Puccini – e come avrebbe potuto altrimenti essere
ammessa ad un festival prestigioso come quello di Torre
del Lago, in contrasto con l’attuale clima di ostracismo
che caratterizza le sedi storiche dell’opera in Italia nei
confronti dell’opera contemporanea?
L’opera giapponese “posa” come se stessa, ma è proprio questa impersonazione che richiama un concetto
fondamentale della teoria postcoloniale, il “mimetismo” di Homi Bhabha, “il segno del fuori luogo, di una
differenza recalcitrante che è coerente con la funzione
strategica dominante del potere coloniale, che intensifica la vigilanza e pone una sfida immanente alle conoscenze ‘normalizzatÈ e ai poteri disciplinari” (2001, p.
124). La musica di Saegusa sbatte in faccia all’ascoltatore il proprio stesso orientalismo, la propria incapacità
di utilizzare altre melodie per narrare la propria storia.
In questo modo Junior Butterfly recupera l’aspetto fortemente politico dell’opera lirica, che l’introduzione di
Saegusa al programma di sala non riesce a stemperare.
Se qui infatti si legge, tra l’altro, che “è un fatto reale che
la sicurezza del Giappone dopo la guerra sia stata mantenuta grazie alla protezione degli Stati Uniti” (Saegusa
2006, pp. 17-18), il libretto di Shimada è da questo punto d’udito molto meno diplomatico. Il personaggio che
rappresenta gli Stati Uniti, il Direttore McCallum, da
cui dipende anche Junior Butterfly, sostiene senza riserve che “la porta verso la guerra va aperta con la forza”
(p. 28). Non solo, ma egli prevede (e in un certo senso
si augura) l’attacco di Pearl Harbour, in modalità che
ricordano pesantemente alcune “teorie del complotto”
sull’11 Settembre:
“Se lo mettessimo nei guai finanziariamente e violassimo le
acque territoriali, il Giappone farebbe la guerra, anche se
il nemico fossero gli Stati Uniti? […] Il loro obiettivo sarà
probabilmente Pearl Harbour. Questo spregevole attacco
farà cambiare l’opinione pubblica. Questa guerra sarà sicuramente l’ultima (p. 28).”
Davanti a questa versione cinica di Realpolitik il desiderio di JB di restare neutrale nei confronti del conflitto
offre un’idea di soggetto maschile fortemente in contrasto con gli eroi testosteronici e belligeranti che rappresentano lo stereotipo della voce tenore. La sua scelta di
non-appartenenza lo associa infatti più a Carmen che a
Don José o allo stesso Pinkerton, che in Puccini è il portavoce di un fanatico americanismo. Non solo ma la sua
posizione neutrale nei confronti della guerra, supportata da ideali pacifisti e non-violenti, contrasta con l’anima violenta degli eroi operistici, che finiscono spesso
per uccidere l’oggetto del loro amore, sia direttamente
come Don José per Carmen, sia tramite il tradimento e
l’abbandono come Pinkerton.
Di conseguenza, anche Naomi è la vittima non di un
potere patriarcale che la offre in sacrificio alla propria
stabilità, ma di una tragedia umanitaria; e il contrasto
con le altre eroine d’opera è tanto più forte quanto più
affine è il loro destino. Coerentemente con questo rimaneggiamento dei ruoli di genere, è quindi JB stesso,
e non un surrogato femminile del patriarcato (come la
moglie di Pinkerton) ad ereditare da Naomi il prettamente femminile lavoro di cura nei confronti del figlio
Chame. Nello stesso momento, Junior Butterfly riceve
anche il pugnale della madre, insieme con la sua triste
storia. In tal modo, JB viene posto all’interno di una
catena matrilineare, in cui lo colloca anche l’uso prevalente del registro tenorile alto per la maggior parte
dell’opera. In questo modo, l’appropriazione del genere
operistico in Junior Butterfly intreccia il luogo apparentemente rarefatto dell’opera e della cultura “alta” con
una volontà politica, riuscendo a dare voce ad un altro
eroe, ad un’altra storia, ad un’altra opera.
Note
1
L’espressione ‘punto d’udito’ come alternativa al più comune ‘punto di vista’ è ripresa da Adriana Cavarero, una delle
poche studiose italiane ad aver intrecciato l’opera lirica e gli
studi di genere nel suo A più voci (2003, p. 134).
2
Nessun testo di Susan McClary e dei ‘new musicologist’
trattati di seguito è stato finora tradotto in italiano. Di conseguenza, laddove il riferimento bibliografico presenta un testo
in inglese, la traduzione è da considerarsi mia.
3
Cito qui dalla versione italiana del libretto, che nell’originale
intreccia giapponese e inglese. Ulteriori informazioni e foto
dell’allestimento sono reperibili sul sito www.italiagiappone.
it/junior_butterfly.pdf.
Bibliografia
Abbate, C., 1993, “Opera; or, the Envoicing of Women”. in
Solie (ED), Musicology and Difference: Gender and Sexuality in
Music Scholarship. Berkeley, University of California Press:
225-258.
Bhabha, H., 2001, I luoghi della cultura. Roma, Meltemi.
Cavarero, A., 2003, A più voci. Filosofia dell’espressione vocale.
Milano, Feltrinelli.
Christiansen, R., 1995, Prima Donna. A History. London,
Pimlico.
Clément, C., 1979, L’opéra, ou La défaite des femmes. Trad. it. a
cura di Grazie Amati, Marina Cordonali, et al., L’opera
lirica, o La disfatta delle donne. Venezia, Marsilio.
McClary, S., 1991, Feminine Endings. Music, Gender and Sexuality.
Oxford (Minn.), University of Minnesota Press.
Shimada, M., 2006, Libretto per l’opera Junior Butterfly.
Programma di sala del 52° festival Puccini (Torre del
Lago, 3-9 Agosto 2006).
Saegusa, S., 2006, “Pensieri su Jr. Butterfly”. Junior Butterfly,
programma di sala del 52° festival Puccini (Torre del
Lago, 3-9 Agosto 2006).
Said, E., 1998, “L’impero all’opera: l’Aida di Verdi”. In Cultura
e Imperialismo. Roma, Gamberetti Editrice: 136-157.
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
101
sezione quattro
sinestesie mediali, corporeità
0. Introduzione
Gli studi sui videoclip1, finora, si sono spesso concentrati in modo eccessivamente preponderante sulla loro
componente visiva, trascurandone la relazione con la
canzone corrispondente. Se è problematico affrontare
tale relazione limitandosi a considerare il piano dell’espressione delle immagini e della canzone, questo
scritto mostrerà come sia invece possibile confrontare
alcuni aspetti del loro contenuto. Ciò è possibile perché
tanto le parole e la musica di una canzone quanto le
immagini di un videoclip presentano delle scene e delle
azioni; in altri termini, in tutti e tre i casi il fruitore modello è invitato a inferire un certo mondo possibile e alcune azioni compiute in tale mondo da alcuni agenti.
Più specificamente, ciascuna delle unità sintagmatiche
nelle quali si articola una canzone tonale o modale incisa in un supporto grazie al quale essa è ascoltabile più
volte (e dunque è considerabile come un “prodotto finito”) invita a inferire otto tipi di azioni2, ciascuna dotata
di un suo agente (che in alcuni casi coincide con gli altri
agenti inferibili, in altri no3):
1. l’azione enunciata dalle parole della frase della canzone considerata;
2. l’azione (la trasformazione del proprio stato) compiuta dal protagonista del percorso narrativo4 (in movimento verso lo stato e/o l’oggetto da lui desiderato)
inferibile dalle parole della canzone considerate;
3. l’azione, corrispondente al percorso tonale (o modale) inferibile dall’unità della canzone considerata, compiuta da un soggetto in movimento verso la meta tonale
(chiamata nel metalinguaggio corrispondente “tonica”)5
o modale (chiamata nel metalinguaggio corrispondente
“finalis”)6 della melodia e della successione di accordi
presenti nella canzone;
4. la sincronizzazione senso-motoria7 (del “danzatore
modello”) con il ritmo dell’unità della canzone considerata;
5. la performance canora (l’enunciazione del cantante modello) e quella strumentale (l’enunciazione dello
strumentista modello) inferibile ascoltando l’unità della
canzone considerata;
6. l’atto locutorio8 (l’enunciazione del parlante evocato) inferibile ascoltando le parole e la performance canora
corrispondente a tali parole nell’unità della canzone
considerata9;
7. la costruzione del prodotto finito corrispondente
alla canzone (l’enunciazione dell’autore modello dell’oggetto sonoro);
8. la performance dello stile di vita corrispondente al genere10 a cui appartiene la canzone.
Per analizzare un videoclip sulla base di tali premesse,
si tratterà allora innanzitutto di analizzarne la canzone,
cercando di rispondere alle seguenti domande:
- quali azioni questa canzone invita a inferire? Da
quali caratteristiche della canzone lo si capisce?
- quali sono le caratteristiche degli agenti di tali azioni e cosa accade loro nel corso della canzone? Da quali
E|C Serie Speciale
Anno I, n. 1 2007, pp. 105-113
ISSN (on-line): 1970-7452
ISSN (print): 1973-2716
EC
Enunciazioni e azioni nella
canzone e nel videoclip
Luca Marconi
caratteristiche della canzone lo si capisce?
Dopo aver risolto tali problemi analitici, si tratterà di
considerare il videoclip, ponendosi altre due domande:
- quali relazioni intercorrono tra le azioni mostrate
dalle immagini del videoclip e quelle inferibili ascoltando la canzone?
- quali relazioni intercorrono tra gli agenti delle azioni mostrate dalle immagini del videoclip e gli agenti delle azioni inferibili ascoltando la canzone?
Come esempio, si risponderà a tali domande considerando il videoclip di Mi fido di te11 di Jovanotti12. Il regista del video13, distribuito nel 2005, è Ambrogio Lo
Giudice, esperto videomaker italiano, regista nel 2003
del film Prima dammi un bacio, che ha diretto molti clip
di Jovanotti da una decina d’anni a questa parte (ad
esempio, Penso positivo, L’ombelico del mondo).
1. Il percorso narrativo delle parole della
canzone
Concentriamoci innanzitutto sul tipo di azioni indicato
al punto 2 dell’elenco riportato qui sopra, il percorso
narrativo compiuto dal protagonista inferibile dalle parole della canzone14.
Nel corso della prima strofa, il suo narratore enuncia
un elenco paratattico di fenomeni percepibili visivamente o uditivamente: vengono descritti, in alternanza, soggetti non in azione e soggetti che compiono nel
presente azioni espresse da verbi intransitivi, senza che
emerga con evidenza un’isotopia15 principale. Inoltre,
non è possibile inferire con certezza il protagonista del
percorso narrativo implicato e la sua meta. L’incertezza
giunge al culmine in corrispondenza con le parole «forse fa male»: oltre alla presenza di un avverbio che implica uno stato di dubbio nell’enunciatore, il co-testo precedente non precisa quale sia il soggetto dell’azione del
far male enunciata e quale soggetto patisca tale azione.
Subito dopo, l’incertezza scompare: a partire dalle pa-
© 2007 AISS - Associazione Italiana di Studi Semiotici
T. reg. Trib. di Palermo n. 2 - 17.1.2005
106
role successive, «eppure mi va», il narratore assume il
ruolo di protagonista ed espone la propria meta con un
enunciato riconducibile a tre isotopie non incompatibili
tra loro: a una lettura più ‘letterale’ emerge un’isotopia corrispondente alla pratica del bungee jumping16; leggendo tale pratica metaforicamente, si profilano poi la
connessione a Internet e l’assunzione di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di queste isotopie, la meta profilata
consiste nel vivere un’esperienza di adiacenza e contatto con l’altro («mi va di stare collegato»), caratterizzata
come un’esperienza particolarmente intensa e sublime
(«di vivere d’un fiato, di stendermi sopra al burrone»),
attenta alla visione del mondo percepito dall’alto («di
guardare giù») e comprendente uno stato di ebbrezza
legato al superamento di un limite, vissuto non disforicamente col timore di essere punito, ma euforicamente
come speranza di raggiungere uno stato utopico («la
vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare»).
Rispetto a questa meta, le parole della seconda parte
del ritornello funzionano come un suo conseguimento,
con una corrispondente distensione: la ripetuta dichiarazione di fiducia del narratore nel narratario («mi fido
di te») implica infatti che vi sia uno stretto contatto tra i
due; e la domanda successiva, «cosa sei disposto a perdere?», implica che il contatto tra narratore e narratario
sia così intenso e attento alla percezione del mondo da
includere anche la disponibilità a rinunciare a qualcosa
che si possiede.
La continuazione della canzone vede poi l’alternanza nelle strofe tra fasi di allontanamento dalla meta,
e dunque di aumento di tensione, e fasi di riavvicinamento alla meta, con diminuzioni di tensione. Le prime corrispondono a due tipi di descrizione da parte
del narratore: quella di attanti17 violenti, con funzione
di “opponente”18, che impediscono di vivere contatti fiduciosi con l’altro («catene, assassini per bene», «lupi in
agguato»), e quella di effetti di azioni violente («l’affitto
del sole si paga in anticipo», «rabbia, stupore», «il cielo
in prigione, questa non è un’esercitazione»); le seconde
corrispondono invece ad altri due tipi di descrizione:
quella di attanti non violenti con funzione di “adiuvante”, che favoriscono la possibilità di vivere contatti fiduciosi («al collo una croce, la dea dell’amore», «arcobaleno», «forza e coraggio») e quella di effetti di azioni non
violente («teste fasciate, ferite curate», «evoluzione», «il
peggio è passato»)19.
Infine, nelle riprese del ritornello si ripresenta, nella
loro prima parte, l’enunciazione della meta e, nella loro
seconda parte, la congiunzione con essa, corrispondente a una grande distensione.
2. Il percorso musicale verso una
tonica/finalis20
Soffermiamoci ora sul tipo di azioni indicato al punto
3 dell’elenco riportato qui sopra. Anche in questo caso
l’inizio è all’insegna dell’incertezza relativamente alla
meta del percorso inferibile: la melodia e la successione
Luca Marconi · Enunciazioni e azioni nella canzone e nel videoclip
di accordi esposte nell’introduzione strumentale e nella
prima strofa possono infatti essere sentite sia come un
percorso modale, nel modo eolico avente come meta
la nota La21, che come un percorso tonale, nel modo
maggiore avente come meta la nota Do.
In entrambe le prospettive, comunque, il percorso simultaneo della melodia (esposta nell’introduzione
dal piano elettrico e nella prima strofa dalla voce di
Jovanotti) e della successione di accordi22 presentato
prima dell’inizio del ritornello non raggiunge mai completamente la meta verso la quale è diretto.
In coincidenza poi con l’inizio del ritornello, l’incertezza sparisce non solo dal percorso narrativo, ma anche
da quello musicale, che durante il ritornello risulta essere un percorso tonale nel modo maggiore avente come
meta la “tonica” Do. Nella successione degli accordi,
questa meta tonale viene raggiunta (sotto forma di accordo di Do maggiore in “stato fondamentale” preceduto dall’accordo di Sol maggiore in “stato fondamentale”) per la prima volta nel corso della canzone, con
una corrispondente forte distensione, subito prima del
momento nel quale il narratore, pronunciando le parole «di stare», comincia a enunciare la propria meta.
Seguono poi, in coincidenza con la continuazione dell’esposizione della meta narrativa, realizzata con le
parole “collegato, di vivere d’un fiato”, una cadenza23
“plagale” (dall’accordo di sottodominante a quello di
tonica), che mantiene la distensione precedente, e, in
coincidenza con le parole “«di stare», di stendermi sopra al burrone, di guardare giù”, una cadenza “d’inganno”, nel corso della quale, cioè, l’attesa di un ulteriore
arrivo alla meta (l’accordo di tonica) viene “ingannata”
facendo subentrare un accordo corrispondente a un allontanamento da essa (un accordo minore costruito sul
sesto grado). In corrispondenza poi con le parole « la
vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare»,
c’è la preparazione di una cadenza “composta” (un accordo di sottodominante viene seguito dall’accordo di
tonica in secondo rivolto e dall’accordo di dominante)
che raggiunge la propria meta in coincidenza con l’arrivo alla meta tonale della melodia cantata da Jovanotti
(e, dunque, con una grandissima distensione tonale) e
con la prima enunciazione del titolo della canzone: il
momento di maggiore distensione musicale dall’inizio
della canzone coincide dunque con il momento nel
quale il narratore raggiunge la propria meta narrativa. Dopo un’altra cadenza plagale e un’altra cadenza
d’inganno, il ritornello si chiude con una preparazione di un’altra cadenza “composta” che in questo caso
non viene però portata a termine, così come le parole
cantate simultaneamente terminano non con un’affermazione, ma con una domanda, creando l’attesa per la
continuazione della canzone.
La successione dell’incertezza iniziale e del percorso tonale del ritornello viene poi riproposta una prima volta
mentre si canta la seconda strofa seguita dalla prima
riproposizione del ritornello e una seconda volta mentre si canta la terza strofa seguita dalla seconda ripresa
del ritornello.
Infine, durante la coda finale priva di parole cantate,
si riprende il giro dell’introduzione, terminando in sfumando senza che in questa ultima sezione venga mai
raggiunta né la “finalis” meta del percorso modale in
essa percepibile né la tonica meta del percorso tonale
avvertibile in alternativa al percorso modale.
3. Le performances vocali e gli atti locutori
evocati
Consideriamo ora le performances vocali presenti in questa canzone, corrispondenti al punto 5 dell’elenco di
tipi di azioni presentato qui sopra, e gli atti locutori che
queste evocano, corrispondenti al punto 6.
I primi otto versi della canzone sono intonati con un
recitativo con funzione di strofa, con un’enunciazione
del cantante al confine tra canto e rapping, evocando
un’intonazione meditativa del locutore. Se, come è stato rilevato più sopra, dalle parole di questi versi non si
possono inferire un’isotopia principale, un protagonista
e una meta narrativa, in esse emerge invece con evidenza un uso insistito di allitterazioni, rime, giochi di parole e figure retoriche: viene dunque evocato un locutore
che, oltre a elencare paratatticamente con intonazioni
meditative alcuni fenomeni percepibili nel presente, è
intento a far assumere ai propri enunciati il tipo di funzione comunicativa chiamato da Jakobson (1963) “funzione poetica”.
Dopo tale recitativo, i sette versi successivi sono intonati con un’ampia frase melodica assai più cantabile,
con funzione d’inizio del ritornello; l’enunciazione del
cantante è dunque un’azione più simile al canto, che
evoca un’intonazione più enfatica ed estatica della precedente, con la quale il narratore enuncia la propria
meta; infine il titolo della canzone e la domanda «cosa
sei disposto a perdere?» sono intonati con una melodia meno cantabile della precedente, con funzione di
conclusione del ritornello; l’enunciazione del cantante
torna così a essere al confine tra canto e rapping ed evoca
un’intonazione più pacata della precedente con la quale il narratore si rivolge al proprio narratario ripetendo
più volte l’enunciazione del proprio atto di fiducia nei
suoi confronti, raggiungendo così la propria meta.
Questa sequenza viene poi riproposta altre due volte
nel corso della canzone, con l’aggiunta, a partire dall’inizio della prima ripetizione del ritornello, di una seconda performance vocale, realizzata, da una voce con lo
stesso timbro di quella principale; questa seconda voce
procede per moto parallelo rispetto all’altra un’ottava
sopra, passando poi, nella coda finale priva della voce
principale, a realizzare dei vocalizzi in moto parallelo
con il riff dell’introduzione, in un registro molto più
acuto24, che la fa risultare un’evocazione del volo enunciato nelle parole precedenti.
4. Le azioni mostrate nel videoclip
Eccoci infine alle immagini del videoclip: innanzitutto, la successione delle azioni da loro mostrate, come la
successione delle enunciazioni del cantante e degli atti
locutori evocati dalla canzone, si articola in tre sezioni,
delle quali la seconda combacia con la seconda sezione
delle altre due successioni, e la terza inizia insieme alla
terza sezione di tali successioni.
Nella prima sezione, la prima azione focalizzata viene
compiuta dal protagonista del videoclip, Jovanotti, e
consiste nel camminare in linea retta, con una chitarra
elettrica25 in mano, lungo il marciapiede di una grande città non ben definita, nella quale si vedono scene
comuni della vita quotidiana contemporanea, ma che
per alcuni particolari è identificabile come una capitale dell’Europa dell’Est, quale ad esempio Budapest. Il
movimento del protagonista è sostanzialmente sincronizzato con la pulsazione della canzone, della quale si
sente l’introduzione strumentale, che coincide poi con
l’accompagnamento della prima strofa: l’atto (evocato
da questa strofa) di elencare con voce meditativa alcuni
fenomeni percepibili nel presente non viene mostrato
dalle immagini del videoclip, ma ciò che viene visto
prima che venga ascoltata la strofa presenta tale atto
locutorio come conseguenza di un percorso realizzato
dal proprio locutore nella quotidianità del mondo contemporaneo muovendosi non solo all’interno della situazione locale alla quale appartiene, ma anche in altri
luoghi significativi (come può essere nell’immaginario
del pubblico di Jovanotti l’Europa dell’Est) portando
con sé simboli della globalizzazione (prima fra tutti la
chitarra elettrica).
Anche la seconda azione focalizzata nel video, coincidente con le prime parole della canzone, viene compiuta da Jovanotti, che lascia la propria chitarra elettrica a
una ragazza che si trova all’incrocio della strada da lui
percorsa fino a quel punto; questo dono a un estraneo
incontrato casualmente viene poi compiuto altre volte
durante la prima parte del videoclip, ogni volta dal destinatario della precedente cessione (che offre un ogget-
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
107
108
to diverso da quello regalatogli),26 nella maggior parte
dei casi caratterizzato come un giovane: queste azioni attirano l’attenzione dell’enunciatario del videoclip
sulla domanda cruciale «cosa sei disposto a perdere?»,
enunciata per la prima volta dopo quattro doni.
Nella prima sezione di immagini, tali azioni si alternano con alcune inquadrature dei movimenti del protagonista che si incrociano con quelli degli altri donatari/donatori nella città dove egli appare inizialmente;
in corrispondenza con le parole «vecchie che ballano
nelle cadillac», «canzoni d’amore per bimbi» e «forse fa
male eppure mi va» Jovanotti è inquadrato nell’atto di
cantare tali parole in lip-synch, con un comportamento
corporeo affine a quello evocato dai suoni vocali corrispondenti: si riafferma dunque la sua presentazione
non solo come un osservatore del prossimo, un donatore nei suoi confronti e un narratore di alcuni aspetti
del proprio contesto, ma anche come un esponente dei
generi “canzone d’autore” e “rap italiano”, che, in linea con tali generi, inserisce nelle parole delle proprie
canzoni riferimenti alla musica e alle proprie scelte di
vita. La prima volta in cui si sente la dichiarazione di
fiducia nei confronti dell’enunciatario, il protagonista
viene inquadrato nell’atto non di cantare, ma di girarsi per poi mantenere una posizione stabile, fissando lo
sguardo nella direzione dove è posta la camera da presa
che lo inquadra, sicché l’enunciatario al quale le parole enunciate si rivolgono viene fatto coincidere con
l’enunciatario di quel videoclip.
La seconda sezione delle immagini è ambientata nella
stessa città dove veniva collocata la prima parte e, come
questa, segue l’incrociarsi di alcuni donatari/donatori
con il protagonista, in alcuni momenti ancora inquadrato nell’atto di cantare in lip-synch con comportamenti corporei affini a quelli evocati dai suoni corrispondenti. La coincidenza tra la cesura tra tali due sezioni e
quella tra la prima e la seconda sezione della canzone
è determinata dal fatto che al termine del ritornello si
vede, oltre che un brusco cambio di inquadratura, un
dono compiuto non dal destinatario del dono mostrato
in precedenza, ma da un soggetto alla sua prima apparizione, del quale dunque non è dato sapere se abbia
ricevuto a sua volta un dono in precedenza, rompendo
così la continuità finora in atto tra l’acquisizione di un
dono e il farne un altro da parte dello stesso soggetto.
Oltre a tali discontinuità, tra la prima e la seconda
sezione di immagini ci sono poi alcune differenze, innanzitutto nella caratterizzazione dei personaggi che si
aggiungono al protagonista: mentre nella prima sezione erano prevalentemente giovani, nella seconda sono
prevalentemente adulti; inoltre, mentre nella prima
sezione non risultavano tra loro particolari differenze
di ceto, nella seconda parte tale caratteristica risulta
come un tratto distintivo molto marcato. Un’ulteriore
differenza consiste poi nel fatto che, mentre nella prima parte solo in un caso un dono non riusciva a essere immediatamente realizzato, venendo comunque
Luca Marconi · Enunciazioni e azioni nella canzone e nel videoclip
attuato subito dopo, nella seconda parte si mostrano
due tentativi falliti da parte di un barbone di dare una
propria mantellina a soggetti più ricchi di lui, finché egli
riesce a metterla sulle spalle di un Crocefisso. Tutto ciò
risulta come un’integrazione a quanto viene enunciato
dalle parole della canzone, in due direzioni: in primo
luogo, rispetto all’isotopia connessa al topic27 “relazione
con l’altro”, che abbiamo visto essere assai ricorrente
Caso analizzato
Giro di accordi
dell’introduzione e
della prima strofa di
Mi fido di te
Giro di accordi di
The Passenger
Giro di accordi di
Zombie
Finalis
La
La
Mi
“Gradi” del modo
corrispondenti alle
“fondamentali” degli
accordi del “giro”
I – VI – III – VII
I – VI – III – VII I – VI – III – V -
I – VI – III – VII
Tipi di accordi presenti
nel “giro”
(M = maggiore
m = minore)
m–M–M–M-
m–M–M–M–
m–M–M–M-
m–M–M–M-
Tabella 1: Confronto tra i giri di accordi dell’introduzione e della strofa di Mi fido di te, di The Passenger
e di Zombie
nelle parole della canzone, nelle immagini la giovinezza
viene valorizzata presentandola come un adiuvante per
il conseguimento di un dono e per la corrispondente
assunzione della fiducia nel prossimo, mentre l’essere
più ricco del donatore viene svalutato presentandolo
come un opponente rispetto a tale conseguimento e
all’assunzione di tale atteggiamento. In secondo luogo,
mentre le parole della canzone accennano a un’isotopia
connessa al topic “religione” in modo assai velato (limitandosi a inserire nel penultimo verso della prima strofa
l’espressione “re magi”, nei primi due versi della seconda strofa i lessemi “croce” e “dea”, e al termine del terzultimo verso della seconda strofa il lessema “prego”),
nelle immagini tale isotopia emerge in modo assai più
clamoroso: in particolare, viene costruito un parallelo tra la figura di Jovanotti e quella del Cristo crocifisso, che compare frontalmente alla macchina da presa
in corrispondenza con la conclusione di una cadenza
composta, e dunque di un arrivo a destinazione, e con
una dichiarazione di fiducia in una posizione assai simile a quella nella quale nella prima sezione era collocato
Jovanotti simultaneamente alla stessa figura musicale e
alle stesse parole, dopodiché nella ripetizione di tale dichiarazione di fiducia ricompare la figura di Jovanotti,
ancora una volta in un’inquadratura simile.28
Così come avveniva tra la prima e la seconda sezione
delle immagini, anche tra la seconda parte e la terza
la cesura coincide con quella tra la seconda e la terza
sezione della canzone e viene determinata da un brusco
cambiamento di inquadratura e dalla sostituzione del
destinatario del dono precedente con un personaggio
mai apparso prima.
A tali discontinuità si aggiunge simultaneamente un
cambiamento nell’ambientazione: se fino al termine
della seconda parte tutte le azioni mostrate dalle immagini si collocavano in un contesto urbano, all’inizio
della terza parte compare un paesaggio extraurbano
(un ponte su un fiume). Vi sono poi novità anche nei
tipi di soggetti coinvolti nelle donazioni mostrate: il primo è una bambina caratterizzata dall’intenso colore
rosso,29 del vestito, dei capelli e del cuore al centro del
ciondolo del suo collare, che la distingue soprattutto dai
giovani donatari/donatori della prima parte, tutti più
scuri sia nel colore dei vestiti che in quello dei capelli;
il secondo soggetto coinvolto è poi un militare in tuta
mimetica30, che appare insieme a un drappello schierato di commilitoni in corrispondenza con le parole «forza e coraggio». La principale novità della terza parte
riguarda però le azioni mostrate: innanzitutto, dopo
il primo dono della terza parte, (la bambina regala il
proprio collare al soldato), la seconda vede per la prima volta nel corso del videoclip l’inversione dei ruoli e
dunque la presenza di uno scambio (il militare dona alla
bambina la propria pistola in coincidenza con le parole «lupi in agguato»); poi vengono focalizzate alcune
nuove azioni: la bambina punta la pistola di fronte alla
posizione dove è posta la macchina da presa, come se la
puntasse contro l’enunciatario del videoclip; viene poi
inquadrato Jovanotti nell’atto di camminare sullo stesso
ponte dove erano prima comparsi la bambina e i soldati, finché si mostra il suo incontro con la bambina, che
sposta il braccio fino a puntare la pistola nella direzione
di Jovanotti; a questo punto, in corrispondenza con le
parole «la vertigine non è paura di cadere ma voglia di
volare», Jovanotti si avvicina alla bambina porgendole il palmo della mano aperto. Solo in quel momento
torna a essere osteso un atto di donazione, che viene
però ora ad assumere un aspetto non di incoatività, ma
di terminatività distensiva: Jovanotti, che è stato il primo donatore del video, riceve in mano la pistola della
bambina mentre si sentono le parole «mi fido di te» e
una cadenza finale, con un nuovo arrivo a destinazione
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
109
e una grandissima distensione rispetto al forte crescendo di tensione precedente. Dopo questa chiusura del
cerchio delle donazioni, non ne compariranno altre, e
la terminatività verrà sancita da una ripresa variata dell’azione iniziale: i due si mettono a camminare fianco a
fianco, dopodiché Jovanotti osserva la pistola e la butta
nel fiume, riprendendo poi a camminare parallelamente alla bambina; le immagini terminano con l’inquadratura dei due personaggi di spalle che si allontanano
insieme e con un percorso musicale che, non giungendo
a una cadenza finale, né tonale né modale, evoca un
movimento non giunto a destinazione.
Le novità che distinguono la terza parte delle immagini
dalle due precedenti integrano quanto viene enunciato
dalle parole soprattutto in due direzioni: innanzitutto,
l’isotopia corrispondente all’opposizione “violento vs
non-violento”, a cui, come abbiamo visto, alludono
molte parole della canzone, emerge ancora più decisamente nelle immagini: in particolare, viene fatta coincidere nella persona di Jovanotti la tendenza ad avere col
prossimo una relazione simile a quella avuta da Cristo,
da lui manifestata nelle prime due parti, con quella a
fidarsi della bambina e a buttare l’arma, manifestata
nell’ultima parte. Simultaneamente, rispetto al topic “relazione con l’altro”, i soldati vengono mostrati come
attanti che compiono azioni violente (il rispondere al
dono di un simbolo d’amore dando in cambio un’arma)
da gettare via volgendo loro le spalle, mentre la bambina viene mostrata come un’attante che compie azioni
non violente (donare simboli d’amore e consegnare le
armi) rispetto alla quale vale la pena di fidarsi e di procederle accanto.
5. Le relazioni tra la canzone e le immagini
del videoclip
Riconsideriamo ora gli otto tipi di azioni distinti all’inizio di questo scritto e vediamo come si può sintetizzare
la posizione nei loro confronti del videoclip analizzato.
1. Delle azioni enunciate dalle parole della canzone,
le immagini focalizzano soprattutto quelle che hanno
come soggetti il narratore (“io”) e il narratario (“tu”),
Tavola 1: parole di Mi fido di te
110
Case di pane, riunioni di rane,
Vecchie che ballano nelle cadillac,
Muscoli d’oro, corone d’alloro,
Canzoni d’amore per bimbi col frack,
Musica seria, luce che varia,
Pioggia che cade, vita che scorre,
Cani randagi, cammelli e re magi,
Forse fa male eppure mi va
Mi fido di te
Mi fido di te
Mi fido di te
Cosa sei disposto a perdere?
Mi fido di te
Mi fido di te
Io mi fido di te
Cosa sei disposto a perdere?
Di stare collegato
Di vivere di un fiato
Di stendermi sopra al burrone
Di guardare giù,
La vertigine non è
Paura di cadere
Ma voglia di volare
Rabbia, stupore, la parte, l’attore,
Dottore che sintomi ha la felicità?
Evoluzione, il cielo in prigione,
Questa non è un’esercitazione,
Forza e coraggio, la sete, il miraggio,
La luna nell’altra metà,
Lupi in agguato, il peggio è passato,
Forse fa male eppure mi va
Mi fido di te
Mi fido di te
Mi fido di te
Mi fido di te
Io mi fido di te
Ehi mi fido di te
Cosa sei disposto a perdere?
Lampi di luce, al collo una croce
La dea dell’amore si muove nei jeans,
Culi e catene, assassini per bene,
La radio si accende su un pezzo funky,
Teste fasciate, ferite curate,
L’affitto del sole si paga in anticipo, prego,
Arcobaleno, più per meno meno,
Forse fa male eppure mi va
Di stare collegato
Di vivere di un fiato
Di stendermi sopra al burrone
Di guardare giù,
La vertigine non è
Paura di cadere
Ma voglia di volare
Luca Marconi · Enunciazioni e azioni nella canzone e nel videoclip
Di stare collegato
Di vivere di un fiato
Di stendermi sopra al burrone
Di guardare giù,
La vertigine non è
Paura di cadere
Ma voglia di volare
Mi fido di te
Mi fido di te
Mi fido di te
Cosa sei disposto a perdere?
Mi fido di te
Mi fido di te
Io mi fido di te
Cosa sei disposto a perdere?
Tavola 2: parole di Zombie
Another head hangs lowly,
Child is slowly taken.
And the violence caused such silence,
Who are we mistaken?
But you see, it’s not me, it’s not my family.
In your head, in your head they are fighting,
With their tanks and their bombs,
And their bombs and their guns.
In your head, in your head, they are crying...
In your head, in your head,
Zombie, zombie, zombie,
Hey, hey, hey. What’s in your head,
In your head,
Zombie, zombie, zombie?
Hey, hey, hey, hey, oh, dou, dou, dou, dou, dou...
Another mother’s breakin’,
Heart is taking over.
When the violence causes silence,
We must be mistaken.
It’s the same old theme since nineteen-sixteen.
In your head, in your head they’re still fighting,
With their tanks and their bombs,
And their bombs and their guns.
In your head, in your head, they are dying...
In your head, in your head,
Zombie, zombie, zombie,
Hey, hey, hey. What’s in your head,
In your head,
Zombie, zombie, zombie?
Hey, hey, hey, hey, oh, oh, oh,
Oh, oh, oh, oh, hey, oh, ya, ya-a...
per far coincidere il protagonista delle immagini del videoclip con il narratore delle parole della canzone e il
loro enunciatario col loro narratario;
2. La presenza al termine di ciascuna delle tre principali sezioni cantate della canzone non di un’affermazione, ma di una domanda e non di una cadenza finale,
ma di una cadenza sospesa, con una forte continuità
col primo accordo della sezione successiva, la triade
minore costruita sul sesto grado, fa sì che ciascuna di
tali sezioni evochi un percorso che al suo termine non
giunge a destinazione, fornendo una continuità che integra le discontinuità (nel passaggio dal ritornello alla
strofa successiva, nel montaggio delle immagini e nelle azioni mostrate) presenti nei punti di cesura tra una
sezione e l’altra. In corrispondenza con le tre cadenze
composte che evocano un arrivo alla meta tonale simultaneamente alle parole «mi fido di te», corrispondenti
alla congiunzione del narratore con la propria meta
narrativa, nelle immagini si mostrano tre azioni dotate
di un’analoga terminatività distensiva: Jovanotti si gira
verso una posizione stabile, il crocifisso viene mostrato
in un’analoga posizione e l’ultima volta il video ostende
il dono dell’arma a Jovanotti che chiude il cerchio delle
donazioni in esso mostrato;
3. Nelle immagini si vedono assai spesso movimenti
(soprattutto la camminata del protagonista) coincidenti
con la sincronizzazione motoria attuabile ascoltando la
canzone, incrementandone dunque l’invito a sintonizzarsi con il suo ritmo;
4. Mentre non si vedono performances di strumentisti
nelle immagini, in alcune di esse si mostra una performance canora affine a quella principale della canzone,
per caratterizzare il loro protagonista come un cantautore; in corrispondenza con l’inserimento, a partire dall’inizio del secondo ritornello, di una seconda performance vocale che procede per moto parallelo alla principale
un’ottava sopra e con lo stesso timbro, nelle immagini si
trova dapprima il parallelismo tra il cantante e il Cristo
crocifisso e nella parte finale il suo procedere in parallelo con la bambina;
5. Nel videoclip non si vedono soggetti nell’atto di
parlare; solo Jovanotti muove le labbra, ma nell’atto di
cantare; gli atti locutori evocati dalla canzone risultano
dunque avvenire in un mondo possibile diverso da quello
mostrato in tali immagini, quale quello immaginato dal
loro protagonista;
6. L’autore modello del videoclip ostende una macroforma in tre parti le cui cesure corrispondono con
le cesure delle tre parti principali della canzone ostese
dal suo autore modello. Nel montaggio del videoclip si
alternano fasi nelle quali viene riproposta immediatamente più volte una stessa breve sequenza di immagini
a fasi di montaggio di sequenze diverse, così come la
canzone di Jovanotti combina ripetizioni immediate
di brevi unità sintagmatiche (i “riffs” della canzone) a
unità non ripetute immediatamente; l’autore modello
della canzone e quello del videoclip risultano così at-
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
111
tuare pratiche (quali il “copia e incolla” e quella che potremmo chiamare “break and repeat”) affini e in linea
con uno dei due generi nei quali si inserisce la canzone,
il rap;
7. Nelle immagini del videoclip, Jovanotti risulta come
un osservatore della vita quotidiana che si prende cura
del prossimo, fiducioso nei suoi confronti e intento a
esprimere cantando la propria posizione rispetto ad alcune questioni cruciali; questo stile di vita è in linea con
i valori promossi dai due generi nei quali si inserisce la
canzone, il rap “impegnato” e la canzone d’autore31.
Note
1
112
Tra i saggi sui videoclip di studiosi stranieri più significativi,
vedi Kaplan 1987, Frith 1988, Wicke 1988, Frith, Goodwin &
Grossberg 1993, Reiss & Feinemann 2000, Dell’Antonio 2004.
Tra quelli realizzati da studiosi italiani, vedi Baroni e Nanni
1989, Sibilla 1999 e Peverini 2004. L’autore di questo saggio
ha affrontato questi temi in Marconi 2001a, 2004 e 2006.
2
Questa individuazione di diversi tipi di azioni inferibili ascoltando una canzone ha alcuni punti in comune con le teorie di
Cone (1974) sulla musica colta vocale; per un’applicazione di
tali teorie alla popular music, vedi Gelbart 2003.
3
Un videoclip che nel corso dell’intero svolgimento delle sue
immagini presenta gran parte dei tipi di azioni indicati nell’elenco presentato in questo saggio, facendole compiere tutte
dall’autrice della canzone illustrata, è quello di Hands clean di
Alanis Morrisette. Ringrazio Roberto Agostini per avermelo
segnalato.
4
Sul concetto di “percorso narrativo”, vedi Greimas e Courtés
1979, tr. it. pp. 227-228.
5
Su queste tematiche, vedi Marconi 2007.
6
Sulla “finalis” come “funzione modale”, vedi Azzaroni 1997,
pp. 239-241.
7
Sul fenomeno della sincronizzazione senso-motoria, vedi
Fraisse 1974, tr. it. pp. 50-58.
8
Sul concetto di “atto locutorio”, vedi Austin 1962.
9
Su queste tematiche, vedi Marconi 2001b, pp. 47-110.
10
Sulla relazione tra la canzone e il sistema dei generi musicali, vedi Fabbri 2001 e 2002.
11
Mi fido di te è stata pubblicata nel CD di Jovanotti Buon
Sangue (Universal, 2005) dove come autori della canzone vengono indicati Jovanotti e Riccardo Onori.
12
Una prima versione, meno approfondita, dell’analisi che
verrà presentata in questo scritto è stata pubblicata in Marconi
2006.
13
Il videoclip di Mi fido di te è reperibile nel sito ufficiale di
Jovanotti, al seguente indirizzo: http://www.soleluna.com/video/index.php.
14
Le parole di Mi fido di te sono riportate nella Tavola 1 al
termine di questo scritto.
15
Sul concetto di “isotopia”, vedi Greimas et Courtés 1979,
trad. it. pp. 187-189 ed Eco 1979, pp. 92-100.
16
Per una riflessione semiotica su questa pratica, cfr. Basso
2005. Ringrazio Gianfranco Marrone per avermi suggerito
di confrontare tale saggio col contenuto delle parole di Mi fido
di te.
17
Sul concetto di “attante”, vedi Greimas et Courtés 1979, tr.
it. pp. 40-41.
18
Sulla coppia di concetti “adiuvante/opponente”, vedi
Luca Marconi · Enunciazioni e azioni nella canzone e nel videoclip
Greimas et Courtés 1979, tr. it. p. 26.
19
In convergenza con la presenza, nel contenuto delle parole
della canzone, di un’isotopia corrispondente all’opposizione
“violento vs non violento”, le allitterazioni più ricorrenti in tali
parole e, più in generale, il ruolo cruciale giocato nell’organizzazione dei loro fonemi dalle coppie [k]/[t∫], [p]/[b], [r]/[l] e
[t]/[d] pertinentizzano l’opposizione fra i fonemi duri e quelli
dolci.
20
Per i suggerimenti fornitimi per la messa a punto di questa sezione della mia analisi, ringrazio Roberto Agostini,
Francesco Galofaro, Susanna Pasticci, Philip Tagg e Andrea
Valle.
21
Uno dei fattori che può spingere a sentire l’introduzione e
la prima strofa di Mi fido di te come un percorso modale è la
somiglianza (esplicitata dalla Tabella 1, inserita al termine di
questo scritto) della loro successione di accordi con i giri accordali di due famose canzoni rock: The passenger di Iggy Pop
(pubblicata per la prima vota nel suo album del 1977 Lust for
life) e Zombie dei Cranberries (pubblicata per la prima volta
nel loro album del 1994 No need to argue). Con quest’ultimo
brano la canzone di Jovanotti ha in comune anche la rilevante
presenza nelle parole di un’isotopia corrispondente all’opposizione “violenza vs non violenza”. Le parole di Zombie sono
riportate nella Tavola 2 al termine di questo scritto.
22
Il primo accordo di Mi fido di te è di La minore in “stato fondamentale”; seguono poi Fa minore in “stato fondamentale”,
Do minore in secondo rivolto e Sol maggiore in “stato fondamentale”; nella fase comprendente l’introduzione e la prima
strofa della canzone, questo “giro” di accordi, dopo essere stato esposto una prima volta, viene ripetuto altre cinque volte.
23
Sulle funzioni delle cadenze nella musica tonale, vedi
Azzaroni 1997, pp. 441-444.
24
Il vocalizzo nel registro acuto evocante il volo realizzato da
Jovanotti per tutta la coda di Mi fido di te, che inizia a tre minuti
e trentasette secondi dall’inizio della canzone e termina sfumando, ha una relazione con il resto della tessitura presente
in tale fase e un profilo melodico simili al vocalizzo nel registro
acuto evocante l’arrivo del protagonista in un luogo ultraterreno compiuto da Bono per tutta la coda di With or without you
(pubblicata per la prima volta dagli U2 in The Joshua Tree nel
1987), che inizia a tre minuti e trentotto secondi dall’inizio
della canzone e termina anch’essa sfumando.
25
La presenza della chitarra elettrica in questo contesto può
essere letta, oltre che come la caratterizzazione di Jovanotti
come un musicista operante nell’ambito di un genere di musica giovanile, anche come una delle allusioni all’americanizzazione del mondo presenti nel testo di Mi fido di te (soprattutto
nelle parole “cadillac”, “jeans” e “funky”) e nelle immagini del
suo videoclip (nella città dell’Europa dell’Est inquadrata molte
persone indossano jeans e hanno un look ‘globalizzato’).
26
Nel corso del videoclip vi è un solo caso nel quale chi riceve
un dono regala poi lo stesso oggetto: nella terza donazione
mostrata, un giovane riceve per strada una valigetta, che poi
cederà a un ragazzo incontrato in metropolitana.
27
Sul concetto di “topic”, vedi Eco 1979, pp. 87-91.
28
La figura della croce è presente assai frequentemente nelle
immagini del videoclip di Mi fido di te: ad esempio, nella chitarra in mano a Jovanotti, nell’inquadratura dell’incontro tra
Jovanotti e la ragazza alla quale egli dona la chitarra, in quella
del dono successivo da parte della ragazza di una borsa piena
di cibo, in quella dell’interno del vagone della metropolitana
dove avviene l’ultimo dono della prima parte, nel lampione
sotto il quale Jovanotti passa subito dopo la donazione fatta dal barbone al crocefisso e nell’inquadratura del viso di
Jovanotti che fa seguito a quella del crocefisso, coincidente
con le parole «mi fido di te». La croce ha un ruolo centrale
anche nel videoclip (diretto nel 1994 da Samuel Bayer) di un
brano che, come indicato più sopra, ha alcune caratteristiche
in comune con Mi fido di te, Zombie dei Cranberries. Il videoclip di Zombie è reperibile consultando il seguente indirizzo:
http://video.google.it/videoplay?docid=-522298290205339
7885&q=cranberries.
29
Nel videoclip, prima della bambina, il rosso caratterizza quasi unicamente la mantellina che il barbone cerca di
donare.
30
L’incontro di un bambino con un militare in tuta mimetica
viene mostrato anche nel summenzionato videoclip di Zombie
dei Cranberries.
31
La presenza in questa canzone di alcune caratteristiche del
genere “rap italiano” e di alcuni aspetti del genere “canzone
d’autore” può essere rilevata anche nella metrica del suo testo
verbale e nell’uso delle rime che viene fatto nel corso di tale
testo: in Mi fido di te si trovano versi con metri ‘canonici’ (endecasillabi e decasillabi in alcuni versi delle strofe, settenari in
alcuni versi del ritornello) e rime interne o tra finali di versi,
tutti elementi spesso reperibili nella canzone d’autore, ma a
volte usati anche nel rap più ‘poetico’; altre parti della canzone sono invece in un metro ‘libero’ e senza rime, come avviene nel rap più ‘prosaico’ (ma anche nella canzone d’autore
più vicina alla poesia novecentesca).
Bibliografia
Austin, J. L., 1962, How to do things with words, London, Oxford
University Press; trad. it. Quando dire è fare, Torino,
Marietti, 1974.
Azzaroni, L., 1997, Canone infinito. Lineamenti di teoria della musica, Bologna, Clueb.
Baroni M. e Nanni F., 1989, “La musica da vedere: il videoclip, i canali e i modi di fruizione”, in Crescere con il rock,
Bologna, Clueb, pp. 169-192.
Basso, P., 2005, “Vertigini patologiche e salute da capogiro.
Mancamenti ed ebbrezza come soglie tra forme di vita”,
in Marrone, G. (a cura di), Il discorso della salute. Verso una
semiotica medica, Roma, Meltemi, pp. 209-221.
Cone, E. T., 1974, The Composer’s Voice, London, University of
California Press.
Dell’Antonio, A., 2004, “Collective Listening: Postmodern
Critical Processes and MTV”, in Dell’Antonio, A. (ed.),
Beyond Structural Listening? Postmodern Modes of Hearing, pp.
201-231.
Eco, U., 1979, Lector in Fabula. La cooperazione interpretativa nei
testi narrativi, Milano, Bompiani.
Fabbri, F., 2001, “La canzone”, in Enciclopedia della musica vol.
1, Torino, Einaudi, pp. 551-576.
Fabbri, F., 2002, Il suono in cui viviamo, Milano, Arcana.
Fraisse, P., 1974, Psychologie du ritme, Paris, PUF; trad. It.
Psicologia del ritmo, Roma Armando, 1979.
Frith, S., 1988, Music for pleasure. Essays in the sociology of pop,
New York, Routledge; trad. it. Il rock è finito. Miti giovanili e
seduzioni commerciali nella musica pop, Torino, EdT, 1990.
Frith, S., Goodwin A. & Grossberg L. (eds.), 1993, Sound and
Vison: The Music Video Reader, Routledge, London.
Gelbart, M. 2003, “Persona and Voice in the Kinks’Songs of
the Late 1960s”, Journal of Royal Musical Association n. 128,
pp. 200-241.
Greimas, A. J., et Courtès, J., 1979, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette; trad. it. Semiotica.
Dizionario ragionato della teoria del linguaggio, Firenze, La
Casa Usher, 1986.
Jakobson, R., 1963, Essais de linguistique génèrale, Paris, Minuti;
trad. it. Saggi di linguistica generale, Milano, Feltrinelli,
1966.
Kaplan, A., 1987, Rocking Around the Clock: Music Television,
Postmodernism & Consumer Culture, Mehuen, New York.
Marconi, L., 2001a, “Muzak, jingle, videoclip”, in Enciclopedia
della musica vol. 1, Torino, Einaudi, pp. 675-700.
Marconi, L., 2001b, Musica Espressione Emozione, Bologna,
Clueb.
Marconi, L., 2004, “Si può dare di più: un bilancio in prospettiva educativa”, in Gasperoni, G., Marconi, L, e
Santoro, M., La musica e gli adolescenti, Pratiche, gusti, educazione, Torino, EdT, pp. 128-164.
Marconi, L., 2006, “Attenti a quei clip: guidare la fruizione
dei video musicali”, in Rigolli, A. (a cura di), La musica
sulla scena. Lo spettacolo musicale e il pubblico, Torino, EdT,
pp. 71-85.
Marconi, L., 2007, “Metafore cinetico-dinamiche nella narratività e nella musica tonale”, in E/C Rivista dell’Associazione Italiana Studi Semiotica on line, http://www.associazionesemiotica.it/ec/contributi/congresso_2007_comunic.
html.
Peverini, Paolo, 2004, Il videoclip. Strategie e figure di una forma
breve, Roma, Meltemi.
Reiss, S & Feineman, N. 2000, Thirty Frames per Second: The
Visionary Art of the Music Video, New York, Abrams.
Sibilla G., 1999, Musica da vedere. Il videoclip nella televisione italiana, Roma, Eri-Rai/VQPT.
Wicke P., 1988, “Video Killed the Radio Star: splendore e
miseria della videomusic, in Musica e Realtà, XI, n. 25, pp.
91-104 (ora in Fabbri, F. (a cura di), Musiche/Realtà. Generi
musicali/Media/Popular music, Milano, Unicopli, 1989, pp.
278-290).
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
113
Forme brevi, remix, remake, ibridazioni, manipolazioni, negli ultimi anni il repertorio degli oggetti indagati
dallo sguardo semiotico si è progressivamente esteso a
fenomeni testuali che hanno contribuito a ridisegnare i confini e gli equilibri del sistema dell’industria dei
media e in alcuni casi hanno trasformato la nozione di
prodotto culturale. Allargare lo sguardo significa anche
impegnarsi in una nuova messa a fuoco degli strumenti
tecnici impiegati nell’analisi dei fenomeni, nella ricognizione delle dinamiche che assicurano il funzionamento
di quelle forme espressive sperimentali che spesso sembrano sfuggire a una comprensione immediata, a una
piena intelligibilità e che pure sono in grado di sollecitare lo spettatore, di indurre una reazione, di catturarne lo sguardo. L’analisi di “oggetti” semiotici ibridi
che sembrano sottrarsi a una classificazione rassicurante (come alcune forme di remix musicale o audiovisivo o forme estreme di remake che coinvolgono sistemi
di significazione differenti) costringe a una riflessione
approfondita sull’impianto teorico e sugli strumenti di
metodo e finisce per sollecitare una riflessione che coinvolge la stessa nozione di testo.
Nell’introduzione a Remix-remake, pratiche di replicabilità
sociosemiotica Dusi e Spaziante significativamente parlano del testo come di un “oggetto plurale, risultato di
più versioni diacronicamente rilevabili, trasposizione in
differenti sostanze espressive, serie di rielaborazioni a
partire da un meccanismo di interconnessione tra più
testi” (2007, p. 9). Il testo inteso come oggetto dinamico, come forma flessibile aperta a infinite manipolazioni in grado di intervenire su tutti gli elementi della sua
architettura di partenza, come matrice di senso modulabile in funzione delle logiche dell’industria culturale e
della forte attitudine del pubblico alla ricomposizione
dei frammenti e dei rimandi intertestuali è senz’altro
un buon punto di partenza per indagare da vicino alcune trasformazioni che spostano i confini tra generi e
linguaggi.
Da tempo sappiamo che la distinzione tra il concetto
sempre più allargato di testo e la nozione di pratica
è sfumato; come affermano sempre Dusi e Spaziante
“remake e remix appartengono a una modalità testuale
che ha a che fare da un lato con enunciati riconoscibili
e definiti, dall’altro con pratiche in corso d’opera, cioè
un farsi discorsivo che ci porta a pensare a modi (configurazioni in fieri) di una testualità collettiva”. La vera
portata delle diverse forme di manipolazione espressiva
si rivela proprio in questo passaggio, i remake e i remix
non sono semplicemente dei tipi di testi ma in un’ottica
macro sono motori semiotici, logiche di produzione e di
circolazione di un senso rinegoziato con il pubblico, in
un certo senso la punta di un iceberg – la contaminazione – che è ancora da esplorare.
Proviamo dunque a fissare un punto di partenza. Se
constatiamo che come consumatori e come semiotici
siamo pienamente calati nell’epoca della replicabilità,
il nostro obiettivo non sarà quello di contribuire a in-
E|C Serie Speciale
Anno I, n. 1 2007, pp. 115-120
ISSN (on-line): 1970-7452
ISSN (print): 1973-2716
EC
Dal bastard pop al mush-up.
Mutazioni in corso
Paolo Peverini
crementare la tipologia delle forme di remake e/o di
remix, quanto piuttosto di provare a individuare alcune
ricadute dell’intermedialità sulle forme testuali, ricercando gli elementi di continuità che accomunano testi
differenti. Si tratta in altri termini di seguire una pista di
riflessione sociosemiotica, di incrociare l’analisi di alcune forme di manipolazione audiovisiva con uno sguardo dall’alto sulle profonde trasformazioni che segnano
il funzionamento dell’industria discografica, televisiva e
ovviamente del territorio sconfinato del web.
Come muoversi dunque? Proviamo innanzitutto a isolare tre “oggetti esemplari” che nascono e circolano in
ambiti differenti per verificarne le influenze reciproche
e per fare emergere alcuni elementi pertinenti di una
mutazione su vasta scala che investe non solo sistemi di
significazione distinti ma settori tradizionalmente separati dell’industria culturale e contribuisce a ridisegnare
la mappa del sistema mediale.
Partiremo dunque da un mash-up video, da un videoclip “di ultima generazione” e da un software per il remix per tracciare alcuni punti di una geografia della
mutazione audiovisiva. Prima di iniziare è opportuno
fare una precisazione, la scelta di lavorare su un corpus eterogeneo si fonda in qualche modo su un’opzione
teorica: rispettare la natura ibrida e mutevole dei fenomeni di remake adottando lo sguardo del bricoleur,
incrociando e sovrapponendo forme espressive diverse
per durata, finalità, articolazione del livello narrativo
e discorsivo. Provare insomma a calarsi nei panni del
consumatore, a giocare con gli spazi smisurati e seducenti della ricombinazione.
1. Il video a pezzi: il mash-up
Il primo testo su cui decidiamo di concentrare lo sguardo è un mash-up video, formula utilizzata per riferirsi a
una particolare forma di remix audiovisivo che consente di selezionare e rielaborare attraverso le operazioni
© 2007 AISS - Associazione Italiana di Studi Semiotici
T. reg. Trib. di Palermo n. 2 - 17.1.2005
complesse del montaggio alcuni frammenti di videoclip
preesistenti. Il mash-up video è una diretta filiazione
del mash-up musicale, una forma di remix ampiamente
consolidata tanto da imporsi come un vero e proprio
fenomeno di massa.
Particolarmente accurata è la definizione di mash-up
video proposta da Wikipedia:
“Video mashups are the latest genre of mashup. first there
were music mashups mashup (music), also known by many
as Bastard Pop, where two or more tracks are combined,
often with one acapella track by one artist over a second
backing track by another.
Then there were software mashups Mashup (web application hybrid) in which two or more sets of data are combined
over the Internet to create a new entity. Such as overlaying
houses for sale over a Google Map.
But more recently the video mashup has come of age thanks
to the likes of YouTube. This is where videos from multiple
sources are edited together into a new video. To date, many
of these video mashups have been parodies, but even music
mashups are being integrated with them to make combined
audio-visual mashups.”
116
Dalla definizione emerge un primo dato rilevante che
sembra confortare l’ipotesi di partenza che considera
il remix non come una tipologia di testi, ma come una
ratio semiotica. Il mash-up video infatti è l’ultima concretizzazione di una logica del bricolage onnivora che si
è alimentata inizialmente del magazzino sconfinato dei
generi musicali ma che si è riproposta anche sotto altre sembianze, ad esempio come sperimentazione sulle
potenzialità dell’assemblaggio di software distinti. Ma
restiamo stretti sul nostro oggetto di analisi: per comprendere i dispositivi su cui si regge il funzionamento
dei mash-up video è utile fissare due momenti di una
dialettica che coinvolge il piccolo schermo e la dimensione della musica live.
Ripartiamo innanzitutto da una considerazione decisiva di Andrew Goodwin sul rapporto tra evoluzione
della performance musicale dal vivo e affermazione del
videoclip nell’Inghilterra dei primi anni ’80. “se l’esecuzione della musica pop consisteva nel cantare su suoni
registrati pressoché identici alla musica su nastro e cassetta, allora mancava solo un passo per accettare come
una pratica pop del tutto legittima l’imitazione di una
performance in un video musicale” (1992, p.33)
Sono gli anni in cui il successo inarrestabile del videoclip contribuisce a trasformare radicalmente le forme
tradizionali del concerto dal vivo. L’esigenza di valorizzare in un modo nuovo i generi musicali di successo
(New Pop e New Romantic), il predominio dell’elettronica nella fasi di produzione e postproduzione, il superamento del tabù dell’autenticità della performance segnano il successo del videoclip e innescano la miccia di
un cambiamento che travolge gli equilibri dell’industria
discografica.
La musica nel piccolo schermo si impone come fenomeno di massa, esce dai limiti della scatola-tv e inva-
Paolo Peverini · Dal bastard pop al mush-up. Mutazioni in corso
de lo spazio del palcoscenico costringendo i musicisti
a elaborare/rinegoziare la propria immagine pubblica
adeguandosi alle forme di uno stile che rapidamente si
sta trasformando in un codice ben articolato e soprattutto a sperimentare l’utilizzo di frammenti di videoclip
o di sequenze video come componente strategica della
regia complessiva dell’evento. In questa prima fase la
contaminazione si è innescata: il live non può fare a
meno del video.
Una frattura decisiva che interviene a rielaborare il rapporto tra la performance dal vivo e le sequenze studiate
a tavolino del videoclip avviene nella metà degli anni
novanta grazie alle nuove forme della musica elettronica. I ritmi spezzati, le forme sempre più complesse
del remix musicale, l’abilità di rileggere nella diretta
dell’evento temi e stili dell’universo pop manipolandoli attraverso il virtuosismo dello scratch riportano in
primo piano la dimensione live e costringono registi ed
etichette discografiche a ripensare l’efficacia delle strategie del montaggio nei videoclip.
La pratica del remix musicale si consolida come fenomeno di massa conquistando progressivamente una
piena legittimità espressiva ed estetica sia dal punto di
vista di chi la produce sia di chi la consuma sia infine
della critica specializzata. Nasce la formula del bastard
pop che si declina nella pratica del mash-up musicale.
Mentre nel piccolo schermo il videoclip tenta di sopravvivere riciclando formule narrative e soluzioni ritmiche
negli spettacoli dal vivo le sequenze di immagini si fanno esse stesse live, subiscono il fascino del remix.
A partire dalla seconda metà degli anni ’90 la figura del
vj si afferma ampiamente. Dal bastard pop per filiazione nasce il mash-up video.
Ora, per comprendere il fenomeno nella sua complessità è bene non perdere di vista l’orientamento sociosemiotico. Questa forma di remix infatti nasce come sperimentazione underground del tutto illegale poiché si
alimenta di intere sequenze di videoclip distorcendone
il significato iniziale senza rispettare il diritto d’autore,
trovando la sua massima espansione nei party illegali,
nei club e successivamente nel web e in particolare in
You Tube, contenitore-vetrina che è allo stesso tempo
una sorgente di tendenze pop. Sfruttando le potenzialità espressive di una sperimentazione che in una prima
fase avviene in contesti estranei all’industria discografica il mash up si è potuto evolvere in modo indipendente. L’industria musicale e televisiva alla fine non hanno potuto fare altro che inglobarlo al proprio interno,
come testimonia il format Mtv Mash in cui il colosso
delle televisioni musicali ha affidato ad abili vj il compito di rileggere sotto forma di remix una selezione di
icone, temi e stili della musica pop. Un frullato audiovisivo dunque, ma con una significativa differenza che ha
fatto storcere il naso ai puristi: la possibilità di sovrapporre legalmente i frammenti di videoclip detenendo il
controllo sui diritti relativi ai materiali originali.
Cos’è dunque il mash-up video oggi? Una forma sincre-
tica di durata variabile in grado di spostare ancora più
in là la pratica del remix-remake, un pastiche flessibile,
in grado di dare forma e rilanciare tutte le modalità del
sincretismo e di adattarsi a canali di diffusione e a contesti di fruizione estremamente differenziati. Sotto questa categoria rientrano dunque testi diversi che possono
assumere le sembianze di un vj contest dal vivo, di un
format breve da inserire strategicamente nel palinsesto
di un’emittente musicale o concretizzarsi in un tributo
virtuosistico e irriverente alle icone del pop da affidare
al passaparola del web.
Per osservare da vicino i dispositivi semiotici all’opera
nei mash-up scegliamo alcuni frammenti dei lavori realizzati da Eclectic method, un collettivo di vj che esplicita nel nome lo stile e l’obiettivo di questa forma di
rielaborazione.
La presenza di due linguaggi di manifestazione aumenta notevolmente le potenzialità di manipolazione dei
materiali originali, dei testi fonte. Ad essere in gioco,
ad attrarre lo spettatore non è solo la forma del contenuto di volta in volta convocata, modellata, predisposta
per la visione ripetuta, ma la forma dell’espressione, la
potenzialità ricombinatoria infinita, che in una prospettiva semiotica possiamo provare a comprendere meglio
ricorrendo a dicotomie come: aggancio-sgancio, sovrapposizione-collisione, coincidenza-spiazzamento.
Siamo qui lontani anni luce dalla possibilità di riconfigurare una qualche coerenza sul piano narrativo. Sotto
l’azione del montaggio l’intera grammatica del linguaggio audiovisivo viene impiegata per far saltare tutte le
isotopie di partenza, l’obiettivo è duplice: rimettere in
gioco la seduzione di materiali di partenza fortemente
codificati (le canzoni e le immagini scelte sono nel migliore dei casi molto noti al pubblico di massa) riaprirne
il senso, giocando la carta del ritmo e assegnando allo
stesso tempo allo spettatore il ruolo coinvolgente del detective chiamato a ricostruire i pezzi di un puzzle dai
confini sfumati.
Per chiudere questa prima ricognizione su alcune forme della mutazione audiovisiva può essere utile fissare i
principali fattori sociosemiotici in gioco nell’elaborazione di nuove pratiche di sincretismo.
- l’intermedialità. come si è visto la crescente convergenza tra mezzi di comunicazione, piattaforme, linguaggi condiziona le tecniche di realizzazione, l’estetica
del mash-up, i cui canoni espressivi devono essere in
grado di reggere la dimensione live (club) e la dimensione differita del web e del piccolo schermo
- la competenza del pubblico a riconoscere confini e
sovrapposizioni di testi, generi e pratiche discorsive è
la premessa stessa della pratica di remix che nei casi
migliori ricerca un equilibrio complesso tra la riconoscibilità delle fonti e il piacere della ricombinazione
- i nuovi canali di diffusione come You Tube sono
fondamentali per trasformare un esperimento underground in un fenomeno di massa perché favoriscono
le forme di consumo produttivo, valorizzano la filoso-
fia dell’open source incoraggiando l’evoluzione del linguaggio e della pratica della mutazione audiovisiva. In
questo senso un mash-up per definizione non può essere un testo chiuso ma una forma perennemente provvisoria, rinegoziabile.
- nel sistema altamente strutturato e competitivo dei
media l’esigenza di resistere all’usura imposta dalle routine di produzione e distribuzione spinge gli autori a
ricercare un margine di opacità sufficiente per garantire al mash-up video una resistenza semiotica minima
all’interno dei palinsesti
Come si diceva il mash-up non è un semplice testo ma
una pratica discorsiva, che trova nella dimensione live
la sua massima espressione. In questo senso non stupisce la capacità di questo fenomeno di superare i limiti
del piccolo schermo, di uscire dagli spazi delle comunità on line per approdare sulla più tradizionale forma
di comunicazione commerciale, la locandina. E’ il caso
dei manifesti realizzati per promuovere Bootie, un appuntamento mensile che si svolge in un locale di San
Francisco specializzato nell’ospitare contest basati sul
mash up. I manifesti giocano a rivendicare il carattere illegale dei raduni inserendo la massima icona della
pirateria, il jolly roger, direttamente nel titolo dell’evento, Bootie appunto, un termine colloquiale che fa riferimento ai bootleg, copie registrate illegalmente degli
album musicali o delle performance live. Il gioco delle
sovrapposizioni e degli incroci azzardati, la filosofia del
remix si traducono in un abile lavoro grafico che fondendo insieme Robert Smith e Bjork, David Bowie e
Britney Spears esplicita in chiave ironica la tendenza
sempre più marcata a ridurre la distanza tra le star del
pop e la comunità dei fan, tra il corpo del mito e lo
sguardo del pubblico.
2. Zelig nella rete delle forme brevi. “Smiley
faces”
Catturato nella rete complessa dell’intermedialità, non
stupisce che il videoclip stesso si stia trasformando, pressato da fenomeni espressivi alternativi come il mash-up
video. La forma breve segna il passo, per resistere deve
avvicinarsi alla seduzione ritmica del remix musicale,
metabolizzarne le logiche e le strategie, rinnovarsi. E’
il caso del secondo testo scelto per questa esplorazione nei territori della mutazione audiovisiva: il videoclip
Smiley faces degli Gnarls Barkley. Si tratta di un piccolo
capolavoro di sperimentazione videomusicale che non
si limita a giocare in modo virtuosistico con la ricombinazione serrata di materiali ma incornicia la pratica
della rielaborazione, del cut-up in una strategia più ampia di rilettura dell’immaginario pop.
Il videoclip si apre con un’intervista a due personaggi
singolari: un fantomatico esperto di storia della musica,
Milton Pawley, interpretato da Dennis Hopper e Sven
Rimwinkle proprietario di un’etichetta discografica, la
A & R fantabulous records attiva tra il 1961 e il 1982,
interpretato da uno dei protagonisti della fiction di fan-
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
117
tascienza Quantum Leap. I due introducono lo spettatore in un vero e proprio labirinto metatestuale in cui è
in gioco un dibattito sull’esistenza del gruppo stesso, gli
Gnarls Barkley
“Milton Pawley: ho raccolto una documentazione fotografica che testimonia senza ombra di dubbio che Gnarls Barkley
esiste (…) hanno contribuito alla nascita dell’hip hop. Erano
coinvolti in Motown. Warhol era un loro amico. Sono un
fenomeno oltre il fenomeno”
“Sven Rimwinkle: si tratta solo di una leggenda. Non esiste
alcun gruppo chiamato Gnarls Barkley”
118
Chiusa l’intervista, una scritta in sovrimpressione “dall’archivio di Milton Pawley”, accompagna le prime sequenze del video, che si rivela essere dunque una sorta
di mockumentary videomusicale, la ricostruzione verosimile di un finto mito dell’industria discografica.
Sequenza dopo sequenza prende forma la strategia
della ricombinazione che segna l’intero lavoro. Come
aveva anticipato Milton Pawley nell’intro il duo degli
Gnarls Barkley è una sorta di misterioso filo rosso che
ha attraversato un pezzo consistente di musica popolare
del ‘900.
Si parte con le immagini in bianco e nero del proibizionismo americano, e con l’esibizione di una big band in
cui il cantante degli G. B. esegue la melodia del brano
Smiley faces guardando in maniera ammiccante in camera. Frammenti di esibizione si alternano a sequenze originali che documentano l’ascesa e il declino della malavita italoamericana e della figura mitica di Al Capone.
Il gioco dei travestimenti progressivamente prende piede, nel fanta-documentario musicale i due incarnano
il ruolo del gangster, G.B. si rivela la sigla di una gang
mafiosa. Siamo solo all’inizio: con l’ausilio della tecnologia digitale e del remix in pochi istanti lo scenario
cambia nuovamente, i due Zelig ora partecipano con
disinvoltura a una performance dell’orchestra di Duke
Ellington, e nello spazio di poche inquadrature li scoviamo in una vecchia fotografia nelle vesti di miliziani
paramilitari sudamericani durante un tentativo di golpe
fallito.
Passano gli anni e i due protagonisti del videoclip/documentario affiancano Warhol durante un’intervista e
accompagnano Lou Reed in sala di registrazione. Dal
bianco e nero si passa al colore, alle tinte sbiadite degli anni della contestazione studentesca e degli hippy.
Gli G. B. ovviamente sono in prima fila nascosti tra il
pubblico ma anche sul palco accanto ai Rolling Stones.
Non manca ovviamente un omaggio al manifesto della
cultura psichedelica: Yellow Submarine.
Con il passare delle sequenze il frullato di generi raggiunge il culmine, così pure il camaleontismo dei musicisti che ritroviamo fotografati accanto a Bob Marley, ai
Clash, addirittura scritturati come comparse nel videoclip di Thriller di Michael Jackson. L’ultima rivelazione
esaspera il gioco dei rimandi e degli omaggi ai grandi
Paolo Peverini · Dal bastard pop al mush-up. Mutazioni in corso
del pop svelando la presenza degli G. B. sul set di Let’s
dance, uno dei più famosi video del re dei travestimenti:
David Bowie.
Il videoclip di Smiley faces si chiude simmetricamente
con una coda, un frammento dell’intervista ai due personaggi del prologo che rilancia il confronto tra realtà e
finzione, esasperando il gioco di specchi
“Milton Pawley: con ogni evidenza gli G.B. sono stati coinvolti in tutta questa musica, di più: loro sono la musica stessa
dell’ultimo secolo”
“Sven Rimwinkle: sono solo chiacchiere, un mito, una leggenda dell’industria discografica. La verità è che G. B. non
esiste”
Mash-up, metatestualità, remix. Smiley faces non è solo
un testo complesso e ironico, un giocattolo semiotico
ammiccante studiato per un pubblico esigente, ma una
forma breve che testimonia delle profonde contaminazioni che marcano il panorama dei prodotti culturali di
largo consumo, dell’attraversamento delle barriere che
separano le forme del pop. L’efficacia di questo video
sta infatti nella capacità di operare una sorta di cross
over semiotico, un ponte in grado di fare collimare strategie semiotiche ben distinte.
In questo senso Smiley faces è un testo tanto più interessante quanto più difficile da classificare perché convoca
alcuni dispositivi del documentario e del mash-up video, sottoponendoli a una profonda manipolazione del
tutto funzionale a costruire un alone simbolico intorno
al nome di una band di recente formazione. Qui non si
tratta di una banale strategia di taglia e incolla, ma della rilettura raffinata di un frammento consistente di immaginario collettivo legato al mondo della musica pop.
In Smiley faces la lezione del mash-up video è ampiamente metabolizzata, la sutura di materiali visivi tanto eterogenei è assicurata dall’impiego massiccio e al tempo
stesso mirato di effetti speciali “fuori dal tempo” come
tendine, salti di pellicola, mascherini che si combinano
con immagini sgranate, sfocate, dai colori smorzati, per
fare emergere un tratto comune alle varie forme della
mutazione audiovisiva di cui parleremo nelle conclusioni, l’estetica vintage.
3. Dal remix al remixer: “I Know where Bruce
Lee lives”
Il terzo oggetto esemplare del nostro corpus è senza
dubbio il più ibrido, un esperimento di sincretismo difficilmente classificabile: il Kung fu remixer, realizzato
dal gruppo di creativi tedeschi Skopp nel 2002. Non
si tratta di un video ma di un generatore di sequenze
audiovisive che offre all’utente la possibilità di accedere
a una library di materiali che potremmo definire “di genere”, una sorta di mini enciclopedia dedicata al kung
fu, e allo stesso tempo permette di giocare con tutte le
principali figure del remix: scratch, ripetizioni, sovrapposizioni, scomposizioni.
Come si è visto le forme della mutazione audiovisiva si
alimentano delle icone popolari, gancio fondamentale
per catturare l’interesse dello spettatore, per innescare
il gioco della ricombinazione. Il kung fu remixer non fa
eccezione ma anzi rilancia ulteriormente l’operazione
di bricolage di miti e figure sullo sfondo di una cornice
tematica, di un genere cinematografico molto codificato, le arti marziali, da alcuni anni ormai pienamente
sdoganato anche dalla critica. Come nei due casi analizzati in precedenza il repertorio delle forme del remix
si accompagna alla presenza esplicita della metatestualità. L’obiettivo è chiaro: ironizzare sulle forme, simulare
la possibilità di svelare il dispositivo semiotico, giocare a
“carte scoperte” con il pubblico. In questo senso il nostro terzo oggetto è davvero esemplare perché fa saltare
alcune distinzioni fondamentali tra testi e formati. Si
apre infatti come un trailer, in cui vengono presentati
i diversi protagonisti e illustrate le isotopie tematiche e
figurative che assicurano immediatamente la riconoscibilità del genere di riferimento.
Chiuso il trailer appare l’interfaccia del remixer che
combina una piena usabilità con la cura dei dettagli
grafici. Il tributo all’estetica imperante del vintage è
ben visibile, assicurato dalla cornice che racchiude lo
spazio riservato al video e che riproduce la texture del
legno in radica di noce ampiamente utilizzato nel design degli anni ’60 e ’70. Sullo sfondo di un motivo musicale immediatamente riconducibile agli action movie
si agita come in un videogame la sagoma di Bruce Lee,
che come tutte le figure a disposizione dell’utente del
remixer è stato “ritagliato” con un semplice software di
fotoritocco dai film originali.
Sulla parte sinistra dello schermo, in basso viene schematizzata la tastiera del computer, con l’indicazione
dei tasti (keys) utilizzabili per elaborare le sequenze audiovideo. Infine c’è la sezione che raccoglie i quattro
ambienti (modes) in cui l’utente può interagire con le
figure predisposte nella library e che rilancia l’originale
operazione di rilettura dell’immaginario cinematografico legato alle arti marziali. Queste quattro sezioni sono
un evidente tributo alle isotopie chiave nella costruzione dell’architettura di un film di arti marziali: suspense,
mistero, combattimento e vittoria e vengono valorizzate con delle colonne sonore specifiche.
Sulla parte destra dell’interfaccia grafica si trova infine
la sezione dedicata alla registrazione e alla visualizzazione dei filmati realizzati dagli utenti. La struttura dei
tool a disposizione dell’aspirante vj si chiude con i tasti
che permettono di attivare/disattivare il modo di riproduzione continuo (loop). Il destino di un’altra icona del
pop è segnato, il mito del kung fu ridotto a una figura
bidimensionale in perenne movimento è ora nelle mani
del popolo della rete.
4. Piccola mappa di un territorio in
espansione
Mash-up, videoclip, kung fu remixer, testi certamente
diversi, eppure legati da dinamiche semiotiche ricorsive, da pratiche della riappropriazione e della rielaborazione sempre più esplicite, invasive. In una prospettiva
sociosemiotica il mash-up, il videoclip di Smiley faces e il
Kung fu remixer sono fenomeni che vanno analizzati
tenendo conto del dibattito sull’open source, sui diritti d’autore, sul consumo produttivo. Cambiano i testi
ma anche i profili di chi li produce, pratica, consuma.
Queste forme ludiche di cut-up audiovisivo sono in rapida espansione, si alimentano della passione del popolo della rete, trovano la massima espressione nel con-
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
119
120
test, gara, sfida al montaggio sfrenato, al virtuosismo
nel sincronizzare audio e video ma anche alla sensibilità di cortocircuitare generi, icone, classici, hit. E allora
proviamo a vedere come questa dimensione “socio” di
una pratica ricombinatoria orizzontale, aperta, fuori
dai canoni tradizionali delle professioni del videomaker,
del vj o del dj si fa semiotica, prende forma nei testi.
L’attitudine alla riappropriazione e alla manipolazione
infatti si attesta e fa tendenza, in alcuni casi si fa estetica
valorizzando:
- il ritaglio e la circolazione di icone popolari immediatamente riconducibili a un genere o un ambito
espressivo
- l’impiego massiccio di elementi grafici come collante per tenere insieme materiali eterogenei fino alla
creazione di combinazioni audiovisive particolarmente
efficaci come nel caso del Kung fu remixer in cui i movimenti sincopati delle figure comandate dall’utente si
presta perfettamente a tradurre e rinforzare sul piano
visivo i ritmi e le sonorità spezzate della colonna audio
- l’utilizzo di immagini non patinate ma spesso ritagliate in modo visibilmente approssimativo, fotografie
segnate dalla patina del tempo, caratteri grafici utilizzati nella comunicazione commerciale degli anni ’60 e
’70
Questi interventi sul piano dell’espressione non sono
ritocchi di superficie, ma figure di una retorica che
ricerca il contatto con il pubblico sfruttando le enormi potenzialità del remix e della tecnologia digitale
per evocare paradossalmente la nostalgia, il ritorno a
un’estetica home made, a un mondo di icone e oggetti a
portata di mano, dunque popolari lontani dagli universi
patinati del piccolo schermo. Dietro questa retorica che
costituisce l’ossatura plastica e figurativa degli strani oggetti semiotici che abbiamo analizzato si nasconde dunque una relazione di tipo semisimbolico, l’home made
evoca nello spettatore l’immediatezza della dimensione
live, la nostalgia rassicurante per un immaginario fatto
di grafica, cinema, fumetti che spesso appartiene all’infanzia e all’adolescenza, induce ad abbassare le difese
nei confronti di operazioni commerciali che simulano
una provenienza dal basso avvalendosi degli stessi strumenti/materiali a disposizione di un pubblico di massa
Nei casi più interessanti come quello del mash up video
e del Kung fu remixer che nascono per iniziativa privata e trovano la massima visibilità e diffusione nello spazio del web la manipolazione/distorsione appassionata
dei frammenti audiovisivi prende le forme di un collage
ironicamente amatoriale. L’estetica home made, l’effetto di senso di una lavorazione non professionale, casalinga, investe tutte le dimensioni del testo. L’obiettivo
non è banalmente quello di commentare o tributare un
omaggio a una melodia, un videoclip o un cantante,
siamo lontani dai consueti meccanismi della citazione
postmoderna, della rilettura cinica e distaccata dell’immaginario popolare. Lo scopo è spiazzare intrattenendo, riaprire ossessivamente l’archivio del vintage
Paolo Peverini · Dal bastard pop al mush-up. Mutazioni in corso
regalando al pubblico la felice illusione di giocare con le
forme e con i ritmi dei propri miti popolari.
Bibliografia
Floch J.M., 2006, Bricolage. Lettere ai semiologi della terraferma, a
cura di M. Agnello, G., Marrone, Roma, Meltemi.
Goodwin A., 1992, Dancing in the distraction factory. Music, television and popular culture, Minneapolis, University of
Minnesota Press.
Peverini P., 2004, Il videoclip. Strategie e figure di una forma breve,
Roma, Meltemi.
Pezzini I., Rutelli R., a cura, 2005, Mutazioni audiovisive.
Sociosemiotica, attualità e tendenze nei linguaggi dei media, Pisa,
ETS.
Spaziante L., Dusi N., a cura, 2007, Remix-remake. Pratiche di
replicabilità, Roma, Meltemi.
Il ragazzo ha talento, questo si è capito. Noah è alto quanto
basta da far sembrare l’imponente contrabbasso poco più
di una grossa chitarra appoggiata per terra. Con piccoli
movimenti del capo e rapide occhiate ha tenuto insieme la
band fino a questo momento con una sorta di determinazione liquida che ha messo tutti a proprio agio. Per quanto
possibile, data la situazione.
Adesso però tocca a lui, è il suo momento, il suo assolo. Gli
altri gli fanno spazio nella musica e lui si butta. La testa si
abbassa, lo sguardo va al pavimento e il cappellino da baseball sulla testa fa il resto. L’intenzione è quella di escludere
tutto ciò che sta intorno, fare come se fosse da solo con il
proprio gruppo in una situazione di intimità rilassata, come
se l’aula non fosse gremita da un pubblico rispettoso e attento. La concentrazione è massima. Per i ragazzi sugli spalti
naturalmente, ma soprattutto – impossibile negarlo – per
quei signori che stanno a un lato della sala e che pochi momenti prima si sono esibiti sullo stesso palco. Professionisti
veri, gente che ha suonato con i più grandi nomi del jazz.
Tra essi il maestro di Noah, Roberto Miranda, ma soprattutto Kenny Burrell, una legenda vivente, uno che ha ormai
da tempo il suo posto nelle enciclopedie.
Gli altri strumenti tacciono, gli unici suoni sono quello profondo del contrabbasso e quello caldo e alto di una chitarra
semiacustica che, di tanto in tanto, lancia un accordo a fare
da sfondo all’esecuzione di Noah. Le grandi mani percorrono il manico in lungo e in largo, rapide e nervose, la pressione dei polpastrelli è forte – troppo – bisogna ricordarsi
di non esagerare. Ma soprattutto bisogna ricordarsi di non
ricordarsi di nulla. Gli occhi si chiudono e le labbra cominciano a muoversi. Il contrabbassista “canticchia” le note
un momento prima di eseguirle sul suo strumento, così le
mani non devono fare altro che riportare quello che già è
chiaro nella testa del musicista. E così accade. Ogni tanto
uno schiocco prodotto con la lingua sul palato segna il tempo, quel tempo così importante perché il fraseggio abbia un
senso. Non c’è nessun suono di batteria da seguire e bisogna
fare di tutto per non perdersi.
Il microfono rimanda e amplifica i suoni più flebili, e al primo breve momento di silenzio fra una nota e l’altra diventa
udibile il rumore della respirazione. L’aria entra dal naso,
i polmoni si riempiono allargandosi improvvisamente, poi
l’aria è trattenuta e, in seguito, lasciata andare lentamente.
Un’altra pausa e un’altra espirazione, intensa e rumorosa
ma non profonda. L’aria entra rapida ma non basta a soddisfare il musicista che rimane in debito di ossigeno, ma è il
momento di una nuova escursione sul manico, nuove note
che si susseguono rapide, le corde percosse che vibrano in
maniera evidente, come solo su un contrabbasso accade. Il
tempo per un nuovo respiro arriverà, ma non ora: ora serve
tenere il fiato, come in immersione.
La mano va sulla parte bassa del manico ma è evidente che
non resterà lì a lungo, ormai bisogna rientrare, tornare con
il gruppo. Non è necessario aprire gli occhi per sentire la
tensione degli altri che si preparano, i due sassofonisti hanno
già le mani sulle chiavi e stringono fra i denti il bocchino,
hanno già ricevuto il biglietto di invito portato dalle note
di Noah e, ora, aspettano solamente il segnale. Non resta
che aprire la porta e lasciarli entrare. Per farlo basta uno
sguardo, mentre la mano sale verso le note più basse, gli
occhi si sollevano da terra uscendo da sotto la falda azzurra
del cappello. È il segnale, i due sassofonisti entrano in scena
camminando mentre già il sax tenore porta in alto le note
E|C Serie Speciale
Anno I, n. 1 2007, pp. 121-132
ISSN (on-line): 1970-7452
ISSN (print): 1973-2716
EC
Azioni e distensioni.
Ipotesi sul corpo e il tempo
nel jazz
Dario Mangano
per fare spazio al sax contralto che lo segue e che subito si
inserisce ricominciando la melodia.
1. Non sono un musicista, questo è logico
Non sono un musicista, né un musicologo. Ho sempre
ascoltato musica e per la maggior parte musica jazz
oltre ad avere strimpellato qualche strumento ma non
sono certamente in grado di riconoscere le sfumature
che i veri musicisti colgono in un brano né descriverlo come farebbe uno di loro. Lo dico subito per quella che ritengo una forma di onestà verso il lettore, che
ha il diritto di sapere fino a dove io ho potuto spingermi nell’osservare il fenomeno di cui parlerò in questo
articolo.
Mi riferisco al fatto, banale per un musicista, che si riesca a tenere il tempo in musica. Si tratta di qualcosa di apparentemente banale, è vero, ma a ben pensarci non è affatto così. Basta provare a scandire mentalmente pochi
secondi e poi confrontare il proprio calcolo con quello
di un orologio per capire che tra i due conteggi vi è sempre una differenza – minima magari – ma bastante per
generare effetti catastrofici, se pensata all’interno dell’esecuzione di un’orchestra. Ebbene, per quanto errori
di questo genere possano accadere in una esecuzione, la
norma è che essi non si presentano. I diversi strumenti
presenti in un’orchestra possono produrre lunghe catene di suoni esattamente quando è previsto che lo facciano, con una precisione tale da lasciare basiti.
Il motivo per cui ho deciso di occuparmi di questo particolare aspetto della musica, malgrado le carenze della
mia competenza, sta nella convinzione che un punto
di vista diverso da quello dell’esperto possa produrre
collegamenti potenzialmente interessanti. Si tratta di
un effetto ben noto a quanti conoscono le avventure
Topolino e Pippo.
Dei due, come è noto, Topolino è quello che sa, il cervellone, colui che comprende il significato degli indizi,
© 2007 AISS - Associazione Italiana di Studi Semiotici
T. reg. Trib. di Palermo n. 2 - 17.1.2005
re studiato da punti di vista diversi. L’improvvisazione,
in particolare, che sembra essere la forma che lo caratterizza più di ogni altra cosa, suscita interessi da parte
di studiosi di ogni tipo che guardano alla musica come
ad una chiave per penetrare i segreti di pratiche diverse
quali la scrittura letteraria o, in un senso molto più totalizzante, la vita quotidiana (Sparti 2005). Le pratiche
di composizione on the spot del jazzista sarebbero una
buona metafora di ciò che facciamo per adattarci al
flusso di eventi variabili che costituisce la nostra vita di
ogni giorno. Da ciò un concetto di società che, secondo
Schutz (1971) non è il frutto dell’esecuzione di un insieme codificato di comportamenti alla Durkeim, ma
l’ ”emergenza”, intesa nel senso letterale del termine,
“ciò che viene fuori” da un insieme di interazioni sempre a rischio (Fabbri 2005).
122
che collega fatti e persone e che scopre il colpevole, il
vero detective insomma. Pippo, invece, che ruolo ha?
Normalmente segue il topo facendo dei pasticci qua e
là, si muove lento e goffo lasciando cadere qualcosa ogni
tanto, ma si sbaglierebbe a ritenere nullo il suo contributo alle indagini. A lui, infatti, è implicitamente affidato il compito di suggerire le idee più insolite. Quando
il topo ha le sue famose orecchie paraboliche basse per
la disperazione perché non riesce a risolvere il caso, è
quello il momento in cui Pippo dice o fa qualcosa. Si
tratta di frasi o azioni apparentemente casuali, qualcosa
di cui il poveretto spesso non capisce il senso, ma che offrono al detective la possibilità di una connessione inaspettata, di un percorso di analisi innovativo che poi è
quello che conduce dritto alla soluzione del caso. A quel
punto all’assistente non resta che sfoderare per qualche
vignetta una faccia inebetita e incredula che tuttavia si
risolve presto in un allegro “yuk! yuk!”.
Per quanto riguarda me, in questo articolo spero di poter offrire una prospettiva particolare su un fenomeno
come quello del tempo in musica che, visto dall’occhio
esperto di un musicista, rischia di scomparire e che invece nel mio caso mantiene intatta quella dose di meraviglia indispensabile per interrogarsi su come funzionino le cose. “Rendere il familiare strano”, come recita
uno dei mantra dell’antropologia (Duranti 2007, Spiro
1990), e in questo caso sarà abbastanza semplice.
Dove invece credo sia il caso di andare oltre Pippo è
nel tirare le conseguenze teoriche di un approccio che,
lo ribadisco, nasce non a ragion veduta ma a passion
veduta1. In altre parole sarà il caso di interrogarsi circa
le origini e le conseguenze di quel piccolo deragliamento dal binario della musicologia che sta alla base del
percorso che intraprenderemo. Che effetti può avere
uno sguardo semiotico e antropologico sulla musica?
Cosa perdiamo del fenomeno e cosa invece ci mette
in condizione di riconoscere? In altre parole, che tipo
di pertinenze induce uno sguardo di questo tipo sulla
musica jazz?
Proprio il jazz, tra l’altro, sembra prestarsi bene ad esse-
Dario Mangano · Azioni e distensioni. Ipotesi sul corpo e il tempo nel jazz
2. The Culture of Jazz Aesthetics2
L’analisi che propongo deriva dal mio coinvolgimento
in un corso universitario che non esito a definire straordinario e per diverse buone ragioni. The Culture of Jazz
Aesthetics è quella che in Italia chiameremmo una materia universitaria, con tanto di esame e voto e, ovviamente, di studenti. Si tratta, in particolare, di un corso attivato all’interno programma di studi in Etnomusicologia
presso la University of California Los Angeles (UCLA
d’ora in poi) e – ed è questa la prima particolarità – coinsegnato da due docenti: Alessandro Duranti, che normalmente insegna Antropologia in questa stessa università, e Kenny Burrell che, pur essendo anch’egli un
docente a UCLA nel Dipartimento di Etnomusicologia,
ha uno statuto del tutto particolare. Kenny Burrell è infatti proprio quel Kenny Burrell, un nome che tutti coloro che conoscono un po’ la storia del jazz non possono
non associare a personaggi come Dizzy Gillespie, Oscar
Peterson, John Coltrane, Benny Goodman, Gil Evans,
Sonnny Rollins, e la lista potrebbe continuare a lungo.
Più, ovviamente, Duke Ellington. Del Duca, in particolare, Burrell è diventato uno dei più grandi esperti, e infatti il suo corso istituzionale ad UCLA riguarda ormai
da tempo proprio questo grande musicista.
Quello che viene fuori da questa combinazione abbastanza curiosa è un corso sul jazz che si rivolge tanto a
coloro che studiano antropologia quanto a coloro che
sono iscritti ai corsi di etnomusicologia e che aspirano
a fare i musicisti. La prospettiva teorica è decisamente
fuori dall’ordinario, non essendo mai, come si potrebbe
essere indotti a pensare, di tipo divulgativo-pedagogico.
Non tende a semplificare concetti di teoria musicale per
renderli comprensibili ad un pubblico che ha interessi
e competenze diversificate come quello che, effettivamente, popola l’aula. È piuttosto una chiave di lettura originale della musica che offre spunti tanto a chi si
interessa di antropologia quanto a chi, invece, fa della
musica la sua professione. Mi viene da descriverlo con
una frase che Fabbri usa per introdurre Dell’imperfezione
di Greimas: non cerca risposte più o meno abbaglianti
ma domande pertinenti (Fabbri 1988). Credo sia opportuno, prima di andare oltre, raccontare brevemente il
modo in cui si svolgevano gli incontri. Rimane infatti da
spiegare come una lezione universitaria possa diventare
l’oggetto di una analisi che miri a chiarire una questione come quella della percezione del tempo da parte dei
musicisti. Il punto è che le lezioni del corso non avevano
nulla a che vedere con una tipica lezione universitaria.
Gli incontri, della durata di tre ore, erano divisi in due
parti ognuna delle quali si basava su un modello didattico completamente differente. La prima parte, vedeva la
presenza in aula accanto a Duranti e Burrell di una serie di musicisti, variamente assortiti tra docenti del Jazz
Program e professionisti di rilievo, che avevano il compito di parlare agli allievi del tema del giorno offrendo
– mani allo strumento – abbondanti esemplificazioni
dei concetti espressi. Dall’improvvisazione all’arrangiamento, dall’ascolto alla registrazione, gli argomenti
variavano in modo da coprire il jazz tanto come pratica di produzione quanto di ricezione, in una lezione
che prendeva la forma di un “concerto commentato”.
L’obiettivo era quello di ricostruire tale genere musicale
in quanto pratica culturale complessa a partire proprio dai
racconti dei protagonisti di questa forma d’arte. Si era di
fronte contemporaneamente alla testimonianza diretta
da parte dei musicisti, la cui conversazione veniva opportunamente indirizzata dalle domande dei docenti, e
a una performance che, per l’antropologo, era una forma
di dato grezzo su cui lavorare in termini analitici.
Proprio l’analisi, era ciò che occupava la seconda parte
degli incontri. I musicisti andavano via per lasciare il
“palco” ai docenti i quali, dopo aver fornito un quadro
teorico di riferimento circa la tematica trattata, passavano a riflettere su ciò che qualche momento prima si
era visto accadere sul palco. Si trattava di vere e proprie
analisi improvvisate che procedevano in qualche caso
per comparazione con quanto era successo negli anni
precedenti in cui era stato tenuto lo stesso corso e che,
naturalmente, avevano un impatto sugli allievi del tutto particolare. L’analisi infatti riguardava non gli usi di
una popolazione lontana, o una lingua con la quale non
saremmo mai entrati in contatto, ma qualcosa che era
accaduto davanti agli occhi degli allievi soltanto pochi
momenti prima e che adesso diventava oggetto di una
accurata disamina da parte dei docenti.
Questo mio scritto analizza alcuni minuti della registrazione video relativa all’ultima lezione tenuta nel corso,
una lezione in cui sul palco si sono alternate due piccole
orchestre composte rispettivamente dai docenti del Jazz
Program e dagli allievi dello stesso. L’obiettivo di questa doppia performance, abbastanza chiaro, è quello di
confrontare non soltanto i diversi modi di suonare di
professionisti (fra i quali Burrell stesso) e studenti ma di
avere la testimonianza diretta degli allievi circa le questioni collegate a una performance live. Un ulteriore
gioco di prospettiva dunque, in cui una parte di quello
che prima era il pubblico (i musicisti del Jazz Program
che avevano seguito il corso) diventa il testimone di una
pratica musicale e nel contempo il dato per una ulteriore elaborazione teorica. Un gioco di specchi e trasformazioni articolato e stimolante le cui conseguenze sul
piano teorico sono tutt’altro che immediate.
3. La semiotica e il dato antropologico: brevi
cenni ad alcune implicazioni metodologiche
Per concludere l’introduzione al mio oggetto di analisi
cominciata nello scorso paragrafo, è il caso che espliciti
il mio punto di vista sul fenomeno in questione. Sebbene
per scrivere questo articolo abbia di fatto analizzato la
registrazione video delle performance che hanno avuto
luogo quel giorno, è il caso di precisare che sono stato
io ad eseguire personalmente la ripresa in questione e
che, più in generale, ho avuto il (felice) compito di videoregistrare l’intero corso che Duranti e Burrell hanno
tenuto nel 2006. Lo dico perché da un punto di vista
semiotico il mio punto di vista e il mio oggetto di analisi
potrebbero essere considerati problematici. O almeno,
è mia convinzione che possano essere tali soltanto se
non esplicitati.
Mi riferisco ovviamente all’annosa questione delle cosiddette pratiche che ha impegnato il dibattito semiotico recente creando contrapposizioni fra diverse scuole
di pensiero3. Sarebbe molto lungo entrare nello specifico delle questioni e finirebbe certamente per portarci
fuori tema. Accenno dunque soltanto all’impostazione
generale del problema, quanto basta a consentirmi di
motivare la mia posizione al riguardo.
Il dibattito, come è noto, ha origini nell’essenza “tesualista” della semiotica che ha sempre preferito lavorare
su mediazioni che, per così dire, si “attestano” indipendentemente dalle intenzioni del ricercatore, piuttosto
che direttamente sui fenomeni sociali come è possibile
osservarli direttamente. Per analizzare il mercato delle automobili, per esempio, piuttosto che informarsi
circa il suo andamento magari intervistando un campione di individui oppure analizzando i dati di vendita,
si preferisce guardare a come gli annunci pubblicitari
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
123
124
mettono in forma le differenti valorizzazioni che è possibile assegnare a tali beni (Floch 1990). I vantaggi di
questo modo di procedere risiedono nel fatto che così,
non soltanto ciò che si scopre non viene inficiato da una
domanda più o meno ben posta da parte di un intervistatore, o dalla situazione più o meno artificiale nella
quale la risposta è raccolta, oppure ancora dal dato più
o meno interpretato di una fonte statistica, ma si perviene direttamente a un modello esplicativo piuttosto
che a un insieme di informazioni la cui strutturazione non può che avvenire in un secondo tempo. Ogni
mediazione – come lo sono un manifesto pubblicitario
rispetto ad un certo mercato o un articolo di un quotidiano rispetto ad una certa realtà sociale – non soltanto
significa una certa realtà ma, nel farlo, la costruisce in
quanto fenomeno sociale. In più, essendo l’osservazione
orientata da un modello di analisi che è anche una teoria generale della produzione del senso (Greimas 1966,
1970, 1983), garantisce un punto di vista uniforme su
oggetti di analisi anche molto diversi che sono appunto
considerati nella loro essenza di fatti sociali. La semiotica in questo modo punta a un livello di pertinenza
della riflessione che non è quello delle sostanze (tanto del
contenuto quanto dell’espressione), sempre variabili,
ma quello delle forme più generali a partire dalle quali le
prime vengono generate.
Questa ipotesi teorica ha retto perfettamente fino a
quando non ci si è posti il problema di analizzare fenomeni che, almeno all’apparenza, non erano testualizzati in alcun modo, come possono essere una interazione faccia a faccia o l’atto di scattare una fotografia
o, magari, di suonare uno strumento. In tutti questi casi
il problema che ci si è posti è capire come funzioni la
semiosi in atto, quella che ha luogo nel qui e ora della
performance. L’idea è insomma che per valutare il senso connesso con certe pratiche si debba avere accesso
direttamente ad esse perché l’azione è da subito interpretazione e costruzione di senso (Marsciani 2007). Per
alcuni tutto ciò richiede una profonda revisione dell’impianto teorico della disciplina, che fornisca strumenti
specifici per lavorare su quella che viene considerata
una dimensione del senso parallela a quella testuale.
Altri invece, pur riconoscendo una dignità alle pratiche
come oggetto di analisi, ritengono che la nozione di testo non debba ritenersi inadeguata e con essa non lo
siano anche tutte quelle che da essa discendono. Anzi,
proprio tale concetto sarebbe essenziale per non perdere la specificità dello sguardo semiotico sulla realtà.
Sto banalizzando molto il dibattito naturalmente, ma
quello che mi sembra emergere, ed è la posizione che
faccio mia in questa analisi, è che non è possibile guardare ad alcuna realtà se non in forma mediata, e dunque costruita. Non esiste lo sguardo puro ed innocente,
ogni punto di vista, ogni passaggio, impone le sue forme
e ci allontana dal “dato”, non foss’altro perché è obbligato a una posizione nello spazio, a un punto di vista.
Cercarlo a tutti i costi equivarrebbe ad accontentarsi
Dario Mangano · Azioni e distensioni. Ipotesi sul corpo e il tempo nel jazz
di tacere su ogni cosa. Ecco allora che il paradigma testualista ritorna non più come una forma per aggirare
il problema (“mi rivolgo a testi già costruiti da altri per i
loro scopi anziché alla realtà”) ma come un valido aiuto
contro l’ipocrisia delle forme. Pensare al dato come a
un testo ci consente – ci obbliga – a rendere conto della sua costruzione, dell’artificio che è stato necessario
per porlo come oggetto di una riflessione ritagliandolo
dal flusso continuo che tutti esperiamo continuamente. Da ciò due conseguenze immediate per il testo che
segue. La prima è che deve essere chiara l’avventura
dell’occhio dello studioso rispetto all’oggetto di analisi.
E dunque, come dicevo, il mio essere a un tempo cameraman e analista di un filmato, ma anche protagonista di
una situazione che a sua volta presenta le particolarità
enunciative di cui abbiamo detto. Ciò che mostra il video e che viene analizzato in questo scritto, non è una
performance qualunque, è un momento preciso di una
lezione con certe caratteristiche che non possono non
avere delle ricadute tanto sul mio sguardo quanto sulla
percezione di coloro che ne erano i protagonisti e che
lo utilizzavano per produrre nuovo senso. La seconda
è che non c’è modo per riprodurre ciò che si vede nel
video su carta senza che si debba dare vita a una vera
e propria operazione di traduzione da un sistema di segni ad un altro. Posso utilizzare tutti gli artifici che la
tecnologia mette a disposizione, mostrare i frame uno
per uno, fare dei disegni, dei modelli tridimensionali,
nulla cambierà il fatto che il modo in cui presento il
dato, già costruito ai miei occhi, lo costuisce nuovamente agli occhi del lettore4. Ho dovuto dunque scegliere la
forma che mi consentisse di rendere al meglio quello
che io ho avuto modo di osservare e tale scelta è caduta sulla forma del racconto. Le poche immagini che
accompagnano questo articolo hanno il solo scopo di
aiutare l’immaginazione, il “dato”, o almeno quello che
la tecnlogia consente di condividere, invece, il lettore
lo ha già incontrato al principio di questo scritto e sarà
presto accompagnato da uno analogo. Naturalmente il
filmato rimane e può essere sempre riguardato, da me o
da qualcun altro. In questo sta la sua forza.
4. Guardare il tempo
L’attimo sembra essere centrale in musica. Tutto ciò che
accade, affinché “funzioni”, è necessario che accada in
un preciso momento e non in un altro. Naturalmente
una parte delle problematiche in questo ambito è relativa a cosa dobbiamo intendere per “funzionamento”.
Cosa vuol dire che la musica funziona? Ovviamente
non si può parlare di funzionamento senza avere in
mente un qualche tipo di effetto e molti considerano tali
effetti di tipo comunicativo. Da qui tutte le questioni
relative alla possibilità o meno di considerare la musica
come un linguaggio e sue le eventuali “specializzazioni” e caratteristiche. La sua famigerata “universalità”,
per esempio, oppure il suo legame con i sentimenti e le
emozioni. Questioni di cui non mi occuperò in questa
sede dal momento che il mio interesse è rivolto alla performance. La musica è qui, per me, qualcuno che suona.
Molte cose mi stupiscono di un atto come quello del
suonare. Si tratta infatti certamente di una delle attività umane più complesse che richiede non soltanto una
dedizione assoluta ma anche quella cosa assolutamente
misteriosa che è il “talento”. Malgrado le sfaccettature
di tale pratica siano tante, come ho detto, una delle più
singolari mi pare quella, per certi versi quasi banale, del
“tenere il tempo”. Mi interessa questo aspetto perché
mi sembra che esso non sia esclusivo appannaggio dei
musicisti esperti, anche la gente comune lo fa continuamente. Loro sono naturalmente molto più bravi di noi,
ma in generale riusciamo abbastanza bene a valutare il
tempo di un brano e a riprodurlo. Dove invece il tempo
diventa un vero e proprio mistero è nelle esecuzioni di
gruppo in cui più musicisti, senza alcun aiuto esterno,
riescono a individuare l’attimo in cui “entrare” (o “uscire”) con una precisione di frazioni di secondo talmente
piccole che è difficile anche pensarle. Nel jazz, in particolare, tutto è reso più difficile dalla presenza costante
di momenti di improvvisazione per i quali non c’è una
partitura da seguire. È vero che, come è stato notato
(Duranti 2004, Fabbri 2005, Sparti 2005), l’improvvisazione si basa su un “sapere” che comprende un insieme
di standard cui il musicista jazz deve essere socializzato
e dunque che, da qualche parte, c’è sempre uno spartito, ma tutto ciò non semplifica la situazione, anzi, la
complica. Legare insieme parti di brani differenti come
si fa normalmente durante una improvvisazione ed accordarli opportunamente è ancor più complesso che seguire un’unica partitura. Come dicono sempre gli ospiti
di Duranti, nel jazz bisogna suonare quello che non è
scritto sulla pagina. Ma come fanno i musicisti a tenere
il tempo? E, soprattutto, come fanno a restare sincronizzati gli uni con gli altri? “entrando” (e “uscendo”)
sempre al momento giusto?
Sono domande che sembrano perfettamente risolte nella teoria musicale. Il tempo è standardizzato attraverso
uno strumento tecnico, il metronomo, e poi tradotto
in forme di notazione molto precise che consentono a
chiunque di riprodurre un certo andamento. Alcune
modifiche vengono di tanto in tanto introdotte nelle
convenzioni ma il principio sul quale si basa il sistema
non cambia: c’è sempre una unità di misura e una macchina che è in grado di riprodurla in maniera esatta.
Di recente, per esempio, con la diffusione della musica
dance e con le esigenze di mixaggio che questa pone, si
è diffusa l’abitudine di misurare il tempo in BPM (beat
per minute) o, più semplicemente, beat. Si tratta di una
unità di misura certamente più precisa di quelle usate
tradizionalmente e che consente di tener dietro meglio
ai tempi rapidi della musica da discoteca, nonché di
operare i dovuti aggiustamenti affinché nel mixaggio le
transizioni tra i pezzi risultino perfettamente in sincrono. I musicisti, almeno sulla carta, imparano a seguire il
tempo da queste macchine che pulsano con ritmo sem-
pre perfettamente uguale. L’idea comunemente diffusa è che insistendo a provare e riprovare un brano con
l’odioso click nell’orecchio questo finisca per essere in
qualche modo introiettato, “entrando nella testa” del
musicista. Da quel momento in poi la macchinetta è
come se venisse incorporata nella persona e non è più
necessaria5.
Nonostante la tecnologia e la notazione ci offrano l’idea
di una temporalità perfettamente compresa e imbrigliata, non sono poche le questioni ancora non risolte.
Giusto per fare un esempio, sembra che ci siano un po’
di problemi a far digerire ai software di notazione automatica certi pezzi suonati. Si tratta di programmi che
sono in grado di riconoscere le note suonate e trascriverle secondo il sistema di notazione standard. Un compito che in linea di principio dovrebbe essere adatto ad
una macchina come il computer che è perfettamente in
grado di misurare frequenze e durate e riportarle in un
linguaggio codificato come quello della musica scritta,
ma che nei fatti non viene eseguito sempre bene. Capita
infatti che il calcolatore non riesca a trascrivere ciò che
è stato suonato dal vivo da veri musicisti e “impazzisca”
producendo degli spartiti insensati. Gli specialisti parlano a questo proposito di errori di quantizzazione (Desain
e Honing 1989). Le conseguenze di ciò non si limitano
però alla constatazione che un software funziona male,
dietro l’intelligenza artificiale delle macchine ci sono infatti le teorie cognitive di cui i software sono l’implementazione e che, in luce di questi risultati, dimostrano di
essere insufficienti. C’è spazio dunque per la ricerca ed
infatti nascono centri come il Music Cognition Group
dell’Università di Amsterdam che raccoglie esperti dei
locali dipartimenti di musicologia e dell’ Institute for
Logic, Language and Computation. Proprio gli esperti di Amsterdam (Clarke 1987, Desain e Honing 1989)
sono arrivati alla conclusione che bisogna distinguere
due “tempi” all’interno di un brano: uno che può facilmente essere quantizzato e che costituisce quella che
viene chiamata la struttura metrica del brano (è il tempo
che anche i non musicisti riescono a seguire e riprodurre agevolmente) e un altro che viene chiamato expressive timing che è molto più difficile da riportare su uno
spartito e in generale da comprendere cognitivamente.
La capacità di riprodurre tali variazioni sembra essere
soltanto di quanti hanno studiato musica anche se, l’assenza di tali microvariazioni, risulta avvertibile a tutti
anche solo come una sensazione sgradevole.
5. Timekeeping
A questo punto vorrei che focalizzassimo l’attenzione
sul racconto che inaugura l’articolo. Si tratta dell’esibizione di Noah Garabedian, allievo contrabbassista
del Jazz Program. La situazione, come ho detto, non è
delle più facili per Noah e ciò traspare in maniera evidente dallo sforzo che fa per mantenere la concentrazione. Davanti a lui, a guardarlo, non ci sono soltanto
gli allievi del corso ma anche il suo maestro, Roberto
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
125
126
Miranda, più altri docenti del corso, incluso il grande
Kenny Burrell. Il punto che mi pare interessante è che
nell’impeto di ricerca della perfezione Noah mette in
atto una serie di manovre che in una situazione normale sarebbero rimaste inespresse o difficili da individuare
e che, invece, sotto stress vengono esagerate e rese evidenti anche a un occhio come il mio che non è allenato
a coglierle. Tre in particolare mi interessano: un certo
modo di muovere le labbra, i rumori che il musicista fa
con la bocca, il suo respiro.
Le labbra di Noah si muovono quasi per tutta la durata
dell’assolo in quella che è una imitazione muta del suono che verrà prodotto dal basso. Leggiamo ogni tanto
chiaramente il “bum” di una nota bassa più altre mille
articolazioni che, viste insieme al suono riprodotto sul
contrabbasso, sembrano esserne la perfetta imitazione.
Si tratta quasi di un linguaggio che ne ha gestuale più
che del parlato o del cantato perché nessun suono viene
emesso o, almeno, è udibile, malgrado il potente microfono monodirezionale. Direi che il contrabbassista
“canticchia” anticipando la nota che, qualche istante
dopo, eseguirà sullo strumento. Un uso peraltro molto comune nelle performance dal vivo. Ciò che invece viene vocalizzato, e risulta perfettamente udibile, è
uno schiocco realizzato probabilmente con la lingua
sul palato. Non si tratta di un suono costante come potrebbe essere quello di un metronomo ma di una sorta
di riempitivo che viene a colmare brevissimi attimi di
silenzio. Entrambe sono attività abbastanza diffuse fra
i musicisti, perché – sembra – aiutino a mantenere la
concentrazione e a non perdere il ritmo. Lo schiocco, in
particolare, riproduce quel suono secco che udremmo
se ci fosse una batteria a suonare insieme al contrabbassista. Si tratta in entrambi i casi di attività semioticamente dense e interessanti. Da un lato il musicista (si)
suggerisce quale sarà la prossima nota e dall’altro “si
accompagna” riproducendo altri strumenti. Si creano
insomma due forme di dialogo del tutto particolari. La
prima avrebbe luogo fra la mente del contrabbassista e
la sua mano, il pensiero sembra essere immediatamente
immagine acustica ed in seguito azione della mano sulle
corde. La seconda riguarda invece lo strumento che
normalmente costituisce il principale interlocutore del
contrabbassista, ossia la batteria. Sherman Ferguson,
straordinario batterista del Jazz Program, era solito riferirsi al contrabbassista come al suo “dancing partner”.
Entrambi strumenti chiave della “sezione ritmica”, sono
evidentemente legati tra loro dal “tipo di discorso” che
svolgono all’inteno del gruppo tanto da trovarsi “citati”,
come in questo caso.
Concentriamoci un attimo sul respiro adesso. La respirazione di Noah, catturata con chiarezza dal microfono
(e probabilmente non dall’orecchio nella stessa situazione), è chiaramente alterata, eppure, evidentemente,
non si tratta di una variazione dovuta semplicemente a
una forma di nervosismo. In quel caso, infatti, si produrrebbe un’accelerazione costante del respiro mentre
Dario Mangano · Azioni e distensioni. Ipotesi sul corpo e il tempo nel jazz
qui il fiato viene trattenuto in momenti specifici, che
hanno palesemente a che fare con quello che il musicista sta suonando. La mia impressione è che il musicista crei deliberatamente degli stati di tensione sul suo corpo.
Perché lo fa? Non sarebbe meglio, come si sente dire
spesso, stare rilassati per potersi concentrare sull’esecuzione? Sembra proprio di no, almeno nel jazz dove
questa pratica di crearsi delle tensioni sfruttando il proprio corpo mi pare abbastanza comune. Pensiamo non
soltanto al respiro ma ai vari movimenti che i musicisti
fanno quando suonano, inarcando la schiena (ho notato
che i sassofonisti lo fanno spesso) o mandando indietro
la testa per farla in seguito scattare da una parte (vizio
dei batteristi). Tutti movimenti che, nel caso dei musicisti classici, mi sembra risultino estremamente ridotti in
ampiezza e frequenza (per quanto a mio avviso ugualmente presenti).
Posto che queste tensioni esistono è necessario allora interrograrsi sul ruolo che hanno nel fare musica6. La mia
ipotesi è che servano per mantenere sotto controllo il
tempo dell’esecuzione e sincronizzarvisi perfettamente.
Un’idea che, se fosse corretta, ci obbligherebbe a riconsiderare almeno in parte il concetto stesso di tempo musicale. Una tensione è infatti una grandezza continua e
non puntuale, pertanto pensarla come la via necessaria
per mantenersi perfettamente a tempo comporta a mio
avviso la necessità di rivedere l’ipotesi comunemente
diffusa secondo la quale il tempo resta definito da cesure che spezzano un continuum. Le pratiche musicali,
in altre parole, ci offrono una visione in cui la scansione
temporale è data non da istanti ma da durate. Si tratta, mi rendo conto, di una prospettiva alquanto diversa
da quella a cui siamo abituati e di cui l’orologio – non
a caso la prima macchina costruita dell’uomo – è una
chiara rappresentazione con il suo movimento discontinuo. È interessante allora che i musicisti, per poter
suonare, debbano concentrarsi su ciò che precede quel
rintocco, quel beat. Valorizzare insomma una durata più
che uno stato7.
Ma in che modo i musicisti valorizzano tali estensioni? e
come è possibile stare perfettamente sincronizzati se, di
fatto, ci focalizziamo non su un attimo ma su una durata? Non complica forse le cose pensare piuttosto che a
un rintocco, allo scatto di una lancetta, allo spazio che
questa percorre prima di fermarsi?
La risposta a questi questiti non possiamo che cercarla
nel modo con cui il tempo viene vissuto da coloro che
fanno musica. Come abbiamo visto, nella durata che
precede l’attimo succedono molte cose che rimangono
visibili in alterazioni del fisico: il respiro è trattenuto, i
muscoli contratti, la testa messa in una certa posizione, il tutto per potersi caricare. Il musicista sembra allora
funzionare come una specie di condensatore che accumula energia fino al momento in cui la rilascia prima
di prodursi in un nuovo ciclo. Affinché il tempo venga
mantenuto è necessario che il musicista regoli opportunamente il fluire di queste tensioni.
Secondo questa prospettiva, per suonare bene in gruppo non è necessario essere d’accordo sugli attimi ma sul
modo in cui si arriva ad essi. Se i componenti avranno
un accordo di tipo censivo, si troveranno perfettamente
in grado di mantenere il tempo anche quando questo
fosse spezzato da un una qualche forma di improvvisazione. Per quanto istantanea possa essere, infatti, nessuna transizione è immediata, è sempre il punto di arrivo
di un percorso che viene fatto insieme. L’unico modo
per arrivare in un certo posto tutti perfettamente puntuali, si sa, è fare la strada insieme.
Va da sé che questa forma di consonanza tensiva non garantisce da sola l’accordo fra i musicisti durante la performance e in particolar modo durante l’improvvisazione. Deve essere considerato soltanto uno degli elementi
che vi contribuiscono. Duranti e Burrell (2004) hanno
dimostrato a questo proposito il ruolo fondamentale
che hanno il contatto visivo e la micro-gestualità come
forme di comunicazione all’interno dei gruppi, grazie
alle quali i musicisti trovano forme di intesa tale da far
pensare ad un’unica entità, un unico “corpo”. Un paradosso che la semiotica non fa alcuna fatica ad accettare, essendo perfettamente previsto dalla teoria con la
differenza tra attanti e attori. Quello che è un insieme
di attori ad un certo livello di pertinenza può benissimo
essere considerato ad un altro livello un’unica figura che
chiamiamo un attante collettivo. La folla è un tipico esempio di attante collettivo, in quanto sebbene composta
da individualità diverse finisce per avere un suo proprio
modo di comportarsi e agire nonché un suo “umore”
che non è mai dato dalla semplice risultante dei modi di
fare e degli umori degli individui che la compongono.
Gli atti compiuti da una folla, come d’altronde da una
formazione musicale, sono sempre diversi da quelli che
i singoli elementi che la compongono avrebbero compiuto nelle stesse medesime condizioni8.
Rimangono invece da valutare, e sono a mio avviso la
cosa più interessante, le modalità con cui questo attante
si costituisce. In questo caso specifico esse hanno a che
vedere con un comune “sentire” che risulta difficile definire in maniera più precisa. Tecnicamente pertengono
ad una dimensione della significazione che non è quella
a cui di solito siamo abituati a fare riferimento che è
di tipo cognitivo, bensì a quella meno frequentemente
considerata del corpo. Come insegna Merleau-Ponty, il
corpo ha le sue logiche (e i suoi saperi) e proprio per questo,
e per la pregnanza che esse hanno nella vita quotidiana,
deve essere considerato una vera e propria dimensione
del senso parallela a quella più comunemente considerata, nonché accettata, di tipo testuale-narrativo. Non
c’è significazione senza senso. Senza la “precondizione
corporea” (Marrone 2001, 2005) della percezione che
è al contempo una prima, fondamentale strutturazione
delle forme significanti non c’è possibilità che queste si
concretizzino nei due piani di espressione e contenuto
e, soprattutto, nella relazione che li tiene insieme per
presupposizione reciproca. Si configura un passaggio,
ricorda Marrone (2001), dall’estesia alla significazione
e da questa all’estetica. Al semiologo, dice Greimas, il
compito di mettere il senso in condizione di significare,
che nella fattispecie significa a vere a che fare con una
semiotica non narrativa o pre-narrativa che pure risulta
possibile e che ha il suo specifico oggetto di analisi nelle
passioni, di cui parleremo nel prossimo paragrafo.
A proposito di tali questioni, sembra che Miles Davis
avesse sviluppato forme di interazione raffinatissime
con i suoi musicisti (Smith 1995). Adottava un sistema di suggerimenti (cues) estremamente articolato che
comprendeva sia forme di gestualità – come occhiate e
grugniti vari – che variazioni nell’esecuzione del brano.
L’unica cosa che sembra non facesse mai era discutere di
come dovesse essere affrontato un pezzo. Niente parole
insomma, nessuna forma di conversazione analitica. In
più, con una strategia degna del miglior Machiavelli,
era solito cambiare l’insieme dei suggerimenti tutte le
volte che saliva sul palco, in modo che i musicisti che lo
accompagnavano fossero costretti a mantenere sempre
il magggior grado di concentrazione intorno alla sua
esecuzione. “Miles non vuole che tu pensi di sapere sappia cosa stia succedendo” (Smith 1995 p. 43 trad. mia)
dice uno dei musicisti che ha suonato con lui. Molti
dicono che in questo modo Davis finisse per avere un
tale controllo sul gruppo che non è esagerato dire che
suonasse pressoché da solo tutti gli strumenti.
5. Un percorso passionale per nulla canonico
Abbiamo visto come il corpo del musicista giochi un
ruolo cruciale nella performance, rendendoci conto del
fatto che esso non può semplicemente essere considerato il luogo dove un coinvolgimento patemico si manifesta come un effetto della musica – come può avvenire
ad esempio nel caso della danza o anche di un semplice
piede che batte a tempo – per il semplice fatto che tale
tensione è funzionale alla performance stessa. Bisogna
caricare quello che abbiamo chiamato un “condensatore” affinché si produca il movimento che porta alla
musica.
È indispensabile a questo punto tentare di integrare
nella teoria semiotica quanto abbiamo rilevato, e trattandosi di questioni che hanno a che vedere con una
complessa articolazione tensiva, il modello di riferimento è quello del percorso passionale9 canonico. In questo caso
il passaggio alla teoria risulta essere di particolare interesse poiché incontra alcune resistenze da parte del modello. Secondo tale schema, infatti, l’alterazione somatica come quella che abbiamo descritto a proposito della
performance di Noah, è legata ad uno stato avanzato di
appassionamento. L’innamorato balbetta, l’ansioso comincia a respirare affannosamente, il collerico va “fuori
di testa”, ma soltanto in una fase avanzata del loro percorso all’interno della passione, un momento in cui il
corpo letteralmente prende il sopravvento sulla mente.
Mentre nelle fasi precedenti del percorso di generazione della passione (costituzione, disposizione e patemizzazione)
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
127
128
vi è una qualche forma di controllo e di strutturazione
razionale, con l’emozione l’individuo diventa preda di sé
stesso, del suo medesimo corpo e agisce.
Nel nostro esempio abbiamo visto tutti i segnali di una
presa emotiva eppure essi non sono venuti in seguito ad
una tensione precedentemente costituitasi ma, al contrario, ne sono stati la causa. La tensione per noi è il prodotto
di una trasformazione somatica che ha poco dell’emergenza,
al contrario, sembra essere indotta del tutto volontariamente. In altre parole, delle tensioni vengono indotte nel
corpo affinché si produca quella articolazione patemica
sulla quale costruire l’ossatura della performance, sia
essa del singolo musicista che di un gruppo.
Sebbene disorientante dal punto di vista dei modelli
teorici una pratica del genere non è nulla di realmente nuovo. La volontaria alterazione dei ritmi corporei
è da sempre utilizzata per produrre stati di coscienza
particolare in cui, per esempio, si diventa più aperti a
forme di simbiosi con altri esseri umani o con la natura.
Il paradosso è che il corpo è al contempo il luogo dove
l’alterazione ritmica della musica produce un appassionamento (la musica parla direttamente al cuore, recita
il senso comune) che “emerge” in forme di azione più
o meno involontarie (battere il piede, piangere, ridere,
avere i brividi etc.) ma è anche il luogo dove, grazie all’alterazione volontaria dei ritmi e alla creazione di tensioni, questo appassionamento si produce e dà vita alla
musica. Non è un caso che l’addestramento alla musica
sia totalizzante e duro come quello militare. In entrambi i casi non si deve imparare cosa fare in determinate
circostanze ma cosa provare davanti ad un certo evento,
come condizionare volontariamente il proprio sentire
generando volontariamente precise forme di appassionamento (o mancanza di appassionamento, che è la
stessa cosa). Più che di apprendimento conviene allora
forse parlare dell’assimilazione di una “strategia pragmatica” che Ceriani (2003 p. 196) considera come una
competenza interiorizzata del tutto simile ad un habitus
che, per l’appunto, può essere tanto una rappresentazione mentale quanto un comportamento fisico.
Una consapevolezza molto chiara e precisa che le tensioni “artificialmente” indotte nel corpo producono stati
passionali la possiedono gli attori che, fra l’altro, hanno sviluppato un insieme di tecniche per alterare il loro
proprio stato emotivo che fanno uso proprio del respiro.
Dario Mangano · Azioni e distensioni. Ipotesi sul corpo e il tempo nel jazz
È un po’ quello che succede a tutti noi quando ci addormentiamo: il ritmo del respiro rallenta e ad un certo
punto, di colpo, dormiamo. “il sonno (fino a quel momento) perseguito come significato, improvvisamente
si fa situazione” (Merleau-Ponty 1945 p. 288) È stato il
respiro ad indurci il sonno o il sonno ad indurre il rallentamento del respiro?
Antonin Artaud riassume così il rapporto tra corpo e
passioni nella recitazione:
“I movimenti dello sforzo fisico sono come l’immagine di un
altro sforzo, doppio del primo, e nei movimenti dell’azione
drammatica si localizzano nei medesimi punti. Dove l’atleta
si appoggia per correre, l’attore si appoggia per urlare una
spasmodica imprecazione, ma la sua corsa è proiettata verso
l’interno. Tutti i mezzi della lotta, del pugilato, dei cento metri e del salto in alto trovano analogie organiche nell’esercizio
delle passioni; hanno gli stessi punti fisici di sostegno.
Però con quest’altro correttivo: qui il movimento è rovesciato
e, per quanto si riferisce ad esempio al problema della respirazione, mentre il corpo dell’attore è sostenuto dal respiro, il
respiro del lottatore o dell’atleta si sostiene sul corpo.”
(Artaud 1938 p. 242)
E ancora, poche righe dopo:
“Sapere che una passione è materia, che è soggetta alle fluttuazioni plastiche della materia, garantisce un dominio sulle
passioni che allarga la nostra sovranità. Raggiungere le passioni attraverso le loro forze, anziché considerarle astrazioni
pure, conferisce all’attore una maestria che lo eguaglia ad un
autentico guaritore”
(Artaud 1938 p. 243)
Quanto dice Artaud non può non ricordarci il celebre
esempio con cui Lévi-Strauss spiega il concetto di efficacia simbolica. Mi riferisco naturalmente allo stregone dei
Cuna che attraverso il semplice canto riesce ad alleviare
il dolore fisico della partoriente (Lévi-Strauss 1958).
Infine sempre Artaud menziona il respiro come un elemento essenziale dell’induzione passionale. Dice:
“È certo che, se il respiro accompagna lo sforzo, la produzione meccanica del respiro svilupperà nell’organismo al lavoro
uno sforzo di analoga qualità. Tale sforzo avrà il colore e il
ritmo del respiro artificialmente prodotto. Lo sforzo accompagna per simpatia il respiro(…)”
(Artaud 1938 p. 242)
6. Corpi musicisti
Il corpo del musicista, pertanto, deve essere considerato
al contempo la persona-musicista e uno strumento nelle
mani di questi10. Si ripropone il paradosso della percezione di Merleau-Ponty per cui io sono al contempo
percetto e percettore, cosa del mondo e strumento di
contatto con questo, soltanto che questa volta il corpo
non finisce con i suoi confini fisici, c’è di mezzo qualcos’altro, lo strumento musicale naturalmente. Finora
non ne abbiamo parlato ma è chiaro che il contrabbasso
gioca un ruolo cruciale in questi fenomeni. Qualunque
strumentista ha con il suo strumento un rapporto unico
tale per cui esso non è più un oggetto nelle sue mani,
un puro strumento appunto, ma diviene una parte del
suo corpo, deve divenirlo. Bisogna dimenticarsi di avere
fra le mani un manico su cui bisogna muovere la mano
e quattro corde da pizzicare se si vuole avere il suono
giusto al momento giusto. Quando nel Frankenstein cinematografico di Kenneth Branagh il mostro si rivolge
al suo creatore per chiedergli ragione di chi o cosa egli
sia, menziona la capacità che ha acquisito di suonare il
flauto. Prima di venire alla luce come composizione di
parti di uomini diversi non sapeva farlo, nella sua mente
non v’era traccia di tale capacità, essa è arrivata allora
evidentemente con quella mano che gli è stata attaccata, e pertanto doveva risiedere in essa.
Caso ancora più interessante quello dei cantanti, i quali
non hanno nulla di “esterno” al proprio corpo per produrre musica. Potrebbe essere interessante, ma questa è
materia per un altro studio, capire in questo caso come
si trasforma il corpo grazie all’addestramento. Non si
tratta banalmente del fatto che si guadagna più fiato
ma, in maniera più profonda, del modo in cui si finisce
per percepire se stessi. Il sospetto che mi viene è che
per padroneggiare davvero la propria capacità vocale
debba avvenire un processo più articolato di quello che
accade nel caso di uno strumento come il contrabbasso e in certo modo inverso a quello. La mia ipotesi, è
che sia necessario dimenticare i meccanismi “naturali”
della fonazione per guadagnare quella consapevolezza che consente in seguito di manipolarli e riacquisirli
in seguito sotto forma di automatismi che consentono
di ottenere prestazioni straordinarie. Ma torniamo al
rapporto del musicista con lo strumento. Alcuni minuti
ripresi nella stessa giornata in cui si è esibito Noah of-
frono a mio avviso qualcosa su cui riflettere.
Roberto Miranda è un uomo distinto e gioviale al contempo. A dire molto del suo modo di suonare sono i gesti che
compie quando si prepara a farlo, oppure quando mette via
le sue cose. Ognuno dei movimenti è perfettamente naturale
e al contempo completamente calcolato e misurato da una
lunga esperienza. Il peso del contrabbasso, perfettamente ripartito sulla sua bassa statura, gli consente di muoversi con
eleganza anche con il grosso strumento a tracolla, la stessa
che usa per montare di fronte a sé, prima di ogni prestazione, il leggio sul quale trova subito posto un real book visibilmente navigato. Non ho mai ben capito quanto lo legga, di
certo non si vede mai farlo, ma gli spartiti devono comunque
restare lì, accanto a lui.
Suona da seduto, con il contrabbasso fra le gambe, e in questa posizione lo strumento non sembra tanto più grande di
lui. Questo pomeriggio è al centro della formazione che per
l’occasione è composta anche da Tom Ranier al pianoforte
e Kenny Burrell alla chitarra acustica.
Roberto ha accompagnato l’assolo di Tom con eleganza e
discrezione, percuotendo con grazia le spesse corde del suo
strumento, un sorriso di complicità sul volto ma lo sguardo altrove, verso una platea che non guarda realmente.
L’orecchio ben teso ad attendere il suo momento. Il suo assolo comincia in maniera abbastanza tipica, le note sono
quelle acute della parte bassa del manico su cui le sue piccole
mani si muovono con una destrezza consumata. Ogni gesto
è morbido e non tradisce mai un eccesso di forza. Il vibrato è ottenuto con misurata precisione e senza impeto. Ogni
possibile sbavatura è subito controllata e smussata. Tutto
deve essere naturale, e l’unico modo perché lo sia veramente
è che appaia tale. Le note si susseguono e man mano che
si avvicendano si fa strada la consapevolezza che siano le
stesse di tanti altri assolo. Roberto ha cominciato con ciò
che conosce bene. E tuttavia man mano che va avanti una
strana forza sembra impossessarsi di lui. Chiude gli occhi.
Comincia a muovere le labbra in silenzio, come a suggerire
al contrabbasso le note un attimo prima che questo le emetta. Sembra che qualcosa nella performance stia cambiando,
probabilmente per adeguarla al sorriso che, dall’assolo di
pianoforte di Tom, non ha mai lasciato il suo viso.
Si alternano momenti in cui le corde vengono pizzicate in
una successione non rapida con altri in cui si lascia che il
suono, basso e profondo, si espanda. È in questi attimi che
le spalle vanno indietro e i polmoni si gonfiano d’aria. Il
respiro, amplificato dalla sensibilità del microfono, risulta
perfettamente udibile. D’un tratto il colpo del piede sinistro
che batte forte sul pavimento di legno. La mano pizzica
profondamente le corde che, in qualche caso, battendo sul
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
129
manico nero, producono il tipico rumore metallico. Si fa
strada un’aria di gioco, di divertimento. Una sequenza di
note ravvicinate e acute è l’occasione per rimettere il moto
il piede che, questa volta con una perfetta intenzione, batte
forte sul legno. Tap Tap Tap. A tempo. La risalita alle note
basse è un occasione per far battere ancora le corde sul manico. Ormai l’intenzione è chiara a tutto il corpo. Gli occhi
serrati. La testa che si muove a destra e a sinistra, in alto e in
basso. Il fiato trattenuto. Le labbra rapide. Ed infine il gesto
di pizzicare le corde esagerato in ampi movimenti di tutto il
braccio. È a questo punto che la tensione sfoga in una emissione sonora. Ah!
Le note si perdono, la compostezza di prima è sparita, sostituita da una esecuzione esagerata che, paradossalmente,
non fa dimenticare l’atteggiamento iniziale – anzi – lo evoca
per differenza. Ormai è un crescendo. Note rapide seguono
momenti di maggiore lentezza, il corpo è tutto un movimento, come fosse in preda ad uno spasmo. Di nuovo un’esclamazione scappa dalla bocca. È a questo punto che accade.
1…2…La terza ripetizione dello stesso suono non arriva
mai. Al suo posto un silenzio che dura una battuta in cui il
fiato di tutti resta sospeso.
Il pubblico esplode in una risata subito condivisa da Roberto
e da tutta la band. Applausi. L’assolo rientra e si continua a
suonare in gruppo.
130
Questa esibizione è evidentemente ricchissima di spunti, vorrei però concentrarmi su un singolo momento,
quell’attimo in cui il contrabbasso tace. Cosa accade in
quel breve momento? Tutto è la risposta che mi sento
di dare pensando a dell’Imperfezione di Greimas (e all’introduzione che ne fa Fabbri) (1988). Si tratta infatti
di un perfetto esempio di quella che Greimas chiama
presa estetica, quell’attimo (che è anche una durata) in
cui il tessuto significante della realtà si sfalda per dare
vita all’esperienza fugace ed abbagliante di una verità.
Non dimentichiamo che la “condizione primaria (della
presa estetica) è l’arresto del tempo” (Greimas 1987 p.
30). Qui il silenzio ci dà la possibilità di ascoltare quello
che c’è oltre l’apparenza di un soggetto e un oggetto
che sono “posti e non dati, in una revisione costante di
agire e di patire; pieghe – non buchi – nella sostanza del
mondo, sempre pronti a farsi e disfarsi” (Fabbri 1988
p. 13).
La mia impressione è che Roberto Miranda in quell’istante di silenzio compia una azione molto precisa:
lasci respirare il contrabbasso. Gli faccia “tirare il fiato” in
quella che è una inversione tra soggetto e oggetto densa
di significati e conseguenze.
Ma c’è di più perché la presa estetica “è agogia nel senso musicale del temine, spunto di trasformazione dei
paradigmi in sintassi cioè, direbbe Brøndal, di ritmo”
(Fabbri 1988 p. 18). Obbligatorio a questo punto ricordare la definizione di agogia: “l’impulso dal quale
scaturisce e si svolge il ritmo musicale inteso quale virtù
soggettiva e non riducibile a schema, sì da lasciare adito
al talento interpretativo personale dell’esecutore, cui ne
spettano l’individuazione e la ricostruzione” (DevotoOli).
Concludendo, ritengo che considerare la base fisica,
Dario Mangano · Azioni e distensioni. Ipotesi sul corpo e il tempo nel jazz
corporale, del suonare cambi del tutto la prospettiva
che possiamo avere su questa pratica. Ecco allora perché gli esperti di Amsterdam hanno tanti problemi con
i modelli per riprodurre l’expressive timing. Quel tipo di
temporalità è propria di una dimensione altra rispetto
a quella cognitiva, una dimensione fisica che non può
che essere considerata a partire da una semiotica del
corpo. L’unico modo di descriverla sembrerebbe essere
tradurla in qualcos’altro, forse in un lessema, come si fa
con allegro, allegretto, andante, o, forse, in una storia.
Note
1
L’espressione non è mia, l’ho presa in prestito da Fabbri
Questo articolo deve moltissimo alla disponibilità di
Alessandro Duranti e Kenny Burrell che mi hanno dato l’opportunità di assistere al loro corso presso la University of
California Los Angeles, ed in seguito di lavorare sui filmati prodotti in quella sede. Questo articolo, in particolare, si
basa sul girato del giorno 30 maggio 2006. Ringrazio inoltre
Alessandro Duranti per le molte idee che mi ha regalato nelle
passeggiate nel campus alla ricerca di un buon caffè e di una
tazzina calda per contenerlo. Segnalo inoltre che le ricerche
di Duranti e Burrell hanno già prodotto un articolo intitolato: Jazz Improvisation: a Search for Hidden Harmonies and a Unique
Self (Duranti e Burrell 2004) e un DVD intitolato The Culture
of Jazz Aesthetics distribuito da UCLA Instructional Media
Collections & Services.
3
Ci si può fare un’idea del dibattito consultando Marrone
(2005b), Basso (2006), Marsciani (2007).
4
Su queste tematiche rimando il lettore a un articolo scritto
insieme a Gianfranco Marrone che sarà pubblicato prossimamente negli atti del convegno intitolato “L’immagine nel discorso scientifico: statuti e dispositivi di visualizzazione” che si
è tenuto al Centro internazionale di semiotica e linguistica di
Urbino nel luglio 2007 ed in cui si analizza il DVD prodotto
da Duranti e Burrell con i materiali del corso.
5
Interessante rilevare qui una sorta di inversione rispetto
alla teoria di Latour sulle macchine. Il sociologo della tecnica parla spesso di come gli oggetti abbiano inscritte al loro
interno forme di soggettività. Un dosso artificiale, come annuncia esplicitamente la lingua francese, può essere considerato un poliziotto disteso (gendarme couché) (Latour 1992), ma
anche altri oggetti come chiudi-porta e girarrosto possono
essere antropomorfizzati nel doppio senso di essere guardati
come qualcosa che può rimandare all’uomo, ma anche, e più
importante, che dà forma a ciò che è umano (Latour 1992).
Nel nostro caso il fenomeno è inverso. Qui la macchina viene
interiorizzata da un individuo, o meglio, incorporata in esso.
La mia sensazione è infatti che il tempo non stia mai soltanto nella testa del musicista ma si localizzi sempre da qualche
parte nel suo corpo, si tratti di un piede che batte o qualcosa
di molto meno percettibile come la contrazione dei muscoli
della mascella.
6
La tensione è elemento chiave di una semiotica celebra il
primato delle dinamiche affettive e dunque tensive nella costruzione del senso. Si vedano al proposito le posizioni molto
diverse di Fontanille e Zilberberg (1998) e Barbieri (2004).
7
Si tratta della cosiddetta dimensione aspettuale che è caratteristica delle passioni in quanto ognuna presuppone – e
2
risulta definita da – una certa prospettiva sul processo in atto.
Così l’ira sarà una passione puntuale mentre il rancore, per
quanto disforico come quella e per molti versi simile ad essa,
sarà invece durativo.
8
Da un punto di vista semiotico va chiarito che le dinamiche
che conducono alla formazione del gruppo come attante collettivo non sono quelle classiche della narratività legate alla
presenza di comuni programmi narrativi congiuntivi o disgiuntivi rispetto a un oggetto di valore (quale potrebbe essere
in questo caso una certa risposta da parte del pubblico). Qui
le dinamiche sono a mio avviso più sofisticate e pertengono
alla nozione di “contagio” proposta da Landowski (2003) che
sposta così l’attenzione sugli aspetti fisici e sensoriali profondi della comunicazione che il semiologo lega al concetto di
unione in contrapposizione a quello narratologico di giunzione.
La risata è tipicamente qualcosa che si diffonde per contagio.
Vedere qualcuno che ride ci induce a seguirlo, anche quando non abbiamo idea di cosa induca tale stato e dunque non
abbiamo chiare su un piano logico le motivazioni di tale azione, la compiamo ugualmente, ne siamo letteralmente attratti.
Ulteriormente interessate il fatto che in un caso come quello
della risata, l’entrata in scena di un secondo attore produce
usualmente nel primo una trasformazione provocando l’intensificazione della risata stessa. In sintesi, il contagio non si
limiterebbe a un semplice “passaggio” ma altererebbe tutte le
entità coinvolte nella situazione ridefinendole completamente.
9
Il percorso passionale canonico è il modello di riferimento per la trattazione delle dinamiche passionali in semiotica
(Fontanille 1993, Greimas e Fontanille 1991). Si tratta di uno
schema che, sulla traccia dello schema narrativo, individua
alcune fasi chiave dei fenomeni passionali e le ordina secondo un criterio logico. Grande merito di tale approccio è stato
quello di mostrare le implicazioni sociali di un ambito fino a
quel momento considerato completamente legato a pulsioni
intime e personali e come tale per nulla sovraindividuale.
10
Il musicista si configura come un ibrido laturiano, è l’unione di un corpo più uno strumento che, nel momento in cui
si costituisce, riconfigura gli elementi che lo compongono. Il
corpo che è soggetto si “oggettivizza” e l’oggetto si “soggettivizza” acquisendo, se non altro, la capacità di fare (Latour
1988, 1992)
Bibliografia
I rinvii bibliografici presenti nel testo fanno riferimento alle
edizioni originali, mentre i rimandi ai numeri di pagina sono
da considerarsi relativi all’edizione italiana qualora la stessa
figuri fra gli estremi sotto riportati.
Artaud, A., 1938, Le Théâtre et son double, Paris, Gallimard;
trad. it., Il teatro e il suo doppio, Torino, Einaudi, 1968.
Barbieri, D., 2004, Nel corso del testo. Per una teoria della tensione e
del ritmo, Milano, Bompiani.
Basso, P., a cura, 2006, Semiotiche, vol. 4, Torino, Ananke.
Canetti, E., 1960, Masse und Macht, Hamburg; trad. it., Massa
e Potere, Milano, Adelphi, 1981.
Ciancarelli, R., a cura, 2006, Il ritmo come principio scenico,
Roma, Audino.
Clarke, E. F., 1987, “Categorical rhythm perception: an ecological perspective” in Gabrielson, A., a cura, Action and
Perception in Rhythm and Music. Royal Swedish Academy
of Music, 55.
Desain, P., Honing, H., 1989, “The Quantization of Musical
Time: A Connectionist Approach”, in Computer Music
Journal, vol. 13, n. 3, New York, MIT.
Duranti, A., 1997, Linguistic Anthropology, Cambridge,
Cambridge University Press; trad. it. Antropologia del linguaggio, Roma, Meltemi, 2000.
Duranti, A., Burrell, K., 2004, “Jazz Improvisation: a Search
for Hidden Harmonies and a Unique Self ”, in Ricerche di
Psicologia, n. 3, vol. 27, pp. 71-101.
Duranti, A., 2007, Etnopragmatica. La forza nel parlare. Roma,
Carocci.
Fabbri, P., 1988, Introduzione alla trad. italiana di Greimas
(1987).
Fabbri, P., 2005, L’improvvisazione Jazz: conversazione e racconto,
in AA.VV., Jazz in Emilia Romagna. L’arte, la storia, il
pubblico, Europe Jazz Network Ed.; titolo originale: “Lo
imprevisto de improviso”, in Revista de Occidente, a cura, J.
Lozano, julio-agusto 2005.
Fabbri, P., Marrone, G., 2001, a cura, Semiotica in nuce II. Teoria
del discorso, Roma, Meltemi.
Floch, J. M., 1990, Sémiotique, marketing et communication, Paris,
PUF; trad. it. Semiotica, marketing e comunicazione, Milano,
Angeli, 1997.
Greimas, A. J., 1966, Sèmantique structurale. Recherche de méthode, Paris, Larousse; trad. it. Semantica strutturale, Roma,
Meltemi, 2000.
Greimas, A. J., 1970, Du Sens, Paris, Seuil; trad. it. Del senso,
Milano, Bompiani, 1974.
Greimas, A. J., 1983, Du Sens II, Paris, Seuil; trad. it. Del senso
2, a cura di P. Magli e M.P. Pozzato, Milano, Bompiani,
1985.
Greimas, A. J., 1987, De l’imperfection, Périgueux, Fanlac ; trad.
it. Dell’imperfezione, Palermo, Sellerio, 1988.
Greimas, A. J., Fontanille, J., 1991, Sémiotique des passions. Des
états des choses aux états d’âmes, Paris, Seuil; trad. it. Semiotica
delle passioni. Dagli stati di cose agli stati d’animo, a cura di F.
Marsciani e I. Pezzini, Milano, Bompiani, 1996.
Latour, B., 1992, Where Are the Missing Masses? The Sociology of
a Few Mundane Artifacts, in Bijker, W.E., Law, J., Shaping
Technology/Building Society, Cambridge (Mass.), MIT
Press, 1992; trad. it. riv. 2006 Dove sono le masse mancanti?
Sociologia di alcuni oggetti di uso comune, in Mattozzi, A., Il
senso degli oggetti tecnici, Roma, Meltemi, 2006.
Fontanille, J., 1993, “Le schéma des passions”, in Proteé,
vol. XXI, n. 1, pp. 33-41; trad. it in Fabbri e Marrone
(2001).
Fontanille, J., Zilberberg, C., 1998, Tension et signification,
Mardaga, Liège.
Hjelmslev, H., 1959, Essais linguistiques, Copenhague, Travaux
de Cercle Linguistique de Copenhague, XII; trad. it.
Saggi di linguistica generale, a cura di Prampolini, M.,
Parma, Pratiche, 1981.
Honing, H., 2006, “Evidence for tempo-specific timing in
music using a web-based experimental setup” in Journal
of Experimental Psychology: Human Perception and Performance,
vol. 32, n. 3, pp. 780-786.
Landowski, E., 2003, Al di qua o al di là delle strategie: la presenza
contagiosa, in Manetti, Barcellona e Rampoldi (2003).
Landowski, E., 2006, Les interactions risquées, Limoges, Pulim.
Latour, B., 1998, Fatti, artefatti e fattici in Nacci, M., Oggetti d’uso
quotidiano. Rivoluzione tecnologiche nella vita d’oggi, Venezia,
Marsilio, 1998.
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
131
132
Leroi-Gourhan, A., 1965, Le geste et la parole. La mémoire et les
rythmes, Paris, Albin Michel; trad. it. Il gesto e la parola vol.
2. La memoria e i ritmi, Torino, Einaudi, 1977
Lévi-Strauss, C., 1958, Anthropologie structurale, Paris, Plon; trad.
it. Antropologia strutturale, Milano, Il Saggiatore, 1966.
Manetti, G., Barcellona, L., Rampoldi, C., a cura, 2003, Il
contagio e i suoi simboli, Pisa, ETS.
Marrone, G., 2001, Corpi sociali, Torino, Einaudi.
Marrone, G., 2005, La cura Ludovico, Torino, Einaudi.
Marrone, G., 2005b, Sostanze tossiche, forme stupefacenti, in
Marrone, G., a cura, Sensi alterati, Roma, Meltemi.
Marsciani, F., 2007, Tracciati di etnosemiotica, Milano, Angeli.
Merleau-Ponty, M., 1945, Phénoménologie de la perception, Paris,
Gallimard; trad. it. Fenomenologia della percezione, Milano,
Bompiani, 2003.
Merleau-Ponty, M., 1960, Signes, Paris, Gallimard; trad. it.
Segni, Milano, Il Saggiatore, 1967.
Pedrazzi, M., 2007, La pratica dell’improvvisatore. Sapere a disposizione e disposizione del sapere, Tesi di Dottorato di ricerca,
Bologna, Università di Bologna.
Piana, G., 2005, Conoscenza e riconoscimento del corpo, Milano,
Mimesis.
Schutz, A., 1971, “Making music together. A study in social
relatioship”, in Collected papers vol. 2, The Hague, Nijhoff,
pp. 159-178; trad. it. in Frammenti di fenomenologia della musica, Milano, Guerini e Associati, 1996, pp. 91-114.
Smith, C., 1995, “A Sense of the Possible. Miles Davis and
the Semiotics of Improvised Performance”, in The Drama
Review n. 39, New York, MIT.
Sparti, D., 2005, Suoni inauditi. L’improvvisazione nel jazz e nella
vita quotidiana, Bologna, Il Mulino.
Sparti, D., 2007, Musica in nero. Il campo discorsivo del jazz,
Torino, Bollati Boringhieri.
Spiro, M. E., 1990, On the Strange and the Familiar in Recent
Anthropological Thought, in Stigler, J. W., Shweder, R. A.,
Herdt G., a cura, Cultural Psychology: Essays on Comparative
Human Development, Cambridge, Cambridge University
Press, pp. 47-61.
Timmers, R., Honing, H., 2002, “On music performance,
theories, measurement and diversity” in Belardinelli
M.A., a cura, Cognitive Processing (International Quarterly
of Cognitive Sciences), vol. 1-2, n. 1-19.
Filmografia
Bird di C. Eastwood, USA, 1988.
Mary Shelley’s Frankenstein di K. Branagh, USA, 1994 (versione
italiana: Frankensttein di Mary Shelley).
Dario Mangano · Azioni e distensioni. Ipotesi sul corpo e il tempo nel jazz
1. Cinema e musica: l’esigenza di esserci
Il cinema propone da sempre – con straordinaria potenza icastica – i propri segni al nostro sguardo, al nostro ascolto e più in generale all’immaginario collettivo.
E per un processo che Christian Metz (1971, p. 120) nei
primi anni Settanta chiamava di aller-rétour, il cinema
attinge a immagini e suoni della realtà extra-cinematografica, li interpreta e li filtra attraverso i suoi codici e
i suoi discorsi specifici; e li restituisce al nostro sguardo
risemantizzati, “cinematografizzati”. È questo il caso
dei brani musicali della colonna audio di un film che
una volta al di fuori dello schermo portano con loro
sempre un po’ di cinema; come diceva Metz (1991, p.
173), aderiscono al film “da cui diventano inseparabili
nella memoria collettiva”, tanto da diventare evocativi
di una sequenza o di un intero film. E ciò vale non solo
per le musiche composte appositamente per un film,
che dunque dal film, in un certo senso, sono motivate,
ma anche per brani musicali non originali che una volta intessuti nella trama audiovisiva e transensoriale del
cinema finiscono per acquisire una dimensione cinematografica e visiva.
Il procedimento di cinematografizzazione di un brano
musicale illustrato da Metz rappresenta una esperienza
comune per spettatori e spettatrici cinematografici, ma
nonostante la dimensione collettiva di tale esperienza, il
grado di cinematografizzazione dipende dalla competenza individuale; in altre parole, benché colonna audio e colonna video concorrano in maniera sinergica e
sinestesica alla costruzione del senso filmico, il processo
evocativo che la musica svolge, una volta distaccata dall’immagine, dipende dalla cooperazione testuale e dalla
competenza di chi ascolta, ne chiama in causa la cultura cinematografica e musicale. E del resto, la musica
costituisce uno di quei nodi attraverso cui gli spettatori
possono inaugurare le “passeggiate inferenziali” (Eco
1994), ovvero nuovi percorsi interpretativi e di senso.
La potenza evocativa della musica, cioè la capacità che
musica e immagine hanno di armonizzarsi a vicenda,
sembra dunque istituire l’“esigenza d’esserci” della musica nel film. Questa espressione appartiene ad un celebre lavoro di Theodor Adorno e Hanns Eisler (1969)2,
La musica per film, in cui, sebbene con una impostazione
teorica distante da quella semiologica, in qualche maniera i due autori pongono la questione del rapporto
fra musica e immagine nel cinema muto. L’immagine
muta, essi scrivono, produce effetti spettrali che mettono a disagio. L’immagine muta è terribile e angosciante
e la musica nel film “ha il gesto del bambino che canta
nel buio per proteggersi”3.
Ma è per la natura stessa del cinema, sistema pluricodico, che la musica non è solo una necessità, ma uno di
quei cerchi concentrici – ancora un’espressione di Metz
(1971) – che costituiscono la struttura del linguaggio
cinematografico, fortemente eterogeneo. Eterogeneità
di materie dell’espressione: immagini fotografiche in
movimento; linguaggio verbale scritto (didascalie, titoli,
E|C Serie Speciale
Anno I, n. 1 2007, pp. 133-136
ISSN (on-line): 1970-7452
ISSN (print): 1973-2716
EC
Requiem for a dream
di Darren Aronofsky.
Ritmo e audiovisione 1
Francesca De Ruggieri
etc.); suono fonico (la voce); suono musicale; suono analogico (i rumori)4.
Nel suo contributo alla semiotica del suono cinematografico, Michel Chion ha introdotto il termine “audiovisione” per indicare una nuova modalità percettiva:
“nella combinazione audiovisiva (…) non si ‘vede’ la
stessa cosa quando si sente; non si ‘sente’ la stessa cosa
quando si vede” (Chion 1990, p. 7). Il fatto è che la percezione non è una somma di dati visivi, auditivi, etc.,
ma è prodotta dall’essere nella sua totalità: la percezione è “un’unica maniera d’esistere che parla contemporaneamente a tutti i miei sensi” (Merleau-Ponty 1948,
pp. 69-83). Musica e immagine intessono un dialogo
costante durante tutto lo scorrere di un film e in questo
rapporto si modificano reciprocamente. “È spesso dal
suo rapporto particolare con l’immagine che la musica
riceve la sensazione di tristezza, di gioia, di dinamismo,
ecc. di cui sembra in seguito colorarla” (Chion 1985,
p. 119). Immagini e musica, insomma, si contaminano.
E non si tratta mai di semplice trasposizione sul piano
acustico di immagini o situazioni emotive, ma di una
forma traduttiva che opera in due direzioni.
Ciò significa che la musica non si limita a raddoppiare
un senso, ma finisce per creare un senso nuovo prodotto, però, dall’incontro con l’immagine. “A posteriori
– continua Chion – si crede fermamente di aver visto
ciò che invece si è soprattutto sentito, e si rimprovera
al suono di raddoppiare un senso che in realtà crea”
(ivi, p. 85). Ma del resto, come potrebbero due materie
dell’espressione così diverse, che sollecitano sensorialità
diverse, duplicarsi? Queste due strutture – visiva e sonora – vengono armonizzate fra loro (ivi, p. 86) secondo
un rapporto ritmico che determina nuove valenze patemiche e una nuova percezione: l’audiovisione, appunto.
Non la semplice corrispondenza fra ritmo musicale e
ritmo della successione visiva5, dunque, ma un ritmo
costruito dall’incontro fra due materie eterogenee.
© 2007 AISS - Associazione Italiana di Studi Semiotici
T. reg. Trib. di Palermo n. 2 - 17.1.2005
Nel film di Darren Aronofsky Requiem for a dream, oggetto della nostra analisi, possiamo osservare un esempio
interessante di costruzione ritmica audiovisiva, in cui
ciò che è visto e ciò che è ascoltato si confondono sul
piano sensoriale; e in cui il montaggio sembra trasporre sul piano audiovisivo il ritmo musicale della musica
hip-hop.
2. La musica al cinema: quali funzioni?
134
Le funzioni semiotiche che la musica svolge nel cinema investono diversi livelli della struttura testuale di
un film. La musica concorre all’articolazione degli stati
emotivi prodotti dal film negli spettatori; concorre alla
rappresentazione degli stati emotivi dei personaggi e
delle situazioni; contribuisce, allo svolgimento narrativo, agendo in particolar modo sulla articolazione spazio-temporale6 e, infine, consente all’istanza enunciativa
di prendere posizione e di commentare le immagini7.
Nel film di Aronofsky, il contributo della musica all’articolazione emotiva del film è fondamentale. In particolare, l’effetto che la musica impiegata in questo film
produce è quello di esaltare e tradurre gli stati emotivi di personaggi e situazioni del film, creando empatia
negli spettatori. È ciò che Chion (1990, p. 17) definisce
musica “empatica”.
Le altre possibili articolazioni della rappresentazione
sonora degli stati emotivi sono la musica anempatica
– che non sembra intensificare o mitigare gli stati e
gli effetti emotivi – e la musica in contrappunto – che
produce sensazioni emotive contrarie rispetto a quelle
rappresentate dalle immagini (ibidem) (dunque contrappunto va inteso dal punto di vista semantico e non
ritmico: non si tratta, cioè, di una mancanza di sincronizzazione fra immagine e suono, ma di una discordanza di significato emotivo e patemico).
La teoria filmica, come nota Annette Kuhn (1995, p.
28) ha avuto la tendenza a non considerare la dimensione patemica come parte integrante dell’esperienza
filmica, perché le emozioni impediscono la razionalizzazione e l’intellettualizzazione dell’opera filmica.
Eppure, l’emozione mette in gioco l’esperienza, dato
fondamentale per la ricezione di un testo filmico. Non
solo: l’emozione non è un effetto immediato e non segnico. Così come non lo sono le passioni. Nei Collected
Papers di Charles Sanders Peirce leggiamo che l’emozione è un processo inferenziale che compare in seguito
ad un pensiero (sviluppatosi a partire dalla percezione
di un oggetto), ma che insorge quando la nostra attenzione è rivolta a circostanze che il pensiero non riesce a
dominare; l’emozione, dunque, è un predicato semplice che si sostituisce ad un predicato complesso (Peirce
1980, pp. 68-70). E del resto, la prima esperienza della
visione filmica è emotiva, è quella che passa per il corpo
fisico sotto forma di emozioni e di reazioni corporee
(ansia, torpore, etc.); mentre l’esperienza successiva è
quella critica, che si articola tuttavia a partire dal vedere
emotivo. Ci sono due modi di andare a cinema, scriveva Roland Barthes (1984, p. 359) negli anni Settanta,
uno critico e uno quasi corporale, di godimento, che
chiama in causa il corpo e le sue reazioni all’immagine
e a ciò che la eccede (la grana del suono, il buio della
sale, la luce che emana dallo schermo, etc.).
Se consideriamo come al cinema la cooperazione degli spettatori sia fondamentale nella costruzione della
fabula – intesa non solo come l’organizzazione delle relazioni fra i personaggi e l’organizzazione degli eventi
secondo una catena cronologica, ma anche come quel
costrutto immaginario che gli spettatori mettono in atto
quando devono collegare due eventi narrativi dal punto
di vista causale, temporale o spaziale – risulta evidente
che il ruolo che la musica svolge sul piano emotivo non
è privo di effetti sul piano discorsivo e narrativo.
Il cinema ci offre infiniti esempi di trasposizione delle
tensioni emotive sul piano acustico; o anche di contraddizione sonora degli stati emotivi mostrati. Un
esempio ampiamente discusso di musica didattica in
contrappunto è quello dell’impiego di Bach nei primi
film di Pier Paolo Pasolini; in Accattone, ad esempio, le
note della Passione secondo Matteo creano un cortocircuito culturale fra le immagine delle borgate e la musica
barocca, colta e borghese. Fin dai titoli di testa, con il
coro Wir setzen uns mit Tränen nieder. Questo innovativo
impiego della musica nel cinema non è solo una sperimentazione tecnicistica, seppur raffinata, ma risponde
ad una precisa impostazione intellettuale e politica: la
musica sacra trasforma ogni gesto di Accattone in un
gestus brechtiano, lo eleva a gesto sociale, lo rende, per
l’appunto, sacro.
Se la musica in contrappunto rivela una esplicita intenzionalità enunciativa, ovvero è una delle forme che
assume l’enunciazione enunciata nel film, non meno
marcata dal punto di vista enunciativo è la musica empatica, ovvero una sonorità che produce un senso di
organicità e coerenza fra stati emotivi rappresentati e
messi in moto dalle immagini e stati emotivi sollecitati
dalla musica. A questo proposito, un esempio piuttosto
sfruttato ma efficace è quello di The End dei Doors in
Apocalypse Now di Francis Ford Coppola, che nella scena d’apertura contribuisce a suscitare negli spettatori il
Francesca De Ruggieri · Requiem for a dream di Darren Aronofsky. Ritmo e audiovisione
senso di orrore che caratterizza il film..
3. Requiem for a dream: breve analisi della
colonna sonora
Anche in Requiem for a dream, la musica svolge una funzione nel produrre le tensioni emotive e nel creare
empatia negli spettatori. In questo film disturbante,
Aronofsky mette in scena le vite di quattro personaggi
risucchiati in un mondo parallelo, attraverso l’uso di diverse sostanze stupefacenti, dalle anfetamine all’eroina,
dalla marijuana alla televisione, dalla cocaina al caffè.
I mondi artificiali in cui entrano i protagonisti sono il
frutto dell’allucinazione (alterazione della visione e dell’ascolto) e dello stordimento (alterazione psicofisica) e
sono popolati da frigoriferi che si muovono ed emettono rumori sinistri, da cibo che si materializza nel salotto
di casa, e altre visioni angoscianti.
La musica contribuisce alla creazione di una “cupezza”
organica in tutto il film, in particolare attraverso il tema
musicale principale della colonna sonora (eseguita dal
Kronos Quartet), che attraversa il film fin dalle prime
scene e che sfuma sui titoli di coda. Naturalmente la
scelta sintattica non è casuale, perché questo tema dalla
melodia inquietante “punteggia” il film lungo tutto il
suo corso (svolgendo dunque una funzione narrativa),
ma soprattutto ritorna sui titoli di coda a costruire la
circolarità del film che racchiude in maniera inesorabile
il destino dei protagonisti, un destino segnato fin dalle
prime sequenze che, dal punto di vista visivo, invece,
sono solari. È dunque la musica che conferisce loro un
senso di cupezza. Un senso di cupezza che, per quel
procedimento evocativo di cui parlava Metz, aumenta non solo ad una seconda visione, ma anche nel momento della rielaborazione critica di ciò che si è visto.
In altre parole la musica non produce empatia in virtù
di caratteristiche intrinseche, ma in virtù della trasposi-
zione sul piano acustico della tensione e della struttura
narrativa.
Requiem for a dream mostra come la dipendenza possa
essere prodotta da ogni tipo di sostanza. Se questa intuizione di Aronofsky non è del tutto originale, decisamente efficace e appropriata risulta l’organicità fra
immagine, musica e suoni analogici (cioè i rumori, ma
qui utilizzati con finalità estetiche). Attraverso un montaggio velocissimo di brevi fotogrammi che ritraggono
i gesti quotidiani dell’assunzione di sostanze (la mano
sul telecomando, il sorso d’acqua per buttare giù le pillole, la banconota arrotolata per sniffare, l’accendino
che scioglie l’eroina), accompagnati da rumori brevi, si
riproduce con enfasi la ritualità ritmica del drogarsi.
Il montaggio hip-hop – come lo stesso regista lo definisce – consiste, dunque, nell’accostare velocemente – e
in alcuni casi simultaneamente nello stesso quadro suddiviso in finestre – brevi fotogrammi di immagini o di
azioni (che potremmo accostare ai break dell’hip hop8),
accompagnati da effetti sonori che pur non provenendo dall’universo diegetico rappresentano le azioni con
cui vanno in sincrono. Questi suoni però sono talmente
amplificati, esagerati o sintetizzati da risultare al nostro
orecchio artificiali. Dunque, una delle isotopie centrali del film, l’artificialità dei mondi in cui si entra per
via delle sostanze stupefacenti, viene tradotta sul piano
acustico in virtù dell’enfasi che il suono conferisce all’immagine.
Benché si tratti di ciò che comunemente potremmo
chiamare rumori, ovvero di suoni irregolari, privi di
forma d’onda armonica, e spesso sgradevoli all’udito,
in realtà i suoni in Requiem for a dream sono collocati sulla
scala musicale, cioè campionati, e danno luogo ad una
originale sinfonia rumoristica. Subiscono, cioè, un processo di estetizzazione. Diventano musica. Nonostante
i rumori non abbiano una forma d’onda regolare o armonica, sono gli intervalli tonali a cui si adeguano a
renderli sostanza dell’espressione di una sequenza musicale. Del resto, è su questo principio che si fondano
gli esperimenti che nell’ambito della storia della musica del Novecento hanno cercato di produrre tracce
musicali attraverso suoni non convenzionali; penso ai
musicisti futuristi come Luigi Russolo, che utilizzò i
rumori a fini compositivi, o alla “musica concreta” di
Pierre Schaeffer, costituita da qualsiasi tipo di suono.
Ma penso anche alla discografia e alle performance
dei Matmos, duo statunitense la cui musica elettronica
utilizza fonti sonore disparate, come il suono prodotto
sfogliando le pagine di un libro, come i rumori di una
sala operatoria da liposuzione o come il suono prodotto
da microfoni a contatto con il corpo.
Nel film di Aronofski, l’accordo sincronico di immagini
e suoni analogici si inserisce spesso su una base ritmica
musicale con cui si fonde. E in questi casi, la base musicale fa da ponte fra due scene successive; crea, cioè, coesione temporale fra due sequenze. L’andamento rapido
del montaggio percussivo, dunque, viene enfatizzato, se
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
135
136
non addirittura prodotto, dal contributo sonoro. Ciò è
dovuto a modalità fisiologiche dell’ascolto: l’orecchio
ascolta per brevi spezzoni e sintetizza tali spezzoni dopo
un paio di secondi (Chion 1990, p. 21): questo consente
ad Aronofski di armonizzare e sincronizzare la brevità
degli spezzoni sonori con la brevità e la frammentazione delle immagini mostrate.
Altre volte, invece, il montaggio sonoro dei rumori
diegetici è accompagnato da suoni che provengono
dall’universo extradiegetico; come, ad esempio, il rombo assordante di un aereo. Il rumore dell’aereo non è
immediatamente riconoscibile, a causa di una saturazione dell’ascolto che caratterizza tutte queste scene di
montaggio. Ciononostante, questo suono lega insieme
i singoli frammenti sonori e nel suo crescendo sembra
introdurci nelle vicende narrate. Il rombo dell’aereo è
uno di quei rumori fuori campo, ma “attivi” (ivi, p. 68)
perché in virtù della sua non stereotipia, sollecita negli spettatori una continua tensione e aspettativa verso
il fuori-quadro: da dove viene questo rumore? Cos’è?
Perché lo sto ascoltando?
I diversi punti di sincronizzazione fra immagine e suono che la rappresenta sul piano acustico, in questo tipo
di montaggio, emergono e sono ripetuti con costanza.
E in virtù di questa accentuazione e di questa ripetizione ritmica viene creato il fraseggio di queste sequenze visivo-musicali: esse attraversano tutta la struttura
narrativa del film e rompono la linearità temporale, sia
sul piano visivo, sia su quello sonoro. Il risultato è la
creazione di un tempo congelato in una continua ripetizione. Questo contributo del suono alla rottura della linearità del tempo filmico produce degli effetti sul piano
narrativo e semantico, poiché sembra evocare il tempo
senza tensione in avanti, ma bloccato nel presente, della
dipendenza da sostanze alteranti.
Il montaggio percussivo, inoltre, agisce sul piano narrativo anche perché costruisce un parallelo fra due racconti: quello della dipendenza da droghe socialmente
e giuridicamente illegali (eroina, cocaina, marijuana) e
quello della dipendenza da droghe socialmente accettate (caffè, cioccolata, televisione, pillole dimagranti).
Ma la sinfonia di rumori agisce anche su un altro piano.
Attraverso l’accordo fra immagine, musica e suoni con
cui si rende la rappresentazione degli stati alterati in
cui entrano i protagonisti, anche gli spettatori vengono
risucchiati all’interno delle allucinazioni: il piano dell’immagine (di volta in volta distorta, sgranata, accecante o sfocata) è accompagnato da rumori incessanti
e insostenibili (lunghi fischi, distorsioni dell’audio) e da
una musica così empatica da risultare insopportabile,
come insopportabili sono le conseguenze dell’alterazione psicofisica che vediamo materializzarsi sui corpi dei
protagonisti. Si trasformano i corpi dei tossicodipendenti in crisi di astinenza, si trasforma per mutilazione
il corpo di Harry (un’infezione dovuta ai buchi gli ha
divorato il braccio che gli viene amputato) e si trasforma il corpo di Sara in virtù di una dieta dimagrante a
base di amfetamine.
Nella scena in cui viene rappresentata la allucinazione
più violenta di Sara, quella che la condurrà in clinica
psichiatrica, la dimensione acustica (un lungo fischio)
rende insopportabile la visione o meglio la rielaborazione della scena appena vista e introduce alla scena
successiva, distorta visivamente e resa angosciante dal
tema musicale accompagnato da rumori amplificati e
ritmati. L’allucinazione e lo stordimento, dunque, sono
prodotti negli spettatori da una trasposizione sul piano acustico delle immagini e delle tensioni narrative ed
emotive. In questo la musica rivela la sua capacità di
mostrare agli occhi più dello sguardo. Ciò che ci sembra di vedere, in realtà è ascoltato, in virtù della contaminazione e cooperazione costante fra sensi. Quella
contaminazione che Chion chiama audiovisione.
Francesca De Ruggieri · Requiem for a dream di Darren Aronofsky. Ritmo e audiovisione
Note
Bibliografia
1
Adorno, Th. W., Eisler H., 1969, Komposition für den Film,
München, Rogner & Bernhard; trad. it. La musica per film,
Roma, Newton Compton, 1975.
Barthes, R., 1984, Le bruissement de la langue, Paris, Seuil; trad.
it. Il brusio della lingua, Torino, Einaudi, 1988.
Cano, C., 2002, La musica nel cinema: funzioni ed effetti di senso,
Roma, Gremese.
Chion, M, 1985, Le son au cinéma, Paris, Cahier du cinéma/
Éditions de l’Étoile.
Chion, M., 1990, L’audio-vision. Son et image au cinéma, Nathan,
Paris; trad. it. L’audiovisione. Suono e immagine nel cinema,
Torino, Lindau, 1997.
Cremonini, G., Cano, C., 1990, Cinema e musica. Il racconto per
sovrapposizioni, Firenze, Vallecchi.
Deleuze, G., 1985, L’image-temps, Paris, Minuit; trad. it.
L’immagine-tempo, Milano, Ubulibri, 1989.
Eco, U., 1994, Sei passeggiate nei boschi narrativi, Milano,
Bompiani.
Kuhn, A., 1995, Family Secrets, London, Verso.
Merleau-Ponty, M., 1948, Sens et non-sens, Paris, Nagel; trad. it.
Senso e non senso,Milano, Il saggiatore, 1962.
Metz, Ch., 1971, Langage et cinéma, Paris, Larousse; trad. it.
Linguaggio e cinema,Milano, Bompiani, 1977.
Metz, Ch., 1991, L’énonciation impersonelle ou le site du film, Paris,
Klincksieck; trad. it. L’enunciazione impersonale o il luogo del
film,Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane,1995.
Peirce, C. S., 1980, Semiotica. I fondamenti della semiotica cognitiva,
Torino, Einaudi.
Rondolino, G., 1991, Cinema e musica. Breve storia della musica
cinematografica, Torino, UTET.
Questo saggio, rielaborazione dell’intervento presentato al
convegno “Mutazioni sonore”, è stato già pubblicato in PLAT.
Quaderni, n. 5, 2006, pp. 379-388.
2
La prima edizione di questo lavoro fu pubblicata in lingua
inglese nel 1947 solo da Eisler con il titolo Composing for the
Films.
3
Il saggio di Adorno e Eisler si presenta, tuttavia, come una
critica al cinema classico hollywoodiano, quello degli anni
Trenta e Quaranta, in cui la musica veniva utilizzata in maniera secondaria, come se fosse un semplice riempitivo (una
“quinta sonora”).
4
Anche quest’ultimo tipo di suono, quello analogico, a volte
viene organizzato secondo la scala musicale e diviene pertanto musica, come accade in Requeim for a dream di Darren
Aronofsky.
5
Per Adorno e Eisler (1969), c’è corrispondenza fra proporzioni musicali e ritmo primario del cinema, quello che deriva
dalla combinazione degli elementi formali; eppure – dicono
Adorno e Eisler – non è possibile trapiantare la struttura ritmica del film in una struttura musicale, in quanto esse non si
trovano mai ad essere né complementari né parallele.
6
La musica conferisce una profondità spaziale e temporale
ad un’arte che già si fonda su “immagini-tempo” (Deleuze
1985): grazie alla musica, nel muto, gli spettatori percepivano
la durata del film, ma anche nel film parlato la musica produce un effetto sull’articolazione del tempo. Ad esempio, produce uno spostamento in avanti o indietro (si pensi ai repentini
cambi di sonorità che producono flash-back e flash-forward,
come accade, ad esempio, in C’era una volta in America di Sergio
Leone), sospende il tempo (come accade in Palombella rossa di
Nanni Moretti, quando l’azione si blocca e tutti i protagonisti intonano I’m on fire di Bruce Springsteen) o lo congela in
una sequenza continuamente ripetuta (come accade in In the
mood for love di Wong Kar-wai, il cui tema principale – Yumeji’s
Theme di Shigeru Umebayshi – accompagna i movimenti che
i protagonisti compiono nel corso del tempo, rendendoli sempre uguali a se stessi).
7
Per una discussione più articolata sulle diverse funzioni
della musica nel cinema, che qui per ragioni di spazio siamo costretti a tralasciare, per concentrarci sull’analisi del testo filmico preso in esame, si veda, oltre alle opere già citate
di Michel Chion, Rondolino 1991; Cremonini, Cano 1991;
Cano 2002.
8
Nella musica hip-hop, il break è il punto in cui la sezione
ritmica riduce la cadenza all’essenziale, spesso alle sole percussioni.
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
137
sezione cinque
interferenze mozartiane
In its issue of Dimanche 9 – Lundi 10 (2006, p. 21), Le
Monde published a photograph that would arrest the
attention of any music lover. Entitled Constance, veuve
Mozart, en 1840 the photo shows Konstanze on the
left, not wearing her usual roccoco-style wig and dress,
but with a white scarf covering her dark hair, which is
combed in two halves in the German style of romanticism. She is shown alongside composer Max Keller
and his wife (and sitting on the left). The daguerreotype, recently discovered in the archives of the Bavarian
town of Altötting, was made in October of 1840, when
Konstanze was 78 years of age and had only two years
left to live. She had long ago remarried, taking as a husband the Swedish diplomat Georg Nikolaus Nissen. At
the time the photo was taken, Mozart had been buried
for half a century, having died on December 5, 1791 at
the age of 35.
Our mental image of Mozart and his world leads us
to think of him mainly as a part of history, a by-gone
era with which we no longer have direct contact. Yet, if
someone has been photographed, he/she already belongs to what Walter Benjamin called the ‘age of technical reproduction’ (Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit).
As such, it is someone ever present, about whom we can
apply our reason, psychology and intuition. True, the
photo is not of Wolfgang but Konstanze; still, she was
close to him and, like Mozart, she embodied the eighteenth century and the world of l’ancien régime. A similar
impression may strike a tourist of today, while visiting
Mozart’s house in Salzburg or places in Prague where
the composer once stayed. Through a kind of ‘indexical
magnetism’ the photograph connects us with Mozart’s
time – and emboldens me to speak of Mozart as an
avantgarde composer.
Of course, to make such a claim requires more of a
foundation than just a photo. First of all, it is hard to
qualify Mozart as a rebellious avantgardist, for what
Alfred Einstein (1976) has said about him is indeed
true: “Mozart never wanted to exceed the boundaries
of convention. He wanted to fulfil the laws, not break
them”. Be that as it may, Einstein adds, “he violates the
spirit of eighteenth-century music by his seriousness
Konstanze Mozart, photographed in Baviere in 1840
E|C Serie Speciale
Anno I, n. 1 2007, pp. 141-150
ISSN (on-line): 1970-7452
ISSN (print): 1973-2716
EC
Mozart or the Idea of a
Continuous Avantgarde
Eero Tarasti
and skilful inventions.” Mozart, as we know, thumbed
his nose at conventional rules of behaviour, as evidenced in his famous correspondence, and likewise by
composing the music for Beaumarchais’s Marriage of
Figaro. Another scholar, Norbert Elias (2004), goes so
far as to explain Mozart’s fall sociologically, in terms
of his efforts to make a living outside the court, as an
independent composer, a status which Beethoven was
the first to attain.
Apart from social context, however, we can interpret
the concept of avantgarde in terms of a more universal
aesthetic attitude or principle of style – not just as it
relates to historical phenomena dating from the early
twentieth century – just as ‘baroque’ can designate a
formal language of overwhelming exuberance, ‘romanticism’ one of generalized sentimentality, and so on. Let
us reconsider, then, the definition of avantgarde.
1. What is avantgarde?
We find the concept discussed in the monumental dictionary of aesthetics by Etienne Souriau, Vocabulaire
d’esthétique (1990). According to Souriau, the ‘avantgarde’, a military metaphor, seems to apply only to arts
dating from the beginning of the twentieth century. It
refers to artists who display a will to break with tradition, convention and permanent schools. The term is
adopted by critics, historians and the public for purposes of either praise or blame. (To this one might add: the
avantgarde is always a marked, marqué, phenomenon,
in the sense of salient and striking). Souriau points out
that the avantgarde, in general, is not the creation of an
individual; rather, it presupposes a group that attempts
new artistic conquests, that carries out ‘experiments’,
and that tries to abolish academic constraints, tradition and order. In this sense, Gustav Mahler was somewhat ‘avantgardist’, given his exclamation: ‘Tradition
ist Schlamperei’ (Tradition is bungling). An avantgard-
© 2007 AISS - Associazione Italiana di Studi Semiotici
T. reg. Trib. di Palermo n. 2 - 17.1.2005
142
ist takes to extremes the parody of conventions, in attempts to make commonly-accepted bourgeois habits
appear ridiculous. This aesthetic was often accompanied by aggressive demonstrations and scandalous performances. The avantgarde favours small performance
venues, and takes place outside the ‘official’ artistic life.
It aims to embody proper artistic values, instead of facile, commercially successful ones. It juxtaposes authentic creation and routine. But carried too far, it may also
lead to an avantgarde snobism that amounts to no more
than the lionization of cult heroes and the imitation of
idols.
Do we find such features at all in the phenomenon of
‘Mozart’? In one sense, No. For we are dealing here
with a unique ‘genius’, not with a group. But on the
other hand, the answer is a hearty Yes, if one thinks
of Mozart’s ambivalence, richness, and ingenuity in
transgressing the commonplaces of his received tonal
language. One needs only to see the film Amadeus to
understand that Mozart characteristically enacted the
‘avantgarde’, in the sense of resistance and parodizing
of all that is schematic and mediocre. Mozart does in
his music what the Marquis de Sade did in literature.
Sade assailed the hierarchies of language, at a time
when the sublime style of eighteenth-century French
literature implied similarly sublime contents. Rebelling
against this stricture, Sade instead filled this style with
frivolous content of lower-level aesthetics.1 Mozart, too,
confronts received style-constraints, in the form of musical topics, and countered these with aesthetic content
of the most unexpected and contrary kinds. Take, for
instance, the Janissary topic (Turkish march), presumedly of a naively grotesque content – following the ‘colonialist’ discourse of the period – which Mozart also
enacted in Monostatos’s arias in the Magic Flute; but the
Turkish topic also fitted well as the main theme of the
first movement to his Piano Sonata in A minor, with its
plainly sublime and tragic intention. Consider, likewise,
the fugato in the Overture to the Magic Flute, which presupposes sublimity, carries a syncopated theme representing the exuberance of worldly joy; or the ‘learned
style’ in the opening of the Requiem, which suddenly foregrounds corporeal musical signs of the ‘sigh’ – of a type
with which Belmonte, in the Abduction from the Seraglio,
conveys his love troubles: “… O wie ängstlich, o wie feurig,
klopft mein liebevolles Herz! ” In this sense, then, there is
quite clearly a bit of the ‘avantgardist’ in Mozart. Still,
we have not as yet proved our thesis. Further criteria are
needed to determine the avantgarde in Mozart – this
time from a semiotic point of view.
For semiotics, the avantgarde always represents ‘nonculture’ (cf. Lotman 2001); therefore it opposes something on the level of culture, not just as an individual
act. Hence an avantgardist cannot use pre-established
techniques. We have an example of this in the history
of Russian art: when Kasimir Malevitch and Alexei
Kruchenykh were planning their cubo-futurist opera,
Eero Tarasti · Mozart or the Idea of a Continuous Avantgarde
Victory over the Sun (1913), they asked the painter Mikhail
Matyushin to write the music, specifically because he
was not a professional composer, but had some skill in
notating scores, having studied violin for a while at a
conservatoire. One could not imagine a professional
composer writing the kind of radical, ‘transrational’
music which the authors were seeking (see Taruskin
1997: 86). This really does not hold true for Mozart,
not even mutatis mutandis, since he mastered all the techniques of his time and that of his predecessors. It is
possible, however, that an avantgardist does not always
irritate the bourgeois (épater le bourgeouis) with exclamation marks, but may do so discretely and without fanfare. When all external effects and fauvisms have been
utilized, it is avantgardist to write in an ‘antique style’
(e.g., Cocteau and Radiguet in the 1920s) or by having
a stage on which there is only empty space, one chair,
and one actor, who is reading a book and making no
gestures. Nothing can remain avantgarde for very long;
the front lines are changing constantly. For instance, serial music eventually led to such extremely complicated
tonal structures that it suddenly turned into aleatorism
when it was noticed that free improvisation would produce quite the same result. What Taruskin has called
‘maximalism’ – multiplication of traditional devices
to extreme limits – does not necessarily mean avantgardism. If the front line is always changing, how can
we view Mozart as part of a ‘continuous avantgarde’?
Would that not be contradictio in adiecto?
Bringing us closer to the core of the issue is the following semiotic observation: the problem of the avantgarde is whether an artist can communicate both code
and message at the same time. Isn’t this too much for the
receiver? As a rule, the code must be familiar, so that
energy is consumed only in decoding the message; but
if the code is also unknown, then too much is expected
of the receiver, who may experience a sort of cognitive
overload. Moreover: isn’t there always a ‘theory’ behind
the avantgarde? In viewing the history of music, Carl
Dahlhaus (1988), in an essay on Beethoven, concluded
that the most abstract philosophical concepts are in
fact the most radically and profoundly changing forces,
even at the level of musical practice. Yet, even if there is
always a background theory, who can analyse and make
it manifest? If an artist is satisfied with tacit knowledge,
he perhaps has no need to recognize a hidden theory,
and even less need to render such a theory in explicit
terms. Starting from Wagner, the reluctance of composers to reveal how they compose is a well-known fact.
In the end, the avantgardist is a kind of perpetual esprit
contestataire, a master of negation – an image that would
delight someone like Theodor Adorno.
2. Between Individual and Society; or, How the
Moi and Soi of the Composer Meet
To go further we must deepen our investigation and
consider if the avantgarde has some ‘theory’ behind it.
If so, then what is that theory, and by what metalanguage can we can deal with it? We also need more empirical facts and observations about Mozart as a composer and about his music.
I have elsewhere proposed that a composer’s work
and social context be scrutinized as an interaction between his ‘ego’ and ‘super-ego’, or ‘self ’ and ‘society’
(see Tarasti 2005, 2006). Instead of ‘ego’, I employ the
French Moi, which in Hegelian terms represents an-undfür-mich-sein, or in Sartrean terms être-en-et-pour-moi, i.e.,
being-in-and-for-myself. For the latter term (super-ego),
I use the designation Soi, understood as the social self or
‘society’. These principles – Ich und Gesellschaft, Myself
and Society – were also to Adorno the central problem
of every composer (that is to say, every ‘existing’ composer). This theoretical idea has at last been used for
interpreting Mozart, in a study by sociologist Norbert
Elias (2004), who combines psychoanalytically tuned
observations with sociological interpretations. Elias’s
central thesis clearly lies in the sphere of what I call the
Soi. In his view, the concept of the ‘biologically’ creative
genius should be abandoned altogether, since the composer’s ego, or Moi, cannot be isolated from his or her
Soi, i.e., community and, particularly, the ‘internalized’
society. Elias writes:
“We often think that the ripening of a congenial talent would
be a kind of automatic ‘inner’ process which is detached
from human destiny in general. One imagines that the creation of great art works is independent of the social existence
of their author, his fate, and [daily] life as a man/woman
among other people. Biographers believed they could separate Mozart the Artist from Mozart the Man. Such a distinction is artificial, misleading and needless.” (Elias 2004:
7374)
Anyone who has studied narratology might be upset
by such confusion between the physical, real composer
and the ‘implied’ composer, although this observation
would be a half-truth. Elias uses terms like ‘innate genius’ and ‘ability to compose’ in a rather casual manner.
What is involved here, undoubtedly, is an inherent ‘ability’, on the order of a natural force. Yet, the fact that
composing and playing music according to the social
habits of his time was incomparably easy for Mozart
can, in Elias’s view, be explained as a sublimating expression of natural energies, not as their direct manifestation (op. cit.: 79). Even if such a capacity as Mozart’s
stems from an innate biological trait, reasons Elias, the
latter can be only an extremely general one, a vague
and indifferent inclination, for which we as yet have no
proper concept.
Elias is surely on the right path when he tries to ‘decode’ the concept of genius. It means that Mozart was
able to do something that most other people cannot do,
namely, to let his imagination flow freely, as a stream of
tones that deeply moved many listeners. The problem
lies in the sublimation: how to eliminate the private part
of the creative vision and reach the universal form, so as
to make art of it. How to cross the bridge of ‘sublimation’, as Elias puts it. Or in our terms, how does one
proceed from Moi – the private, the an-und-für-mich-sein
– to Soi, i.e., the social, the an-sich-sein? Elias finds this
shift impossible to describe. We shall return to this issue
below; for now, let us approach this mystery via notions
of existential semiotics.
Elias’s interpretation strongly emphasizes the aspect of
Soi. On his view, Mozart’s premature demise was due
to social processes in the life of high arts and culture,
whose victim he became. This macrohistorical crisis, as
reflected in the microhistory of Mozart’s life and creative output, embodied a shift from artisanry or handicrafts, to the art of professional artists. In handicraft art,
the court nobility of Mozart’s time dictated the norms
of taste – the creative imagination of the artist was
channelled strictly according to the aesthetics of the
class in power. By contrast, the next phase saw artists
becoming more independent, at the least the equals of
their audiences, and in a sense determining the latter’s
tastes and needs by their innovations, which the general
public tries to follow. The general transition from hired
artisan to independent artist appeared also in music
and in the ‘structural’ quality of art works. Mozart’s
fate shows the kinds of problems encountered by an
exceptionally gifted artist in the swirl of such a revolutionary development. He left his employer, the Bishop
of Salzburg, broke off his relationship with his father,
and tried to live as an independent artist, trusting in the
favour of Viennese court circles. Existentially speaking, the issue was that of freedom versus necessity: Mozart,
seeking to fulfil the fantasies of the Moi, now had the
freedom to pursue an independent and original tonal
language. But, as is known, this effort failed in the social
sense, and the court people turned their backs on him.
The other hypothesis by Elias, which again joins individual destiny to that of society, is the so-called ‘criterion of sense’. According to him, the meaning or significance of life comes from being accepted by the group
with which one identifies. Mozart experienced a devastating loss of sense when upon being rejected by those
circles. This rejection, according to Elias, eventually led
to Mozart’s no longer being able to fight even against
his own illness – a thesis rejected by other scholars, who
claim there is no reason to take, say, the Magic Flute as
any kind of ‘musical testament’, since he had started
many composing projects that were interrupted by his
sudden death.
3. The Mozartian Ich-Ton
A composer’s identity, however, is formed by more than
just the whims of a given community. We should replace biological models with more precise biosemiotic
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
143
ones. All living organisms, in relating to their Umwelt,
are guided by the principle of the Ich-Ton (Me-Tone),
as theorized by Jakob von Uexküll (1940). This musical
term, as used by Uexküll, serves as a metaphor for the
manner or code whereby a living organism selects from
its surroundings those signs to which to react, while
rejecting or overlooking others, and furthermore, the
kinds of signs by which it responds to its environment.
If we return this metaphor back to music – and why
not? that is what Ruwet once did for Lévi-Strauss’s idea
of myth as a musical score – then we get in touch with
that ‘bridge of sublimation’ that, according to Elias,
constitutes the core of creation and that in our own
model corresponds to the shift from für-mich-sein to fürsich-sein (being-for-myself to being-for-itself).
144
What would it mean to speak of a Mozartian Ich-Ton? Is
it a latent content, some principle or deep structure that
presses for release in some surface structure, for eruption
into music as heard? In Mozart’s music do we ever sense
some compelling drive, which must first burst forth, and
only afterwards resolve into tones? Does Mozart’s music manifest what Ernst Kurth called Wille zum Klang?
Another Mozart biographer, Wolfgang Hildesheimer
(1984), is correct in his view that the fateful ‘must’ is missing from Mozart’s protagonists – and also from themes,
i.e., those musical actors in the musical discourse itself.
If, as Alfred Einstein claims, the criterion of greatness
in music is that an artist first creates an inner world and
then expresses it to others in his Umwelt – or Dasein, as
we would like to put it – then do we experience such
a greatness in Mozart? Is the melody of the Lachrymosa
such an expression of the soul, a Kierkegaardian lament,
squeezed from the poet’s breast, becoming poetry and
song on his lips? No doubt, Mozart can be taken as
a romantic; but in general, the impact of his music is
not based on the latter kind of aesthetic response or
sentiment. The Mozartian Ich-Ton does not appear as
such a transcendent force, as a pre-sign that precedes its
proper, actualized sign; it does not occur as a virtuality
awaiting actualisation. Rather, it manifests in the course
of the music, in the syntagmatic stream of tones, in that
‘Mozartian’ easiness whereby theme-actors unfold and
develop from each other, in a process of constant variation; in a word: in their horizontal appearance, in the
existential sense of Erscheinen.
I borrow the latter concept from German philosophy,
particularly from that of Karl Jaspers. One of the fundamental notions of existential semiotics, Erscheinen
does not only mean the vertical ‘manifestation’ of the
immanent (which would be simply the same as the appearance of the surface structure from ‘being’ and from
isotopies of the deep structure, in the Greimassian or
Heideggerian sense), but rather the gradual unfolding of the surface in a linear fashion, in a continuous
opening and bursting out. In existential appearing
– Erscheinung and Schein – this linear or temporal appear-
Eero Tarasti · Mozart or the Idea of a Continuous Avantgarde
ance is NOT the appearance of something predetermined by ‘being’, but something that can at any time
freely choose its course. It is guided or drawn along only
by the Ich-Ton of the events, the identity of the subject;
we can never know in advance how it will react in each
situation. Therefore the Schein which manifests the
‘truth of being’, in the sense that it is a kind of figuration or ornamentation of structure, is not yet a properly
existential Schein, which would take place in constant
choice at every moment. The choice should be genuinely free, not programmed by any predefined structure
or ontological principle. Mozart’s music precisely fulfils this idea of perpetual, existential Schein and Spiel:
we can never anticipate in which direction he will go.
Therefore his music is maximally informative, instantiating fully the modality of ‘know’ (savoir). One can,
of course, find in his music that kind of Schenkerian,
‘organic’ narrativity, which follows the necessity of the
Urlinie, pulling downward on scale-steps 5-4-3-2-1. But
the subject is also present in Mozart’s music. This is the
subject who, by hesitating, slowing down, giving up,
turning around – in a word, by negation – shows demonstrates that he is in an existential situation of choice. If
this freedom of choice did not exist, there would be no
hesitation, except perhaps as some slight resistance to
the ‘inevitable’ Ursatz.
Accordingly, in Mozart we can never guess what will
happen next. Compare, for instance, he treats a repetitive melody, borrowed from Muzio Clementi’s Piano
Sonata in B flat major, by turning it into a fugato
theme in the overture to the Magic Flute. This was one
of Mozart’s typical puns; he consciously ‘borrowed’ the
theme from Clementi, having heard it in Vienna at a
piano competition between the two composers, in the
presence of the Emperor Joseph II. Whereas Clementi
lets his theme close in a very conventional manner,
stopping the promising beginning with a cadence, after
which comes new thematic material, thus loosening the
overall coherence – Mozart makes of it a cheerful fugato in which the repetitive rhythmic impulse is retained
throughout nearly all of the overture, safeguarded
against monotony by bold yet congenial syncopations
(accents on weak beats). Here Mozart follows his great
idol in fugue writing, Handel – but neither is he far from
the “Dance of the Furies” in Gluck’s Orfeo. This comparison demonstrates in brief the difference between
talent and genius (as described, above, by Einstein).
Because of its constantly unpredictable horizontal manifestations, Mozart’s is ‘new music’ before the concept
of new music existed; it is ‘avantgarde’ before the avantgarde. The same feature has been noticed by others as
well, though described in different terms. For example, Ernst Lert, in his rich study Mozart auf dem Theater
(1918), has noted that the deepest sense of Mozart’s
music lies in the shape of its melodies, whose length
and lushness were the sign of his power. The same is
meant by Charles Rosen, in his landmark study The
Classical Style (1997), when he speaks of Mozart’s ability
to dramatize the concerto form: the object is not the individual themes and their colouring, but their succession
(op. cit. : 203). In this sense, Mozart walked a tightrope
between two forces: “… freedom or submission to rules
... eccentricity or classical restraint ... licence or decorum…. (ibid.: 210), and in the end came to represent
“… freedom from formal preconceptions” (211). Rosen
notes that Mozart bound himself only by the rules that
he reset and reformulated anew for each work (210). Is
this not precisely what the avantgarde composer – or
any other vanguard artist – does?
What is essential to the Ich-Ton in Mozart is something
experienced only in the inner temporality of the music,
not as any external force. For this reason he was open
to all kinds of outer impulses as the starting points for
composing, whether commissions or any other prosaic
points of departure. These may have set in motion the
syntagmatic ‘appearance’ of his work, but the work that
emerged was itself not an exteroceptive or indexical sign
of this impulse. It was without foundation that the later
generations from Beethoven to Wagner disparaged, for
instance, the frivolousness of Cosi fan tutte – true, perhaps of the libretto, but not of the music itself. The latter is sheer, unadulterated Mozart, a subject who casts
himself worrilessly on his Ich-Ton, which, like Goethe’s
genius, never abandons him.
‘Insisting’ musical gestures in Handel’s Water Music
145
Fugato theme from the Overture to the Magic Flute by
Mozart
‘Insisting’ musical gestures in the Dance of Furies from
Orfeo by Chr. W. Gluck
The main theme of the 1st movement to the piano sonata
in B flat major by Muzio Clementi
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
Note
1
. I am indebted to Harry Veivo for calling my attention to
this parallel.
Bibliography
146
Allanbrook, W. J., 1983, Rhythmic Gesture in Mozart, Chicago
and London,
University of Chicago Press.
Benjamin, W., 1972-1988, “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit”, Gesammelte Schriften
I.2. 472-508, Frankfurt am Main, Suhrkamp.
Dahlhaus, C., 1988, Klassische und romantische Musikiästhetik,
Regensburg, Laaber.
“Document: Constance, Veuve Mozart en 1840”, Le Monde,
Dimanche 9 – lundi 10 juillet 2006, p. 21 (Culture).
Einstein, A., 1976, Greatness in Music, New York, Da Capo
Paperback.
Elias, N., 2004, Mozart, neron muotokuva [Mozart, Portrait of a
Genius], Suom, Aulikki Vuola. Helsinki, Gaudeamus.
Hildesheimer, W., 1984, Mozart, Suom, Päivi ja Seppo
Heikinheimo, Keuruu, Otava.
Lert, E., 1918, Mozart auf dem Theater, Berlin, Schuster &
Loeffler.
Lotman, Y. M., 2001, Universe of the Mind: A Semiotic Theory of
Culture, Bloomington, IN, Indiana University Press.
Monelle, R., 2000, The Sense of Music: Semiotic Essays, Princeton,
NJ, Princeton University Press.
Monelle, R., 2006, The Musical Topic: Hunt, Military and Pastoral,
Princeton, NJ Princeton University Press.
Ratner, L. G., 1980, Classic Music: Expression, Form, and Style,
London, Schirmer.
Rosen, C., 1997, The Classical Style. Haydn, Mozart Beethoven,
Expanded edition, New York, Norton.
Schenker, H., 1956 (1935), Der freie Satz, Zweite Auflage hrsg,
von Oswald Jonas, Wien, Universal Edition.
Stefani G. and Guerra Lisi S., 2006, Prenatal Styles in
the Arts and the Life, Acta Semiotica Fennica XXIV,
Imatra, International Semiotics Institute at Imatra;
Semiotic Society of Finland; Università Popolare di
MusicArTerapia.
Tarasti, E., 2000, Existential Semiotics, Bloomington, IN,
Indiana University Press.
Tarasti, E., 2003. Signs of Music: A Guide to Musical Semiotics,
Berlin, Mouton de Gruyter.
Tarasti, E., 2005, “Existential and Transcendental Analysis of
Music”, Studi musicali 34 (2): 223-266.
Tarasti, E., 2006. “Introduction to a Philosophy of Music”,
In: Music and the Arts I-II,
Proceedings from ICMS7 (Acta Semiotica Fennica XXIII;
Approaches to Musical Semiotics 10). 3-30. Imatra and
Helsinki, Finnish Network University of Semiotics; ISI at
Imatra; Semiotic Society of Finland.
Taruskin, R., 1997, Defining Russia Musically. Princeton, NJ,
Princeton University Press.
Uexküll, J. v., 1940, Die Bedeutungslehre, Leipzig, Barth.
Eero Tarasti · Mozart or the Idea of a Continuous Avantgarde
Che una sonata di Mozart sia un testo è per la semiotica
un’assunzione, più che una conclusione. L’assunzione
deriva facilmente a sua volta dall’assunto, più difficilmente confutabile, che un romanzo – poniamo – sia un
testo, perché possiede un’unità concettuale, accompagnata da un qualche tipo di unità editoriale, di fruizione, e di considerazione condivisa. Poiché la semiotica
non si occupa solo di testi verbali, ci sentiamo legittimamente autorizzati a estendere la nozione di testo anche
a oggetti comunicativi che fanno uso di sistemi di segni
diversi dalla parola, che condividano certe condizioni
di unità concettuale, editoriale, di fruizione ecc. – come
ci appaiono in generale, per esempio, le opere d’arte di
qualsiasi tipo. Ed ecco quindi che parliamo tranquillamente di testi visivi, di testi audiovisivi, di testi verbovisivi (come le pubblicità su carta, e i fumetti), e addirittura di testi olfattivi e gastronomici. Parliamo anche,
ovviamente, di testi sonori, e di quel loro sottoinsieme
particolarmente importante che sono i testi musicali – e
tra questi ci sarà anche la nostra sonata di Mozart.
Eppure, i diversi tipi di unità che abbiamo vagamente
elencato non sono ugualmente rilevanti per permettere al semiologo di decidere se qualcosa sia un testo o
meno. Il mio quotidiano di oggi, per esempio, fa fatica
a essere considerato un testo, nonostante goda di unità editoriale, di una certa unità di fruizione e di considerazione condivisa. Tendiamo a parlare, semmai, di
palinsesto, in casi come quelli del quotidiano: ovvero,
una studiata combinazione di testi differenti e autonomi, che comunque riceve, nel suo complesso, una certa
natura simil-testuale, ovvero una qualche unità concettuale generale. Ma questa unità è troppo debole per poter parlare tranquillamente di un quotidiano come un
testo. Le posizioni di Umberto Eco e di Algirdas Julien
Greimas sono singolarmente vicine al proposito. Eco
(1978) parla di un testo come l’espansione di un semema; Greimas (1979:275 ed.it.)1 vede ogni testo come
riducibile a un quadrato semiotico di base, il quale a
sua volta è l’espansione logica di un’opposizione categorica. Che si tratti di un semema oppure di un’opposizione categorica, in ambedue i casi il testo viene descritto come qualcosa che espande e sviluppa un nucleo
centrale. O meglio, che espande e sviluppa almeno un
nucleo centrale: soprattutto nella posizione di Eco, il
testo è facilmente suscettibile di più di una interpretazione – tuttavia, anche nella posizione di Eco, se non
è possibile trovare nemmeno un nucleo centrale (che
non sia banale, evidentemente), viene a cadere quella
condizione imprescindibile di coerenza che è alla base
del considerare qualcosa come testo.
Potremmo dire, dunque, interpretando Eco, che qualcosa è davvero un testo se possiamo considerarlo portatore di almeno un discorso, ovvero se, nel suo complesso, può essere ridotto a una macroproposizione, cioè a
un dire qualcosa a proposito di qualcosa. Non siamo
lontani, nel fare questo, dalla concezione di Peirce2 del
dicisegno, ovvero un segno che dice qualcosa: quel-
E|C Serie Speciale
Anno I, n. 1 2007, pp. 147-150
ISSN (on-line): 1970-7452
ISSN (print): 1973-2716
EC
Quando Mozart faceva piano bar.
Appunti per una
sociosemiotica dello sfondo
Daniele Barbieri
lo che, nel linguaggio verbale, è un enunciato. Ma un
enunciato è comunque caratterizzato da una struttura
che possiamo definire predicativa: un soggetto è, o fa,
o subisce qualcosa; in altre parole, a un topic viene accompagnato un comment3; oppure ancora, a un tema si
associa un rema. Anche senza allontanarci dal linguaggio verbale, è evidente che la coppia topic/comment è
più maneggevole di quella soggetto-predicato, che resta
comunque troppo vicina alle proprie origini grammaticali. È facile pensare a esempi verbali in cui il topic sia
il predicato e il comment il soggetto. Ma forse appare
ancora più utile la nozione peirceana di rema, che sarebbe un segno pronto a combinarsi predicativamente
con (almeno) un altro rema per costituire un dicisegno.
La nozione peirceana di rema è interessante perché non
implica la semplicità del segno, ma solo la sua incompletezza ai fini del dire effettivo. Insomma, mentre un
dicisegno è un discorso (e quindi ci permette di parlare di un testo che lo esprime), un rema ne è solo una
componente non autonoma, un elemento che da solo
non dice. Può essere semplice come una singola parola
quando venga astratta dal contesto dell’enunciato, ma
può essere anche un oggetto molto complesso, che tuttavia solo quando venga associato a un altro rema può
essere considerato come parte di un discorso. Quando
ci occupiamo di testi narrativi (verbali, sonori, visivi
ecc.) la natura di testo del nostro oggetto è garantita
dalla narratività stessa.
Un racconto contiene comunque (almeno) una relazione predicativa, ed è riconducibile a una macroproposizione di base – altrimenti non sarebbe un racconto, ma
solo una collezione di eventi. Si potrebbe semmai discutere se quelli che riteniamo solitamente testi narrativi lo
siano davvero – ma credo che comunque il bisogno di
ricostruire un’unità sia insito nel ruolo stesso del lettore
di qualcosa che viene recepito come testo narrativo. E
sarà dunque sufficiente che un testo venga considerato
© 2007 AISS - Associazione Italiana di Studi Semiotici
T. reg. Trib. di Palermo n. 2 - 17.1.2005
148
come testo narrativo per indurci a trovare in esso una
cellula predicativa unitaria, un topic commentato di
fondo, insomma un discorso. Tuttavia, una sonata di
Mozart non è un testo che si proponga come narrativo. Quindi, a meno che non vogliamo superimporgli
una dimensione narrativa di qualche tipo, per poterlo
considerare come testo dovremo identificare (almeno)
un discorso di base; dovremo poter dire che quella sonata dice qualcosa a proposito di qualcosa. Uno dei
ruoli della critica musicale è proprio questo: darci delle
chiavi di lettura, suggerirci quale possa essere il discorso
di un brano musicale, aiutarci a vedere un’opera come
un testo.
Eppure, quella medesima sonata di Mozart che si presta benissimo a essere letta come un testo veniva anche eseguita dal medesimo Mozart per allietare le serate mondane del suo datore di lavoro, l’Arcivescovo
di Salisburgo – almeno sino al 1781. In quelle serate,
tuttavia, i presenti non ascoltavano musica; ovvero quelle
serate non erano concerti, occasioni in cui il pubblico si
radunava per ascoltare. La musica di Mozart, come quella di un qualsiasi suonatore di piano-bar, serviva per
ravvivare lo sfondo sonoro di un’occasione mondana
in cui tutto poteva essere importante salvo la musica,
visto che presumibilmente vi partecipavano persone
potenti o meno, interessate a incontrare, a conoscere, a
scambiare opinioni, con altre persone potenti o meno.
La musica ricopriva dunque una funzione non troppo
dissimile da quella della tappezzeria, delle decorazioni
dorate, delle livree eleganti dei servitori.
Che cosa ne era della natura testuale della sonata di
Mozart in un’occasione come questa? E che cosa ne
è della natura testuale di un qualsiasi brano di musica
che siamo disposti a considerare come un testo, quando
venga fruito in condizioni analoghe, cioè come sfondo,
tappezzeria, contorno?
Che Mozart si sentisse sprecato in situazioni come queste è dimostrato dal fatto che, appena ebbe la possibilità
di farlo, si licenziò, e se ne andò a Vienna, dove contava
di trovare un pubblico molto più propenso a dare attenzione al suo discorso musicale. Ma questo non toglie
che, finché stava a Salisburgo, le sue sonate dovessero
essere composte anche in funzione di una fruizione
come quella che richiedeva l’Arcivescovo; e quindi che,
in qualche modo, la loro natura compiutamente testuale
dovesse convivere con una natura molto diversa, in cui
nessun discorso poteva davvero emergere, perché mancava, negli ascoltatori, una delle condizioni di base per
la ricezione di un discorso: una sufficiente attenzione.4
Osserviamo, ora, che non qualsiasi testualità si presta
a rivestire questa funzione di sfondo. È facile osservare,
per esempio, che tutte le testualità basate sulla parola
sono inadatte a fungere da sfondo, che si tratti di oralità o di scrittura. Se la parola orale non viene seguita
con sufficiente attenzione non viene nemmeno colta, e
diventa un brusio di fondo, ed è questo a poter fare da
sfondo (proprio come la musica di Mozart), oppure, più
probabilmente, a essere sentito come rumore, disturbo.
Se la parola scritta non viene letta, ma solo guardata
senza attenzione, è pura immagine – e l’immagine è
invece adatta, adattissima, a fare da sfondo. Non a caso
si parlava poco sopra di tappezzeria sonora: la tappezzeria è infatti un tipico esempio di produzione visiva che
nasce per un ruolo di sfondo. Ma anche un dipinto del
Tintoretto può, proprio come la sonata di Mozart, essere insieme un testo e un motivo di sfondo, un elemento
marginale (ma presente) di un contesto più ampio.
La comunicazione audiovisiva si presta a fare da sfondo
quando la parola non c’è o è marginalizzabile, come
succede facilmente con i video-clip, o come succede,
più banalmente, in quelle case in cui il televisore sempre acceso assolve una funzione di generico conforto
per la solitudine, e non viene prestata attenzione a quello che viene detto.
Potremmo ipotizzare una generalizzazione, dicendo
che sono adatte a fungere da sfondo quelle forme di comunicazione che non sono nate per veicolare autonomamente dei discorsi, anche se oggi lo fanno, e ormai
anche da tempo. Non sono adatte, invece, le forme di
comunicazione basate sulla parola, perché dove c’è parola c’è comunque inevitabilmente un atto enunciativo
basato su un discorso.
Per spiegare meglio che cosa intendiamo dire, restiamo in campo musicale, e prendiamo l’esempio di una
delle funzioni tradizionali della musica, dall’antichità ai
giorni nostri: quella di supporto per il ballo. Ha senso
dire che la musica da ballo, quando fruita come tale, veicola discorsi? Mi pare piuttosto che la musica si limiti
a fornire un pretesto (in un certo senso, uno strumento)
per l’attività dei ballerini; ed è questa attività, congiuntamente alla musica, a costituire il vero discorso. In altre parole la musica costituisce un semplice topic (per
quanto articolato al suo interno si tratta comunque in
termini peirceani di un rema) di cui l’attività di ogni singolo ballerino è il comment. Sulla base della musica, ogni
ballerino costruisce il proprio discorso e lo esibisce agli
altri, ma quel discorso si basa sulla musica e senza la
musica non esisterebbe. Pur senza costituire un discorso (e dunque un testo) la musica trasmette senso, ma
questo senso si compie solo all’interno dell’attività per
cui quella musica esiste. Non un testo, dunque, ma un
pretesto, uno strumento, un utensile, per la costruzione di
un discorso che la inglobi, è la musica da ballo.5
La musica che nasce per fare da sfondo si presenta invece piuttosto come un comment buono per dare significato
a numerosi topic situazionali. Può qualificare una situazione sociale come allegra, o sentimentale, o istituzionale, o funebre, e così via. Il testo, in questo caso, non è
la musica, bensì la situazione nel suo complesso, di cui
la musica rappresenta una componente non indipendente. Non dimentichiamo che praticamente tutta la
musica composta sino al sedicesimo secolo è stata scritta come accompagnamento di situazioni, pubbliche o
private, religiose o laiche; che la musica vocale costi-
Daniele Barbieri · Quando Mozart faceva piano bar. Appunti per una sociosemiotica dello sfondo
tuisce sempre un comment del topic che è espresso dalle
parole che vengono cantate; e che una dimensione di
musica strumentale che si possa considerare autonoma
dal punto di vista dell’espressione di un discorso non
nasce prima del diciassettesimo secolo, e arriva a maturità solo con il classicismo viennese.
Insomma, esiste storicamente moltissima musica che
non è nata per veicolare un discorso, bensì semmai per
prendere parte a un discorso più ampio, caratterizzandolo (talvolta anche in maniera fondamentale). Eppure,
il fatto che questi brani musicali non siano, a rigore, dei
testi, non impedisce loro di possedere una grandissima
complessità interna: la complessità, in altre parole, non
è una prerogativa dei testi, ma può caratterizzare tranquillamente anche le forme pretestuali (o forse, diremo
meglio, pre-testuali), come tutte le forme di musica da accompagnamento (del canto, del ballo, della cerimonia,
della situazione…). La semiotica sembra essersi troppo
concentrata sull’idea di testo propriamente detto, troppo sull’idea di discorso – in quanto, magari, prodotto di
un atto di enunciazione. Non dimentichiamo piuttosto
che se è pur vero che un rema può essere compreso
pienamente solo all’interno di un dicisegno, il rema
esiste comunque di per sé, e – come qualsiasi parola
– può trovarsi integrato in dicisegni diversissimi che autorizzano a interpretarlo in maniere molto diverse tra
loro. Per quanto complesso sia, dunque, un rema può
trovarsi a essere utilizzato in discorsi molto diversi, a
scopi comunicativi anche contrari – proprio come una
qualsiasi parola del lessico della lingua.
Quello che può ingannare è probabilmente il fatto che
queste strutture rematiche hanno uno statuto culturale
e un’identità spesso non meno forte di quelli dei testi
veri e propri. Ogni pezzo di musica da ballo ha un titolo, è un’opera, e tantissimi sono i pezzi immediatamente
riconoscibili e identificabili da chiunque. Non per questo si tratta di testi. Non per questo dobbiamo necessariamente leggerli come discorsi.
Io credo che solo il linguaggio verbale sia nato per costruire autonomamente dei dicisegni. Gli altri linguaggi, anche se sono arrivati presto o tardi a un livello sufficiente di autonomia comunicativa, sono probabilmente
nati per costituire dei remi, dei pre-testi, che richiedevano un azione comunicativa ulteriore (tipicamente verbale o simil-verbale) per arrivare a costituire dei testi.
La pittura si è emancipata molto prima della musica da
questa dimensione unicamente rematica, ma presumibilmente le immagini dei primitivi venivano utilizzate
come supporto cerimoniale, o comunque come aiuto a
un discorso che veniva condotto anche con altri mezzi.
È difficile pensare che potessero costituire dei discorsi
compiuti autonomi.
Anche oggi, del resto, vi sono immagini che costituiscono dei discorsi a se stanti e altre dei semplici pretesti,
dei remi, che hanno bisogno della parola o di altro per
poter veicolare un discorso. Talvolta le medesime immagini possono avere ora l’uno ora l’altro ruolo.
Come abbiamo detto, la storia dell’autonomia discorsiva della musica non inizia prima del Seicento. È un
fatto noto come la musica strumentale che si sviluppa
da allora in poi abbia come punto di partenza le forme
della musica per danza. L’ascoltatore le riconosceva e
non disdegnava (come non disdegna nemmeno oggi) di
abbozzare, magari solo mentalmente, i movimenti corrispondenti. Con questo, confermava la natura rematica, di topic da commentare, della musica. Tuttavia, al tempo stesso, percepiva anche le variazioni, le differenze,
rispetto alle situazioni standard della musica da danza,
e in questa ricezione (che potremmo definire frontale, in
quanto l’ascoltatore critico si trova di fronte alla musica,
mentre il danzatore è immerso in essa) poteva comprendere la musica come discorso a proposito della musica
stessa.
In questo senso, la musica strumentale del Settecento
associa una natura estremamente intellettuale (ricezione frontale di un discorso che ha per oggetto la musica stessa6) a una estremamente sensuale e immersiva,
vicinissima alle radici della danza. Ma la possibilità di
questo discorso di carattere intellettuale diventa col
tempo la base per capire, da Haydn in poi, che il discorso musicale può parlare anche di altri oggetti, per
esempio di emozioni e sentimenti. Credo che sia dovuto
a questo passaggio il grande allargamento di pubblico e
il grande successo della musica in epoca romantica: una
cosa è una musica che parla di musica, altra cosa è una
musica che parla di passioni ed emozioni! L’argomento
del discorso è diventato di interesse collettivo: non è più
ristretto ai pochi privilegiati in grado di capire la grandezza dell’Arte della fuga.
Eppure, quando Mozart scriveva le proprie sonate era
ben consapevole che una delle condizioni del loro successo era che l’ascoltatore potesse trovarle gradevoli anche eseguite come sfondo, anche negando o ignorando
la loro natura di discorso autonomo, degradandole dunque a rema, a comment della situazione. E questo, non
solo perché le sonate dovevano essere adatte al servizio
di piano-bar di lusso richiesto dall’Arcivescovo, ma anche perché persino in una ricezione attenta l’ascoltatore
deve avere il diritto di distrarsi, e deve ricavare qualcosa
dalla musica anche se non riesce a coglierne la struttura
complessiva – perché la musica vive anche momento
dopo momento, frammento dopo frammento, ed è solo
auspicabile, ma non necessario, ascoltarla e comprenderla tutta con la medesima attenzione per poterne godere e, in qualche modo, “capirci qualcosa”.
Come va analizzato dunque un testo che nasce anche,
contemporaneamente, per essere un pretesto? Che cosa
ne è delle nostre presunzioni di unità concettuale di
fronte a una forma di comunicazione che prevede sistematicamente un fruitore che può distrarsi, e quindi che
può cogliere porzioni qualsivoglia dell’opera?
Va ora osservato che, a ben guardare, in qualche modo,
qualsiasi testo può fungere da pretesto per la costituzione di un testo ulteriore; ovvero qualsiasi dicisegno può
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
149
150
essere inteso come rema per essere associato a un altro rema per ottenere un nuovo dicisegno. Quando uso
una poesia per dimostrare ai presenti la mia cultura,
sto facendo esattamente questo: la poesia diventa un
comment di me stesso in quanto persona acculturata, un
elemento del mio discorso su me stesso. Tutta la cultura
è fatta di riuso in questo senso. I testi sono molto meno
scatole chiuse di quanto la tradizione semiotica voglia
farci credere.
A rigore, queste scatole giustificano bene la distinzione
tra interpretazione e uso che Eco (1990) ci ha insegnato.
Finché si interpreta si rispetta la scatola, quando si utilizza
non la si rispetta più. Un critico onesto ha il dovere di
rispettare le scatole, ma un contesto culturale ha prima
di tutto il dovere di evolversi, di essere vivo: in un certo
senso, di romperle. Rispettare le scatole testuali significa rispettare il passato e garantire la continuità culturale. Ma il rinnovamento passa attraverso l’uso, e solo
trattando i testi come pretesti, ovvero come strumenti,
come utensili, come coltellini Opinel, possiamo produrre nuovi testi.
La musica da ballo ha una funzione seduttiva. Produce
discorsi nei danzatori, e in questo modo appare come
un oggetto di interesse perché si dimostra in grado di
stimolare altri discorsi. Questa è una delle principali
modalità della seduzione: non tanto il dimostrarsi bello
e intelligente come persona, quanto il dimostrarsi capace di stimolare nell’altro pensieri interessanti. Una
persona è per noi interessante per la qualità di quello che
dice o esprime, ma è seducente per la qualità di come ci
sentiamo in sua presenza, ovvero per quello che il suo
dire e fare stimola in noi. Se vediamo le cose in questo
modo, ci accorgeremo che non è solo la musica da ballo
a essere seduttiva, ma ogni produzione estetica lo è, e le
opere d’arte prime tra tutte.
Certo la seduzione opera anche attraverso la produzione di discorsi, e le opere d’arte stesse producono evidentemente discorsi; ma questi discorsi sono funzionali
alla seduzione stessa, e la loro funzione principale all’interno della seduzione è quella di fornire all’altro dei
topic migliori da commentare, ovvero quella di fornirgli
occasione di migliori discorsi.
Probabilmente non possiamo ridurre l’opera d’arte
alla funzione seduttiva, ma certamente non possiamo escludere la funzione seduttiva dall’opera d’arte.
Probabilmente la natura stessa dell’estetico è legata alla
funzione seduttiva.
Possiamo forse decidere se l’opera d’arte ci seduca al
fine di trasmetterci il suo discorso, oppure se, viceversa,
ci trasmetta il suo discorso al fine di sedurci, invitandoci all’emozionante ginnastica intellettuale di costruire
discorsi su discorsi, a partire da quello stimolo? Se decidessimo per il primo corno del dilemma, ridurremmo
l’arte a propaganda; ma se decidessimo per il secondo
la ridurremmo a un esercizio vuoto e fine a se stesso. È
probabilmente in questa dialettica non risolvibile che si
costruisce il fascino dell’arte, che è sempre l’una e l’altra
cosa, senza mai potersi risolvere in nessuna delle due.
È dunque su questa ambiguità di fondo che Mozart
giocava per allietare le serate dell’Arcivescovo, perché
è nella natura stessa dell’opera d’arte quello di essere
al tempo stesso testo, e pretesto per una testualizzazione ulteriore. Ed è nella natura della musica quello di
prestarsi a una fruizione frontale, consapevole, destinata alla comprensione di un discorso, e insieme anche a
una fruizione immersiva, orfica, in cui si partecipa alla
costruzione di altri discorsi – e la musica è la condizione
di base del comune accordo, del comune vibrare, del
senso di collettività.
Quando Mozart suonava dall’Arcivescovo, chi voleva
ascoltare, ascoltava. Il senso, lo sappiamo, non trova
mai un arrivo che ne garantisca l’acquisizione definitiva. Ma in certi casi non trova nemmeno un punto di
partenza ben definito, ed è lo stesso significante a variare con il variare dell’attenzione. Erano note nell’aria
di una serata dedicata ad altro, dunque, ma pronte ad
aggregarsi di quando in quando, genialmente studiate
per catturare di colpo la nostra attenzione, e portarci
poi, almeno fugacemente, con loro.
Note
1
Vedi anche Marsciani-Zinna (1991:46)
Cfr. Proni (1990:244)
3
Che, come minimo, ne predica l’esistenza (o la non-esistenza).
4
Sui temi dell’attenzione e della tensione vedi Barbieri
(2004).
5
Su testi e pre-testi vedi anche Barbieri (2005).
6
Cfr. al proposito la bella tesi di Laurea di Francesco Galofaro
(2000), che ha per oggetto l’analisi del discorso di un concerto
di Vivaldi.
2
Bibliografia
Barbieri, D., 2004, Nel corso del testo. Una teoria della tensione e del
ritmo, Milano, Bompiani.
Barbieri, D., 2005, “Appunti per un’estetica del senso”, Tempo
fermo, n.4, disponibile online all’indirizzo http://www.
arteadesso.net/tempofermo/numeri/4/barbieri_tf_
4.html
Eco, U. ,1978, Lector in fabula, Milano, Bompiani.
Eco, U. ,1990, I limiti dell’interpretazione, Milano, Bompiani.
Galofaro, F., 2000, Capire l’antifona. Interpretazione musicale e semiotica del testo, Tesi di laurea, Università di Bologna
Greimas, A. J., Courtes, J., 1979, Sémiotique. Dictionnaire raisonné
de la théorie du langage, Paris, Hachette; trad. it. Semiotica.
Dizionario ragionato della teoria del linguaggio, Firenze, La
casa Usher, 1986.
Marsciani, F., Zinna, A., 1991, Elementi di semiotica generativa,
Bologna, Esculapio.
Proni, G., 1990, Introduzione a Peirce, Milano, Bompiani.
Daniele Barbieri · Quando Mozart faceva piano bar. Appunti per una sociosemiotica dello sfondo
Commissionato dal Teatro alla Scala (dove era in scena
proprio nei giorni stessi del convegno “Mutazioni sonore”, dopo la “prima” assoluta di Lisbona del 18 marzo
2006), Il dissoluto assolto rappresenta un caso emblematico di interferenze tra il lascito fertilissimo della musica
di Mozart e due tra gli autori più significativi del panorama contemporaneo: Azio Corghi e José Saramago.
Dal collaudato sodalizio tra il compositore italiano e il
premio Nobel portoghese è nato un “teatro musicale in
un atto” che sovverte provocatoriamente l’esito di uno
dei miti fondamentali dell’Europa moderna, quello di
Don Giovanni, riscrivendone l’incarnazione più celebre: l’opera di Mozart e Da Ponte. Lo scioglimento inventato ex novo da Saramago rimescola le carte in tavola, scambiando vittime e carnefici, ipotizzando scenari
inediti in cui s’intrecciano millanteria e calunnia, fino
a quella fondamentale umiliazione del libertino che gli
frutterà, inaspettatamente e insospettabilmente, la salvezza. Sul piano musicale, alla riscrittura drammaturgica di Saramago corrisponde perfettamente quel gioco
postmoderno con la tradizione che rappresenta una
delle componenti fondamentali della poetica di Corghi,
per il quale la memoria sonora diventa il reagente essenziale per discorsi di attualità patente. Le caratteristiche
della più autentica scrittura corghiana (la dialettica tra
canto e recitazione, un fantomatico coro madrigalistico,
un’orchestra sinfonica mobilissima) interagiscono con
la citazione mozartiana diretta e non, ma anche con
il ricorso a una serie di “bacini” di memorie musicali
diverse, private e collettive, colte e popolari. L’opera
contemporanea viene dunque a fondarsi su una doppia
interferenza, tra testi verbali e musicali di un quartetto
di autori del passato e del presente, con un’interazione
fecondissima di significati incrociati.
1. Dopo due secoli, il dissoluto è assolto
Per cominciare, col Dissoluto assolto Saramago realizza
una critica ideologica acuta e serrata del libretto scritto
da Lorenzo Da Ponte per Mozart. Questa, in breve, la
vicenda. Nel prologo dell’atto unico Donna Elvira, in
forma di manichino, lamenta con Leporello di esser stata sedotta e abbandonata da Don Giovanni. Per consolarla il servo le mostra la lista in cui sono annotate tutte
le conquiste del padrone. Quando l’atto unico inizia,
Don Giovanni viene affrontato dalla statua di bronzo
del Commendatore, venuta a esigere il pentimento del
libertino. Quest’ultimo però nega di aver violentato la
figlia del Commendatore, Donna Anna. La statua chiama allora a raccolta le fiamme dell’inferno, ma queste
non rispondono al suo comando, suscitando lo scherno
di Don Giovanni. La statua ritorna allora alla completa
immobilità. Ricompare intanto Donna Elvira che mette in atto il suo piano: fingendo uno svenimento, riesce
a scambiare il catalogo di Don Giovanni con un libro
bianco. Irrompe poi con Donna Anna e Don Ottavio
per punire in modo originale il libertino: nega infatti di
aver mai avuto rapporti col seduttore, mentre Donna
E|C Serie Speciale
Anno I, n. 1 2007, pp. 151-154
ISSN (on-line): 1970-7452
ISSN (print): 1973-2716
EC
Interferenze contemporanee.
Mozart, Corghi
e Il dissoluto assolto
Raffaele Mellace
Anna lo proclama impotente. Don Giovanni protesta
allora con veemenza e invoca la testimonianza del catalogo, che però si rivela vuoto. Nasce un breve duello in
cui Don Ottavio resta ucciso. Umiliato, Don Giovanni
cade in preda al più profondo scoramento. Ma ecco,
appare sulla soglia Zerlina: la ragazza rivela al libertino
l’inganno tramato contro di lui e gli si concede, proprio
ora che il seduttore è diventato fragile e infelice. Il dissoluto è così assolto, mentre la statua del Commendatore
cade a terra, disintegrandosi.
Samarago e Corghi attuano nel loro lavoro un sottile slittamento di prospettiva per cui i protagonisti del
dramma – esattamente i personaggi dell’opera di Da
Ponte e Mozart: Leporello e Don Giovanni, Donna
Elvira, il Commendatore, Zerlina ecc. – gettano la
maschera che siamo abituati a veder loro addosso, per
rivelare aspetti insospettabili delle rispettive personalità, smentendo così il personaggio in cui sono cristallizzati da oltre due secoli. Già dal titolo è evidente il
capovolgimento del modello mozartiano, andato originariamente in scena col titolo di Il dissoluto punito o
sia Il Don Giovanni. Saramago ne ha infatti riscritto lo
scioglimento, tramite una trouvaille che riguarda un oggetto simbolo della virilità del libertino: il “non picciol
libro”, decantato nella celebre aria “del catalogo”, in
cui il servo Leporello annota puntualmente le conquiste
del padrone. Il Convitato di pietra da emissario trascendente è poi ridotto a innocua e patetica statua di bronzo, da leggersi in quanto “monumento al benpensante
ipocrita”: inquietante ma impotente. Il ruolo millantato
ma non assolto dal Commendatore è assunto invece
dalle due nobili vittime del seduttore, Donna Elvira e
Donna Anna, che si trasformano a sorpresa in carnefici. Annichilito proprio nella sua hybris caratteristica,
il libertino appare ora nei panni di un essere umano
umiliato e offeso. Ed è a questo punto, con un’estrema,
ennesima svolta, che la salvezza – l’”assoluzione” del
© 2007 AISS - Associazione Italiana di Studi Semiotici
T. reg. Trib. di Palermo n. 2 - 17.1.2005
152
titolo – giungerà da una fonte inaspettata: la mai sedotta Zerlina. La “contadinotta” mozartiana, proprio
grazie alla sua genuina autenticità, è in grado di salvare
Don Giovanni con un gesto che richiama l’altissima dignità dei personaggi femminili dei precedenti lavori di
Saramago e Corghi. Grazie a Zerlina Don Giovanni si
trasforma in vincitore. Premiato per il coraggio, per la
determinazione a non scendere a compromessi. Meglio
ancora: premiato a causa dell’umiliazione in cui è precipitato dall’alterigia nobiliare che da sempre ha contraddistinto il personaggio. Non è Don Giovanni, ma
il comune mortale Giovanni a vincere: non nel luogo
in cui se ne manifesta la superbia, bensì nel momento
della debolezza irrimediabile giunge ex machina, dalla
direzione più imprevista, la salvezza. Una salvezza tutta terrena, originata da un gesto di tenerezza suscitato
dalla prostrazione dell’ex burlador.
Tanto quanto Zerlina, anche Donna Elvira è trasformata rispetto alla fisionomia originaria. L’irruzione del
personaggio al banchetto è capovolta di segno: Elvira
non è più redentrice bensì vendicatrice, a dispetto di
un’intera tradizione (Molière, ad esempio) che le attribuiva una moralità d’alto profilo. Si direbbe quasi
che abbia imparato dal suo amato/antagonista: non è
più sincera, ma simula. E ha fatto tesoro persino della
tattica spicciola di Don Giovanni: questi all’inizio del
dramma di Da Ponte si era dileguato lasciandola sola
col servo, che in quell’occasione le aveva inflitto il catalogo. Quando Don Giovanni scompare in Saramago/
Corghi, Elvira sa bene invece come reagire: “fingendo
di sentirsi male”, riesce ad allontanare Leporello e a
sostituire il catalogo vero con uno falso, per preparare
una punizione “divina” operata paradossalmente con
l’inganno.
L’azione si sviluppa dunque giocando sulla delusione
delle aspettative dello spettatore, che proprio non si
attende questa Zerlina, questa Donna Elvira e, per certi
versi, questo Don Giovanni. Ingannatori e ingannati si
scambiano le parti, in una scena del banchetto dilatata a dismisura e svolta tra occupazioni triviali: leggere giornali, lucidare spade, sparecchiare. Quasi che il
registro comico, di cui in tutta la tradizione del Don
Giovanni è di norma apportatore il servo, diventi dominante, istituendo un tono permanente da commedia,
ribadito dall’ironia di cui è investita tutta la prosopopea
dell’imbelle Commendatore e dallo scioglimento inaspettatamente fausto dell’intreccio.
2. Azione drammatica, personaggi e vocalità
In realtà, benché l’esito “salvifico” della vicenda sia affidato a Zerlina, è un’altra la “prima donna” del dramma: Donna Elvira, personaggio passionale, disperato,
dai comportamenti estremi. Elvira necessita di un’interprete estremamente versatile, di un’attrice di prima
sfera (a un’attrice e non a una cantante è destinato il
ruolo). In anni recenti Corghi ha evidenziato a più riprese una propensione per un genere di attrice in gra-
Raffaele Mellace ·Mozart, Corghi e Il dissoluto assolto
do di trascorrere dalla recitazione al canto (ad esempio
nel recente ... poudre d’Ophélia!, del 2003). Generalmente
nel Dissoluto assolto la vocalità prescritta agli interpreti
trascorre su un ampio spettro, in rapporto strettamente funzionale con la caratterizzazione drammatica di
ciascun personaggio. Si definisce così come funzione
dell’azione drammatica, segnale evidente di un ruolo
scenico preciso.
Il Commendatore guadagna nel libretto predisposto da
Corghi un “doppio” musicale, del tutto originale rispetto al dramma di Saramago: un coro maschile invisibile, fantomatico e ironico. Personaggio fondamentale,
il Coro invisibile denuncia un’ulteriore passione del
miglior Corghi: la scrittura madrigalistica per gruppo
vocale a cappella. L’ottetto vocale è infatti protagonista
nelle opere Gargantua, Blimunda, Rinaldo & C. e Tat’jana,
così come nel balletto Mazapegul e nelle musiche di scena per La Piovana del Ruzante, e occupa interamente la
“scena” dei più brevi I sogni di Blimunda e This is the list.
È ormai più che ventennale la fedeltà esibita da Corghi
nei confronti di questo strumento drammatico, che provoca l’irruzione nella vicenda di un piano “altro”, di
una dimensione irreale, in grado di rivelare dinamiche
nascoste e ragioni intime dell’azione scenica, offrendone un commento consapevole. Nel Dissoluto assolto do-
vrebbe rivestire quella funzione, trascendente in senso
lato, che la ridicola statua bronzea del Commendatore
non è in grado di ricoprire; e tuttavia la sua apparente onniscienza viene smentita dall’alternarsi di formule
affermative e interrogative con cui viene commentato
e previsto il destino di Don Giovanni. Un’ambiguità
strutturale che si associa al gioco fonico (“dissoluto/assolto”: “parafrasi fonetica sul titolo dell’opera”, la definisce Corghi) e alla tecnica vocale (i frequenti sussurrando
e mormorando) scelti da Corghi per amplificare il carattere fantomatico di questo “doppio” del Commendatore.
Tra personaggi in carne e ossa, statue di bronzo, cori
e manichini invisibili, la sala dell’estremo banchetto di
Don Giovanni diventa così il campo in cui si affrontano in dialettica serrata linguaggi conflittuali: un gioco
drammatico in cui la reinvenzione dello scioglimento è
agita da una complessa costellazione di “attori”.
Un’ultima parola, a proposito della struttura del dramma. Corghi ha introdotto un prologo all’azione, costruendolo attorno all’aria “del catalogo” del Don Giovanni:
pagina sulla quale il compositore ha già composto nel
1996 la citata “commedia armonica” This is the list per
ottetto vocale per il Festival Mozart di Rovereto. Letto
in quanto scelta drammaturgica, l’impiego del celebre
testo dapontiano permette di introdurre il protagonista
anche in sua assenza. Il dissoluto entra così in azione,
persino in assenza, già dal fondamentale Prologo, in cui
agisce, sempre in assenza, anche il Commendatore, col
risuonare del suo tema in orchestra.
3. Memoria e invenzione
Sul piano musicale, alla riscrittura drammaturgica di
Saramago corrisponde perfettamente quel gioco postmoderno con la tradizione che si conferma una delle
componenti fondamentali della poetica di Corghi, per
il quale la memoria sonora diventa il reagente essenziale per discorsi della più patente attualità. La partitura,
scritta tra il maggio e l’ottobre 2004, si costituisce come
uno straordinario, complesso gioco con la memoria,
dalla quale il compositore evoca i materiali più svariati, archetipi semanticamente densi (e perciò capaci di
sostanziare l’azione drammatica) e al tempo stesso musicalmente vitalissimi (e dunque in grado di sottoporsi
a una riformulazione radicale, prestandosi a sostenere
campate drammatiche impegnative). Protagonista dell’azione – invisibile sulla scena ma ugualmente “presente” – è la grande orchestra sinfonica, la cui scrittura
mobilissima e cangiante rappresenta un microcosmo
connotato da una fitta rete di elementi semantici, un humus fecondo di provocazioni uditive. Il parco motivico
– vero e proprio sistema di Leitmotive – vanta una decina di temi: “del Commendatore”, “di Don Giovanni”,
“di Donna Elvira”, “di Zerlina”, “di Leporello”, “della
calunnia”, “della vendetta o delle quarte e quinte incrociate”, “del presentimento”, “della paura”, “rock”,
nonché un “controsoggetto dialettico” e associazioni
più elementari, come l’eco di campane che rimanda per
onomatopea al nome di “Don Juan”. Quattro le aree da
cui trae origine la memoria musicale di Corghi:
1) Il linguaggio “colto” dell’opera buffa, anche oltre
Mozart. L’aria “del catalogo” occupa il cuore dell’invenzione drammaturgica del Dissoluto assolto. L’aria
mozartiana subisce in particolare una trasformazione
in duetto: Leporello ne resta il titolare ma sullo sviluppo del pezzo operano numerose interferenze, che culminano nella metamorfosi in duetto, dapprima con le
voci alternate, poi sovrapposte. Il Manichino di Donna
Elvira contrappunta infatti il canto di Leporello con
una serie di figure ritmico-melodiche pregnanti, che
finiscono per realizzare un contrasto assai dinamico
rispetto alla nota verve del catalogo. Soprattutto l’Andante evidenzia numerosi interventi, tra cui la sovrapposizione dell’accompagnamento della canzonetta di Don
Giovanni (a imitazione del mandolino), che opera così
una sorta di identificazione ideale tra servo e padrone. Il patrimonio dell’opera buffa regala un ulteriore
spunto: un frammento della celebre aria “della calunnia” (l’aria di Basilio “La calunnia è un venticello”) dal
Barbiere rossiniano, presente anch’esso sin dal Prologo e
spesso eseguito da strumenti collocati in regioni remote:
strane coppie come flauto e contrabbasso cui si deve,
in apertura del Prologo, la prima ricorrenza del tema,
un venticello che spira costante e ironico per tutto il
dramma.
2) Il canto popolare. Corghi ha da sempre intrattenuto un dialogo assiduo con la cultura folklorica, impiegando i canti popolari come elementi fondamentali
del corredo tematico dei suoi lavori. Nel Dissoluto assolto
sono almeno quattro i temi che attingono al patrimonio
folklorico di canti funebri, a ballo, a la boara, infantili, provenienti da diverse tradizioni italiane, dall’Emilia alla Sicilia: “del presentimento”, “della paura”, “di
Don Giovanni” e il “controsoggetto dialettico”.
3) Il madrigale. Al Commendatore spetta un tema “se-
E|C Serie Speciale · Anno I, n. 1 2007
153
154
rio”, conforme all’impostazione morale del personaggio, e tuttavia non alieno da un’insospettabile deriva
comica. Deriva infatti dal madrigale A un dolce usignolo
tratto dalla “commedia armonica” Festino nella sera del
Giovedì grasso avanti cena (1608) di Adriano Banchieri,
contemporaneo di Monteverdi e stravagante autore
tanto di musica sacra quanto di ludici titoli profani.
4) La memoria privata. L’utilizzo del tema di Banchieri,
così come di temi popolari emiliani, è caratterizzato da
una piccola preistoria privata, a cominciare dal quel
“tema del Commendatore”, fragoroso, sinfonico, in posizione dominante: Corghi li aveva infatti già adottati,
accanto ad alcuni temi popolari impiegati nel Dissoluto,
nella Rapsodia in Re (D), composta nel 1998 per l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Da semplice
citazione, il meccanismo compositivo si rivela dunque
affine all’antica, illustre prassi rinascimentale della parodia, ovvero l’assunzione non soltanto di una linea
melodica, ma di più complesse strutture articolate preesistenti, a dar vita a un nuovo lavoro.
La fitta trama di riferimenti tematici da cui nasce la
partitura del Dissoluto assolto testimonia evidentemente
una duplice esigenza. Quella, diremmo psicologica,
di formulare la propria creatività in termini dialogici:
una concezione dell’atto creativo in quanto cimento
tra invenzione originale e imitazione della tradizione
(intendendo l’imitazione nel senso altissimo di emulazione qual era concepito dall’estetica classicistica).
D’altra parte una tale rete motivica assicura una solidità strutturale, una qualità di pensiero compositivo,
una straordinaria unitarietà e compattezza che permettono di non dipendere strettamente dall’evolversi degli
eventi scenici, e poter così realizzare una drammaturgia
musicale autonoma, adoperando trama motivica, contrappunto vocale e timbro orchestrale come sistemi di
orientamento essenziali per l’ascoltatore. Strumenti attraverso i quali la musica racconta una storia spesso al
di là delle parole.
Raffaele Mellace ·Mozart, Corghi e Il dissoluto assolto
Bibliografia
Azio Corghi. Catalogo delle opere pubblicate da Casa Ricordi – BMG
Ricordi S.p.A., Milano, Ricordi, 2003 (versione elettronica, aggiornato sempre al 2003, in http://www.ricordi.
it).
Mellace, R., 1998, “Canti notturni e antichi usignoli: la
‘Rapsodia in Re (D)’ di Azio Corghi”, Programma di
sala, Concerto sinfonico, 10-12 dicembre 1998, Bologna,
Teatro Comunale.
Mellace, R., 2006a, “Don Giovanni 2006. ‘Il dissoluto assolto’ von Saramago und Corghi“, in Mozart. Experiment
Aufklärung im Wien des ausgehenden 18. Jahrhunderts, a c. di
H. Lachmayer, Ostfildern, Hatke Cantz, pp. 707-711.
Mellace, R., 2006b, “Il dissoluto assolto, o sia il Convitato senza pietra. Corghi, Saramago e il mito di Don Giovanni”,
in Il dissoluto assolto, Programma di sala, Teatro alla Scala,
stagione 2005/06, pp. 107-136.
Saramago, J., 2005, Don Giovanni ou o dissoluto absolvido: teatro,
Lisboa, Caminho; trad. it. di R. Desti, Don Giovanni, o Il
dissoluto assolto, Torino, Einaudi, 2005.
Seminara, G., 2006, “Genesi di un libretto”, ivi, pp. 137177.
http://www.teatroallascala.org/public/LaScala/IT/stagioni/stagione1/opera-e-balletto/SanctaSusanna_
DissolutoAssolto/DissolutoAssolto/opera/index.html
(contiene il libretto e, a c. di R. Mellace, opera in breve,
discografia e bibliografia dal programma della “prima”
scaligera cit.)
AISS
E|C Serie Speciale
Anno I, n. 1 2007
La musica pervade la vita quotidiana. Il suono, il rumore, il linguaggio musicale articolato scandiscono
le esperienze comunicative, attraversano e modellano le pratiche sociali. Se la musica ha a che vedere
in modo costitutivo con il linguaggio, caratterizzandosi - come il linguaggio - in funzione del ritmo, del
tempo, dello spazio e della sensorialità, i segni che compongono il “paesaggio sonoro” costruiscono
“forme di vita” vere e proprie che delle sonorità si alimentano e che le riproducono. Basti menzionare le
tante forme di espressione e contenuto presenti in innumerevoli discorsi, quali quello cinematografico
(colonne sonore), quello teatrale (accompagnamenti, opere liriche), letterario (romanzi con il tema
della musica), pubblicitario (i jingles); e ancora, l’informazione (la musica nei TG), la moda (le sfilate
a suon di musica), l’architettura (ambientazioni sonore in punti-vendita, ma anche in luoghi pubblici),
i videoclip, la TV commerciale...
I testi raccolti in questo fascicolo analizzano secondo una prospettiva sociosemiotica alcuni modelli,
forme, usi espressivi e comunicativi delle pratiche musicali, con un occhio particolare rivolto alla
contemporaneità, ma anche con alcune “variazioni” finali rivolte a considerare, attraverso Mozart,
alcuni aspetti dell’interferenza tra classico e contemporaneo.
I saggi contenuti in questa pubblicazione provengono dal convegno “Mutazioni sonore”...
ISSN (on-line): 1970-7452
ISSN (print): 1973-2716
© 2007 AISS
T. reg. Trib. di Palermo n. 2 - 17.1.2005
www.ec-aiss.it

![Musica_e_immagine.pps [modalità compatibilità]](http://s1.studylibit.com/store/data/007525709_1-5cde61487a57acc65bf762230b059028-300x300.png)