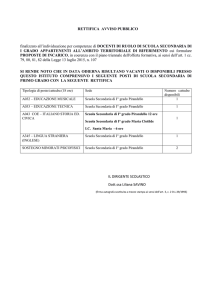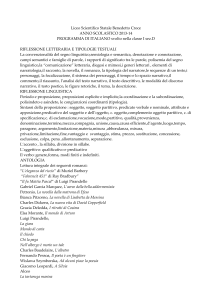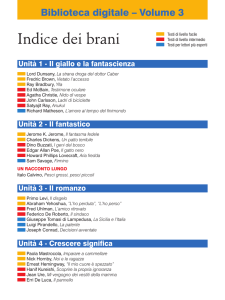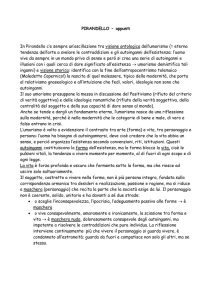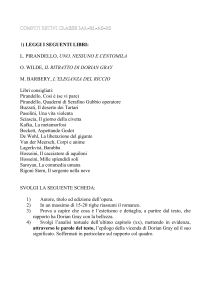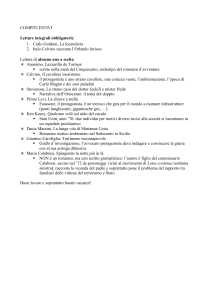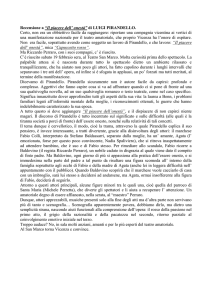LETTERATURA ITALIANA MODERNA E CONTEMPORANEA
(MONOGRAFICO II SEMESTRE A.A. 2012-13)
PROF. GIUSEPPE LANGELLA
A.A. 2012-13
Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Lettere e Filosofia
Introduzione
Il corso di Letteratura italiana moderna e contemporanea è tenuto dal prof. Langella. Esso è tenuto
solo per studenti laureandi in lettere, sia moderne sia antiche, invece per gli altri rami della facoltà
di Lettere e filosofia è necessaria l’approvazione del docente (ottenibile senza problemi), poiché
normalmente gli altri studenti sono affidati al corso di Letteratura italiana moderna e
contemporanea del prof. Elli. Esso si articola in due semestri, affinché chi ha solo 6 cfu possa
seguire indistintamente il primo o il secondo semestre: a lezione, il professore tiene dei corsi
monografici, tra loro slegati, il cui argomento cambia di anno in anno. In maniera autonoma e
domestica è assegnata agli studenti, per ogni semestre, la preparazione sul relativo corso
istituzionale, ossia i contenuti fissi ed immutabili della letteratura italiana, dell’Ottocento per il
primo semestre e del Novecento per il secondo (per i quali si rimanda alle altre dispense di
Scribamates).
Il corso monografico del secondo semestre 2012-13 ha per tema le storie e le tipologie degli oggetti
nella
letteratura
italiana
contemporanea.
Esso
prevede,
nella
bibliografia:
- i testi (reperibili nei materiali didattici, alla pagina web del professor Langella – oppure presenti
nei volumi del corso istituzionale: Letteratura.it vol. 3a o 3b), coi relativi commenti fatti a lezione,
fondamentali per il corso;
- la lettura domestica di alcune novelle di Pirandello (quali siano è specificato nell’apposito
programma, disponibile alla pagine web del professore)
- il volume D. Savio, Il carnevale dei morti, Novara, Interlinea, 2013.
La dispensa qui presente contiene gli appunti completi delle lezioni del professore, che sono
preamboli teorici ed analisi e commento di alcuni testi (quelli appunto scaricabili dall’aula virtuale
del prof.), ma accanto ad essi contiene il riassunti precisi di tutte le novelle di Pirandello richieste
all’esame, con anche il loro commento, che su alcune è stato condotto a lezione, mentre su altre non
si trova altrove, se non qui; inoltre, è presente un sintetico ma esauriente e completo riassunto del
volume di Savio, Il carnevale dei morti.
L’esame è lungo ed abbastanza complesso, più per la parte istituzionale che per questa monografica,
ma sia il professore, sia gli assistenti (a parte uno) sono molto comprensivi e disponibili.
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 1
Appunti delle lezioni del prof. Langella
Definizione
- Un oggetto è cosa (non una persona né un animale) materiale (che si può vedere e toccare) fatta
dall’uomo (non esistente in natura) per un determinato scopo (ha quindi valore strumentale).
L’oggetto è dunque tale solo perché legato alle persone, che si circondano e si avvalgono di essi.
“I Promessi Sposi” del Manzoni
- Capitolo I. Il primo oggetto nominato nel libro è una sega, tirata in causa come similitudine per
indicare la forma spezzata e frastagliata del monte Resegone, che domina il panorama lecchese, ed
inoltre fa parte della semantica degli oggetti artigianali, del popolo piccolo, che è il rivoluzionario
protagonista de “I Promessi Sposi”. Il secondo oggetto nominato è il breviario, cioè il libro di
preghiere, di don Abbondio, per indicare il valore della cultura e della conoscenza, fondamentali nel
romanzo. Gli oggetti che capitano al terzo posto compongono l’abbigliamento e l’armamentario dei
bravi, che li caratterizza propriamente ed identifica il Seicento come il secolo degli scontri, dei
duelli: la reticella verde, il ciuffo enorme, i baffi arricciati, la cintura di cuoio con due pistole, il
corno pieno di polvere da sparo, poi uno spadone con il marchio del padrone don Rodrigo. Infine,
quando prende vita il ritratto di don Abbondio, dopo il colloquio coi bravi, si interrompe la
narrazione e si fa un’anamnesi, un ritratto retrospettivo del personaggio, incentrato sulla mancanza
di coraggio e sulla debolezza: il curato è paragonato, quotando la seconda lettera ai Corinzi di san
Paolo, ad un vaso di terra cotta, fragile e cagionevole di contro alla violenza della storia, costretto a
vivere a contatto con molte persone forti e malvagie, che sono dei vasi di ferro.
- Capitolo II. Importanti sono l’acconciatura ed il vestiario di Lucia, pronta per un matrimonio
contadino, baggiano: gli spilloni d’argento, che tengono i capelli acconciati, disposti a mo’
d’aureola, poi una veste di granati con bottoni d’oro, quindi un bustino a fiori, una gonnella corta di
seta e due calze vermiglie.
- Capitolo III. Gli oggetti dello studio dell’Azzecca-garbugli sono oggetti d’arredo, simbolo di una
cultura imponente ma passata, che esiste da sempre ma è male usata, lasciata ad impolverarsi: i
ritratti dei dodici Cesari, uno scaffale ricco di libri, una tavola piena di leggi e carte, circondata da
sedie e da un seggiolone a braccioli.
- Capitolo IV. Il Seicento è il secolo della pompa magna, cioè dell’estro e dell’esuberanza, dello
sfarzo e del lusso, e la descrizione scenografica della schiera di parenti ed amici dell’ucciso da fra
Cristoforo, pronti ad accoglierlo per ricevere le sue scuse, è fatta tutta per metonimia (è la “retorica
discreta” del Manzoni, non pomposa come nel barocco, ma moderata): non si descrivono i
personaggi nobili ed elitari, alteri e sdegnosi, ma essi sono descritti tramite i loro vestiti, cioè gran
cappe, alte penne, durlindane pendenti, gorgiere crespe e rabescate zimarre. Con grande umiltà, fra
Cristoforo chiede scusa così solennemente da convincere il fratello dell’ucciso che la morte del
parente fosse quasi colpa del medesimo, e non sua, così tutta la schiera teatrale dei nobili rimane
scossa dall’atteggiamento del frate. L’oggetto fondamentale di padre Cristoforo è il cosiddetto pane
del perdono, donatogli dal fratello dell’ucciso per il viaggio, simbolo imperituro della sua
conversione, ed esso è portato su di un piatto d’argento, da parte del nobile, e riposto in un’umile
sporta, un cofanetto spartano, da parte del frate: questi due oggetti, il piatto e la sporta, assumono un
valore sociologico, cioè rappresentano da un lato la pomposità estrosa dei nobili, dall’altro
l’essenzialità e la modestia dei frati.
- Capitolo V. La carrellata scenografica, dal basso all’alto, del palazzotto di don Rodrigo, lo
caratterizza per deminutio, cioè per diminuzione: è un signorotto, che ha un piccolo regno, di un
piccolo paese, come un avvoltoio che si nutre delle carcasse (in contrasto con la descrizione del
palazzo dell’Innominato, fiera aquila che domina l’intero cielo). Le casupole attorno al palazzo di
don Rodrigo fanno intuire un certo tipo di società grazie agli oggetti che si intravedono in queste
case: sono tutti oggetti agricoli (zappe, rastrelli, cappelli di paglia) o armi (reticelle e fiaschi di
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 2
polvere), ad indicare che le persone che gravitano attorno a don Rodrigo sono sia contadini sia
bravi, dalle facce torve e cattive.
- Capitolo VI. Renzo si reca da Tonio per chiedergli d’essere testimone nel matrimonio a sorpresa.
La casupola di Tonio è un ambiente povero e contadino, caratterizzato con grande realismo, a mo’
della pittura del Pitocchetto o del verismo: il focolare, il paiolo con la polenta (poca, data la
carestia), il tavolo con le seggiole, la tafferìa di faggio (i piatti di legno). La cucina è l’ambiente
dove si cucina, dove si mangia e dove ci si riscalda, il locus principale della vita di casa.
- Capitolo VII. Di sera, i contadini, finito il faticoso lavoro, tornano stanchi dai campi verso le case.
Sono caratterizzati dalle vanghe e dalle zappe che portano sulle spalle, che li identificano in quanto
tali. I rintocchi della campana, invece, scandiscono il tempo, che è un tempo rustico ed agreste,
poiché le campane suonano alla fine del giorno lavorativo.
- Capitolo VIII. Don Abbondio riceve Tonio per saldare i debiti che questi ha contratto. Sia il fatto
che il parroco faccia da usuraio, sia il fatto che abbia oggetti con l’area semantica del vecchio e del
superato, quasi non volesse cambiarli per avarizia (vecchia seggiola, vecchia zimarra, vecchia
papalina, luce scarsa della lucerna), sia il fatto che si giri e si rigiri i soldi che gli dà Tonio (le
berlinghe con su sant’Ambrogio), sia il fatto che conservi addosso la chiave del suo armadio e si
guardi attorno sospettoso quando lo apre (per tirare fuori il pegno che Tonio ha dato per avere il
prestito, la collana di sua moglie Tecla), fanno di don Abbondio un personaggio avaro.
Fondamentali oggetti sono anche carta, penna, calamaio e polverino (si mette un po’ di polverina
sulla pagina scritta per far cristallizzare la scrittura) ed il tappetino del tavolo, che sono lanciati
verso Lucia quando questa tenta di pronunciare la formula per il matrimonio a sorpresa.
- Capitolo XII. Durante l’assalto al forno delle grucce, nei tumulti di san Martino, i popolani
rivoltosi prendono prima pane e farina, poi i soldi, infine gli attrezzi per fare il pane, i quali però
sono portati in piazza per farne un falò (sono la màdia, il cassone, il frullone, la gramola, la paniera
ecc...). Manzoni sottolinea poi come non sia un’idea né utile né geniale quella di distruggere gli
attrezzi per la panificazione, schierandosi contro l’irrazionalità secentesca: si impedisce in tal modo
di poter produrre in futuro altro pane, ed anche Renzo, da buon contadinotto ed esterno spettatore, si
rende conto di ciò.
I “Canti” leopardiani
- Ne “La quiete dopo la tempesta”, che ha l’intento di dimostrare la schopenhaueriana teoria del
piacere negativo (per cui il piacere è solo assenza di dolore), i protagonisti sono esclusivamente la
natura e gli umani, indagati minuziosamente in molte tipologie. L’unico oggetto è un carro che fa
tintinnare i sonagli (con maestria musicale nel verso, tra allitterazioni ed onomatopee), quasi a
celebrare la tempesta passata. In dittico con la precedente poesia è “Il sabato del villaggio”,
anch’esso riguardo alla teoria del piacere negativo, dove però, in mezzo ai personaggi (dalla
donzelletta alla vecchierella, dai fanciulli al zappator, dal legnaiuol al garzoncello) ed alla natura (il
mazzolino di rose e viole, contestato da Pascoli, poiché rose e viole fioriscono in momenti diversi,
dunque non possono essere contemporaneamente in mano ad una donna), spiccano sempre pochi
oggetti: la squilla, cioè la campana, che ha il compito, battendo il tempo, di scandire i ritmi della
giornata; il martello e la sega, oggetti rustici ed artigianali, legati esclusivamente al lavoro. C’è
dunque grande penuria di oggetti nella letteratura italiana del romanticismo, dove importano più le
persone ed i loro sentimenti, che differenziano ogni persona dalle altre, di contro all’illuminismo
che ha reso ogni individuo uguale in base al fatto che la ragione fosse posseduta da tutti.
Arrigo Boito e la diatriba tra scienza e poesia sugli oggetti
- Nella poesia “Lezione d’anatomia”, lo scapigliato Boito tratta una lezione universitaria tenuta da
un professore, il quale disseziona davanti agli studenti un corpo umano di una donna incinta,
secondo il tema macabro ben noto alla scapigliatura. La poesia diviene un pretesto per criticare il
positivismo e la scienza da parte del poeta e della poesia, poiché queste due discipline intendono il
corpo diversamente: è un oggetto, non più una persona, per la scienza positivista (“ecco le valvole,
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 3
ecco le celle, ecco l’aorta”, come l’Arcimboldi, pittore barocco che dipinge le persone
componendole con la frutta: l’uomo è degradato e ridotto a mera cosa), invece è una persona, non
già un oggetto, per la poesia. Essendo gli scapigliati al crocevia della letteratura, vicini in parte al
decadentismo, gli oggetti iniziano ad introdursi nella poesia.
Giovanni Verga e gli oggetti del verismo
- Ne “I Malavoglia”, quando ‘Ntoni, esule e sradicato, partito in viaggio attratto dalla sirena del
progresso, ritorna con la coda tra le gambe, fallito, alla casa del Nespolo, dove lo aspettano i fratelli
sopravvissuti, egli vuole rivisitare la casa per poter rivivere i suoi ricordi, prima di andarsene per
sempre, per espiare le sue colpe, che non possono essere assolte. Nel visitare la casa, si nota ancora
come la descrizione sia più degli ambienti che degli oggetti, i quali non sono ancora parte della
letteratura italiana: nella cucina si nota il forno, nella stalla niente, nelle camere manco meno.
- In “Rosso Malpelo”, novella di “Vita Dei Campi”, il padre di Rosso Malpelo, il ragazzo
indemoniato che lavora nella cava, si chiama mastro Misciu, grosso, bonario e minchione, e muore
quando gli frana addosso la miniera: il figlio assiste alla tragedia, chiama i soccorsi che tardano,
scava con le unghie, ferendosi, per liberare il padre, ma questi muore. Un giorno si ritrovano degli
oggetti personali di mastro Misciu, e poco dopo il cadavere: benché Rosso Malpelo non voglia
vederlo, accetta e si lega moltissimo alle vesti (che la madre gli aggiusta su misura) ed al piccone
del padre. I panni e lo strumento di lavoro divengono quindi una sorta di oggetto transizionale, che
accompagnano Malpelo durante la crescita e sostituiscono il padre che non c’è; si caricano dunque
di un plusvalore emotivo ed affettivo, tale che Malpelo può continuare la vita del padre ed invocarlo
grazie a tali oggetti.
- Nella novella “La Roba”, la cosiddetta roba, che fa da fil rouge alla poetica verghiana, ossia i beni
immobili (la terra, gli edifici ecc...), non è importante in sé, in quanto oggetto, ma in quanto indica
il proprietario, in quanto posseduta: ecco perché, in martellante iterazione, all’inizio del brano ogni
cosa vista e sentita è “di Mazzarò”. Avviene dunque quello che Giacomo Debenedetti ha chiamato
“feudalesimo della roba”, in cui prevale il primato dell’avere, la smania di possedere, che intacca
persino le persone, considerate a mo’ di cosa, cioè reificate (dal latino res,ei).
Pascoli ed i “Poemetti”
- Arditamente, ma a buon diritto, si può dire che gli oggetti fanno una comparsa vera e propria da
protagonisti nella letteratura italiana solo con la poetica di Giovanni Pascoli. Con “Il Fanciullino” si
compie infatti quello che per la critica è un “allargamento del poetabile” e per Gianfranco Contini è
una “democrazia poetica” (ma il più acuto a riconoscere ciò è Edoardo Sanguineti, il quale parla
marxisticamente di abolizione della lotta tra le classi verbali, in modo di porre tutte le parole sullo
stesso piano), invero i soggetti protagonisti delle poesie dell’autore non sono più gli eccessi di
cultura alta, gli sfoggi classicistici ed il puro ornamento, ma ci sono nuovi soggetti: le piccole cose,
modeste e quotidiane (è la cosiddetta poetica degli oggetti), mai considerate dalla tradizione, dato
che con la veggenza del fanciullino il poeta può scovare persino in esse un significato vero e
profondo, nobilitando la materia più umile e facendo compiere una radicale metamorfosi alla realtà
bassa, semplice e comune, infatti “trova la poesia in ciò che lo circonda. Inoltre, la poesia delle
piccole cose ha anche una forte implicazione concettuale, quella dell’accontentarsi del poco, del
gioire del piccolo, un ideale che gli proviene direttamente dal poeta latino Orazio e dalla sua “aurea
mediocritas”, infatti “esser poeta della mediocrità, non vuol dire davvero essere poeta mediocre”:
non a caso, la posizione ideologica dell’autore è quella di un socialismo umanitario di stampo
contadino, teso a valori, interclassisti ed evangelici, di conciliazione e fratellanza, vagheggiando,
come nella sua cara e felice fanciullezza, una realtà immersa nella natura, semplice ed ingenua,
dove le modeste persone vivono tra piante ed animali e sono paghe dei pochi e piccoli oggetti che
hanno.
- Nei “Primi Poemetti”, c’è una poesia chiamata “Le armi”: Pascoli odia le armi, gli ricordano la
guerra, la violenza della storia e soprattutto la morte del padre, dunque in realtà queste armi sono gli
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 4
arnesi del contadino, gli strumenti del mestiere, e Pascoli usa questa metafora riprendendola dal
profeta Isaia (libro di Isaia, 2,4), il quale dice che, quando ci sarà la pace universale, le lance e le
spade verranno fuse e trasformate in vomeri e falci. I “Poemetti” sono, secondo il parere di Giorgio
Bàrberi Squarotti, un “romanzo georgico”, dove nelle poesie si racconta la storia di una famiglia di
contadini della Garfagnana, che è quella operante proprio in questa lirica.
- All’inizio della poesia, il padre dice al figlio Nando di andare a prendere delle nuove armi, che
saranno sue, poiché prima di allora ha usato solo quelle di altri: Nando si reca nello stendino (cioè
nella caverna, nella fucina) del fabbro Aladino, per farsi fare gli strumenti, ed il fabbro forgia,
battendo il maglio (una macchina, azionata dalla forza motrice dell’acqua, la quale picchia sul ferro
per dargli la forma, a mo’ di martello: anticipa in un certo qual senso il mito della macchina, caro al
Novecento letterario, ma rimane pur sempre un mezzo, uno strumento, qualcosa di sfruttato dalla
perizia dell’uomo, non c’è ancora il capovolgimento del rapporto tra uomo e macchina, in cui sarà
la macchina a guidare l’uomo) sul tasso (l’incudine), la lancia e la spada, donde la citazione di Isaia,
che contribuisce alla sacralizzazione degli oggetti e del mondo agricolo. Si è come nella fucina di
Efesto, di Vulcano, che plasma le armi leggendarie, oppure si è al principio dei tempi, al momento
del dio platonico, il demiurgo, che forgia la kora, ossia la materia del mondo; tutto in maniera
mitizzata.
- Inizialmente, questi strumenti saranno ruvidi e neri, ma, con l’uso, la fatica e l’impiego
quotidiano, diventeranno lucidi e belli, sempre più personali: ancora una volta, gli oggetti sono tali
quando usati dall’uomo, migliorando con il sudore umano. Poi, Pascoli esprime la sua visione di
una società utopica di contadini, piccoli proprietari terrieri che da sé provvedono al proprio
sostentamento, in maniera evangelica (dalla Genesi: l’uomo si sostiene lavorando la terra): “fate
armi nuove per ognun che viene nuovo nel mondo”.
- Sulla strada, Nando vede i sintagmi della primavera, cioè le operazioni della potatura (forbici e
pennato, con il loro rumore onomatopeico, tipicamente pascoliano, sono gli strumenti deputati a
ciò) e la pioggia, prevista dal padre. Poi assiste ad una antropomorfizzazione degli oggetti, perché il
maglio diviene un gigante rosso, in maniera quasi epica. Quasi Achille che si reca dagli dei per
avere le armi mitologiche, il maglio già sa chi è Nando e perché lì si è recato. Il maglio spiega che
le armi, ossia i soliti attrezzi del mestiere contadino, sono sei, ed in maniera umile ed evangelica,
essi sono tre fratelli e tre sorelle, che apparterranno a Nando per tutta la sua vita (ciò è espresso dal
ciclo della natura, ossia da quando sorge a quando cade la Gallinella, ossia la costellazione delle
Pleiadi, la famosa Chioccetta).
- Il primo strumento, cioè il primo fratello, è la vanga, che serve a triturare e smuovere le zolle di
terra, già solcate grossomodo dall’aratro, ma spacca la schiena anche al contadino. Spiega quindi
come si forgia dal nulla una vanga. Per secondo c’è il piccone, il quale da un lato ha la zappa e
dall’altro ha la scure, dunque ha una doppia vocazione, poiché serve a scavare, ad andare in
profondità, dentro la terra ma anche dentro la memoria collettiva. Al terzo posto c’è la falce, che
serve a mietere l’erba ed il grano, paragonata implicitamente alla luna e richiamata da Caino, che si
dice esser stato il primo contadino della storia; la crinella è la falce più piccola, per l’erba e basta,
invece la frullana è la falce grande, quella per il grano della mietitura, quella tipica dell’iconografia
della morte. Per quarto c’è il pennato, detto in gergo la roncola, una variante lunga dell’accetta, fatta
non per spaccare la legna, ma potare con colpo netto i rami sottili e leggieri, che servono per il
fuoco, per il cibo agli animali ed anche per costruire piccoli e grandi oggetti. Quinto viene il
marrello, un modo toscano di definire la zappa, che serve a muovere la terra per posare i semi e poi
per ricoprirla dolcemente. Ultimo e sesto posto va al badile, cioè la pala, col suo manico lungo e
con la punta differente rispetto alla vanga, che serve a sollevare la terra per poi ricoprire i punti
scoperti.
D’Annunzio ed “Il Piacere”
- Nel romanzo “Il Piacere” prende vita una nuova poetica degli oggetti, quella estetica, fatta di
oggetti eleganti, raffinati, preziosi, rari, ma fini a se stessi, frivoli, vuoti, inutili, in parallelo
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 5
all’estetismo (infatti spesso l’estetismo medesimo, benché vorrebbe evitare ciò, degenera nel kitsch,
ossia in oggetti che hanno pretesa d’essere artistici, ma in realtà sono volgari), i quali divengono,
per la prima volta nella letteratura italiana, un elemento di status symbol, da cui insomma
dipendono il rango sociale ed il gusto del proprietario dell’oggetto stesso (l’idea è già anticipata ne
“La Roba” di Verga). Si è insomma nell’atmosfera decadente della fin de siècle, dove la società
diviene di massa, anonima ed alienata, e contemporaneamente gli oggetti divengono insignificanti,
di pessimo gusto, quotidiani e comuni, fatti in serie, dunque l’estetismo ha una pretesa reazionaria,
quella di ripristinare un antico splendore, quella di rivendicare il proprio individualistico “vivere
inimitabile” (secondo la definizione che Annamaria Andreoli ha dato della vita di D’Annunzio) e la
singolarità delle proprie cose, di contro alla società di massa ed agli oggetti banali. Ecco che quindi
gli oggetti favoriti dall’estetismo sono delle vere e proprie opere d’arte, status symbol di una società
nobile, alta ed antica, sono cose artefatte, artificiali, opere dell’uomo. Si assiste all’estetizzazione
degli oggetti.
- La scena del passo antologizzato si apre con una vendita all’incanto, cioè un’asta, la quale diventa
un evento mondano, un’occasione per gente d’élite, dove si offrono alcuni oggetti, e l’entrare in
possesso degli oggetti in vendita fa dimostrare ai presenti la propria ricchezza e la propria eleganza,
infatti le cose altro non sono se non segno dello status symbol del loro proprietario. Segue una
enumerazione, tecnica tipicamente dannunziana, degli oggetti esposti. Che cosa dà prestigio a questi
oggetti, e dunque ai loro proprietari? 1) L’antichità (quadri della scuola toscana, arazzi fiamminghi,
maioliche del Metauro, orologi del XVIII secolo). 2) La preziosità dei materiali (gemme, medaglie,
monete, argenti, cristalli di Ròcca). 3) La lavorazione dell’uomo, magari anche d’autore (mobili
intarsiati, quadretto del Foppa, elmo cesellato da Antonio Del Pollaiuolo, centauro intagliato nel
sardonio [madreperla] per Lorenzo il Magnifico, gioielli del tempo di Ludovico il Moro, codici
miniati a lettere d’oro su pergamene azzurre). Gli oggetti divengono quindi delle opere da
collezione, è il collezionismo, singolare ed elitario, il fenomeno cui soggiacciono i partecipanti
all’asta, insomma gli esteti. Elena Muti conquista nell’asta il centauro fiorentino, ed Andrea Sperelli
si complimenta con lei, giudicandola “un’eletta” (è la concezione elitaria e di aumento sociale che
comporta l’estetismo) e pensando quali piaceri Elena può dare ad un “amante raffinato” come lui
(nell’edonismo estetico, fatto di piaceri e di culto dei sensi, la donna stessa si reifica, diviene un
oggetto, capace di dare voluttà). D’Annunzio spiega poi ciò che va di moda nell’elegante Roma
umbertina, appunto la “mania” del biblot e del bric-à-brac (il ninnolo, il soprammobile, l’oggetto da
mettere in casa) comprato in una vendita privata; non a caso, D’Annunzio lavora come giornalista
analizzando tutte le tendenze del momento, che soggiacciono al fascino dell’estetizzazione (ecco
che i cuscini si fanno con pineta e piviale, ornamenti dei vestiari dei sacerdoti, ecco che i fiori si
mettono nei vasi di farmacia o nelle coppe di vino, ecco che i gioielli appartenuti ai nobili sono
assai pregiati). Sul finire della scena, Elena suggerisce ad Andrea un “gioiello mortuario”, epigone
del gusto del macabro che caratterizza l’Ottocento, che è un orologio fatto a mo’ di teschio ricavato
nell’avorio, il quale sottolinea una tematica cara a tutti gli esteti: l’inevitabile scorrere del tempo (è
il topo del tempus fugit, tanto caro non solo al classicismo, ma anche al Seicento), che indica la
momentaneità e la frivolezza del piacere sensuale, un tempo cui solo l’arte può sottrarsi, ma non la
vita.
- Nel secondo passo antologizzato, prende vita la descrizione dell’alcova, del nido del piacere
dell’esteta, che sembra anticipare e pregustare la voluttà stessa. In questo caso la donna oggetto di
piacere è Maria Ferres, la donna angelica, bellissima, spirituale e casta, che l’esteta deve violare,
usare, sporcare, in una sorta di profanazione e sacrilegio nei confronti della donna santa, appunto la
madonna, incarnata nel nome di Maria: l’eros perverso ed esacrante, al limite dell’eccesso, è l’esito
più radicale dell’estetismo stesso, ma fa comunque parte dell’estetismo europeo (è, insomma, un
piacere malato). La descrizione è infatti condotta, oltre che con la solita enumerazione di
D’Annunzio e con i soliti criteri oggettistici già anticipati (1-antichità; 2-preziosità dei materiali; 3lavoro dell’uomo, magari anche d’autore), nell’area semantica del sacro, pronto appunto ad essere
esacrato: le stoffe ecclesiastiche, gli arazzi di soggetto sacro (annunciazione, parabole, vita di
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 6
Maria), il baldacchino di velluto, il paramento, il pagliotto, il pluviale, la sagrestia in legno, le
dalmatiche con la Creazione, le stoffe liturgiche, le maioliche di Luca della Robbia ed il trittico di
Hans Memling. Giorgio Bàrberi Squarotti ha parlato di “simulacri del sacro cristiano” ne “Il
Piacere” del Pescarese, ossia di oggetti di cui, di cristiano, non rimane che l’esterno, il superficiale,
fatto apposta per la volontà estetizzante di profanarlo. Il critico Pupino dice che soltanto il sadico
non ha nessun motivo per fare del male, dunque è molto più grave di chi lo fa con motivo, perché è
fatto gratuitamente per il solo gusto di avvilire e distruggere: ecco la grossa differenza tra i
personaggi malvagi dell’Ottocento, come il signorotto don Rodrigo, spinto in fondo in fondo
dall’amore, ed i personaggi del decadentismo, come appunto l’esteta Andrea Sperelli, spinto dal
solo gusto di far del male, che è profondamente malato (sarà nel conte Sperelli quella “maladie de la
volonté” di cui parla lo psicologo francese Paul Bourget).
Gozzano e “le buone cose di pessimo gusto”
- Il critico marxista Edoardo Sanguineti ha introdotto il concetto di “poetica [...] dell’obsolescenza”
a proposito di Gozzano, spiegando che le persone e gli oggetti stessi descritti dai crepuscolari, di cui
appunto Gozzano è capofila, sono vecchi, passati di moda, di cattivo gusto, kitsch, come del resto la
stessa parola “obsoleto”, piuttosto inusitata: quelli dei crepuscolari non sono più gli oggetti antichi,
classici, intramontabili, sempre da mostrare, che sono stimati dal classicismo e dall’estetismo
ottocentesco, ma sono cose polverose, meno nobili, quasi da vergognarsi di mostrare. Perché i
crepuscolari hanno quest’idea? Poiché sono consapevoli della crisi sociale e culturale di cui sono
partecipi, e poiché vivono tutta una vita triste, malinconica, appartata, addirittura nell’attesa della
morte dato che sono malati, allora non rimane loro che prendere le distanze, allontanarsi, mettere la
sordina dalla vita presente e consolarsi colle cose obsolete del tempo remoto.
- Nella poesia “L’amica di nonna Speranza”, tratta da “La Via Del Rifugio”, Gozzano riprende la
tecnica dannunziana dell’enumerazione, ma tramite essa crea un trionfo di oggetti démodées,
bruttini e vecchiotti, che descrive guardando una foto, d’età preunitaria, di un stanza di una casa
torinese in cui l’allora giovane nonna Speranza è ospite di un’amica. Tra le cose che spuntano: un
pappagallo imbalsamato, il busto dell’Alfieri, la frutta di marmo messa in campane di vetro, i
mosaici veneziani, ecc... L’intento di Gozzano è quello dell’ironia, che è infatti il suo sigillo, con
cui abbassa il tono e riconduce tutti questi soprammobili ad oggetti di scarso valore, che però, da
buon crepuscolare, si accinge a cantare, per ammettere la crisi della società di cui è testimone.
- In un passo de “La Signorina Felìcita”, poemetto tratto da “I Colloqui”, l’ambiente privilegiato
non è più quello nobile ed alto del salotto, dove si ospitano ed intrattengono gli ospiti, ma quello da
un lato della cucina, dove lavora Felìcita, tra sporco e macchie, tra odori e scarti, e dall’altro del
solaio, un luogo polveroso ed impresentabile, pieno di disordine e robe inutili: sono stanze umili,
marginali, periferiche, in linea con l’ideale obsoleto e kitsch crepuscolare. Michaìl Bachtìn, critico
russo, nell’opera “Estetica E Romanzo” inventa la categoria del “cronotopo”, ossia di un luogo che
suggerisce una particolare idea di tempo: in questo caso, la cucina e la soffitta dei crepuscolari sono
il cronotopo del passato remoto, di qualcosa di vecchio ed inutile. Nella strofe IV l’avvocato e
Felìcita sono nella soffitta di villa Amarena, dove, tra il tanto “ciarpame reietto” buttato in qualche
maniera, ci sono vecchi arnesi, materassi e ceste, robacce di altri tempi, ma permangono ancora un
dipinto dell’ultima marchesa che ha posseduto la villa ed un quadro di Torquato Tasso.
- 1) Il ritratto della marchesa, di gusto settecentesco, arcadico ed a stile impero (con anche tocchi di
area semantica sepolcrale: “riposata”, “tomba”, “dorme”, “ciò che è stato”, il tutto in riferimento
all’obsolescenza), permette di spiegare che villa Amarena era la dimora estiva di alcuni nobili, che,
in decadenza ed indebitati, l’hanno venduta ai contadinotti da cui discende Felicita, così ora
l’altisonante quadro, che di solito domina gallerie e sale principali, è buttato in qualche modo nel
solaio. L’oggetto diviene così il segno di una trasformazione sociale particolarmente acuta alla fine
dell’Ottocento, quella della crisi della nobiltà e dell’ascesa dei popolani; infatti il padre della donna
altro non è se non, come detto più avanti nel poemetto, un “mercante inteso alla moneta”, cioè un
sempliciotto rustico dedito solo al guadagno. È l’obsolescenza sociologica. 2) Felicita, che non
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 7
brilla per cultura, chiede perché sul capo di Tasso ci siano delle foglie di ciliegio: con un filo di
bonaria ironia alla Gozzano, l’avvocato, perito umanista ed uomo acculturato, sorride e spiega che,
in realtà, esse sono foglie d’alloro, una cui corona era solitamente data ai grandi poeti (appunto
laureati, cioè cinti del laurus, l’alloro). L’oggetto, ancora una volta, significa che la società
decadente, ormai improntata su altri valori, ha perso la stima e l’utilità della letteratura e della
cultura in generale, ed i crepuscolari confermano ciò: alla fine del poemetto, Gozzano afferma “mi
vergogno d’esser poeta!”. È l’obsolescenza culturale.
Pirandello ne “I Vecchi E I Giovani”
- Il meno pirandelliano dei romanzi, infatti è un romanzo storico, è ambientato in Sicilia alla fine
dell’Ottocento, e non è privo di tocchi di autobiografismo nelle vicende del romanzo e nei suoi
personaggi, che si ispirano alla famiglia di Pirandello. Si allineano nel testo tre generazioni: il
generale Gerlando Laurentano, ossia il nonno (già il nome è parlante, il suffisso “ger” in greco
indica vecchiaia) che si batte per i moti del ’48, poi Roberto Auriti, un nipote, che si batte ad
unificazione avvenuta, ed infine il nipote giovanissimo, Lando Laurentani, che partecipa ai fasci
siciliani. Quando si invecchia, Pirandello spiega che si possono imboccare due vie: o si spengono
poco a poco gli ideali della gioventù, prendendo vita la corruzione e la decadenza (è il caso dello
scandalo della banca romana), oppure, rimanendo fedeli ai propri ideali di gioventù, si perde il
contatto con la storia, poiché si rimane cristallizzati in vecchi valori, mentre il mondo è cambiato; è
questo il caso del personaggio di Mauro Mortara, il fedele servitore del generale Gerlando, che,
anche dopo la sua morte, continua ad adorare. Quando, negli anni ’90, al culmine dello scandalo
della banca romana, Mauro Mortara arriva a Roma, ha l’aspettativa di trovarsi nel caput mundi,
nella gloria eterna di una città immortale e cristallizzata nel suo passato antico, perché è ancora
legato ad ideali passati che ha percepito nella sua giovinezza, così gira estasiato per le strade della
capitale, inciampando spesso perché distratto dal panorama; dunque si rifiuta di vedere tutto il male,
la corruzione e lo scandalo che c’è nella Roma di quegli anni (su cui, non a caso, Pirandello
continua a far piovere, è autunno, c’è fango ovunque, ad indicare proprio il deterioramento
dell’epoca), in una sorta di espressionistica deformazione grottesca che Pirandello fa del
personaggio.
- Dentro a questo romanzo, il Siciliano descrive accuratamente la stanza del generale Gerlando,
chiamandola “il camerone”: in essa sono raccolte, a mo’ di piccolo museo, le reliquie di un eroe di
guerra, che per il Mortara sono cimeli e simboli di un passato eroico, sigilli altisonanti di una
grande età, pregni dei suoi ideali, una sorta di sacrario venerabile ed antico custodito gelosamente
dal Mortara in memoria del suo padron Gerlando (infatti è lui che possiede la chiave della stanza).
Mauro tiene le finestre e le persiane chiuse, quasi per non far disperdere dal sole il respiro stesso del
generale racchiuso all’interno della stanza, in cui tutto è rimasto proprio come Gerlando l’ha
lasciato. L’area semantica è proprio quella della sacralità (“chiesa”, “santuario”, “preghiera”,
“reliquia” ecc...). Michaìl Bachtìn, critico russo, nell’opera “Estetica E Romanzo” inventa la
categoria del “cronotopo”, ossia di un luogo che suggerisce una particolare idea di tempo: in questo
caso, il museo della stanza del generale è il cronotopo del passato prossimo. È un passato che è
finito, concluso, morto, ma soltanto da poco, tanto che se ne vedono gli effetti, infatti attraverso il
Mortara gli oggetti della stanza, i mobili e gli ideali stessi dell’epoca rivivono, trovano nuova luce,
sono ripristinati ed hanno ancora valore, dunque sono ancora validi, servono a ricordare, sono utili
(è la situazione opposta del cerpame reietto dei crepuscolari, che sono trapassati, non servono a
niente). “Come in chiesa un divoto nella preghiera” dice Pirandello quando Mauro, respirando l’aria
della stanza, ricorda e fa rivivere tutto un glorioso passato. Tra i tanti oggetti, ci sono: “suppellettili”
che sono anticaglie di salotti napoleonici, “mobili decrepiti” dissestati e con qualche crepa, “divani”
sbiaditi, “lastre” metalliche poste sul tetto per far reggere il soffitto, “ciotole” per raccogliere
l’acqua che percola dal soffitto, tanto che i topolini stessi vi fanno capolino, a segno
dell’ammaloramento dell’ambiente. Poi un “leopardo” imbalsamato ed impolverato (il generale è
stato un cacciatore, assiduo frequentatore di safari in Africa), ancora quattro medaglie, epigoni di
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 8
riconoscimenti in guerra attribuiti al Laurentano, infine una lettera ingiallita e sbiadita, l’ultima
lettera del generale, esiliato a Malta in quanto nobile, nonostante abbia lottato per il regno d’Italia,
che è un eroe romantico, il quale lotta per una causa persa, così, per non darla vinta al destino, alla
fine si suicida (Mauro si commuove quando la rilegge dopo anni).
- In questo palazzo aristocratico del generale vive anche don Cosmo, il fratello del generale, il quale
è un filosofo, distaccato e disincantato, che è il portavoce dell’idea di Pirandello: egli sa che il
palazzo è vecchio e cade a pezzi, è un passato ormai antico, dunque non ha più valore, bisogna
commisurarlo col mondo moderno e non tenerlo cristallizzato al passato. Con l’umorismo suo tipico
(che è assieme commedia e tragedia, sorriso divertito e riso amaro e consapevole), Pirandello spiega
che i valori ormai sono passati.
“Amore A Cape Town” di Bianca Garavelli
- La sensibilità maschile conserva gli oggetti che hanno valore storico, pubblico, civile, invece la
sensibilità femminile conserva gli oggetti che hanno un valore privato, personale e familiare. La
protagonista, alter ego di Bianca Garavelli, è una grande viaggiatrice, la quale ama viaggiare non
solo per visitare posti nuovi e provare nuove esperienze, ma anche per poi gustare il piacere di
tornare nella propria casa (è una sorta di nòstos ulissiaco, cioè il tema del ritorno in patria). Del
resto, il viaggio è uno dei grandi archetipi della letteratura occidentale (a partire dall’Odissea, si
parla proprio di tema odeporico, cioè di letteratura di viaggio), che è metafora della vita stessa, del
cammino della vita insomma. L’oggetto, in “Amore A Cape Town”, diviene il mezzo per ricordare
il viaggio compiuto, con il piacere della scoperta ed il piacere del ritorno: la casa della protagonista,
che è il luogo stabile dell’essere, è piena di oggetti, che sono la traccia mnestica del viaggio stesso,
il luogo della memoria, infatti la casa altro è se non il riflesso della propria esistenza e del proprio
vissuto, dove si accasano tutti i ricordi. Ecco perché la casa va colta “nei suoi particolari prima
ancora che nel suo insieme”, nei soprammobili prima che nei mobili e nelle pareti.
Pirandello in “Serafino Gubbio”
- I “Quaderni Di Serafino Gubbio Operatore” è il grande romanzo cinematografico di Pirandello,
dove il protagonista, Serafino Gubbio, è un operatore cinematografico, il quale ha il compito di
girare la manovella con cui la pellicola, catturando la luce dall’esterno, è impressionata e registra
progressivamente le immagini dell’ambiente circostante. Si è nei tempi del cinema muto e
primordiale, tra gli anni ’10-’20, infatti la prima stesura, col titolo di “Si Gira…”, è del 1916, ma
l’edizione definitiva è del 1925. Il tema è quello della modernità tecnologica, cioè del mito della
macchina: c’è una degenerazione del rapporto tra uomo e macchina, perché l’uomo non è più il
padrone ed il dominatore degli oggetti, ma ne è schiavo, vive in funzione delle cose, è totalmente
alienato dalla sua autenticità e sottomesso alle leggi della roba. Quando ci si chiede chi è il
protagonista del romanzo, bisognerebbe in realtà chiedersi che cosa è il protagonista, e la risposta la
dà Pirandello stesso: Serafino è “una mano che gira una manovella”, una sineddoche (la mano al
posto dell’uomo), ossia una persona che non è più tale perché ha solo il compito di dipendere da un
oggetto, e tutto il resto della sua persona è da buttare. L’alienazione di Serafino lo porta ad essere
lui stesso una macchina, è una reificazione (ossia un passaggio a semplice materia), diventa un
prolungamento stesso della cinepresa, infatti il protagonista è un meccanismo in primo luogo
ritmicamente regolare, cioè che gira la manovella a cambio di velocità in base alle esigenze della
scena, ed in secondo luogo impassibile, cioè che non si fa condizionare da ciò che lo circonda, non
prova sentimenti.
- Mentre stanno girando un film sul safari, il cacciatore spara per gelosia non alla tigre, come da
copione, ma alla prima attrice, e la uccide, così la tigre si spaventa e sbrana il cacciatore, e tutti gli
altri sul set devono sopprimere la tigre prima che faccia altri danni. Sono morti insomma il
protagonista, la prima donna e la tigre, ma Serafino continua a girare, costante nella ripresa ed
immutevole davanti allo scempio: sente però la necessità di raccontare questa cosa, per vendicarsi
rispetto alla sua alienazione, al suo essere solo una mano che gira una manovella, così inizia a
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 9
scrivere dei “quaderni”, come se la letteratura avesse il compito di raccontare ciò. Ecco spiegato il
titolo.
- Questo messaggio di schiavizzazione dell’uomo all’oggetto, da parte di Pirandello, è
diametralmente opposto a quello che Svevo lancia alla fine di “Zeno”. Per Svevo, se tutti gli animali
hanno avuto in dono una qualità fisica che li aiuta nel loro ambiente (in maniera creazionistica, gli
uccelli hanno le ali, i pesci le pinne ecc...), l’uomo ha invece un sacco di mancanze nelle qualità
fisiche, infatti è inadatto all’ambiente, però ha un’unica grande qualità psicologica, ossia l’intelletto,
l’intelligenza, con cui è stato capace di creare degli oggetti a proprio uso e consumo per adattare
l’ambiente a sè: essi sono “ordigni” per Svevo, delle protesi, delle cose fatte dall’uomo per l’uomo,
di cui esso è creatore, proprietario, dominatore. È insomma l’uomo a prevalere sugli oggetti.
- Nel testo in antologia, una persona si avvicina a Serafino e chiede se non hanno trovato ancora un
ordigno per sostituire l’uomo che gira la manovella (questo personaggio, di cui c’è un’accurata
descrizione, altri non è se non Pirandello stesso: occhi acuti, barbetta ecc...). Serafino risponde di
no, ma la sua giustificazione è stupida e banale: se una macchina sarebbe altrettanto impassibile,
non potrebbe tuttavia regolare il ritmo in base alla scena. È insomma l’ultimo spiraglio di umanità e
di personalità nell’epoca contemporanea, che sta pian piano dando sempre più spazio alle macchine.
Pirandello, nel romanzo, intende allora che quando le macchine sostituiranno l’uomo, allora sarà
davvero un problema, ed altro non è se non il preannuncio dell’automazione che caratterizzerà tutto
il Novecento, un problema sempre più detonante nel XX secolo.
Montale e gli oggetti
- Con Montale ed il modernismo europeo l’oggetto subisce una metamorfosi: non ha più un valore
d’uso, ma ha un valore metafisico (in un’accezione similare ma leggermente diversa rispetto al
tardosimbolismo). Negli anni ’50, per definire Montale, Luciano Anceschi ha sigillato una “poetica
dell’oggetto”, in contrapposizione alla “poetica dell’analogia” tipica del tardosimbolismo. Essa è
l’alta frequenza di cose (mari, scogliere, dirupi, serpi, alberi, uccelli) che popolano la poesia di
Montale: rispetto ad una poesia che deve essere mera descrizione sentimentale, la lirica che si
riempie di cose è una rappresentazione del reale, ma una rappresentazione nuova, con qualità
innovative ed inedite, in cui gli oggetti vanno oltre il loro esserci, acquisendo un valore metafisico,
rinviando cioè ad un pensiero o ad una riflessione, poiché sono palesemente delle allegorie. Thomas
Stearn Eliot, il capofila del modernismo, riprendendo i poeti metafisici del ‘600 inglese, parla
proprio in un testo nel 1920 di correlativo oggettivo (“objective correlative”), ossia di un qualcosa
di esteriore (spesso proprio un oggetto) che si collega a qualcosa di astratto, una “direct sensuous
apprehension of thought”, ossia un afferramento del pensiero che si ottiene per mezzo delle vie
sensoriali. Un oggetto che il poeta ha caricato di vibrazioni multiple, che concentra in sé tante cose,
evitando la descrizione annacquata di tanti sentimenti. Montale scrive le stesse cose prima che Eliot
teorizzi il correlativo oggettivo, ma è il sentimento dell’epoca ad essere comune, a partire
soprattutto dai modelli francesi della poesia simbolista. La poetica degli oggetti in Montale è molto
più presente ed abbondante in “Ossi Di Seppia”.
- L’erto muro. Lo scalcinato muro. La gran muraglia. La rete che ci stringe. Il lento franamento. Il
crollo di pietrame. Questi sono gli oggetti chiave di “Ossi Di Seppia”: significano esclusione,
imprigionamento, sofferenza, “impietrato soffrire senza nome”, dunque, il famoso “male di vivere”,
cioè la coscienza della crisi e della condizione dolorosa in cui è costretto a vivere l’uomo del
Novecento. Inizialmente sono interpretate come descrizioni del paesaggio marino della Liguria.
Solo Contini si accorge di una “crisi nell’ordine teoretico”, ossia inizia ad intendere Montale come
un profilarsi, a partire dalla bassezza e dalla mancanza del reale, di uno sbocco, della ricerca di una
via d’uscita. Nella sezione “Mediterraneo”, Montale vede nel mare una presenta paterna e
rigenerante, portatrice, nel suo respiro, di un solenne ammonimento, ossia della possibilità di
entrare, panteisticamente, nel ribollire dell’elemento acqueo, di abbandonarsi alla sua forza. Il
tracciato psicologico del libro è quello dell’autoconoscenza, ossia quello di “coscienza di sé in
divenire”, in un processo continuo di spostamento, di rettifica, di modifica.
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 10
- La poesia “Crisalide”, l’ultima della prima edizione degli “Ossi”, è dedicata a Paola Nìcoli, una
delle giovani coetanee delle estati passate a Monterosso, un bozzolo di bellezza destinata a divenire
farfalla. Importantissimi sono i versi 58-67, in cui si concentra tutta la poetica degli “Ossi”:
sofferenza, male di vivere, (la muraglia immane, il determinismo, la necessità filosofica,
l’imminenza del fato che non si può cambiare ed è inevitabile) e speranza, attesa di essere liberato
(la crisalide che sboccia, il fatto che non era necessario, la contingenza filosofica, lo spiraglio che
evade la necessarietà degli eventi, il “miracolo laico”, la libertà).
- La lirica “Casa sul mare”, ai versi 16-33, sviluppa sempre la dialettica montaliana, tipica degli
“Ossi”, tra necessarietà e contingenza, tra ineluttabilità e speranza, tra prigione e sofferenza contro
libertà ed emancipazione. Vuole “passare il varco”, ma sa che non ogni persona “che vuole
s’infinìta”, cioè approda alla salvezza. Nel frattempo Montale assume dalla tradizione elementi
stilistici (Eliot parla di “sposarsi col rinnovamento della tradizione” nel saggio “Tradition and
individual talent”) per ribadire la sua poetica innovativa: “vanisce” è citazione di Ecclesiaste,
Dante, Petrarca e Leopardi. Luigi Blasucci parla proprio di “riscatto del quotidiano concettuale”.
- La poesia “Incontro”, Dedicata ad Anna degli Uberti, ragazzina che veniva d’estate a fare il bagno
nella Monterosso montaliana, va oltre la dialettica tra male di vivere e liberazione, ed approfondisce
il tema dell’autoriconoscimento, tra i versi soprattutto 41-55: è l’incontro, la relazione, il legame
che ripristina la conoscenza di sè e del mondo che il poeta possiede, riscattando la sua ignoranza.
Chiuso in sè, si smarrisce, ma nel dialogo con l’alterità, si ritrova. La donna è dunque come
l’angeletta stilnovistica di Dante, è un’apparizione salvifica, un’epifania joyceana, alla stregua di un
correlativo oggettivo, la quale rivela che l’uomo deve scendere nel mondo, deve superare la viltà
dell’autoesclusione, deve accettare la vita.
- Eusebio, Arsenio ed altri sono i nomignoli che gli amici danno ad Eugenio: ecco perché la poesia
“Arsenio” la si vede spesso in maniera autobiografica. Qui la poetica degli oggetti si vede molto
bene, poiché tutte queste cose, benché non proprio oggetti, che rappresentano la tempesta (versi 123) sono sbattute sulla pagina e servono a far intuire che Arsenio vorrebbe suicidarsi. Si presenta
ancora la dialettica tra l’immobilismo impassibile e necessario, il delirio della paralisi, il rovello
interiore, cioè il male di vivere, di contro alla volontà, in questo caso, di espiazione, di desiderio di
farla finita, di cessare di vivere. Però Montale desidera essere liberato, non liberarsi, quindi non può
agire, non può nemmeno farla finita, può soltanto rimanere bloccato, come fa l’uomo del
Novecento, nella coscienza della crisi. Egli accetta allora il male di vivere, come un “giunto”,
flebile e pronto a piegarsi, facendo riferimento a Dante, in Purgatorio I. Egli allora si arrende a
vivere in una “ghiacciata moltitudine di morti”, ossia i traditori incastrati nel Cocìto, con allusione
alla “Divina Commedia”. Questi oggetti banali e quotidiani, i giunchi ed il ghiaccio, sono recuperati
in una chiave letteraria altissima.
Oggetti reali nella linea lombarda
- Luciano Anceschi, in un’antologia del 1952, riconosce una “linea lombarda” iniziata da sei poeti
del Nord nel secondo dopoguerra, che poi proseguirà negli anni con altri protagonisti. Anceschi, di
scuola fenomenologica in filosofia, celebre professore di estetica e fondatore della rivista “Il Verri”,
è un intellettuale il quale, sebbene più tardi rispetto alle produzioni del movimento della linea
lombarda in sé, ha tracciato una sorta di poetica di tale linea all’interno della prefazione alla sua
antologia, la quale si applica a tutti gli autori, precedenti e successivi, di questa linea lombarda.
L’antologia che Anceschi crea, accogliendo questi sei poeti, è dunque una critica militante, pratica e
concreta.
- Nella prefazione di Anceschi, fatta ancora un po’ secondo i canoni della prosa d’arte, cioè elegante
e forbita ma anche un po’ sfuggente, è chiaro il contenuto che la linea lombarda, di contro alle
tendenze tardo-simboliste dell’orfismo, dell’ermetismo e degli altri movimenti coevi, recupera la
realtà. Non a caso, il retroscena culturale che è appena stato è quello della fenomenologia filosofica,
che pone in rilievo gli enti concreti e le relazioni tra di essi, e quello del neorealismo letterario e
cinematografico, che pone al centro la quotidianità e la problematicità della vita materiale. Infatti,
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 11
nella linea lombarda, gli oggetti tornano ad essere emblemi di concretezza, sono il recupero di
istanze realiste, è a partire da essi che la poesia scaturisce, dopo una stagione tutta trascorsa nel
segno dell’analogia, dell’evocativo, dell’astratto, in cui gli oggetti sono stati assunti come simboli,
perdendo i loro connotati di realtà. Ecco perché Anceschi parla di “una poesia in re” per i lombardi,
di contro alla “poesia ante rem” della lirica precedente, troppo intangibile, che ha la smania di
abolire il reale (hantise de abolir). Inoltre, per la linea lombarda, questi oggetti, pur essendo reali e
pratici, hanno un sovrasenso eletto a dimensione dell’universale (ma non come per la lirica pura dei
tardo-simbolisti, dove gli oggetti diventano solamente un simbolo totalizzante, indecifrabile ed
arbitrario scelto in base alle sensazioni dell’autore, perdendo del tutto il loro significato vero e
concreto): per dire ciò, Anceschi parla di “massimo di intensità”, cioè di un significato valido e
comprensibile da ciascuno per questi oggetti trattati.
- Vittorio Sereni è il maggior poeta e quello più anziano ed autorevole della iniziale linea lombarda.
Nella sua opera “Diario D’Algeria” (che è un libro di prigionia, dato che Sereni combatte in Africa
durante la seconda guerra mondiale ma è fatto prigioniero, dunque in realtà la guerra non la vive sul
campo), c’è un poemetto titolato “Il male d’Africa”. La poesia inizia con uno sguardo sulla Milano
grigia e meccanicizzata, per poi passare alla nostalgia del continente nero, appunto il cosiddetto mal
d’Africa.
- Gli oggetti in “Il male d’Africa” sono in primo piano: motocicletta e pentola; invece le persone
sono in secondo piano: l’anima e noi. La motocicletta solitaria è accostata all’anima attardata, in
una frase tutta nominale e caratterizzata dall’ipallage (non è la moto ad essere solitaria, bensì
l’anima che la cavalca): ecco che dunque la motocicletta è personificata, prende il posto del
motociclista, che scompare. A conclusione, ciò che la poesia stessa vuole dire ha origine
dall’oggetto, con una sorta di metonimia, dove l’agente è sostituito dall’agìto, dove l’oggetto,
concreto e reale, ha un sovrasenso che lo elegge a rappresentante della persona. Ecco dove sta la
“poesia in re” di Anceschi. Allo stesso modo, nei versi successivi, la pentola prende il posto di
qualcuno che cucina, grazie all’aggettivo familiare: ecco che la pentola è personificata, è il nucleo
domestico ed intimo che viene ricordato, dove l’oggetto tangibile ha un sovrasenso che rappresenta
una persona. Oltre alla vista, inoltre, è tirato in gioco l’udito, con la parola “eco” e l’onomatopea
indiretta “borbottìo”.
Poetica dell’oggetto nell’école du regard
- Nello stesso anno in cui a Palermo prende vita il cosiddetto “gruppo ’63”, che è alla base del
movimento della Neoavanguardia in Italia, in Francia Alain Robbe-Grillet, il capofila, assieme ad
altri autori, dà luogo al gruppo dell’école du renard (cioè la scuola dello sguardo). Questo
movimento, nato appunto nel 1963 a Parigi dal manifesto di Robbe-Grillet, intitolato “Pour un
nouveau roman”, dà un grandissimo rilievo alla poetica degli oggetti. Infatti, la scuola dello
sguardo, osservando il mondo come registrazioni meccaniche di un obiettivo fotografico, toglie
tutta la centralità all’uomo, toglie tutto il soggettivismo di ascendenza romantica, ed elegge a
protagonista della vita l’oggetto, ossia la realtà inanimata, materiale ed estranea delle cose, fino ad
allora rimaste schiacciate e sullo sfondo dal predominio della presenza umana. Non c’entrano più
allora nei romanzi i personaggi, i sentimenti e la trama, ma gli oggetti che fanno da sfondo, tanto
che, come bloccati in un’istantanea fotografica, anche le persone divengono immobili e mere cose.
Il nouveau roman fa ciò in maniera provocatoria e sperimentalista, per sottolineare l’alienazione e la
reificazione cui è sottoposto l’uomo contemporaneo (un concetto già presente in molti autori
novecenteschi, come Pirandello), messo in disparte ed in secondo piano dal modus visendi
dell’école du regard. Nel suo manifesto, Alain Robbe-Grillet spiega che è stufo di conferire
un’anima, una manciata di aggettivi ed una miriade di significati alle cose, eleggendole a persone ed
a costanti antropologiche, poiché le cose sono cose, meri oggetti, e l’unico senso che essi hanno è
esistere, esserci, stare “qui presenti”. Gli oggetti hanno un “falso mistero”, essi non hanno “alcun
segreto”, sono senza un significato recondito, essi hanno semplicemente la loro “inconsistenza”, ci
sono, punto e basta, senza quella felice formula de “il cuore romantico delle cose” che tanto è stata
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 12
cara agli autori a cavallo tra Ottocento e Novecento. Gli oggetti non hanno cuore, non sono il
correlativo oggettivo di nulla, non hanno psicologia o sociologia, e rimangono totalmente “estranei
all’uomo”: le cose che l’uomo si è fabbricato a proprio uso e consumo hanno conquistato
un’autonomia ed un ruolo di primo piano, mentre l’umanità, alienata e sola, è ridotto a mero fondo
scenico.
Calvino e l’oggettività
- Nell’articolo “Il mare dell’oggettività”, uscito sulla rivista “Il Menabò” nel 1960, la svolta epocale
che Calvino registra è l’abolizione del dualismo tra io e mondo, tra interno ed esterno, poiché il
soggettivismo viene sommerso dal “mare dell’oggettività”. È una svolta che non è stata prevista né
calcolata, ma in cui l’uomo si trova dentro. Precedentemente, durante il primo quarantennio del
Novecento, insomma fino allo spartiacque del secondo dopoguerra, c’è stata invece una resistenza
passiva o attiva da parte degli artisti e dei letterati, che hanno chiuso il loro io in un guscio in
opposizione all’esterno del mondo: ecco da dove nascono, in Italia, l’ermetismo, “Solaria” e la vena
del magico. C’è stata dunque un’irriducibilità della propria coscienza al mondo esterno, una
“inondazione soggettiva” che ha manipolato tutto ciò che la circonda secondo i propri e singolari
canoni, ecco perché in Europa si hanno il modernismo, l’espressionismo, il surrealismo ecc... Come
già Calvino ha detto nella postfazione al cosiddetto “ciclo dei nostri antenati”, l’io contemporaneo
non fa più attrito, non si aggrappa né si impone più nella sua vita, ma si lascia scivolare tutto il
mondo addosso, si lascia fluire sopra la lava e l’inondazione dell’oggettivismo. La resa
incondizionata a questo mare dell’oggettività è causata, secondo l’autore, dalla “crisi dello spirito
rivoluzionario”: infatti è venuto meno il tentativo dell’uomo di indirizzare ed interpretare il corso
del reale, di manipolare e correggere il mondo secondo le proprie idee, poiché l’umanità è stata
messa di fronte ad una realtà troppo complessa e labirintica, con uno sviluppo esponenziale ed
autonomo, in cui le cose vanno avanti da sole, dai costumi agli stili di vita, dall’arte alla letteratura
alla società; l’esterno è troppo articolato, insomma, per essere piegato a proprio piacere dalla
coscienza di ogni singolo individuo.
“Palomar” di Calvino
- Calvino, in un momento di autoesegesi, afferma che gli Americani dicono Pàlomar, in riferimento
al grande centro d’osservazione, ma lui si è rifatto alla parola spagnola palomàr, che significa
colombaia, dunque così va pronunciato, tuttavia in realtà la colombaia nulla c’entra col romanzo.
Calvino ha chiamato così il protagonista del libro poiché gli ha evocato la figura del palombaro. Il
signor Palomàr è un uomo che si mette in marcia lungo il cammino della conoscenza, per conoscere
la verità della società e della storia, ma il suo arrovellarsi ed il suo continuo ipotizzare sono
immediatamente smentiti da continue verifiche, che si avvicinano al vero ma si fermano sempre al
di qua della conferma.
- Ogni testo di Calvino, come spiega in calce al suo ultimo romanzo (penso sia Palomar), è
identificato da tre numeri in sequenza, che indicano la tipologia di ciò di cui si parla. Quando
troviamo il numero 1, è un testo descrittivo, che corrisponde ad un’esigenza visiva che ha per
oggetto le forme della natura, vicino insomma alla scienza; il numero 2 è un testo narrativo, che ha
a che fare con le azioni dell’uomo, è antropologico e culturale, riguarda la letteratura, è un
racconto; il numero 3 è un testo riflessivo, più filosofico, che riguarda i grandi temi che fanno
scattare la meditazione e la speculazione, dunque è la filosofia. “Palomàr” è 3.3.1, dunque molto
filosofia ed un po’ di scienza.
- Già nel suo romanzo neorealista, “Il Sentiero Dei Nidi Di Ragno”, all’interno della postfazione
detta i canoni del neorealismo, e sembra divertirsi a buttare dentro una serie di tesi, poi a smontarne
alcune ed a convalidarne altre. Anche ne “Le Città Invisibili”, in alcune note in corsivo mette i
discorsi suoi, sotto la maschera di Marco Polo, con Kubilai Khan, in cui smonta le certezze dei
luoghi comuni e mette in questione le idee chiare e distinte, con una facie divertita. Calvino si pone
dunque come un intellettuale problematico e critico, che, da contemporaneo qual è, mette in dubbio
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 13
ogni convinzione, è abilissimo nella pars destruens, però senza mai smettere di cercare la risposta
convincente, di proporre ipotesi, di inseguire la verità, di restituire una visione unitaria, organica,
sintetica e totale del cosmo (è l’enciclopedismo, tipico della contemporaneità), in mezzo alla
complessità labirintica e difficile del reale, ma sempre fermandosi un po’ prima di dettare una verità
oggettiva, poiché il mondo e l’esistenza sono troppo intricati per averne una per davvero.
- Nel testo antologizzato, si spiega che il signor Palomar, dopo aver iniziato a cercare per semplice
diletto la ricchezza delle cose del mondo, decide di procedere ad un’osservazione sistematica ed
organica di tutto ciò che lo circonda, in maniera enciclopedica: “prova a fissare tutto ciò che gli
capita a tiro”, in un atto conoscitivo totalizzante. Tuttavia, le realtà da registrare sono tante e tali da
impazzire, da mandarlo in crisi e da non provare più piacere a compiere ciò: è la complessità
labirintica del reale che lo ferma. Allora, per superare ciò, Palomar avanza l’ipotesi di fare una
selezione delle realtà da analizzare, per poter giungere insomma ad una conclusione, ad una verità
frutto di una visione pseudo-enciclopedica, tuttavia incappa in problemi di scelte, esclusioni,
gerarchie di preferenze, che necessitano per forza il tirare in causa il soggettivismo: l’io, il suo
sistema di valori, le proprie convinzioni e le proprie manie, il suo relativismo, gli permetterebbero
di arrivare ad una verità vacillante, filtrata e non autentica. Bisogna “lasciare da parte l’io” per non
prevaricare l’attendibilità del risultato, allora il mondo, con tutte le sue cose e le sue persone, si
sdoppia e si piazza davanti alla finestra del signor Palomar: ci sono dunque due mondi, un mondo
fuori, che si fa guardare, ed un mondo dentro, quello in cui vive Palomar e di cui fa parte, il quale
sta osservando. Allora anche il soggetto, l’io che guarda, è un oggetto, è qualcosa di osservato,
poiché è parte del mondo, ed è un buon risultato. La soluzione sarebbe dunque l’osservare il mondo
con gli occhi del mondo, ossia guardare le cose dal di fuori, con uno sguardo che viene dall’esterno,
e non dalla propria soggettività: la visione del mondo dovrebbe dunque cambiare, essere oggettiva e
veritiera. “Macchè. È il solito grigiore”: anche questa ipotesi viene scartata e non serve. L’uomo
non si arrende alla complessità del reale, dispersivo e disarticolato, ma affronta la “sfida al
labirinto”, tanto cara a Calvino, tentando di dare risposta ai propri quesiti, di ricercare la verità, di
aprire un varco nel labirinto. La soluzione proposta alla fine del brano è che, nel corso della vita
passata alla ricerca della realtà, non si arriva ad una soluzione certa, ma può capitare,
accidentalmente ed in maniera del tutto fortuita, che ci sia una congiunzione favorevole, quando
meno ce lo si aspetta, che illumina un pochino di più la verità e la rende manifesta all’individuo (è,
alla lontana, l’epifania di Joyce, l’intermittenza del cuore di Proust, care anche a Pirandello).
Erri De Luca e l’oggetto contemporaneo
- Autore contemporaneo, si è occupato molto dell’aspetto religioso ed ebraico della letteratura
italiana contemporanea, conciliandola con la sua passione, tutta francescana, per le scalate a piedi
nudi, tra montagna e scogli. Nella prosa “Penultime Notizie Circa Ieshu/Gesù” parla delle
esperienze giovanili nella vita di Gesù Cristo, sottolineando molto la sua dimensione modesta, di
figlio di falegname. Con la frase in antologia, Erri De Luca spiega che la nostra società
contemporanea, fredda e tecnologica, ha creato il prototipo del prodotto finito, completo,
massificato, il quale ha perso la sua autenticità, la sua origine, la sua materia prima, tutti elementi
che diventano irriconoscibili ed immateriali. Una volta, invece, i prodotti di un tempo sono stati più
calorosi, più spontanei e più validi, dove la materia prima rimane riconoscibilissima. Si pensi alla
semplicità di una seggiola di legno di contro al sofisticato e composito monitor di un computer. Si
pensi all’impianto centralizzato di riscaldamento di contro al caminetto ed al focolare domestico.
Neoavanguardia, romanzo apocalittico e società dei consumi
- La società dei consumi, massificata, industrializzata e spersonalizzata, ha trasformato, in età
contemporanea, l’oggetto in semplice e bassa merce. Questo concetto, sebbene già presente in nuce
nel clima decadente (soprattutto dell’estetismo, che vuole l’esclusività dell’oggetto estetico [che
diviene status symbol] di contro a quello popolare), è chiarito totalmente con l’avvento vero e
proprio della società dei consumi negli anni ‘60, da parte del movimento del gruppo ’63, i cosiddetti
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 14
“novissimi”, quelli insomma della neoavanguardia. È molto vicina all’idea della pop art inglese ed
americana. Nel testo “Piangi piangi”, il poeta Edoardo Sanguineti, capofila della neoavanguardia,
vuole sottolineare il carattere ormai artificiale dell’oggetto (idea già in nuce nell’estetismo): esso è
spersonalizzato (ti compro un fratellino e lo chiami Michele), fatto di materiale sintetico e chimico
(spada di plastica, capodoglio di gommapiuma), industrializzato (ci sono gli oggetti di marca, con
un marchio di fabbrica che dà prestigio, come la Bosch o la Montecatini). In questa aenumeratio, tra
giocattoli ed elettrodomestici, Sanguineti elenca anche armi, in riferimento alla corsa agli
armamenti della guerra fredda.
- Nel romanzo “Dissipatio H. G.”, Guido Morselli parla del dileguo dell’H. G., cioè dell’humani
generis, del genere umano. Il protagonista, un vero e proprio misantropo, schifato dagli uomini e
dalla società, si suicida, ossia arriva a dileguarsi, a dissiparsi. Il suo suicidio però fallisce, ed il
protagonista torna a vivere sulla Terra, ma si trova solo: l’umanità intera è scomparsa, in maniera
sconvolgente ed angosciante, ma anche ironica, poiché non si sa perché, non è spiegato dove sono
finite le persone. Se il misantropo voleva uscire lui di scena, invece sono state le persone a
precederlo. Inizialmente, tutta la sua misantropia lo rende felice, ma col tempo inizia a sentire il
peso della solitudine e della propria coscienza, così, vagando solo per un mondo deserto, si trova a
che fare solo con oggetti, a cui dà un’anima umana virtuale e fittizia, alla ricerca di un po’ di
compagnia. Nel passo antologizzato, il protagonista decide di innalzare un cenotafio all’umanità:
esso è un monumento funebre che però non contiene la salma del morto, fatto solo per evocare il
suo ricordo. Il cenotafio è fatto di materiali tipici della pop art, insomma della società dei consumi,
dominata da oggetti che vanno dalle grandi marche alle cose banali e commerciali, insino ai grandi
manifesti pubblicitari. Complice il terrorismo degli anni di piombo e l’imminenza della guerra
fredda, negli anni ’70 in Europa va di moda il romanzo apocalittico, che narra di catastrofi di livello
globale e della condizione di pochi deputati che sono costretti a sopravviverci: è questo il genere di
“Dissipatio H. G.” di Morselli, il quale, pur non facendo parte della neoavanguardia, ne assorbe
l’elemento della società dei consumi e lo applica al suo romanzo apocalittico.
Oldani ed il realismo terminale
- Per il poeta milanese Guido Oldani (vivente), le persone che hanno varcato la soglia del terzo
millennio sono frutto di uno “squilibrio della distribuzione dei popoli”, poiché la maggior parte
degli esseri umani vive condensata in città, in una “catasta” del mondo, e dunque è divenuta
qualcosa di antropologicamente diverso, vicina piuttosto ad un oggetto, ammucchiato in un insieme.
Privo di cultura ed intelligenza, senza la mente, ridotto a qualcosa di fisso, immobile, inerte, l’uomo
vive una “autocensura nelle intelligenze”, per cui non può più esprimersi, non è più libero, non ne è
più in grado e nemmeno lo vuole, ha quasi paura di dire ciò che pensa e si autodifende tenendo gli
occhi chiusi, perché è incastonato in e ridotto ad oggetto (infatti nel Novecento il ruolo dell’oggetto
è andato sempre in crescendo, finché la relazione tra uomo ed oggetto si è rovesciata, prendendo
esso il sopravvento sulle persone, diventando esso il soggetto, mentre l’uomo è divenuto oggetto).
Tutte le analogie e le metafore che si utilizzano nel mondo nuovo, quello del terzo millennio, sono
dunque “similitudini rovesciate”, infatti si assiste ad una “rivolta del linguaggio”: il secondo
termine di paragone non è più la natura, ma l’oggetto, che diviene quindi il nuovo protagonista, il
nuovo governante degli esseri umani (l’amore è una camera a gas, l’amante è come una moto, la
donna è come un conto in banca). L’uomo non fa più i conti con la verità, vive in una realtà
totalmente artificiale, dove regnano gli oggetti, la natura altro non è che un qualcosa di
addomesticato, come del resto l’uomo. Tutte queste concezioni stanno nei libri, editi da Mursia nel
2010 e nel 2012, ossia “Il Realismo Terminale” e “La Faraona Ripiena”, che sono i saggi teorici. Il
libro di poesie su questo realismo terminale è invece “Il Cielo Di Lardo”, sempre del 2012.
- Nella poesia “Cravatte”, la similitudine rovesciata, la rivolta del linguaggio sta nel fatto che,
durante un incendio: il fuoco sono cravatte rosse verso il cielo, il fumo è grigia carta che incarta le
cose infiammate, il camion dei pompieri ha una pancia piena d’acqua che alza la gamba e fa pipì sul
fuoco.
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 15
Novelle di Pirandello: riassunto e commento
La giara
- Don Lollò, contadino tirchio che per ogni nonnulla corre a chiamare l’avvocato, compra
un’enorme giara per raccogliervi l’olio, ma essa un giorno è rinvenuta rotta. Il conciabrocche Zi
Dima, nel ricomporre le due parti della giara col suo mastice miracoloso, rimane però chiuso al suo
interno poiché la bocca della giara è troppo stretta per uscirvi. Don Lollò si accorda allora con
l’avvocato per rompere la giara e far uscire il conciabrocche, a patto che questi poi gliela ripaghi,
ma Zi Dima non vuole e vi rimane dentro. Quella sera, mentre gli altri contadini urlano e danzano
demonicamente attorno alla giara, ubriachi al chiaro di luna, e Zi Dima canta dentro di essa, don
Lollò, seccato ed irascibile, la butta a terra e la spacca.
- Zi Dima è il genio incompreso, che vuole far valere la sua arte nel riparare le cose, invece don
Lollò è una maschera espressionista arcigna e contorta, come un ulivo saraceno. La situazione è
all’apparenza, di primo impatto insomma, comica, nel senso del paradossale, poiché fa scoppiare la
risata, però quando Zi Dima e Don Lollò riescono a litigare su di una soluzione così semplice e che
hanno sotto gli occhi, la situazione rivela la propria natura umoristica, nel profondo della
comprensione della realtà, in bilico tra risata e pietà per tali personaggi. La stessa giara diviene
simbolo della prigione della forma, insomma di un’identità forzata in cui sia Zi Dima sia don Lollò
si calano, non volendo uscire dal proprio punto di vista, non volendo cedere la propria parte al
mondo, non volendo rinunciare al proprio soggettivismo: la frantumazione della giara, che segna la
fine della novella, segna allora la rottura di questa prigione e l’apertura, per quanto brutale e forzata,
del punto di vista di don Lollò a darla vinta a Zi Dima.
Pensaci, Giacomino!
- Il professor Toti, intellettuale, vecchio e ricco, ha sposato, per salvarsi la facciata, una giovane
moglie, Maddalena, da cui ha avuto un neonato viziato e capriccioso, Ninì; tuttavia ha un alunno
prediletto, Giacomino, al quale tiene più di se stesso e vuole lasciare in eredità ogni cosa, dato che,
in realtà, Ninì è figlio proprio di Giacomino, avendolo egli concepito con la moglie del professore
su monito di ques’ultimo. Nella vita, ricerca la pace ed il riso, poiché si comporta con Giacomino,
moglie e Ninì in maniera bonaria e paternalistica, non da marito, da genitore o da maestro: tutte le
persone ridono di lui e non capiscono il suo piacere di accondiscendere, come un nonno, alle
frivolezze di questi tre, che lo trattano male. Un giorno la moglie ha una crisi e si chiude in una
stanza, così il professor Toti si reca col figlioletto da Giacomino, ma fatica ad entrare nella di lui
casa poiché la sorella del ragazzo non vuole che frequenti il vecchio e pure col figlio illecito, e per
di più Giacomino è stufo delle intrusioni, dei favori e del suo stesso rapporto col professore, infatti
rivela d’essersi fidanzato. Toti allora si sente offeso e triste, scoppia in lacrime, si appella al fatto
che è un vecchio destinato a morire e che per tutta la vita altro non ha fatto che dare attenzioni e
soldi a Giacomino, il quale si dimostra irriconoscente. Il ragazzo, addolorato ma stufo, esplode
allora negli insulti e lo invita a smettere di farsi coprire di ridicolo da tutta la gente del paese.
Tuttavia, Toti, se il ragazzo non accetterà di raccogliere la propria eredità, avendo in dono la sua
famiglia ed il suo denaro, minaccia di andare dalla fidanzata di Giacomino a screditarlo, grazie al
piccolo Ninì, e di togliergli tutti i favori che gli ha fatto: infatti, andandosene, ripete: “Pensaci,
Giacomino!”.
- È la base per quella che probabilmente è la più famosa pièce teatrale di Pirandello, recitata nel
1916 in siciliano e nel 1917 in italiano, a Roma. È l’eterno impasse del relativismo, per cui ogni
cosa è vista da occhi diversi e soggettivi: secondo Toti, lui sta aiutando Giacomino, ma secondo
Giacomino, Toti lo sta rovinando; entrambe queste tesi sono vere, ma nessuna delle due è la verità.
Anche la diatriba tra apparenza e realtà è importante, poiché Toti salva le apparenze solo in
superficie, mascherando la propria ignominia (e forse latente omosessualità) col matrimonio,
benché tutti in paese ridano di lui, invece Giacomino non si sa bene se sia sottomesso o se sia solo
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 16
stato ammaliato dai favori di Toti, però tenta di salvare le apparenze sino in profondità, volendo
troncare qualsiasi rapporto col professore, ma non si sa se potrà mai uscire dalla sua “prigione della
forma”.
Pallottoline!
- In cima al monte Cavo, nel Lazio, c’è un osservatorio meteorologico abitato dal professor
Maraventano e dalla sua famiglia, aperto ai turisti solo per pochi mesi, per il resto isolato. La
moglie, Guendalina, e la figlia, Didina, vorrebbero avere una vita sociale e premono per conoscere i
turisti, invece il professore ama la solitudine, non si fa vedere e passa il tempo a studiare astronomia
in maniera filosofica, vagheggiando e sognando il profondo dello spazio. Maraventano si diverte ad
insegnare le sue teorie a moglie e figlia, annoiate, spiegando con polemica, sdegno e rabbia la
piccolezza dell’uomo, che è solo un verme, le cui invenzioni, come auto e ferrovie, non sono nulla
contro la velocità della luce. Un giorno Didina piange perché vuole un vestito nuovo da sfoggiare la
domenica, l’unico giorno in cui la famiglia scende a Roma per andare a messa: il professor
Maraventano spiega che ciò è roba da ridere, perde di significato in confronto alla profondità
dell’universo, e non glielo compra.
- Maraventano è la caricatura espressionista di un uomo selvaggio, barbuto e capellone, altero e
rabbioso, che non si mostra mai e vive ad una distanza cosmica dal mondo: infatti, se il
cannocchiale ha lo scopo di avvicinare gli oggetti distanti, il suo è un cannocchiale rovesciato, che
allontana gli oggetti vicini, ed in ciò consiste l’umorismo della novella, poiché sembra una cosa
buffa ma in realtà è un dramma umano. C’è pure il relativismo, ossia le “pallottoline” che sono i
pianeti del sistema solare, il pulviscolo minimo che è l’umanità, nei confronti dell’infinita
sterminatezza del cosmo (sembra riecheggiare alcuni “Pensées” di Pascal). Il confronto è facile con
“Dialogo D’Ercole E Di Atlante”, un’operetta morale di Leopardi in cui Ercole è inviato a sostenere
la terra sulle spalle al posto di Atlante, ma alla fine i due titani si mettono a giocare a palla con la
terra, dato che essa sembra fissa e smorta, eppure è talmente sgonfia come palla che cade: anche
qui, la terra è ridotta a pallottolina, con l’ironia tipica delle “Operette Morali”, poiché l’uomo, visto
da lontano, in realtà è qualcosa di insignificante e privo di senso (è la stessa conclusione della
“Seconda Premessa” a “Il Fu Mattia Pascal”, dove si spiega che, dopo la rivoluzione copernicana,
l’uomo ha capito la sua posizione di secondo piano nell’universo, non più al suo centro).
L’illustre estinto
- Appena nominato ministro del lavoro, a Roma l’onorevole Ramberti ha un infarto e finisce in
ospedale in fin di vita, così si prefigura, da uomo illustre che è stato, un funerale teatrale ed in
pompa magna: processioni magistrali, presenza di massime autorità, discorsi pubblici, carri e fiori e
veli, articoli sui giornali, silenzio sacrale. Morto Ramberti, il funerale però ha diversi imprevisti: la
giornata si rivela soleggiata e ricca di risate; nel silenzio della camera ardente, il cadavere si caga
addosso; la bara viene scambiata con quella di un seminarista abruzzese, e finisce in Abruzzo.
- La poetica dell’umorismo vuole che la “digestio post mortem” non sia solo l’occasione di una
risata, cioè non sia solo comica, ma anche l’occasione per una profonda riflessione che porta a
ridere e piangere assieme, porta all’umoristico, poiché la cagata dell’onorevole apre gli occhi al
lettore, è una sorta di epifania che rivela come vedere in profondo, in realtà, il testo, svelando
l’inutilità di tutta quella pompa magna e la “sciocca pupazzata” che è la vita, un carnevale di
maschere che mettono in scena una parte, nel pieno del relativismo.
Padron dio
- Un umile ed anziano pastore che vive sui monti della Sicilia, per guadagnare, scende in paese e
posa per una pala d’altare, inconsapevolmente recitando un giudice ebreo: gli è dunque affidato il
nomignolo di Giudè e ciò causa la sua ignominia in città. Ora vive di un’elemosina particolare,
poiché si presenta nelle ville in qualità di esattore, dichiarando che la terra appartiene a dio e che
dunque i ricchi debbono pagare una tassa per usarla: modo migliore di sdebitarsi non è che fare
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 17
l’elemosina ad un povero come lui. Vive da senzatetto, immerso nella natura, e trova luogo
sopratutto in mezzo alle erbacce, alle quali si paragona: esse crescono nelle proprietà terriere che
non sono rivendicate da nessuno, così come lui è emarginato. Decide allora di coltivare quelle terre
di dio, seminando il frumento per mangiare, ed il grano cresce alto e biondo; ma una febbre terribile
lo costringe all’ospedale per qualche giorno, così quando Giudè torna al suo piccolo podere, lo
trova cinto da una siepe e sorvegliato da un cane: qualcuno l’ha occupato, e lui non può raccogliere
ciò che ha seminato.
- È la base per il poemetto lungo contenuto nella raccolta poetica “Zampogna” del 1901.
- In Giudè (quasi un primitivo di “Vita Dei Campi”, per la sua ingenuità e selvaticità) ci sono il
sentimento del contrario e la prigione della forma, cioè l’umorismo ed il relativismo. Anzitutto la
sua situazione fa ridere ma, se ci si riflette, mostra la profondità e la lungimiranza di pensiero di
Giudè. Poi lui è cristiano ma dalla gente è ritenuto un terribile giudice ebreo, così, con un pizzico di
follia, sfrutta questa occasione per calarsi nella maschera grottesca di un esattore divino. Egli si rifà
al principio del “Pentateuco” dell’Antico Testamento, quello per cui ogni cosa sulla terra è di dio
[da cui il titolo], quello per cui va messa in comunione ogni cosa tra tutte le persone, quello per cui
si lavora la terra duramente per farla produrre. Eppure la svolta nel testo avviene quando lui, uomo
evangelico e “comunista”, che predica che ogni cosa è di dio e va condivisa, si trova spiazzato
perché la SUA terra, che dovrebbe essere di tutti-nessuno, è stata usurpata.
Canta l’epistola
- Tommasino Unzio avrebbe ricevuto un’eredità consistente da un lontano parente se si fosse fatto
prete. Divenuto suddiacono, ha compiti ed affari umili in chiesa, tra cui quello di cantare le lettere:
per questo ruolo povero tutti lo scherzano e lo chiamano Canta l’epistola. Eppure, in seguito ad una
crisi di fede, Canta l’epistola si è tolto l’abito di religioso, perdendo l’eredità, tra le furie del padre:
egli si chiude perennemente in camera sua, concedendosi al massimo qualche passeggiata solitaria.
Ingrassa ed inizia a vivere tanto per vivere, senza neanche rendersene conto, come nuvole e vento
che passano senza meta, svelando la vanità che si cela dietro a tutto ed il tedio dell’esistenza umana.
Un giorno Canta l’epistola è sfidato a duello dal tenente De Venera poiché ha offeso la sua
fidanzata per un motivo per lui grave ma per gli altri insignificante (è il topos del duello d’onore, di
origine feudale e di recente ripreso dal Manzoni e dal De Marchi, ma anche nel “Mattia Pascal”):
infatti da tempo Canta l’epistola proteggeva un filo d’erba, quasi a proteggere la sua vita nel mondo,
appeso ad un minuscolo filo, e quella donna vi si era seduta sopra. Durante il duello è ucciso, e
confessa d’esser morto, paradossalmente, per un filo d’erba.
- Nella prigione della forma, relativistica, anche dopo lo scioglimento dei voti, Tommasino è
chiamato Canta l’epistola, benché abbia rivelato di esser divenuto prete per vocazione, e non per
avere l’eredità, ma del titolo attribuitogli non si può più liberare. C’è una corrispondenza
concettuale (ma anche filologica, nelle parole riprese alla lettera), col Vitangelo Moscarda di “Uno,
Nessuno E Centomila”: l’autocoscienza è la causa prima dei mali dell’uomo, la quale imprigiona
nelle forme, dunque bisogna rinunciare alla coscienza per poter vivere; è una filosofia nichilista, di
ascendenza leopardiana, che vede la vanità di ogni cosa ed il tedio dell’esistenza, entrambe prive di
senso o di fine. Ecco perché decide di accettare il duello, essendo leopardianamente la vita inutile,
dato che, con un pizzico di follia, egli ha protetto quel filo d’erba come fosse il significato della vita
stessa, ed ora vede la morte come una via d’uscita: ne risulta una visione da comica ad umoristica,
cioè che inizialmente fa ridere, ma poi continua a far ridere però fa anche piangere.
La trappola
- Il signor Fabrizio racconta come sia angosciato dalla verità della vita, che è buio, è inconscio
irrazionale, è riflesso, mentre ciò che le persone credono di vivere è solo è maschera, è finzione
razionalizzata, è una luce illusoria, ossia morte. Spiega di stare cercando di cambiare continuamente
aspetto, opinione, relazioni, di essere libero e vitale, come in un flusso continuo, mentre invece è
chiuso ed imprigionato in una forma, che è una trappola per la vita. Lamenta poi che la vecchiaia gli
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 18
sta impedendo di fuggire da questa trappola. Quindi si scaglia contro le donne, schiave della propria
bellezza, che intrappolano gli uomini, lui compreso: infatti, di recente, si è innamorato di una
donna, e, credendola sterile, ha avuto da lei un figlio, confermando la donna il suo ruolo di trappola
per la vita. Fabrizio rivela di vivere con in casa il padre, in stato vegetale da tanti anni, il quale non
vede l’ora di essere liberato da quella trappola che è la vita: pensa allora di suicidarsi e di portare
con sé il padre, dando fuoco alla casa.
- Novella con palese dichiarazione di poetica, riprende del tutto l’antinomia basilare tra “flusso” e
“prigione della forma”, dunque tra verità e finzione, alla base de “L’Umorismo”, per cui la realtà
che ci circonda può essere percepita solo in maniera relativistica, cristallizzando il flusso autentico
della vita in idee, convenzioni, caratteristiche e maschere che sono valide solo dal punto di vista di
chi le applica, ma in realtà false. É una lunga confessione in prima persona, pienamente decadente.
Percorre tutto il testo l’idea che la vita sia in realtà morte se vissuta nella prigione della forma, così
si nasce già morti, e non resta all’uomo che aspettare di morire del tutto, dunque di liberarsi dalla
trappola della vita. Il modo per fuoriuscire dalle maschere è allora la follia, cioè la tendenza al
suicidio del protagonista.
I pensionati della memoria
- Il protagonista racconta che, se tutte le persone morte vengono sepolte e lì rimangono, i suoi morti
invece gli ritornano, infatti ha sempre la casa piena di persone morte, in realtà per lui vive. Si spiega
meglio: dato che le persone le conosciamo solo secondo la nostra ottica, infatti in maniera relativa
noi, arbitrariamente, attribuiamo categorie e finzioni alle persone, allora, pur morendo esse, in realtà
sopravvivono le maschere che noi abbiamo attribuito loro, poiché le abbiamo create noi e le
portiamo nella nostra memoria, immutabili e fisse. Racconta poi di ricordarsi di un suo conoscente
tedesco che vive a Bonn, il signor Herbst, che fa il cappellaio e che, anche se sarà morto, lui lo
ricorda fissato nella sua forma, secondo una sua idea, unicamente sua, che non può cambiare né
morire mai. Le persone piangono allora i propri cari morti soltanto perché non possono più
continuare a dargli la forma che gli hanno sempre dato.
- È il relativismo pirandelliano a fare da padrone in questa novella: ogni realtà la si conosce solo
relativamente, secondo il proprio punto di vista soggettivo, come ben definito nel saggio
“L’Umorismo”. Pirandello ha studiato a Bonn, quindi nella novella c’è pure un tratto di
autobiografismo. I pensionati della memoria sono personaggi che sono ricordati come tali anche
dopo la morte, in quanto vittime della “prigione della forma” pirandelliana, per la quale si
attribuisce arbitrariamente un profilo, alcune caratteristiche, una maschera insomma, alle realtà che
ci circondano, però in maniera relativa soltanto al nostro punto di vista, dunque sbagliata, e per di
più, una volta attribuita tale identità ad una realtà, è impossibile togliergliela; si può pensare a ciò
quale il tema classico della funzione eternatrice della scrittura, il monumentum aere perennius di cui
parla Orazio, di bacchilidea e pindarica memoria, ribaltato però secondo l’ottica di Pirandello.
La toccatina
- In una Roma grigia, Cristoforo Golisch, romanaccio ciccione, si reca a trovare l’amico di vecchia
data Beniamino Lenzi, mingherlino, poiché questi ha subito un colpo apoplettico, un tocco della
morte insomma, ed ora è mezzo paralizzato e mentalmente ritardato: mentre lo vede fare i suoi
esercizi di riabilitazione, prova un misto di tristezza e rabbia per la condizione dell’amico, ed agli
altri riferisce che avrebbe preferito sparargli. Un mese dopo il colpo apoplettico tocca anche
Cristoforo, rendendolo mezzo paralitico e mezzo rimbambito. Il medico dice che si riprenderà, ma
la sorella per precauzione getta via le pistole di casa. Il fatto è che Cristoforo, quasi per incanto,
parla solo tedesco e non è consapevole di aver avuto una toccatina. Riacquisiti un po’ di movimento
ed un po’ di italiano, si reca da Beniamino perché vuole fare i suoi stessi esercizi di riabilitazione,
come se fosse divenuto consapevole della malattia. Cristoforo e Beniamino si allenano assieme ed
un giorno si recano a casa della loro vecchia amica Nadina, che, vedendosi arrivare due
handicappati, non sa se ridere o piangere, ma decide di scherzare con loro.
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 19
- La situazione all’apparenza è buffa e paradossale, perché dal nulla il destino di ogni uomo può
cambiare improvvisamente, e ciò fa ridere, ma se ci si pensa un po’, la situazione è umoristica, ossia
sì fa ridere, ma fa anche disperare, piangere e provare pietà per i due (è come accade a Nadina, che
non sa se ridere o piangere). Entranti in una prigione della forma, ossia paralizzati, letteralemente,
in quello stato, da esso è impossibile uscirne, in mezzo a tutto il relativismo pirandelliano: se
inizialmente Cristoforo vorrebbe farla finita, sia con l’amico, ma anche probabilmente con se stesso,
per liberarsi con pazzia da quello stato, poi, forse non del tutto consapevole, né lui né l’amico, della
propria condizione menomata, continua ad esercitarsi invano con gli attrezzi per liberarsi dalla sua
maschera, cioè la condizione di handicappato. La parvenza dei due uomini non può che essere,
infine, quella di una deformazione espressionista, con la bocca semiaperta, le gambe non del tutto
funzionanti, i movimenti a scatto e la faccia sformata.
Quand’ero matto…
- Il protagonista, Fausto Bandini, si dichiara savio e guarito, ma un tempo è stato matto, e gli sono
successe un sacco di cose strane, poiché, da matto, ha pensato troppo, ha pensato che le altre
persone hanno un’anima come la sua, dunque è stato troppo altruista, troppo aperto all’altro.
Quando era matto, Fausto ha scritto un trattato di filosofia morale, con tanti dialoghi, apologhi e
storielle che fanno riflettere, anche su dio, per convincere la moglie della propria sanità mentale.
Quando era matto, Fausto si sentiva parte della natura, parte del ciclo della notte e del giorno, parte
delle piante e degli animali, scrupolosamente attento a non calpestarli ed a non danneggiarli.
Quando era matto, Fausto era sposato con Mirina, la quale lo disprezzava per il suo modo di
concepire la vita, però il protagonista trovava consolazione nella sorella della moglie, la quale aveva
un punto di vista simile al suo, tuttavia è morta: mentre fa visita alla camera mortuaria della
cognata, un sibilo proveniente dagli alberi e dagli uccelli attira la sua attenzione su di una stanza
della casa, in cui la moglie lo sta tradendo con il suo vicino; Fausto, presa in disparte Mirina, la
porta davanti al cadavere della donna e le dice che lui la perdona per il tradimento, ma la moglie
scappa via. Quando era Matto, Fausto ha permesso che tutti i dipendenti, che gestivano la sua
fortuna, gli rubassero abbondantemente i soldi, lasciandolo povero: l’unico che gli ha rubato poco e
gli è rimasto vicino anche nella povertà è stato Santi, primo marito di Marta; Santi, morto d’un
colpo apoplettico, lascia allora in eredità ciò che ha accumulato, rubando a Fausto, proprio a Fausto
stesso, e Marta, da buona consigliera, ha salvato il protagonista dalla pazzia e lo ha “fatto rinsavire”,
sposandolo in seconde nozze.
- Il testo è pieno di reminescenze: il trattato morale ricorda “Una Vita” di Svevo, il ciclo della
natura ricorda l’“Alcyone” dannunziana, la voce del bosco e del chiù ricorda il Pascoli di
“Myricae”.
- La situazione è del tutto umoristica: lo stato di matto, in realtà, è migliore di quello di sano per il
buon Fausto; se ciò inizialmente suscita l’irresistibile ilarità, con l’avvertimento del contrario, in
realtà, quando ci si riflette sopra, giunge il sentimento del contrario: normalmente, un savio sta
meglio di un matto, ma in questo caso non è così, bensì il contrario, e ciò fa ridere ma anche
piangere. Non manca il relativismo: con le sue azioni da matto, Fausto è convinto di fare del bene,
ed in effetti lo fa, ma i suoi gesti, come la scrittura filosofica, l’amore della natura, il perdono del
tradimento ed il suo lasciarsi derubare, dagli altri sono intesi non come azioni di bontà, ma di
stupidità. Nella stessa persona convivono allora due identità, una matta ed una savia, ma esse sono
tali solo viste dagli altri, a seconda del fatto che Fausto compia azioni buone o no.
La paura del sonno
- Nella folkloristica Sicilia vive Saverio Càrzana, detto il Mago, un vecchio maestro nella
fabbricazione dei burattini, uomo focoso e magniloquente, accanto alla moglie, Fana, donna placida
e remissiva, che crea e cuce il vestiario di tali burattini, e troppo spesso si addormenta. Saverio si
compiace delle sue creazioni e le crede più perfette degli uomini fatti da dio, pieni di acciacchi:
infatti, una mattina, il troppo sonno è fatale alla povera Fana, che muore. La camera funebre è
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 20
allestita, e quivi tutti i burattini sembrano piangere la padrona. Frattanto, i compaesani consolano
Saverio col vino. L’indomani ha luogo il funerale col trasporto della bara, cui Saverio non
partecipa, affranto, ma al camposanto Fana rinsavisce, tra il clamore generale e le urla al miracolo.
Riportata a casa, don Saverio sviene dallo shock, ma, rinvenuto, inizia poi a manovrare le sue
marionette perché esprimano il suo baldanzoso stato di giubilo. Tuttavia, da quel giorno, le notti per
la coppia divengono indormibili: Saverio ha l’ansia che sua moglie non si svegli più, invece Fana è
continuamente svegliata dal marito che bada al suo essere viva. Finché la morte non la coglie in
pieno giorno.
- La situazione è umoristica: la morte apparente al principio può essere un momento di gioia,
l’attimo di farsi una risata sopra lo scampato pericolo, ma, quando subentra il sentimento del
contrario, ci si accorge che forse era meglio morire, dato che si vive nel terrore di morire, anzi non
si vive proprio più, è un massacrante cotidie mori, è risata ma anche pietà e tragedia. Non manca
anche il relativismo, cioè la soglia tra realtà e finzione, tra l’essere morti e l’essere creduti morti
dalla gente. Particolare la similitudine parallelistica tra l’uomo, che sta a dio, ed i burattini, che
stanno all’umanità, ma un’umanità rappresentata come maschera, come deformazione grottesca,
come persone che hanno perso il fondamento.
Formalità
- In una Sicilia ardente, Gabriele Orsani è il giovane ereditiere di un’azienda dove lavora il vecchio
contabile Carlo Bertone, il quale gestisce ogni cosa, non capendo nulla di amministrazione il
giovane Orsani. In azienda si presenta un omino di nome Lapo Vannetti, che sembra un manichino
per come si veste e si muove, per di più con un occhio di vetro e un difetto di pronuncia, il quale
vende assicurazioni per le imprese e per la vita delle persone, ma viene gentilmente invitato ad
andarsene. Frattanto Carlo avvisa Gabriele che la più grossa zolfara sta andando in malora e che
l’azienda rischia il fallimento: Carlo intima allora al giovane di tagliare le spese di casa, ma
Gabriele cade nella disperazione, sapendo di non poter fare nulla, poiché in vita sua non ha mai
fatto niente. Il giovane Orsani vive in un matrimonio infelice e privo di comunicazione con la
moglie Flavia: lui dà a lei i soldi e la lascia fare, e lei si occupa della casa e dei bambini. La prima
volta che si parlano davvero avviene quando Gabriele le rivela che sono sull’orlo della bancarotta e
si sfoga contro di lei, infine esplode nel pianto e sviene. Flavia chiama allora Lucio Sarti, vecchio
amico che la famiglia Orsani ha cavato fuori dalla strada e sistemato dabbene, nonché innamorato di
e segretamente ricambiato da Flavia, nonché medico, il quale, mentre Gabriele è svenuto, compie
allusioni e proposte a Flavia, e nel frattempo riesce pian piano a far rinsavire il protagonista.
Tuttavia Gabriele, pur svenuto, ha sentito tutti i discorsi di Lucio e Flavia e si è convinto che sia
stato Lucio a mandargli l’omino dell’assicurazione, affinché, alla sua morte, rimanesse una
cospicua eredità alla donna, poi sposabile da Lucio. Ed in effetti è stato così. Allora Gabriele decide
di obbligare Lucio, in virtù degli aiuti che la famiglia Oriani gli ha dato, ad essere complice in una
truffa ai danni dell’assicurazione, facendosi dichiarare sano e poi lasciandosi morire, affinché i soldi
vadano a moglie e figli, ma Lucio non possa sposarla, altrimenti sembrerebbe palese che la sua
dichiarazione di sanità sia stata viziata. Lucio è titubante sul daffarsi, ma in casa, chiamato da Carlo,
si presenta il buffo assicuratore Lapo, e tutti cominciano a fargli pressione: costretto dalle
circostanze, Lucio si arrende e compila le carte, tra la vocina stridula e difettosa dell’assicuratore
che dice “formalità, formalità”, il quale, nel suo outfit ridicolo, gli sembra la predestinazione
sconciata e malefica del proprio futuro.
- La sconciatura espressionista dell’assicuratore Lapo Vannetti, che sembra un pupo mal
riaggiustato, è il riflesso della vicenda sconcia, sul piano morale ed esistenziale, in cui Lucio si è
fatto intrappolare da Gabriele.
- Ciascuno dei personaggi della vicenda, soprattutto Gabriele, Flavia e Lucio, vive in una
strettissima prigione della forma, con addosso una maschera davvero tremenda, costretto a recitare
una parte per poter vivere, ed a tenersi addosso il giudizio della società e le convenzioni sociali
della propria posizione: è un triangolo amoroso dai tratti contemporanei e meschini. Gabriele è
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 21
riuscito a veder chiaro, al di fuori del relativismo e delle verità soggettive che lo circondano, solo in
punto di morte, da svenuto, da alieno ed estraneo alla vita, in un attimo rivelatorio, accaduto in un
contesto insignificante e banale, in cui gli è parso chiaro che cosa fosse la propria vita e che cosa
dovesse fare. Il finale della novella ha i tratti della beffa, dunque all’apparenza, in superficie,
sembra ironico e ridicolo, sembra cioè soltanto comico, ma se si guarda in profondità al gesto cui
arriva Lucio, non si smette di ridere per il ribaltarsi contro di lui della situazione, però non si può
non provare tristezza e pietà tragica, dunque umorismo, per il destino sporco, lurido e disonesto che
ha appena firmato.
Lumìe di Sicilia
- In uno sgargiante ristorante napoletano, coi camerieri indaffarati a predisporre la cena, entra
Micuccio Bonavino, rustico e campagnolo, cercando di Teresina, la cantante, ma, assente la donna,
è fatto accomodare in disparte. Micuccio ricorda di come, nella Sicilia natia, ha scoperto il talento
vocale di Teresina e le ha pagato gli studi a Napoli, nutrendo nel frattempo amore a distanza per la
donna, ma mai ricambiato direttamente. Rientrata al ristorante Teresina, con la sua vecchia madre
Marta, si scopre che quella è una serata speciale ed elegante per festeggiare la carriera canora di
Teresina, ma Marta, meravigliata e sconvolta di vedere dopo anni Micuccio, si fa apparecchiare con
lui un tavolo in cucina, ed avvisa che Teresina è impegnata nelle sale. Quando Micuccio nota di
sfuggita Teresina, rimane frastornato nel vedere una donna di città, sofisticata e cresciuta, troppo
distante dal suo mondo impacciato e contadino, fuori portata per un amore già solo supposto da
parte sua. Triste e sconsolato lui, ma anche Marta, intesi i sentimenti del ragazzo, Micuccio decide
di andarsene senza neanche farsi salutare, donando però delle lumìe (un tipo di agrume). Arrivata
Teresina, si rattristisce nel non averlo potuto salutare, ma è felicissima delle lumìe e, benché la
madre le proibisca di portare in sala un frutto così rozzo e contadinesco, Teresina ne accaparra
quante più può ed inizia a distribuirle tra i galantuomini, gridando e saltellando in giro per le sale.
- È palese, ed anche molto triste, il relativismo di questa storia: è l’amore provato da una parte, ma
non dall’altra, infatti l’interpretazione che Micuccio dà ai sentimenti di Teresina è molto diversa da
ciò che effettivamente la donna prova. Il relativismo si esplica anche nella prigione della forma:
giunta a Napoli, capitale partenopea ed elegante, la semplice contadinotta Teresina si trasforma in
una raffinata e composta signora di città, e da quella forma non uscirà più, ingabbiata in
quell’identità; nella forma ancora rustica e campagnola di Siciliana primitiva, invece, se la
immagina ancora Micuccio. Eppure nel finale, grazie ad un pizzico di follia, sembra che Teresina
ritorni alle origini, priva della maschera da gran signora con cui ora si identifica, mettendosi a
saltellare ed urlare, distribuendo le lumìe della sua terra natale.
Ciàula scopre la Luna
- In una miniera di zolfo, nell’ardente Sicilia, una sera Cacciagallina, il supervisore, vuole far
restare i minatori a lavorare di notte per finire il carico, ma nessuno lo ascolta: gli unici a rimanere
sono Zi Scarda, un vecchio privo di un occhio e perciò assaporatore delle lacrime che dalla cavità
vuota cadono, ed il suo caruso Ciàula, un trentenne così soprannominato per il vizio di fare il verso
della cornacchia (in siciliano, Ciàula). Ciàula non ha paura del buio della miniera, che ben conosce,
però ha paura del buio della notte, della quale non conosce niente: tutto è iniziato quando, esplosa
una mina in miniera, che ha ucciso molti e fatto perder l’occhio a Zi Scarda, Ciàula è rimasto
rintanato tutto il giorno in cava, ma, uscitovi di notte, si è smarrito nel buio ed è rimasto terrorizzato
a vita. Quella notte Ciàula era impaurito per il buio che avrebbe trovato uscendo, ma, vicino agli
ultimi scalini, si accorge di una luce e, strabiliato, lascia cadere il sacco di zolfo e si mette a
guardarla. Tale luce è la luna, che il protagonista non ha mai visto così grande, vicina e bella, come
se l’avesse appena scoperta, dunque scoppia in lacrime.
- È un relativismo un po’ sentimentale ed appassionato quello di questa novella, per il quale la realtà
si colora di una luce lunare diversa in base alla persona che la guarda. Per Ciàula, la mera visione
della Luna diviene un fenomeno stupendo, purificante e limpido, qualcosa di inedito e mai provato
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 22
dal protagonista, mentre per altri la visione della Luna sarebbe stato qualcosa di diverso, in quanto
normale. Il buio, al contrario, che fa normalmente paura a tutti e da tutti è considerato sempre
uguale a se stesso, in realtà per Ciàula esiste in due tipologie, ossia il buio dell’interno, quello della
cava, che lui ama, ed il buio esterno, quello all’esterno, della notte, che lui teme: ancora una volta la
verità sta relativisticamente negli occhi di chi guarda. L’atto stesso della luce lunare è qualcosa di
illuminante, dunque si può far rientrare nella categoria del pirandelliano momento rivelatorio, che
accade in un contesto banale e quotidiano, grazie al quale il protagonista comprende il proprio stato,
svela la propria condizione e si vede sino al profondo dell’anima.
La buon’anima
- Bartolino Fiorenzo sposa in seconde nozze Carolina Sarulli, la quale, vedova, ha avuto per primo
marito la buon’anima di Cosimo Taddei, uomo intelligente e generoso, nella cui casa la coppia vive
e nella cui casa è presente un’enorme sua fotografia appesa, che mette in soggezione Bartolino, più
bamboccione ed ingenuo e per questo parodiato dalle amiche di Carolina, in specie da Ortensia. In
viaggio di nozze a Roma, Carolina ripercorre con Bartolino tutte le tappe, i luoghi, le visite e le
prassi già fatte con Cosimo, facendolo sentire sempre in inferiorità ed in imbarazzo, tanto che
spesso s’immagina l’enorme foto del Taddei che lo irride, però decide di stare al gioco pur di vedere
felice la moglie. Rincasata, la coppia trova morto il marito di Ortensia, la quale soffre di un dolore
indicibile, troppo drammatico a parere di Carolina: quando Bartolino prova a consolare Ortensia,
arriva lui a tirare in causa il fatto che anche Carolina avrà sofferto per la morte di Cosimo, ma la
donna afferma di averlo subito superato. Eppure Bartolino constata il contrario, dato che gli fa fare
tutte le cose dell’ex-marito. Per uscire da quella condizione asfissiante, decide di tradire la moglie
con Ortensia, ma subito se ne pente. Un giorno però capisce che la collana di Ortensia si può aprire,
e dal pendente che cosa può uscire, se non un’altra foto di Cosimo, che lo saluta beffardo pure in
quel frangente, avendolo superato in anticipo anche con l’amante.
- Ancora una volta, la situazione di primo impatto è comica, poiché in superficie non può che far
ridere il complesso d’inferiorità di un uomo nei confronti di un morto, che pure ritorna vivo ogni
volta che lo si guardi nelle fotografie, e saluta sbeffeggiando; eppure, la situazione, dopo un’attenta
riflessione, ha nel profondo anche dei tratti di tragico. Con un tocco di pazzia, Bartolino tenta di
uscire da quell’impasse, tradendo la moglie, per cercare di sopravvivere in quella penosa
condizione; eppure poco cambia, poiché alla fine sempre una foto irridente di Cosimo si ritrova.
Cosimo è una sorta di living portrait, un tizio che è morto ma di una morte apparente, poiché nella
novella è più presente che mai.
Soffio
- Il protagonista viene a sapere da Calvetti, segretario del suo amico Bernabò, della morte di un
conoscente visto poco prima, così afferma come basti un soffio per morire, ed accompagna la frase
congiungendo pollice ed indice e soffiandoci dentro. Credeva quasi d’avere il potere di controllare
la morte delle persone con quel gesto. D’improvviso Bernabò si presenta dal protagonista e riferisce
che Calvetti è morto, così il protagonista ripete la frase e rifà il gesto, e stavolta a svenire, sotto i
suoi occhi, è proprio Bernabò. Lo porta, rubicondo e moribondo, nella di lui casa, dove la sorella ed
il medico assistono inermi alla sua morte. Il protagonista confessa alla donna ed al medico il
significato del suo gesto mortale, e questi gli ridono dietro: anche lui ne ride, ma, rientrando a casa,
sul vialone soffia su moltissime persone, e l’indomani sui giornali esce la notizia di un’epidemia
che ha mietuto centinaia di vittime. Il protagonista si sente pazzo e matto, ma non può credere al
potere delle sue azioni. L’indomani riprova il gesto soffiando su di un bimbo malato di un morbo
terribile, e lo uccide immediatamente. Inizia a convincersi della sua forza mortale. Entrato in
ospedale, trova il medico che era accorso da Bernabò, insiste ancora sul suo potere, ma tutto il
reparto, infermieri compresi, lo schernisce pesantemente, così, stizzito, il protagonista soffia su di
loro: una strage prende luogo, i corpi a terra scatenano le urla in corsia. Il protagonista si rifugia in
una stanza in cui, davanti ad uno specchio, inizia a riflettersi, a toccarsi il corpo, a prendere
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 23
consapevolezza totale del proprio potere, di essere la morte, l’epidemia. Davanti allo specchio,
soffia sul proprio riflesso, così muore e si ritrova, in bilico tra delirio e realtà, in un luogo idilliaco
ed agreste.
- La novella è narrata in prima persona dal protagonista. Il momento rivelatorio, accaduto in un
contesto banale ed insignificante, accade davanti allo specchio, quando il protagonista si vede
vivere, si vede di riflesso oltre la propria maschera, e svela la propria condizione originaria, quella
insomma di un vivo che può uccidere, comprendendo appieno la propria identità. Il sentore della
storia ha quasi dell’incredibile, dell’inverosimile, ma proprio in quanto impossibile questa storia è
vera. Si parte da una situazione comica e buffa all’apparenza, che fa scattare l’irresistibile risata di
un uomo convinto di poter uccidere col soffio, ma se si ragiona e riflette su ciò, si capisce come il
comportamento del protagonista sia sì comico, ma anche drammatico e pietoso, insomma
umoristico, avendo capito con quanta leggerezza la morte possa colpire le persone, benché di certo
non sia in realtà per causa sua. Per uscire dalla situazione e liberarsi, non rimane che la follia come
valvola di sfogo, che si attua nel suicidio.
Prima notte
- Una vecchia madre, Mamm’Antò, ripiega sapientemente la dote lasciata alla figlia, fatta di vestiti
e lenzuola: per la donna, vedova da anni del marito, è tutto ciò che rimane di una vita dolorosa
passata nel lavoro. La madre ha infatti deciso un matrimonio vantaggioso e combinato per la figlia,
Marastella, con Lisi Chìrico, che però fa il becchino ed è vedovo da poco. Il giorno delle nozze ogni
cosa è pianificata, con l’intervento di tutto il parentado, ma Marastella continua a piangere per il suo
destino obbligato di sposa. Il corteo nuziale sembra più una parata funebre, e, terminate le
cerimonie, la giovane si dirige sconsolata nella sua nuova casa, quella di Lisi, la quale si trova
proprio accanto al cimitero dove lui lavora, in cima al colle del paesino siculo. Un po’ isterica, un
po’ disgustata da Lisi, un po’ in terribile disagio, Marastella è un continuo piangere. La coppia
finisce la prima notte di nozze col fare una passeggiata nel contiguo camposanto, dove lei
compiange disperatamente il padre, che non avrebbe permesso tale matrimonio ed avrebbe dato una
vita migliore alla famiglia, mentre lui compiange la sua da poco defunta prima moglie, il grande
amore.
- Il sentore umoristico è presente nel comportamento dei personaggi: all’apparenza, è buffa e
ridicola l’idea che gli sposini passino la prima notte al camposanto, ma, dopo un’attenta riflessione,
si evince che il loro comportamento è dettato da un destino avverso che ha fatto perdere loro il
grande amore della loro vita, e con esso la possibilità di avere una vita migliore. Ecco che dunque,
nel pieno del relativismo, Marastella e Lisi sono bloccati in un matrimonio senza amore, e, con
addosso una maschera, si abitueranno a recitare una mera parte, bloccati dalla prigione della forma
nelle figure di moglie e marito di una famiglia che in realtà non esiste.
La rallegrata
- Due cavalli si stanno abbuffando in una stalla. Fofo è il cavallo di casa, che osserva Nero, il nuovo
acquisito, il quale è invece uno stallone appartenuto ad un principe e ad una principessa che però
sembrano essersi disfatti di lui. Nero non sopporta Fofo, in quanto tutti i cavalli presenti in stalla
non hanno ancora capito il perché della loro presenza lì, invece Fofo, presuntuoso e sicuro di sé,
sembra essere certo del proprio compito e commenta gli altri palafreni con sufficienza. Questi
cavalli, come dice Fofo, sono addetti a trasportare dei carri contenenti lunghe casse, e ad essere
riveriti da lunghi cortei durante il trasporto. Mentre tirano quello che credono un normale carro
seguito da una sfilata, Fofo anzitutto secca Nero coi suoi discorsi saccenti e commenta
maliziosamente il passo degli altri cavalli, infine tenta di istruire Nero, nuovo al mestiere, sul
procedere in modo elegante, impassibile e lento, ed a non fare la rallegrata, ossia a scalpitare, nitrire
ed agitarsi. Seccato, Nero inizia a ribellarsi, la processione è scandalizzata, ma un uomo accorre a
placare lo stallone: è Giuseppe, il vecchio stalliere di Nero quando egli lavorava ancora nelle
scuderie principesche, prima d’essere scartato, il quale rivela a Nero che la cassa che trasportano è
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 24
la bara della sua stessa principessa, e che il seguito in clamore altro non è se non un corteo funebre.
Fofo, borioso, arriva a mentire pur di sembrare il solito intelligente, affermando che lui lo sapeva
già dall’inizio: loro trasportano i morti.
- Nella novella è presente la tecnica dello straniamento: la narrazione, col relativo suo significato, è
affidata al punto di vista, straniato, di un cavallo, e non di un normale uomo. Il momento rivelatorio
arriva solo alla fine, nel solito contesto banale ed insignificante, ma è portato in maniera attiva da
Giuseppe: grazie a lui, i cavalli finalmente escono dalla loro condizione inconsapevole, si vedono
oltre il loro semplice ruolo e comprendono il significato del loro lavoro e con esso della loro
esistenza. La situazione è comica per tutto il testo, sino alla fine, ossia sino al momento rivelatorio:
è buffo, all’apparenza, un intero branco di cavalli che traina, inconsapevole, un mucchio di casse
seguito da un corteo di persone, così come è carico di ilarità il comportamento sbeffeggiatorio e
saccente di Fofo; tuttavia, smascherata la situazione, essa diviene umoristica, rivelando, oltre alla
comicità della beffa, la tragicità ed il dramma che si nasconde, dopo un’attenta riflessione, dietro al
lavoro di questi cavalli, costretti a trainare cadaveri. L’elemento più importante di questa novella è
che la prigione della forma, ossia la recita mascherata che i cavalli fanno, eseguendo senza sosta, e
senza saperne il motivo, il loro mestiere, privi di coscienza o di personalità propria, intrappolati nel
ciclo eterno del loro compito, è compresa dai cavalli stessi soltanto alla fine.
Di sera, un geranio
- Il protagonista sembra essere al di fuori del proprio corpo, come un’anima che vaga sulla terra, ed
al momento sta osservando il proprio corpo, rossastro, peloso e sporco, nonché la stanza in cui esso
giace inerme, identificandosi di volta in volta con tutti gli oggetti d’arredo, dalla lampada al
comodino. È questo quello che sente il protagonista: d’essere come morto. Tende allora un
profondo sguardo verso l’ambiente naturale, osservando le foglie che cadono, l’orizzonte con l’alba
che sale, gli alberi, i prati ed i campi lontani, e poi, vicino, nel giardino accanto alla stanza, un
geranio: il protagonista si identifica con esso ed improvvisamente il geranio si accende di vitalità
propria, quasi la povera anima fosse penetrata al suo interno.
- La novella racconta una materia quasi fantastica, onirica ed allucinata, dove la realtà si distingue a
malapena dal sogno, infatti appartiene alla tarda fase della novellistica pirandelliana, di argomento
surreale. È la storia di un personaggio, anonimo e spersonalizzato, quindi l’uomo medio e comune,
che sta trapassando, la cui anima si eleva dal corpo, morente. Il relativismo nella novella sta man
mano diminuendo, poiché l’anima, disgregando la propria forma, perdendo la propria identità
imprigionata nel corpo, sta assumendo casualmente la dimensione di tutto ciò che vede, dagli
oggetti antropici iniziali ai paesaggi naturali finali, poiché, con la morte, si sta liberando della
prigione della forma e sta tornando alle origini, al flusso incondizionato e vitale dell’esistenza,
ancora caotico ed incontaminato, dunque autentico.
La tragedia d’un personaggio
- Il protagonista afferma che ogni domenica mattina riceve a casa sua tutti i personaggi dei propri
futuri racconti, e li trova persone strane, assurde, al limite della vita, che vogliono essere compatite,
in una ressa caleidoscopica e multiforme. Un libro regalato al protagonista contiene la storia del
dottor Fileno, il quale ha scoperto il rimedio per tutti i mali, cioè far leggere libri di storie passate,
affinché, attraverso un cannocchiale rovesciato, le disgrazie del presente sembrino piccole piccole,
spedite nel passato da moltissimi anni e dunque non più dolorose. La domenica il dottor Fileno
compare in fila dall’autore e gli racconta la propria tragedia, ossia quella di non essere una persona
vera, che, faticosamente, può riuscire a cambiare il corso della propria vita, passando da una forma
ad un’altra, da una condizione ad un’altra, ma di un personaggio fittizio, rilegato per sempre ad
essere ricordato da tutti in una posizione immutabile, quella di un uomo che soffre e soffrirà in
eterno. Allora Fileno chiede di essere messo in una storia dell’autore, per uscire dalla prigione di
quel maledetto libro e per essere ricordato per sempre in un testo migliore. L’autore rifiuta, poiché
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 25
Fileno non è un suo personaggio, ma di un romanzo altrui, e gli suggerisce di applicare anche per sé
quel famoso cannocchiale ribaltato, la cura di ogni male, che lui stesso ha inventato.
- La situazione è umoristica, poiché può solo far ridere, alla prima apparenza, che una fiumana di
buffi individui si rechi dal proprio autore, ma questi, benché faccia ironia su di loro, alla fine li
compatisce in maniera tremenda, capendo il dramma umano, la tragedia di tali personaggi. È anche
una metanovella, cioè una novella che parla di altre novelle, poiché in essa sono accennate storie di
molti personaggi, alcuni di novelle vere, altre di novelle solo progettate e mai scritte. Il discorso che
il dottor Fileno fa al protagonista esprime tutta la prigione della forma pirandelliana: dato che le
persone le conosciamo solo secondo la nostra ottica, infatti in maniera relativa noi, arbitrariamente,
attribuiamo categorie e finzioni alle persone, allora, pur morendo esse, in realtà sopravvivono le
maschere che noi abbiamo attribuito loro, poiché le abbiamo create noi e le portiamo nella nostra
memoria, immutabili e fisse, così come erano; è da questo dramma terribile, che dà il titolo al testo,
che Fileno chiede di essere liberato, dalla prigione della forma del suo precedente romanzo, per
essere posto in una nuova storia che esalti per sempre le sue qualità. Sembra il topos della funzione
eternatrice della poesia, di Pindaro, Bacchilide ed Orazio, per cui il compito della letteratura è
esaltare e far perdurare nella memoria collettiva l’identità di alcuni personaggi, travasato però
nell’ottica della poetica pirandelliana.
La patente
- Il giudice d’Andrea, dall’aspetto bizzarro, ha problemi d’insonnia quasi tutte le notti, così durante
esse pensa a come sbrigare i casi a lui sottoposti. Da più giorni sulla scrivania ha un caso
insbrogliabile, cioè quello del protagonista, Rosario Chiàrchiaro, il quale ha denunciato per
diffamazione due giovanotti che gli hanno fatto le corna per strada in senso scaramantico, poiché il
Chiàrchiaro ha perso il lavoro ed è stato emarginato da tutti in quanto etichettato come iettatore,
cioè uno che porta sfiga. Il giudice d’Andrea si strugge sul come risolvere il caso, perché la vittima
c’è sicuramente, però non si può colpevolizzare i primi due che sono capitati male, così decide di
chiamare in casa sua il Chiàrchiaro per convincerlo a ritirare la denuncia. Arrivato, lo iettatore si
presenta proprio conciato come uno iettatore, in volto e nel vestiario, e si comporta come tale,
dicendo di non toccarlo e di non parlargli troppo. Chiàrchiaro fa intendere al giudice d’Andrea che
ha querelato i giovani non per farli condannare, ma perché vuole che il tribunale gli riconosca
ufficialmente il suo potere iettatorio. Vuole insomma avere la patente per poter professare il
mestiere di iettatore e guadagnare portando sfortuna alla gente e facendosi pagare per andarsene,
dato che è senza lavoro e senza soldi.
- Il giudice d’Andrea è ritratto con una maschera espressionistica davvero grottesca e paradossale,
in bilico tra una candida bambola meccanica ed un pupazzetto con una parrucca afro. Anche il
Chiàrchiaro, tuttavia, decide di sua spontanea scelta di mettersi vestiti logori e da pazzo, nonché di
farsi crescere barba e capelli trascurati, da vero iettatore, in una caricatura vivente. Il
comportamento del protagonista è inizialmente creduto comico, poiché fa scattare l’irresistibile
ilarità il fatto che un tizio voglia esser etichettato come portatore di malocchio, eppure, dopo
un’attenta riflessione, la vicenda fa sempre ridere, ma un po’ anche piangere, perché evidenza sino a
che punto il dramma umano di questo personaggio, strozzato ed emarginato dalla società, sia
costretto a spingersi. Il nucleo del brano è quindi il relativismo nel senso della prigione della forma:
considerato da tutti uno iettatore, Chiàrchiaro non riesce più a liberarsi di questa etichetta, tanto da
perdere il lavoro, vedendosi marchiata addosso una maschera terribile, insomma un pregiudizio
sociale. Eppure, con la solita valvola di sfogo che è la pazzia, il protagonista riesce a campare,
volendo sfruttare la sua fama di iettatore e continuare a recitare tale parte, pur di guadagnare
qualcosa per vivere.
Il treno ha fischiato
- In ospedale è ricoverato Belluca, e molti, come l’anonimo protagonista, lo vanno a trovare,
dicendo che ha avuto un attacco di delirio. Del resto era plausibile, poiché Belluca, contabile in una
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 26
grossa azienda, ha sopportato per anni ed anni, a testa bassa ed occhi chiusi, un lavoro sottopagato e
sovrasfruttato, patendo rassegnato una posizione impiegatizia insostenibile. Il giorno prima era
infatti accaduto che non avesse combinato niente per tutta la giornata lavorativa, ed, ai rimproveri
terrificanti del capo-ufficio, che era arrivato a malmenarlo, avesse risposto soltanto di aver sentito
fischiare il treno. Il protagonista arriva allora in ospizio e si rivela essere il di lui vicino di casa.
Racconta di come persino la vita privata di Belluca sia disastrata, vivendo angariato con tre donne,
cioè moglie, suocera e sorella, per giunta cieche, che urlano tutto il giorno, nonché con due figlie,
vedove, ed i rispettivi nipoti, prive di voglia di badare ai bimbi, e dovendo logicamente mantenere
tutte quelle bocche, irriconoscenti ed ingrate, da solo, portandosi anche a casa il lavoro di sera e di
notte. Arrivato in stanza, Belluca racconta al suo vicino di come la notte precedente, sentito
fischiare il treno passante lì vicino, abbia iniziato a vagare colla mente in tutt’Italia, guardando oltre
la sua piccola cittadina, esplorando posti lontani e sconosciuti, vallate e campagne, mari e monti,
città bellissime ed esotiche. Soltanto che si era ubriacato troppo di quel sogno, di quella boccata
d’aria, ed il giorno seguente era ancora rintontito e mezzo pazzo: d’ora in avanti, Belluca sa come
tirare avanti la propria vita, ascoltando il treno che fischia, ma non troppo a lungo.
- Il protagonista è il tipico uomo della crisi novecentesca, costretto per campare ad indossare la
maschera dell’impiegato ed a vivere recitando in silenzio la sua parte, vittima della società, del
lavoro e della sua stessa famiglia. Il fischio del treno, per Belluca, è il famoso momento rivelatorio,
in cui egli si vede al di fuori della sua situazione alienata, si vede vivere, così riscopre il mondo
esterno oltre la sua dimensione privata, familiare o lavorativa, così cupa, angosciante e stretta, ed è
più sereno, viaggiando con l’immaginazione. Questo piccolo tocco di pazzia è una via di fuga che
permette allora a Belluca di continuare a vivere nel mondo in maniera meno infelice (tentando però
di non abusare di ciò, altrimenti rischia un altro attacco come quello narrato). Il comportamento
all’apparenza sembra comico, rivelando la risata che suscita un uomo che ascolta un treno e con
esso delira in viaggio, ma, dopo un’attenta riflessione, si scopre umoristico, poiché continua a far
ridere, ma rivela il tragico dramma dell’infelicità umana che è parte della vita di Belluca.
La carriola
- Il protagonista si presenta, dice di essere un irreprensibile avvocato, commendatore e docente
universitario, gravato dal peso delle sue responsabilità pubbliche, ma anche private, avendo una
famiglia da mantenere e da far rigare diritta, così, nel segreto più assoluto e spaventoso, dice di
doversi sfogare una volta al giorno con una vittima che non può parlare, ma lo guarda con due occhi
terrorizzati. Tornando un giorno da lavoro, si addormenta sul treno, e quando si risveglia, un po’
rintontito, si trova sulla soglia d’ingresso di casa propria: quivi si specchia nella targhetta metallica
che contiene tutti i suoi titoli, ed improvvisamente si vede vivere, si vede fuori da se stesso, fuori
dal suo ruolo sociale, come se ciò che avesse vissuto non fosse stata la propria vita, ma solo una
maschera da indossare, una parte da recitare, rivelando come non sopporti la sua famiglia, i suoi
titoli, il suo lavoro e la sua stessa vita. Entrato in casa, trova ancora tutto al proprio posto, ma ormai
ha capito in che situazione alienante e soffocante sta vivendo, e necessita di essere liberato e di
sfogarsi. Ecco perché, come ha detto in principio, si chiude a chiave nel proprio studio e, in gran
segreto, si vendica con la sua vittima muta: fa fare la carriola alla propria cagnolina, che la guarda
cogli occhi che sembrano comprendere il dramma terribile dell’atto che il protagonista compie.
- La suspese domina tutto il brano, interrotto a metà dall’epifania, dal grande momento rivelatorio
in cui il protagonista si specchia, in un momento banale ed insignificante, in qualcosa e si vede
vivere oltre la sua maschera e la sua forma, dall’alto, comprendendo lo stato di alienazione ed
oppressione in cui vive, recitando soltanto una parte che non è sua, vedendosi sino al profondo della
propria vera anima. Il personaggio risulta dunque come sdoppiato, tra la maschera che si cala
addosso e la prigione della forma in cui la società lo rilega, vittima delle convenzioni sociali e del
ruolo che deve seguire, nel pieno del relativismo pirandelliano, e ciò che invece è l’uomo vero,
incondizionato, che è libero ed autentico: a questo stato, il protagonista approda solo per brevi
istanti, ogni giorno, grazie alla valvola di sfogo della follia, quella con cui si vendica di tutto ciò a
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 27
cui è costretto ed ottiene la sua rivincita, cioè il gioco infantile di far fare la carriola alla sua
cagnetta. La situazione, palesemente comica in superficie, è in realtà umoristica, poiché dietro alla
risata non può che esserci la pietà per il dramma umano che ogni giorno l’irreprensibile avvocato è
costretto a vivere.
Berecche e la guerra
- Il professore di storia Federico Berecche ha un’adulazione immensa per la Germania, la migliore
assoluta nella cultura, nella storia, nell’economia e nel militare, tanto da fingersi spesso tedesco. In
birreria, accusa l’Italia di codardia perché, nonostante la triplice alleanza, nella prima guerra
mondiale non s’è schierata con la Germania, ma è subito zittito da tutti i suoi amici, neutralisti o
addirittura avversi alla Germania ed all’Austria-Ungheria. Berecche abita al limitare del suo
paesino, una via disilluminata e remota, con molti alberi, immersa nella campagna praticamente,
che il professore apprezza molto poiché spesso vi passeggia e pensa: quella sera, pensa a come
andrà a finire questa maledetta guerra mondiale, pensa alla sua vita angosciata (ma, da rigido
tedesco, non se ne lamenta affatto), con un figlio distante che studia lettere a Roma, una moglie che
lo odia ed una figlia cieca e triste. Berecche poi ricorda di come, da bambino, assisteva ai dibattiti
del padre e dei di lui amici sulla guerra franco-prussiana, discussi davanti ad una cartina
dell’Europa con tanto di bandierine d’invasione. Oggigiorno, egli vorrebbe giocarci, prendendo le
bandierine tedesche ed austriache e facendole espandere ovunque, dall’Inghilterra alla Russia.
L’indomani, una notizia sconvolgente arriva in famiglia: i fratelli del fidanzato della figliola cieca,
Gino Vesi, sono morti in guerra, combattendo per l’Austria in quanto Trentini. Tutti in famiglia
evidenziano le prepotenze austriache, tranne Berecche che giustifica la sua amata Austria, assai
adirato, consapevole anche che uno dei suoi figli, quello a Roma, inneggia alla Francia, e non alla
Germania. Chiuso nel suo studio, il protagonista riflette molto, e pensa che, tra molti anni e
generazioni, un nuovo professore di storia parlerà della guerra mondiale, dei grossi imperi di
Germania ed Austria, bestioni enormi ed incontrollabili, e della misera Italia, loro alleata
sottomessa: di tutto ciò, in realtà, rimarranno solo poche e brevi righe nei manuali di storia.
Berecche pensa poi al marito di una delle sue figlie, tale Livio Truppel, svizzero, fa l’orologiaio, è
una persona semplice e genuina, a modo; tuttavia si è visto distruggere dai dimostranti italiani il
proprio negozio, a causa del suo cognome tedesco, e tra tali dimostranti c’era anche un figlio del
protagonista, Faustino. La situazione diventa tragica quando Faustino e pure Gino Vesi non fanno
ritorno a casa per molte notti, finché con una lettera non comunicano alla famiglia di esser andati a
combattere in Francia per far vedere che anche gli Italiani hanno un po’ di coraggio battagliero. La
moglie e la figlia, sua donna, scoppiano in lacrime e deprecano l’atroce guerra, ed anche Berecche
si sente toccato personalmente, per la prima volta. Nei giorni seguenti, proprio Berecche inizia a
ragionare, inizia a concepire l’idea che la sua bella Germania abbia sbagliato ad iniziare una guerra
contro tutto il mondo. Allora, nell’esasperazione generale, di nascosto ed all’insaputa di tutti, il
vecchio protagonista inizia ad equipaggiarsi per partecipare lui alla battaglia: compra un cavallo e
partecipa ad un corso d’equitazione…tuttavia cade rovinosamente e ripetutamente, finché non si
ferisce, finisce in ospedale e starà alla famiglia a riportarlo a casa. Tutto questo, conclude Berecche,
grazie alla sua cara Germania!
- La prigione della forma è il tema cardine di tutta la novella. Il modo in cui Berecche vede il
mondo germanofono è adulatorio, idilliaco, privo di contatto col reale, fissato in un’identità ed in
una categoria stabile ed immutabile. Il modo in cui, invece, sono viste Germania ed Austria dagli
Italiani, è totalmente diverso, bloccati essi in una visione demistificata, maligna ed avversa. Il
problema è che risulta pressoché impossibile cambiare un’opinione cementata e solidificatasi per
tutta una vita, così, se si trovano motivi contrari, li si irride, ci si adira, si risponde sgarbatamente, si
arrivano a brutti atti. È necessario un guazzabuglio del cuore umano, una serie ininterrotta di
drammi e di catastrofi, che toccano pure il personale, per far cambiare forma all’idea positiva che di
Germania ed Austria possiede Berecche. È uno scontro di punti di vista, di visioni parziali e
soggettive, più corretto o meno, e tutta la vita è riducibile a questo: un perenne relativismo. La
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 28
caduta definitiva da cavallo di Berecche sembra quasi il folgore che abbacina san Paolo al galoppo
sulla via per Damasco, e lo converte: benché la palinodia del protagonista sia già iniziata da prima,
a differenza di san Paolo che si cristianizza d’improvviso, il parallelismo è innegabile.
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 29
Davide Savio – Il carnevale dei morti
Il tema della morte attraversa tutta la produzione di Pirandello, dai romanzi alle novelle al teatro.
Infatti, come ha sottolineato Giovanni Macchia nel capitale saggio “Pirandello O La Stanza Della
Tortura”, l’autore: 1) mette in scena dei personaggi che poco hanno a che fare con la vita, dato che
alcuni sono in una condizione sociale tale da renderli morti, altri vivono alienati, reificati e lontani
dalla vita, altri ancora muoiono fisicamente e realmente, oppure muoiono solo in maniera apparente
e presunta, altri infine sono fantasmi, spiriti, non sanno nemmeno di essere mai esistiti; 2) mette in
scena dei luoghi di uscita, cioè soglia tra vita e morte, come manicomi, cimiteri, carceri, uffici di
lavoro, camere ardenti o mortuarie, case ridotte a prigione. Nelle opere di Pirandello c’è allora una
sfilata di personaggi e luoghi dannati, cioè un carnevale dei morti. Questo è il motivo conduttore di
questo libro: la morte.
Dalla sconciatura alla maschera
- Applicando l’espressionismo (finalmente chiarito dallo studio “Pirandello E L’Espressionismo” di
Graziella Corsinovi), Pirandello a volte rappresenta la realtà in maniera troppo sovraccarica, con un
gusto paradossale, deformante, caricaturale, grottesco, nel quale i dati sensoriali di chi percepisce il
reale sono piegati dalla sua interpretazione soggettiva, che dall’interno si proietta all’esterno, sulla
realtà medesima, modificandola. Ne “L’Umorismo” Pirandello usa più volte il verbo “sconciare”,
nel senso di sporcare, così a partire da ciò il critico Giacomo Debenedetti, nel suo celebre scritto “Il
Romanzo Del Novecento”, conia il termine sconciatura, cioè bruttezza imbrattata; dunque,
Debenedetti crea coerentemente la categoria del personaggio sconciato, in accordo con
l’espressionismo pirandelliano, poiché molti personaggi delle opere del Siciliano sono delle
sconciature, cioè hanno la fisiognomia brutta e imbrattata. Infatti, Debenedetti parla dell’“invasione
vittoriosa dei brutti” nella letteratura italiana del Novecento proprio a partire da Pirandello, poiché,
se più correttamente si può dire che i brutti entrano nell’intera letteratura europea con l’età
contemporanea (ossia già con la bohème e la scapigliatura, il naturalismo ed il verismo, ma prima
ancora gli incunaboli si trovano nel romanticismo europeo, dove subentrano i poveri, gli umili, gli
strati bassi), Debenedetti spiega però che nell’Ottocento le deformazioni sono giustificate dal
contesto sociale e storico, dall’esterno insomma, invece nel Novecento sono i fattori interni che si
scatenano all’esterno e deformano grottescamente, in maniera espressionistica, i protagonisti delle
storie.
- In molte lettere, Pirandello pensa di avere il naso grosso, e proprio dall’osservazione del naso si
scatena il romanzo “Uno, Nessuno E Centomila”: questi sono casi compiuti di deformazione
espressionistica, la cui matrice va cercata nel “Tristram Shandy” del romanziere inglese Laurence
Sterne, in cui fa da sottofondo l’idea che dalla grandezza del naso dipenda la grandezza della
persona. Ma come Pirandello sia giunto all’idea dell’espressionismo, che poi ha portato alla
sconciatura, è lungo spiegarlo. L’origine di tale modus va ricercata nella ritrattistica di Leonardo da
Vinci, uno dei primi pittori a porre la psicologia nei dipinti, grazie alla sua teoria dei “moti
mentali”, per la quale la psiche dei personaggi si esprime nell’espressione dei loro volti,
somatizzandosi. Il passaggio alla caricatura, invenzione del Seicento, è allora molto breve. Ma il
clou si ha nell’Ottocento, quando il positivista Cesare Lombroso afferma addirittura che i tratti
somatici del volto dipendano dall’indole interiore, che li ha deformati, ed in tal modo crede
facilmente distinguibili i criminali in base alla conformazione del cranio. A metà XIX secolo si
colloca Honoré de Balzac, l’autore realista della “Comédie Humaine” (che tanto ha influenzato
naturalisti e veristi): i suoi personaggi hanno tratti somatici rovinati e distrutti, in cui si colgono i
segni della devastazione sociale. Un naso d’eccezione deriva dal “Caso Di Emilio Roxa”, una
novella di Capuana, dove l’anomalia del naso diviene punto di partenza di un ragionamento per la
rivelazione dell’oltre. Insomma, da un lato basta esagerare un piccolo particolare del corpo perché
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 30
esso rovini totalmente e interamente la figura di una persona, dall’altro quell’insignificante
particolare è la scintilla che innesca ragionamenti sulla comprensione del tutto.
- Nelle prime novelle pirandelliane, ad esempio la primissima del 1884, “Capannetta”, non c’è
alcuna traccia di sconciatura, al massimo i personaggi sono un po’ caricaturali. La prima
sconciatura pirandelliana è allora nella novella “Il no di Anna” del 1895, dove Mondino, il più bello
del paese, non si accorge dell’amore per lui di Anna, convinto di poter avere di meglio; passa però
la vita ad avere rifiuti, e da vecchio decide di accettare le effusioni dell’ormai anziana Anna, ma
questa lo rifiuta a sua volta: Anna è descritta come decrepita ed imbruttita, sta morendo di morte
naturale ed ha passato tutta la vita a morire dentro per Mondino. Da questa novella si capisce che il
modo migliore di sconciare, cioè di imbruttire, i personaggi, è proprio la morte: Pirandello la
chiama “toccatina”, un tocco della morte (è il colpo apoplettico) che in realtà non ti ammazza, però
ti imbruttisce in uno stato in bilico tra vita e morte. Le toccatine arrivano ai protagonisti di
moltissime novelle, una su tutte quelli de “La toccatina”, novella per antonomasia, i cui protagonisti
sono vittime di un colpo apoplettico che li rende paralitici e ritardati.
- La sconciatura, in generale, è una bruttezza imbrattata; tuttavia, ci sono alcune precise constanti
dei personaggi sconciati: 1) si accorciano e, più spesso, si allungano, in una sproporzione grottesca
e paradossale (come accade anche ad oggetti quali le cassapanche, che, allungandosi, ricordano le
bare, tipo ne “L’illustre estinto”); 2) cambiano colore, dal rubicondo paonazzo e rossiccio (si veda
“La toccatina”) sino al pallore biancastro della cera e del marmo (non a caso si arriva ad essere
rigidi come cadaveri, in stato di rigor mortis, si veda “La paura del sonno”).
- A tal proposito, nei primi esperimenti poetici, come in “Pasqua Di Gea”, Pirandello ha parlato
delle larve, cioè degli spettri, dei fantasmi, di immagini candide e pallide, tipiche della letteratura
classica, ma riprese anche da Dante e dallo stilnovo, che indicano le illusioni della vita. Queste, da
essere semplici illusioni intangibili, man mano nel pensiero dell’autore prendono forma concreta, e
divengono le maschere illusorie che le persone indossano, le quali deformano grezzamente il volto
di chi le indossa, come un’illusione resa tangibile.
- “La scelta”, uscita su Ariel, racconta di quando i bambini di Agrigento ricevono i regali andando
alla fiera, in cui il piccolo Luigi Pirandello, accompagnato dal suo maestro Pinzone, finiva sempre
davanti alla bancarella delle marionette; ora, Pirandello adulto si reca sempre presso quella
bancarella, ma non in cerca di pupi, bensì di personaggi. Il passaggio da deformazione
espressionistica, da sconciatura, da larva, sino al pupo, cioè al burattino, alla marionetta (che in
Sicilia ha una lunga tradizione risalente all’alto medioevo, infatti tutti questi fantocci si usano nelle
storie dei paladini di Carlo Magno e del ciclo carolingio-francese, in lotta contro gli infedeli
saraceni), è molto breve, poiché l’espressionismo è tale da essere uscito dalla persona stessa ed
essersi trasformato in una maschera da indossare, una forma fittizia attribuita dalla società o dalla
persona a se stessa, vittima del relativismo che le convenzioni sociali impongono, costretta ad
essere ciò che di lei si crede o ciò che vuol far credere. Ecco perché allora le persone sembrano tutte
fatte di legno o di pezza, che si scheggiano, si sciupano, si staccano e si ricuciono, hanno occhi
biechi e di vetro (sembra l’assicuratore in “Formalità”). La deformazione espressionista, la
sconciatura o il pupo, la maschera insomma, è sintomo della crisi epocale del Novecento, in cui
l’uomo, alienato, vittima del relativismo e dell’umorismo, ha perso qualsiasi fondamento.
Vita e morte della maschera
- Un importante tema affrontato da Pirandello ne “L’Umorismo” è il relativismo. Per l’autore, il
mondo e l’esistenza sono un “flusso continuo”, cioè un movimento fluido ed un continuo divenire,
in cui tutto si trasforma e non sta fermo in canoni costanti: il caos primordiale, prima della
fissazione delle regole, è allora vita, poiché fa pensare mondo ed esistenza come qualcosa di libero
ed incondizionato. L’uomo invece cerca, dentro a questo flusso, di trovare delle costanti, di fissare
l’essenza delle cose e delle persone, di attribuir loro un’identità stabile, ma ciò è un’azione sbagliata
ed arbitraria, mortificante, basata sul punto di vista parziale di chi giudica e sulle circostanze
particolari in cui si è conosciuta una realtà, quindi si creano delle finzioni che non sono la verità
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 31
oggettiva ed assoluta (la quale rimane inconoscibile), ma un punto di vista soggettivo (infatti uno
stesso ente, visto da più punti, può essere Tizio, Caio e Sempronio), inoltre, così facendo, si
rilegano le cose e le persone in una “prigione della forma”, in una “maschera” che viene imposta o
che ci si autoimpone, dalla quale poi è impossibile uscire. L’idea della vita come flusso perviene
probabilmente dalla “durée” del filosofo francese Henri Bergson; la scomposizione molteplice delle
personalità in un singolo individuo deriva invece dallo psicologo francese Alfred Binet, autore de
“Les Altérations De La Personnalité”; la querelle sul relativismo, va segnalato, è molto accesa a
quel tempo, avendo scoperto il tedesco Albert Einstein da poco le leggi scientifiche sulla relatività
ristretta; infine, la diatriba tra realtà ed apparenza, ossia tra ciò che è veramente, cioè da un punto di
vista oggettivo, e ciò che sembra alle persone, cioè da un punto di vista soggettivo, deriva dal
pensiero del tedesco Arthur Schopenhauer. È chiaro, a conclusione, che il relativismo consiste nel
fatto che: 1) le realtà possiedono identità diverse a seconda di chi le osserva, poiché tali identità
sono solo verità soggettive che esistono negli occhi di chi le guarda; 2) solo il flusso incondizionato
è vita, invece la forma attribuita è morte.
- Tuttavia, è possibile riuscire a raggiungere uno stato di esistenza privo di maschere, al di fuori
della prigione della forma: è quello che accade a Mattia Pascal, “forestiere della vita”, ma anche a
Serafino Gubbio, che osserva distaccato attraverso un obiettivo, ed anche a Vitangelo Moscarda,
alla fine del suo romanzo. Se non si raggiunge per sempre tale condizione, per lo meno si può
raggiungerla in alcuni momenti, rari ed inconsueti, che accadono nel quotidiano, banali ed
insignificanti, quasi coincidenti colle “epiphanies” di James Joyce e colle “intermittences du coeur”
di Marcel Proust, tipiche del modernismo europeo, in cui appunto all’uomo è concesso cogliere il
mondo proprio ed altrui spogliato dalle convenzioni e dalle relazioni fittizie entro cui conosce
abitualmente la propria e l’altrui esistenza, e di venire a contatto con la verità oggettiva e la propria
vera identità, diventando maestri del disincanto, con una visione oggettiva, distante e distaccata. In
questo momento rivelatorio, l’uomo si vede vivere, si specchia in qualcosa, si vede di riflesso oltre
la propria maschera, in maniera irrazionalistica. Si diviene insomma delle “Maschere Nude” (titolo
della raccolta delle opere teatrali di Pirandello), un forte ossimoro che indica che ci si è tolti la
maschera e si è usciti dalla prigione della forma. Non a caso, nella novella “La vita nuda”, quando
un artista deve scolpire un monumento funebre con rappresentate la vita e la morte, la committente
strepita ardentemente affinché la donna che rappresenta la vita sia “nuda, nuda, nuda!”, poiché il
flusso vitale, che rappresenta la verità, è privo di vestiti, di maschere, di forme, di convenzioni
fittizie. Non a caso, nella novella “Il tabernacolo”, ad un povero scultore è commissionato un
tabernacolo con l’ecce homo (è l’episodio giovanneo in cui Ponzio Pilato mostra agli ebrei che
Gesù è stato flagellato, come da loro richiesta) da un ricco notaio anticlericale, ma quando arriva il
momento del pagamento, il notaio muore, ed i suoi eredi non pagano lo scultore perché sembra
impossibile che il notaio, avverso alla religione, abbia ordinato un tabernacolo: per ribellione,
l’artista si denuda e si mette a fare il cristo flagellato nel suo tabernacolo, mentre tutti i compaesani
vengono a vederlo; si è dunque spogliato della propria maschera ed ha rivelato ciò che è realmente:
un pazzo maltrattato e povero.
- Qual è però il modo di togliersi la maschera, di uscire dalla forma? È un pizzico di follia, è un po’
di pazzia, è l’essere matto. È quello che accade nella novella “Quand’ero matto”, dove la bontà
gratuita del protagonista c’è solo nella sua fase di folle. È lo stesso tocco di pazzia che avviene in
“Uno, Nessuno E Centomila”, poiché solo grazie ad essa Vitangelo, alla fine del romanzo, è felice.
È la situazione, privata e nascosta, del protagonista de “La carriola”, che si chiude in studio per
giocare assurdamente colla cagnolina. Ma questa pazzia può avere anche l’estrema variante del
suicidio o peggio dell’omicidio, ultimo e radicale gesto liberatorio dalla prigione della forma. Nella
novella “Candelora”, la moglie Candelora, per procurare mecenati a suo marito, pittore, si
prostituisce, ma, avendo deciso di smettere, non riesce a levarsi la nomea di escort, e, per uscire da
quella maschera, si suicida inghiottendo veleno. In “Sole e ombra”, il protagonista, un exgaribaldino, deluso dall’Italia unita, che ha tradito i valori del risorgimento, si getta nel mare per
galleggiare ed ingerisce veleno. In “La casa dell’agonia”, il protagonista è il tipico personaggio
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 32
sconosciuto, di cui non si sa nulla, con una fisiognomia sconciata, bloccato in casa ad attendere un
ospite che non verrà mai, così, nel silenzio, si identifica con i mobili e gli oggetti del salotto, e si
sente morto dentro: per uscire da ciò, decide, nel momento in cui un gatto sta facendo cadere un
vaso di fiori, di gettarsi sotto di esso e morire. Il protagonista di “Soffio” acquista la consapevolezza
di poter uccidere le persone semplicemente soffiandosi tra le dita. In “La trappola”, il protagonista
vive angariato da cavilli filosofici e vive con un padre in stato vegetativo, e sul finale pensa di dar
fuoco alla casa per uccidere sé ed il padre, liberando entrambi. In “La toccatina”, il protagonista,
inizialmente, avrebbe preferito sparare al suo amico ed a se stesso, dato che entrambi hanno subito
un colpo apoplettico e sono paralizzati dentro una vita da handicappati. In “La tragedia d’un
personaggio”, il protagonista accoglie in casa propria i personaggi dei suoi futuri racconti, e li libera
mettendoli in storie in cui poi li fa morire.
Il doppio
- Il tema del doppione e dell’alter ego (un classico della letteratura occidentale, canonizzato a
partire dallo studio psicanalitico di Otto Rank, titolato “Il Doppio”) deriva a Pirandello da
quell’ironia sdoppiante, cioè che pone le persone e le cose da un punto di vista straniato, incontrata
in molti autori romantici tedeschi al periodo dell’università di Bonn, come Heinrich Heine, Adalbert
von Chamisso, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann e Ludwig Tieck. Tale tema è funzionale al suo
umorismo ed al suo relativismo, perché essi hanno a che fare con il limite tra apparenza e realtà, tra
come si sembra e come si è, dando l’idea d’una doppia ottica rispetto al singolo ente, idea che si
tramuta nella duplicazione dell’ente stesso.
- La liberazione dalla vita pesante è ricercata da Pirandello medesimo, il quale vive con un tocco di
pazzia, ma, pur avendoci pensato più volte, come rivelano le lettere, non arriva mai al suicidio
(nonostante le sventure della propria vita): la sua liberazione avviene tramite i propri personaggi, i
quali, con l’umorismo ed il relativismo, vivono ingabbiati in situazioni paradossali e con addosso
una maschera limitante, ma riescono in gran parte a sopravvivere, grazie al solito pizzico di follia. I
personaggi pirandelliani allora sono suoi doppioni, alter ego di Pirandello, che lo aiutano a liberarsi
dalla vita pesante, come ben ha messo in chiaro Jean-Michel Gardair nello studio “Pirandello E Il
Suo Doppio”.
- Un primo tema del doppio si trova sotto forma di doppio fotografico, ossia piazzato nelle
fotografie, privo di qualsiasi deformazione, sconciatura o maschera, in cui chi è fotografato è come
se tornasse vivo e divenisse motivo di beffa per chi lo guarda. In “La buon’anima” il defunto primo
marito di una donna, che ricorre nelle foto di casa e persino dentro il monile alla collana, irrita il
secondo marito al tal punto da convincerlo a tradire la moglie. In “La maestrina Boccarmè”, la
maestrina vive nel ricordo della gioventù, in specie d’una storia d’amore avuta con un uomo di cui
venera la foto, ma presto viene a sapere da una vecchia amica che tale foto l’uomo la dà a tutte le
donne con cui ha fatto sesso, così ne distrugge l’effigie. In “Pena di vivere così”, un marito,
mortagli la seconda moglie, torna dalla prima, ma questa scopre nel cassetto un album di foto della
seconda moglie, capendo di esserne solo uno squallido surrogato.
- Un secondo tema del doppio si trova sotto forma di doppio pittorico, cosa che ricostituisce un
topos letterario dell’Ottocento, quello del living portrait: un ritratto prende vita e riflette l’anima di
chi lo guarda, come avviene nelle opere “Il Castello Di Otranto” di Horace Walpole,
“L’Antiquario” di Walter Scott, “Il Ritratto Ovale” di Edgar Allan Poe, “La Caffettiera” di
Théophile Gautier, “Gli Elisir Del Diavolo” di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann ed “Il Ritratto Di
Dorian Gray” di Oscar Wilde. Pirandello usa il living portrait nel teatro, dentro il suo “Enrico IV”,
in cui un attore caduto da cavallo si convince di essere l’imperatore Enrico IV di Germania che in
quel momento stava impersonando per una battuta di caccia in maschera: tale personaggio ha come
doppione un quadro che lo ritrae proprio mentre è vestito da Enrico IV, dunque è lui stesso una
persona che prende vita da una tela, tanto che in nessun punto dell’opera compare il suo nome reale
ed anagrafico, come se la sua esistenza appartenesse solo all’oltre pittorico. Nell’ultima novella
pirandelliana, “Effetti di un sogno interrotto”, il centro del racconto è un quadro della Maddalena, la
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 33
quale è identica alla moglie defunta di un forestiero che, vedendo la tela, la vuole, ma il proprietario
del quadro non può venderlo e così si attira le ire del forestiero: di notte, il proprietario sogna il
forestiero e la Maddalena che si tengono per mano, poi si sveglia bruscamente, e l’indomani
incontra il forestiero vestito cogli stessi vestiti che aveva visto in sogno.
- La danza macabra è un topos pittorico squisitamente basso medievale, in cui uomini
(simboleggianti la vita) e scheletri (simboleggianti la morte) ballano assieme, con funzione di
memento mori, cioè di far ricordare che prima o poi bisogna morire. Nella danza macabra, gli
scheletri risultano i doppioni degli uomini vivi, i quali sono consapevoli di dover morire e divenire
scheletri. Nella novella “La morta e la viva”, un uomo sposa una donna, ma questa è creduta
dispersa, così ne sposa la sorella, ma presto la donna torna in famiglia, così il marito si ritrova due
mogli e fa un sacco di figli: la morte apparente ha funzione di beffa, ma concorre come memento
mori e fa vivere assieme i vivi ed i morti.
- Il fastidioso insetto chiamato mosca ha un connotato simbolico marcatissimo in Pirandello: stando
e nascendo dove c’è putrido di cadavere, ella, svolazzando qua e là, tocca persone che sono morte
dentro, psicologicamente, oppure a breve moriranno proprio fisicamente. Nella novella “Un po’ di
vino”, un figuro alto e vecchio, ma cadaverico, è fatto accomodare da un ragazzo giovane, come se
facesse sedere un fantoccio, e su questi inizia insistentemente ad inveire una mosca, che il figuro
non scaccia con la mano, poiché è già morto: il narratore spiega proprio che le mosche toccano chi è
in procinto di morire, e non può nemmeno alzare le mani per scacciarle. In molte altre novelle le
mosche tornano, ed anche in Vitangelo Moscarda, il protagonista di “Uno, Nessuno E Centomila”,
nel suo stesso nome.
Il fantastico pirandelliano
- Come ha chiarito Italo Calvino, Pirandello è stato il primo ad introdurre, seppur vagamente, una
tematica che si può definire “fantastica”, la quale non c’entri però col gotico, col misterico e col
meraviglioso d’ascendenza romantica nordica, nella letteratura italiana. C’è da dire che le basi della
sua ironia sdoppiante derivano proprio da autori romantici tedeschi, portatori della fantasia nordica,
come il romanzo “La Meravigliosa Storia Di Peter Schlemihl”, di Adalbert von Chamisso, in cui il
protagonista vende l’ombra al diavolo in cambio di una borsa magica da cui estrarre infinite
ricchezze, o “Gli Elisir Del Diavolo”, di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, la storia inquietante di
un monaco che crea, da una Venere dipinta, un suo doppione infernale con cui celebrare riti pagani.
Eppure, partendo da ciò, Pirandello elabora una visione del mondo allucinata, appunto fantastica,
grazie anche all’espressionismo che permette di modificare la realtà che circonda l’uomo in base
alla propria percezione. Il fantastico pirandelliano è allora conturbante, cioè fatto di ombre e di
sogni; ecco perché, nelle storie pirandelliane, la realtà risulta piena di morti. A ciò concorre la
“Divina Commedia”, a lungo studiata dal Siciliano, su cui ha abbozzato anche degli studi,
considerandola un viaggio fantastico ante-litteram, dove le anime sono ridotte ad ombre trasparenti
ed il corpo tangibile di Dante è visto come anomalo. A ciò potrebbe concorrere il platonico mito
della caverna, citato direttamente da re Lear, dentro un saggio pirandelliano, quando il re denuncia i
filosofi che hanno fatto accorgere l’uomo della sua piccolezza: Platone, nel mito della caverna,
afferma che l’uomo vive al buio dentro una grotta e vede solo le ombre delle realtà, che stanno
all’esterno illuminate dal sole. Di conseguenza, sono le ombre, simbolo del fantastico, che l’uomo
vive tutti i giorni, e null’altro, poiché in realtà l’uomo vive un perpetuo sogno, da cui non si sveglia
se non al momento della morte.
- Le “Novelle Per Un Anno” che vanno dal 1931 alla morte di Pirandello rivelano una diversità
d’impianto e di tono, che ha indotto i critici a parlare di una fase surrealista, metafisica, insomma
fantastica, della produzione. In realtà tutto si spiega con l’avvicinamento dell’autore a Massimo
Bontempelli, che ha fatto parte dell’esperienza del Teatro D’Arte, e con la lettura del romanziere
Franz Kafka: è palese dunque l’adesione al loro realismo magico. A parte una drastica riduzione del
dialogo e delle parti riflessive ed argomentative in favore del monologo, nonché un limitato ed
accorto uso dei vocaboli, seppur sempre in un registro medio, i racconti trattano il viaggio, spesso
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 34
allucinato, del protagonista nella propria interiorità o nella propria interpretazione degli eventi
quotidiani, con una percezione turbata della realtà e delle persone, dettata dallo stupore di chi
distingue a fatica dal sogno e dalle ombre.
- È il caso della novella “L’uscita del vedovo”, in cui il marito vive bloccato in casa in un
matrimonio infelice che gli succhia tutta l’energia, e solo alla morte della moglie tenta di svegliarsi
dal sonno e dalle ombre, ed, uscito di casa, incappa in un’avventura con una prostituta, eppure,
anche volendo, non riesce a togliersi la maschera di morto che vive nel sonno tra le ombre, così non
fa sesso con lei. È il caso di “Visita”, in cui la signora Wheil, appena morta, torna a far visita al
protagonista per potergli parlare del loro primo incontro, e questi non riesce a capire se sta
sognando o no, se la donna è vera o è un’ombra; tale novella è interessante perché mostra analogie e
parallelismi con una particolare traduzione italiana fatta dell’opera “Donna Di Picche” del
romanziere russo Puskin, dove una contessa che custodisce il segreto per vincere alle carte, appare
in sogno da morta al protagonista, e gli svela tale segreto. Non manca il tema del fantastico anche
sottoforma di spiritualismo e di occultismo, del resto concetti chiave del decadentismo e già molto
cari a Capuana, dentro molte novelle pirandelliane e dentro “Il Fu Mattia Pascal”, dove Anselmo
Paleari è proprio studioso dell’occulto e della teosofia, e Mattia-Adriano prende parte a molte
sedute spiritiche organizzate in casa dal Paleari.
La morte dell’autore
- Pirandello evita la propria morte anzitutto grazie ai suoi doppioni, cioè i suoi personaggi, in cui si
riflette e che fa liberare con un tocco di pazzia, la quale è una valvola di sfogo. Ma il Siciliano evita
il problema della propria fine anche in un secondo modo, ossia velocizzando il tempo dei propri
racconti, come per esorcizzare ciò che spaventa inculcandolo in uno spazio letterario. È ciò che
accade in una novella della fase fantastica, molto tarda, cioè “Una Giornata”, dove il protagonista
rivive tutta la vita in un solo giorno: rimasto senza memoria, è riconosciuto da tutti, trova la
famiglia e dorme con la moglie, ma l’indomani mattina, vedutosi allo specchio, è improvvisamente
vecchio, e non capisce ancora se è realtà o incubo. Il terzo modo di Pirandello per esorcizzare la sua
morte rientra ancora nella categoria del primo, ossia ha a che fare coi propri personaggi: stavolta
però, non è il conceder loro un briciolo di pazzia, ma è il mandarli a morire, liberandoli
definitivamente e con loro esorcizzando la propria morte, come se l’autore fosse un mago, un
demiurgo, un negromante che evoca le anime, cioè crea i personaggi, per poi avere il potere di
ucciderle, salvando se stesso. Infatti, in accordo col tema del doppio, tutti temono un po’ la propria
immagine, la propria ombra, il proprio riflesso sullo specchio, e, se inizialmente si guardano con
narcisismo, finiscono poi per sfogare la rabbia, che provano, repressa, per se stessi, sul proprio
doppio, uccidendolo. È questo il caso proprio de “Il Fu Mattia Pascal”, in cui Mattia suicida
Adriano lasciando i suoi oggetti lungo un ponte tiberino.
- Due sono i luoghi cardine delle opere pirandelliane, ossia la Sicilia, isola arida ed infuocata,
coperta di zolfo e polvere, colta in una dimensione arcaica e folkloristica, quasi terra del mito e
della superstizione, abitata dai contadini; e Roma, priva di monumenti e ritrovi mondani, senza
sfarzo bizantino o politica, ma concepita come burocratica ed impiegatizia, teatro angusto, grigio ed
asfissiante delle esistenze anonime e meschine nella modernità, abitata da piccoli borghesi.
- Leonardo Sciascia ha detto che, per Pirandello, la sua Sicilia è una “Spoon River mediterranea”; la
celebre “Antologia Di Spoon River” (1915) è una raccolta di poesie del poeta americano Edgar Lee
Masters, in cui ogni lirica racconta, in forma di epitaffio funebre, la vita di una delle persone sepolte
nel cimitero di Spoon River, in cima ad un colle, un piccolo paesino immaginario degli US.
Pirandello e Masters nemmeno si conoscono, ma la vicinanza è chiara, poiché anche Masters prima
libera i suoi personaggi con la morte (Pirandello li direbbe maschere nude), dopo li fa raccontar di
sé. Uno dei luoghi chiave per Pirandello è allora il cimitero, sede della morte come pazzia che dà
liberazione, presente soprattutto in collina, sulla cima di un colle, in una dimensione verticale
insomma, dentro molte novelle, come “Prima notte”, dove una giovane coppia di sposini, nella
prima notte di nozze, si reca al cimitero a compiangere ciascuno il rispettivo amore, morto e
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 35
sepolto, cioè il padre di lei e la prima moglie di lui, e come “La corona”, dove un vecchio dottore si
sposa con una ragazza che ha la metà dei suoi anni, la quale è in realtà ancora innamorata di un
giovane morto anni prima, sulla cui lapide sempre si reca. Ma si va oltre, perché Pirandello ed i suoi
protagonisti divengono come i guardiani dell’aldilà, potendo lui creare personaggi, cioè evocare dei
morti viventi, per poi farli uccidere: è un “figlio del Caos”, in riferimento alla contrada d’Agrigento
da cui è nato, ma questa definizione è una citazione del “Faust” di Goethe (“des Chaos Sohn”),
dunque Pirandello è anche il diavolo, è Mefistofele, è un negromante. Un altro luogo importante
nelle novelle è l’uscita del paese, caratterizzata dal silenzio, dal mare o dalla campagna, in cui
spesso i protagonisti si addentrano tramite un lungo viale, insomma un piano orizzontale, come in
“La morta e la viva”, dove un uomo sposa una donna, ma questa è creduta dispersa, così ne sposa la
sorella, ma presto la donna torna in famiglia, ed inizialmente tale prima moglie è ospitata in una
cameretta in affitto al limitare del paese, o come in “L’uscita del vedovo”, dove il marito vive
bloccato in casa in un matrimonio infelice che gli succhia tutta l’energia, e solo alla morte della
moglie tenta di redimersi, ed, uscito di casa, arriva al limite del paese oltre un lungo vialone, ed
incappa in un’avventura con una prostituta, o come in “Berecche e la guerra”, in cui lo stesso
Berecche abita in una via buia ed isolata, in mezzo alla campagna, nel fondo del paese. Ma si va
oltre, perché questo limitare, questo concetto di soglia, rappresenta la dialettica alternata al limite
relativistico tra realtà ed apparenza, nonché al limite umoristico tra ridicolo e tragico.
- Per Pirandello, la morte come liberazione coincide molto spesso, nei racconti ma anche nei
romanzi (quando ne “I Vecchi E I Giovani”, muore Salvo, quando in “Uno, Nessuno E Centomila”
muore Vitangelo, quando nella novella “Soffio” il protagonista si suicida, quando in “Di sera, un
geranio” l’anima sta per dissolversi), con la visione di un paesaggio agreste ed idilliaco, con il
recarsi verso la campagna, quasi fosse un back to origins, un ritorno alle origini, al suo paesino
siciliano, quindi ad un ruolo al di fuori della forma, ancora caotico ed incontaminato, dunque
autentico.
- Nelle sue ultime volontà, Pirandello ha chiesto una morte silenziosa, senza notizia alcuna, e
l’arsura del proprio cadavere colla dispersione delle ceneri: nessuno degli eredi avrà il coraggio di
fare ciò, così si organizza un funerale e le polveri sono raccolte in un’urna.
- In molte poesie giovanili, soprattutto quelle di “Zampogna”, Pirandello cita insistentemente la sua
volontà di essere un albero, in quanto esso vive, ma non si sente, dunque sarebbe l’ideale doppio
dell’autore, poiché privo della poetica umoristica e della prigione della forma. Infatti, nella novella
“I due giganti”, sono descritti un pino ed un cipresso centenari, isolati verso il cielo, ai quali
corrispondono i due giganti protagonisti della novella (che, velatamente, sono due innamorati, ossia
Pirandello e la sua fidanzatina all’università di Bonn, tale Jenny), e che, formalmente, costituiscono
la parola IO, cioè I (il pino, snello) ed O (il cipresso, bombato). Pirandello stesso è stato per tutta la
vita molto affezionato ad un pino nella sua vecchia contrada del Caos ad Agrigento, e proprio lì di
fianco, nella sua casa natia, è sepolto.
Scribamates thinking good, feeling better!
Pagina 36