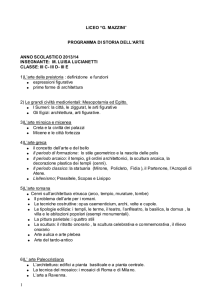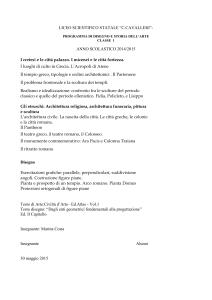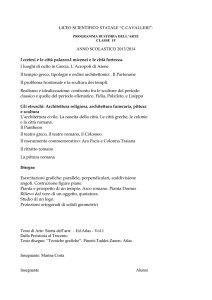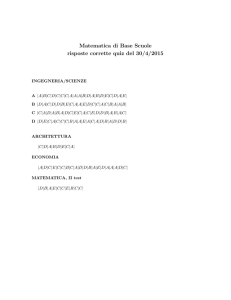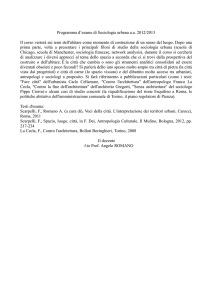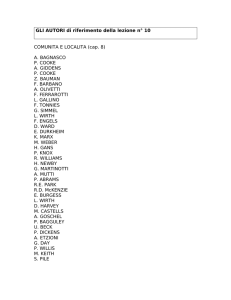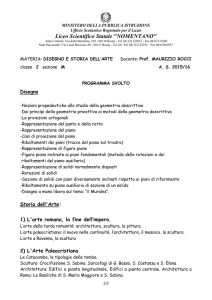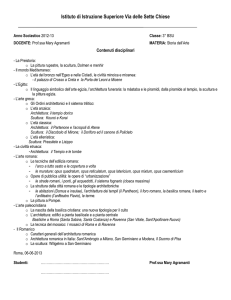FULVIO IRACE
Politecnico di Milano
METROPOLIS *
“Alla scultura ormai non resta come futuro che il campo urbano e sociale, e la
misura e i modi che ne conseguono”. Francesco Somaini
In un appunto senza data (ma certamente scritto attorno al 1974) custodito,
insieme a tanti altri fogli di disegni e di pensieri, tra le carte d’archivio, Francesco
Somaini abbozzava una stringata autobiografia, assai prossima però, per modi e
contenuti, al messaggio di un possibile manifesto. “Dal 1970 – annotava – con
disegni e scritti ed un libro con Enrico Crispolti ‘Urgenza nella città’ […] credo di
aver messo a fuoco, oltre che una critica, la tipologia di una progettazione
plastica urbana con un arco che va dall’intervento preesecutivo sino
all’immagine contestatoria. Dal 1974 ho scelto come medium espressivo a
questo fine il fotomontaggio.” L’annotazione contiene insieme un consuntivo e
un programma: “il contenuto di un messaggio urbano e le sue implicazioni
sociali postulano uno specifico di più vasta risonanza, atto ad incontri su una
scala più ampia di quelli forniti dai circuiti privilegiati tradizionali dell’arte”.
I primi anni settanta sono per Somaini densi di riflessioni, testimoniate da fitti e
numerosi appunti manoscritti in cui egli riversa, con la foga di annotazioni
subitanee, pensieri, studi e propositi da far poi confluire in una più pacata e
argomentata redazione: se non scientifica, certamente icastica e definitiva. Un
manifesto in fieri, insomma, in bilico sul confine labile che in quel decennio
turbinoso metteva in discussione la separatezza delle discipline, avocando più
stretta cooperazione tra scultura, architettura, paesaggio.
Non è la sua una posizione isolata, giacché per tutto il decennio precedente crisi
dell’arte e crisi della città erano state il sottofondo comune al generale stato di
insoddisfazione e malessere che aveva alimentato l’insorgere inaspettato e
virulento del pensiero utopico e della ricerca di possibili vie d’uscita. A partire
dall’“anarchitettura” con cui Gordon Matta-Clark commentava fallimenti e
disastri dell’architettura richiamando i diritti dell’anarchia, negli anni della land
art e dei movimenti “radical” si configurano infatti nuovi format professionali: e
se gli architetti si imparentano e si ibridano con gli artisti accogliendoli nelle loro
fila o cooptandone le modalità operative, non sorprende che gli artisti escano
dal guscio delle gallerie con l’ambizione di misurarsi con l’ambiente. Alla crisi
della scultura come oggetto chiuso in sé corrisponde quasi simmetricamente
quella dell’architettura come professione al servizio delle tecniche. Entrambe
sentono di dover oltrepassare un limite, di dover intraprendere un viaggio di
riscoperta che ridia una prospettiva e un senso a posizioni e attività
sclerotizzate.
Primo e comune punto di partenza è la critica alla città moderna e
l’insoddisfazione verso quello stile internazionale che ha disseccato l’utopia delle
avanguardie del primo Novecento nella formulazione burocratica di una
tecnologia al servizio del capitale. Si tratta di un’onda lunga, avviata dalla messa
in mora dell’idea di “modernità classica” e perseguita poi dal movimento
discontinuo ma incalzante di messa a punto di nuovi strumenti, di nuove
prospettive per superare d’abbrivio un’impasse più che storica, epocale. La
soluzione non poteva essere trovata entro le istituzioni; andava sollecitata
nell’ambiente urbano, perché la prova più evidente del fallimento erano proprio
le distorsioni della metropoli, che in America Jane Jacobs aveva evidenziato con
grande successo nel suo capolavoro del 1961, Vita e morte delle grandi città.
Sostenitrice di una radicale revisione del modello di sviluppo urbanistico delle
città moderne incentrate sulla scala del traffico e dunque ostili alle
manifestazioni della vita di relazione, Jacobs non a caso è uno degli autori su cui
maggiormente si accentra l’attenzione di Somaini, che tuttavia annota ai margini
dell’edizione italiana del 1969: “giusto, ma troppo intimistico”. Come vedremo,
infatti, per Somaini la disumanizzazione della metropoli contemporanea non può
essere combattuta con il rifiuto della grande città. Al contrario, accettandone
come irreversibile e insopprimibile la “forza attrattiva”, bisogna imparare a
canalizzarne la potenza deviandola nella “forza d’urto” di una nuova tensione
estetica.
Non si tratta nel suo caso di posizioni improvvisate, ma anzi di scelte
conseguenti un impegno silenzioso e ostinato di sistematica ricognizione nella
vasta letteratura scientifica nell’ambito soprattutto della sociologia e
dell’antropologia urbana che l’industria editoriale in quegli anni mette a
disposizione del lettore italiano: la lista è lunga, ma tutt’altro che casuale, e la
frequentazione della biblioteca dello scultore riserva a studiosi e ricercatori
molte sorprese. Punto di partenza – e testo di riferimento per l’intensa
frequentazione – è La città nella storia di Lewis Mumford (di cui l’artista
possiede l’edizione del 1967); ma la lista si allunga a comprendere, tra altri,
Henri Lefebrve (Il diritto alla città, 1970), Alexander Mitscherlich (Il feticcio
urbano), Michel Ragon (La cité de l’an 2000, 1968), Aldo Rossi (L’architettura
della città, 1970), Carlo Aymonino (Origini e sviluppo della città moderna, 1965),
Jane Jacobs (Vita e morte delle grandi città, 1969), Clarence S. Stein (Verso
nuove città per l’America, 1969), Willy Hellpach (L’uomo della metropoli, 1960),
oltre a due classici d’inizio secolo: Città in evoluzione di Patrick Geddes, nella
traduzione italiana del 1970 per Il Saggiatore, e La città lineare di Arturo Soria y
Mata, pubblicato in traduzione italiana dalla stessa casa editrice nel 1968.
La sua sembra più la biblioteca di un architetto impegnato che quella di un
artista: non a caso Somaini stesso si definisce “operatore estetico, scultore,
compagno di via dell’architetto”. Le sue letture sono avide e metodiche e,
soprattutto, tutt’altro che estemporanee: inseguono con precisione una linea a
cavallo tra urbanistica, storia, psicologia ambientale, antropologia e sociologia.
Somaini è lettore vorace ma selettivo: le pagine dei testi della sua biblioteca
sono intarsiate di sottolineature che mirano a isolare nel flusso del
ragionamento punti chiave da trasformare in punti d’azione: impressionante
l’intensità con cui chiosa pagine e passaggi con riflessioni e commenti attinenti
alla sua specificità. Sulle pagine di Una città più umana di Hans Paul Bahrdt
(nell’edizione De Donato, 1960) annota: “non critica al concetto della grande
città come operato dalla critica conservatrice ma da un lato affermazione della
necessarietà e ineluttabilità della grande città e dall’altro percezione e
figurazione della sua tragicità immanente di oggi”.
Legge con partecipe attenzione Teorie e storia dell’architettura, il rovente saggio
in cui Manfredo Tafuri faceva tabula rasa delle grandi narrazioni di cui si
alimentava ancora il mito salvifico delle avanguardie, trovando nelle sue tesi
radicali un supporto alla convinzione per cui “un frammento architettonico ha la
capacità di investire di nuovi significati un insieme precostituito”. La tesi critica,
cioè, viene assimilata e riportata alla sua urgenza di incisione sulla realtà urbana
attraverso la particolare espressione della sua arte. Si rinsalda così la ricerca di
una scultura “scioccante” – capace cioè di entrare in rotta di collisione con
l’inospitalità della metropoli – ma anche il suo deciso rifiuto di soluzioni troppo
facili, come gli appaiono – negli anni della loro massima declinazione – i tentativi
delle neoavanguardie.
Si tratta di un punto fondamentale, perché la cultura di quella che Tafuri aveva
ironicamente definito “internazionale delle utopie” era allora al suo apogeo,
consacrata dalla pervasiva circolazione di nuove immagini di città che
promettevano una via d’uscita dall’apocalisse urbana nei paradisi artificiali di
metropoli sospese, di armonie riconquistate e ricomposte nel vuoto
antropizzato, dagli oceani ai deserti, addirittura galleggianti come nuvole
tecnologiche nell’aria.
Appare dunque netto il suo rifiuto di quell’utopismo di maniera (particolarmente
feroci gli strali contro l’Arcology di Soleri) e ancora più lucida l’equiparazione di
quei mondi perfetti alle gated community americane, risultato di una
privatizzazione dello spazio sociale sottoposto a ferreo controllo centrale. “Oggi
[…] non è lecito avere sogni non possibili. L’utopia astratta fatta di avvenirismo
puro porta in sé un troppo largo margine di errore ed è un rischio che non si può
correre.”1 Contro quest’utopismo sterile, si dichiara a favore di “una
concentrazione dell’analisi su limitati insiemi settoriali, individuati però fra gangli
vitali della struttura urbana”. Coerentemente, dalla lettura di L’architettura della
città di Aldo Rossi (di cui possiede l’edizione del 1970) è spinto a riflettere sulla
necessità di individuare i “luoghi primari” su cui far convergere le sue azioni.
Milano, 12 gennaio 2017
* Estratto dal testo in catalogo Skira