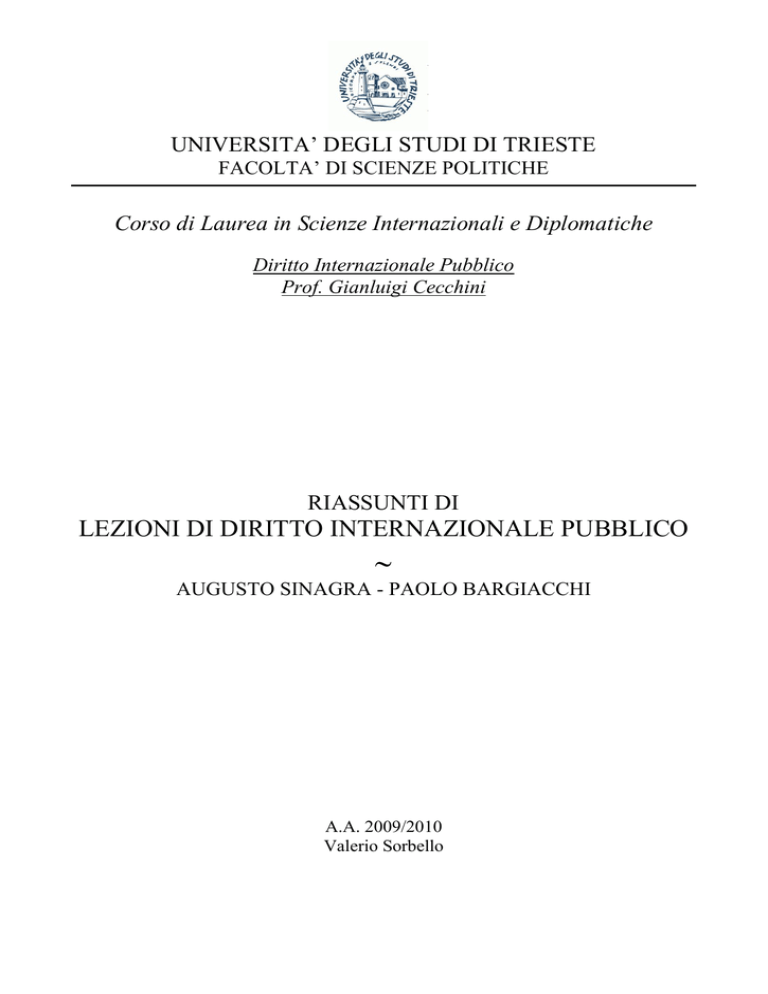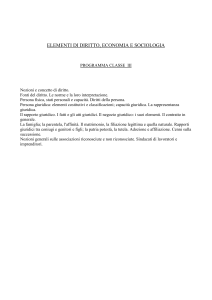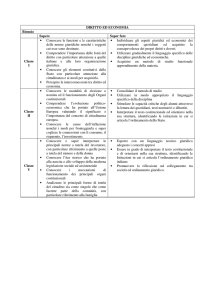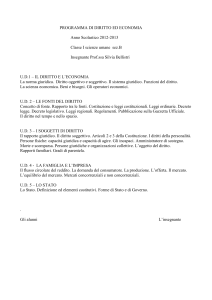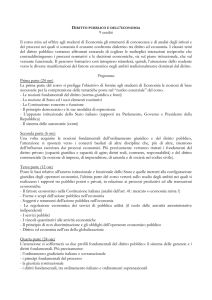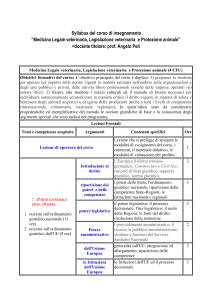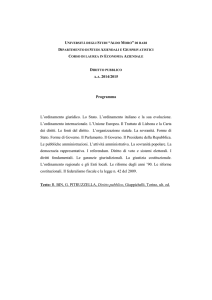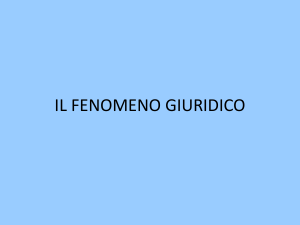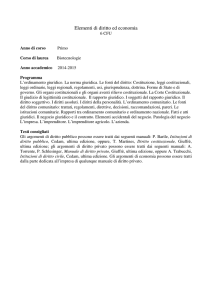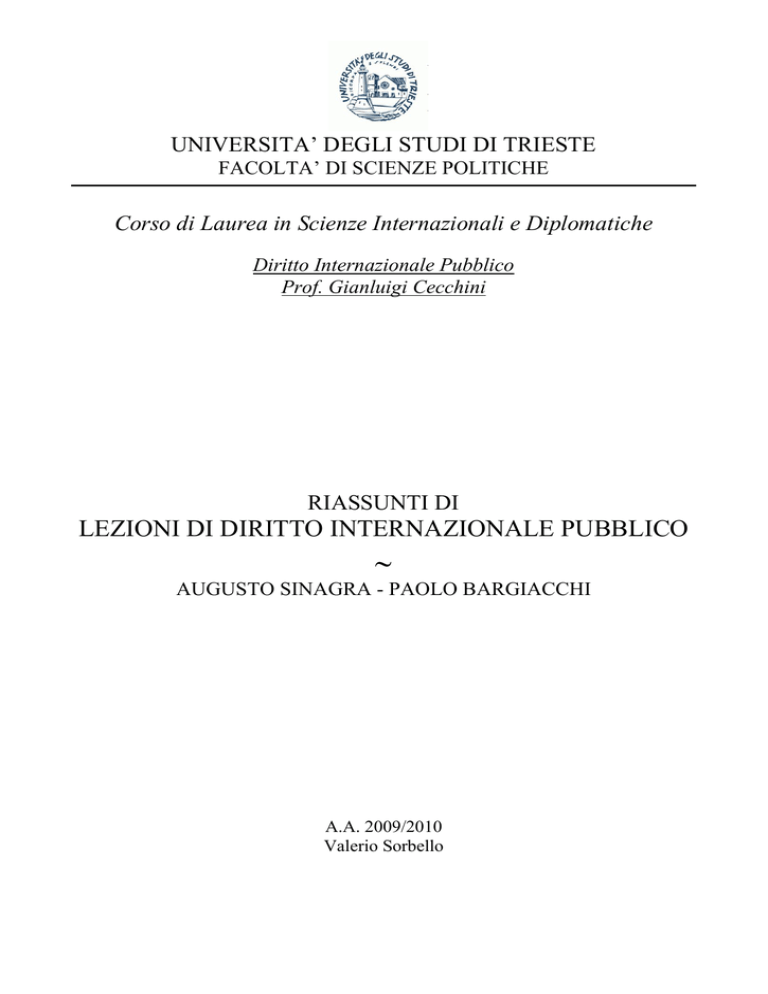
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE
FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE
Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche
Diritto Internazionale Pubblico
Prof. Gianluigi Cecchini
RIASSUNTI DI
LEZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO
AUGUSTO SINAGRA - PAOLO BARGIACCHI
A.A. 2009/2010
Valerio Sorbello
2
CAPITOLO I – LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE E IL DIRITTO
1. La Comunità internazionale e l’origine sociale del diritto: ubi societas, ibi auctoritas et ius
La Comunità internazionale (CI) è quella che “si individua per trovare la sua ragione d’essere e per
ritrarre il suo modo di essere dal fatto dell’esistenza di enti indipendenti o sovrani” ed il diritto
internazionale (DI) è l’ordinamento giuridico di questa comunità sociale di enti che si contrappone
al diritto interno.
La CI produce diritto, in quanto qualunque società inevitabilmente produce comandi che si
impongono ai consociati. La “volontà” del corpo sociale richiede solamente il consenso diffuso e
generale degli enti facenti parte della Comunità.
Se la “volontà” del corpo sociale internazionale non fosse così intesa, si dovrebbe accedere a una
nozione di carattere pattizio, negoziale, contrattuale che sarebbe condizionata nella sua cogenza al
consenso dei singoli destinatari: il fondamento di obbligatorietà di una simile volontà starebbe
esclusivamente nella volontà individuale dello Stato di auto-vincolarsi, negando così l’eteronomia
della norma giuridica in quanto comando, cioè come momento di obbligatorietà. Tuttavia, tale
interpretazione contrattualistica della volontà del corpo sociale è da rigettare.
La funzione legislativa si presenta in modo anorganico (non istituzionale) attraverso una volontà
collettiva e politica riferibile alla CI. Il DI ha un’origine sociale, è il prodotto giuridico dell’eadem
sentire comunitario, cioè della coscienza giuridica collettiva della comunità sociale di riferimento,
quella internazionale: ubi societas, ibi auctoritas et ius.
La dottrina che riconosce l’estrinseca socialità del diritto è riconducibile alla “Scuola realista”,
soprattutto quella italiana con il QUADRI.
A livello internazionale, l’ordinamento giuridico è il prodotto dell’agire e del volere del gruppo
sociale composto dagli Stati: sono questi le forze sociali che manifestano a livello giuridico
l’auctoritas e lo ius nella vita di relazione internazionale.
L’appartenenza dello Stato alla CI, anzi la sua stessa esistenza in tale contesto, è un momento
fenomenico delle relazioni internazionali (RI). L’essere Stato è un mero dato fattuale di natura pregiuridica: “Stato” lo si è già per forza propria, non lo si diventa a posteriori per volere politico altrui
o per qualificazione normativa dell’ordinamento. Il diritto esprime e riflette l’ordine sociale già
raggiunto all’interno di un gruppo sociale.
Definizione di DI di Cecchini: contratto sociale adottato per esprimere l'ordine della
comunità internazionale in quanto costituita da Stati indipendenti, sovrani e
superiorem non recognoscentes. il fenomeno giuridico internazionale è la
raffigurazione formale della permanenza di un certo ordine sociale (ubi societas ibi
ius).
2. Il fondamento di obbligatorietà del DI: la teoria realistica e quella volontaristica
Secondo l’interpretazione realistica del fenomeno giuridico internazionale, il fondamento di
obbligatorietà del DI va ricercato esaminando la prassi statuale, manifestazione dell’esistenza di un
fatto di sovranità (collettiva) politica che costituisce il fondamento di obbligatorietà della regola
giuridica internazionale.
L’autorità del gruppo sociale è fondamento di obbligatorietà di due norme fondamentali sulla
produzione normativa (principi formali):
- la norma “consuetudo est servanda” (“le consuetudini devono essere rispettate”);
- la norma “pacta sunt servanda” (“i patti devono essere rispettati”).
Queste due norme, dette primarie, istituiscono i procedimenti di produzione giuridica da cui
derivano tutte le norme consuetudinarie e convenzionali (norme secondarie).
3
I due principi formali rappresentano il fondamento ultimo, giuridico ed effettivo di obbligatorietà di
tutte le altre norme internazionali; fondamento che viene ad identificarsi nella stessa volontà
collettiva manifestata dall’auctoritas del corpo sociale internazionale.
Secondo l’interpretazione volontaristica, c.d. teoria della Vereinbarung, il fondamento
dell’obbligatorietà della norma si trova nella volontà degli stessi soggetti destinatari del precetto
normativo. Ciò vuol dire che la norma vincolerebbe i destinatari per il fatto che essi accettano di
obbedire al comando in essa contenuto: ciò negherebbe in re ipsa la giuridicità del comando, in
quanto una norma è giuridica solo se è eteronoma rispetto ai suoi destinatari , cioè se ha la forza di
imporsi su di loro indipendentemente dal loro contegno soggettivo e volontaristico. Tale
impostazione confonde il fondamento dell’obbligatorietà delle norme pattizie (manifestazione di
volontà degli Stati che concludono il trattato) con il fondamento dell’obbligatorietà della fonte
normativa internazionale. Il trattato come fonte è obbligatorio sempre, ma solo per tutti gli Stati che
ve ne fanno parte.
Il TRIEPEL sostenne che “quando gli Stati emettono manifestazioni di volontà di eguale contenuto
dirette alla creazione di norme giuridiche, le volontà distaccatesi dagli Stati che le abbiano emesse, si
unirebbero (Vereinbarung), dando così vita ad una nuova volontà diversa e superiore (Gemeinwille)
risultante dalla fusione delle volontà manifestate singolarmente; ad una volontà comune unitaria,
capace di imporsi agli emittenti come volontà superiore, normativa”. Sostenere che tali volontà, da
sole, creino diritto oggettivo senza bisogno di una norma presupposta che dia efficacia giuridica
vincolante all’accordo, lascia in realtà le parti al contratto o al trattato internazionale, libere di
disvolere ciò che esse stesse hanno voluto. Questa conclusione è diretta conseguenza di due
presupposti della teoria volontaristica:
- il diritto si riduce al comando del sovrano, cioè alla legge;
- essendo l’autorità dello Stato un dato assoluto non è ammissibile l’esistenza di un’auctoritas
superstatuale che esprimendo l’eadem sentire del corpo sociale, si imponga sull’intera
comunità, compresi i membri dissenzienti.
In tale ottica, anche le consuetudini si collocherebbero nello schema logico dell’accordo, nonostante
i dati della realtà dimostrino che questo tipo di norme non ha nulla a che vedere con un accordo
(tacito o espresso che sia) tra gli Stati che contribuiscono a formarle e che ne sono destinatari.
3. Segue: la teoria normativistica e quella giusnaturalistica
Secondo le teorie giusnaturalistiche, l’obbligatorietà della norma giuridica e del diritto
internazionale, si deve al fatto che il comando trovi fondamento in istanze riconducibili a superiori
ispirazioni e motivazioni religiose o laiche, a seconda che tali istanze siano connaturate ad una
volontà superiore a quella umana o direttamente alla stessa natura umana.
I giusnaturalisti scelgono a priori e in modo astratto una serie di valori prefissati senza controllarne
la validità in rapporto alla realtà sociale e storica. Le consuetudini e i trattati troverebbero il
fondamento di obbligatorietà nel diritto naturale che, a sua volta, è legato ad un dato trascendente,
aprioristicamente individuato. Pur affermando che le norme giuridiche siano sempre esistite e siano
sempre state applicate nel corso della storia umana, i giusnaturalisti mancano poi di darne
dimostrazione: anzi, lo studio delle vicende storiche, dimostra che non è mai esistita una norma
giuridica da sempre e sempre applicata e fatta valere!
La teoria normativistica pura, cd. Dottrina pura del diritto o Reine Rechtslehre, che trova in
KELSEN il suo esponente più importante, pretende di ricavare l’obbligatorietà del fenomeno
giuridico scindendola completamente da ogni altra componente. Essa si fonderebbe solamente su
una norma fondamentale, la norma base o Grundnorm, presupposta ed indimostrabile, che garantisce
l’obbligatorietà dell’intero ordinamento giuridico ad essa soggetto e sottoposto (indipendentemente
dalla volontà politica). L’idea del KELSEN secondo cui l’ordinamento è come una piramide
4
rovesciata con la Grundnorm al vertice non soddisfa perché formalistica e inidonea a spiegare
effettivamente il fondamento di obbligatorietà del diritto; senza considerare la pericolosità di una
simile ricostruzione, che legittimerebbe e giustificherebbe qualsiasi ordinamento o norma, persino
quello nazista!
Anche MORELLI postula l’esistenza di una norma fondamentale (la consuetudo est servanda) che
dà validità ed efficacia a tutte le altre, “presupposta e la cui giuridicità costituisce un postulato
indimostrabile sul terreno giuridico”: tale norma è “una mera ipotesi che va accolta perché idonea a
spiegare logicamente la realtà”. Anche in questo caso si pretende di spiegare il fatto giuridico sul
piano della logica astratta e non della realtà effettiva. Il MORELLI tuttavia, diversamente da Kelsen,
non è indifferente al ruolo che svolge la realtà socio-politica nella formazione del diritto (fonte in
senso materiale) e coglie i caratteri anorganici e fattuali dell’ordinamento internazionale.
Le teorie che postulano l’esistenza di una norma-base presupposta e indimostrabile ignorano il fatto
che è la coscienza giuridica collettiva degli Stati a fondare l’obbligatorietà delle norme
dell’ordinamento e che solo per ragioni connesse all’intrinseca, concreta struttura dell’ordinamento
giuridico si può ritenere che la norma subordinata sia legittimata, anche in punto di obbligatorietà, da
quella sovraordinata.
4. Monismo, dualismo e monismo strutturale
Riguardo al problema del rapporto tra l’ordinamento interno dello Stato e l’ordinamento
internazionale, due sono le concezioni che si oppongono: il dualismo e il monismo.
La dottrina monista presuppone in modo assiomatico la doverosa e necessaria armonia del mondo
reali. L’esistenza di norme che sono in contraddizione tra loro non è ammissibile e non deve essere
possibile dal momento che la dovuta conseguenza della presupposta ed indimostrata unitarietà del
diritto è proprio l’esistenza di un unico ordinamento giuridico. L’ordinamento internazionale e gli
ordinamenti interni non possono neanche essere equivalenti perché ciò significherebbe riconoscere
che sono “separati”, quindi, ammettere la possibilità dell’antinomia normativa tra questi. Sorge la
necessità logica e formalistica di individuare quale dei due ordinamenti abbia il primato sull’altro,
ossia se la Grundnorm abbia natura interna o internazionale.
La maggior parte dei monisti, e con essi KELSEN, afferma la natura internazionale della norma-base
e la derivazione degli ordinamenti giuridici statali da quello internazionale. Gli Stati eserciterebbero
le competenze che sono loro conferite dall’ordinamento internazionale ed i loro ordinamenti sono
parziali rispetto a quello internazionale che è onnicomprensivo. Tale impostazione monista e
normativi sta postula l’esistenza di una “struttura a gradini”, c.d. Stufenbautheorie, che, come
vertice, ha la Grundnorm e , come destinatari ultimi del DI, ha gli individui e non gli Stati.
La dottrina dualista, elaborata all’inizio da TRIEPEL e ANZILLOTTI, considera il diritto interno e
quello internazionale come ordinamenti originari e autonomi, separati e distinti che non
costituiscono in alcun modo un unicum. Essi si distinguono sotto molteplici e fondamentali aspetti:
- fonti: li pone una diversa volontà normativa, quella dello Stato per l’ordinamento interno e
quella della Comunità per l’ordinamento internazionale;
- destinatari delle norme: rispettivamente, gli individui e gli Stati;
- rapporti disciplinati: interni e interindividuali, da un lato, e internazionali ed interstatuali,
dall’altro.
In questo quadro, le antinomie normative sono ammissibili, dal momento che la reciproca
indipendenza dei sistemi impedisce la prevalenza giuridica dell’uno sull’altro: nella propria sfera di
applicazione, ciascun ordinamento è pienamente efficace, valido e normativamente indifferente
rispetto all’altro. Per tale ragione, un obbligo internazionale assunto da uno Stato può non
corrispondere, automaticamente o necessariamente, l’equivalente obbligo di diritto interno.
5
Ciò vuol dire che il diritto internazionale crea obblighi giuridici per gli Stati, ma non anche che il
diritto internazionale possa “direttamente” modificare il diritto interno. La superiorità del diritto
internazionale si manifesta nei confronti dello Stato un quanto membro della Comunità sociogiuridica internazionale.
Concezione Monista
Concezione Dualista
Unità dell’ordinamento internazionale e degli Separazione dell’ordinamento internazionale e
ordinamenti interni
degli ordinamenti interni
Le antinomie normative sono considerate delle Le antinomie normative sono ammissibili, anzi
patologie da eliminare
naturali in un quadro di ordinamenti separati
5. Il dominio riservato dello Stato e la pretesa incompletezza dell’ordinamento giuridico
internazionale
Si intendono appartenenti al dominio riservato (o esclusivo) dello Stato quelle materie non
disciplinate dal diritto internazionale. L’indubbio restringimento dell’ambito, o scope, di
competenza esclusiva dello Stato si spiega con l’accresciuta interdipendenza economica e politica a
livello globale e con la necessità di una più diffusa ed intensa cooperazione tra gli Stati. Con questo
non vuol dire che l’essenza politica e la nozione giuridica di sovranità dello Stato sia parimenti
erosa o modificata.
In tale ottica, QUADRI evoca da una parte l’idea di una compenetrazione sempre più marcata ed
incisiva della struttura sociale componente (lo Stato) nella struttura sociale composta (CI) , dall’altra
evidenzia che tale processo è prima politico, sociale, fattuale e solo poi anche giuridico.
L’ambito del dominio riservato, oggettivamente non delimitabile, si configura in termini relativi,
cioè secondo limiti che variano in funzione delle contingenze storiche e politiche.
Alcuni autori sostengo la pretesa lacunosità ed incompletezza dell’ordinamento giuridico
internazionale, c.d. sistema primitivo, per il fatto che esso non disciplinerebbe tutte le fattispecie
che si manifestano nella vita di relazione internazionale. Questa conclusione ignora le
caratteristiche originarie e costitutive della vita di relazione internazionale che divengono, di
riflesso, le caratteristiche dell’ordinamento giuridico internazionale secondo il principio ubi
societas, ibi auctoritas et ius.
Affermando tale incompletezza, tali autori non colgono l’elemento fondamentale della coesistenza
socio-giuridica degli Stati a livello internazionale, cioè di essere, la loro Comunità, anorganica a
livello strutturale e contrattualistica, privatistica a livello di rapporti intersoggettivi.
Una lettura “privatistica” dei rapporti giuridici internazionali calata in un contesto strutturale privo
di “istituzioni, costituzioni e funzioni” (nel senso che hanno nel diritto interno) conferma solo la
minore efficacia dell’apparato giuridico internazionale in confronto a quello statuale, e non la sua
lacunosità o addirittura inesistenza.
La tesi dell’incompletezza va rigettata per altri due motivi:
- da un punto di vista logico, se la mancata disciplina giuridica internazionale di alcuni
fenomeni sociali dimostrasse realmente l’incompletezza dell’ordinamento internazionale,
allora si dovrebbe concludere anche per l’incompletezza degli ordinamenti interni, dato che
neanche essi disciplinano l’intere gamma dei fenomeni sociali;
- la presunta incompletezza si spiega con la notazione che, in ogni sistema giuridico, la
“mancata” disciplina di certe fattispecie significa solo che quell’ordinamento non ritiene di
approntare una specifica regolamentazione, costituendo una libera scelta del legislatore
internazionale che si traduce dal punto di vista normativo nel garantire libertà d’azione ai
soggetti in relazione alla fattispecie non disciplinata.
6
CAPITOLO II – I SOGGETTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE
1. Realismo e funzionalismo nell’indagine sulla soggettività internazionale
La definizione di “soggetto” generalmente condivisa è quella per cui è tale l’ente “cui fanno capo i
diritti e gli obblighi” internazionali.
Tuttavia le posizioni divergono al momento di applicare metodologicamente la definizione ai
fenomeni concreti, a seconda che essa venga utilizzata in funzione dell’esame realistico dei dati
fenomenici della realtà socio-politica internazionale (realismo) oppure che essa venga applicata in
maniera funzionale alla valutazione dei dati normativi di quella realtà, considerati con più riguardo
rispetto alla situazione materiale dell’ente nel contesto delle RI (funzionalismo).
La nozione funzionalistica del soggetto internazionale propone che la soggettività sia individuata
negli enti in funzione del loro essere destinatari (attivi e passivi) di norme internazionali.
Lungi, però, dall’essere una conseguenze quasi dovuta dell’essere destinatario di norme, la
soggettività è, invece, l’effetto, il riflesso giuridico di caratteristiche intrinseche, pre-giuridiche
possedute dall’ente. Questa fondamentale premessa non confligge con la definizione di “soggetto”
riportata all’inizio, ma resta condivisibile a patto che la destinatarietà “di diritti ed obblighi” sia
intesa con riguardo agli aspetti sostanziali e costitutivi dell’ente e non a quelli normativi ed
estrinseci.
L’approccio realistico ai dati fenomenici della vita socio-politica internazionale permette di fornire
descrizioni giuridiche di quei dati che siano effettive, cioè conformi alla realtà concreta e materiale
delle cose. Il DI è sempre de iure condito, mai de iure condendo.
Applicando questa impostazione alla nozione di “soggetto”, la si precisa nel senso che è “soggetto”
solo chi, per forza propria, ha la capacità effettiva di impegnare l’ordinamento, azionando i propri
diritti e rispondendo dei propri obblighi. Ogni altro fenomeno che manchi di tale capacità non è un
soggetto di diritto internazionale, per quanto “importante o visibile” possa essere sulla scena
internazionale.
I realisti criticano con due argomenti il tentativo di individuare funzionalmente i soggetti
dell’ordinamento internazionale:
- la loro individuazione “funzionale” finisce per accomunare sotto la stessa definizione
fenomeni radicalmente e costitutivamente diversi (come gli Stati e l’individuo);
- la prassi degli Stati dimostra l’astrattezza della lettura funzionalista della soggettività
internazionale: la vita di relazione internazionale continua ad essere decisivamente
indirizzata dagli Stati e non dagli altri enti cui troppo facilmente si attribuisce la qualifica di
“soggetti”.
2. Segue: il soggetto “territoriale”; il soggetto “funzionale”; il soggetto “potenza”
Impostando il ragionamento in ottica realista, la prima conclusione è che i soggetti sono
qualitativamente sempre tutti uguali, anche quando impegnino l’ordinamento e siano destinatari di
norme in misura quantitativamente diversa tra loro. Ciò mostra, ancora una volta, come la
destinatarietà di norme non sia un parametro di soggettività internazionale in quanto se un ente è
soggetto perché destinatario di norme, allora anche al misura quantitativa di quella destinatarietà
condiziona la soggettività, ampliandola o restringendola a seconda della quantità di norme di cui
l’ente è destinatario.
Non varia, dunque, il “peso giuridico” degli enti-soggetto, cioè la soggettività internazionale frutto
di qualità costitutive e pre-giuridiche, ma varia l’ampiezza, lo scope, “quantitativa” della loro
soggettività, cioè il numero dei rapporti giuridici di cui sono termine.
7
Dalle c.d. Paci di Westfalia del 1648 (data di nascita dell’odierna CI) emerge che i “soggetti” delle
RI sono quegli enti politici capaci, nel rapportarsi con l’esterno, di azionare per forza propria
l’ordinamento giuridico. Ciò avviene in virtù del fatto che l’ambiente internazionale è composto da
enti indipendenti e sovrani. Grazie a questa seconda conclusione, si identificano due tipi di
soggetti: gli Stati e gli insorti.
Secondo il DONATI, è soggetto, e quindi indipendente, solo chi controlla un territorio in via
esclusiva (ius excludendi alios) perché non può aversi sovranità senza potere territoriale. Tale
concezione territoriale e della soggettività dell’ente (soggetto “territoriale”) non è però condivisa
dalla maggioranza della dottrina.
Secondo la concezione del soggetto “potenza” di ARANGIO-RUIZ, è soggetto non l’ente che è
sovrano sul territorio, ma l’ente che si palesi nelle RI come una potenza: è soggetto chi è
indipendente ed è indipendente chi è potenza. Questa condizione dipende dall’essere un ente
“realmente esistente come unità sovrana e indipendente e partecipante alle RI”, dove l’indipendenza
e la sovranità dell’ente-soggetto in quanto potenza “non ha niente a che vedere con una maggiore o
superiore potere militare, economico e/o politico”.
Tuttavia, queste due posizione sono accomunate dal fatto che si lega la soggettività ad un altrettanto
fondamentale e generale “requisito subbiettivo generale permanente” (che sia l’indipendenza dovuta
alla sovranità territoriale o all’essere potente nelle RI).
Meno convincente è la seconda impostazione che si allontana dalla concezione territoriale della
soggettività. Secondo la concezione del soggetto “funzionale”, la soggettività va ricondotta
all’essere ente destinatario di una o più norme internazionali. Viene dunque sganciato il concetto di
soggettività da quello di indipendenza, diventando così fuorviante utilizzare la stessa categoria della
soggettività per fenomeni che sono radicalmente diversi tra loro (gli enti-soggetti indipendenti e gli
enti-soggetti non indipendenti, portatori di status giuridici che si manifestano sempre e solo nei
limiti delle competenze attribuite o dei diritti concessi dai primi).
3. Lo Stato
Lo Stato è esclusivamente un dato fattuale, pre-giuridico e non giuridico, rispetto al quale
l’ordinamento si limita ad indicare elementi di fatto che, se presenti, determinano l’applicazione
delle norme internazionali. All’ordinamento spetta dunque solo il compito di prendere atto di tale
statualità, ma non di attribuirla con effetti costitutivi.
L’ordinamento valuta solo, ab externo, se l’ente socio-politico riesce ad agire effettivamente nella
vita di relazione internazionale (e quindi a manifestarsi come soggetto di diritto).
In dottrina si confrontano due concezioni di Stato:
lo Stato-apparato: lo Stato come apparato di governo contrapposto alla comunità sociale,
cioè l’autorità o il complesso delle autorità che detengono la summa potestas nel seno di
ciascuna comunità, il gruppo di uomini che ivi esercita il potere politico (nozione accolta
dalla dottrina dato che la CI è società di Stati e non di popoli);
lo Stato-comunità: lo Stato come apparato di governo e comunità dei governati, cioè lo
Stato come la stessa comunità degli uomini, il popolo che, attraverso l’organizzazione
politica entro un territorio definito, assumerebbe il carattere di Stato.
In generale, poi, si ritiene che lo Stato sia un ente composto da tre elementi fattuali:
il popolo;
il territorio;
il governo (o potestà d’imperio o sovranità).
Tale triade definisce la sovranità interna ed è complementare alla c.d. sovranità esterna, cioè
all’indipendenza da qualsiasi altro Stato.
8
La nozione di indipendenza è valutata in termini concreti: il corpo sociale che si organizza per
governare un territorio deve essere effettivamente in grado di esercitarvi lo ius excludendi alios.
L’ordinamento dello Stato è indipendente se originario, cioè se non dipende formalmente da un
altro ordinamento statale e trova in sé stesso la fonte della sua legittimità.
Ai fini della statualità sono giuridicamente irrilevanti tanto l’instaurazione legittima o meno
dell’autorità di governo rispetto all’ordinamento costituzionale dello Stato (c.d. colpi di Stato)
quanto la dimensione territoriale (c.d. micro-Stati)
4. Segue: Stato federale; riconoscimento dello Stato; il concetto di organo
La Confederazione di Stati è l’Unione organizzata permanente avente per scopo la comune difesa
esterna dei membri e il mantenimento della pace fra essi. Gli Stati membri della Confederazione
restano a tutti gli effetti enti sovrani e indipendenti, cioè soggetti di diritto internazionale, e gli
obblighi tra loro intercorrenti trovano fondamento nel trattato.
Lo Stato federale è unico soggetto del DI laddove gli Stati che lo compongono (Stati federati) sono
giuridicamente irrilevanti per l’ordinamento internazionale (gli Stati federati sono normali
suddivisioni territoriali interne dello Stato). Sola peculiarità dello Stato federale è quella di avere
una ripartizione interna di competenze, poteri e funzioni articolata in senso federale e non unitario.
Il riconoscimento dello Stato è una dottrina del passato che pretendeva di condizionare l’esistenza
giuridica dello Stato nell’ordinamento internazionale al suo previo riconoscimento da parte degli
altri e preesistenti Stati. Tale teoria del riconoscimento costitutivo è ormai abbandonata,e quando si
parla di riconoscimento, lo si intende in senso meramente dichiarativo.
Il riconoscimento è solo un atto politico che diventa il presupposto perché si producano alcuni
effetti giuridici nelle relazioni tra riconosciuto e riconoscente.
Il concetto di organo dello Stato è ampio e si considera tale “qualsiasi organo, inquadrato
nell’organizzazione dello Stato, che eserciti funzioni legislative, esecutive, giuridiche o altre,
qualunque sia la sua posizione nell’organizzazione dello Stato e quale che sia il suo carattere di
organo del governo centrale o di un ente territoriale dello Stato”; “un organo include qualunque
persona o ente che gode di tale status secondo il diritto interno dello Stato; si tende poi a includere il
c.d. organo di fatto, cioè la persona o il gruppo di persone che agiscono in realtà secondo le
istruzioni o sotto la direzione o controllo di uno Stato.
Nel diritto internazionale, non si può ritenere che gli atti dell’organo dello Stato siano imputati allo
Stato perché pensare di imputare un atto a chi non ne sia l’autore è un non-senso: è dunque
inaccettabile ragionare come se esistessero due soggetti, perché così si attribuirebbe all’organo un
qualche autonomo rilievo, cioè un rilievo di soggettività nel DI.
Se lo Stato è un’unità fattuale e pre-giuridica, il rapporto con il suo organo è di totale
immedesimazione: perciò l’atto dell’organo è già di per sé un atto dello Stato.
5. Territorio e sovranità: la nozione “funzionale” di sovranità
L’ente-soggetto Stato manifesta il suo imperium su un territorio rispetto al quale è sovrano e
indipendente.
La sovranità si lega essenzialmente al territorio che diventa l’ambito spaziale all’interno del quale
arriva a esercitarsi il potere dello Stato. La frontiera tra i sovrani diventa un momento politicogiuridico di delimitazione e coesistenza delle sfere statuali di sovranità, ancor prima che un simbolo
fisico-territoriale.
La sovranità, a livello concettuale, non è descrivibile in termini esclusivamente territoriali, per cui
derivano delle conseguenze significative:
9
a) il territorio non è elemento costitutivo del soggetto “Stato”. Per QUADRI è un presupposto
materiale (e non costitutivo) della soggettività internazionale; per ARANGIO-RUIZ non è
neanche un presupposto materiale della soggettività perché l’ente è soggetto se è potenza e
la potenza prescinde dalla territorialità dell’ente-soggetto;
b) il territorio non è un bene del sovrano;
c) il territorio statale non è l’unico ambito spaziale entro il quale si irradia l’imperium del
sovrano.
Dunque, la sovranità va descritta come controllo “dinamico” di uomini, cose e situazioni, e non
come mero possesso “statico” di territori. La sovranità deve essere dunque descritta in termini
“funzionali”, così che sia ricostruibile in ogni situazione in cui lo Stato esercita, in via esclusiva, la
coercizione, il controllo, la potestas su una collettività.
Per il controllo del territorio statale, i suoi limiti spaziali coincidono con i confini dello Stato
(comprensivi del mare territoriale) entro i quali il sovrano ha il diritto di non subire ingerenze e
immistioni nel libero ed indisturbato esercizio della propria sovranità o postestas, cioè nel “diritto
subiettivo internazionale dello Stato ad esercitare indisturbatamente tale potere”.
Le eccezioni al divieto di non ingerenza negli affari interni dello Stato confermano che l’ambito di
applicazione del domino riservato si va progressivamente riducendo in conseguenza dell’attuale
momento storico che evidenzia sempre più una maggiore interdipendenza tra la struttura sociogiuridica dello Stato e della CI.
A ciò si aggiunga poi che lo Stato ha comunque degli obblighi internazionali in materia di
trattamento dei cittadini stranieri presenti sul proprio territorio. Nel caso in cui l’obbligo di
protezione dello straniero non sia adempiuto, lo Stato di nazionalità dello straniero può intervenire
in protezione diplomatica del proprio cittadino. Lo Stato che interviene aziona un proprio diritto,
non un diritto dell’individuo.
Attiene ai poteri dello Stato sul proprio territorio, infine, la disciplina in tema di ammissione ed
espulsione di cittadini stranieri, salvo i limiti in materia di rifugio, protezione umanitaria e non
respingimento alle frontiere e salva ogni eventuale diversa disciplina fissata dagli ormai numerosi
ed appositi trattati internazionali.
6. Segue: il “controllo” da parte dello Stato su “comunità viaggianti” e territori fuori dai
propri confini
Le caratteristiche del controllo esercitato dal sovrano sulle c.d. comunità viaggianti (navi ed
aeromobili) permettono di cogliere il significato giuridico essenziale della sovranità e la sua
funzionalità.
La nave o l’aeromobile, lungi dall’essere assorbita dal sovrano del territorio in cui si trova a
passare, rappresenta una comunità di individui che, in linea di principio, resta soggetta alla
sovranità dello Stato di bandiera e, in linea di eccezione, resta anche soggetta al concorrente o
prevalente imperium dello Stato territoriale.
In linea di principio, le vicende della comunità viaggiante sono di competenza dello Stato di
bandiera nella misura in cui non trascendano certi limiti, cioè non si ripercuotano sulla vita della
comunità territoriale: in questo caso, provocando le vicende della nave allarme sociale nella
comunità territoriale, il sovrano territoriale interviene, esercitando la sua potestas di governo anche
nei confronti della nave straniera.
Il criterio di concorrenza tra le attività di governo, imperniato sulla rilevanza dei fatti della comunità
viaggiante per la vita ordinata e pacifica della comunità territoriale, appare soddisfacente da un
punto di vista generale, dando conto delle effettive esigenze dell’uno e dell’altro sovrano, cioè
rispettivamente l’esercizio della navigazione marittima e l’interesse all’interazione con altre
comunità e sovrani nel rispetto dell’ordine sociale (esigenze di ordine pubblico e pubblica sicurezza
della comunità territoriale).
10
Dunque, lo “Stato è responsabile nei confronti di tutti gli individui soggetti alla sua attuale autorità,
sia che tale autorità venga esercitata entro il suo territorio si all’estero, in particolare con riferimento
agli agenti statali i quali, esercitando la loro autorità all’estero, riconducono gli individui nella
giurisdizione dello Stato membro cui appartengono”.
Tuttavia l’applicazione di tale impostazione non è stata univoca da parte di alcune corti1.
7. Altri soggetti (veri o presunti) internazionali: insorti; movimenti di liberazione nazionale;
governi in esilio; Santa Sede; Ordine di Malta
Soggetto “territoriale”
Soggetto “potenza”
Soggetto “funzionale”
L’ente è soggetto in quanto L’ente è soggetto in quanto L’ente è soggetto in quanto
sovrano su di un territorio
potenza nelle RI
destinatario
di
norme
internazionali
Agli insorti nessuna delle tre posizioni elencate in tabella nega la soggettività internazionale; essi
sono definiti come un “gruppo organizzato [sotto un comando responsabile] di individui che prende
le armi in occasione di una guerra civile o di moti rivoluzionari interni, sulla spinta di determinati
fini politici, quale la conquista del potere o la secessione di un territorio per acquisire
l’indipendenza o per unirsi ad un altro Stato”. La loro soggettività dipende dal conseguimento,
mediante l’organizzazione del gruppo, dell’esercizio effettivo del potere di governo su una parte del
territorio dello Stato; diversamente, il rivoltoso rimane un fenomeno di diritto interno.
Gli insorti sono soggetti di diritto internazionale tout court che per il tempo dell’insurrezione
coesistono, con il soggetto-Stato cui si sono rivoltati, all’interno del territorio statale, prima
governato solo dal soggetto-Stato ed ora, dopo l’insurrezione, in parte governato anche dagli insorti.
Decisivo è il rilievo sulla non temporaneità del soggetto-insorti: se gli insorti non vengono sconfitti,
non si avrà una trasformazione qualitativa del soggetto in qualcos’altro ma solamente una
mutazione esterna dell’ente soggetto (da una veste insurrezionale a una statuale) che resta, però, lo
stesso. Ciò vuol dire che il nuovo soggetto-Stato è comunque tenuto a farsi carico verso gli altri
Stati degli obblighi assunti dall’ente-soggetto predecessore.
Agli insorti si applicano (e gli insorti devono rispettare) le norme di diritto internazionale “nella
misura in cui ad essi siano materialmente applicabili” in un determinato momento storico-politico
della loro lotta.
È l’esercizio della potestas di governo su un territorio che spiega l’unanime riconoscimento della
soggettività internazionale degli insorti.
La maggior parte della dottrina e della prassi non riconosce i governi in esilio quali soggetti
internazionali. Il fenomeno è politico, e non giuridico, e consiste nel trasferimento (o diretta
costituzione) all’estero, presso un altro Stato, dei governi il cui territorio è stato oggetto di invasione
bellica: “governi” che, una volta in esilio, non hanno più né un popolo né un territorio da governare;
la loro attività di “governo” in territorio straniero avverrebbe solo e grazie al consenso del sovrano
territoriale, il che per il QUADRI è un non senso.
Similmente, sembra doversi negare la soggettività anche ai Movimenti di Liberazione Nazionale
(MLN), cioè agli enti organizzati che si fanno portatori, a livello politico-internazionale, di istanze
di autodeterminazione di un popolo. Si tratta di un fenomeno che si contraddistingue per l’obiettivo
politico, non per il controllo su un territorio o per le modalità armate della lotta. Lo specifico
obiettivo politico distingue il MLN dagli insorti che non hanno come obiettivo caratterizzante della
loro azione il rovesciamento di un governo straniero o razzista o militare, ma semplicemente il
1
Per gli esempi vedi libro pp 56,57,58,59,60.
11
rovesciamento del governo al potere (qualunque esso sia) per motivi di avversione politica interna.
Tolto il velo della politica, ci sembra che del MLN resti poco in punto di soggettività giuridica
internazionale: o è un “normale” fenomeno insurrezionale o è un “normale” fenomeno politico che
non ha soggettività.
Per quanto riguarda la Santa Sede, si dovrebbe concludere per l’inesistenza di una sua soggettività
internazionale, estinta con la presa di Roma nel 1870.
Secondo ARANGIO-RUIZ, il fatto che con la c.d. Legge delle Guarentigie vennero riconosciuti al
Pontefice garanzie, privilegi e immunità è interpretabile come prova del perdurare della soggettività
dell’ente, nel senso che al venir meno della sovranità territoriale, la Santa Sede continuò ad essere
(e ad essere considerata) una potenza, e quindi un soggetto, nelle RI.
Secondo l’impostazione funzionalistica, l’essere destinatario di norme giuridiche è già di per sé una
prova sufficiente della soggettività della Santa Sede.
Anche in questo caso il soggetto sarebbe sui generis per la peculiarità degli scopi perseguiti, ovvero
quelli religiosi.
Tuttavia, è solo con il Concordato del 1929 che torna a manifestarsi nel DI un ente-soggetto distinto
dalla Santa Sede e capace di manifestare un’autonoma potestas di governo territoriale (il soggettoStato Città del Vaticano); esso si viene a manifestare non in forza del concordato, ma data la sia
esistenza effettiva ed indipendente, dovuta al fatto sociale e politico della sua azione sovrana di
governo.
Sulla stessa falsariga, si deve parimenti ritenere la non soggettività internazionale del Sovrano
Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta (SMOM). I
“Cavalieri di Malta” esercitarono in passato potestà di governo sulle isole di Rodi (1310-1523) e di
Malta (1530-1798). La perdita della sovranità territoriale determinò la fine della potestas di governo
e l’estinzione della soggettività internazionale.
8. Le Organizzazioni Internazionali
In base all’impostazione fin qui seguita, tutte le Organizzazioni internazionali (OI) non sono
soggetti, perché mancano, anche nelle forme più evolute (ONU e UE), della capacità di esprimere
una volontà politica e di imporla ai soggetti internazionali che le compongono, cioè gli Stati, di cui
restano strumenti ed interpreti della loro volontà politica.
La c.d. “indipendenza” delle OI si rivela, in termini giuridici, come autonomia che, per quanto
ampia ed articolata, non vi equivale.
La descrizione funzionale di tali fenomeni perde di vista l’effettiva realtà politica del fenomeno
“OI”; inoltre, il soggetto di diritto si riconosce in funzione della sua effettiva capacità politica di
essere indipendente, non della sua autonomia normativa.
La capacità delle OI di concludere trattati, lungi dall’essere prova di autodeterminazione politica, è
solo la conseguenza, il riflesso normativo della volontà politica degli Stati membri che le
compongono: sono sempre gli Stati a garantire l’adempimento effettivo degli obblighi assunti dalle
OI.
In dottrina, due sono le teorie che cercano di dimostrare la soggettività delle OI:
- la teoria contrattualista: essa afferma la soggettività dell’OI per il fatto che il suo stesso
trattato istitutivo lo prevede. Esso sarebbe dunque la fonte mediante cui l’OI si manifesta da
subito come ente separato, autonomo e distinto rispetto agli Stati membri e da cui
scaturirebbe la soggettività. Il QUADRI sostiene criticamente che un trattato non possa
fondare un nuovo ente, diverso, distinto e indipendente rispetto agli stessi Stati creatori, in
quanto “non è l’organizzazione che ha diritto a vedere rispettati i suoi atti dagli Stati
12
-
membri, sono invece gli Stati membri che hanno gli uni verso gli altri il diritto a che gli atti
dell’OI siano rispettati”.
la teoria istituzionalista o esistenzialista: essa pone l’accento sull’effettiva “partecipazione
alle RI con carattere di autonomia ed indipendenza rispetto agli Stati membri dell’OI”;
sarebbe il concreto, effettivo e successivo dipanarsi della vita dell’ente ad attribuire la
personalità internazionale. Solo se si attiva un meccanismo di trasformazione della base
sociale dell’ente-organizzazione, l’OI diventa sufficientemente autonoma ed indipendente
ed il trattato inizia a produrre effetti erga omnes, tra cui il manifestarsi della soggettività
internazionale.
Delle due, è la teoria istituzionalista che è più lineare e coerente dal punto di vista logico e
giuridico, ma neanch’essa descrive l’effetiva realtà delle RI e il ruolo che le OI ivi ricoprono.
La teoria del soggetto-potenza di ARANGIO-RUIZ applicata alle OI conduce a risultati intermedi
tra l’approccio funzionale e quello che interpreta territorialmente la nozione di indipendenza
dell’ente (che nega la soggettività alle OI). Egli manifesta alcuni dubbi di portata generale del
funzionalismo riconducibili:
a) alla “costituzione parietaria” del sistema internazionale che impedisce qualsivoglia
indipendenza dell’OI dagli Stati membri;
b) all’inidoneità di consuetudini e trattati a costituire la soggettività dell’ente;
c) all’atteggiamento negativo degli Stati membri.
L’autore non esclude dunque che la soggettività internazionale si possa manifestare nell’enteorganizzazione “dotato di un certo grado di indipendenza ed effettivamente operante sul piano delle
RI” e che ciò si verifichi ad esempio in “organismi a carattere universale o tendenzialmente
universale come la SdN o l’ONU”.
La soggettività internazionale dell’OI si manifesterebbe, come personalità primaria, sulla falsariga
degli altri enti-soggetti dell’ordinamento. Ma essa non deriverebbe come mera conseguenza
dall’attuazione dei poteri e delle funzioni previsti nel trattato istitutivo, poiché permane l’ineludibile
vincolo di strumentalità che lega l’OI agli Stati membri che impedisce all’ente di manifestarsi come
potenza nelle RI.
Le OI, enti autonomi ma non indipendenti, assumono rilievo nella sfera di auto-organizzazione
della propria attività e negli ordinamenti interni, ma non anche, a livello sostanziale e “strutturale”,
nel DI dove restano strumenti di cooperazione fra gli Stati membri che, con la propria soggettività
giuridica, ne garantiscono l’operatività e l’efficienza.
9. Segue: la sovranazionalità
Le tesi sovranazionaliste sostengono l’esistenza di un tipo peculiare di organizzazioni, dette
sovranazionali, dotate di una limitata sovranità ceduta (o trasferita) dai loro stessi membri e i cui
ordinamenti costituirebbero una sorta di tertium genus tra l’ordinamento internazionale e gli
ordinamenti interni.
Duplice è l’estemporaneità di tali tesi, dato che stravolgono sia l’idea di sovranità (categoria
poilitico-giuridica unitaria e indivisibile) che la teoria generale del DI, ipotizzando un terzo genere
di ordinamento.
L’organizzazione “sovranazionale” avrebbe poteri propri e la capacità di attuare, anche
coercitivamente, la propria volontà e le proprie determinazioni, essendo il prodotto giuridico di una
“base sociale” comunitaria che sarebbe autonoma ed originaria tanto quanto internazionale.
Tale ricostruzione è inaccettabile, perché non è accertata né l’autonomia (la struttura socio-giuridica
della CE esiste in costanza della volontà politica degli Stati membri) né l’essere originaria (il
13
sistema normativo comunitario, fondandosi sul trattato istitutivo della CE va descritto con le
categorie del DI e non sovranazionale).
Il rapporto tra Stato membro e OI va ricostruito “non in termini di trasferimenti di sovranità o di
rinunce a parti di questa, bensì, più realisticamente, in termini di deleghe o trasferimenti di
competenze, giuridicamente ed istituzionalmente definite”.
10. Segue: la trasformazione della base sociale dell’organizzazione internazionale: la nascita
degli Stati Uniti
In seno all’OI si potrebbe verificare un fenomeno socio-giuridico di grande interesse capace di
trasformare la base sociale dell’ente-“organizzazione internazionale” nella base sociale di un entesoggetto “Stato”. La trasformazione comporta che da un ente derivato dal trattato istitutivo possa,
nel tempo, emergere un ente effettivamente indipendente dagli Stati membri, a patto che si attivi,
nella sfera sociale dell’OI, un meccanismo socio-politico (prima che giuridico) idoneo a spezzare il
rapporto tra Stati membri ed organizzazione
La vicenda storica degli Stati Uniti d’America dimostra la fondatezza giuridica della teoria
istituzionalista che si riconduce ad ARANGIO-RUIZ e MONACO.
In questo caso, l’OI si è trasformata in un nuovo e completamente diverso ente-soggetto statuale
con sostituzione:
a) del nuovo ente-soggetto all’organizzazione;
b) della Costituzione dell’ente-soggetto al trattato istitutivo dell’estinta organizzazione;
c) di suddivisioni amministrative territoriali sub-statali agli Stati membri dell’organizzazione,
anch’essi estinti.
Questo processo dinamico presuppone la coesistenza e l’interazione di due diverse sfere sociogiuridiche: quella interstatuale, regolata dal DI, e quella interindividuale, regolata dal diritto interno
dell’OI.
Perché l’interazione tra le due sfere determini la trasformazione della base sociale
dell’organizzazione è necessario che la dimensione interindividuale manifesti “forme man mano più
complesse, nelle quali essa appaia sempre più invadente rispetto alle comunità singole, fino ad
assorbire queste ultime in se stessa, costituendo l’istituzione interindividuale totale decentrata”: per
tal via la trasformazione è completa e la dimensione interindividuale si sostituisce a quella
internazionale.
11. L’individuo
Opinioni discordanti esistono in dottrina anche sul tema della soggettività internazionale
dell’individuo, sebbene la maggioranza ne neghi la soggettività.
Nell’attribuzione di posizione giuridiche di rilievo internazionale agli individui, sono sempre gli
Stati i soggetti dei sottesi rapporti giuridici, mentre gli individui sono solo oggetti di quei rapporti
interstatuali.
La legittimazione processuale attiva dell’individuo nei sistemi di protezione internazionale dei
diritti umani resta decisivamente condizionata alla partecipazione dello Stato al trattato che
istituisce il sistema di protezione nel senso che l’individuo beneficia della tutela non per forza
propria ma solo se lo Stato è parte al trattato.
Fuori dal caso dell’individuo beneficiato dallo Stato per ciò che riguarda la tutela internazionale dei
suoi diritti, la descrizione giuridica non muta.
Si prenda ad esempio il caso del pirata: la pirateria è vietata dal DI; il pirata sembra il destinatario
della norma proibitiva ma, in effetti, l’unico rapporto giuridico di DI intercorre, a livello di soggetti,
tra gli Stati i quali si obbligano reciprocamente a vietare, proibire e punire un fenomeno ritenuto
14
così allarmante da legittimare comportamenti degli Stati altrimenti illeciti. E lo stesso si può dire
per il terrorismo: il terrorista rimane oggetto della normativa internazionale e non certo il soggetto.
Il rilievo giuridico dell’individuo nella vita di relazione internazionale è sempre mediato e indiretto
e, oltre al caso del terrorista e del pirata, questa impostazione si conferma valida anche nell’ipotesi
di responsabilità penale personale del criminale internazionale.
In questo caso le situazione ipotizzabili sono due: o il criminale agiva in qualità di organo dello
Stato (la responsabilità penale personale si intende come una sanzione ulteriore che il DI appronta
per le forme più gravi di illecito internazionale dello Stato) oppure non aveva alcun legame
organico con uno Stato (si ricade nell’ipotesi del pirata). In entrambe le situazioni non si tratterebbe
di soggettività internazionale dell’individuo.
In conclusione, si può riscontrare una eccezione muovendo dalla nozione di soggetto-potenza, che
ritiene anche l’individuo, in quanto potenza delle RI, soggetto internazionale, il c.d. potentato
individuale (alcuni esempi sono Napoleone Bonaparte, Hailé Sellassié e Re Giacomo d’Inghilterra).
12. I popoli ed il diritto all’autodeterminazione
La nozione di popolo ed il correlato principio di autodeterminazione dei popoli assunse uno
spiccato rilievo giuridico durante il processo di decolonizzazione promosso dall’ONU dopo la fine
della II Guerra Mondiale.
Il diritto all’autodeterminazione trovò così spazio in numerosi atti giuridici internazionali, al punto
da diventare subito un principio generale di DI, inderogabile e la cui violazione costituisce un
crimine internazionale.
Si definisce diritto all’autodeterminazione il diritto di scegliere liberamente il proprio status politico
e di perseguire, altrettanto liberamente, il proprio modello di sviluppo economico, sociale e
culturale. Un popolo può legittimamente usare la forza per affrancarsi da una dominazione
coloniale, razzista o straniera.
I numerosi richiami normativi alla nozione di “popolo” hanno spinto la dottrina ad interrogarsi sulla
sua eventuale soggettività internazionale. Il popolo, tuttavia, non è destinatario ultimo ed effettivo
del diritto di autodeterminazione ma l’oggetto, il materiale beneficiario della norma internazionale
obbligatoria tra gli Stati.
Al di là della difficoltà di individuare in concreto un popolo sulla base della definizione generale
che lo individua in relazione ad una comunanza tra gli individui di razza, lingua, cultura, religione e
tradizioni, vi è comunque che il popolo non coincide automaticamente con lo Stato (c.d. Stati
multinazionali).
La nozione di autodeterminazione s’è dunque evoluta nel corso dei decenni assumendo, oltre alla
valenza esterna tipica del periodo della decolonizzazione, anche una valenza interna.
Si è cominiciato a definire ed affermare, negli Stati plurinazionali, il diritto del popolo ad
autodeterminarsi internamente, cioè ad avere “un accesso effettivo alle autorità pubbliche rivolto ad
ottenere lo sviluppo politico, economico, sociale e culturale”, con la possibilità, se tale “accesso”
alla vita dello Stato è impedito, che esso si autodetermini anche esternamente.
In conclusione, il limite tra autodeterminazione esterna ed interna è di difficile accertamento, tanto
più considerando le tensioni politiche e sociali che accompagnano le istanze di autodeterminazione
di una collettività all’interno di Stati plurinazionali e che talvolta prendono il sopravvento sul
dialogo politico e sull’applicazione del diritto.
15
CAPITOLO III – IL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE: PRINCIPI E
CONSUETUDINI
1. Precisazioni terminologiche
Le consuetudini (norme generali, consuetudinarie), i trattati (norme particolari, pattizie,
convenzionali) e gli atti delle organizzazioni internazionali (norme di terzo grado) sono le norme
internazionali la cui esistenza è riconosciuta da tutti.
Le consuetudini e i principi sono il prodotto di un processo intrinsecamente socio-giuridico, a
carattere dinamico che è azionato direttamente dagli enti-soggetti dell’ordinamento internazionale.
I trattati, invece, sono il prodotto di un processo socio-giuridico che è procedimentalizzato e
formalizzato, tanto che le norme sono quasi sempre scritte.
Sulla base di ciò, si distingue efficacemente tra diritto spontaneo (consuetudini e principi) e diritto
volontario (trattati).
La volontà dello Stato è sempre presente sia quando il suo comportamento materiale concorre alla
formazione, modifica ed estinzione della consuetudine, sia quando il suo partecipare, con atti
formali e scritti, al procedimento di stipulazione del trattato, concorre alla formazione, modifica ed
estinzione della norma convenzionale.
La differenza tra le due categorie di norme sta solo nel diverso modo in cui si manifesta una volontà
comunque idonea dal punto di vista logico e costitutivo. Ciò che effettivamente distingue le norme
generali da quelle particolari è il processo di formazione.
Infine, il numero dei destinatari non influisce sulla caratteristica costitutiva della norma, che si lega
al processo di formazione: una consuetudine può essere particolare pur restando una norma
generale; il trattato resta una norma particolare anche se si estende a tutti gli Stati, quindi se è
generale.
2. Le asimmetrie normative del diritto internazionale
Nel DI non esiste un rapporto di sovra-ordinazione tra norme generali e norme pattizie: fatte salve
le norme di jus cogens che sono inderogabili, “le norme pattizie hanno in linea di principio
un’efficacia normativa del tutto equivalente ed autonoma rispetto alle regole di diritto non scritto o
consuetudinario”.
Quasi inevitabilmente si avrà la prevalenza della norma pattizia, in quanto il suo contenuto è più
specifico di quello della norma generale. Questa usuale prevalenza della norma pattizia sulla
generale non significa che quest’ultima non prevalga mai, né che l’applicazione della norma pattizia
impedisca ogni residuo rilievo alle norme generali.
Il perdurante rilievo delle norme generali si manifesta, direttamente e indirettamente, nella fase di
interpretazione della norma pattizia.
Un qualsiasi trattato non potrebbe essere applicato ed interpretato come se esistesse un vacuum
normativo, cioè senza alcun riguardo al DI generale o agli altri sistemi convenzionali del DI.
L’ordinamento giuridico internazionale impone l’esigenza della systemic integration, cioè di una
systemic view tra i vari regimi convenzionali ed il diritto internazionale generale.
Si riconosce, comunque, nell’ordinamento giuridico internazionale l’esistenza di asimmetrie
normative, derivate dal fatto che esiste una “informal hierarchy” nel DI dovuta al fatto che “alcune
norme sono più importanti di altre (norme imperative o jus cogens) e che in caso di conflitto, deve
essere dato loro effetto”.
16
3. I principi di diritto internazionale
Posizioni divergenti in dottrina esistono circa la classificazione dei principi quali norme generali.
Distinguiamo, innanzitutto, due principi formali (o sulla produzione normativa) che rappresentano
il fondamento giuridico di obbligatorietà sia delle consuetudini (consuetudo est servanda) che dei
trattati (pacta sunt servanda); essi sono obbligatori perché così vuole il corpo sociale internazionale
di cui sono il primo prodotto giuridico.
L’esistenza di tali principi formali è la conseguenza giuridica, concreta e riscontrabile della secolare
prassi storico-politica internazionale.
Dalla prassi internazionale si derivano, poi, i c.d. principi materiali (o di organizzazione della CI),
cioè quelle norme che disciplinano concretamente alcune singole fattispecie. Il tratto che le
caratterizza sta nel tempo di formazione che è immediato; il modo di formazione è quello spontaneo
proprio di tutte le norme generali.
In generale, la prassi dimostra che i principi materiali sono “espressione immediata, diretta della
volontà del corpo sociale della valutazione istintiva delle situazioni sociali e di una reazione
istintiva a tutto ciò che turba questa armonia”.
Pur essendo norme primarie dell’ordinamento, i principi non sono anche norme “costituzionali”
dello stesso, poiché non ha senso parlare di “costituzione” in ambito internazionale perché
l’ordinamento giuridico di riferimento è l’espressione di una comunità sociale anorganica nella sua
strutturazione e paritaria nei suoi rapporti intersoggettivi. L’ambiente socio-giuridico internazionale
esprime solamente rapporti di stampo privatistico e contrattualistico.
Per questo motivo il fondamento dei DI sta nel fatto diffuso dell’agire e del volere dell’intero corpo
sociale collettivo, non potendo prescindere, dunque, dall’intrinseco legame tra ius e societas
internazionale.
La primarietà dei principi, rispetto ai trattati e alle consuetudini, va ricercata nel nesso diretto ed
immediato che li lega, in quanto prodotto giuridico, alla societas di riferimento, che è il fattore
socio-politico di quella produzione normativa.
Quando si manifesta, la prevalenza dei principi sulle altre norme si deve o al fatto che ne fondano la
stessa obbligatorietà (principi formali) o al fatto che il corpo sociale internazionale li vuole
inderogabili (principi materiali).
4. Segue: l’art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia (CIG)
La maggior parte della dottrina ritiene di assegnare ai principi una “posizione a sé stante, per
sottolineare l’inerenza diretta alla struttura di fondo del sistema e il carattere generalissimo delle
regole che essi consacrano”.
In quest’ottica devono intendersi i sette principi enunciati, nel 1970, dalla Dichiarazione relativa ai
principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati
in conformità della Carta delle Nazioni Unite.
Questa Dichiarazione non fa menzione del tempo di formazione delle sette norme, omissione che
ignora l’immediatezza della formazione del principio, eliminando di fatto la loro distinzione con la
consuetudine, pur riconoscendo ai primi il legame immediato e diretto che caratterizza i principi.
Ciononostante, la maggior parte della dottrina nega l’esistenza dei principi o per via
dell’impostazione metodologica che adotta (normativismo, che ricostruisce il DI senza considerare
la sottostante realtà sociale e fenomenica e procedono sulla base dommatica e presupposta della
grundnorm; positivismo, che riduce l’obbligatorietà di qualsiasi norma alla volontà autonoma e non
17
eteronoma degli Stati, rendendo i diversi tipi normativi indistinguibili) o per via della lettura che
fornisce dell’art. 38 dello Statuto della CIG.
Chi nega i principi in base all’art. 38 dello Statuto della CIG2, considera i “principi generali di
diritto” ivi citati come meri principi metagiuridici di giustizia, equità, utilità etc., per il fatto che
l’art. 38 attribuirebbe alla CIG il potere di creare diritto. I principi generali di diritto sarebbero fonti
materiali del diritto che il giudice dovrebbe utilizzare, creando il diritto per il caso particolare, per
colmare le lacune dell’ordinamento giuridico internazionale.
In base ad un’altra interpretazione del su detto articolo, si ritiene che esso non attribuisca alla Corte
il potere di creare diritto ma solo quello di applicarlo. Da ciò deriva non solo il valore giuridico dei
“principi” ivi richiamati, ma anche che l’art. 38 indichi solamente ai giudici della CIG gli strumenti,
principali e sussidiari, per la risoluzione delle controversie a loro sottoposte, tra cui vi sarebbero i
principi di diritto internazionale esistenti per via autonoma e originaria e non trasferimento dal
diritto interno.
5. La consuetudine
La consuetudine (o uso) è la norma di diritto internazionale generale che si produce per
l’interazione di due elementi (costruzione dualistica):
a) l’elemento oggettivo (diuturnitas, usus) dato dalla ripetizione costante e conforme di un
determinato comportamento da parte dei soggetti di diritto internazionale; il lasso di tempo
necessario alla formazione della norma può anche essere relativamente breve, sebbene mai
immediato. Numerosi e diversi sono i fatti idonei alla formazione della consuetudine, in
particolare:
- la prassi diplomatica e gli altri atti e comportamenti degli Stati: con essa si intendono le
più diverse e svariate “espressioni di punti di vista, intenzioni, richieste, pretese” che
manifestano, attraverso la corrispondenza diplomatica, la posizione degli Stati sulle
questioni attinenti le RI; gli altri atti sono invece gli atti interni allo Stato aventi natura
legislativa, amministrativa e giurisdizionale, mentre i comportamenti consistono di atti
materiali riferibili allo Stato;
- la giurisprudenza internazionale;
- i trattati internazionali
b) l’elemento soggettivo (opinio iuris sive necessitatis) dato dal convincimento del soggetto
che quel comportamento sia giuridicamente necessario e quindi obbligatorio.
A riguardo dell’elemento soggettivo, per alcuni, l’opinio iuris del soggetto sta nella convinzione
che il comportamento si conformi ad una norma giuridica già esistente e che, per questo, sia
obbligatoriamente dovuto; per altri, invece, l’opinio iuris è la convinzione che il comportamento,
proprio mancando una preesistente regolamentazione giuridica, debba essere tenuto perché
doveroso verso gli altri membri della comunità sociale di riferimento.
2 Articolo 38 dello Statuto della CIG:
1. La Corte, la cui funzione è di decidere in base al diritto internazionale le controversie che le sono sottoposte, applica:
a. le convenzioni internazionali sia generali che particolari, che stabiliscono norme espressamente riconosciute dagli
Stati in lite; b. la consuetudine internazionale, come prova di una pratica generale accettata come diritto; c. i principi
generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; d. con riserva delle disposizioni dell'articolo 59, le decisioni
giudiziarie e la dottrina degli autori più qualificati delle varie nazioni come mezzi sussidiari per la determinazione delle
norme giuridiche.
2. Questa disposizione non pregiudica il potere della Corte di decidere una controversia ex aequo et bono qualora le
parti non siano d'accordo.
18
La prima interpretazione, implicando che le consuetudini si formino per errore, va respinta. La
seconda risulta fondata dalle dinamiche socio-giuridiche internazionali, fatto salvo il fatto che
l’elemento soggettivo sia presente solo nella fase di formazione della norma.
Una volta che il comportamento sia divenuto norma giuridica, l’atteggiamento psicologico del
soggetto può consistere solo nella consapevolezza di rispettare la norma già esistente rispetto a cui
il soggetto non è più uno dei fattori che ha contribuito alla sua formazione, ma solamente un
destinatario.
In linea di principio e salva l’ipotesi della consuetudine particolare (locale, regionale), il fatto che il
comportamento sia osservato, perché considerato giuridicamente doveroso, dalla maggioranza dei
soggetti della CI, impone il rispetto della norma anche agli Stati che non hanno contribuito o che si
sono opposti alla sua nascita. La prassi internazionale, diplomatica e giurisprudenziale, conferma
questa ricostruzione del fondamento di obbligatorietà della consuetudine.
Tale impostazione sistematica, da un lato, trova eccezione nelle consuetudini particolari (locali o
regionali) e, dall’altro, è invece contestata dalle teorie consensualistche che rigettano l’idea che le
consuetudini possano vincolare gli Stati indipendentemente dalla loro volontà, propendendo per la
loro applicazione solo agli Stati che le abbiano accettate o riconosciute e non a quelli che ne
abbiano conteStato la nascita o la vigenza, c.d. Stati obiettori persistenti; i consensualisti riducono,
dunque, l’obbligatorietà della consuetudine ad un accordo di natura tacita, c.d. tacita conventio o
factum tacitum, tra gli Stati che determinerebbe la sua formazione.
Tale tesi non è accettabile perché non coglie l’interazione dello Stato con la CI e perché la prassi
internazionale è di segno nettamente contrario.
6. Lo Stato obiettore persistente e la consuetudine regionale o locale
Lo Stato obiettore persistente è quello che ripetutamente contesta la doverosità giuridica di un
comportamento tenuto da altri Stati nelle RI e, di conseguenza, non si ritiene poi obbligato al
rispetto dell’eventuale consuetudine che da quel comportamento si sia venuta a formare.
Da un lato, il problema dell’applicabilità della consuetudine allo Stato obiettore si pone solo dopo
che la norma si è formata e, dall’altro, prima della formazione della norma, l’obiezione non ha ad
oggetto la norma, ma i comportamenti materiali e l’opinio iuris degli altri Stati dai quali potrebbe
nascere la consuetudine.
Al riguardo si possono avere tre ipotesi:
1) la consuetudine esiste ed ha carattere generale;
2) la consuetudine esiste ma ha carattere particolare, vale cioè solo per alcuni Stati;
3) non esiste alcuna consuetudine.
Nella teoria generale, il problema dell’obiettore si pone solo nel caso 1, negli altri due siamo di
fronte, rispettivamente, ad una consuetudine particolare e a semplici pretese politiche talmente in
contrasto da non essersi riuscite a tradurre in norme consuetudinarie.
La consuetudine particolare ha un ambito soggettivo di applicazione limitato ai soli Stati che
hanno concorso a formarla ed è anche detta regionale o locale perché, di solito, si forma e si applica
all’interno di aree geografiche circoscritte ed omogenee per storia, tradizioni, costumi, lingua, etc.
Se si assume ad elemento costitutivo delle norme generali il modo spontaneo di formazione, e non
l’ambito soggettivo di applicazione, anche tra pochi Stati si può ben formare una norma in modo
spontaneo, e chi resta estraneo alla consuetudine particolare, vi resta perché la norma non ha un
carattere generale.
La giurisprudenza internazionale (CIG) non afferma l’esistenza di consuetudini generali, poi
derogate a favore dello Stato obiettore persistente, ma afferma:
19
a) l’esistenza di una consuetudine generale rispetto alla quale l’obiezione persistente dello
Stato è giuridicamente irrilevante;
b) l’esistenza di una consuetudine particolare rispetto alla quale lo Stato non è un obiettore ma,
in effetti, un vero e proprio estraneo;
c) l’inesistenza di qualunque consuetudine, generale o particolare che sia.
La prassi degli Stati conferma l’inesistenza dell’obiezione persistente: oltre al caso
dell’applicazione ai nuovi Stati delle consuetudini preesistenti alla loro stessa nascita, anche in altri
occasioni lo Stato ha applicato, infine, la norma che aveva obiettato in modo persistente oppure gli
altri Stati lo hanno ritenuto astretto al suo rispetto indipendentemente dalle sue obiezioni.
Tenuto conto della teoria generale del DI generale, dell’esistenza della consuetudine particolare,
della giurisprudenza e della prassi, ci sembra che la nozione dello Stato obiettore persistente sia da
respingere.
7. Lo jus cogens
La nozione di jus cogens, cioè di norme imperative (inderogabili) di DI generale, è costitutivamente
caratterizzata dall’impossibilità per tutte le altre norme (consuetudinario o convenzionali) di
derogarla a pena di nullità.
Le norme di jus cogens godono di superiorità gerarchica rispetto alle altre norme del DI, mentre in
caso di contrasto tra due o più norme di jus cogens si utilizzano i normali strumenti di
interpretazione e risoluzione delle antinomie normative.
La nozione è oggi codificata nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati:
- l’art. 53 dopo aver sancito la nullità di qualsiasi trattato in contrasto con lo jus cogens,
definisce la norma imperativa del DI generale come quella “accettata e riconosciuta dalla CI
degli Stati nel suo insieme come norma alla quale non è consentita alcuna deroga e che può
essere modificata soltanto da una successiva norma del DI generale avente lo stesso
carattere”.
- l’art. 71 prevede le conseguenze dell’invalidità del trattato in contrasto con lo jus cogens e
consistono, oltre che ne venir meno dell’obbligo per gli Stati parti di continuare ad eseguire
il trattato, negli ulteriori obblighi di “eliminare, possibilmente, le conseguenze di qualsiasi
atto compiuto sulla base” delle norme nulle e di rendere i rapporti tra loro conformi alla
norma di jus cogens. In caso di nullità sopravvenuta, la nullità non ha effetto retroattivo e
sono fatti salvi i diritti, gli obblighi e le situazioni giuridiche derivanti dall’esecuzione del
trattato prima che sopravvenisse la nullità.
La dottrina prevalente colloca le norme di jus cogens non in una categoria a sé ma all’interno delle
altre consuetudini da cui si distinguono per l’inderogabilità, cioè per una peculiarità di tipo
normativo e non costitutivo. Per quanto riguardi la loro individuazione, manca nella Convenzione di
Vienna un criterio concreto. È solo dall’esame della prassi degli Stati e della giurisprudenza
internazionale che, in concreto, si individuano le norme di jus cogens oggi viventi.
Le norme imperative di DI generale hanno anche la caratteristica di dar luogo, se violate, ad un
regime rafforzato di responsabilità internazionale: l’art. 41 del Progetto di articoli ricollega alla
grave violazione di una norma di jus cogens:
a) l’obbligo per tutti gli Stati di cooperare al fine di porre termine alla violazione;
b) l’obbligo per tutti gli Stati di non riconoscere come legittima la situazione creatasi a seguito
della violazione e di non aiutare o contribuire al perdurare dell’illecito.
Per essere rilevante ai fine dell’applicazione del regime di responsabilità aggravata, la violazione
deve essere grave o sistematica.
20
8. Le dichiarazioni di principio dell’Assemblea Generale dell’ONU e gli atti unilaterali
L’Assemblea Generale (AG) dell’ONU “può fare raccomandazioni ai membri delle Nazioni Unite
od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed all’altro, su qualsiasi questione o argomento che rientri
nei fini della Carta”. Le risoluzioni emanate dall’AG sono innumerevoli, e tra queste ve ne sono
alcune che la stessa AG definisce dichiarazioni di principi e il cui contenuto richiama concetti,
valori o aspettative di particolare rilievo per la CI.
A differenza di tutte le altre risoluzioni, ci si chiede se le dichiarazioni di principi possano avere un
effetto giuridico diretto sulla formazione delle norme internazionali. Ciò non è assolutamente
possibile, poiché gli atti dell’AG non sono giuridicamente vincolanti per gli Stati membri che per
primi dimostrano chiaramente di non attribuire effetti giuridici vincolanti alle risoluzioni
dell’organo. Neanche la prassi successiva interna dell’ONU sostiene la tesi precedentemente
esposta: non è il consenso politico (anche quando unanime) a modificare il tipo normativo dell’atto
che è sfornito di qualunque obbligatorietà giuridica.
Le dichiarazioni di principi possono rilevare per la formazione delle norme internazionali in via
unicamente indiretta, cioè possono rappresentare uno dei molteplici elementi della prassi che
contribuiscono alla formazione di una norma consuetudinaria, se ripetuti nel tempo e se supportati
da un’opinio juris qualificata.
Gli atti unilaterali sono manifestazioni di volontà che producono effetti giuridici nell’ordinamento
internazionale senza necessità che prima si “incontrino” con un’altra manifestazione di volontà
proveniente da un diverso soggetto, come invece avviene nella quasi totalità dei casi.
Gli atti unilaterali producono effetti giuridici in sé e per sé, per il fatto che anche un solo soggetto
ha manifestato una volontà tesa a produrre effetti giuridici. Nella categoria vanno ricordati:
- la denuncia o il recesso da un trattato, con cui lo Stato si svincola nei confronti degli altri
Stati parti al rispetto degli obblighi sanciti dal trattato;
- la richiesta, cioè l’atto introduttivo di un ricorso di fronte ad un’istanza decisoria
internazionale;
- la rinuncia, cioè l’atto di disposizione di un diritto che produce effetti estintivi per lo stesso;
- la promessa, cioè la dichiarazione unilaterale di tenere (o non tenere) un certo
comportamento che comporta l’obbligo per il promittente di adempiere quanto promesso, in
seguito alla chiara manifestazione dell’intenzione del promittente di volersi vincolare
giuridicamente.
21
CAPITOLO IV – IL DIRITTO INTERNAZIONALE CONVENZIONALE: I TRATTATI
1. Definizione e caratteristiche fondamentali
Il trattato (o accordo, convenzione, patto, carta, protocollo, etc.) è la fonte di produzione normativa
internazionale, in quanto crea norme pattizie, che ha assunto un rilievo preponderante come
strumento di regolazione giuridica delle relazioni interstatuali.
Il trattato viene definito dalla Convenzione di Vienna come “l’accordo internazionale concluso in
forma scritta fra gli Stati e disciplinato dal diritto internazionale, contenuto sia in un unico
strumento sia in due o più strumenti connessi, e quale che sia la sua particolare denominazione”.
Da questa definizione restano però esclusi sia i trattati conclusi in forma orale che quelli conclusi tra
Stati ed OI o tra due o più OI per i quali il riferimento è la Convenzione di Vienna del 1986, non
ancora in vigore.
Non sono trattati internazionali ma contratti internazionali gli accordi conclusi tra Stati e società o
investitori stranieri, né sono trattati internazionali gli accordi tra enti territoriali di Stati diversi.
Nei trattati l’accordo consiste nella convergenza delle volontà di due o più soggetti internazionali
tesa a creare, modificare, estinguere norme giuridiche; attraverso il vincolo costitutivo le parti
reciprocamente assumono l’obbligo di rispettare, applicare ed eseguire il contenuto del trattato.
L’obbligatorietà dei trattati si fonda sulla norma pacta sunt servanda, superiore ai trattati, che
traduce giuridicamente l’aspettativa sociale della CI che gli impegni solennemente assunti siano
rispettati e che la loro violazione sia sanzionata come illecita.
La manifestazione di volontà secondo le procedure previste dall’ordinamento interno ed
internazionale è solamente la condizione da integrare per assumere il vincolo che resta comunque
eteronomo rispetto alla volontà dello Stato parte al trattato. Infatti, la norma pacta sunt servanda
produce, nei confronti della volontà degli Stati di essere parti al singolo trattato, lo stesso effetto di
fondare l’obbligatorietà di tutti i trattati internazionali.
2. Trattati-legge e Trattati-contratto. Pseudo-trattati. Trattati multilaterali generali e
formazione di una consuetudine da una norma convenzionale.
La natura giuridica delle RI fa sì che l’accordo possa avere solo natura contrattualistica, ovvero
privatistica: gli Stati, attraverso il trattato, non legiferano, ma contrattano.
Non ha infatti senso la distinzione del XIX secolo proposta tra trattati-legge (trattato-accordo,
trattato-normativo) e trattato-contratto (trattato-negozio) in base a cui, presupponendo che tutti i
trattati possano avere carattere sia pubblicistico che privatistico, si riteneva che i primi
producessero, in via eteronoma, diritto oggettivo, mentre i secondi producessero, in via autonoma,
solo diritti e obblighi tra le parti.
I primi, quindi, manifestazione di una volontà di “obbligare”, cioè di una volontà “autoritaria”; i
secondi, invece, di una volontà di “obbligarsi”, di una volontà “negoziale”.
Su tale errata impostazione, si proponeva poi per i trattati internazionali la distinzione tra negoziofonte e negozio-condizione, sensata solo in un contesto pubblicistico. Tuttavia, non producendo
effetti “pubblicistici” di diritto oggettivo, i trattati internazionali sono solo negozio-fonte,
assimilabili ai contratti obbligatori atipici di diritto interno.
Recentemente, la dottrina ha attribuito ad alcune categorie di trattati la definizione di normativi (o
legislativi o universali) e hanno ricostruito i loro effetti obbligatori come obbligazioni “collettive”
erga omnes partes (i.e. Carta dell’ONU, Trattato OMC, diritti umani, energia nucleare, etc.).
Può accadere, ed è ammessa tale possibilità, che una norma contenuta in un trattato diventi anche
una norma consuetudinaria, “travalicando”, così, il proprio ambito soggettivo di applicazione e
diventando anche una consuetudine se, dopo la conclusione del trattato, la CI, con una prassi
22
qualificata e costante, consideri il contenuto di una o più norme del trattato come vincolante
indipendentemente dall’essere parte al trattato, cioè come norma generale applicabile a tutti.
In tal caso allo Stato non parte al trattato non si applica l’originaria norma convenzionale, ma quella
consuetudinaria di identico contenuto che la prassi ha formato in un secondo momento.
QUADRI definì fittizia la pretesa di “sostenere che una consuetudine formatasi in senso conforme
all’accordo, in seguito a questo” vincoli gli Stati terzi al trattato: questi ultimi sarebbero vincolati
dal principio di DI che “si cela” sotto la forma di quello che non è un vero trattato ma uno pseudotrattato (o pseudo-accordo).
L’esistenza di uno pseudo-trattato non esclude la possibilità che una consuetudine nasca da un
trattato. Un trattato può infatti dare solenne conferma di un principio o di una consuetudine già
esistenti (pseudo-trattato), ma può anche accadere che, al momento della conclusione del trattato, la
consuetudine non esista e si venga a formare in un momento successivo.
In questo ultimo caso, alla fine del processo di produzione normativa, esistono due norme, di
identico contenuto, che coesistono nell’ordinamento internazionale e che producono effetti ciascuna
secondo il modo (generale o particolare) della propria categoria di appartenenza.
Tuttavia, questi due tipi normativi, pur avendo identico contenuto, possiedono un differente
funzionamento: un trattato a partecipazione universale resta uno strumento di DI particolare le cui
norme si formano, modificano ed estinguono in base alle regole di funzionamento del
corrispondente tipo normativo (non si intenda dunque il “trattato generale” come appartenente al DI
generale come le consuetudini e i principi).
Secondo TUNKIN, i “trattati multilaterali generali” (ricompresi dall’autore tra le norme di DI
generale) deriverebbero gli effetti delle loro norme per gli Stati terzi al trattato non
dall’”ultrattività” della norma convenzionale ma dall’esistenza di una unica norma mista (mixed
norm) contenuta nel trattato ma di DI generale che, contemporaneamente spiegherebbe effetti di
tipo convenzionale per gli Stati parti ed effetti di tipo consuetudinario per gli Stati terzi.
Tali tesi si limita a ritenere che le norme dei trattati multilaterali generali producano obblighi verso
gli Stati terzi in quanto anche e contemporaneamente norme consuetudinarie, sulla base di una sorta
di “sdoppiamento” degli effetti obbligatori della norma in funzione dell’essere il destinatario parte o
meno al trattato. Tale teoria non è comunque né sostenuta dalla logica né riscontrata nella realtà.
3. Obblighi reciproci, assoluti ed interdipendenti
Un trattato bilaterale o plurilaterale fissa obblighi tra gli Stati di natura reciproca. In caso di loro
violazione, solo lo Stato cui era dovuto l’obbligo potrà far valere la responsabilità internazionale
dello Stato che quell’obbligo ha violato.
Anche le consuetudini, di solito, fissano obblighi di natura reciproca: anche in tal caso è solo Stato
cui era dovuto l’obbligo violato che può agire.
Esistono, accanto agli obblighi di natura reciproca, altri obblighi dovuti dal singolo Stato non ad un
altro, ma a tutti gli altri Stati della CI, oppure a tutti gli altri Stati parti al trattato: rispettivamente,
obblighi erga omnes e obblighi erga omnes partes, che caratterizzano alcune norme che tutelano
valori ritenuti particolarmente importanti dagli Stati.
Sebbene dalle peculiarità normative dello jus cogens e degli obblighi erga omnes non si possa
desumere una gerarchia formale nell’ordinamento internazionale, si può però desumere una
prevalenza di tipo “interpretativo”. È significativo comunque che in ragione dell’importanza del
valore tutelato, si faccia prevalere la norma del trattato a più ampia partecipazione o quella che ha
ad oggetto il valore più importante.
23
Proprio con riguardo alle obbligazioni convenzionali la dottrina ha distinto tra:
- obblighi interdipendenti: il loro adempimento ad opera di una parte dipende
necessariamente, per le caratteristiche del trattato, dal corrispondente adempimento ad opera
di tutte le altre;
- obblighi reciproci: essi consistono in un “mutuo e reciproco scambio di benefici o
concessioni tra le parti;
- obblighi integrali (o assoluti): essi richiedono “un’applicazione ed un’esecuzione assoluta
ed integrale in ogni caso” e si ritrovano nei trattati a tutela dei diritti umani. Essi hanno
carattere assoluto e non reciproco; sono rivolte al “mondo intero piuttosto che alle singole
parti, per cui la cui violazione ad opera di uno Stato parte non legittima gli altri Stati parti a
denunciare il trattato o ad adottare corrispondenti contromisure, neanche nei confronti dei
cittadini dello Stato inadempiente: il che è particolarmente importante nei trattati di diritto
umanitario (es. tutela prigionieri di guerra).
L’individuazione dei tre tipi di obblighi distingue le conseguenze giuridiche che, in caso di loro
violazione, si verificano per le altre parti:
1) in caso di violazione sostanziale ad opera di uno Stato di un obbligo integrale, le altre parti
contraenti non potranno invocare tale violazione come motivo di estinzione del trattato (o di
sospensione totale o parziale della sua applicazione);
2) in caso di violazione sostanziale ad opera di uno Stato di un obbligo interdipendente, qualsiasi
altra parte contraente potrà invocare, per quanto la riguarda, tale violazione come motivo di
sospensione totale o parziale dell’applicazione del trattato.
L’incompatibilità tra norme contenute in trattati diversi va risolta non in termini di
gerarchia/invalidità ma di prevalenza/disapplicazione (salvo il caso di contrasto con lo jus cogens).
Le antinomie normative vanno, dunque, risolte dando ai trattati interpretazioni tra loro compatibili
o, altrimenti, lasciando agli Stati l’individuazione, volta per volta, della soluzione migliore.
4. Obblighi erga omnes e erga omnes partes
La sentenza della CIG del 1970 distinse tra gli obblighi che uno Stato assume bilateralmente nei
confronti di un altro e quelli che assume nei confronti dell’intera CI. Rispetto a questi ultimi, “tutti
gli Stati hanno capacità di avere interessi legittimi nella loro protezione; sono obbligazioni erga
omnes”.
Gli obblighi erga omnes hanno la caratteristica di essere dovuti nei confronti di tutti gli Stati e,
quindi, di essere esigibili da qualunque Stato nei confronti di chi li abbia violati. Accanto a questi
tipi di obblighi, vi sono i c.d. obblighi bilaterali, per cui gli Stati sono tenuti reciprocamente al loro
rispetto, in caso di violazione dell’obbligo ad opera di una parte, solo l’altra ha titolo per invocarne
la responsabilità.
La principale conseguenza dell’essere un obbligo erga omnes è “procedurale” nel senso che la sua
violazione può essere invocata da qualunque Stato: l’obbligo è “legalmente indivisibile”. È infatti
previsto che uno Stato diverso da quello leso possa invocare la responsabilità internazionale di chi
ha violato l’obbligo, in due casi:
a) quando l’obbligo violato è “posseduto da un gruppo di Stati incluso lo Stato che lo viola, ed è
stabilito in protezione di un interesse collettivo del gruppo”;
b) quando l’obbligo violato “appartiene all’intera CI”.
Gli obblighi erga omnes possono avere sia fondamento consuetudinario che convenzionale, cioè
possono essere sia erga omnes (ipotesi b) sia erga omnes partes (ipotesi a) .
Sul dubbio circa l’esistenza di tali obblighi, lo studio del 2006 della Commissione di Diritto
Internazionale (CDI) sulla Fragmentation del DI, ha riaffermato l’esistenza degli obblighi erga
omnes, ricostruendoli nel senso che:
a) lo Stato (non direttamente leso dalla violazione) è legittimato ad agire in nome e per conto di
tutti, c.d. uti universi, perché membro della CI;
24
b) la reazione alla violazione può anche non essere collettiva e, quindi, lo Stato non leso può
agire da solo o in seno ad una coalizione di Stati;
c) esiste un’analogia (come se) tra l’attuazione collettiva degli obblighi erga omnes e
l’esercizio dei poteri pubblici nel diritto interno.
Seppur forti le somiglianza, l’assimilazione tra jus cogens e obblighi erga omnes è da respingere: le
prime non impongono sempre e necessariamente anche obblighi erga omnes; pur essendo tutelati
gli identici valori, resta diverso lo strumento normativo di garanzia: l’inderogabilità per le prime,
l’esigibilità per le seconde.
La tutela erga omnes è “solo” il riflesso normativo della volontà politica degli Stati che, in un dato
momento storico, avvertono l’esigenza di approntare una tutela giuridica rinforzata per certi valori.
5. Trattati e Stati terzi. La codificazione del diritto internazionale
In quanto diritto particolare , i trattati producono effetti solamente tra le parti contraenti, c.d. pacta
tertiis nec nocent neque prosunt. Gli Stati terzi ne restano giuridicamente estranei, anche quando
beneficiano materialmente del trattato, poiché i trattati sono res inter alios acta. Diversa è la
questione quando gli Stati conferiscono alla Stato terzo un diritto o un obbligo sulla base del loro
trattato: in questo caso è necessario il consenso dello Stato terzo per assumere l’obbligo
(accettazione espressa e in forma scritta) o per esercitare il diritto (consenso presunto, salvo
contraria indicazione); altrimenti il trattato non produce alcune effetto giuridico per lo Stato terzo.
La c.d. codificazione del DI consiste nel rilevare e formulare per iscritto, attraverso la conclusione
di trattati, le norme consuetudinarie ed i principi internazionali già esistenti in modo da garantire
una maggiore chiarezza e una maggiore certezza del diritto non scritto.
Anche la codificazione non va intesa in senso pubblicistico (potestà legislativa), ma in senso
privatistico, cioè come espressione inevitabile del “contrattualismo” che permea le RI.
La sua importanza risiede anche nel favorire lo sviluppo progressivo del DI, compito attribuito dalla
Carta dell’ONU all’AG attraverso studi e raccomandazioni.
Per “sviluppo progressivo del DI” la CDI ha inteso “la preparazione dei trattati su materie che non
sono state ancora regolate dal DI o per le quali il diritto non è stato ancora sufficientemente
sviluppato nella prassi degli Stati”.
Il momento della codificazione è anche l’occasione per emendare o migliorare norme già vigenti o
per consolidare normativamente comportamenti sociali non ancora definitivamente avvertiti come
doverosi dalla coscienza giuridica collettiva degli Stati.
La conseguenza di essere una norma di mera codificazione o norma di sviluppo progressivo è di
non poco conto: nel primo caso, la norma si imporrà a tutti gli Stati per il fatto di essere già e
comunque una consuetudine; nel secondo caso, la norma vincolerà solo gli Stati parti dell’accordo
per il fatto di non appartenere al DI generale.
Tra gli accordi di codificazione e di sviluppo progressivo del DI va annoverata la Convenzione sul
diritto dei trattati del 1969 che sistema organicamente tutta la materia del c.d. “diritto dei trattati”.
6. Procedura di formazione del trattato: negoziato, autenticazione, firma
La Convenzione di Vienna del 1969 si applica solo ai trattati conclusi tra Stati, mentre la
Convenzione di Vienna del 1986 si applica a quelli conclusi tra OI e tra OI e Stati.
Lo Stato ha la capacità di concludere trattati, per il tramite di un suo rappresentante, cioè
l’individuo che attesti formalmente di esserlo attraverso l’esibizione di un documento, c.d. pieni
poteri, definito come “documento emanante dall’autorità dello Stato e che designa una o più
persone a rappresentare lo Stato per la negoziazione, l’adozione o l’autenticazione del testo di un
25
trattato, per esprimere il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato o per compiere
qualsiasi altro atto che si riferisca al trattato”. La presentazione del documento che attesta l’essere
plenipotenziario, non è necessaria in due casi:
1) quando “dalla pratica degli Stati interessati o da altre circostanze [risulta] che essi avevano
l’intenzione di considerare quella persona come rappresentante dello Stato a quei fini e di
non richiedere la presentazione dei pieni poteri”;
2) quando alla formazione del trattato partecipino determinate categorie di persone che, in virtù
delle loro specifiche funzioni o della posizione ricoperta nell’ordinamento dello Stato, sono
ipso facto considerati rappresentanti dello Stato.
L’atto compiuto dalla persona priva del potere di rappresentare ed impegnare lo Stato non produce
effetti giuridici, salva successiva conferma dello Stato interessato.
La procedura di formazione del trattato segue un “percorso-tipo” che inizia con i negoziati
(trattative): durante questi, gli Stati si confrontano e discutono le rispettive posizioni alla ricerca di
un’intesa comune che possa essere trascritta in un documento scritto giuridicamente vincolante.
In caso di esito positivo, le intese vengono “cristallizzate” in un documento scritto mediante la sua
adozione.
L’adozione ha lo scopo di chiudere il negoziato su una determinata versione del testo del trattato ed
avviene di solito all’unanimità (nel caso di una conferenza internazionale, è richiesta la
maggioranza dei 2/3).
Un effetto significativo che si collega all’adozione del trattato è che da quel momento sono
vincolanti le disposizioni del trattato attinenti a “questioni che si pongono necessariamente prima
dell’entrata in vigore del trattato”.
L’autenticazione del testo del trattato conferisce definitività, anche dal punto di vista formale, al
testo che non può più essere modificato, salva la riapertura formale dei negoziati e la rinnovazione
dell’intero iter di formazione del trattato. Con l’autenticazione del trattato si chiude la fase di
formazione iniziata con i negoziati e si apre quella della stipulazione.
Durante la fase della stipulazione, gli Stati manifestano il consenso a vincolarsi giuridicamente al
contenuto del trattato autenticato; all’esito di questa seconda fase, il trattato entra in vigore
producendo effetti giuridici per gli Stati parti.
La firma, oltre ad autenticare il trattato e salvo il caso della stipulazione in forma semplificata,
produce anche l’effetto per cui lo Stato che ha firmato il trattato “deve astenersi”, prima della sua
entrata in vigore, dal compiere “atti che priverebbero il trattato del suo oggetto e del suo scopo”. Lo
Stato, dopo la firma, non può porre in essere atti pregiudizievoli all’oggetto e allo scopo del trattato,
a meno che non manifesti espressamente agli altri firmatari l’intenzione di non divenirne mai parte,
cioè l’intenzione di non dare seguito giuridico (manifestazione del consenso) alla firma apposta sul
testo autenticato del trattato. Tale divieto vale anche quando la procedura di formazione del trattato
sia in diversa fase o non contempli la firma e la successiva manifestazione del consenso.
Se lo Stato intende compiere atti pregiudizievoli nel periodo che intercorre tra l’avvenuta
stipulazione e l’entrata in vigore, esso dovrà attivare la procedura formale di denuncia;
diversamente, incorrerà nella responsabilità internazionale per inadempimento.
7. Segue: stipulazione in forma solenne e semplificata. Entrata in vigore
Riguardo le forme di stipulazione del trattato vige un fondamentale e ultrasecolare principio di
libertà delle forme in base al quale gli Stati sono liberi di scegliere tra loro qualunque mezzo per
manifestare il consenso ad essere vincolati dal trattato.
26
Nella prassi, sono due le forme e procedure (internazionali, che assumono diretto valore
nell’ordinamento giuridico) che si sono affermate: le forme semplificate e quelle solenni di
stipulazione.
Salvo il caso in cui il trattato firmato violi manifestamente una norma di importanza fondamentale
del diritto interno di uno Stato, ogni violazione del diritto interno non può essere opposta, sul piano
internazionale, agli altri Stati contraenti.
Nel momento in cui lo Stato porta a conoscenza legale degli altri che, nel proprio ordinamento, ha
perfezionato, nel rispetto delle proprie norme interne, le procedure necessarie a manifestare il
consenso ad obbligarsi rispetto al trattato già firmato, la procedura internazionale è perfetta.
Le procedure di stipulazione del trattato sono due:
- forma solenne (ratifica, accettazione, approvazione e adesione): l’espressione del consenso
a vincolarsi può risultare da apposito atto scritto che prende il nome di ratifica o
accettazione o approvazione. A differenza dell’adesione, i tre atti presuppongono una previa
firma da ratificare, approvare o accettare. L’espressione solenne del consenso può anche
risultare dall’adesione (o accessione) dello Stato al trattato, nel caso in cui lo Stato sia
“intervenuto”, manifestando il suo consenso, in un momento successivo rispetto agli Stati
contraenti originari. Tale possibilità deve però essere prevista espressamente dagli Stati
contraenti originari, ovvero il trattato deve essere “aperto”.
Il documento che attesta la ratifica, detto strumento di ratifica, deve essere poi portato a
conoscenza legale degli altri Stati affinché la manifestazione di consenso dello Stato
produca l’effetto giuridico di obbligarlo rispetto al trattato nei confronti degli altri Stati.
Questa fase avviene tramite: scambio degli strumenti; deposito degli strumenti presso il
depositario indicato nel trattato; notifica degli strumenti agli altri Stati contraenti o al
depositario del trattato.
Il completamento di tale procedura a volte coincide con l’entrata in vigore del trattato.
- forma semplificata (firma e scambio degli strumenti costituenti di un trattato): essa consiste
di due procedure: la firma e lo scambio degli strumenti costituenti il trattato. In linea
generale, l’entrata in vigore del trattato coincide, nelle forme semplificate, con la firma o
l’avvenuto scambio degli strumenti.
Le modalità e i tempi dell’entrata in vigore di un trattato sono molto diversi e sono rimessi alla
volontà degli Stati. Di solito, simili previsioni sono contenute nelle disposizioni finali del trattato;
se manca ogni previsione, il trattato entra in vigore “non appena il consenso a vincolarsi ad esso sia
Stato espresso da tutti gli Stati che hanno partecipato alla negoziazione”.
Trattati bilaterali
Entrata in vigore coincide con il momento in cui
gli Stati vengono reciprocamente a legale
conoscenza del consenso all’essere vincolati.
Trattati multilaterali
Entrata in vigore è condizionata al deposito di
un determinato numero di strumenti di ratifica,
in modo da eliminare ogni incertezza sulla sua
entrata in vigore.
Gli Stati possono comunque convenire che un trattato, sebbene non ancora in vigore, si applichi a
titolo provvisorio.
8. Interpretazione, emendamento e modificazione del trattato
Le norme sull’interpretazione dei trattati, in quanto norme internazionali vincolanti per gli Stati
parte, si impongono anche al giudice interno che, se chiamato a interpretare un trattato
internazionale, le dovrà applicare in luogo delle disposizioni interne.
27
La regola generale e primaria di interpretazione stabilisce che un trattato “deve essere interpretato in
buona fede, seguendo il buon senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e
alla luce del suo oggetto e scopo”. Abbiamo poi vari approcci:
- approccio letterale, cioè di carattere oggettivo e finalizzato alla comprensione del
significato letterale del testo;
- approccio teleologico, cioè che tenga conto dell’oggetto e dello scopo del trattato: di fronte
a due possibili interpretazioni della stessa norma si adotta quella maggiormente compatibile
e coerente con il fine del trattato;
Nell’interpretazione dei trattati si può ricorrere ai c.d. i mezzi sussidiari di interpretazione (i lavori
preparatori del trattato e le circostanze nelle quali è stato concluso, i principi ermeneutici di portata
generale, i criteri di logica giuridica del diritto romano e l’interpretazione analogica) solo in due
casi:
a) quando serva a confermare “il senso che risulta dall’applicazione della regola generale e
primaria dell’interpretazione”;
b) quando serve a chiarire il senso dell’interpretazione dopo l’applicazione della su detta regola
ha lasciato il significato della disposizione “ambiguo o oscuro” oppure ha condotto ad un
risultato “manifestamente assurdo o irragionevole”.
L’emendamento si intende come l’alterazione delle disposizioni del trattato a seguito di un accordo
tra tutti gli Stati parti. Al trattato di emendamento si applicano le regole sulla conclusione e l’entrata
in vigore dei trattati: esso è dunque un normale trattato internazionale che presenta la specificità di
alterare, in tutto o in parte, un trattato già in vigore.
È fatta salva la diversa volontà degli Stati, che possono prevedere, soprattutto per i trattati
multilaterali, dettagliate procedure di emendamento.
Tuttavia, “l’accordo di emendamento non vincola gli Stati che sono già parti al trattato e che non
divengano parti di detto accordo”. Questa ipotesi non va confusa con quella della modifica del
trattato inter se, cioè a seguito di un accordo intervenuto ab initio solo tra alcuni Stati parti. Nel
primo caso, l’intenzione iniziale è quella di giungere ad un’alterazione generale del trattato, sebbene
alcuni Stati parti possano restarne fuori; nel secondo caso, sin dall’inizio l’intenzione di alterare il
trattato è solo di alcuni Stati, i quali concludono solo tra loro (inter se) l’accordo modificativo.
La successione tra due diversi trattati aventi ad oggetto la stessa materia si regola a seconda che
tutte le parti del trattato anteriore siano anche parti a quello posteriore, oppure no (non esiste l’idea
di una gerarchia formale): nel primo caso, è previsto che “il trattato anteriore si applica soltanto
nella misura in cui le disposizioni sono compatibili con quelle del trattato posteriore; nel secondo
caso, vige la stessa regola già vista per il caso di difformità tra gli Stati parti alla versione originaria
e alla versione emendata dello stesso trattato multilaterale: tra gli Stati parti ad entrambi i trattati si
applicano le regole del trattato anteriore che siano compatibili con quello posteriore; tra lo Stato
parte ai due trattati e lo Stato parte ad uno solo di essi, si applicano le regole del trattato cui
entrambi sono parti.
La modificazione dei trattati (accordi inter se) consiste nell’alterazione dei trattati multilaterali solo
tra alcuni degli Stati parti. Qui, vi è l’intenzione, sin dall’inizio, di alcuni Stati parti al trattato di
modificarlo limitatamente ai rapporti tra loro. L’accordo inter se è possibile solo se:
1) espressamente previsto dal trattato;
2) nel silenzio del trattato, se “non pregiudica il godimento da parte delle altre parti dei loro
diritti in base al trattato né l’adempimento dei loro obblighi”;
3) se la modifica prodotta dall’accordo inter se non è incompatibile con la “realizzazione
dell’oggetto e dello scopo del trattato nel suo complesso”.
28
L’accordo inter se può anche riguardare la sospensione “in via temporanea e solamente nei loro
rapporti reciproci” del trattato multilaterali cui gli Stati dell’accordo sono parti. Esso, comunque,
non può costituire una violazione sostanziale del trattato, legittimando altrimenti gli altri Stati a
sanzionarlo.
9. Le riserve
La riserva è la “dichiarazione attraverso la quale lo Stato esprime la sua volontà di limitare gli
effetti giuridici nei confronti di certe disposizioni del trattato”. Non vanno confuse con le riserve, le
dichiarazioni e le dichiarazioni interpretative, che manifestano il punto di vista dello Stato su una
disposizione, su come verrà interpretata o a quali organi dello Stato verrà riferito un termine
contenuto nel trattato, ma non hanno lo scopo di modificare, alterare o escludere l’applicazione
della disposizione del trattato oggetto di dichiarazione.
La riserva può essere apposta al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione,
dell’approvazione o dell’adesione e va formulata “per iscritto e comunicata agli Stati contraenti ed
agli altri Stati aventi titolo per diventare parti al trattato”.
La riserva può sempre apporsi al trattato, salvo che:
1) il trattato non lo proibisca;
2) il trattato indichi come possibili solo alcune riserve, vietandone qualsiasi altra;
3) in ogni altro caso, la riserva sia incompatibile con l’oggetto o lo scopo del trattato.
Il punto 3 è una soluzione che garantisce la c.d. “flessibilità” dei trattati, favorendo la più ampia
partecipazione possibile degli Stati ai trattati.
L’obiezione a una riserva per incompatibilità con l’oggetto o con lo scopo del trattato impedisce
l’entrata in vigore del trattato tra lo Stato riservante e quello obiettore, ma la non entrata in vigore è
condizionata alla ulteriore, espressa e netta volontà in tal senso dello Stato obiettante; mentre
l’accettazione della riserva, compatibilmente all’oggetto e allo scopo, determina l’entrata in vigore
del trattato nei limiti precisati dalla riserva.
Il regime della Convenzione di Vienna in materia di riserve è derogabile, e lo mostra la prassi
soprattutto a riguardo dei trattati di tutela dei diritti umani3.
10. Invalidità, estinzione e sospensione del trattato
L’invalidità (o di nullità) del trattato comporta la sua inidoneità a produrre effetti giuridici e
consiste nell’inesistenza, nella nullità o nell’annullabilità del trattato:
- nei casi di inesistenza manca l’atto giuridico perché manca “l’imputazione della
manifestazione della volontà ad un soggetto di DI”; è causa di inesistenza del trattato:
a) la violenza assoluta o fisica “che non vizia la volontà perché più semplicemente la nega”;
b) i Trattati di pace e i trattati ineguali4;
- nei casi di nullità e annullabilità l’atto esiste ma è viziato; a seconda della gravità del vizio
mutano gli effetti giuridici dell’invalidità.
3
Per gli esempi vd. pgg. 198-200: Comitato dei diritti dell’uomo e c.d. Sistema di Strasburgo.
I trattati ineguali sono quelli in cui una delle due parti non ha opzioni alternative tra cui scegliere e può determinarsi
in un senso soltanto. La dottrina ritiene che in essi si debba valutare, per la loro eventuale invalidità, se il ridotto o
inesistente margine di libertà negoziale per una delle parti dipenda o meno dall’impiego (o dalla minaccia) di violenza
ad opera dell’altra. I trattati di pace, secondo SCELLE, non sono trattati bilaterali perché giuridicamente mancherebbe
uno dei due soggetti, per cui si tratterebbe di atti unilaterali; secondo QUADRI, valutando l’esistenza o meno della
violenza per poi giudicarne la validità, è riconoscibile in alcuni casi la bilateralità dei trattati di pace; altri autori
muovendo dalla bilateralità dei trattati ineguali, pongono il problema sul piano dell’interpretazione, per cui in un trattato
ineguale il problema sarebbe lo scarso margine di potere contrattuale di una parte, cui si pone rimedio interpretando
restrittivamente certe clausole favorevoli ai vincitori.
4
29
Sono cause di nullità del trattato:
a) la violenza, relativa o morale, esercitata sul rappresentante dello Stato o direttamente
sullo Stato mediante la minaccia o l’uso della forza5;
b) il contrasto del trattato con lo jus cogens.
Sono cause di annullabilità del trattato:
a) la violazione di disposizioni di diritto interno riguardanti la competenza a concludere
trattati6;
b) la manifestazione del consenso ad obbligarsi da parte del rappresentante dello Stato
avvenuta al di fuori dei poteri conferitigli7;
c) l’errore8;
d) il dolo9;
e) la corruzione del rappresentante dello Stato.
La decisione di far valere il vizio per l’annullabilità è a discrezione solamente dello Stato
interessato (legittimazione relativa), mentre tale possibilità non è concessa per la nullità,
caso in cui qualunque Stato può far valere il vizio (legittimazione assoluta).
Gli effetti dell’invalidità retroagiscono al momento della conclusione del trattato (ex tunc). Se, in
esecuzione di trattato non valido, sono stati compiuti degli atti, qualunque parte può chiedere a
qualsiasi altra di ripristinare, ove possibile, lo status quo ante; tuttavia, se gli atti sono stati compiuti
in buona fede non divengono illeciti per il sol fatto che il trattato è invalido.
L’estinzione e la sospensione determinano la cessazione, rispettivamente definitiva e temporanea,
dell’idoneità del trattato a produrre effetti giuridici.
Le cause dell’estinzione del trattato operano ex nunc, cioè dal momento in cui si verificano. Esse
possono anche operare come cause di sospensione. La regola generale è che “l’estinzione di un
trattato o il recesso di una parte possono aver luogo o in conformità alle disposizioni del trattato
oppure in ogni momento, per consenso di tutte le parti, previa consultazione degli altri Stati
contraenti” (stessa cosa vale per la sospensione).
Nel caso in cui il trattato non contenga disposizioni relative alla sua estinzione e non preveda
possibilità di denuncia o di recesso, questa non è consentita salvo che non risulti che corrispondeva
all’intenzione delle parti ammettere la possibilità di una denuncia o di un recesso, oppure che il
diritto di denuncia o di recesso possa essere dedotto dalla natura del trattato.
La manifestazione del mutuo consenso delle parti all’estinzione (o sospensione) degli effetti di un
trattato può anche essere implicita come nel caso in cui tutti gli Stati parti di un trattato concludano
successivamente un nuovo trattato avente per oggetto la stessa materia.
Una importante causa sia di estinzione che di sospensione del trattato è quella che a fronte della
violazione sostanziale (ripudio del trattato o violazione essenziale dell’oggetto o dello scopo) di un
trattato ad opera di uno Stato parte, l’altro (o gli altri) Stato è legittimato, in ragione
dell’inadempimento degli obblighi assunti, ad invocare la violazione come motivo di estinzione del
5
In entrambi i casi, si ha riguardo alla c.d. violenza relativa in cui il soggetto ha comunque manifeStato la propria
volontà, sebbene illecitamente condizionata. Tale violenza può essere esercitata mediante atti o minacce il cui contenuto
è interpretato sulla base delle prassi internazionali.
6
In linea generale, il DI resta indifferente di fronte ad eventuali violazione del diritto interno, salvo quando tale
violazione è “manifesta”, cioè “obiettivamente evidente per qualsiasi Stato che si comporti in materia secondo la pratica
abituale e in buona fede”, e riguarda una norma interna sulla competenza a stipulare trattati di importanza fondamentale
7
La manifestazione di consenso non avrà rilievo a meno che “la restrizione non sia stata notificata prima che il
consenso sia Stato espresso agli altri stati partecipanti alla negoziazione”.
8
L’errore, cioè la falsa rappresentazione della realtà, può essere invocato dallo Stato solo se: 1) è un errore su un fatto o
situazione che si supponeva esistente al momento della conclusione del trattato; 2) è scusabile, nel senso che lo Stato né
ha contribuito a determinarlo con il suo comportamento, né le circostanze erano tali per cui lo Stato poteva rendersi
conto della possibilità di errore; 3) esso ha costituito una base essenziale del consenso.
9
Il dolo si realizza quando “uno Stato è Stato indotto a concludere un trattato dal comportamento fraudolento di un altro
Stato che ha partecipato al negoziato”.
30
trattato o di sospensione totale o parziale della sua applicazione (inadimplenti non est
adimplendum).
L’impossibilità sopravvenuta consente allo Stato di estinguere, recedere o sospendere
l’applicazione del trattato se l’esecuzione dello stesso è divenuta impossibile a seguito della
“scomparsa o della distruzione definitiva di un oggetto indispensabile all’esecuzione del trattato”.
L’ultima clausola di estinzione, recesso o sospensione è dovuta alla c.d. clausola rebus sic stantibus
o al cambiamento fondamentale delle circostanze. In virtù degli effetti potenzialmente pericolosi
per la stabilità dei trattati, questa clausola viene applicata in modo restrittivo per limitarne al
massimo l’uso (e l’abuso):
- negandone l’applicazione salvo casi eccezionali;
- fissandone tre condizione per l’operatività della regola: 1) il cambiamento fondamentale
doveva essere imprevedibile dalle parti; 2) le circostanze mutate devono aver costituito una
base essenziale del consenso delle parti a vincolarsi al trattato; 3) le circostanze mutate
devono aver trasformato radicalmente la portata degli obblighi che rimangono da adempiere
in base al trattato.
- non applicandola ai trattati che fissano i confini;
- non applicandola nel caso in cui il cambiamento sia dovuto a una violazione dell’obbligo del
trattato o obbligo internazionale, ad opera di uno Stato parte che invoca la clausola a danno
di altri Stati parti del trattato.
Il modo di operare delle cause di invalidità, estinzione e sospensione si attua previo accertamento e
accettazione degli Stati interessati. Lo Stato parte che vuole far valere le cause di invalidità,
estinzione e sospensione deve notificare, per iscritto, la “misura proposta nei riguardi del trattato e
le ragioni di essa”. Passati tre mesi, senza sollevazione alcuna di obiezioni, lo Stato può adottare la
misura proposta. Se invece si riscontra un’obiezione, nasce una controversia internazionale, per la
quale risoluzione si dovranno, innanzitutto, usare i mezzi per la risoluzione pacifica delle
controversie. Trascorsi 12 mesi dalla data di sollevamento dell’obiezione, e se non c’è stata
risoluzione, sono previste due ulteriori procedure:
a) ricorso unilaterale alla CIG o, di comune accordo, istituzione di un arbitrato;
b) attivazione della procedura obbligatoria di conciliazione (domanda al Segretario ONU).
Risolta la controversia o in mancanza di obiezioni, lo Stato notificante può dichiarare la nullità del
trattato, porvi termine, recederne o sospenderne l’applicazione, con un atto che “deve essere
contenuto in uno strumento comunicato alle altre parti”
11. La successione degli Stati nei trattati
Il problema della c.d. successione degli Stati nei trattati si viene a porre nel momento in cui un
territorio cessi di essere soggetto alla sovranità di uno Stato e passi sotto la sovranità di una altro.
La complessa e frammentata disciplina generale e convenzionale e la variegta prassi consentono di
trovare un punto comune rappresentato dal condizionare il verificarsi degli effetti successori alla
volontà degli Stati interessati dal fenomeno di successione.
La prassi internazionali, dunque, attribuisce un decisivo rilievo alla volontà degli Stati previa
accettazione da parte dell’altro Stato delle dichiarazioni e notificazioni operate dallo Stato
successore10.
10
Un’eccezione è costituita dai c.d. trattati localizzabili che regolano i confini internazionali, nei quali la successione
tra stati non pregiudica gli obblighi già previsti. Essi hanno natura reale o territoriale e sono indicati come tali gli
obblighi riguardanti l’uso di territori, o limiti al suo uso, e i diritti a favore di un territorio (res transit cum suo onere).
31
Il fenomeno della successione tra Stati negli obblighi convenzionali ha assunto maggior rilievo con
riguardo agli Stati di nuova indipendenza (pur valendo la c.d. “mobilità delle frontiere del
trattato”). Diversi sono gli orientamenti e le soluzioni:
- alcuni Stati invocano il principio della tabula rasa in base a cui il nuovo Stato non assume
alcuno degli obblighi in precedenza gravanti sul predecessore;
- altri Stati concludono accordi di devoluzione con il predecessore aventi ad oggetto proprio i
diritti e gli obblighi convenzionali che gravano su quest’ultimo (continuità dei trattati).
Nel segno della continuità dei trattati, lo Stato nuovo emana una dichiarazione unilaterale rivolta
agli Stati che sono parti di trattati conclusi dallo Stato predecessore, il cui oggetto e scopo è proprio
quello di regolamentare la successione dello Stato nuovo nei trattati conclusi dal predecessore. La
dichiarazione produce effetti una volta che gli altri Stati l’abbiano accettata.
Il fenomeno di successione dovuto a unione e separazione di Stati è regolato per la continuità degli
obblighi, lasciando però alla volontà degli Stati la diversa opzione di applicare l’opposta regola
della tabula rasa.
In caso di unione di uno o più Stati “ogni trattato in vigore alla data di successione tra Stati per
ciascuno di essi continua ad essere in vigore per lo Stato successore salvo che:
a) lo Stato successore e l’altro o gli altri Stati parti abbiano diversamente stabilito;
b) risulti dal trattato o sia altrimenti stabilito che l’applicazione del trattato nei confronti del
successore sarebbe incompatibile con l’oggetto o lo scopo del trattato o che muterebbe radicalmente
le condizioni per la sua efficacia.
In caso di separazioni territoriali con smembramento di uno Stato o mera secessione da
quest’ultimo si conferma la regola della continuità degli obblighi.
32
CAPITOLO V – FENOMENI DI ADATTAMENTO TRA ORDINAMENTI GIURIDICI
DIVERSI
1. Considerazioni introduttive
Il problema dell’adattamento di un ordinamento rispetto ad un altro non si pone solamente
nell’ipotesi dell’adattamento del diritto interno al DI, ma anche nei casi di adattamento del DI al
diritto interno. L’adattamento è, quindi, la conseguenza giuridica della continua e progressiva
integrazione tra strutture socio-giuridiche diverse, Stati e CI (teoria dualista).
Possiamo definire l’adattamento come la “condizione necessaria di efficacia nell’ordinamento
interno della disciplina concordata in ambito internazionale”.
2. L’adattamento del diritto interno al diritto internazionale
I meccanismi di adattamento del diritto interno al DI vanno distinti a seconda che l’adattanda
norma sia di origine pattizia o generale.
Ogni Stato fissa le proprie regole di adattamento al DI, che l’ordinamento internazionale considera
come fatti giuridici in linea di principio irrilevanti. Ciò che rileva per il DI è sola la responsabilità
dello Stato in caso di mancato adattamento agli obblighi internazionali.
L’adattamento dell’ordinamento italiano alle norme di DI generale avviene in modo automatico ed
originario: originario perché le norme internazionali sono immesse nel nostro ordinamento “nel
loro contenuto autentico e nel significato loro proprio dell’ordinamento nel quale esse si formano e
progressivamente evolvono”; automatico perché l’art. 10 della Costituzione “provvede a creare le
norme interne necessarie per adempiere alle prescrizioni delle norme internazionali generali, senza
che occorra alcun intervento legislativo”. Ciò che si applica non è né direttamente la norma
internazionale, né una sua trasformazione in una norma interna di identico contenuto, ma è una
diversa ed ulteriore norma interna, tacitamente adottata e ricostruita, dal punto di vista del
contenuto, in termini identici rispetto alla norma internazionale.
Si determina, quindi, una correlazione tra le vicende della norma internazionale e quelle della
corrispondente norma italiana: una modificazione o l’estinzione della norma internazionale nel suo
ordinamento si riflette indirettamente sulla corrispondente norma interna, nel senso che l’interprete,
deve tempestivamente adattare il contenuto della norma interna alle vicende normative
internazionali.
Secondo l’art. 10, le norme internazionali sono sovraordinate rispetto alla legge ordinaria in forza
del principio di specialità. La Corte Costituzionale ha poi distinto tra le consuetudini internazionali
esistenti prima e quelle formatesi dopo l’entrata in vigore della Costituzione, ritenendo che solo le
prime prevalgano sempre in base al principio della specialità e, invece, condizionando la prevalenza
delle seconde al rispetto dei “principi fondamentali del nostro ordinamento”.
Tuttavia, il limite dei “principi fondamentali” vale anche per le consuetudini “precedenti” le quali,
in caso di contrasto, dovranno disapplicarsi, ferma restando la responsabilità internazionale dello
Stato per l’inadempimento della norma consuetudinaria.
3. Segue: procedimento ordinario e procedimento speciale di adattamento
I procedimenti di adattamento del diritto interno al DI sono sostanzialmente due e valevoli sia per le
norme pattizie che per quelle generali.
Il procedimento ordinario “consiste nel riprodurre le norme internazionali, con legge ovvero altro
atto dotato di forza normativa adeguata ai loro contenuti, riformulandole direttamente e
materialmente nell’ordinamento nazionale mediante norme interne ad hoc”.
33
Tale procedimento è necessario quando la norma internazionale non è self-executing e quindi si
richiede una disciplina interna integrativa e non di mera esecuzione. Se la norma è self-executing, la
scelta tra adattamento ordinario o speciale è rimessa al legislatore interno.
Il procedimento speciale “consiste invece nel disporre un rinvio a norme internazionali, ordinando
la loro osservanza, senza alcuna riformulazione diretta delle medesime nell’ordinamento
nazionale”. A tal riguardo si è parlato di rinvio non ricettizio dell’ordinamento interno a quello
internazionale. Nell’adattamento alle consuetudini e ai principi, il rinvio opera in via continua,
mentre l’adattamento ai trattati opera in via specifica.
Una differenza tra procedimento ordinario e speciale di adattamento consiste nella formulazione
esplicita o implicita della norma interna: nel primo caso si ha la materiale ed esplicita redazione
della norma interna; nel secondo caso si procede implicitamente, lasciando ad ogni organo statale
competente il compito di interpretare il trattato per accertare il contenuto della norma internazionale
e disporre le corrispondenti modificazioni del diritto interno.
4. Segue: l’adattamento al diritto internazionale pattizio
Con l’adattamento ordinario ai trattati, l’ordinamento interno produce un atto che riproduce
integralmente il contenuto materiale del trattato senza richiamarlo; con l’adattamento speciale,
invece, si emana un ordine di esecuzione, ossia un “atto mediante il quale lo Stato, per dare piena
ed intera esecuzione al trattato, rinvia in blocco alle norme in esso contenute”, che si compone di
due soli articoli, uno che contiene la formula dell’ordine di esecuzione e l’altro che rinvia al testo
del trattato.
Nella prassi è utilizzata prevalentemente la tecnica dell’ordine di esecuzione per due motivi:
1) evita di riprodurre in una norma interna il testo del trattato internazionale, eliminando così i
rischi connessi ad eventuali difformità di testo, significato e spirito occorsi durante la
traduzione;
2) “lega” le vicende normative, nell’ordinamento internazionale, del trattato alla produzione di
effetti giuridici nel diritto interno (mentre la tecnica ordinaria “svincola” da tali effetti
interni).
Ogni trattato è recepito con un ordine di esecuzione ad hoc e può essere contenuto in una legge
costituzionale, in una legge ordinaria o in un decreto amministrativo (strumenti di cui poi assume
poi il rango).
L’assunzione da parte del trattato del rango del provvedimento interno contenente l’ordine di
esecuzione pone, dal punto di vista della gerarchia delle fonti, un problema di successione di leggi
nel tempo.
Un ordine di esecuzione contenuto in una legge ordinaria può essere abrogato da una successiva
legge ordinaria (lex posteriori derogat lex priori)11: in tal caso la legittima successione delle leggi a
livello interno determinerebbe la violazione di obblighi internazionali assunti dall’Italia ratificando
il trattato e la sua responsabilità internazionale.
Mancando fino alla riforma costituzionale del 200112 una espressa previsione risolutiva del
problema, si operava attraverso due tecniche per garantire la prevalenza dei trattati:
1) Interpretare le norme interne incompatibili con il trattato nella maniera più conforme
possibile agli obblighi internazionali assunti (attività di interpretazione);
11
Questo, come si vedrà non è possibile, tranne nel caso in cui il legislatore non manifesti apertamente la volontà di
ripudiare gli obblighi internazionali in precedenza assunti.
12
Il riformato art. 117 prevede espressamente il rispetto da parte del legislatore statale e regionale dei “vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.
34
2) Applicare il criterio di specialità considerando la norma internazionale come lex specialis
rispetto alla norma interna in contrasto.
La specialità della norma pattizia è impropria, nel senso che non è dovuta al contenuto della norma
internazionale, più specifico rispetto a quello della norma interna, più generale, ma al fatto politico
dell’importanza della partecipazione dello Stato alla vita di RI e al fatto giuridico dell’avere proprio
lo scopo e la specifica funzione di dare attuazione a quegli obblighi internazionali.
Con la riforma costituzionale del 2001, il riformato art. 117 fa assumere al trattato il rango di
“norma interposta” tra la Costituzione e la legge ordinaria. Essendo norma interposta, la legge
interna in contrasto è costituzionalmente illegittima per violazione del su detto articolo.
L’art. 117 pone, poi, il problema circa la sua applicabilità o meno a tutti i trattati: nel caso tale
questione fosse risolta positivamente, la potestà del Parlamento verrebbe posta in situazione di
subordinazione, riscontrando limiti incisivi. Per non ritenere, sulla base di tale interpretazione,
l’incompatibilità tra la Costituzione e la legge costituzionale di riforma, si sono proposte diverse
soluzioni imperniate su un’interpretazione restrittiva del richiamo ai “trattati internazionali” dell’art.
117, circoscrivendo l’operatività “soltanto per i trattati cui all’art. 80 Cost., rispetto ai quali il
Parlamento abbia provveduto ad emanare la legge che autorizzava la ratifica comprensiva
dell’ordine di esecuzione”, e rimettendo alla tecnica dell’interpretazione conforme e al principio di
specialità il compito “per tutti gli altri trattati…di garantire la prevalenza delle loro norme di
attuazione rispetto alle norme interne pari-ordinate incompatibili”.
Ciononostante, il prevalente dato normativo e la giurisprudenza restano di segno opposto, cioè
favorevole all’applicazione dell’art. 117 a qualunque trattato.
5. Segue: le norme della Costituzione Italiana sulla ratifica dei trattati
Le disposizioni costituzionali in materia di stipulazione ed adattamento dei trattati internazionali
sono:
- art. 72 (par. 4): l’approvazione del disegno di legge autorizzante la ratifica deve avvenire
attraverso l’utilizzo della procedura normale di esame e di approvazione diretta (seduta
plenaria delle Camere).
- art. 75 (par. 2): è vietato sottoporre le leggi di autorizzazione alla ratifica al referendum
popolare abrogativo.
- artt. 80 e 87 (par. 8): il Presidente della Repubblica “ratifica i trattati internazionali, previa,
quando occorre, l’autorizzazione delle Camere”. Le Camere “autorizzano con legge (c.d.
legge di autorizzazione13) la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri
alle finanze o modificazioni di leggi” (solo stipulazione in forma solenne, perché la forma
semplificata non contempla la ratifica).
La Costituzione “tace” con riguardo alla stipulazione dei trattati in forma semplice, generalmente
impiegata negli accordi bilaterali o in quelli aventi ad oggetto questioni di carattere tecnicoamministrativo.
Questo tipo di accordi è ammesso dal nostro ordinamento, in quanto una lettura sistematica degli
artt. 80 e 87 della costituzione porterebbe a ritenere che la competenza a ratificare sia attribuita al
Presidente della Repubblica solo per i trattati di maggior rilievo e che sarebbe legittimo il suo non
coinvolgimento in tutti gli altri casi. Ci sarebbe, dunque, una delega implicita della competenza a
stipulare, “rilasciata” dal Presidente della Repubblica ai Ministri competenti.
13
La legge di autorizzazione deve essere contenuta in una legge costituzionale quando l’adempimento degli obblighi
scaturenti dal trattato richieda “una modificazione dell’organizzazione costituzionale dello Stato o la modificazione
delle competenze che la Costituzione o altre leggi costituzionali attribuiscono alle regioni o il compimento di atti
contrari a disposizioni della Costituzione, come l’estradizione di cittadini o di stranieri per reati politici.
35
6. L’adattamento del diritto internazionale al diritto interno. L’adattamento del diritto
interno agli atti delle Organizzazioni internazionali
Di maggior rilievo per quanto riguarda l’adattamento del DI al diritto interno è il tema della
validità della stipulazione dei trattati: la ratifica avviene, infatti, in base alle norme e alle procedure
interne di ciascuno Stato. Le violazioni di diritto interno in materia di competenza a concludere
trattati non rilevano per il DI salvo il caso in cui si violi “manifestamente” una norma interna “di
importanza fondamentale”.
Stessa cosa dicasi per i requisiti di validità del trattato attinenti alla fase, di diritto interno, di
ratifica, che la norma internazionale rinvia agli ordinamenti interni, perdendo così di contenuto
materiale e dispositivo.
Per l’adattamento agli atti delle OI (norme e sentenze), lo Stato appronta una serie di meccanismi e
procedure interne che attribuiscono effetti giuridici, diretti o indiretti, agli atti dell’OI.
I c.d. atti di terzo grado sono subordinati sia al DI generale (salvo il criterio di specialità), sia al
diritto pattizio (a cominciare dal trattato istitutivo dell’OI).
Tale fattispecie ricade, comunque, nell’ipotesi di adattamento del diritto interno al diritto
internazionale pattizio. Il fondamento di obbligatorietà di questi atti per gli Stati membri è proprio e
solo il trattato istitutivo dell’OI che, oltre a delimitare scopo, oggetto, limiti e competenze dell’atto,
obbliga gli Stati membri al loro rispetto, adattando di conseguenza gli ordinamenti interni.
Ogni adattamento a una fonte di terzo grado ha, in concreto, una propria “storia” normativa diversa
dalle altre direttamente correlata alla generale configurazione dell’OI che produce gli atti. Ciò che
non muta è la radice del fenomeno giuridico, ovvero la volontà politica degli Stati membri che
istituiscono e modellano le OI in funzione delle loro esigenze di cooperazione.
La prassi, la maggior parte della dottrina e la giurisprudenza ritengono sempre necessario un
adattamento ad hoc per ogni singolo atto (adattamento in via ordinaria), anche quando il recependo
atto sia self-executing.
Infine, poche sono le OI che hanno potere di emanare atti vincolanti per i propri Stati membri; più
frequentemente le OI emanano raccomandazioni non vincolanti per informare ed agevolare la
cooperazione internazionale oppure elaborano progetti di convenzioni internazionali, poi sottoposti
alla libera valutazione degli Stati membri per l’eventuale firma e ratifica (ad es. l’Organizzazione
Internazionale del Lavoro, ILO, e l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile, l’ICAO).
7. L’adattamento del diritto interno al diritto comunitario
Nel rapporto tra UE e Stato membro, l’adattamento del diritto interno al diritto comunitario (DC)
avviene in modo diretto e automatico, stabilendo la prevalenza della normativa comunitaria sulla
normativa interna dello Stato. Questa prevalenza non deriva dalla presunta potestà “sovranazionale”
dell’UE, ma da un normale fenomeno di adattamento.
In altre parole, l’efficacia del DC nell’ordinamento interno di uno Stato membro è conseguenza
delle disposizioni del Trattato di Roma del 1957 che espressamente prevedono il fatto normativo di
questo peculiare adattamento del diritto interno al DC (rimanendo comunque inquadrato nella
generale categoria dell’adattamento del diritto interno al DI).
Il primato del DC è sancito dall’art. 11 della Costituzione (originariamente pensato e riferito
all’ONU). Richiamo necessario all’art. 11 Cost. per giustificare l’introduzione nel nostro
ordinamento di una nuova fonte legislativa “esterna” per la quale non appariva sufficiente il ricorso
al criterio di specialità per garantirne la prevalenza e la resistenza rispetto al diritto interno
eventualmente difforme.
36
Circa il contrasto tra norme comunitarie e norme interne, spettava solo alla Corte Costituzionale,
previa remissione della questione di legittimità costituzionale dal giudice a quo, accertare il
contrasto della norma interna con l’art. 11 e procedere alla sua disapplicazione.
Solo nel 1984, la Corte Costituzionale definì compiutamente l’assetto dei rapporti tra DC e diritto
interno affermando, da un canto, il potere di qualunque giudice di disapplicare direttamente il diritto
interno in contrasto con il DC e, dall’altro, l’estraneità delle norme comunitarie rispetto
all’ordinamento interno in conseguenza della diversità e separatezza degli ordinamenti interno e
comunitario. Tale impostazione non provoca l’invalidità della norma interna in contrasto con quella
comunitaria.
Negli ultimi anni la Corte Costituzionale ha meglio precisato:
1) il destino della norma interna in contrasto con quella comunitaria: la norma interna è
disapplicata e “si ritrae e non è più operante” di fronte alla norma comunitaria la cui “forza e
valore” deve essere garantita, ma solo nei limiti “dell’ambito materiale e dei limiti temporali
in cui vige la disciplina comunitaria” con la conseguenza che, fuori da tale ambito, “la
regola nazionale serba intatto il proprio valore e spiega la sua efficacia”;
2) l’esistenza di limiti interni inderogabili, c.d. controlimiti costituzionali, alla piena ed
incontrastata efficacia del DC: tali limiti inderogabili sono rappresentati dai principi
“supremi o fondamentali” del nostro ordinamento costituzionale che caratterizzano la
struttura stessa dello Stato14;
3) il rango del DC nel nostro ordinamento: esso non assume il rango di norma interposta tra la
Costituzione e la legge ordinaria ma si pone al livello della Costituzione cui, però, deve
inderogabilmente il rispetto dei principi fondamentali.
8. Le regioni italiane ed il diritto internazionale e comunitario
Anche se prive di soggettività internazionale, le suddivisioni amministrative territoriale dello Stato
partecipano ai meccanismi di adattamento al DI e al DC.
Riguardo all’adattamento al DI, l’art. 117 Cost. riserva esclusivamente allo Stato la conduzione
della politica estera e la materia dei rapporti internazionali dello Stato; ciononostante, riconosce
pure la competenza concorrente delle regioni e delle province autonome di Treno e Bolzano in
materia di “rapporti internazionali e con l’UE”: esse hanno la possibilità di concludere accordi
internazionali con Stati terzi “nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato” e hanno il
potere/dovere di attuare ed eseguire, nelle materie di loro competenza, gli accordi internazionali e
gli atti normativi dell’UE “nel rispetto delle norme di procedura fissate dalla legge dello Stato che
disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza della
regione”.
La potestà legislativa delle regioni è poi rafforzata dalla sua attribuzione in via residuale, cioè “con
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.
I rapporti internazionali concessi alle regioni sono di tre tipi:
a) attività all’estero di natura promozionale, intese a favorire lo sviluppo sociale, economico e
culturale della regione;
b) attività di mero rilievo internazionale, cioè quelle “attività di vario contenuto,
congiuntamente compiute dalle regioni e da altri organismi esteri aventi per oggetto finalità
di studio o di informazione oppure la previsione di partecipazione a manifestazioni dirette
ad agevolare il progresso culturale o economico in ambito locale”;
c) conclusione di accordi internazionali in senso proprio, previo ottenimento dei pieni poteri,
rilasciati se: 1) la materia è di competenza (esclusiva o concorrente) regionale; 2) se, nelle
14
Ciò dimostra che il fondamento della partecipazione italiana al processo di integrazione europea è inevitabilmente
contrattualistico.
37
materie di competenza concorrente, la regione rispetta i principi fondamentali fissati dallo
Stato; 3) se l’accordo regionale è compatibile con “le linee e gli indirizzi della politica estera
italiana”.
Il governo può adottare, in tutte e tre le ipotesi, qualunque misura ritenuta necessaria all’esito di una
valutazione di opportunità dell’attività regionale in rapporto alle scelte e agli indirizzi della politica
estera dello Stato.
Per quel che riguarda il potere delle regioni di dare “attuazione ed esecuzione degli accordi
internazionali” nelle materie di loro competenza, le regioni devono rispettare il limite dei “principi
fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato”: questo perché, da una parte, nel riferirsi agli “accordi
internazionali ratificati” si presuppone il previo intervento dello Stato, dall’altra, la regione ha
l’obbligo di comunicare preventivamente , a fini di controllo, la propria attività ai competenti organi
Stati, riconfermando l’esclusiva e inderogabile competenza dello Stato a svolgere “compiti
preordinati ad assicurare l’esecuzione al livello nazionale degli obblighi derivanti dagli accordi
internazionali”.
Riguardo l’adattamento al DC ad opera delle regioni, si ci riferisce sempre all’art. 117 Cost. in base
al quale le regioni “nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione ed esecuzione…degli atti
dell’UE, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina le
modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza”.
In sede di formazione del DC (c.d. fase ascendente) e di attuazione ed esecuzione dello stesso (c.d.
fase discendente), le regioni, in linea di principio, sono tenute anche al rispetto del limite costituito
dai principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato nelle materie di competenza concorrente;
nelle materie di loro esclusiva competenza, invece, il rispetto è dovuto solo nei riguardi delle
“norme di procedura” dettate dallo Stato.
L’indifferenza del DI per la ripartizione interna di competenze tra gli organi dello Stato, ha in
gran parte giustificato la “chiusura” che, per molti anni, lo Stato ha avuto nei confronti delle
competenze regionali in materia di attuazione ed esecuzione della normativa internazionale e
comunitaria. Con la riforma del 2001, la Costituzione ha finalmente disciplinato il “potere
sostitutivo” dello Stato in caso di inadempienza dell’ente sub-statale, l’uso del quale è consentito
solo per evitare l’insorgere della responsabilità internazionale a carico dello Stato e “soltanto in
caso di successiva e persistente inerzia della regione”. La riforma ha introdotto due disposizioni:
- alla regione inadempiente viene fissato un congruo termine per l’adozione dei necessari
provvedimenti di adeguamento, scaduto il quale, e permanendo l’inerzia della regione, il
Consiglio dei Ministri adotta in sostituzione i provvedimenti dovuti oppure nomina un
commissario ad acta per l’adozione degli stessi.
- gli atti statali sostitutivi sono “adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni
al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia, e perdono efficacia dalla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e recano l’esplicita indicazione
della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute (c.d. principio di cedevolezza della normativa statale sostitutiva a fronte della
“tardivamente” sopravvenuta normativa regionale).
38
CAPITOLO VI – GARANZIE DELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI
E
1. Nozioni introduttive: autotutela, garanzia, controversia. Arbitrato e giurisdizione
nell’ordinamento internazionale
I caratteri costitutivi e strutturali del sistema internazionale, cioè l’anorganicità della CI e il DI
come suo riflesso normativo, si riflettono su due aspetti della coesistenza interstatale:
1) le lesioni della sfera giuridica di un o Stato da parte di un altro (che devono essere riparate);
2) la risoluzione delle controversie tra Stati.
Mancando organi giudiziari e di polizia internazionali, la disciplina di questi aspetti è rimessa agli
Stati stessi interessati che agiscono in autotutela di fronte alle lesioni ricevute e utilizzano mezzi,
pacifici o violenti, per risolvere le controversie.
L’autotutela è la “libertà che il DI rilascia all’offeso di agire contro la sfera dell’offensore…è
sanzione del DI in quanto si connette al compimento dell’atto illecito: l’offensore non può invocare
l’autorità del DI contro l’offeso che invada la sua sfera giuridica. Gli atti dell’offeso che in sé
sarebbero illeciti divengono leciti in ragione del torto subito.
Una norma si compone di una prima parte descrittiva della fattispecie e di una seconda parte
contenente la garanzia dell’altra parte della norma: “garantire una norma significa creare una
situazione favorevole alla soddisfazione dell’interesse giuridicamente rilevante o creare una
situazione sfavorevole alla violazione della norma stessa”.
Nel DI, i termini “sanzione” e “garanzia” sono sinonimi ed il primo è quello usato in prevalenza,
anche se il secondo appare più adatto al contesto internazionale per il suo significato più ampio e
perché trasmette meglio la giuridicità del garantire il mantenimento dell’ordine sociale attraverso il
diritto: cioè con sanzioni ex post, ma anche con garanzie ex ante.
Autotutelandosi, il soggetto internazionale aziona le garanzie connesse alla norma violata da un
altro soggetto. Queste garanzie sono di due tipi: coercitive, se l’azione è direttamente volta contro
l’offensore; privative (o giuridiche) se l’azione consiste nella privazione della tutela giuridica che
l’ordinamento garantiva all’offensore prima che violasse la norma.
Il turbamento dell’ordine sociale internazionale che attiva il sistema giuridico delle garanzie
comporta l’insorgere di una controversia internazionale tra due o più soggetti, definita come “un
disaccordo in punto di diritto o di fatto, un conflitto di posizioni giuridiche o di interesse tra due
soggetti”. Si distingue tra controversie:
- potenziali: quando l’insorgere della controversia è possibile ma non certo (situazione
suscettibile di degenerare in controversia);
- attuali (o esistenti): quando, a livello fenomenico, si constata l’esistenza di due posizioni
differenti, ciascuna resistente rispetto all’altra.
Per la risoluzione delle controversie internazionali, la teoria generale non permette l’esistenza di
fenomeni giurisdizionali ma solo di fenomeni di tipo arbitrale.
In ambito giurisdizionale, l’organo esercita la potestas decidendi senza riguardo alla volontà dei
controvertenti che, volenti o nolenti, resteranno soggetti alla decisione del giudice.
Tali fenomeni giurisdizionali compaiono solo negli ordinamenti interni, mentre in quello
internazionale è sempre necessario che il convenuto accetti il procedimento che l’attore pretende di
instaurare affinché, poi, l’istanza internazionale possa procedere e decidere la controversia: il che
significa che si tratta di arbitrato e non di giurisdizione (anche se il consenso degli Stati è
manifestato una tantum).
39
Salvo casi eccezionali, le istanze di c.d. “giurisdizione internazionale” sono tutte create dalla
volontà degli Stati per mezzo di trattati, volontà che deve essere manifestata ogni volta che sorge la
specifica controversia.
Ciononostante, l’esservi, a fondamento dello jus dicere internazionale, un patto voluto dagli Stati (e
non un patto necessitato) suggerisce di riqualificare questi fenomeni in senso arbitrale e non
giurisdizionale.
2. Il fondamento di obbligatorietà della sentenza e del lodo arbitrale internazionale
La sentenza internazionale ha lo stesso fondamento di obbligatorietà del lodo arbitrale, cioè
l’obbligo, liberamente assunto dagli Stati parti alla controversia, di rispettare la decisione
dell’istanza decisoria da loro prescelta.
Tuttavia si riservano i termini “giudice”, “sentenza” e “giurisdizione” a certe ipotesi in cui la
“Corte” è permanente, precostituita e competente in via automatica e generale sulle controversie; i
termini “arbitro”, “lodo” e “arbitrato” alle altre ipotesi in cui il “tribunale” è istituito di volta in
volta dalle parti in causa, che scelgono gli arbitri, il diritto sostanziale e la procedure applicabile alla
loro controversia.
Se la volontà dei controvertenti è la base dell’obbligatorietà dei procedimenti sia arbitrali che
giudiziali, ciò non significa che anche i loro provvedimenti decisori conclusivi (lodo e sentenza)
siano obbligatori perché le parti alla controversia li vogliono come tali.
Il lodo e la sentenza sono obbligatori perché l’ordinamento giuridico li considera come fatti
giuridici in senso stretto produttivi di obblighi per la parte vincitrice e quella soccombente,
indipendentemente dalla loro volontà.
3. Mezzi pacifici diplomatici di risoluzione delle controversie internazionali
I mezzi pacifici diplomatici di risoluzione delle controversie internazionali (ID) sono: il negoziato,
i buoni uffici, la mediazione, la conciliazione, le commissioni d’inchiesta.
L’ONU si occupa solo delle controversie internazionale che possano, proseguendo ed aggravandosi,
mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; per cui, nel cercare
un componimento pacifico gli Stati possono anche sottoporre la ID all’attenzione del Consiglio di
Sicurezza (SC) o dell’AG. Nel caso in cui i mezzi a disposizione per la risoluzione della ID non
siano sufficienti, lo Stato deve deferirla al Consiglio di Sicurezza che “se ritiene che la
continuazione della ID sia in fatto suscettibile di metter a rischio il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale” potrà raccomandare procedimenti o metodi di sistemazione adeguati o
raccomandare direttamente la soluzione che ritenga adeguata, cioè delle raccomandazioni (atti non
vincolanti per le parti a cui sono rivolte).
Il negoziato si caratterizza per la partecipazione delle sole parti controvertenti che cercano un’intesa
risolutiva della questione. Numerosi trattati predispongono il ricorso al negoziato quale condizione
di procedibilità per impiegare altri mezzi diplomatici e non diplomatici.
Secondo la CIG, dovrebbe poi sussistere un obbligo di buona fede nella conduzione dei negoziati.
Nei buoni uffici un terzo mette in contatto le parti controvertenti allo scopo di facilitare l’inizio o la
ripresa dei negoziati, limitando esclusivamente a ciò la sua attività.
Nella mediazione il terzo partecipa attivamente al negoziato e, a volte, presenta proposte di
soluzione, sebbene ufficiose e non vincolanti per le parti; le parti non hanno obblighi verso tale
procedura e possono in qualsiasi momento rifiutarla o interromperla.
40
Nella conciliazione, il terzo riceve dalle parti l’incarico di esaminare la questione controversa al
fine di proporre una formale soluzione (non vincolante per le parti). Tale procedura è modellata
sulla falsariga di quella arbitrale, ed è prevista come obbligatoria da molti trattati come fase iniziale
o intermedia della gestione diplomatica delle ID: ciascuna parte ha il potere unilaterale di attivare la
procedura anche contro la volontà della controparte.
Le commissioni d’inchiesta (sempre costituibile dal SC) si compongono di individui designati dalle
parti o da una OI, indipendenti e imparziali il cui compito è quello di accertare le circostanze di
fatto inerenti la controversia giuridica. Sebbene l’accertamento non sia vincolante, il suo carattere
oggettivo ed imparziale è un elemento importante ed efficace per la risoluzione della ID.
4. Segue: mezzi pacifici non diplomatici. La Corte Internazionale di Giustizia
La Corte Permanente di Arbitrato (CPA), istituita nel 1899, è una lista di arbitri, indicati dagli Stati
membri, a disposizione per la risoluzione delle controversie che vengano loro deferite. È, dunque,
una struttura permanente che, mediante l’International Bureau presieduto dal Segretario Generale,
fornisce assistenza giuridica ed amministrativa alle parti e agli arbitri per l’instaurazione e lo
svolgimento della procedura arbitrale. Se richiesta, la CPA designa direttamente gli arbitri per la
singola ID, così come le parti possono scegliere, come regole di procedura del loro arbitrato, anche
quelle messe a disposizione dalla CPA.
L’accordo tra le parti per instaurare un arbitrato può essere successivo all’insorgere della
controversia (accordo di compromesso) o precedente, cioè stipulato in via preventiva e generale
(accordo di clausola compromissoria). Il c.d. trattato generale di arbitrato è un trattato concluso
tra due più Stati al solo scopo di regolare il componimento di future ID.
La Corte Internazionale di Giustizia (CIG), con sede a L’Aja e il cui statuto è allegato alla Carta
dell’ONU, ha una duplice competenza:
- contenziosa (attivabile solo dagli Stati): la CIG non avendo automaticamente “giurisdizione”
deve attendere che le parti sottopongano la specifica ID alla Corte mediante un
compromesso;
- consultiva (attivabile dall’AG, dal SC o da qualsiasi altro organo ONU autorizzato dall’AG).
La CIG possiede tre titoli di giurisdizione, che evidenziano l’assenza di obbligo per lo Stato parte
allo statuto di sottoporsi, contro la propria volontà, al giudizio della Corte:
- c.d. giurisdizione speciale contenziosa: derivata dalla sottoposizione di una specifica ID alla
Corte mediante compromesso;
- c.d. giurisdizione obbligatoria: derivata dalla clausola compromissoria completa di un
trattato che consente il ricorso unilaterale alla CIG, vista la preventiva accettazione della
competenza della CIG da parte degli Stati;
- c.d. clausola opzionale o facoltativa di giurisdizione obbligatoria: derivata dallo statuto
della CIG che consente agli Stati, in ogni momento, di “dichiarare che essi riconoscono
come obbligatoria ipso facto e senza accordo speciale, rispetto a ogni Stato che accetti lo
stesso obbligo, la giurisdizione della Corte in tutte le ID giuridiche relative:
a) all’interpretazione di un trattato;
b) a ogni questione di DI;
c) all’esistenza di qualsiasi fatto che, se provato, costituirebbe una violazione di un
obbligo internazionale;
d) alla natura o all’estensione della riparazione dovuta per la violazione di un obbligo
internazionale.
L’eventuale contumacia dello Stato che ha accettato la competenza della CIG non impedisce lo
svolgersi del procedimento e l’emanazione della sentenza, anche nei suoi confronti.
41
L’intervento di Stati terzi nella procedura è consentito “qualora abbiano un interesse di natura
giuridica suscettibile di essere toccato dalla decisione del caso”, presentando un’istanza di
intervento in giudizio e ottenendo il consenso degli Stati già parte della ID (lo Stato terzo non è
comunque vincolato dalla sentenza). Lo Stato convenuto può sollevare eccezioni di natura
preliminare aventi ad oggetto o la “competenza della CIG o la ricevibilità del ricorso unilaterale o
ogni altra eccezione sulla quale si chieda una decisione prima che prosegua il processo sul merito”.
La CIG apre un procedimento incidentale, con la cui sentenza accoglie o respinge l’eccezione con
ogni derivata conseguenza processuale.
La CIG può disporre di misure cautelari qualora sussista il pericolo di un pregiudizio irreparabile a
salvaguardia dei diritti rispettivi di ciascuna parte.
La CIG decide applicando il DI e secondo equità (ex aequo et bono) solo se le parti lo richiedano
espressamente. La sentenza è definitiva e inappellabile; nel caso in cui emergano successivamente
fatti, prima ignoti, decisivi per la risoluzione della ID, la sentenza è soggetta a revisione. Lo Stato è
quindi obbligato al rispetto e all’esecuzione della sentenza, pur non esistendo strumenti coercitivi
ab externo. Nel caso in cui lo Stato soccombente non la esegua, l’unica possibilità per lo Stato
vincitore è quella di ricorrere al SC che emana raccomandazioni allo Stato recalcitrante di dare
“piena e immediata esecuzione” alla sentenza.
5. Mezzi non pacifici di risoluzione delle controversie: la guerra. Il diritto internazionale
umanitario
I mezzi non pacifici di risoluzione delle ID implicano l’uso della forza militare da parte di uno
Stato nei confronti di un altro (mezzi coercitivi). Sono compresi nella categoria anche i c.d. mezzi
afflittivi, cioè quelli di natura economica (embargo) e di altra natura (blocco delle coste,
interruzione comunicazioni o relazioni diplomatiche, etc.).
Nei secoli passati la disciplina giuridica riteneva legittimo il ricorso all’uso della forza e della
guerra nelle RI sia per la risoluzione delle ID che per auto tutelarsi.
Alla guerra (oggi vietata dalla Carta dell’ONU) che rappresentava lo strumento più estremo si
aggiungeva l’azione coercitiva per legittima difesa, per rappresaglia e per intervento (oggi
legittimo solo a certe condizioni). Di dubbia esistenza era poi un definito e stringente obbligo di
cercare una risoluzione pacifica della ID.
La guerra, dunque, consta nell’uso massiccio della violenza bellica finalizzato alla debellatio 15 dello
Stato nemico ed è sempre stata intesa dagli Stati come una “sanzione” giuridica e, quindi, come una
reazione grave ad una precedente e grave violazione del DI da parte di un altro Stato.
In termini giuridici, vi sono due considerazioni da svolgere riguardo la guerra:
1) non è rilevante, in punto di diritto, discutere di guerra giusta o ingiusta (bellum iustum) da
un punto di vista morale, etico, etc. Per un giurista, la guerra può e deve essere qualificata
solo in termini di liceità o illiceità in rapporto alle norme vigenti, in un dato momento
storico, nell’ordinamento internazionale;
2) la recente proibizione internazionale di muovere guerra è il frutto di una significativa
evoluzione del DI che oggi proibisce, in linea di principio, ciò che un tempo era lecito.
L’attuale ricorso alla guerra viene giustificato dagli Stati invocando eccezioni alla generale norma
proibitiva.
Il complesso problema della legittimità della guerra trova un utile strumento giuridico di
comprensione nella distinzione tra “guerra-rivoluzione” e “guerra-sanzione”: quest’ultima possiede
15
Estinzione della soggettività giuridica internazionale in conseguenza della sconfitta militare.
42
una legittimazione non posseduta dalla prima, cioè il potere di sanzionare una precedente violazione
del DI, e non l’intenzione di creare un nuovo ordine.
Questa impostazione comporta che, di fatto, “la legittimità o meno della guerra non può stabilirsi ex
ante, ma ex post. La rivoluzione, se riesce, instaura un ordinamento nuovo e con ciò stesso di auto
legittima; se non riesce, essa si evolve in una semplice ribellione all’ordine costituito e, quindi, in
nient’altro che in una serie di fatti illeciti”.
La nozione di “guerra-rivoluzione” va completata dall’ulteriore, realistica constatazione che, a
volte, la guerra illegittima, pur essendo riconosciuta tale dagli Stati non belligeranti, può comunque
non essere sanzionata da questi ultimi per la loro incapacità politica e militare di irrogare la
sanzione nei confronti dello Stato aggressore (illecito accertato ma non sanzionato).
Ogni tentativo di limitare giuridicamente il ricorso alla guerra e alla forza nelle RI sconta l’assenza
di una istanza internazionale, terza ed imparziale, capace di imporre ai belligeranti le proprie
valutazioni e decisioni.
Gli Stati hanno creato nel corso dei secoli un consistente corpus normativo sempre più ampio ed
articolato per regolare il modo di fare in guerra, c.d. ius in bello. Nel corso dell’Ottocento emersero
due tendenze giuridiche:
1) si tentò di disciplinare il diritto di fare la guerra, c.d. ius ad bellum;
2) si “umanizzarono” le ostilità belliche introducendo, nello ius in bello, una serie di norme a
tutela degli individui, civili o militari, in esse coinvolti, c.d. diritto internazionale
umanitario.
Il diritto internazionale umanitario (DIU) si applica in situazioni di guerra. Esso trovò compiuta ed
organica positivizzazione in alcune importanti convenzioni concluse a L’Aja e a Ginevra. Queste
convenzioni, oltre a regolamentare la condotta degli eserciti durante il conflitto (c.d. diritto
dell’Aja), introdussero norme a tutela degli individui, civili o militari, in esse coinvolti a qualunque
titolo nelle ostilità (c.d. diritto di Ginevra).
Ai conflitti armati internazionali si applicano le Convenzioni del 1949 ed il primo Protocollo
aggiuntivo del 1977. Essi sono conflitti tra Stati o conflitti a questi assimilabili (lotta di un popolo
all’autodeterminazione contro una dominazione coloniale, razziale o un’occupazione straniera).
I conflitti armati interni, c.d. guerre civili, sono regolate dalle Convenzioni del 1949 e dal secondo
Protocollo aggiuntivo del 1977. Nel caso in cui un conflitto armato privo di carattere internazionale
scoppi sul territorio di uno degli Stati parti, tutti i belligeranti sono tenuti a garantire e rispettare una
serie di obblighi minimi di trattamento in qualunque situazione e a beneficio di qualunque individuo
(garanzie umanitarie fondamentali). Nel 1977 si ampliò la tutela per gli individui coinvolti a
qualunque titolo nel conflitto interno, definendo in modo più puntuale la stessa nozione: è interno il
conflitto che non ricade nella definizione di conflitto internazionale e che “ha luogo nel territorio di
uno Stato tra le sue forze armate e le forze armate dissidenti o altri gruppi armati organizzati”. Le
situazioni interne si ritengono internazionalmente rilevanti quando “la guerra civile abbia raggiunto
un’intensità tale da essere equiparata ad uno scontro tra due eserciti convenzionali”.
Il c.d. principio di umanità è una clausola considerata una sorta di “norma” di chiusura dell’intero
sistema di DIU dal momento che è formulata in modo da colmare ogni eventuale lacuna nella
disciplina convenzionale mediante rinvio al diritto non scritto.
Tale principio, come quasi tutto il DIU, è considerato diritto generale avente natura inderogabile
(CIG e ICTY).
43
6. Lo ius ad bellum nel diritto internazionale generale e onusiano: il divieto di minaccia e uso
della forza, l’aggressione e la rappresaglia
Lo ius ad bellum,cioè il diritto di muovere guerra, venne limitato sin dagli anni ’20 del Novecento
fino alla sua completa proibizione nel 1945, con l’approvazione della Carta dell’ONU: la rinuncia
degli Stati alla forza e, contestualmente, il loro comune impegno a mantenere la pace e la sicurezza
internazionale rappresentano le chiavi di volta dell’intero sistema onusiano.
Tuttavia, numerosi sono stati, dopo il 1945, gli episodi della prassi in aperto contrasto o in pretesa
deroga all’art. 2 della Carta dell’ONU. Di fronte al ripetuto uso illecito della forza la dottrina si è in
sostanza divisa in tre filoni:
1) Il filone maggioritario (CIG) considera tali episodi quali “mere” violazioni della norma che
non ne inficiano la cogenza;
2) Il filone minoritario attribuisce alle ripetute violazioni della norma un valore addirittura
desuetivo;
3) Il terzo orientamento, sempre più diffuso, considera alcuni di questi episodi come indicativi
di nuove e legittime eccezioni al divieto della Carta che, quindi, verrebbe derogato ab
externo.
L’attuale nozione di uso vietato della forza riguarda la forza armata (oltre a essere vietata la
minaccia dell’uso della forza) e non anche la coercizione economica o politica. Tale quadro rende,
di conseguenza, illecita sia l’aggressione che la rappresaglia.
La nozione di aggressione è definita come “l’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la
sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato, o in qualunque altro
modo contrario alla Carta delle Nazioni Unite”.
Tra gli atti di aggressione sono annoverati “l’invasione o l’attacco al territorio di uno Stato da parte
delle forze armate di un altro Stato, o un’occupazione militare, anche temporanea, risultante da tale
invasione o da tale attacco, o un’annessione con l’impiego della forza nel territorio o in una parte
del territorio di un altro Stato”; “ il bombardamento da parte delle forze armate di uno Stato contro
il territorio di un altro Stato o l’impiego di una qualsiasi arma da parte di uno Stato contro il
territorio di uno Stato”; “il fatto che uno Stato metta a disposizione di un altro Stato il proprio
territorio per perpetrare un’aggressione armata”.
Nessuna motivazione di ordine politico, militare, economico può mai giustificare un’aggressione e
la guerra di aggressione costituisce un crimine contro l’umanità che impedisce all’aggressore di
godere di qualunque frutto dell’azione illecita.
L’applicazione del criterio politico dei “due pesi due misure”, c.d. double standard, nel valutare gli
atti di aggressione non ha ancora permesso la cristallizzazione di una nozione giuridica certa e
vincolante nel DI generale.
La rappresaglia (o contromisura) è una forma di autotutela che consiste nella possibilità per lo
Stato di ledere, a sua volta, un diritto dello Stato offensore. Secondo i principi generali di autotutela,
se proporzionata alla lesione subita e se non armata, l’azione di rappresaglia non è illecita per
l’ordinamento.
La rappresaglia è, quindi, una reazione ad un’azione ormai esaurita nei tempi e nei modi. Nel caso
in cui, invece, l’azione sia ancora in corso, la reazione è a titolo di legittima difesa. Se, infine, non si
reagisce a qualcosa ma si agisce per primi, usando la forza, si avrà un’aggressione.
In concreto, non è facile distinguere la rappresaglia dalla guerra e dalla legittima difesa, ma un
convincente criterio di distinzione tra guerra e rappresaglia potrebbe stare nell’intento (animus)
dello Stato offeso che agisce: se l’obiettivo è quello di riparare il torto subito in precedenza si avrà
rappresaglia; se, invece, l’obiettivo dell’azione violenta è debellare l’altro Stato, allora si avrà
guerra.
44
La rappresaglia può essere sia armata che pacifica, ma, benché la prima sia stata per secoli la tipica
sanzione del DI, la Carta dell’ONU l’ha vietata nella misura in cui implica la minaccia o l’uso della
forza contro un altro Stato.
Per reagire ad un illecito subito, perciò, l’unica possibilità è adottare contromisure non coercitive,
pacifiche, proporzionate, di durata limitata e reversibili.
7. Il capitolo VII della Carta dell’ONU ed il ruolo del Consiglio di Sicurezza
Di fronte alla scelta radicale di bandire la minaccia e l’uso della forza dall’ordinamento
internazionale, la Carta approntò una disciplina giuridica alternativa per i casi di necessario ed
inevitabile ricorso alla coercizione armata, attribuendo al SC il monopolio dell’uso della forza e
lasciando agli Stati, in via eccezionale e condizionata, la sola possibilità di usare la forza in
legittima difesa.
Il riferimento normativo è il capitolo VII della Carta dell’ONU (artt. 39-51), dedicato proprio
all’Azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione.
L’art. 39 fissa i presupposti per l’azione del SC che consistono nel previo accertamento (rimesso
alla discrezionalità politica del SC) della “esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione
della pace, o di un atto di aggressione”. Il SC può limitarsi a fare raccomandazioni oppure decidere
“quali misure debbano essere prese…per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza
internazionale” (misure obbligatorie per tutti gli Stati membri).
L’art. 40 indica le c.d. misure provvisorie che non sono oggetto di decisione vincolante del SC, ma
di sola raccomandazioni: il SC “invita le parti interessate ad ottemperare a quelle misure
provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili”. Tali misure non possono pregiudicare “i
diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate, avendo come unico scopo quello di evitare
l’aggravamento della situazione”; sono dunque misure cautelari e non obbligatorie per le parti.
Gli artt. 41 e 42 prevedono, invece, rispettivamente le c.d. misure non implicanti l’uso della forza
e le c.d. misure implicanti l’uso della forza, che vengono adottate con decisione vincolante.
Le misure previste dall’art 41 hanno contenuto vario a seconda del loro scopo che è quello di
costringere lo Stato, senza usare la forza armata, a porre fine alla minaccia, violazione della pace e
della sicurezza internazionale o all’atto di aggressione.
Stessi obiettivi che si possono raggiungere mediante l’uso di misure coercitive, secondo l’art.42.
Queste misure devono essere necessarie e proporzionali all’obiettivo da raggiungere, che è
unicamente quello di ripristinare la pace e la sicurezza internazionale violate o minacciate da uno
Stato.
Il monopolio dell’uso della forza da parte del SC si sarebbe dovuto realizzare mediante un
articolato sistema operativo incentrato sul SC e caratterizzato dall’impiego di contingenti militari
messi a disposizione dagli Stati membri ma posti sotto il comando politico del SC e quello militare
del Comitato di Stato Maggiore. Tale schema (artt. 43-47) è rimasto lettera morta.
Il “nuovo” sistema di sicurezza collettiva, pur incentrato sulla direzione politica del SC, prevede
l’autorizzazione del SC agli Stati membri ad impiegare la forza armata per il raggiungimento degli
obiettivi indicati dal SC.
Lo Stato autorizzato dal SC ha un notevole margine di libertà dal punto di vista militare e operativo,
sebbene, in teoria, il SC potrebbe (e dovrebbe) esercitare uno stretto controllo sull’operazione
militare autorizzata; nella prassi, tuttavia, il SC si limita a riscontrare che l’obiettivo dell’azione sia
raggiunto (questa impostazione ha dato vita alle più varie interpretazioni delle risoluzioni che
concedessero la c.d. autorizzazione implicita all’uso della forza).
La dottrina sta comunque dibattendo sul fondamento giuridico di legittimità di questo sistema di
sicurezza collettiva basato sulla delega (autorizzativa) all’uso della forza da parte del SC agli Stati
membri:
45
-
-
-
Per alcuni, tale sistema non ha fondamento, neanche implicito, nella Carta e, in ogni caso, le
azioni di sicurezza collettiva dovrebbero inderogabilmente rispettare il generale limite
funzionale di legittimità costituito dal solo obiettivo di mantenere o ripristinare la pace e la
sicurezza internazionale;
Per altri, si sarebbe formata una norma consuetudinaria, interna al sistema onusiano, che
legittimerebbe il diverso modello operativo;
Altri ancora, ritrovano il fondamento nella Carta, desumendolo implicitamente dal
complessivo impianto normativo della stessa oppure interpretando estensivamente alcune
sue disposizione (in particolare l’art.42);
PICONE fonda la legittimità di alcune autorizzazioni direttamente sul DI generale, in quanto
la Carta non sarebbe più un valido riferimento.
Di fronte all’impossibilità giuridica di agganciare alla Carta questo tipo di risoluzioni, c.d. ultra
vires, la tesi considera quali “deleghe in bianco del potere di intervento degli Stati, al fine di
legittimare…dei comportamenti statali unilaterali che restano…estranei al sistema ONU, e vanno
sottoposti al solo DI generale”; si viene così a formare una consuetudine, materiale e procedurale,
esterna al sistema onusiano (legittimata, anche, dall’ambito normativo e concettuale delle reazione
alla violazione di obblighi erga omnes).
8. Segue: le operazioni di peace-keeping
Sin dagli anni ’50, l’ONU riuscì ad istituire numerose missioni, a carattere non coercitvo, per il
mantenimento della pace, c.d. peace-keeping operations, che sono divenute via via più numerose,
complesse ed articolate per dimensioni, poteri e obiettivi perseguiti.
Le missioni di peace-keeping (PK) si svolgono sotto la direzione del Segretariato Generale (SG)
dell’ONU su delega del SC. Il compito principale del SG è costituire una forza di peace-keepers da
inviare in missione, composta dai contingenti messi volontariamente a disposizione dagli Stati
membri, i c.d. caschi blu.
I caschi blu (CB) costituiscono una forza multinazionale con un mandato ampio ed articolato, il cui
comando militare, operativo e logistico del personale civile e militare della missione è affidato a
uno o più Stati; il cui centro di controllo politico è il SC; il cui centro di controllo esecutivo è il SG;
il cui centro di controllo militare è il Comando Militare delle Forze Multinazionali sul territorio.
Dal punto di vista giuridico, si distinguono le operazioni di PK di:
a) prima e seconda generazione, dove l’uso della forza da parte dei CB è solo per legittima
difesa ed il consenso del sovrano territoriale è necessario per effettuare la missione;
b) terza generazione (o operazioni di peace-enforcement): dove i CB hanno mandato di usare
la forza anche coercitivamente per raggiungere gli obiettivi della missione ed il consenso del
sovrano territoriale non è necessariamente richiesto, c.d. mandato robusto.
Da ciò deriva che le operazioni di PK sarebbero sui generis, in quanto ascrivibili al Capitolo VI
della Carta e non al VII. Il tal senso si parla di operazioni a metà strada tra l’uno e l’altro, c.d.
Capitolo VI e mezzo, che, in pratica si fonderebbe su una “consuetudine” affermatasi all’interno del
sistema, in attuazione estensiva delle disposizioni del Capitolo VI”. Tale tesi è maggioritaria in
dottrina: PICONE sviluppa e applica anche alle operazioni di PK la tesi che vuole attribuite, agli
Stati ONU, nuove competenze e poteri fondati sul DI generale, considerando variegata e copiosa la
prassi in materia (soprattutto post-1989). Egli spiega, dunque, la prassi come manifestazione del
potere di cui sono investiti gli Stati “di tutelare uti universi, cioè collettivamente, per conto della CI,
determinati valori essenziali della CI” e dell’attribuzione all’ONU dei poteri strumentalmente
necessari per adempiere a tale compito.
46
Tuttavia, fuori da questa impostazione, se si esamina la sostanza effettiva delle operazioni di PK,
diventa possibile ascrivere anche queste operazioni alle funzioni del SC ex artt. 39-42 (Capitolo
VII). Infatti, l’elemento caratterizzante il Capitolo VII dal punto di vista giuridico è lo stesso fine
ultimo e complessivo che le sue norme perseguono, non lo strumento che, in concreto, si utilizza
per raggiungerlo. Esaminando in quest’ottica i mandati delle operazioni di PK ci si accorge che,
seppur in forme, qualificazioni e strumenti diversi, perseguono tutti i fini tipici indicati dall’art. 39 e
ss.
9. Le eccezioni al divieto di minaccia e uso della forza: la legittima difesa e le dottrine
cosiddette preventive sull’uso della forza
Fuori dal caso dell’autorizzazione del SC, in base alla Carta l’unico altro modo di usare
legittimamente la forza per uno Stato è in legittima difesa.
Questo istituto (art. 51) giustifica in punto di diritto, escludendone l’illiceità, l’azione violenta che
lo Stato intraprende per difendersi da un attacco armato e in atto (o imminente) nei suoi confronti.
La legittima difesa può anche essere collettiva quando uno o più Stati agiscono in difesa di un altro
Stato oggetto di un attacco.
La reazione difensiva violenta dell’aggredito incontra stringenti limiti di legittimità:
- l’attacco deve essere armato e attuale (o imminente);
- la reazione deve essere necessaria, immediata e proporzionata;
- la reazione deve essere finalizzata esclusivamente ad interrompere l’attacco (ogni attività
coercitiva successiva alla cessazione dell’attacco, diventa rappresaglia armata, vietata dal
DI).
La legittima difesa, tuttavia, ha un limite funzionale nella Carta: lo Stato aggredito ha diritto di
difendersi fino a quando “il SC non abbia preso le misure necessarie al mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale”.
In base ad una lettura sistematica dell’art. 51 della Carta e del DI generale, si possono coordinare i
sistemi di sicurezza collettivi dell’ONU e del DI generale nel senso che il primo prevale, da un
punto di vista operativo e funzionale, sul secondo, a patto che il SC non sia in stallo per il
disaccordo politico ed i veti incrociati dei membri permanenti.
Si può quindi parlare di una sorta di “complementarietà” che presuppone, in linea di principio, la
prevalenza sempre del sistema onusiano ma, in caso di suo stallo, la “ricaduta”, c.d. fall-back, della
fattispecie sul sottostante sistema di DI generale che, a quel punto, attivandosi la disciplina. Si
garantisce così che la pace e la sicurezza internazionale saranno sempre mantenute o ripristinate
qualunque sia la condizione politica internazionale.
Il problema più complesso in tema di legittima difesa è che, negli ultimi 60 anni, gli Stati hanno
tentato di ampliare a dismisura e indebitamente la nozione così da poter “etichettare” con questa
definizione praticamente qualsiasi uso della forza, altrimenti vietato.
La prassi internazionale successiva all’11 settembre 2001 dimostra che alcuni Stati, in particolare
gli Stati Uniti, hanno preteso di ampliare, a dismisura, i limiti di legittimità dell’istituto, reinterpretando in modo estensivo:
a) la nozione di “attacco armato”, fino a ricomprendervi anche gli atti sporadici, intermittenti e
di non particolare gravità o intensità, i c.d. small-scale attack. Se la nozione “classica
implicava, da un lato, l’invio di forze armate regolari nel territorio di un altro Stato e,
dall’altro, uno stretto legame organico tra le forze che conducono l’attacco e lo Stato
straniero, oggi si asserisce in maniera innovativa che:
47
1) sono “attacchi armati” anche gli atti terroristici16;
2) vanno estensivamente attribuite ai sovrani territoriali tutte le azioni dei gruppi
terroristici presenti e operanti sui loro territori.
b) il criterio di attribuzione dell’attacco armato allo Stato facendovi rientrare qualunque atto
compiuto dai non-State actors (i.e. i gruppi terroristici) presenti ed operanti sul territorio
dello Stato. Per sostenere l’ampliamento innovativo della norma sulla legittima difesa
potrebbe essere addotto l’esempio dell’Afghanistan e di Al-Qaeda, ma è poco indicato per
almeno due ragioni:
- ammesso e non concesso che l’attacco dell’11 settembre 2001 equivalesse a un
“attacco armato”, non si sarebbe comunque trattato di legittima difesa (ma di
rappresaglia degenerata in guerra), essendosi l’attacco esaurito.
- pur ammettendo che, al di là della contingente e temporanea cessazione dell’attività
ostile il giorno 11 settembre, l’attacco fosse armato e fosse anche e ancora in corso (ongoing) o di nuovo imminente, gli stretti ed effettivi legami tra Al-Qaeda e il governo dei
talebani dell’Afghanistan potrebbero far ipotizzare un vincolo organico tra loro piuttosto
che un’innovativa, estensiva attribuzione allo Stato degli atti dei non-State actors.
c) l’accezione preventiva fino a ricomprendervi non solo gli attacchi in corso o imminenti, ma
anche quelli solo ipotizzati, ipotizzabili e puramente eventuali.
Si ricordi che, in linea assolutamente generale, il diritto a difendersi legittimamente è condizionato
in modo stringente prima in punto di fatto (attacco in corso o imminente) e poi, se l’attacco sussiste,
anche in punto di diritto (reazione necessaria e proporzionata).
Fuori dal limite di fatto, lo Stato non ha alcuno diritto a reagire e la competenza è, eventualmente,
del SC; fuori dal limite di diritto la reazione dello Stato è illegittima.
Non si tratta dunque di introdurre una nuova e più ampia nozione teorica di attribuzione, ma di
interpretare, nel caso concreto, quella esistente in buona fede così che diventi efficace strumento di
lotta contro certi fenomeni e non si presti, invece, ad abusi giuridici e strumentalizzazioni politiche.
Nel distinguere gli attacchi armati dagli atri usi della forza, la giurisprudenza della CIG è chiara, e
anche nella prassi è conforme e si adegua, e ritiene che:
a) gli attacchi intermittenti di un gruppo terroristico non costituiscono attacchi armati (lo Stato
deve rimanere inerte o comunque reagire in maniera proporzionata e non si deve abbassare
la soglia oltre la quale un attacco diventa armato);
b) un gruppo terroristico in sé e per sé non può muovere guerra ad uno Stato.
Il parametro della proporzionalità, rispetto alla distinzione su menzionata, è forse più decisivo per
gli equilibri internazionali e per garantire l’esigenza fondamentale di ogni Stato: quella di vivere in
sicurezza ed auto tutelarsi quando necessario.
Per quanto riguarda la difesa preventiva, il requisito dell’imminenza garantisce allo Stato di poter
adeguatamente prevenire le minacce esterne e, nello stesso tempo, evita di fondare la reazione
anticipata sulla diversa nozione della ragionevole prevedibilità dell’attacco che darebbe spazio a
valutazioni dello Stato che si “sente” minacciato troppo discrezionali, soggettive ed unilaterali. Il
tentativo di estensione in senso preventivo dell’ambito di legittimità della difesa fino alle minacce
solamente future ed ipotetiche è, a volte spiegato con la “inherent right theory” (art. 51). Tale teoria
è da respingere non solo perché esiste già una convincente spiegazione del significato e della
funzione del termine “inherent”, ma è anche dimostrato che la norma consuetudinaria autorizzasse
un tempo, e tutt’oggi, la difesa preventiva.
16
L’11 settembre 2001, i lanci di razzi contro Israele dal Libano nel 2006 (Hezbollah) e da Gaza nel 2008-2009
(Hamas).
48
La difesa preventiva concepita come mezzo per contrastare fenomeni lesivi e minacciosi ipotizzati,
non consoce i requisiti della proporzionalità della reazione all’azione aggressiva (assente), della
necessità della difesa (considerata in re ipsa) e neanche dell’essere reazione strumentale a fermare
l’attacco in corso.
L’opposizione della CI, della dottrina e dell’ONU alla dottrina della guerra preventiva fu da subito
compatta e giuridicamente fondata, al punto da impedire qualunque suo radicamento
nell’ordinamento internazionale.
10. Segue: le altre eccezioni: quelle fondate sul diritto internazionale generale; lo Stato di
necessità; il caso fortuito; la forza maggiore; il distress; il consenso dell’avente diritto
Una questione di massima attualità e attenzione è quella che si siano formate dopo 1945 nuove
norme permissive sull’uso della forza e ruota attorno all’idea che la violazione di obblighi erga
omnes legittimi una reazione, anche coercitiva, di uno o più Stati (ma uti universi) contro chi quegli
obblighi ha violato (i.e. intervento umanitario). Sebbene l’elaborazione teorico-dottrinale a sostegno
è ormai delineata e convincente, restano da accertare due ulteriori condizioni, di carattere pratico,
inerenti questa prospettiva:
a) che, nella prassi, l’attuazione coercitiva degli obblighi erga omnes si riscontri effettivamente
e con il supporto dell’opinio juris della maggioranza degli Stati;
b) che l’attuazione in concreto del principio teorico non sia oggetto di manipolazioni ed abusi
di natura politica.
Si noti che l’attuazione uti universi di obblighi erga omnes si inserisce, con coerenza e senza
soluzione di continuità, nell’impianto sistematico generale della dottrina realistica del fenomeno
socio-giuridico internazionale. Le difficoltà nascono nel momento in cui il SC assume un ruolo
preminente nella fase decisoria, esecutiva ed operativa di un meccanismo uti universi. Infatti, nel
momento in cui la reazione comunitaria alla violazione di obblighi erga omnes si
“procedimentalizza” attraverso un organo politico che diecide condizionato giuridicamente dai
membri permanenti, non possono sorgere dubbi sulla tenuta giuridica della teoria di fronte ai
comportamenti politici del SC.
Vediamo ora altre tipiche ed indiscusse eccezioni al divieto sull’uso della forza che costituiscono
altrettante circostanze di esclusione dell’illecito, non dando luogo a responsabilità internazionale.
Il consenso dell’avente diritto (cioè lo Stato che avrebbe titolo a invocare la responsabilità da
illecito di un altro Stato) al compimento da parte di un altro Stato di un atto o comportamento lesivo
sul proprio territorio legittima l’azione coercitiva, escludendone l’illiceità. Nella prassi, l’ipotesi si è
spesso verificata nel caso di azioni per la liberazione di ostaggi compiute da forze speciali straniere
in territorio altrui. Il consenso, per essere validamente prestato, deve provenire da un governo
effettivamente rappresentativo ed essere liberamente prestato, senza coercizioni, prima o
contemporaneamente al fatto.
Nel caso di distress (estremo pericolo) l’autore dell’illecito viola intenzionalmente la norma perché
non ha un altro ragionevole e praticabile modo per salvare la propria vita o le vite di altre persone
affidate alla sua cura.
La causa di forza maggiore si verifica quando “l’autore del fatto, pur rendendosi conto che il suo
comportamento lede un diritto spettante a uno Stato, non è materialmente [per una forza irresistibile
o un evento imprevedibile] in grado di impedire l’evento”. In tal caso manca la volontà dell’agente
di violare la norma.
49
Nello stato di necessità il compimento dell’atto illecito è “l’unico modo per salvaguardare un
interesse essenziale dello Stato nei confronti di un grave ed imminente pericolo e non pregiudica
seriamente un interesse essenziale dello Stato nei cui confronti era dovuto l’obbligo violato”. Chi
agisce per necessità non reagisce ad una precedente azione (a differenza della legittima difesa); per
chi agisce per necessità, il pericolo non riguarda una o più persone ma l’ente poltico-collettivo
statuale (a differenza del pericolo imminente). Per alcuni si tratterebbe di un vero e proprio diritto
alla conservazione dello Stato; altri ritengono che tale ipotesi debba respingersi dati gli esempi della
prassi: c’è il rischio che il diritto di conservazione diventi una “supernorma” trasversale capace, per
il solo fatto di esistere, di condizionare tutte le altre indebolendo l’intero ordinamento.
Quest’ultima preoccupazione va ridimensionata, dato che il Progetto di articoli riconosce la
“necessity” ma, lungi dal considerarla generale causa di esclusione dall’illecito, la definisce in
termini molto ristretti, destinandola ad un’applicazione di carattere assolutamente eccezionale (in
caso di non lesione “seria” di interesse “essenziale” di un altro Stato).
Il caso fortuito si ha quando il fatto illecito dello Stato è dovuto ad un evento esterno imprevisto,
incontrollabile e di cui l’autore è rimasto inconsapevole. L’inconsapevolezza dello Stato di violare il
DI è il fondamento di questa causa.
11. Segue: l’intervento uti singuli e l’intervento umanitario
L’intervento attribuisce allo Stato, allo scopo di tutelare un proprio interesse (uti singuli), il diritto
di intervenire in territorio altrui, senza il consenso del sovrano territoriale, a protezione dei propri
cittadini che lì si trovino in pericolo (se necessario anche intervento armato).
Si è formata nel tempo una consuetudine internazionale che legittima l’intervento dello Stato di
cittadinanza a fronte dell’impossibilità o della non volontà dell’altro Stato di agire in protezione
degli interessi degli stranieri presenti sul proprio territorio. Questa è un’eccezione al divieto di uso
della forza che si fonda sul DI generale e va soggetta almeno a tre requisiti:
a) l’esistenza di un pericolo attuale o di gravi violazioni in danno dei cittadini stranieri;
b) l’impossibilità o la non volontà dello Stato territoriale di garantire adeguata protezione dal
pericolo;
c) la proporzionalità dell’intervento rispetto al pericolo e all’obiettivo di protezione.
L’intervento umanitario (IU), invece, è sempre operato nell’interesse dell’intera CI (uti universi).
È previsto il diritto per uno o più Stati sulla base del DI generale di agire legittimamente uti universi
nel territorio di uno Stato dove sia in corso una grave e sistematica violazione dei diritti umani
fondamentali. Gli Stati agirebbero dunque come “gestori dell’ordinamento giuridico internazionale”
e non violerebbero né il divieto di ingerirsi negli affari interni dello Stato, né quello di rispettarne
l’integrità territoriale e l’indipendenza politica, né quello di non usare la forza.
Qui non rileva il contegno del sovrano territoriale ai fini della legittimazione ad intervenire. L’IU va
ricondotto, come species a genus, all’esistenza e alla tutela degli obblighi erga omnes.
Il problema giuridico da risolvere in tema di IU è quello di ritrovare il punto di equilibrio tra il
principio del divieto di ingerenza negli affari interni dello Stato e il principio che è finalizzato alla
cura degli interessi ritenuti coessenziali alla stessa esistenza della CI.
Su questo teoria e prassi sono discordanti: l’IU, tanto più se applicato in via preventiva, si presta a
strumentalizzazioni politiche e diventa talvolta una posticcia legittimazione giuridica per il
raggiungimento di fini politici ulteriori17.
17
Alcuni episodi della prassi: intervento della NATO contro la Serbia-Montenegro nel 1999 tutela dei kosovari;
intervento USA in Nicaragua contro il governo sandinista; intervento in Iraq nel 1990 contro il governo irakeno a favore
di curdi.
50
Un tentativo di chiarire questi complessi problemi giuridici si ebbe nel 2000 con la costituzione
della Commissione Internazionale sugli Interventi e sulla Sovranità degli Stati (ICISS) chiamata
a studiare i nuovi confini politici e giuridici tra IU e sovranità statuale. Nel suo report, l’ICISS ha
evidenziato la nozione di “responsabilità di protezione” dello Stato verso i propri cittadini. Tale
responsabilità, che diviene un obbligo di protezione, grava sullo Stato e, nel caso in cui questo non
possa o non voglia adempierlo, sulla CI.
Inquadrare l’IU come conseguenza necessitata della violazione del dovere di protezione verso i
propri cittadini incombente sullo Stato è un primo passo importante per allontanare da questo
istituto il rischio dell’indebita ingerenza esterna negli affari interni dello Stato. Il secondo passo è
stato quello di limitare l’intervento a ipotesi di più gravi crimini internazionali, contribuendo ad
evitare indebite ingerenze e strumentalizzazioni.
Resta, tuttavia, il problema della codificazione dettagliata di quello che è ancora in prevalenza un
generico orientamento politico degli Stati e, soprattutto, di valutare in concreto, caso per caso, se
tali norme vengano applicate con coerenza e tempestività nell’interesse di tutte le popolazioni
oggetto di crimini internazionali.
Nell’ottica della minimizzazione di questi rischi, l’ICISS sin dal 2000 e, poi, il SC dell’ONU hanno
formulato alcuni orientamenti tesi a regolare (e limitare) l’intervento militare nel territorio dello
Stato che non protegge i propri cittadini. La reazione della CI deve essere appropriata e necessaria:
questi parametri vanno misurati in funzione delle molteplici e pacifiche modalità di pressione ed
intervento che possono attuarsi nei confronti dello Stato incapace o recalcitrante a fermare e punire
le violazioni commesse sul proprio territorio. Solo in un secondo momento ed eventualmente,
l’appropriatezza e la necessità dell’IU saranno misurate in funzione di provvedimenti coercitivi
(usati previa autorizzazione del SC come extrema ratio).
51
CAPITOLO VII – ILLECITO E RESPONSABILITA’ DELLO STATO
1. L’illecito internazionale. Nozione ed elementi costitutivi: l’elemento oggettivo
La commissione di un atto internazionale illecito è il presupposto della responsabilità internazionale
dello Stato.
Mentre le norme primarie fissano gli obblighi internazionali, le norme secondarie stabiliscono le
conseguenze che derivano dalla violazione delle prime.
Specularmente si instaura nell’ordinamento internazionale un rapporto giuridico primario, avente
ad oggetto la vigenza ed il rispetto della norma convenzionale o consuetudinaria che fissa l’obbligo,
ed un rapporto giuridico secondario che sorge, dopo la violazione dell’obbligo previsto dalla
norma primaria, tra il soggetto leso e il soggetto offensore. Su quest’ultimo grava non solo l’obbligo
di adempiere quello primario violato, ma anche di adempiere quello secondario conseguente
all’avvenuta commissione dell’illecito, oltre alla possibilità di essere soggetto al potere
sanzionatorio dello Stato leso.
Le norme internazionali in materia di illecito e responsabilità sono di tipo consuetudinario, e hanno
visto con l’approvazione del Progetto di articoli del 2001 un importante momento di codificazione e
sviluppo progressivo in materia, anche se lo strumento è limitato perché non riprodotto dagli Stati in
uno strumento giuridico internazionalmente vincolante.
L’illecito internazionale ha due elementi costitutivi: uno di carattere soggettivo e l’altro di carattere
oggettivo.
L’elemento oggettivo consiste nella violazione di un obbligo internazionale vigente per lo Stato al
momento del compimento dell’atto (fatto illecito commissivo) o dell’omissione (fatto illecito
omissivo): esso consiste nell’antigiuridicità della condotta secondo il generale principio di legalità.
L’illecito può essere:
- istantaneo, quando la violazione dell’obbligo internazionale non presenta un carattere
continuativo, ma si esaurisce nel momento in cui lo Stato pone in essere la condotta
antigiuridica;
- continuativo, quando la violazione si estende su tutto l’intero periodo in cui l’atto continua e
permane non conforme con l’obbligazione internazionale.
Non incide, poi, il tipo di norma violata sulla qualificazione dell’illecito, quello che cambia in modo
significativo sono le conseguenze giuridiche dell’illecito in funzione proprio del tipo di norma
violata. Ciò è testimoniato dalla scomparsa della distinzione tra crimina e delicta (o violazioni
minus generis): i primi costituenti una violazione di un obbligo internazionale essenziale per la
salvaguardia di interessi fondamentali della CI; i secondi, costituenti una violazione di ogni altra
norma internazionale.
La categoria dei crimini internazionali dello Stato non è mai nata, tuttavia, a livello sostanziale, la
coscienza giuridica collettiva degli Stati avverte, reagendo di conseguenza, l’esistenza di fatti illeciti
dello Stato di particolare gravità, di “speciale” illiceità che vanno puniti con regimi speciali di
responsabilità e non con regimi ordinari.
Secondo il Progetto di articoli, la prassi e la giurisprudenza, la colpa non sarebbe un elemento
costitutivo dell’illecito; per cui, in assenza di causa di giustificazione, lo Stato sarà considerato
internazionalmente responsabile a prescindere del contegno psicologico dell’individuo-organo.
L’aspetto psicologico dell’individuo-organo rileva con riguardo:
1) ad alcune circostanze di esclusione di illecito (caso fortuito, per cui la violazione non è
dovuta al comportamento dell’individuo-organo);
2) al quantum della riparazione, maggiore o minore in funzione dell’atteggiamento psicologico
(doloso o negligente) dell’individuo-organo;
3) nei casi specifici indicati dal Progetto di articoli.
52
Per quanto riguarda il danno (morale o materiale), esso non è un elemento costitutivo dell’illecito:
il Progetto di articoli non ne fa menzione, considerando che già la stessa violazione della norma sia
un danno. Esso può rilevare al momento di quantificare concretamente la riparazione dovuta per
l’illecito commesso: dovrà essere “totale” e in essa va compreso qualunque danno, morale o
materiale.
2. Segue: l’elemento soggettivo. Gli organi di fatto
L’elemento soggettivo dell’illecito internazionale consiste nell’attribuibilità allo Stato, in base al
DI, dell’azione o dell’omissione lesiva dell’obbligo internazionale.
Al fine dell’attribuzione o meno della condotta dello Stato, non conta la ripartizione interna di
competenze. Indipendentemente da chi sia il responsabile, in base al diritto interno dello Stato, della
condotta internazionalmente illecita, le norme internazionali sulla responsabilità da atto illecito si
limitano ad attribuire la condotta allo Stato in quanto soggetto di DI.
Lo Stato è altresì responsabile nell’ipotesi del c.d organo esorbitante, cioè dell’organo che agisce
fuori delle competenze a lui attribuite dal diritto interno o contro le istruzioni ricevute, e nell’ipotesi
del c.d. organo di fatto, cioè del privato che, pur non essendo organo dello Stato, esercita comunque
“elementi” di autorità governativa.
Per quanto riguarda quest’ultima fattispecie, l’evoluzione giurisprudenziale ha condotto
all’enucleazione ed applicazione della diversa nozione di “overall control”, più ampia ed
onnicomprensiva (della precedente nozione di “under the control”) in base alla quale ai fini
dell’accertamento del legame organico di fatto tra Stato e gruppi armati organizzati è sufficiente
dimostrare che lo Stato impartisce al gruppo direttive di portata generale: è sufficiente, perché poi
ne risponda, che lo Stato abbia il controllo generale e complessivo (e non come precedentemente
diretto e specifico) delle condotte del gruppo. Nel caso della condotta del singolo privato (o del
gruppo non organizzato militarmente), lo Stato è responsabile indirettamente delle loro azioni, per
non aver impedito il verificarsi della condotta illecita ad opera dei singoli privati o gruppi di privati.
3. La responsabilità dello Stato come conseguenza dell’illecito
La violazione di una norma consuetudinaria o convenzionale legittima solo lo Stato leso a
invocare la responsabilità internazionale dello Stato offensore, nei confronti del quale fa valere:
a) l’obbligo di cessare la condotta illecita, chiedendo anche garanzie ed assicurazioni di non
ripetizione di tale condotta;
b) l’obbligo di riparare integralmente il pregiudizio, morale e materiale, causato.
La violazione di una norma di jus cogens, prevede in aggiunta:
a) l’obbligo di tutti gli altri Stati di cooperare al fine di porre termine alla violazione;
b) l’obbligo per tutti gli altri Stati di non riconoscere come legittima la situazione creatasi a
seguito della violazione e di non aiutare o contribuire al perdurare dell’illecita situazione.
La violazione di un obbligo erga omnes da spazio a diverse ipotesi:
a) in via generale, chi debba considerarsi leso dall’illecito: 1) è leso lo Stato cui era dovuto
“individualmente” l’obbligo violato (obbligo dei trattati bilaterali); 2) è leso lo Stato che fa
parte di un gruppo di Stati, nei confronti dei quali era dovuto l’obbligo violato (obbligo erga
omnes partes); 3) è leso lo Stato, in quanto facente parte della CI, quando l’obbligo violato
era dovuto a quest’ultima intesa nella sua unità (obbligo erga omnes).
Negli ultimi due casi, lo Stato si considera leso se la violazione altera radicalmente la
posizione di tutti gli Stati verso cui era dovuto l’obbligo per ciò che riguarda l’ulteriore
esecuzione della prestazione, c.d. obbligo interdipendente.
53
b) la possibilità per lo Stato, che non è leso dall’illecito, di invocare comunque la responsabilità
internazionale dell’offensore nell’interesse dello Stato leso o dello Stato beneficiario
dell’obbligazione violata.
La riparazione dell’illecito, cioè la cancellazione delle conseguenze dannose provocate dall’illecito
al fine di ristabilire lo status quo ante, può consistere nella restituzione, nella compensazione e nella
soddisfazione.
La restituzione in forma specifica (o in natura) ristabilisce la situazione che esisteva prima che si
verificasse l’illecito; se il ripristino dello status quo ante è impossibile o se comporta per l’offensore
un onere sproporzionato rispetto al beneficio di cui godrebbe lo Stato leso, questo tipo di
restituzione è esclusa.
La compensazione (o restituzione per equivalente) consiste nel pagamento allo Stato leso di una
somma pecuniaria corrispondente al valore stimato dalla restituzione in forma specifica; alla
compensazione può anche aggiungersi il risarcimento del danno, qualora le perdite non risultino già
coperte dalla restituzione in natura o per equivalente.
La soddisfazione è “la forma di riparazione che appare dovuta laddove le altre modalità non siano
state sufficienti a rimediare all’illecito; in particolare, essa permette la riparazione del danno morale
subito e può consistere in varie forme (scuse formali, rincrescimento, pagamento somma simbolica
o punizione individui responsabili dell’illecito).
Esistono dei limiti di legittimità alle contromisure che uno Stato leso può intraprendere a seguito
dell’illecito commesso da un altro Stato; in particolare le contromisure sono legittime se:
- sono adottate in risposta ad un precedente illecito di un altro Stato e “al fine di indurlo a
rispettare i suoi obblighi;
- non implicano l’uso o la minaccia della forza, né violano i diritti umani fondamentali;
- non violano le norme di jus cogens;
- sono proporzionate, temporanee e reversibili negli effetti;
- sono precedute da una richiesta di riparazione da parte dello Stato leso e dalla notifica
dell’intenzione di adottarle.
Possono adottare contromisure contro lo Stato offensore anche gli Stati non lesi ma legittimati ad
invocare la responsabilità internazionale dell’offensore, al fine di assicurare la cessazione della
violazione e la riparazione degli interessi dello Stato leso o dello Stato beneficiario delle
obbligazioni violate.
4. Responsabilità delle Organizzazioni internazionali
Per i regimi speciali di responsabilità si intendono quei sistemi normativi istituiti da trattati che, in
caso di violazione delle loro norme primarie, prevedono anche i meccanismi, le procedure e le
sanzioni da attivare ed applicare (norme secondarie) per far valere la responsabilità internazionale
da illecito dello Stato offensore.
Questi regimi così costituiti sono detti “autonomi o self-contained” per evidenziare proprio la loro
auto-sufficienza normativa (sistema OMC, sistema di protezione dei diritti umani).
La peculiarità di questi regimi sta nell’automaticità dei meccanismi procedurali che consentono agli
individui di attivare direttamente la procedura di accertamento della violazione contro lo Stato
membro.
Questi regimi convenzionali, per quanto autonomi, non vivono in un vacuum normativo, cioè al di
fuori del DI generale, ma esso costituisce la cornice di riferimento per il sistema convenzionale,
c.d. fall-back.
Per quanto riguarda la responsabilità delle OI, abbiamo visto nei capitoli precedenti come esse non
abbiano soggettività internazionale (dato il suo carattere derivato e strumentale nei confronti degli
54
Stati membri) per cui, in linea di principio, non può sorgere in capo ad esse un’effettiva
responsabilità.
Ciononostante, la posizione più diffusa in dottrina vuole che le OI siano internazionalmente
responsabili dei loro atti, in conseguenza della soggettività internazionale che possiedono (idea
altrettanto diffusa in dottrina), e che la responsabilità vari, da un’OI all’altra, in funzione delle
competenze attribuite e del grado di autonomia finanziaria voluto dagli Stati membri.
È a tal proposito in elaborazione un Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale delle
Organizzazioni internazionali da parte del CDI che considera illecito l’atto compiuto dall’OI se a
questa è attribuibile e se compiuto in violazione di un obbligo internazionale gravante su essa.
5. La responsabilità da fatto lecito
La responsabilità da fatto lecito, cioè quella che deriva allo Stato da una condotta lecita per il
diritto internazionale che abbia prodotto un danno ad un altro soggetto (attività inquinanti o
pericolose compiute sul proprio territorio).
Il tema è ancora molto dibattuto tra chi ritiene che possa esistere una norma sulla responsabilità da
fatto lecito e chi ritiene che in questi casi lo Stato sia responsabile per aver violato (commettendo un
illecito) la norma di DI generale che gli vietava danni ad altri Stati nello svolgimento di certe
attività.
Nondimeno, la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza sono orientate verso la preferenza per la
tesi della responsabilità da fatto illecito, dato che esiste un “obbligo generale degli Stati di fare in
modo che le attività condotte nell’ambito della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non
causino danni all’ambiente di altri Stati o a zone fuori dalla giurisdizione nazionale”.
55
CAPITOLO VIII – ESENZIONE DELLO STATO DALLA GIURISDIZIONE STRANIERA
E IMMUNITA’ DEI SUOI AGENTI. I TRIBUNALI PENALI INTERNAZIONALI
1. L’immunità dello Stato. L’“extraterritorialità” della sede diplomatica in territorio
straniero
Le peculiarità che contraddistinguono il modo di essere della CI (soggetti indipendenti e sovrani
superiorem non recognoscentes) si riscontrano anche nelle regole sulla tendenziale immunità degli
individui-organi dalla responsabilità per le condotte illecite dello Stato e nell’esenzione dello Stato
dalla giurisdizione straniera.
Lo Stato, in quanto soggetto di DI, è sempre internazionalmente responsabile per gli illeciti che
commette, mentre sono immuni (salvo eccezioni) i suoi individui-organi che hanno posto in essere
la condotta illecita sia per il DI che per il diritto interno degli altri Stati.
Le regole sull’immunità sono essenzialmente la necessitata conseguenza di un generale assetto delle
RI imperniato sulla parità ed eguaglianza dei soggetti che quelle relazioni intrattengono
(riconoscimento reciproco come strutture socio-giuridiche opache al loro interno).
Le regole sull’immunità soddisfano, inoltre, l’esigenza di garantire la continuità e la certezza dei RI
anche quando l’organo di uno Stato abbia violato il diritto interno di un altro Stato, garantendo cioè
il libero ed indisturbato esercizio della funzione diplomatica dello Stato nel territorio dello Stato
straniero.
La tutela degli individui-organi si estende anche alle sedi, agli archivi e ai beni delle missioni
diplomatiche e consolari dello Stato in territorio straniero, cioè ai locali e beni permanenti adibiti e
strumentali all’esercizio della missione.
Tuttavia le sedi diplomatiche e consolari in territorio straniero non sono spazi “extraterritoriali”,
cioè territorio straniero soggetto alla sovranità dello Stato che ha inviato la missione (Stato della
missione) e non a quella dello Stato territoriale. “Extraterritorialità” significa semplicemente che a
quella porzione di territorio, dove si trova la sede diplomatica o consolare, è garantita l’esenzione
dell’esercizio della giurisdizione dello Stato territoriale.
L’esenzione, benché amplissima, non è assoluta: essa è relativa in quanto è funzionalmente
commisurata alla sola necessità di consentire il libero, pieno ed indipendente esercizio della
funzione diplomatica dello Stato estero. La giurisdizione dello Stato territoriale si riafferma ogni
qual volta nell’ambito spaziale della sede non si esercitino attività correlate o inerenti l’esercizio
della funzione diplomatica e, in aggiunta, queste attività turbano o ledono gravemente l’ordine
pubblico dello Stato territoriale.
2. L’immunità (assoluta e relativa) degli Stati dalla giurisdizione straniera. La Convenzione di
New York del 2005 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni
L’istituto dell’immunità costituisce una significativa deroga al principio di territorialità in base al
quale lo Stato ha il diritto esclusivo di esercitare, sul proprio territorio, tutte le funzioni necessarie al
suo governo. La deroga si spiega con il principio “par in parem non habet imperium et
iurisdictionem”, che ha comunque subito una significativa evoluzione in tempi più recenti: se fino
alla metà del XIX secolo esso sanciva l’immunità assoluta dello Stato straniero dalla giurisdizione
dei tribunali interni dello Stato territoriale; più di recente esso si è evoluto sancendo la c.d.
immunità relativa, per cui l’immunità è garantita sono nei casi in cui lo Stato straniero agisce
nell’esercizio delle proprie prerogative sovrane (atti jure imperii) ed è negata ogni volta che lo Stato
straniero agisce come un normale soggetto privato nell’ambito dei rapporti giuridici di diritto
privato (atti jure gestionis o jure privatorum).
Il discrimine tra atto jure imperii e jure privatorum va ricercato nella sussistenza o meno di un
interesse direttamente connesso alle finalità pubbliche perseguite dallo Stato.
56
La regola sull’immunità relativa è divenuta una norma consuetudinaria, soddisfacendo la duplice
esigenza di regolamentare un fenomeno ormai frequente e di tutelare il privato che ha rapporti
giuridici con lo Stato straniero.
Tale consuetudine è recepita anche nella recente Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità
giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York nel 2005, che riconferma la garanzia
dell’immunità giurisdizionale solo per gli atti jure imperii. La Convenzione non si applica, però, ai
regimi d’immunità speciale18 né alle immunità e ai privilegi riconosciuti dal DI ai Capi di Stato, né
infine alle immunità relative ad aeromobili od oggetti spaziali “di proprietà o gestiti da uno Stato”.
L’art. 5 sancisce l’esenzione generale dello Stato dalla giurisdizione straniera salve le specifiche
eccezioni previste, tutte riconducibili ad attività iure privatorum dello Stato.
Lo Stato può rinunciare all’immunità, consentendo, per il singolo procedimento, l’esercizio della
giurisdizione nei suoi confronti da parte del tribunale locale. Il consenso deve essere esplicito,cioè
formalizzato in un accordo internazionale, in un contratto scritto o in una comunicazione scritta o
dichiarazione resa davanti al tribunale procedente, e non è desumibile per fatti concludenti.
Lo Stato non può più invocare l’immunità dalla giurisdizione qualora egli stesso abbia iniziato il
procedimento, qualora vi abbia partecipato senza sollevare obiezioni o qualora abbia agito in via
riconvenzionale, c.d. counterclaim. In ogni altro caso, se lo Stato convenuto si costituisce in
giudizio solo per invocare l’immunità, se non compare in giudizio restando contumace o se
compare un suo rappresentante in qualità di teste, la condotta dello Stato straniero convenuto non
sarà interpretabile come consenso ad essere giudicato e, quindi, come rinuncia all’immunità.
I casi in cui lo Stato non può invocare l’immunità, salvo il diverso accordo tra gli Stati interessati,
sono poi indicati negli artt. 10-17 della Convenzione.
Per quanto riguarda l’immunità dello Stato dalla giurisdizione di esecuzione, gli Stati hanno
interpretato questa forma di immunità in termini più ampi rispetto a quelli applicati all’immunità
dalla giurisdizione di cognizione dello Stato territoriale. La non coincidenza tra i due regimi di
immunità comporta che, a volte, uno Stato non sia immune dalla cognizione dello Stato territoriale
ma, ciononostante, i suoi beni restino immuni da misure esecutive o coercitive. In tal caso, il criterio
discriminante sta nell’essere il bene in oggetto di esecuzione destinato a finalità pubbliche o meno.
Su questo aspetto, la Convenzione si muove in prevalenza nel solco della codificazione del diritto
preesistente: in ottica di sviluppo progressivo la distinzione è tra misure anteriori e posteriori alla
sentenza. Le misure anteriori alla sentenza sono escluse, mentre le misure successive alla sentenza
sono possibili quando: 1) lo Stato vi acconsenta espressamente o abbia appositamente destinato
beni allo scopo; 2) il bene oggetto della misura coercitiva si trovi sul territorio dello Stato del foro e
sia utilizzato per un fine diverso da quello pubblico non commerciale.
3. L’immunità funzionale e personale dell’individuo-organo dello Stato
Le norme sull’immunità riguardano gli atti compiuti dall’individuo-organo nell’esercizio delle
funzioni pubbliche in territorio straniero. Quest’ultimo presupposto, il territorio straniero, è lo
stesso che giustifica le immunità dello Stato, ovvero il principio ne impediatur legatio.
Distinguiamo due tipi di immunità dell’individuo-organo:
- immunità funzionali: esse comportano “l’esenzione dalla giurisdizione del foro a favore
degli individui-organi che operano nell’esercizio delle mansioni loro affidate da uno Stato
estero”. All’individuo-organo spetta l’esenzione dalla giurisdizione penale e civile e tale
esenzione perdura anche dopo la cessazione dalla carica. Due aspetti sono importanti:
1) in forza dell’immedesimazione tra organo e corpo dello Stato, il titolare del diritto di
immunità è lo Stato;
18
Immunità delle sedi diplomatiche e consolari; immunità delle missioni speciali; immunità delle missioni e delegazioni
presso le Conferenze ed OI.
57
-
2) l’immunità non è mai dalla legge, ma sempre e solo dalla giurisdizione, il che
significa: a) che l’agente diplomatico non è autorizzato a violare le leggi dello Stato
di residenza; b) che l’immunità non fa venir meno il carattere di reato dei fatti; c) che
specie nel caso di attività causa di turbamento dell’ordine interno, gli Stati offesi
possono dichiarare l’agente persona non grata e porre termine alla missione
mediante espulsione o esercitando pressioni sullo Stato accreditante per il richiamo.
L’immunità dalla giurisdizione penale è assoluta, non conosce deroghe come stabilito dalla
Convenzione di Vienna del 1961; l’immunità dalla giurisdizione civile ed amministrativa è
esclusa quando l’individuo-organo agisce come privato cittadino.
immunità personali: esse garantiscono ad alcuni organi dello Stato19 una tutela
supplementare perché li rendono immuni dalla giurisdizione anche per gli atti compiuti a
titolo privato. La norma si giustifica con l’esigenza di garantire l’individuo-organo da
qualunque interferenza che lo possa ostacolare nel pieno e libero svolgimento delle sue
funzioni pubbliche. Questa immunità vale fino a quando l’individuo riveste la carica di
organo statale: cessata la carica, cessa anche l’immunità personale.
L’immunità personale, oltre a garantire l’immunità completa dalla giurisdizione penale e,
con dei limiti previsti nella Convenzione di Vienna del 1961, quella parziale dalla
giurisdizione civile ed amministrativa, comporta anche l’inviolabilità della persona e del suo
domicilio.
Negli ultimi anni la prassi (a livello convenzionale) si sta orientando in tema di immunità verso una
modifica della vigente disciplina normativa. Si afferma, in sostanza, che di fronte alla commissione
di crimini internazionali o alla violazione di norme di jus cogens, l’individuo-organo non goda di
alcuna immunità (né funzionale né personale) e sia responsabile a titolo personale e penale di fronte
ai tribunali interni ed internazionali. Secondo tale impostazione, l’immunità funzionale verrebbe
meno perché commettere un crimine internazionale non può mai considerarsi un atto inerente
l’esercizio di funzioni pubbliche, mentre la norma sull’immunità personale, anche mentre
l’individuo-organo è ancora in carica, non rileverebbe mai perché su di essa prevalgono le norme
che vietano inderogabilmente la commissione di simili efferati crimini internazionali. A corollario
di questa impostazione c’è la possibilità di perseguire e punire l’individuo-organo autore del
crimine in due modi:
a) nel DI, mediante i tribunali internazionali precostituiti (CPI) o istituiti ad hoc che fissano gli
obblighi di cooperazione per gli Stati parti ai trattati istitutivi o membri dell’ONU;
b) nel diritto interno, mediante eventuali clausole di giurisdizione penale universale in base
alle quali la pretesa punitiva dello Stato nei confronti dell’autore del crimine prescinde non
solo dalle immunità ma anche dai classici criteri di collegamento (personali o territoriali) tra
fatto criminoso e giurisdizione dello Stato.
Tuttavia, questa impostazione appare oggi ancora una tendenza giuridica del futuro più che un dato
normativo già rilevabile, effettivo e vigente. A parte qualche trattato internazionale e alcune
manifestazioni della prassi, il DI non ha ancora recepito questa modifica. La stessa CIG ha
affermato nel 2002 l’inesistenza di una norma consuetudinaria che neghi l’immunità per gli
individui-organi che commettono crimini internazionali o violano lo jus cogens. Il fondamento per
negare l’immunità all’individuo-organo non si riscontra, dunque, nel DI generale, ma va ricercato,
se esistente nel singolo caso, nel DI pattizio.
L’impostazione classica, ancora in prevalenza accolta dalla prassi, qualifica “l’atto compiuto
nell’esercizio delle funzioni” non in ragione delle finalità o dei motivi perseguiti dell’individuo
organo, ma in ragione “di qualunque collegamento, diretto od indiretto, con la funzione cui l’organo
è preposto. Si considera, perciò, ufficiale l’atto posto in essere attraverso l’impiego di strumenti
pubblicistici a disposizione dell’individuo organo in ragione della qualifica ricoperta”. Dunque, la
19
Capi di Stato, Capi di Governo, Ministri degli Affari Esteri, diplomatici.
58
responsabilità internazionale ricade sempre e solo sullo Stato di appartenenza dell’individuo-organo
ha posto in essere la condotta. L’eventuale sanzione per l’individuo-organo, aggiuntiva e
concorrente rispetto al regime sanzionatorio applicabile allo Stato, testimonia la volontà della CI di
ritrovare, di fronte ai crimini più efferati, strumenti di prevenzione e repressione sempre più
completi ed efficaci.
In conclusione, di fronte ad un crimine internazionale, ci sembra da accogliere la ricostruzione che
prevede, sulla base di apposite norme convenzionali, la responsabilità dello Stato e quella penale
dell’individuo-organo. Responsabilità che possono essere fatte valere con tempi, modi e procedure
diverse di fronte ad istanze diverse, in tal senso depone la più recente prassi dei tribunali penali
internazionali (TPI).
4. I Tribunali penali internazionali: dal Trattato di Versailles del 1919 ai Tribunali di
Norimberga e Tokyo
È con riguardo alla responsabilità penale dell’individuo-organo che si è talvolta parlato della c.d.
“giurisdizione penale internazionale” (GPI), cioè quella giurisdizione internazionale competente a
giudicare individui responsabili di crimini internazionali.
La maggior parte dei fenomeni di GPI trovano fondamento in trattati, cioè in accordi tra Stati i quali
consentono che la struttura burocratico-giudiziale da loro istituita eserciti, nelle sole fattispecie
previste dal trattato istitutivo, la competenza ad indagare, processare e punire gli individui-organi
degli Stati parti al trattato (idem per il tribunale penale internazionale fondato su una risoluzione del
SC). Ci si trova dunque dinanzi ad un fenomeno privatistico-contrattualistico interstatuale: il
tribunale internazionale è una “sovrastruttura” giuridica creata dagli Stati.
La nascita del Diritto Internazionale Penale (DIP) si fa risalire alla pretesa punitiva degli Stati
vincitori della Prima Guerra Mondiale nei confronti dell’Imperatore tedesco Guglielmo II di
Hohenzollern, artt. 227-228 del trattato di Versailles del 1919. I due articoli rimasero lettera morta,
ma una parte della dottrina riconosce valore giuridico a questo episodio storico.
Di avviso totalmente opposto è quella dottrina che dalla completa inesecuzione delle previsioni del
trattato di Versailles deduce l’inesistenza di qualunque sviluppo giuridico di carattere penale
nell’ordinamento internazionale.
Simili contrapposizioni sono emerse in dottrina anche riguardo alla creazione dei Tribunali
Internazionali di Norimberga e di Tokyo.
Autorevole dottrina è critica, dal punto di vista giuridico, nei confronti dei due tribunali e ne
ridimensiona il valore giuridico, ai fini dello sviluppo del DIP, discutendone la stessa
internazionalità. In particolare considera le due istanze giudiziali come organi comuni delle Potenze
vincitrici (e non organi internazionali), chiamati ad operare su territori destatalizzati della Germania
e del Giappone a seguito della sconfitta militare.
I due Tribunali sono stati criticati anche per non aver rispettato, nelle sentenze di condanna emesse,
alcuni principi fondamentali del diritto penale, a cominciare dai principi nullum crimen sine lege e
nulla poena sine lege: i due Tribunali avrebbero retroattivamente applicato le norme e le pene,
punendo condotte individuali che, al momento della loro realizzazione, non erano illecite per il DI.
Indipendentemente da questi fondati rilievi, la maggioranza della dottrina considera comunque
decisivo l’apporto dei due Tribunali per lo sviluppo del DIP, preferendo evidenziare come tali
critiche “nulla tolgono al valore di precedente morale e giuridico dei principi di Norimberga.
59
5. I Tribunali penali internazionali per il Ruanda e la ex-Jugoslavia
Il Tribunale per la ex-Jugoslavia (ICTY) ha competenza a giudicare gli individui (anche se organi
statali) responsabili di gravi violazioni del DIU, commesse dal 1991 in poi sul territorio della exJugoslavia. In particolare, l’ICTY è competente a conoscere e giudicare le gravi violazioni delle
Convenzioni di Ginevra del 1949, le violazioni delle “leggi e consuetudini della guerra”, il crimine
di genocidio e i crimini contro l’umanità.
Il Tribunale per il Ruanda (ICTR) è competente a giudicare gli individui (anche se organi statali)
responsabili di gravi violazioni del DIU commesse (tra il 1° gennaio 1994 ed il 31 dicembre 1994)
sul territorio del Ruanda e sul territorio degli Stati limitrofi. In particola, l’ICTR ha competenza sul
crimine di genocidio, sui crimini contro l’umanità e sulle violazioni dell’art. 3 delle Convenzioni di
Ginevra del 1949 e del secondo Protocollo aggiuntivo del 1977.
Entrambi gli statuti dei Tribunali prevedono l’impossibilità per gli imputati di prevalersi delle
immunità. Entrambe le risoluzioni istitutive dei due Tribunali richiamano il Cap. VII della Carta
dell’ONU, ma si è molto discusso in dottrina sul loro fondamento di legittimità.
Un primo orientamento ritrova il fondamento nella Carta, sebbene vi siano opinioni diverse sulla
specifica norma da richiamare: ora l’art. 40, i Tribunali sarebbero “misure provvisorie” per il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; ora l’art. 41, i Tribunali sarebbero
“misura per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale non implicante l’uso della
forza; ora l’art. 42, i Tribunali sarebbero misura implicante l’uso della forza armata (ipotesi che non
trova riscontro nella realtà); ora, infine, gli artt. 24 e/o 29 della Carta.
Un secondo orientamento rigetta il tentativo di interpretare estensivamente le disposizioni della
Carta o di estendere oltremodo le competenze del SC, concludendo per la sostanziale illegittimità
della creazione dei due tribunali, evidenziando: a) l’impossibilità per un organo politico quale il SC,
privo di judicial powers, di istituire organi sussidiari con tali funzioni20; b) impossibilità di
considerare un tribunale penale internazionale come una semplice “misure non implicanti l’uso
della forza” (art. 41 Carta)21; c) il rappresentare questo modo di procedere del SC un atto di
prevaricazione degli interessi politici di parte e contingenti, in sostanziale violazione di principi
fondamentali dell’ordinamento internazionale come quello della sovranità ed indipendenza politica
dello Stato.
Un terzo orientamento nega che la Carta rappresenti la base giuridica per i tribunali “consiliari” e,
invece, ritrova il fondamento della loro legittimità direttamente nel DI generale. PICONE afferma
che i due Tribunali non rappresentino misure ai sensi del Cap. VII, ma veri e propri strumenti
sanzionatori applicati dalla CI, per il tramite del SC, nei confronti degli individui responsabili di
illeciti erga omnes. Il DI generale diventa parametro giuridico di riferimento per queste sanzioni che
testimoniano la volontà della CI di reagire a crimini così efferati.
Al di là dei molteplici e fondati dubbi sulla legittimità dei TPI, la successiva prassi degli Stati ha
mostrato una diffusa accettazione delle loro attività. Se questa successiva prassi ha fatto salvi gli
effetti delle attività dei due Tribunali, ciò non significa assolutamente che “sia derivata una norma
20
Riguardo a ciò, l’ICTY si è espresso a favore della sua stessa legittimità come strumento a disposizione del SC per
conseguire il fine attribuitogli dalla Carta: non sarebbe questione di delega ad un organo sussidiario una funzione di cui
lo stesso organo principale è sprovvisto. Sarebbe questione, per l’organo principale di perseguire il suo fine essenziale e
di raggiungerlo con qualunque strumento (compresi i tribunali penali internazionali). La dottrina, però, ha correttamente
osservato che, proprio ai sensi del Cap. VII della Carta, il compito del SC è solo quello di adottare “misure di peaceenforcement” e non anche quello di adottare misure che, incidendo sui diritti e sulle prerogative sovreane degli stati si
risolvono in vere e proprie misure di “law-making, law-determining e law-enforcing”, assolutamente non previste.
21
Riguardo ciò, l’ICTY ha ritenuto che l’art 41 della Carta non precluda al SC l’adozione di una misura consistente
nell’istituzione di un tribunale: l’elenco in esso contenuto è meramente esemplificativo, non tassativo.
La dottrina, su ciò, ribadisce che non è possibile superare i limiti funzionali e di legittimità del Cap. VII qualsiasi sia il
contenuto e lo scope delle misure ex art. 41.
60
consuetudinaria, o abbia avuto inizio il suo processo di formazione, in base al quale il SC sarebbe
autorizzato a costituire simili istituzioni sulla base del Cap. VII”. Non è un caso che i successivi TIP
siano stati istituiti non con risoluzione del SC, ma con altri e diversi strumenti giuridici (trattati).
Il sistema dei TIP si fonda sull’obbligo per tutti gli Stati membri dell’ONU di cooperare nella
maniera più ampia al fine di assisterli e coadiuvarli nel perseguire e punire i responsabili dei
crimini.
Sia l’ICTY che l’ICTR esercitano la primazia della “giurisdizione internazionale” sulle
giurisdizioni nazionali, a cominciare da quelle degli Stati di cui le vittime o gli indagati/imputati
hanno la nazionalità o in cui i fatti criminosi sono stati commessi. Il ricorso alla primazia è
dimostrato dalla prassi dei due Tribunali, attesa in quel momento storico-politico l’incapacità (o la
mancanza di volontà) delle giurisdizioni statali direttamente interessate ad investigare e perseguire i
responsabili. Solo negli ultimi anni,vuoi per la ritrovata capacità delle giurisdizioni nazionali di
adempiere a tale compito, vuoi per il desiderio degli Stati di terminare l’impegnativa e costosa
esperienza dei TIP, si è elaborata, su proposta dei giudici dei due Tribunali, accolta dal SC, una
completion strategy: si è fissato un termine finale per il completamento delle attività dei tribunali e
ciò ha così determinato un sempre più frequente rinvio alle corti nazionali delle indagini e dei
processi già istruiti o pendenti di fronte ai due tribunali internazionali.
In questo contesto appare criticabile la c.d. streamlined indictments, introdotta per accelerare le
indagini ed i processi e, quindi, rispettare la completion strategy, e cioè la richiesta del Procuratore
di ridurre i capi di imputazione allo scopo di restringere l’oggetto delle indagini e del processo.
6. La Corte Penale Internazionale
La Corte Penale Internazionale (CPI) fu istituita a Roma nel 1998 tramite adozione del suo
Statuto, entrato in vigore nel 2002 dopo il deposito della 60° strumento di ratifica. La sua sede e la
sede delle sue prigioni è a L’Aja.
La CPI ha competenza penale non sugli Stati ma sugli individui (anche quando organi dello Stato) i
quali rispondono a titolo personale dei crimini di sua competenza. L’individuo non può in nessun
caso invocare l’immunità per evitare l’accusa e, nel caso, la pena della CPI e del suo Stato. Oltre a
ciò, gli Stati membri devono inserire nelle loro legislazioni la norma che nega l’immunità ai propri
organi per i crimini internazionali indicati dallo Statuto, così da poterla applicare nei casi in cui
spetti alla giurisdizione statale procedere.
Il fondamento di legittimità della CPI è subito evidente, trattandosi di un “normale” sistema
convenzionale fondato su un trattato: fatto salvo il caso dell’intervento del SC, gli Stati non parti
allo Statuto non hanno obblighi di cooperazione nei confronti della CPI e dell’attività da questa
eventualmente richiesta.
Il funzionamento e l’efficacia dell’articolata struttura giudiziale si fonda, essenzialmente,
sull’obbligo degli Stati parti al trattato (o di tutti gli Stati membri dell’ONU se l’obbligo deriva da
una risoluzione del SC) di cooperare pienamente alla CPI, non possedendo essa un proprio apparato
coercitivo: dalle notifiche dei mandati di comparizione o di arresto e consegna alla loro stessa
esecuzione, la CPI fa affidamento sulla cooperazione e sulle strutture degli Stati parti. L’attività di
indagine, invece, è svolta in modo indipendente dal Procuratore.
Per quanto riguarda il rapporto tra giurisdizione della CPI e giurisdizioni nazionali, si applica il
principio della complementarietà, in base al quale spetta, in primo luogo e in via esclusiva, allo
Stato parte esercitare la giurisdizione penale sui responsabili dei crimini previsti dallo Statuto. Solo
in un secondo momento, ed eventualmente, è previsto l’intervento sostitutivo della giurisdizione
internazionale. La complementarietà si attiva e si sostituisce la giurisdizione della CPI a quella dello
Stato ogni volta che uno Stato (anche non parte allo Statuto e se la CPI è attivata dal SC) si dimostri
non volenteroso o incapace di investigare, perseguire e punire i crimini dell’individuo.
61
La CPI dichiara inammissibile il passaggio di competenze nel caso:
1) se uno Stato stia già investigando o processando gli stessi fatti a meno che “lo Stato sia non
volenteroso o veramente incapace di portare avanti l’investigazione o l’accusa”;
2) se uno Stato, all’esito delle indagini, ha archiviato il caso a meno che “la decisione sia
risultata dalla non volontà o incapacità dello Stato semplicemente a proseguire”.
È considerato non volenteroso lo Stato i cui procedimenti e le cui decisioni manifestano l’intento
“di proteggere la persona interessata dalla responsabilità penale per i crimini di competenza della
CPI”. Anche il ritardo ingiustificato dello Stato nel procedere può essere considerato prova di non
volenterosità, assieme anche al fatto che i procedimento non sia (o sia stato) condotto
“indipendentemente e imparzialmente” o sia stato gestito in un modo incompatibile con un’effettiva
volontà di perseguire e punire i crimini.
Indica l’incapacità dello Stato ad esercitare la sua giurisdizione la sua incapacità di “ottenere la
presenza dell’imputato o le prove o le testimonianze necessarie o, altrimenti, di condurre il
procedimento”, a causa del “totale o sostanziale collasso, oppure indisponibilità, del suo sistema
giudiziario”.
I crimini di competenza della CPI sono elencati dall’art. 5 dello Statuto:
- crimine di genocidio: il genocidio è definito come la commissione di certi atti (elemento
oggettivo) con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico,
razziale o religioso (elemento soggettivo); il crimine si costituisce in presenza di entrambi
gli elementi.
- crimini di contro l’umanità: essi sono commessi consapevolmente e in modo esteso o
sistematico in assenza di un conflitto armato o, in caso di belligeranza, contro persone che
non partecipano direttamente alle ostilità. Elementi caratterizzanti di questi crimini sono, ad
esempio, gli attacchi diretti contro le popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del
disegno politico diretto a realizzare l’attacco.
- crimini di guerra: essi sono riconducibili al DIU e sono caratterizzati per “lo stretto rapporto
che intercorre tra il fatto criminoso, il momento ed il luogo in cui viene commesso”. Per
crimini di guerra si intendono innanzitutto “le gravi violazioni della Convenzione di Ginevra
del 1949, ovvero gli atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle
Convenzioni; in secondo luogo rientrano nella categoria le altre “gravi violazioni del diritto
e delle consuetudini applicabili nei conflitti armati internazionali, nel quadro stabilito dal
DI”. Per quanto riguarda i conflitti armati non internazionali, costituiscono crimini di guerra
le gravi violazioni alle Convenzioni di Ginevra commesse “contro persone che non
partecipano direttamente alle ostilità, inclusi i membri delle forze armate che hanno deposto
le armi e quelli usciti dai combattimenti per malattia, lesioni, detenzione o altre cause”, oltre
che tutte le “altre gravi violazioni delle leggi e degli usi di DI applicabili ai conflitti armati
di carattere non internazionale”.
- crimine di aggressione: essi non sono ancora perseguibili dalla CPI.
Le precondizioni per l’esercizio dell’azione penali da parte della CPI sono indicate dall’art.12 dello
Statuto, per cui essa è competente:
- quando il crimine è commesso da un cittadino di uno Stato parte;
- quando il crimine è commesso sul territorio di uno Stato parte.
Queste due precondizioni sono alternative e sono necessarie solo nel caso in cui la CPI si attivi
proprio motu o su richiesta di uno Stato. Nel caso in cui, infatti, l’attivazione sia sollecitata da una
risoluzione del SC, il crimine può essere investigato, perseguito e punito dalla CPI da chiunque e
dovunque sia stato commesso.
Esistono tre modi di attivazione della competenza della CPI, i c.d. trigger mechanisms, previsti
dall’art. 13:
62
1) uno Stato parte può segnalare al Procuratore “una situazione nella quale uno o più dei
crimini di competenza del CPI appaiano essere stati commessi” anche nel proprio territorio
(trigger utilizzato in 3 dei 4 casi attualmente all’esame della CPI22).
2) Il SC segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o più di tali crimini appaiono
essere stati commessi (trigger utilizzato in 1 dei 4 casi attualmente all’esame della CPI23).
3) La CPI può attivarsi motu proprio su iniziativa autonoma del Procuratore il quale apre
un’indagine “sulla base delle informazioni relative ai crimini di competenza della CPI. Le
pertinenti informazioni, c.d. notitia criminis, possono essere acquisite direttamente dal
Procuratore o essergli fornite tramite una comunicazione da ONG, privati cittadini, Stati, OI,
organi dell’ONU, etc. (trigger mai utilizzato). In questo caso, il Procuratore, dopo aver
concluso che vi siano delle ragionevoli prove per procedere con l’investigazione, presenta
alla Pre-Trial Chamber la richiesta di autorizzazione ad iniziare le indagini; se, al contrario,
il Procuratore ritiene ingiustificate le informazioni pervenutegli, ne informa coloro che le
hanno fornite.
Ai sensi dell’art. 16, il SC ha la facoltà di sospendere (o impedire l’inizio) dell’attività investigativa
o processuale della CPI su una questione specifica per 12 mesi; essa è avanzata con risoluzione ex
Cap.VII della Carta e può essere rinnovata di anno in anno.
La legge applicabile dalla CPI è indicata dall’art. 21, mentre i principi penalistici che ne guidano
l’attività sono indicati nella terza parte dello Statuto (artt. 22-33). Tra questi troviamo:
- nullum crimen sine lege: esso sancisce che, da una parte, nessuna persona può essere
accusata di un fatto che al momento del suo verificarsi non costituisce un crimine oggetto di
giurisdizione della CPI; dall’altra, che la definizione di un crimine sarà interpretata
restrittivamente e non sarà applicata per analogia (in caso di ambiguità interpretazione a
favore dell’indagato, accusato o condannato).
- nulla poena sine lege: esso sancisce che una persona condannata dalla CPI può essere
punita solo in base alle disposizioni dello Statuto;
- irretroattività ratione personae dello Statuto: esso dispone che nessuna persona è
penalmente responsabile in forza dello Statuto per un comportamento precedente all’entrata
in vigore dello stesso. Nel caso in cui il diritto applicabile ad un caso sia modificato prima
della sentenza definitiva, alla persona oggetti d’inchiesta verrà applicato il diritto più
favorevole.
I crimini di competenza della CPI sono imprescrittibili e la pena applicabile è quella detentiva fino
ad un massimo di 30 anni o l’ergastolo.
7. Altri tribunali a carattere internazionale: la SCLS, lo STL, le ECCC, le Balkan War
Crimes Court
Seguendo una diffusa schematizzazione, ci si riferisce ai tribunali di Norimberga e Tokyo come ai
“tribunali di prima generazione” (cioè quelli dei vincitori sui vinti); ai tribunali ICTY e ICTR
istituiti con risoluzione del SC come ai “tribunali di seconda generazione” (cioè quelli di origine
ed impronta internazionale); ai tribunali di più recente istituzione come ai “tribunali di terza
generazione” (cioè quelli che presentano elementi di carattere internazionalistico e di carattere
interno).
Questi ultimi, i c.d. tribunali ibridi, presentano il tratto comune di “internazionalizzare” la funzione
giurisdizionale penale dello Stato allo scopo di meglio garantirla ed attuarla, anche dal punto di
vista del rispetto di certi standards (sostanziali e processuali) per gli imputati e per le vittime.
22
Questi 3 casi sono: Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Repubblica Centro-Africana. La richiesta è sempre
giunta dagli stati nei cui territori si erano verificati i crimini segnalati.
23
L’unico caso è quello del Darfur in Sudan, dove in caso è stato segnalato dal SC.
63
Nessuno di essi, però, è da un punto di vista propriamente giuridico un “tribunale internazionale”,
cioè un organo della CI avente funzione giurisdizionale. Con il termine internazionale ci si riferisce
alla presenza, nella struttura, nell’azione o nella composizione del tribunale, di un elemento di
estraneità rispetto all’ordinamento statale di riferimento, più o meno riconducibile al contesto
internazionale. (Per gli esempi delle corti vd. pagg. 426-431.)
64
CAPITOLO IX – LE NAZIONI UNITE
1. Considerazioni introduttive
Prima di entrare nello specifico della struttura dell’ONU, è importante portare l’attenzione sul fatto
che l’ordinamento internazionale non coincida con il c.d. ordinamento dell’ONU.
Quando riferito ad una OI, il termine ordinamento giuridico è ammissibile solo se con esso si vuole
semplicemente indicare un sistema di norme che regola la vita dell’ente-organizzazione. Impiegato,
altrimenti, in senso proprio, dovrebbe dimostrarsi il suo essere manifestazione normativa di una
societas dell’OI.
Sono, poi, anche da respingere tutte quelle ipotesi che vedrebbero la coincidenza del sistema
onusiano con quello internazionale per il solo fatto che tutti gli Stati sono membri dell’ONU. Con
tale affermazione si riconosce uno sviluppo organico della CI, organizzata nell’ambito di un unico
corpo sociale con organi, istituzioni e competenze che di quel corpo unitario ne sono diretta
espressione. A ben vedere, si avrebbe al posto dell’ONU, lo Stato Mondiale!
La pretesa coincidenza, dunque, tra sistema ONU e ordinamento internazionale è, già di per sé,
intrinsecamente contraddittoria in punto di teoria perché se veramente si realizzasse non si avrebbe
più un’OI su cui ragionare!
L’interpretazione realistica del diritto e della politica internazionale descrive giuridicamente
l’ONU come un fenomeno giuridico ad appartenenza volontaria che “organizza” politicamente gli
Stati non perché le relazioni giuridiche internazionali si siano strutturalmente e radicalmente
trasformate, ma semplicemente perché, in questo momento storico, la volontà degli Stati è quella di
organizzarsi e cooperare tra loro a diversi livelli per raggiungere obiettivi comuni mediante
un’articolata e complessa struttura burocratico-normativa di tipo permanente.
2. Dalla Società delle Nazioni all’Organizzazione delle Nazioni Unite
La Società delle Nazioni (SdN) fu il primo tentativo politico di creare un foro di dialogo e
cooperazione intergovernativa per evitare o limitare il ricorso alla guerra e alla forza nelle RI, anche
creando un sistema giuridicamente vincolante per garantire la pacifica convivenza degli Stati.
La SdN condivide con l’ONU la struttura tripartita: un’Assemblea plenaria, un Consiglio a
partecipazione ristretta e privilegiata, un Segretariato.
Per il resto, è difficile fare altri paragoni. L’ampiezza ed il numero delle funzioni dell’ONU non
sono comparabili a quelle della SdN che nasceva con il fine essenziale, quasi esclusivo, di garantire
relazioni pacifiche tra i suoi membri, mentre l’ONU in aggiunta a questo fine ne persegue
comunque molti altri.
Sebbene ancora formalmente in vita durante la Seconda Guerra Mondiale, la SdN non svolse alcun
ruolo significativo, indebolita politicamente, sin dal 1939, per l’uscita di alcuni Stati e
oggettivamente travolta dalla violenza bellica poi scatenatasi. Ne è riprova il fatto che, proprio
durante la guerra, gli Alleati (USA e UK) già pianificassero il futuro ordine politico, commerciale e
monetario internazionale che prescindesse dall’esperienza fallita della SdN.
Questo nuovo ordine si sarebbe fondato su tre OI:
- l’ONU, 1945, a vocazione politica per il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale;
- l’OIC (mai nata), sostituita con l’OMC istituita nel 1994, a vocazione commerciale chiamata
ad amministrare il commercio internazionale secondo dettami economici liberisti;
- BM e FMI, 1944, organizzazioni “economiche” per la regolamentazione della cooperazione
internazionale monetaria e finanziaria.
65
Il percorso di nascita dell’ONU è costellato di vertici e dichiarazioni, tenutisi sin dal 1941, tra le
Potenze Alleate, che aggiunsero man mano dei tasselli al grande disegno dell’ONU:
- 1° gennaio 1942, Dichiarazione di Washington, c.d. Dichiarazione delle Nazioni Unite,
sottoscritta dai 26 Stati alleati, le c.d. Nazioni Unite, accettando e facendo propri i principi
della Carta Atlantica del 1941;
- 30 ottobre 1943, Dichiarazione di Mosca, c.d. Dichiarazione sulla sicurezza collettiva,
sottoscritta da USA, URSS, UK e Cina, prevedendo la necessità di creazione di un’OI a
vocazione universale e con l’obiettivo di garantire la pace e la sicurezza internazionale;
- agosto-ottobre 1944, Conferenza di Dumbarton Oaks, in cui si elaborò il progetti di statuto
OI a vocazione universale;
- febbraio 1945, Conferenza di Yalta, dove Stalin, Roosevelt e Chuchill discussero di alcuni
aspetti più specifici e delicati della futura OI. Con la c.d. Dichiarazione di Yalta, le tre
potenze si accordarono sul meccanismo di voto del SC: per le “questioni non procedurali”
bastava la maggioranza comprendente il voto dei 5 membri permanenti (auto-attribuzione
diritto di veto alle 5 potenze prossime vincitrici della guerra);
- 25 aprile 1945, Conferenza di San Francisco, aperta solo a chi avesse dichiarato guerra alle
Potenze dell’Asse prima del 1945 e avesse firmato dal Dichiarazione delle Nazioni Unite del
1942. La Conferenza si concluse il 26 giugno 1945 con l’adozione per acclamazione della
Carta delle Nazioni Unite e la firma dei 50 Stati presenti, i c.d. Stati firmatari originari (che,
però, sono 51, includendovi anche la Polonia). La Carta entrò in vigore il 24 ottobre 1945
con il deposito del 29° strumento di ratifica.
3. Acquisto e perdita dello status di membro dell’ONU. Emendamento e revisione della Carta
Per tutti gli altri Stati non presenti a San Francisco, la procedura di ammissione è stabilita dall’art.
4: essa implica la richiesta dello Stato candidato ed un’accettazione da parte dell’ONU, previa
verifica dei requisiti richiesti. In realtà è il SC che prende in esame lo Stato candidato e poi lo
propone con propria raccomandazione all’AG, che ha quindi la possibilità di deliberare. In caso
contrario, l’AG non può deliberare e può solo invitare il SC a riconsiderare favorevolmente la
richiesta dello Stato candidato.
Una volta membro lo Stato può essere sospeso (in tutto o in parte) dall’esercizio dei diritti, espulso
o può recedere.
La sospensione dalla qualità di membro significa l’impossibilità temporanea di esercitare i diritti
connessi allo status ma non la perdita della loro titolarità. La sospensione può essere:
- totale: costituisce una sanzione aggiuntiva a quelle eventualmente già irrogate ai sensi del
Cap.VII della Carta e viene comminata, su proposta del SC, dall’AG a maggioranza dei 2/3
dei membri presenti e votanti (le astensioni non sono computate nel quorum);
- parziale: è prevista per lo Stato “che sia in arretrato nel pagamento dei suoi contributi
finanziari all’Organizzazione” per i due anni precedenti e comporta solamente
l’impossibilità per lo Stato di votare in seno all’AG.
L’espulsione, cioè la perdita dello status di membro24, viene comminata, sempre dall’AG e sempre
su proposta del SC (voto unanime), in caso di persistente violazione dei principi della Carta.
Il recesso non è espressamente previsto dalla Carta ma per le considerazioni già svolte sui trattati e
sui c.d. trattati a perpetuité è ovviamente ipotizzabile. Si ritiene in dottrina che il recesso possa
avvenire legittimamente solo in circostanze eccezionali e/o in caso di mutamento fondamentale
delle circostanze (clausola rebus sic stantibus): fuori da queste ipotesi uno Stato non potrebbe
24
Ad oggi, nessun membro è mai stato espulso.
66
legittimamente recedere dall’ONU25. Appare comunque difficile immaginare come, in concreto, la
sanzione dell’inefficacia del recesso potrebbe applicarsi ad uno Stato fuoriuscito.
Lo status di osservatore permanente viene concesso dall’AG a Stati, OI e altri enti e, pur non
comportando il diritto di voto in AG, consente comunque di partecipare attivamente ai lavori
dell’organo plenario alle cui riunioni l’osservatore partecipa e prende la parola, alla cui
documentazione accede, etc.
La Carta delle Nazioni Unite stabilisce la prevalenza degli obblighi in essa sanciti su qualunque
altro obbligo internazionale assunto dallo Stato membro. Tale prevalenza si apprezza, in particolare,
con riguardo alle decisioni del SC emesse ai sensi del Cap.VII. tale disposizione si applica anche
agli obblighi previsti dagli atti vincolanti degli organi principali. Gli obblighi internazionali
incompatibili con quelli della Carta sono generalmente considerati inapplicabili e non validi.
Per quanto riguarda le modificazioni della Carta, si distinguono le ipotesi di emendamento e di
revisione:
La procedura di emendamento prevede la ratifica della risoluzione che delibera la modifica da
almeno 2/3 di tutti i membri dell’AG, compresi i membri permanenti del SC, affinché
l’emendamento entri in vigore per tutti gli Stati membri (anche i nolenti).
La procedura di revisione richiede la convocazione (con doppia votazione: dei 2/3 di tutti i membri
e di 9 membri qualsiasi del SC) di una Conferenza generale dei Membri delle Nazioni Unite. Se,
all’esito della conferenza, vengono decise e votate modifiche alla Carta (a maggioranza dei 2/3),
queste entrano in vigore per tutti gli Stati membri, una volta ratificate da 2/3 degli Stati membri,
compresi i membri permanenti del SC.
A tal proposito si notino due aspetti: a) la richiesta della maggioranza in tema di modifiche ai
trattati multilaterali a larga partecipazione, e non l’unanimità; b) l’essere qualunque modifica
condizionata al volere dei membri permanenti.
4. Gli organi principali: l’Assemblea Generale
Sono organi principali dell’ONU l’Assemblea Generale (AG), il Consiglio di Sicurezza (SC), la
Corte Internazionale di Giustizia (CIG), il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC), il
Segretariato (SG) e il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria (CAF); sono principali perché creati
e disciplinati nelle loro linee essenziali direttamente dalla Carta.
Sono organi sussidiari, invece, tutti quelli creati dagli organi principali con un loro atto; la
creazione dell’organo sussidiario deve essere necessaria e nei limiti delle competenze attribuite
dalla Carta all’organo principale che istituisce il sussidiario.
L’Assemblea Generale è l’unico organo plenario dell’ONU, composto di Stati (gli individui che
partecipano ai lavori assembleari, i delegati, sono organi dello Stato), che lavora per sessioni
annuali ordinarie e speciali. Essendo organo collettivo, l’attività è imputata a tutti gli Stati membri;
decidendo in modo collegiale, poi, l’AG esprime una volontà unitaria.
La maggior parte dei poteri dell’AG sono disciplinati dagli artt. 10-19; un potere di carattere
generale è quello che da all’AG la possibilità di “discutere qualsiasi questione od argomento che
rientri nei fini della Carta o che abbia riferimento ai poteri e alle funzioni degli organi previsti dalla
25
Esiste un unico caso verificatosi di recesso, quello dell’Indonesia dal 1965 al 1966 per protesta contro l’elezione della
Malesia a membro non permanente del SC. In questo caso, il requisito delle circostanze eccezionali non rilevò dato che
il recesso fu dovuto a motivi politici di carattere non certamente eccezionale. Del resto, l’Indonesia non invocò
circostanze eccezionali a fondamento della sua decisione; l’ONU, dal canto suo, accettò di fatto il recesso tanto che
cancellò l’Indonesia dalla lista dei membri. Ciò, secondo CONFORTI, “depone in favore della tesi della piena ed
incondizionata facoltà del singolo membro di ritirarsi dalle Nazioni Unite”.
67
Carta”. Al potere di discutere si collega il potere di fare raccomandazioni sia agli Stati membri che
al SC “su qualsiasi di tali questioni od argomenti”.
Il potere di fare raccomandazioni è limitato dall’art. 12, che priva l’AG di tale competenza “durante
l’esercizio da parte del SC delle funzioni assegnategli” dalla Carta ai sensi del Cap. VI e VII. Sulla
base della prassi questo limite non va interpretato estensivamente: la mera iscrizione all’ordine del
giorno del SC di una situazione o di una questione ai sensi dei Capp. VI-VII non impedisce all’AG
di fare raccomandazioni. Il limite “sussiste solo nel momento e per tutto il tempo in cui siano
effettivamente in corso il dibattito, o l’azione conciliativa o coercitiva del SC in merito alla
questione”.
L’AG ha anche la specifica competenza di “raccomandare misure per il regolamento pacifico di
qualsiasi situazione che, indipendentemente dalla sua origine, essa ritenga suscettibile di
pregiudicare il benessere generale o le relazioni amichevoli tra le nazioni”, la c.d. funzione
conciliativa, che esercita pure il SC.
Altro specifico potere dell’AG è quello di intervenire nelle questioni previste dal Cap. VII
(esaminandole, discutendole e rivolgendo raccomandazioni agli Stati), ma con un vero e proprio
obbligo di deferimento della questione al SC nel caso in cui la situazione minacciosa per la pace e la
sicurezza “renda necessaria un’azione” del SC ai sensi del Cap. VII.
In sostanza, l’AG costituisce un foro politico di dialogo, discussione e confronto tra gli Stati con
limitati e condizionati poteri effettivi.
Potere di notevole rilevanza dell’AG è quello di “esaminare e approvare” il bilancio dell’ONU.
Nell’espletamento di tale funzione l’AG emana decisioni vincolanti per tutti gli Stati: dopo aver
determinato la ripartizione tra gli Stati membri delle spese dell’Organizzazione (cioè le singole
quote-Stati), l’AG adotta con decisione (o risoluzione) il relativo atto. Il bilancio è biennale e la
ripartizione è in funzione della capacità contributiva dello Stato. Nel caso in cui uno Stato sia in
arretrato almeno di due anni con il pagamento, l’AG lo può sospendere dall’esercizio del diritto di
voto.
Riguardo i limiti di autorizzazione delle raccomandazioni dell’AG, si discute ancora molto in
dottrina se il loro effetto di liceità permetta allo Stato di derogare addirittura obblighi internazionali
già assunti o se, invece, produca effetti giuridici di minore portata: a favore della deroga
CONFORTI; contrario MARCHISIO, per il quale estendere l’applicazione [dell’art. 103] al
contenuto delle raccomandazioni condurrebbe a negare la distinzione tra atti vincolanti e atti non
vincolanti degli organi ONU.
5. Segue: il Consiglio di Sicurezza
Il Consiglio di Sicurezza è un organo a composizione ristretta e privilegiata, il cui campo d’azione è
delimitato dai Capp. VI-VII: il regolamento pacifico di controversie e situazioni e l’azione (anche
coercitiva se necessario) a tutela della pace e della sicurezza internazionale quando minacciate o
violate. Inoltre si ricordi che ai sensi dell’art. 24:
a) il SC ha la responsabilità primaria nel mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale;
b) tale responsabilità gli è stata “conferita”26 dagli altri Stati membri in nome dei quali il SC
agisce;
c) gli Stati membri accettano ed eseguono le decisioni del SC adottate legittimamente.
L’azione del SC deve avvenire in accordo con i fini e i principi delle Nazioni Unite. In quest’ottica,
anche il privilegio auto-attribuitosi dai membri permanenti si poteva giustificare politicamente
(come “contraltare” per l’assunzione della gravosa responsabilità di mantenere la pace e la
26
In realtà sappiamo che, più che un conferimento, fu un’auto-attribuzione della competenza imposta dai 5 membri
permanenti a tutti gli altri.
68
sicurezza internazionale) e giuridicamente (come un dovere di voto, conseguente alla gravosa
responsabilità). Purtroppo, dal 1945 ad oggi, il diritto di veto è stato quasi sempre usato a tutela
dell’interesse individuale del singolo membro permanente e ben poco in funzione dell’interesse
collettivo alla pace e alla sicurezza internazionale; e non poche volte il SC è rimasto bloccato,
impedito dal veto di uno o più Stati.
La prassi, ormai consolidata, del SC ha interpretato l’art. 27, par.3, nel senso di attribuire al membro
permanente la facoltà di astenersi dal voto e non, invece, l’obbligo di votare. L’astensione del
membro permanente non impedisce l’adozione della risoluzione del SC. In alcuni casi si è registrata
l’assenza del membro permanente dalla riunioni del SC.
Uno Stato non membro del SC “può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi
questione sottoposta al SC, ogniqualvolta quest’ultimo ritenga che gli interessi di tale membro siano
particolarmente coinvolti” (obbligo di integrazione). Uno Stato non membro del SC, o anche non
membro dell’ONU, se parte a una controversia all’esame del SC, “sarà invitato a partecipare senza
diritto di voto, alla discussione relativa alla controversia” (facoltà di integrazione).
Una maggiore apertura del SC agli Stati non membri e agli individui che possano fornirgli
informazione necessarie per decidere o valutare lo sviluppo di situazioni al suo esame, è uno dei
temi centrali del tentativo di riforma dei meccanismi di funzionamento dell’organo.
Analizziamo ora una serie di proposte di riforma in senso limitativo o abolitivo del veto, osteggiate
non solo dai membri permanenti, ma anche da chi mira a conseguire un seggio permanente
“munito” di veto:
- una prima proposta è quella di motivare il veto da parte del membro permanente, il c.d.
indicative voting. In altre parole, si richiede un’illustrazione pubblica della posizione
assunta, senza conseguenza giuridiche comunque sul voto finale. Pur non impendendo, in
punto di diritto, l’uso del veto, tale proposta renderebbe il suo utilizzo più complesso in
punto di fatto, “costringendo” politicamente i membri permanenti ad un uso più “trasparente
e democratico” di tale potere.
- una seconda proposta consiste nel limitare il veto sfruttando la distinzione tra questioni
procedurale e altre questioni: tale distinzione è importante perché nel caso delle questioni
procedurali le decisioni vengono prese con il voto di 9 membri, mentre in tutti gli altri casi
tra i nove voti necessari per l’adozione della risoluzione ci devono essere anche tutti e 5 i
voti dei membri permanenti. L’uso del veto, quindi è limitato alle questioni diverse da quelle
meramente procedurali. A questa situazione si propone di rendere vincolante per il SC
l’elenco delle questioni da considerare procedurali. Una volta aggiornato e ampliato
(considerando procedurali anche le decisioni prese ai sensi del Cap. VI e dell’art.40), e reso
vincolante l’elenco avrebbe un’oggettiva diminuzione dell’uso del veto.
Il SC è composto, dal 1965, da 15 membri, di cui 5 permanenti e 10 non permanenti, in carica per
due anni senza possibilità di immediata rielezione. Spetta all’AG eleggere, con voto segreto a
maggioranza dei 2/3 dei presenti e votanti, i membri non permanenti (ogni anno eletti 5 Stati in
modo da garantire un ricambio progressivo) tenendo conto in primo luogo del contributo dello Stato
al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale27 e, inoltre, del criterio della equa
distribuzione geografica.
Con riguardo a quest’ultimo criterio, la risoluzione n° 1991 del 1963, oltre a prevedere l’aumento
dei seggi non permanenti da 6 a 10, stabilì che i seggi sarebbero stati divisi tra i gruppi regionali
esistenti: Africa, 3 seggi; Asia, 2 seggio; Latino America e Caraibi, 2 seggi; Stati “occidentali”, 2
seggi; Europa orientale, 1 seggio.
27
“Contributo” inteso in senso economico-militare nel senso di eleggere gli stati che più finanziano il bilancio ordinario
dell’ONU e più partecipano, con uomini e finanze, alle operazioni di PK.
69
Tutti gli Stati presenti e votanti in AG votano per tutti i seggi secondo una procedura che favorisce
il ballottaggio tra i due candidati di ciascun gruppo che ottengono al primo round di votazione il
maggior numero di voti.
Analizziamo ora, il dibattito sulla riforma della composizione del SC è riconducibile a tre
posizioni:
- la c.d. modest expansion degli USA, tiepidamente favorevoli ad un limitato aumento dei
seggi, non più di 2-3 seggi permanenti destinati a Giappone e Germania;
- la proposta del gruppo Uniting for Consensus (UFC), in cui vi era l’Italia, che prevedeva un
SC a 25 membri con 10 nuovi seggi non permanenti biennali, con possibilità, però, di
immediata rielezione, c.d. longer-term seats28;
- la proposta del gruppo G4 (Giappone, Germani, India, Brasile) che, insieme all’Unione
Africana (UA), chiedevano di aggiungere in SC anche sei nuovi seggi permanenti.
Purtroppo la diversità di vedute tra G4 e UA sul diritto di veto ai nuovi membri permanenti
(conditio sine qua non della riforma per gli africani) condusse alla rottura dell’alleanza (che aveva i
numeri per raggiungere la soglia dei 2/3) con il risultato finale di avere, nel luglio 2005, tre
differenti draft resolutions di riforma, tutte prive del sostegno necessario a raggiungere i quorum di
2/3: quindi esse non furono mai votate.
In conclusione, resta da evidenziare come anche il SC abbia il potere di istituire organi sussidiari,
in particolare ne ha fatto un notevole ricorso negli ultimi anni (come nel caso dei TPI), suscitando
accesi dibattiti in dottrina e tra gli Stati.
6. Segue: il Segretariato, l’ECOSOC e gli Istituti Specializzati
Il Segretariato svolge e garantisce l’azione amministrativa dell’ONU. A capo del Segretariato sta il
Segretario Generale (SG) che nella sua qualità di “più alto funzionario amministrativo
dell’Organizzazione” svolge sia funzioni amministrative (art. 97) che funzioni politico-diplomatiche
(art. 98). Il SG è nominato dall’AG su proposta del SC. La Carta non dispone nulla circa la durata
del suo mandato, né circa la rielezione: la prassi del SC e dell’AG ha fatto sì che la rielezione sia
possibile e che la durata del mandato sia tendenzialmente di 5 anni.
Il SG nomina il personale dell’Organizzazione, a lui sottoposto gerarchicamente e soggetto al suo
potere disciplinare. Il SG partecipa in quanto tale alle riunioni dell’AG, del SC, dell’ECOSOC, del
CAF ed esplica altresì quelle altre funzioni che gli siano affidate da tali organi. Ciò significa che ha
competenza nella preparazione dei lavori e nell’attuazione delle decisioni degli altri organi
onusiani. Egli, anche se non esplicitato dalla Carta, rappresenta l’ONU nelle relazioni esterne,
anche negoziando e concludendo per essa gli accordi con gli Stati o le altre OI.
Qualsiasi trattato stipulato da uno Stato membro deve essere registrato presso il Segretariato, che
curerà di pubblicarlo nella United Nations Treaty Series; in caso di mancata registrazione, il
trattato non potrà essere invocato di fronte agli organi dell’ONU.
Per quanto riguarda le funzioni politiche del SG, grazie alla genericità della previsione dell’art. 98 il
SG può ricevere deleghe molto ampie e ha sviluppato un’articolata capacità politico-diplomatica di
intervento e mediazione, soprattutto riguardo il regolamento di controversie e situazioni suscettibili
di minacciare la pace e la sicurezza internazionale.
Riguardo le missioni di peace-keeping, spetta al SG determinare la composizione della forza che
effettuerà la missione e negoziare con gli Stati membri per far sì che questi mettano a disposizione
dell’ONU i contingenti nazionali necessari. Altresì importante è il suo ruolo di dialogo e
mediazione con lo Stato dove avverrà la missione.
28
Andò invece persa l’idea italiana dei membri c.d. semi-permanenti, destinati ad occupare il seggio per un periodo più
lungo dell’attuale biennio.
70
Il SG ha, poi, la possibilità di “richiamare l’attenzione del SG su qualunque questione che, a suo
avviso, possa minacciare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale”: funzione
questa di carattere politico in cui la discrezionalità e il campo d’azione è particolarmente ampio.
Strumento particolarmente usato a tal scopo dal SG sono le missioni d’inchiesta, consistenti
nell’invio di gruppi di osservatori, commissioni di esperti, suoi inviati speciali o suoi rappresentanti
speciali nei luoghi dove si stanno sviluppando (o sono in corso) situazioni di crisi allo scopo di
redigere rapporti conoscitivi, instaurare il dialogo con le parti implicate, etc.
Il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) ha il compito di “compiere o promuovere studi o
relazioni su questioni internazionali economiche e sociali, culturali, educative, sanitarie e simili”.
L’ECOSOC realizza, nelle materie di sua competenza, i vasti obiettivi dell’ONU in materia di
cooperazione internazionale. Ciò spiega perché tali fini siano perseguiti sotto la direzione dell’AG,
organo incaricato del “compito di adempiere le funzioni” di cooperazione internazionale economica
e sociale.
L’ampia competenza ratione materiae dell’ECOSOC si concretizza nella possibilità di indirizzare
raccomandazioni all’AG, agli Stati membri e agli Istituti Specializzati interessati; al SC può solo
fornire informazioni e coadiuvarlo, se richiesto.
Oltre a ciò, questo organo svolge un’importante funzione di raccordo tra ONU e Istituti
Specializzati che gravitano nell’orbita dell’Organizzazione.
Gli Istituti Specializzati (IS), c.d. sistema delle Nazioni Unite, sono normali OI che stipulano, dopo
la loro istituzione, un accordo con l’ONU (accordo di collegamento) che, conferendo loro la
qualifica di “Istituto Specializzato delle Nazioni Unite”, crea un rapporto permanente ed articolato
di reciproca cooperazione che favorisce il raggiungimento sia del fine tecnico-specifico del singolo
IS, sia del fine generale dell’ONU di sviluppare il progresso in ogni campo attraverso il dialogo e la
cooperazione pacifica tra gli Stati membri.
È affidato dall’ONU all’ECOSOC:
a) il compito di “concludere accordi con qualsiasi istituto di quelli indicati all’art.57 per
definire le condizione in base alle quali l’Istituto considerato sarà collegato alla Nazioni
Unite;
b) il compito di “coordinare le attività degli IS mediante consultazioni con tali IS e
raccomandazioni ad essi come mediante raccomandazioni all’AG ed ai membri dell’ONU;
c) il compito di “ricevere rapporti regolari sulle misure prese per attuare le sue
raccomandazioni e le raccomandazioni fatte all’AG su questioni che rientrino nella sua
competenza.
Sebbene il rapporto di collegamento tra ONU e IS si caratterizzi per il potere di coordinamento e
indirizzo che, nei confronti dei secondi, spetta all’Organizzazione, gli IS restano comunque
autonomi. Il loro impegno a prendere in debita considerazione le raccomandazioni provenienti dagli
organi ONU, se disatteso in maniera grave e persistente, potrebbe incidere sulla prosecuzione del
rapporto instauratosi con la stipulazione dell’accordo di collegamento.
71
CAPITOLO X – LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
GENERALE E CONVENZIONALE
1. Considerazioni introduttive
Analizziamo preliminarmente le principali correnti del pensiero filosofico, politico e giuridico
riguardo al settore dei diritti umani (DU):
- giusnaturalismo: i diritti umani appartengono allo ius naturale e ritrovano il loro
fondamento di obbligatorietà nella natura stessa o nella ragione (recta ratio) dell’uomo
oppure in valori assiomatici di carattere trascendentale (erroneamente si ritengono i diritti
umani da sempre esistenti);
- positivismo: i diritti umani esistenti e vincolanti sono quelli che un ordinamento giuridico
riconosce come tali mediante la loro positivizzazione, ovvero versandoli in testi giuridici
vincolanti (si scade nel formalismo giuridico);
- realismo: i diritti umani tutelano quei valori e quei comportamenti relativi alla persona
umana che, in un determinato momento storico-politico, la CI sente doveroso riconosce e
proteggere con lo strumento del comando e della garanzia giuridica (l’obbligatorietà si
desume dalla prassi internazionale).
Le norme di sui DU fissano diritti ed obblighi esclusivamente tra i soggetti internazionali, unici
termini del rapporto giuridico sotteso alla norma. L’individuo è sempre e solo l’oggetto, il
destinatario materiale della tutela giuridica che, a suo vantaggio o a sanzione di un suo
comportamento, si instaura e vige tra i soggetti internazionali.
Dato conto della storicità dei DU, a livello internazionale i primi e più significativi dati normativi si
ritrovano nell’ambito del sistema dell’ONU.
2. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948
La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo fu adottata dall’AG con risoluzione nel 1948.
Essa è contenuta in un documento non vincolante ed ha un contenuto ampio ed onnicomprensivo.
Essa ha rappresentato il punto di riferimento fondamentale per tutti i successivi testi e nozioni in
materia di DU. La gamma dei diritti in essa enunciati è ampia: dai diritti basilari a quelli
processuali; dalle libertà garantite in tutte le Costituzioni ai diritti economici, sociali e culturali.
Se non si può ritenere, da un punto di vista giuridico, che nel 1948 la Dichiarazione fosse
giuridicamente vincolante, è vero che, però, l’impegno politico e morale solennemente assunto
dagli Stati nella Dichiarazione ha messo in moto un meccanismo virtuoso che, progressivamente,
grazie alla prassi, ha fatto sì che numerose di quelle enunciazioni politiche abbiano acquisito un
valore giuridico, in taluni casi anche cogente. Difatti, la maggior parte delle norme in essa contenute
sono ormai consuetudinarie con la sola particolarità di presentare, in taluni casi, un contenuto
ampio, se non quando generico.
3. La protezione dei diritti umani nel sistema dell’ONU: i Patti del 1966
Due sono i momenti significati dell’attività dell’ONU come foro di promozione e tutela dei DU:
- i Patti sui diritti umani del 1966: comprendono il “Patto internazionale sui diritti civili e
politici” e il “Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali”. Pur essendo
entrambi articolati su un’ampia elencazione di diritti riconosciuti e garantiti, presentano
un’intrinseca diversità dei diritti oggetto di tutela: mentre la maggior parte dei diritti civili e
politici si traducono in un obbligo di non ingerenza da parte dello Stato, che può essere
agevolmente definito e che può trovare applicazione immediata, non così è per i diritti
economici, sociali e culturali che richiedono un’esplicita attività da parte degli Stati e la loro
72
-
applicazione rende necessaria una progressività subordinata e condizionata dalla situazione
economica e da altri fattori propri ad ogni Stato.
la Commissione per i diritti umani, oggi sostituita dal Consiglio per i diritti umani:
Il “Patto internazionale sui diritti civili e politici” riprende l’elencazione già contenuta nella
Dichiarazione del 1948. Le deroghe ai diritti previsti dal Patto (fatto salvo un nucleo di diritti
inderogabili29) sono possibili solo “in caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l’esistenza
della nazione e venga proclamato con atto ufficiale” (art. 4). Per limitare ulteriormente la possibilità
di deroga è previsto inoltre che:
a) le misure devono essere strettamente necessarie in rapporto alla situazione;
b) le misure non devono essere “incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi
dal DI”;
c) le misure non possono essere discriminatorie.
Sebbene lo Stato che adotta le misure derogatorie sia tenuto ad informare, tramite il SG dell’ONU,
tutti gli Stati dell’oggetto e del motivo della deroga, nessun controllo sulla legittimità di tali misure
è ammesso.
Altra possibilità di deroga è concessa, poi, per altre ragioni quali “quelle stabilite dalla legge e che
siano necessarie in una società democratica, nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza
pubblica, dell’ordine pubblico, o per tutelare la sanità e la morale pubblica o gli altrui diritti e
libertà”; in questo caso, però, le limitazioni sono oggetto di controllo di legittimità da parte del
Comitato dei diritti dell’uomo. Il compito del Comitato dei diritti dell’uomo è di controllare il
rispetto del Patto, il quale prevede due diverse procedure di controllo:
a) la presentazione da parte degli Stati al Comitato di “rapporti sulle misure che essi hanno
adottato per dare attuazione ai diritti riconosciuti dal Patto, nonché sui progressi compiuti
nel godimento di tali diritti”. Tale meccanismo prescinde dal consenso degli Stati e li
obbliga a presentare, a richiesta del Comitato (solitamente quinquennale), i rapporti previsti.
Una volta esaminati, il Comitato presenta agli Stati “i propri rapporti e le osservazioni
generali che ritenga opportune” cui gli Stati possono rispondere presentando opportuni
rilievi.
b) la presentazione di una comunicazione da parte di uno Stato membro che denuncia al
Comitato l’inadempimento degli obblighi pattizi da parte di un altro Stato membro. La sua
attivazione non è automatica, ma serve un’apposita dichiarazione dello Stato di accettazione
della competenza del Comitato a ricevere ed esaminare le comunicazioni di un altro Stato
(procedura ad oggi mai usata).
Il protocollo opzionale del Patto prevede un altro meccanismo di controllo, quello delle
comunicazioni individuali, quelle degli individui soggetti alle proprie giurisdizioni che rivendicano
di essere vittime di una violazione da parte dello Stato membro al protocollo di uno dei diritti
elencati nel Patto”. Le considerazioni espresse in questa fattispecie dal Comitato prendono il nome
di pareri e, sebbene non vincolanti, hanno comunque forma e contenuto di vere e proprie decisioni
circa la fondatezza o meno della violazione lamentata dall’individuo. L’efficacia di tale sistema si
fonda sulla credibilità ed autorevolezza delle denunce-pareri del Comitato e sulla loro spontanea
osservanza da parte dello Stato.
Il “Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali” si distingue dall’altro Patto del
1966 essenzialmente per due aspetti:
29
I diritti inderogabili sono: diritto alla vita; divieto di tortura; di schiavitù e servitù; arresto per debiti; irretroattività
della legge penale; diritto al riconoscimento della personalità giuridica; diritto alla libertà di pensiero, coscienza e
religione.
73
1) enuncia diritti legati alla sfera economica, sociale e culturale del singolo che richiedono una
realizzazione più in chiave collettiva che individuale;
2) stabilisce un diverso sistema di controllo.
Il Patto impegna gli Stati a garantire ed attuare una serie di diritti a cominciare da quello
all’autodeterminazione e alla libertà disposizioni delle proprie risorse economiche.
Per ciò che riguarda i meccanismi di controllo, nel 1966 fu previsto unicamente il sistema dei
rapporti statali, rimettendo il compito di ricevere, esaminare e formulare i pareri sui rapporti statali
all’ECOSOC.
Due significative e più recenti novità hanno eliminato praticamente le differenze tra i due sistemi di
controllo dei Patti:
- nel 1985, l’ECOSOC ha istituito il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici,
sociali e culturali, incaricato di ricevere esaminare e formulare pareri su rapporti presentati
dagli Stati;
- nel 2008, l’AG ha adottato il Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti
economici, sociali e culturali che introdurrà (quando in vigore) anche per esso la procedura
delle comunicazioni individuali e quella delle comunicazioni interstatuali.
4. Segue: il Consiglio per i Diritti Umani
La Commissione per i diritti umani era un organo sussidiario dell’ECOSOC che, inizialmente,
aveva solo il compito di studiare e preparare progetti di convenzioni o dichiarazioni in materia di
DU. A partire dagli anni ’60, si cominciò ad attribuirgli nuove funzioni di controllo, istituendo due
apposite procedure: la procedura confidenziale e la procedura pubblica.
Essendo composta da Stati, la politicizzazione dei lavori della Commissione fu inevitabile: questa
situazione che impediva o ritardava i lavori, unita ad alcune inefficienze nell’attuazione delle
procedure di controllo, attirò critiche sempre più forti al punto che si decise di istituire, in sua
sostituzione, il Consiglio per i diritti umani.
Il Consiglio per i diritti umani (CDU) fu costituito nel 2006 come organo sussidiario dell’AG e ha
come scopo principale quello di promuovere il rispetto universale “per la protezione dei diritti
umani e delle libertà fondamentali di tutti, senza distinzioni di alcun tipo e in maniera giusta ed
equa”.
Tra i compiti affidati al Consiglio spiccano:
- quello di occuparsi delle violazioni dei DU, incluse quelle di carattere grave e sistematico,
facendo le opportune raccomandazioni (non vincolanti);
- quello di assumere, rivedere e, se necessario, razionalizzare e migliorare “tutti i mandati,
meccanismi, funzioni e responsabilità” della precedente Commissione, mantenendo
comunque in vita la tripartizione tra procedure speciali, pareri e comunicazioni. Il sistema
delle comunicazioni ereditato dalla Commissione, c.d. complaint procedures, è stato
razionalizzato e migliorato, tuttavia, pur restando confidenziale e rivolta alle gravi e
sistematiche violazioni dei DU, cerca una maggiore cooperazione con lo Stato interessato. In
tale ottica, due gruppi di lavoro hanno il compito di vagliare le comunicazioni ricevute
portando all’attenzione del CDU e dello Stato quelle più attendibili e gravi.
- svolgere l’universal periodic review (UPR) nei confronti degli Stati, ovvero sottoporre ogni
4 anni al ritmo di 48 Stati ogni anno, tutti gli Stati membri dell’ONU ad un esame
concertato del loro human rights records allo scopo di migliorare e promuovere la tutela dei
DU ad ogni livello ed in ogni Stato. La review del singolo Stato è condotta da un apposito
gruppo di lavoro composto dai 47 Stati del CDU e coadiuvato da un triumvirato di tre Stati
che fungono da relatori. Il meccanismo della review è quello del dialogo cooperativo e
interattivo tra Stato esaminato e CDU. Completata la review, il triumvirato prepara il report
in vista della sua adozione da parte del CDU in seduta plenaria. Lo Stato ha la responsabilità
74
di dare esecuzione alle raccomandazioni del report e nella successiva review, dopo 4 anni,
anche questo aspetto sarà oggetto di controllo e dialogo. In caso di mancata cooperazione, il
CDU può segnalare la situazione dello Stato e, se l’ostruzionismo persiste, può anche
decidere misure nei suoi confronti.
Il CDU si compone di 47 Stati, eletti a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dell’AG per un
triennio (vietata l’immediata rielezione solo dopo due mandati). Continua a valere il criterio della
equa distribuzione geografica, tuttavia è stato introdotto un temperamento per evitare che entrassero
in CDU Stati con un discutibile “ruolino di marci” in materia di DU. Nella scelta dei membri del
CDU, l’AG dovrà tener conto sia del contributo dei candidati alla promozione e protezione dei DU,
che gli impegni e le promesse da essi volontariamente assunti.
5. La protezione dei diritti umani presso la CEDU
L’Europa offre il più alto standard di tutela dei DU. Sin da subito infatti, il Consiglio d’Europa
cominciò ad elaborare un progetto di convenzione per la tutela dei DU e nel 1950 a Roma fu firmata
la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa
enuncia e garantisce un’ampia gamma di diritti e libertà fondamentali dell’individuo, per garantire
l’effettività delle quali la Convenzione prevede la creazione di una Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Essa è chiamata a controllare, in via automatica
ed obbligatoria, il rispetto della Convenzione da parte degli Stati membri mediante la procedura di
ricorso interstatale e la procedura di ricorso individuale. La competenza automatica ed
obbligatoria comporta che per l’instaurazione del procedimento e della competenza della CEDU,
vale una volta e per tutte il consenso manifestano dallo Stato al momento della ratifica della
Convenzione.
La modifica più evidente al testo originario della Convenzione è introdotta dal Protocollo n°11 del
1998, che consiste nella scomparsa dell’originario sistema dualistico di controllo della
Convenzione imperniato sulla CEDU e sulla Commissione europea dei diritti dell’uomo, con la
soppressione di quest’ultima che aveva il compito di ricevere, istruire ed esaminare i ricorsi
individuali.
Il Protocollo n°14 è l’unico non ancora in vigore, il quale nuovamente emenda il sistema di
controllo della Convenzione, in particolare riguardo alla composizione della CEDU, alla sua
articolazione interna, alla disciplina del ricorso individuale e al meccanismo di controllo
sull’esecuzione delle sentenze da parte degli Stati.
Le procedure di controllo a disposizione della CEDU possono attivarsi mediante:
- ricorso interstatale: comporta la possibilità per uno Stato membro di deferire alla Corte la
violazione commessa da un altro Stato membro. Sebbene esso sia talvolta usato per fini
strumentali di natura politica, questa facoltà è attribuita agli Stati parti in funzione
dell’interesse oggettivo alla tutela dei DU previsti dal sistema di Strasburgo.
- ricorso individuale: consente, previo l’esaurimento dei ricorsi interni, ad una “persona fisica,
organizzazione non governativa o gruppo di privati che sostenga di essere vittima di una
violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella
Convenzione o nei suoi protocolli” di vedere esaminato il suo caso dalla Corte di
Strasburgo.
La sentenza della CEDU, se sfavorevole allo Stato convenuto, è innanzitutto di “accertamento”
della violazione di un diritto sancito dalla Convenzione. Gli Stati si impegnano a conformarsi alle
sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parte. L’obbligo è ampio ed
integrale, nel senso che lo Stato deve fare tutto ciò che è necessario per eliminare la violazione e
ripristinare la piena conformità del proprio ordinamento alla Convenzione. I giudici nazionali non
75
potranno considerare le sentenza di Strasburgo come meri “suggerimenti” ma come indicazioni
vincolanti, anche per le questioni interpretative.
Sul rispetto e sull’esecuzione della sentenza vigila il Comitato dei Ministri cui le sentenze, a tal
fine, vengono trasmesse. Per ciascuna sentenza, il Comitato apre una procedura di controllo che
viene chiusa solo nel momento in cui si accerti, sulla base delle comunicazioni dello Stato tenuto ad
eseguire la sentenza, che tutte le misure necessarie alla piena esecuzione sono state attuate.
Diversamente, la mancata o incompleta esecuzione della sentenza rimane all’ordine del giorno del
Comitato che può adottare risoluzioni (non vincolanti) allo scopo di fare pressione sullo Stato.
La Convenzione prevede, infine, la possibilità di denuncia della stessa, mentre quella di recedere
dal Consiglio d’Europa è prevista dal proprio Statuto. Il recesso dall’Organizzazione comporta
anche la denuncia della Convenzione.
6. La protezione dei diritti umani nell’OSCE e nell’UE
La c.d. human dimension è una delle tre dimensioni30 attraverso cui l’Organizzazione per la
Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) persegue il fine statutario di garantire la sicurezza
tra gli Stati parti. Tra il suoi numerosi organi ricordiamo:
- il Summit, cioè il vertice dei Capi di Stato e di Governo degli Stati OSCE, che si riunisce
periodicamente in occasione di eventi o esigenze particolari oppure quando sia necessario
definire le linee-guida politiche generali di lungo periodo dell’OSCE.
- il Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri, che si riunisce annualmente e ha il compito di
rivedere e valutare complessivamente le attività dell’OSCE dell’anno pregresso e pianificare
quelle dell’anno seguente.
- il Consiglio Permanente, che si riunisce settimanalmente ed è composto dai rappresentanti
permanenti presso l’OSCE degli Stati membri, ha il compito di gestire l’ordinaria
amministrazione e di costituire un foro di dialogo e consultazione politica tra gli Stati.
- l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE, ha il compito di facilitare il dialogo tra i Parlamenti
nazionali degli Stati membri e svolge funzioni consultive e funzioni di studio, discussione e
monitoraggio dell’OSCE e del rispetto da parte degli Stati membri.
- il Foro di cooperazione per la sicurezza, si riunisce settimanalmente a Vienna e ha
l’importante compito di prendere decisioni sugli aspetti militari della sicurezza e della
cooperazione in ambito OSCE, in particolare favorendo l’adozione da parte degli Stati di
misure che aumentino e sviluppino la confidenza e la sicurezza reciproca in ambito militare.
Per quanto riguarda le attività nel campo della tutela dei DU, tre sono le istituzioni più importanti
impegante a promuovere la democrazia ed assistere gli Stati nella costruzione di sistemi veramente
democratici:
- il Rappresentante per la libertà dei media;
- l’Ufficio per le istituzioni democratiche ed i diritti umani (ODIHR);
- l’Alto Commissario per le minoranze nazionali (HCNM).
Tra i numerosi atti giuridici e politici adottati dall’OSCE merita un cenno la c.d. Dichiarazione di
Budapest del 1994 con cui gli Stati legano indissolubilmente la nozione di democrazia al rispetto
dei DU. Assumono particolare rilievo le missioni di osservazione e monitoraggio delle elezioni
politiche che l’OSCE invia regolarmente in molti paesi. L’OSCE riesce così a essere presente in
Europa sud-orientale, in Europa orientale, nel Caucaso meridionale e in Asia centrale; inoltre
istituisce missioni simili a quelle di PK.
I diritti umani trovarono ingresso formale nell’Unione Europea solo nei nuovi trattati di
integrazione, l’Atto Unico Europeo del 1987 e il Trattato di Maastricht del 1992. In particolare
30
Le altre due dimensioni sono quella politico-militare e economico-ambientale.
76
quest’ultimo sancì solennemente il ruolo dei diritti umani nel processo di integrazione politica ed
economica europea tanto da statuire che “l’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia,
rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono
comuni agli Stati membri” e che “l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”.
Il rispetto di tali principi è posto a condizione, per gli aspiranti stati membri, da soddisfare per
essere ammessi all’UE e condizione, per gli Stati già membri, da integrare sempre per rimanere
nell’UE. Le eventuali violazioni (o minacce di violazione) commesse dagli Stati membri, saranno
vagliate dal meccanismo di controllo previsto dal Trattato di Maastricht del 1992, poi ampliato dal
Trattato di Amsterdam del 1997.
Altro passaggio significativo nel quadro della tutela dei DU nell’UE è quello dell’adozione della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, c.d. Carta di Nizza, proclamata solennemente
nel 2000 dalle tre Istituzioni Comunitarie. Essa riafferma i diritti fondamentali già parte integrante
del patrimonio culturale, politico e giuridico dell’UE e degli Stati membri, cercandone una
sistematizzazione. Inoltre, essa non cerca assolutamente di estendere o modificare le competenze
dell’UE.
Il Trattato di Lisbona, qualora entrerà in vigore, modificherà il Trattato di Maastricht, innanzitutto
introducendo un nuovo articolo che sancirà i valori fondamentali posti alla base dell’UE e della
società che si intende creare in Europa.
7. La protezione dei diritti umani in America
Nel campo della tutela dei DU, costituisce senza dubbio un punto di riferimento politico e giuridico
per gli Stati dell’America la Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell’uomo del 1948.
Infatti, la coeva istituzione dell’Organizzazione degli Stati Americani (OAS) ha favorito un
collegamento tra le enunciazioni della Dichiarazione e quelle, in materia di DU, contenute nella
Carta istitutiva dell’OAS al punto che la giurisprudenza e la dottrina la considerano
“l’interpretazione autentica dei diritti dell’uomo riferiti all’atto costitutivo dell’OAS”, capace di
rafforzare l’obbligatorietà di questi ultimi.
Decisivo è stato il ruolo dell’OAS di l’impulso politico per la tutela dei DU, che ha portato
all’adozione della Convenzione americano dei diritti dell’uomo nel 1969, sfruttando la precedente
esperienza giuridica europea.
Il sistema americano di protezione dei DU si articola sulla Corte e sulla Commissione:
- la Commissione dei diritti dell’uomo nasce nel 1959 come organo autonomo dell’OAS
chiamato inizialmente a meri compiti di promozione dei DU. Successivamente, alla
Commissione furono attribuite nuove ed ulteriori funzioni fino a quando, con la
Convenzione del 1969, divenne anche l’organo di tutela e promozione dei DU nel sistema
convenzionale. Essa dunque è competente a ricevere i ricorsi interstatali e i ricorsi
individuali aventi ad oggetto violazioni della Convenzione o della Dichiarazione, aprendo,
se necessario, il relativo procedimento di fronte alla Corte.
- la Corte interamericana ha una giurisdizione condizionata alla dichiarazione di accettazione
dello Stato membro.
8. La protezione dei diritti umani in Africa, Asia e nei Paesi arabi
Al momento dell’istituzione dell’Organizzazione dell’Unità Africana (OUA) nessun riferimento
era contenuto nella sua Carta al tema dei DU. Solamente verso la fine degli anni ’70, l’OUA invitò
il Segretario Generale dell’Organizzazione a promuovere una Conferenza di esperti giuristi affinché
77
lavorassero ad uno strumento regionale di protezione dei DU: questo fu completato nel 1981 e
portò all’adozione della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli.
La Carta presenta numerose similitudini con la Dichiarazione universale del 1948 e pone
particolarmente l’accento sia sul legame tra diritti individuali e diritti collettivi, che sul diritto
collettivo dei popoli africani allo sviluppo. Se ne distingue, invece, per alcune ragioni:
a) alcuni diritti non sono sanciti;
b) mancano limiti precisi e stringenti alla possibilità dello Stato di sospendere o limitare il
godimento dei diritti sanciti dalla Carta.
La Carta africana istituisce e disciplina anche l’organo di controllo, cioè la Commissione africana,
che ha il compito di:
a) promuovere i DU;
b) interpretare le disposizioni della Carta a richiesta degli Stati membri, dell’UA o di altra
Organizzazione africana riconosciuta dall’UA;
c) ricevere ed esaminare le comunicazioni dagli Stati, relative a violazioni commesse da altri
stati, dagli individui e dalle ONG.
Una prima e importante modifica del sistema africano di protezione dei DU si ebbe con l’adozione
nel 1998 del Protocollo istitutivo della Corte Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli. La Corte è
un organo dell’UA e ha una funzione complementare rispetto a quella affidata alla Commissione.
Ha una competenza giurisdizionale e una consultiva: la prima si estende a tutte le questioni relative
all’interpretazione e all’applicazione della Carta Africana e del Protocollo e di ogni altro trattato sui
SU che sia stato ratificato dagli Stati parti alla controversia; la seconda si esercita a richiesta di uno
Stato membro dell’UA, della stessa UA e di qualunque altra organizzazione africana riconosciuta
dall’UA e può avere ad oggetto “qualsiasi materia di diritto collegata alla Carta o qualsiasi altro
strumento di DU rilevante”.
Nel 2008, il nuovo protocollo di Sharm El-Sheik all’Atto Costitutivo dell’UA ha fuso la Corte di
giustizia africana e la Corte Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli in un’unica Corte Africana
di Giustizia e dei diritti umani.
La protezione dei DU nel continente asiatico è stata solo di recente sviluppata con l’adozione della
Carta dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Carta ASEAN) del 2007. Essa mira a
istituzionalizzare la cooperazione intergovernativa nel sud-est asiatico sulla falsariga del modello di
integrazione europea, prevedendo la creazione di un organo a tutela dei diritti umani, a cui spetterà
il compito, in seno all’ASEAN, di promuovere e proteggere i diritti e le libertà fondamentali in
conformità con i fini e i principi enunciati nel Preambolo della Carta.
La genericità e laconicità della disposizione che istituisce lo Human Rights Body è stata criticata da
più parti: in particolare per il fatto che non gli sia stato attribuito alcun potere sanzionatorio per le
violazioni dei DU commesse dagli Stati membri.
La creazione di un sistema organico ed incisivo di protezione e garanzia dei DU nei Paesi
musulmani ed in quelli arabi è rallentato ed ostacolato dalle divisioni politiche al loro interno.
A livello di struttura di riferimento, la Lega Araba (LA) è il principale riferimento: la sua Carta
istitutiva non fa menzione esplicita dell’obiettivo relativo alla tutela dei DU. Sull’onda delle
iniziative promosse dall’ONU, la LA, nel 1968, istituì, al suo interno, un organo, la Commissione
araba permanente per i diritti dell’uomo, incaricato di studiare, discutere e promuovere iniziative e
progetti di convenzioni in materia.
Nel 1994 si arrivò all’approvazione da parte del Consiglio della LA della Carta Araba dei diritti
dell’uomo, che fu subito oggetto di critiche e forti riserve da parte di alcuni stati, specialmente di
quelli a diritto islamico che o contestavano alcune disposizioni in contrasto con la loro tradizione e
legislazione religiosa o, ancor più radicalmente ritenevano (come l’Arabia Saudita) che la legge
coranica fosse già universale ed esaustiva in materia e che, quindi, l’adottando strumento fosse
inutile e duplicativo.
78
Tale insoddisfazione, se non aperta opposizione, spinse la LA a ristudiare il progetto allo scopo di
riformarlo. Nel 2004 la Commissione araba permanente, sottopose un nuovo testo al Consiglio della
LA che adottò la Carta araba dei diritti dell’uomo, contestualmente aprendola alla firma, alla
ratifica o all’adesione. Il difficile compromesso tra la tradizione islamica e l’impostazione che, per
certi diritti, a livello pressoché universale è seguita sembra raggiunto dal richiamo alla
Dichiarazione Universale del 1948 e ai Patti del 1966.
In controllo sul rispetto e l’attuazione della Carta da parte dei suoi membri, è istituito un Comitato
Arabo sui diritti umani che presenta triennalmente un rapporto sulle misure adottate per realizzare,
garantire e proteggere i diritti e le libertà sanciti dalla Carta.
9. Asilo, rifugio e divieto di respingimento
La Convenzione sullo status di rifugiato del 1951 tutela, garantendogli protezione giuridica, chi
“nel giustificato timore di essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza,
la sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello
Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole avvalersi della
protezione di detto Stato”. Il rifugiato è colui che è perseguitato dal proprio Stato.
Chi fugge dalla guerra, dalla fame o semplicemente cerca in uno Stato diverso dal suo una nuova
vita non è un rifugiato.
Il termine asilo ha indicato, da sempre, la protezione che materialmente uno Stato offre, “entro la
propria sfera territoriale”, a chi fugge dalla persecuzione cercando rifugio altrove. L’asilo si
distingue in:
- asilo territoriale: è la protezione che lo Stato garantisce allo straniero in fuga dalla
persecuzione all’interno del proprio territorio ed è l’unica fattispecie regolata dal DI.
- asilo diplomatico: è la protezione che viene offerta allo straniero in fuga in luoghi diversi dal
territorio dello Stato di rifugio come nelle sedi delle missioni diplomatiche e consolari dello
Stato all’estero. Tale ipotesi, con l’eccezione del continente latinoamericano, non è regolata
dal DI anche perché la sede della missione diplomatica e consolare non è territorio dello
Stato di invio della missione ma, a tutti gli effetti, territorio del sovrano locale. Nel caso in
cui, l’individuo rifugiatosi presso l’Ambasciata lasci volontariamente la sede diplomatica (o
perché respinto) ben potrà lo Stato territoriale procedere al suo arresto. E similmente lo
Stato della missione (nel caso in cui decida di garantire la protezione) non potrà vantare
verso lo Stato territoriale un diritto di condurre indisturbatamente presso il proprio territorio
(a meno che lo Stato di cittadinanza dell’individuo non lo consenta per ragioni di
opportunità politica nei rapporti con quello Stato concedendogli il c.d. salvacondotto).
La fattispecie dell’asilo diplomatico è diversamente regolata nel continente latinoamericano. La
Convenzione sull’asilo diplomatico del 1954, firmata da 20 stati dell’OAS, prevede che l’asilo
“concesso nelle rappresentanze diplomatiche, navi da guerra o aeromobili e campi militari, a
persone perseguitate per motivi politici, sarà rispettato dallo Stato territoriale”. Si riconosce poi il
diritto, ma non l’obbligo per lo Stato di rifugio, di concedere asilo diplomatico, mentre gli Stati
territoriali sono obbligati a rilasciare il salvacondotto affinché l’individuo che ha chiesto e ottenuto
asilo possa lasciare, in condizioni di assoluta sicurezza, il Paese.
Tale Convenzione è riproduttiva di una regola consuetudinaria di portata locale (o regionale) già
esistente tra gli Stati latinoamericani.
Il principale obbligo imposto dalla Convenzione del 1951 allo Stato alla cui frontiera giunge
l’individuo in cerca di rifugio è quello di non respingimento. Si fa obbligo, dunque, allo Stato di
non respingere e, intanto, accogliere il rifugiato; in un secondo momento, la posizione politica e
giuridica del rifugiato sarà valutata dallo Stato che lo ha accolta. In questo modo, se l’elemento
79
della persecuzione esiste l’individuo non respinto è posto sotto asilo, altrimenti, in assenza di
persecuzione lo Stato accogliente può restituire l’individuo al suo Stato di cittadinanza.
Non è fatto alcun obbligo allo Stato di concedere lo status di rifugiato a chi ne abbia i requisiti.
Qualora lo status non venga conferito, lo Stato si accorda con un altro che sia disponibile ad
accogliere il rifugiato dandogli asilo oppure dovrà continuare a proteggere l’individuo sul proprio
territorio.
La Convenzione di Ginevra del 1951 è molto legata al contesto socio-politico in cui è nata, ovvero
quello della divisione del mondo in blocchi, le cui vicende internazionali degli anni successivi
hanno mostrato nuovi e inattesi sviluppi sociali legati ai c.d. esodi di massa. Di fronte a tali
fenomeni, non contemplati dalla Convenzione, la prassi degli Stati si è orientata nel senso di
garantire un rifugio ed una protezione temporanea alle masse in fuga.
I c.d. temporary protected status garantiscono l’esigenza umanitaria di proteggere chi, in quel
momento, è in difficoltà e, allo stesso tempo, garantiscono il diritto dello Stato di accoglienza di
non farsi carico dell’onere sociale, politico ed economico legato all’accoglienza definitiva di masse
così numerose di stranieri. La protezione dura fin quando dura nel Paese di origine degli sfollati la
causa che li ha costretti all’esodo (fatta salva ogni diversa scelta politica dello Stato di accoglienza).
Il divieto di respingimento sembra si sia oggi anche caratterizzato, dal punto di vista giuridico, dal
divieto di respingere anche chi, se respinto, potrebbe patire sofferenze o gravi violazioni dei propri
diritti per eventi oggettivi non legati alla sua condizione personale (c.d. ragioni di umanità).
Fermo restando le libere e diverse scelte politiche che uno Stato può fare in materia di migrazione
(accogliere o meno i migranti), dal punto di vista giuridico vi è che lo Stato non abbia alcun obbligo
internazionale di consentire l’ingresso sul proprio territorio agli stranieri.
80
CAPITOLO XI – IL DIRITTO INTERNAZIONALE DEL MARE
1. Considerazioni introduttive
Nel DI, il mare rileva essenzialmente da tre punti di vista:
a) come territorio dello Stato, c.d. mare territoriale, o come spazio comunque soggetto ai
poteri di imperio dello Stato anche fuori dal mare territoriale, c.d. zona contigua;
b) come spazio non soggetto e non assoggettabile alla sovranità di nessuno Stato, c.d. alto mare
o mare libero;
c) come spazio sfruttabile economicamente dallo Stato secondo regimi normativi
sostanzialmente svincolati dai criteri di sovranità territoriale, c.d. zona economica esclusiva.
Nel regolare giuridicamente i loro rapporti, gli Stati furono guidati, come lo sono ancora oggi, da
due considerazioni:
1) tutelare la propria sovranità sia a livello territoriale (da interferenze provenienti dal mare)
che extraterritoriale (difesa delle proprie navi fuori dal territorio statale);
2) sfruttare le possibilità economiche che il mare offre sia direttamente (pesca, risorse del suolo
e sottosuolo marino) che indirettamente (navigazione marittima a fini commerciali).
La prima disciplina ebbe natura consuetudinaria, sulla base della quale ancora oggi si ispirano le
regole fondamentali. Tuttavia, recentemente, si è sentita l’esigenza di una regolamentazione più
dettagliata e puntuale della materia, di cui le Convenzioni sul diritto del mare a partecipazione
pressoché universale sono la prova; tra esse ricordiamo:
- le 4 Convenzioni di Ginevra del 1958 sul mare territoriale e zona contigua, sull’alto mare,
sulla piattaforma continentale, sulla
pesca e la conservazione delle risorse
biologiche dell’alto mare;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare di Montego Bay
(UNCLOS) del 1982.
Quello che, in generale, emerge è una disciplina
consuetudinaria e convenzionale del mare
sostanzialmente unica a livello internazionale,
caratterizzata da una continua e simultanea
attenzione per le due considerazioni sopra
svolte.
2. Il mare territoriale e il diritto di passaggio inoffensivo
Il mare territoriale è una parte del territorio dello Stato a tutti gli effetti, sulla quale si manifesta la
sovranità negli stessi modi e per gli stessi scopi riscontrabili sulla terraferma. L’unica peculiarità è
rappresentata dalle caratteristiche fisico-morfologiche del mare che, rispetto al suolo, determinano
una diversa articolazione dell’esercizio concreto dei poteri del sovrano.
La UNCLOS riconosce l’estensione della sovranità dello Stato al mare territoriale, “allo spazio
aereo sovrastante il mare territoriale come pure al relativo fondo marino e al sottosuolo”.
In questa zona, lo Stato, per la sua adiacenza alla terraferma, ha le stesse esigenze di controllo e
difesa della propria integrità territoriale e della propria popolazione.
L’esercizio di poteri sovrani anche al di fuori del mare territoriale dimostra l’esigenza, avvertita da
tutti gli Stati, di irradiare la propria sovranità in ogni luogo dove appaia necessario nel rispetto delle
concorrenti ed identiche pretese altrui e/o del principio di libertà che vale negli spazi non soggetti
alla sovranità esclusiva di uno Stato (nozione funzionale di sovranità).
La linea, dunque, che demarca il mare territoriale dal resto del mare diventa un’esigenza logica di
spazialità per garantire migliore certezza alle RI, ma non un limite oggettivo ed insormontabile.
81
La spazialità “relativa” che si lega al mare non si orienta solo nel senso di garantire un più esteso ed
articolato potere di azione allo Stato costiero, ma si manifesta anche a vantaggio degli stranieri che,
sia per mancanza di confine territoriale di terraferma che per le modalità concrete di utilizzo del
mare, godono di una maggiore tolleranza da parte del sovrano nel momento in cui entrano nelle sue
acque territoriali.
Il diritto di passaggio inoffensivo della nave straniera nel mare territoriale (e, al contrario,
l’inesistenza di tale diritto nelle acque interne dello Stato) è la migliore esemplificazione di questo
peculiare rapporto tra sovrano, territorio e straniero.
La concorrenza tra due potestas di governo (una territoriale dello Stato costiero e l’altra navale) si
può spiegare agevolmente grazie alla nozione funzionale di sovranità: lo Stato territoriale deve
“funzionalmente” proporzionare i propri interventi alla compenetrazione reale che si realizza tra
comunità navale e comunità territoriale.
In base alla UNCLOS, per delimitare la fascia di mare territoriale si usa il criterio della linea di
base: cioè si segue la linea della bassa marea, c.d. linea di base normale; oppure in casi eccezionali,
si segue la linea che collega certi “punti appropriati” nel caso di coste frastagliate, profondamente
incavate, presenza di isole nelle immediate vicinanze della costa, c.d. linea di base diritta. Una
volta tracciata la linea di base si calcola, da quel punto in avanti la fascia di mare territoriale fino al
limite massimo di 12 miglia marine.
I poteri dello Stato costiero sono incisivi e incontrano solo due categorie di limiti:
1) il diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale delle navi straniere. Per
“passaggio”, la UNCLOS intende il movimento della nave “continuo e rapido”, senza soste
e finalizzato all’attraversamento, senza scali, del mare territoriale oppure all’ingresso o
all’uscita dalle acque interne. Tale passaggio è “inoffensivo” quando non arreca pregiudizio
alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero. Tutti i casi di passaggio ostile
sono contenuti nell’art. 19 della Convenzione.
2) la potestà “navale” concorrente, con il limite per l’intervento o meno dello Stato costiero
rappresentato dalla rilevanza esterna o interna (cioè lesiva o meno per il suo ordine
pubblico) dei fatti occorsi a bordo della nave. Tale problema è affrontato dalla UNCLOS
solo con riguardo alle navi straniere in transito nel mare territoriale, e non con riguardo a
qualunque ipotesi di presenza della nave straniera nelle acque territoriali dello Stato
costiero). Lo Stato costiero, non dovrebbe esercitare sulle navi in transito né la sua
giurisdizione penale né quella civile, fatti salvi i casi eccezionali indicati che per la
giurisdizione penale sono:
- esplicita richiesta di intervento da parte dello Stato della nave;
- lotta al narcotraffico;
- conseguenze di reato che si estendono allo Stato costiero;
- reato che disturba la pace del paese o il buon ordine nel mare territoriale.
L’intervento dello Stato costiero è ammesso dalla UNCLOS solo per le navi mercantili e quelle di
Stato utilizzate per scopi commerciali, non anche per le navi da guerra e quelle di Stato in servizio
non commerciale.
Lo Stato costiero ha diritto di emanare leggi e regolamenti per disciplinare, nel quadro delle
previsioni della UNCLOS, il passaggio inoffensivo all’interno del proprio mare territoriale;
parimenti, lo Stato ha anche il diritto di proteggersi, con ogni misura necessaria, contro qualunque
passaggio che sia ostile.
Riguardo alla navigazione degli stretti, per la UNCLOS essi “non costituiscono una zona costiera a
sé stante, ma sono porzioni di acque interne o di mare territoriale che mettono in comunicazione
due porzioni di alto mare o di zone economiche esclusive e che sono utilizzate per la navigazione
internazionale. La norma internazionale favorisce e garantisce il transito evitando che lo Stato
82
costiero lo impedisca o renda troppo onerosa la navigazione internazionale: negli stretti vige il
diritto di passaggio in transito di cui godono tutte le navi e gli aeromobili. Questo diritto deve essere
esercitato in modo continuo e rapido, secondo modalità di navigazione normali.
Negli stretti che “collegano il mare territoriale di uno Stato all’alto mare o alla zona economica
esclusiva di un altro Stato” si applica il diritto di passaggio inoffensivo, che non può essere sospeso.
3. La zona contigua, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale
La zona contigua (ZG) è quella fascia di mare adiacente al mare territoriale che si estende fino a 24
miglia marine “dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale”, all’interno
della quale lo Stato costiero può esercitare i controlli necessari a:
1) prevenire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di
immigrazione entro il suo territorio o mare territoriale;
2) punire le violazioni delle leggi e regolamenti di cui sopra, commesse nel proprio territorio o
mare territoriale.
La zona economica esclusiva (ZEE) è una zona di mare che si estende fino a 200 miglia marine
dalle linee di base da cui viene misurata la larghezza del mare territoriale, all’interno della quale lo
Stato costiero gode di “diritti sovrani” di natura economica. A differenza della ZG dove lo Stato
esercita poteri di polizia, la ZEE è solo funzionale all’esercizio di diritti di sfruttamento economico
delle risorse (biologiche e non biologiche) ivi presenti al fine di esplorarle, sfruttarle, conservarle e
gestirle.
Nonostante non valga nella ZEE quella generalissima libertà che è tipica dell’alto mare, il regime
resta improntato a garantire la massima libertà possibile per gli Stati diversi da quello costiero in
ragione del fatto che si è al di fuori del suo mare territoriale e pure ben distanti dalle sue coste e che
la ZEE mira a soddisfare le sole esigenze economiche dello Stato costiero.
In linea di principio, quindi, si ritiene di riconoscere agli Stati gli stessi diritti e le stesse libertà di
cui godono nell’alto mare (alcune sempre garantite, altre garantite se non incompatibili con i diritti
di cui gode lo Stato costiero).
Si chiede, poi, sia allo Stato costiero che agli altri Stati di esercitare i diritti ed adempiere gli
obblighi tenendo in debito conto i diritti e gli obblighi della controparte. Tale generico richiamo al
“debito conto” delle altrui posizioni giuridiche è completato dall’ancor più generico dettato che, in
caso di conflitto tra gli interessi dello Stato costiero e quelli degli altri Stati, indica come criteri di
risoluzione l’equità, “tutte le circostanze pertinenti” e l’importanza “che tali interessi rivestono sia
per le parti in causa, sia per la CI nel suo complesso”.
Un regime peculiare è fissato dall’UNCLOS per lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche
nella ZEE: lo Stato costiero determina la propria potenzialità (quota massima) di sfruttamento delle
risorse biologiche e, se non la sfrutta per intero, “deve [previo accordo] concedere ad altri Stati
l’accesso all’eccedenza della quota” massima in precedenza determinata.
La piattaforma continentale dello Stato costiero “comprende il fondo e il sottosuolo delle aree
sottomarine che si estendono al di là del suo mare territoriale attraverso il prolungamento naturale
del suo territorio terrestre fino all’orlo esterno del margine continentale, o fino ad una distanza di
200 miglia marina dalle linee di base da cui viene misurata la larghezza del mare territoriale”.
Lo Stato costiero “esercita sulla propria piattaforma continentale diritti sovrani allo scopo di
esplorarla e sfruttarne le risorse naturali”. I diritti sono esclusivi (se lo Stato costiero non li esercita,
nessun altro può farlo salvo autorizzazione del primo) e automatici ma riguardano solo il suolo ed il
sottosuolo, non estendendosi quindi anche alle acque e allo spazio aereo sovrastanti la piattaforma.
Gli altri Stati hanno il diritto di posare cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale
senza che lo Stato costiero possa impedirglielo. Al contrario, le perforazioni a qualunque scopo
della piattaforma sono autorizzate e regolamentate dallo Stato costiero.
83
4. L’alto mare e la International Seabed Authority
L’alto mare è residualmente definito come la zona di mare che non sia inclusa in una ZEE, nel
mare territoriale o nelle acque interne dello Stato. Il regime giuridico dell’alto mare è improntato
alla massima libertà possibile ed è “aperto a tutti gli Stati, sia costieri che privi di litorale” al fine di
esercitare (anche se con limiti di carattere generale e di carattere specifico):
- la libertà di navigazione: il criterio di base è che la nave sia sottoposta alla giurisdizione
esclusiva dello Stato di cui batte bandiera. La nave che non ha bandiera, la c.d. nave pirata,
che ha più bandiere o che le cambia a seconda della convenienza è considerata una nave
senza nazionalità e resta soggetta alla giurisdizione di tutti gli Stati. La giurisdizione sulla
nave straniera in alto mare da parte dello Stato non di bandiera può essere esercitata solo in
casi eccezionali.
- di sorvolo;
- di posa dei cavi sottomarini e condotte;
- di costruzione di isole artificiali e altre installazioni consentite dal DI;
- di pesca;
- di ricerca scientifica.
I generali obblighi di cooperazione tra gli Stati per combattere in alto mare la pirateria, le
trasmissioni non autorizzate, la tratta degli schiavi si traducono nella possibilità per lo Stato di far
valere, mediante le sue navi da guerra, aeromobili militari e navi o aeromobili chiaramente
contrassegnati ed identificabili come in servizio di Stato, il diritto di visita.
Il diritto di visita è quel diritto che consente di fermare, abbordare e controllare la nave straniera se
esiste il fondato motivo di sospettare che essa sia impegnata in una delle attività sopra elencate.
La pirateria in alto mare consiste in ogni atto illecito di violenza, sequestro o rapina commesso
dall’equipaggio o dai passeggeri di una nave o aeromobile privati contro un’altra nave o aeromobile
o contro persone o beni da essi trasportati. L’atto di pirateria qualifica la nave o l’aeromobile come
pirata anche se batte bandiera di uno Stato. Lo Stato non di bandiera può sequestrare, in prima
battuta, la nave o l’aeromobile pirata, arrestando le persone a bordo e requisendone i bene e, in
seconda battuta, decidere “la pena da infliggere nonché le misure da adottare nei confronti delle
navi, aeromobili o beni”.
Il diritto di inseguimento conferma la dimensione funzionale della sovranità negli spazi posti al di
fuori del territorio dello Stato. Esso permette allo Stato costiero di inseguire la nave straniera,
partendo dalle proprie acque interne o dal mare territoriale, fino all’alto mare quando vi sia il
fondato sospetto che la nave straniera abbia violato le leggi e i regolamenti dello Stato costiero. Per
essere legittimo, l’inseguimento deve essere continuo e avere una ragionevole previsione di
conseguimento del risultato.
La libertà dello Stato in alto mare è oltremodo limitata dal regime giuridico applicabile alla c.d.
Area, cioè “il fondo del mare, il fondo degli oceani e il relativo sottosuolo, al di là dei limiti della
giurisdizione nazionale”. Esso non incide sul regime giuridico delle acque sovrastanti e dello spazio
aereo situato al di sopra che, resta caratterizzato dalle libertà esposte a inizio paragrafo.
Nell’Area, il regime applicabile riguarda le risorse ivi presenti che sono considerate patrimonio
comune dell’umanità e, in quanto tali, sottratte allo sfruttamento e alla gestione unilaterale dei
singoli Stati e affidate in gestione esclusiva all’Autorità Internazionale dei fondi marini (ISA) che
agisce per conto dell’umanità cui sono conferite tali risorse. Essa è un’OI composta ipso facto da
84
tutti gli Stati parti alla UNCLOS mediante la quale gli Stati “organizzano e controllano l’attività
nell’Area con il particolare scopo di gestire le risorse dell’Area”31.
I vantaggi finanziari, economici, scientifici e tecnologici delle attività condotte nell’Area dall’ISA
sono equamente ripartiti tra tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro condizione geografica e con
particolare attenzione agli interessi e alle necessità dei Paesi in via di sviluppo (PVS).
Le attività dell’ISA sono svolte per “favorire un sano sviluppo dell’economia mondiale ed
un’espansione equilibrata del commercio internazionale” e per “promuovere la cooperazione
internazionale per uno sviluppo generale di tutti i paesi”.
5. Il Tribunale Internazionale per il diritto del mare
Il sistema di risoluzione delle controversie sull’interpretazione e l’applicazione del DI del mare è
variamente articolato. Le controversie di carattere generale e quelle sui fondi marini sono regolate
dallo Statuto della UNCLOS.
Gli allegati V,VI,VII,VIII alla UNCLOS disciplinano, nell’ordine, la procedura di conciliazione,
contengono lo Statuto del Tribunale Internazionale per il diritto del mare (ITLOS), disciplinano la
procedura arbitrale e la procedura arbitrale speciale. A ciò si aggiunga la possibilità per le parti in
controversia di sottoporre la questione alla CIG32.
31
32
Per l’approfondimento della struttura dell’ISA vd. pgg. 545-549.
Per l’approfondimento dell’ITLOS e dei mezzi di risoluzione delle controversie vd. pgg. 549-551.
85
CAPITOLO XII – IL DIRITTO INTERNAZIONALE DELL’ECONOMIA
1. Brevi cenni sull’evoluzione del settore
Le diseguaglianze economiche tra gli Stati, i danni provocati dal colonialismo, il ricorso al
protezionismo a difesa dei mercati e dei prodotti nazionali provocavano, all’alba della fine del
secondo conflitto mondiale, un duplice negativo effetto per l’economia internazionale e per i
rapporti politici interstatuali: rallentavano la crescita globale e aumentavano la tensione
internazionale.
Tra gli Stati vincitori della Seconda Guerra Mondiale si andò dunque affermando la pretesa di
garantire una disciplina giuridica internazionale anche dei rapporti economici (commerciali e
finanziari) tra gli Stati.
Il nuovo ordine internazionale, dal punto di vista economico, avrebbe visto attribuire all’ONU una
competenza in materia, ma soprattutto avrebbe visto la nascita di nuove OI a larga, se non
universale, partecipazione chiamate a regolamentare il settore secondo i dettami della teoria
economica liberista e neoliberista (FMI, IBRD, ITO/OMC).
I fori di dialogo e di confronto in materia economica si sono costituiti nelle c.d. Istituzioni di
Bretton Woods, cioè quelle OI a partecipazione praticamente universale che disciplinano il sistema
monetario internazionale (FMI e IBRD) ed il commercio internazionale (OMC).
I decenni successivi al 1945 non mostrarono solo la liberalizzazione dei mercati nei Paesi
industrializzati di matrice politica occidentale, ma anche, a seguito della decolonizzazione,
l’avanzamento delle istanze dei PVS che rivendicano una specificità politica che trova affermazione
giuridica nella rivendicazione della sovranità economica, del diritto allo sviluppo e
nell’introduzione del sistema delle preferenze generalizzate.
L’inizio degli anni ’70 segna la fine del c.d. sistema di Bretton Woods, con la sospensione del gold
exchange standard, cioè la convertibilità del dollaro in oro, da parte degli USA e l’introduzione del
c.d. sistema di cambi fluttuante.
La tendenza degli ultimi decenni, infine, vede una progressiva “conversione” di molti stati ai
dettami del neoliberismo e una crescita dei flussi commerciali e degli indicatori economicofinanziari del “mercato mondiale”. Parallelamente si assiste ad una profonda ed articolata
strutturazione giuridica dei fenomeni interstatuali di integrazione economica a livello regionale e
sub-regionale (UE, Paesi latinoamericani).
2. Il General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT)
La regolamentazione giuridica del commercio internazionale era avvertita come necessaria, in
particolare dopo la crisi del ’29, per almeno due ragioni:
- il protezionismo limitava il regime degli scambi commerciali internazionali, producendo
effetti discorsivi per le diverse economie e generando inefficienze;
- da posture protezionistiche spesso nascevano controversie internazionali, le c.d. “guerre
commerciali”, che, talvolta, degeneravano in veri e propri conflitti armati.
Nel 1947 entrò in vigore l’Accordo generale sul commercio e sulle tariffe (GATT), ovvero
l’accordo multilaterale che sanciva la progressiva riduzione su scala mondiale delle barriere
doganali al commercio internazionale, introducendo anche alcune significative clausole giuridiche.
Ciò fu sicuramente alla base della prematura morte dell’Organizzazione Internazionale del
Commercio (ITO).
Anche dopo le modifiche introdotte nel 1994, il sistema del GATT continua ad articolarsi sul
principio di non discriminazione nei rapporti commerciali internazionali nel senso che uno Stato
parte non può applicare trattamenti commerciali e doganali differenti in ragione della provenienza
di una merce, sancendo la c.d. clausola della nazione più favorita, in base alla quale il miglior
trattamento riservato da uno Stato parte a qualunque prodotto originario di un altro Stato parte viene
86
“immediatamente e senza condizioni” garantito anche ad ogni altro analogo prodotto di qualunque
altro Stato.
In tale ottica si inserisce anche la c.d. clausola del trattamento nazionale, in base a cui i prodotti
stranieri, una volta importati dal mercato nazionale, hanno diritto a non essere discriminati rispetto
agli analoghi prodotti di origine nazionale: hanno diritto di ricevere lo stesso trattamento in termini
di tasse interne ed altre imposizioni, leggi, regolamenti, restrizioni, etc.
Altra significativa previsione del GATT è quella che mira a combattere il fenomeno del dumping,
cioè la vendita di un prodotto in un mercato straniero a un prezzo inferiore al suo “valore normale”.
Tale pratica è vietata perché può gravemente danneggiare l’industria locale dell’analogo prodotto
domestico che subisce la vendita in dumping del prodotto straniero. In tal caso, lo Stato che importa
il prodotto venduto in dumping può applicare un dazio anti-dumping il cui valore dovrà esattamente
corrispondere all’illecito margine di dumping.
Per quanto riguarda le sovvenzioni statali all’economia, il GATT non le vieta, ma obbliga lo Stato,
nel caso in cui la sovvenzione possa, direttamente o indirettamente, incidere sul commercio
internazionale, a notificare agli altri stati “la portata e la natura delle sovvenzioni”, gli effetti
prevedibili sui flussi commerciali e le circostanze che rendono necessaria la sovvenzione.
In linea di principio, il sistema del commercio multilaterale come delineato dal GATT dovrebbe
vietare ogni restrizione al commercio così da lasciare alla libera dinamica del mercato la fissazione
delle migliori e naturali condizioni economiche. Tuttavia, la prassi dimostra che, pur in un quadro
complessivo di tendenziale liberalizzazione dell’economia internazionale, gli Stati restano
comunque pronti ad intervenire a sostegno o a protezione delle loro imprese, dei loro comprati
produttivi o, addirittura, della loro stessa economia complessivamente considerata.
Il riflesso normativo di questo comprensibile atteggiamento degli Stati si ritrova nella stessa
formulazione delle norme del GATT, in genere costruite sull’affermazione di un generale principio
di libertà economica costellato, però, di eccezioni di natura restrittiva o di norme che poco limitano
ma, nel frattempo, introducono benefici meccanismi interstatuali di dialogo, discussione, confronto
e risoluzione delle questioni per impedire lo scontro commerciale, dannoso per tutti.
3. L’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)
L’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nasce nel 1994 con l’obiettivo di sistematizzare
ed amministrare coerentemente, sotto l’egida di una sola OI, i molteplici settori dell’economia e del
commercio internazionale meritevoli di disciplina giuridica. Essa “funge da quadro di istituzionale
comune per la gestione delle relazioni commerciali tra i suoi membri nelle questioni relative agli
accordi e agli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati del presente Accordo” (art. II
del Trattato Istitutivo).
L’OMC è un grande foro di negoziato tra gli Stati, di esecuzione degli accordi e di risoluzione delle
controversie internazionali aventi ad oggetto le questioni del commercio internazionale33.
Tra i molteplici accordi amministrati dall’OMC, sono tre quelli di particolare importanza atteso che
disciplinano alcuni settori-chiave del commercio internazionale:
a) il GATT che governa il commercio delle merci;
b) il GATS che governa il commercio dei servizi (Allegato 1a);
c) il TRIPS che governa gli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (Allegato
1b).
33
Fino alla nascita dell’OMC, l’occasione per le negoziazioni interstatuali sul commercio internazionale era offerta dai
c.d. rounds, incontri multilaterali di durata non prestabilita ai quali partecipavano le folte delegazioni di tutti gli stati e
in cui venivano discusse le questioni più urgenti o rilevanti. Tale prassi non è comunque cessata con la nascita
dell’OMC, ma si è modificata.
87
Gli Allegati 2 e 3 del Trattato OMC contengono altri due importanti accordi: la DSU, l’intesa sui
meccanismi di risoluzione delle controversie, e il Trade Policy Review Mechanism, il meccanismo
di controllo delle politiche commerciali.
La struttura dell’OMC34 è complessa dal momento che, a fianco degli organi principali previsti dal
trattato istitutivo (Conferenza ministeriale, Consiglio generale, Segretariato) vi è poi una pletora di
organi sussidiari (Consiglio per gli scambi di merci, Consiglio per gli scambi di servizi, Consiglio
per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio o Consiglio TRIPS)
chiamati ad amministrare i singoli accordi che appartengono al “sistema OMC”.
Gli Stati membri dell’OMC sono divisi in categorie: Stati industrializzati, Stati in via di sviluppo,
Stati meno sviluppati. In base alla qualificazione (spetta comunque agli Stati auto-definirsi in una
delle categorie), cioè al minor grado di sviluppo e industrializzazione dello Stato, si ottengono
deroghe o moratorie nell’applicazione delle norme del “sistema OMC” e agevolazioni commerciali.
Il diritto di recesso dall’OMC è espressamente previsto dal suo Trattato.
4. La risoluzione delle controversie nel sistema OMC
L’Allegato 2 del trattato OMC, il Dispute Settlement Understanding-Intesa sulla risoluzione delle
controversie (DSU), ha formalmente ordinato ed integrato un sistema di risoluzione delle
controversie (che abbiano ad oggetto il trattato dell’OMC e gli accordi commerciali multilaterali
contenuti negli allegati) che esisteva già nel precedente sistema del GATT, sebbene con alcune
significative differenze:
1) il nuovo sistema post-1994 è dotato di un apposito organo, il Dispute Settlement Body
(DSB), chiamato ad amministrare le norme e le procedure del sistema. Il DSB istituisce i
panels e ne adotta le relazioni, vigila sull’applicazione delle proprie decisioni e
raccomandazioni e autorizza la sospensione di concessioni e altri obblighi convenzionali.
2) prima dell’attivazione della fase contenziosa, ampio spazio è dato alla soluzione
“extragiudiziale” della controversia: si richiede, in sostanza, allo Stato di valutare, prima di
presentare ricorso, l’utilità dell’iniziativa giudiziale, cioè la possibilità che la controversia
possa effettivamente risolta “positivamente”. La richiesta valutazione di utilità del
proponendo ricorso è peculiare in un quadro di risoluzione delle controversie: il punto è che
il settore del commercio internazionale, per quanto venga disciplinato giuridicamente e
procedimentalizzato, resta comunque difficilmente inquadrabile negli stessi schemi rigidi e
formali che sono tipici e scontati in qualsiasi altro settore oggetto di formazione.
L’OMC non dispone di poteri coercitivi che effettivamente possono garantire l’esecuzione forzata
della decisione giudiziale nel caso in cui lo Stato non la esegua spontaneamente. E diciamo
effettivamente perché ci riferiamo ad inesistenti meccanismi giuridici che non siano quelli
sanzionatori previsti dal trattato o quelli di pressione politica ed economica esercitabili dagli Stati
nei confronti del recalcitrante di turno.
Qualora i mezzi extragiudiziali non dovessero risolvere la controversia, lo Stato reclamante può
chiedere al DSB la costituzione di un panel che analizza le disposizioni degli accordi commerciali
oggetto della controversia e citati dalla parti in causa. Il panel è costituito di 3 o 5 persone
“qualificate” in materia di diritto e politica commerciale internazionale, indipendenti e, salvo
diverso accordo tra le parti, di nazionalità diversa da quella delle parti controvertenti. Il panel, non
essendo un organo “giurisdizionale” a sé stante, offre, valutando oggettivamente e tecnicamente la
questione, l’expertise tecnico perché poi il DSB possa esercitare le funzioni. Se il panel conclude
che una misura statale è incompatibile con gli obblighi sanciti dagli accordi OMC raccomanda che
lo Stato membro ripristini la conformità del diritto interno al diritto (internazionale) dell’OMC e
può anche suggerire “i modi…per ottemperare a tali raccomandazioni”. Concluso il procedimento,
34
Per la descrizione approfondita degli organi dell’OMC vd. pagg. 572-574.
88
il panel presenta la relazione al DSB perché esso la adotti (salvo respingerla all’unanimità). In sede
di adozione, il DSB formula raccomandazioni o decisioni alle Parti interessate che sono poi
soggette a verifica per ciò che riguarda la loro effettiva applicazione da parte dei destinatari.
Qualora lo Stato presenti appello contro la relazione del panel all’Appelate Body (AB), organo di
appello permanente, esso può presentarlo limitatamente “a questioni giuridiche contemplate nelle
relazioni del panel e alle interpretazioni giuridiche sviluppate dal panel”; poi, l’AB può
“confermare, modificare o annullare le contestazioni e le conclusioni giuridiche del panel”
mediante relazione che il DSB deve adottare.
Una volta adottata la relazione dal DSB, lo Stato interessato ha 30 giorni a decorrere dall’adozione
per informare “il DSB delle sue intenzioni per quanto riguarda l’applicazione delle
raccomandazioni e delle decisioni del DSB” e qualora non possa ottemperare subito, può negoziare
un termine ragionevole.
Dovendo sorvegliare l’applicazione delle sue raccomandazioni, il DSB, in caso di non applicazione
da parte dello Stato di una sua relazione, può autorizzare lo Stato pregiudicato a ricavare una
compensazione (“reciprocamente accettabile”) del danno ricevuto e a sospendere
(provvisoriamente) concessioni o altri obblighi dovuti verso lo Stato inadempiente (c.d.
contromisure compensative).
Eventuali questioni, sollevate dallo Stato che non ha dato esecuzione alle richieste del DSB, relative
alle misure di sospensione sono sottoposte ad arbitrato che si svolge dinanzi al panel originario e
che stabilisce solamente “se il livello di tale sospensione sia equivalente al livello di annullamento o
pregiudizio dei benefici” causato dalla prima misura.
Il sistema di risoluzione delle controversie in ambito OMC è un sistema aperto, disponibile a una
soluzione amichevole e concordata della questione. Tra le principali ragioni di questa impostazione
sta l’obiettivo di favorire, sia con le procedure descritte che con la conciliazione in qualunque
momento, il consolidamento del sistema multilaterale.
5. Le “istituzioni” di Bretton Woods: la Banca Mondiale ed il Fondo Monetario
Internazionale
La regolamentazione del sistema monetario internazionale, ovvero l’insieme delle norme e delle
intese interstatuali che si sono sviluppate per assicurare, mediante accordi, uno svolgimento equo ed
ordinato delle transazioni internazionali” trova origine nella conferenza di Bretton Woods del 1944.
Le due istituzioni, istituti specializzati dell’ONU, che ne scaturirono furono: la Banca
Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD, Banca Mondiale) e il Fondo Monetario
Internazionale.
La Banca Mondiale (BM)35 nacque con lo scopo principale di facilitare la ricostruzione e lo
sviluppo post-bellico fornendo assistenza tecnica e finanziaria ai paesi in difficoltà, sebbene già
rientrasse nei suoi scopi anche quello di promuovere gli investimenti esteri privati, l’equilibrata
espansione del commercio internazionale, di incoraggiare gli investimenti internazionali per lo
sviluppo delle risorse produttive dei membri, etc.
Terminata la fase di ricostruzione post-bellica, la BM si è maggiormente orientata sugli obiettivi di
promozione e sviluppo, tanto che mira a ridurre la povertà mondiale fornendo assistenza tecnica e
finanziaria ai progetti di sviluppo presentati dagli Stati più poveri in molteplici settori.
35
La BM è composta dai seguenti organi: il Consiglio dei Governatori, composto dai governatori nominati dagli stati
membri esercita tutti i poteri della BM e si riunisce annualmente; il Consiglio degli Amministratori esecutivi, composto
da 24 membri, è responsabile della condotta e delle operazioni generali della BM; in base alla delega dei governatori.
89
Oggi, la BM è a capo del c.d. “Gruppo della Banca Mondiale”, composto da altre 4 OI36 che
perseguono complessivamente il fine già indicato di ridurre la povertà mondiale elevando lo
sviluppo dei paesi non industrializzati.
La BM, pur avendo la struttura operativa di un’OI, è organizzata per ciò che riguarda la qualità di
membro e il diritto di voto secondo lo schema delle società di capitali. Il peso del voto dello Stato
dipende dalla quota di capitale sociale della BM sottoscritta, c.d. voto ponderato in funzione dei
parametri economico-finanziari.
Il recesso dalla BM è libero e può avvenire in qualunque momento. In caso di violazione degli
“impegni verso la Banca”, poi, uno stato membro può essere sospeso dall’esercizio di tutti i suoi
diritti con delibera del Consiglio dei Governatori. Se trascorso un anno dalla sospensione la
violazione persiste, lo status di membro della BM cessa automaticamente, fermo restando l’obbligo
di regolare tutti i conti con la Banca.
Al Fondo Monetario Internazionale (FMI)37 furono attribuiti numerosi obiettivi e, in particolare,
due:
1) regolare il meccanismo dei pagamenti internazionali mediante un regime fisso di cambi in
cui valore delle singole monete era fissato rispetto all’oro e in cui il dollaro era considerato
equivalente all’oro, c.d. gold exchange standard;
2) assistere dal punto di vista finanziario gli Stati, in caso di squilibrio della loro bilancia dei
pagamenti con l’estero, intervenendo con le proprie risorse ed evitando l’adozione da parte
dello Stato in difficoltà di misure unilaterali, inevitabilmente restrittive dei flussi finanziari
internazionali.
Il FMI promuove anche la cooperazione monetaria internazionale, facilita l’espansione e l’armonico
sviluppo del commercio internazionale e favorisce l’istituzione di un “sistema multilaterale di
pagamenti per le transazioni correnti fra i paesi membri e l’eliminazione di restrizioni valutarie che
ostacolino lo sviluppo del commercio mondiale”.
L’iniziale gold exchange standard dipendeva dall’impegno, unilateralmente assunto dagli USA, di
convertire in oro i dollari eventualmente presentati dalle banche centrali straniere. Questa
impostazione comportò la necessità che sia il FMI che gli Stati si dotassero di proprie riserve in oro
e dollari. Gli Stati costituirono poi le riserve del FMI versando in oro e in dollari una parte (il resto
in valuta nazionale) della quota di capitale del FMI da loro sottoscritta. Le riserve del FMI erano e
sono impiegate per aiutare gli Stati in difficoltà con la propria bilancia dei pagamenti.
La partecipazione dello Stato membro al FMI è organizzata secondo lo schema della società di
capitali, nel senso che il peso del voto dello Stato varia in funzione dei diritti speciali di prelievo
(DSP) che lo Stato detiene.
La crisi del gold exchange standard provocò due importanti mutamenti, di forma e di sostanza, in
seno al FMI:
1) nel 1969, a fronte del timore che il deficit americano potesse non garantire la conversione in
oro dei dollari presentati dalle banche centrali straniere, si creò un nuovo strumento di
riserva, cioè i c.d. diritti speciali di prelievo (DSR);
2) nel 1971, gli USA revocarono il loro impegno a convertire i dollari in oro, ponendo fine al
regime di cambi fissi: da quel momento in poi, i cambi tornarono a fluttuare liberamente,
seppur nel rispetto di alcune direttive di controllo.
Dopo il 1971, lo Stato poteva decidere di fissare la parità della propria valuta secondo diverse
opzioni: rispetto ai DSP; rispetto alla moneta di un altro stato, mediante fluttuazione congiunta di
due o più monete “agganciate” tra loro, etc.
36
Le OI del Gruppo della Banca Mondiale sono: l’IDA, Associazione internazionale per lo sviluppo, strettamente
complementare alla BM; l’IFC, Società finanziaria internazionale; il MIGA, Agenzia multilaterale di garanzia degli
investimenti; l’ICSID, Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti.
37
Gli organi principali del FMI sono: Consiglio dei Governatori; Comitato esecutivo; Direttore Generale.
90
La riforma del FMI post-1971 prevede l’obbligo per gli Stati “di collaborare col FMI e con gli altri
paesi membri al fine di garantire regolari accordi di cambio e promuovere un sistema stabile di tassi
di cambio” per il raggiungimento dello scopo essenziale e del principale obiettivo del sistema
monetario internazionale.
Il recesso (ritiro volontario) dello Stato membro dal FMI è libero ed attuabile in qualsiasi
momento. Il FMI può sospendere uno stato nel momento in cui esso venga meno “ad uno qualsiasi
degli impegni assunti in base allo statuto” dal diritto di usare le risorse generali del Fondo ma non
anche dal diritto di voto negli organi. Se, trascorso un “ragionevole periodo di tempo” dalla
dichiarazione di decadenza, lo Stato continua a “non adempiere ad alcuno degli impegni assunti”,
allora il FMI può, a maggioranza del 70% dei voti, sospendere anche il diritto di voto. Se, trascorso
un ulteriore “ragionevole periodo di tempo”, lo Stato sospeso nei suoi diritti “persiste nel “non
adempiere ad alcuno degli impegni assunti”, allora potrà essere “invitato” a ritirarsi dal FMI (c.d.
ritiro obbligatorio), a maggioranza dell’85% dei voti.
6. Cenni sul diritto allo sviluppo
A partire dalla fine della decolonizzazione, i PVS hanno promosso e modellato una parte
sostanziale della complessiva disciplina giuridica delle relazioni economiche internazionali. In
particolare la riaffermazione della nozione di sovranità economica, ovvero la sovranità permanente
ed inalienabile dello Stato sulle proprie risorse naturali ed il diritto di sfruttarle economicamente.
Con la fine del colonialismo, la sovranità economica diventa, quindi, il diritto di controllare e
gestire le proprie risorse economiche e si associa strettamente al diritto di sviluppo dello stesso
paese, così come definito nella Dichiarazione sul diritto allo sviluppo contenuta in una risoluzione
dell’ONU del 1986.
Definire i limiti ed i contenuti giuridici dello status economico di uno stato nell’ordinamento
internazionale è una questione complessa perché la maggior parte delle enunciazioni e dei principi
in sul punto sono contenuti all’interno di strumenti non giuridicamente vincolanti.
Il diritto allo sviluppo definito come il diritto per lo Stato di nazionalizzare o espropriare le attività
economiche condotte da imprese straniere sul proprio territorio ed il sistema delle preferenze
generalizzate. Esso trova un’organica sistemazione nella Dichiarazione del 1986, che rappresenta
una sorta di codificazione di una serie di elaborazioni e concetti, politici e giuridici, che sin dalla
nascita dell’ONU erano stati affermati sulla scena internazionale.
Lo “sviluppo” è definito come un “comprensivo processo economico, sociale, culturale e politico,
che mira al costante miglioramento del benessere dell’intera popolazione e di tutti gli individui sulla
base della loro attiva, libera e significativa partecipazione allo sviluppo e all’equa distribuzione tra
benefici che ne derivano”. In generale, molti degli obblighi derivanti dalla Dichiarazione hanno
carattere programmatico.
Nel loro processo di creazione e rafforzamento del c.d. capacity development, vale a dire la capacità
di programmare ed attuare le proprie politiche di sviluppo, i PVS sono affiancati e assistiti dal
Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP). La sua attività presenta la particolarità di
offrire allo Stato assistito un’ampia gamma di servizi e di rappresentare anche un tramite tra
investitori stranieri e autorità locali.
Per quel che riguarda la speciale disciplina giuridica dei PVS in alcuni casi o settori, analizziamo
lo status giuridico dei PVS nel DI, in riferimento al tema delle nazionalizzazioni e al sistema di
preferenze generalizzate.
Nel caso di nazionalizzazione da parte di uno stato di interi settori della propria economia o di
singole imprese, così come nel caso in cui lo Stato proceda ad espropriare beni o attività di persone
fisiche o giuridiche straniere presenti ed operanti sul proprio territorio, il punto riguarda il ristoro
91
economico che deve essere garantito a chi è rimasto vittima della nazionalizzazione o
dell’espropriazione: se e quanto debba essergli corrisposto e a che titolo.
La prassi è ormai certa sulla necessità di corrispondere una somma, mentre è molto più incerta sulla
quantità. Inizialmente si era orientati verso un indennizzo che fosse appropriato, rimettendo poi allo
stesso stato nazionalizzante o espropriante la risoluzione delle controversie eventualmente originate
dalla sua azione. Negli anni successivi, però, la prassi, se possibile, divenne più incerta, anche in
conseguenza dei forti contrasti politici ed economici tra stati industrializzati e PVS, facendo
prevalere una duplice tendenza:
- a livello procedurale, si cerca di precostituire affidabili meccanismi di risoluzione delle
controversie, evitando azioni unilaterali;
- maggiore attenzione alla tutela dei diritti dell’individuo, quantificando l’indennizzo in
maniera molto più vicina al valore effettivo del bene “colpito” dalla misura statale.
Il sistema delle preferenze generalizzate, allo scopo di favorire lo sviluppo dei PVS attraverso un
miglior accesso ai mercati degli Stati industrializzati, garantisce tariffe doganali agevolate, in
deroga alla clausola della nazione più favorita. Ogni stato industrializzato può quindi divenire un
preference-giving country a favore di un certo numero di PVS beneficiari. Importanti modifiche al
sistema si sono avute con l’individuazione in seno ai PVS dei c.d. paesi meno sviluppati (LDC) che
ha determinato un’ulteriore distinzione nel trattamento tariffario riservato a questi ultimi.
7. L’International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)
L’ICSID, il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti,
è una struttura permanente istituita nel 1965 con un trattato multilaterale, che eroga servizi di
arbitrato e conciliazione per la risoluzione delle controversie tra stati e investitori esteri relative ad
investimenti operati da questi ultimi nel territorio dello Stato parte al trattato istitutivo dell’ICSID.
Il suo obiettivo è quello di risolvere le controversie dinanzi a un tribunale arbitrale “internazionale”
evitando che il loro protrarsi o il loro degenerare determini danni significativi al commercio
internazionale, scoraggiando di riflesso gli investimenti internazionali che hanno un ruolo
fondamentale nel promuovere lo sviluppo economico mondiale.
L’ICSID si serve per assolvere ai suoi compiti di una struttura permanente composta dal
Segretariato e dal Consiglio di Amministrazione.
Per essere sottoposta all’arbitrato o alla conciliazione dell’ICSID, la controversia deve essere
giuridica, riguardante un investimento e coinvolgere uno stato parte alla Convenzione e un
investitore che abbia la nazionalità di un altro stato parte.
La giurisdizione dell’ICSID non è automatica, ma è necessario che, una volta sorta la controversia,
le parti manifestino per iscritto la volontà di sottoporla all’ICSID. Una volta dato il consenso, non è
più possibile revocarlo unilateralmente e il lodo arbitrale, oltre che vincolante per le parti, deve
essere anche riconosciuto ed eseguito da qualunque stato parte all’ICSID, secondo la propria
disciplina in tema di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere eprevia presentazione di
una copia certificata del lodo.
Elemento essenziale del sistema ICSID sta nell’impossibilità per lo Stato di nazionalità
dell’investitore coinvolto nella controversia di agire in protezione diplomatica, a meno che l’altro
stato non si rifiuti di eseguire il lodo ICSID. Infine, la contumacia di una parte non impedisce al
Tribunale di emettere il lodo.
92
CAPITOLO XIII – IL DIRITTO INTERNAZIONALE DELL’AMBIENTE
1. La Dichiarazione di Stoccolma del 1972 e lo United Nations Environmental Programme
La disciplina giuridica internazionale dell’ambiente, intesa come norme a tutela dello “spazio
vitale” che garantisce “la qualità della vita e la completa salute degli esseri umani, includendo le
generazioni non ancora nate”, è un fenomeno relativamente recente nella vita di RI degli Stati.
È solo con gli anni ’70 che la CI comincia ad affrontare il tema dell’ambiente da un punto di vista
organico ed onnicomprensivo con i vertici di Stoccolma del 1972 e di Rio del 1992.
Il benefico effetto dei grandi “Vertici per la Terra” di Stoccolma e Rio fu quello di innescare una
laboriosa attività di formazione internazionale che, negli anni successivi, condusse alla stipula di
numerose convenzioni e all’emersione del c.d. principio dello sviluppo sostenibile.
Il risultato, dunque, fu il consolidamento, nel DI consuetudinario, dell’obbligo per lo Stato di
garantire che le attività svolte sotto la propria giurisdizione e controllo non pregiudicassero
l’ambiente degli altri stati o delle aree non soggette alla sovranità degli Stati.
La Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano di Stoccolma del 1972, cui parteciparono
113 stati, portò all’adozione di un Piano di azione per l’ambiente umano e, soprattutto, di una
Dichiarazione sull’ambiente umano che fissò una serie di principi e linee guida politiche in materia
ambientale che gli Stati si impegnavano a seguire ed attuare sia a livello internazionale che
nazionale. I 26 principi della Dichiarazione nacquero come statuizioni politiche senza alcun valore
giuridicamente vincolante, anche se una parte di esse si è tradotta col tempo in norme
internazionali.
Uno dei risultati più significativi della Conferenza fu la raccomandazione rivolta all’AG di creare
un organo che si occupasse in modo permanente e strutturato del tema ambientale.
Nel 1972 l’AG creò come suo organo sussidiario il Consiglio direttivo del Programma Ambientale
delle Nazioni Unite (UNEP), chiamato a controllare, dirigere e gestire i programmi ambientali
ONU. L’UNEP è una struttura che da un punto di vista tecnico-operativo si occupa della gestione
dei programmi, dei fondi e dei trattati ambientali conclusi sotto l’egida dell’ONU; il Consiglio
direttivo svolge il controllo politico-finanziario sulle attività dell’UNEP.
Uno sviluppo nella promozione e nel consolidamento del DI sull’ambiente fu dato dalla
Convenzione CITES del 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora a rischio
di estinzione dove meglio si delineava il nesso tra ambiente e sviluppo.
Si delineò quindi il concetto di sviluppo sostenibile, principale nozione giuridica di riferimento per
al normativa ambientale internazionale e nazionale, ma che cerca anche di essere un approccio
politico e culturale per affrontare, in modo integrato, i molteplici aspetti che si legano alla necessità
di progredire e migliorare la qualità della vita.
2. Lo sviluppo sostenibile e la Dichiarazione di Rio del 1992
Il c.d. Rapporto Bruntland del 1987 definiva lo sviluppo sostenibile come “un processo di
cambiamento in cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento
dello sviluppo tecnologico ed i cambiamenti istituzionali sono tutti in armonia e rafforzamento del
potenziale attuale e futuro per rispondere ai bisogni umani e alle aspirazioni umane”.
Nel 1992 a Rio de Janeiro fu convocata la Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo
sviluppo (UNCED) cui parteciparono 183 stati.
I risultati della UNCED testimoniano che l’evoluzione del DI ambientale nel ventennio 1972-1992
va ricostruita secondo due direttrici principali:
93
1) la più puntuale definizione delle tematiche ambientali così da orientare e focalizzare meglio
gli sforzi della CI;
2) la trasformazione di alcuni enunciati politici in norme giuridiche a conferma di
un’evoluzione della coscienza giuridica collettiva degli Stati sui temi dell’ambiente.
I principali risultati furono una maggior definizione in dettaglio della nozione di sviluppo
sostenibile, la Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, la Dichiarazione sulle foreste e la
c.d. Agenda 21.
La Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo38 enuncia 27 principi che, seppur contenuti in
uno strumento non vincolante, sono divenuti nel tempo criteri informatori di carattere generale della
successiva disciplina giuridica.
L’Agenda 21, il Piano d’azione per il XXI secolo, è un documento programmatico non vincolante
adottato dalla UNCED, che rappresenta l’ambizioso tentativo di pianificare le linee di crescita
ambientale, sociale ed economica dell’intera umanità secondo il già indicato approccio integrato,
multidisciplinare e di lungo termine.
3. La Convenzione-quadro sul cambiamento climatico ed il Protocollo di Kyoto
La UNCED portò anche alla firma di due importanti trattati:
- la Convenzione-quadro sul cambiamento climatico: essa fissa un’articolata serie di
obblighi il cui obiettivo è quello di “stabilizzare…le concentrazioni di gas ad effetto serra”
definiti come “i gas di origine naturale o prodotti da attività umane che fanno parte
dell’atmosfera e assorbono e riflettono i raggi infrarossi nell’atmosfera” terrestre, così da
evitare che le attività umane che generano tali emissioni producano “qualsiasi pericolosa
interferenza” sul sistema climatico, determinandone cambiamenti artificiali. Il principio
della responsabilità comune ma differenziata è il perno dell’intera Convenzione.
- la Convenzione sulla diversità naturale.
Nel 1997, ritenendo insufficiente l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra stabilito dalla
Convenzione-quadro, venne firmato a Kyoto il Protocollo alla Convenzione-quadro, il c.d.
Protocollo di Kyoto. Esso impegna i paesi industrializzati a ridurre, nel periodo 2008-2012, le
emissioni di almeno il 5% al di sotto dei livelli del 1990 allo scopo di invertire la tendenza e
diminuire complessivamente le emissioni di questi gas a livello mondiale.
I numerosi obblighi imposti dal Protocollo sono modulati in funzione del principio della
responsabilità comune ma differenziata e, quindi, variano in funzione del grado di sviluppo
economico e della capacità inquinante dello Stato, fissando in pratica impegni di limitazione e
riduzione delle emissioni nocive solo per i paesi industrializzati.
Il Protocollo di Kyoto introduce il sistema delle unità di riduzione delle emissioni e a ciascun
paese è assegnata una quota di riduzione da raggiungere. Attraverso il c.d. emission trading
mechanism, è possibile “commerciare” con gli altri paesi le unità di riduzione acquistandole o
vendendole.
In vista della scadenza, nel 2012, del primo periodo di riduzione globale delle emissioni nocive
previsto dal Protocollo di Kyoto, nel 2007 si è tenuta a Bali la Conferenza delle Nazioni Unite sul
cambiamento climatico, in cui si è stabilito un piano di azione biennale, c.d. Bali roadmap, che
prevede, tra le altre, un meccanismo di finanziamento a favore dei paesi tropicali per la salvaguardia
delle loro foreste e nuovi impegni in punto di riduzione delle emissioni e trasferimento di tecnologia
“pulita” ai PVS.
38
Per i principi più rilevanti in essa enunciati vd. pgg. 615-617.
94
4. La Convenzione sulla biodiversità ed il Protocollo di Cartagena
La Convenzione sulla biodiversità ha come obiettivo fondamentale la conservazione della diversità
biologica, “l’uso durevole dei suoi componenti e la ripartizione giusta ed equa de benefici derivanti
dall’utilizzazione delle risorse genetiche”. Essa è volutamente generica e si applica a tutte le
componenti della diversità biologica che si trovino in zone sotto giurisdizione di uno stato parte e a
tutte le attività ed i procedimenti realizzati sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato parte.
Questa impostazione e l’assenza di una lista delle componenti della diversità biologica protette
dovrebbe favorire una tutela quanto più onnicomprensiva. Anche se tale genericità contenutistica
degli obblighi previsti rischia di indebolire la portata precettiva dell’impianto normativo.
Nel 2000, in ottica di cooperazione, è stato adottato il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza,
il cui obiettivo è quello di proteggere in maniera adeguata “il trasferimento, la manipolazione e
l’uso sicuro degli organismi viventi modificati” per mezzo della tecnologia, c.d. OGM organismi
modificati geneticamente, onde evitare che si producano effetti negativi per la conservazione e
l’uso sostenibile della diversità biologica, oggetto della Convenzione del 1992.
Esso si basa sull’approccio precauzionale, per cui a fronte di dubbi e di contrasti scientifici
sull’esatta valenza e pericolosità degli OGM, il principio che deve guidare le azioni degli Stati è di
agire con cautela e, quindi, di non addurre a motivo di inazione la mancanza di certezza scientifica
se si palesa un possibile rischio per la diversità biologica.
Per facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati sui prodotti OGM e sulle normative nazionali
vigenti in materia, è istituito il Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza allo scopo di
assitere gli Stati nell’attuazione del Protocollo.
Gli impegni sulla biodiversità sono stati solennemente riconfermati durante il G-8 del 2009 a
Siracusa, all’esito del quale i 19 ministri dell’ambiente riunitisi hanno adottato la Carta di Siracusa
sulla biodiversità.
5. La “democrazia ambientale” ed il Vertice di Johannesbourg del 2002
La c.d. “democrazia ambientale” è intesa come la partecipazione consapevole ed informata dei
cittadini ai temi ambientali da concretizzarsi sia in un adeguato accesso alle informazioni
concernenti l’ambiente in possesso delle pubbliche autorità, sia nella possibilità di partecipare ai
processi decisionali.
Il tema della democrazia ambientale come prefigurato dalla Dichiarazione di Rio ha assunto
comunque un rilievo giuridico nel DI ambientale grazie alla disciplina organica approntata dalla
Convenzione di Arhus del 1998, sull’accesso alle informazioni, la partecipazione al pubblico ai
processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
Il terzo grande Vertice internazionale sull’ambiente si tenne a Johannesbourg nel 2002 e fu
dedicato allo sviluppo sostenibile. Tuttavia vi fu una diffusa insoddisfazione sui modesti risultati
concreti raggiunti dalla conferenza.
Sui temi al centro dei lavori, considerati essenziali alla promozione di un modello globale di
sviluppo sostenibile, gli Stati non sono riusciti a trovare accordi sufficientemente specifici e, tanto
meno, a concludere trattati vincolanti.
Concludendo, negli ultimi 40 anni il settore si sta progressivamente giuridicizzando e alcune
enunciazioni politiche non vincolanti contenute delle Dichiarazioni di Stoccolma e Rio si sono
tradotte in norme vincolanti. La normativa ambientale è, però, caratterizzata da una diffusa
genericità degli obblighi e da un grado di attuazione per certi versi non adeguato ai rischi che
concretamente si palesano per l’ecosistema.
Le esigenze economiche degli Stati prevalgono su quelle ambientali condizionando fortemente le
scelte politiche al momento di scrivere le norme ambientali. Su questo già complesso quadro di
posizioni e relazioni economiche internazionali si innestano le rivendicazioni dei PVS.
95