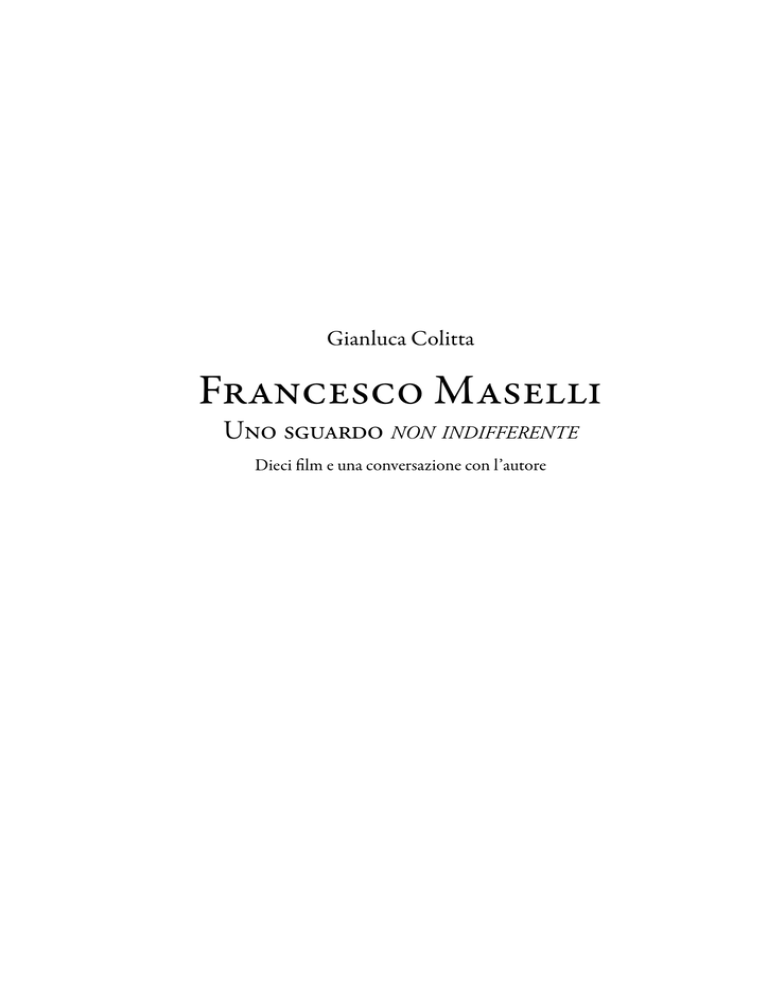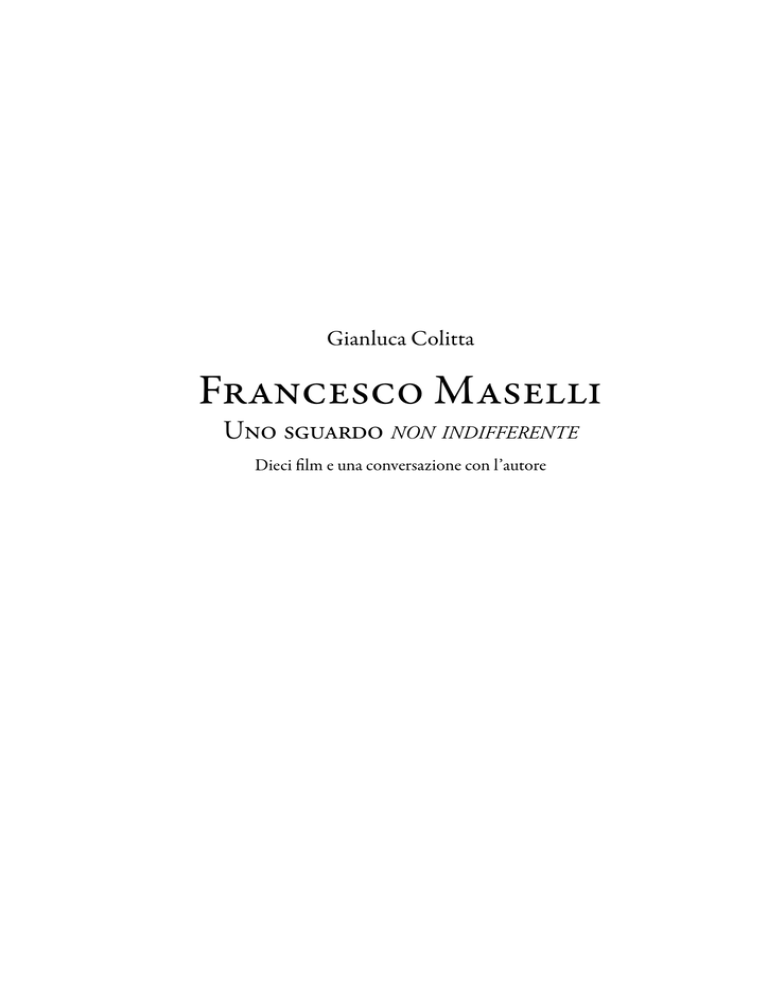
Gianluca Colitta
Francesco Maselli
Uno sguardo NON INDIFFERENTE
Dieci film e una conversazione con l’autore
Prefazione
di Domenico Monetti
Mentre sto scrivendo questo invito alla lettura di questo bel volume del regista e studioso Gianluca Colitta, il caso vuole che veda il
toccante documentario di Massimo Mida La metropoli di Titina Maselli (1969). Per delle strane coincidenze che accadono tra spettatore
e schermo, osservando Titina passeggiare e raccontarsi per le strade
di Roma – e per l’esattezza a Campo de’ Fiori – ho visto in quel viso,
in quegli occhi, il suo fratello regista. Io che non ho mai conosciuto
Francesco Maselli se non di sfuggita a una presentazione di un libro
di Goliarda Sapienza, mi è sembrato di averlo incontrato intimamente
negli anni Sessanta e Settanta, come in una sorta di ipotetico e fantascientifico viaggio nel tempo. Lo stesso strano fenomeno l’ho “vissuto”
leggendo Francesco Maselli. Uno sguardo non indifferente. Dieci film e
una conversazione con l’autore, perché non è solo un libro di cinema
come se ne scrivono ormai tanti, troppi, tanto da creare la triste conseguenza di avere una sproporzione notevolissima tra chi scrive e chi
legge, ma una briosa, spiritosa e intensa conversazione tra un regista
ormai affermato e uno giovane, che non ha ancora realizzato dei lungometraggi, ma dei cortometraggi molto interessanti. Il volume è diviso
sostanzialmente in due parti: una di analisi dei film – e il merito di
Colitta è di non trattare tutto il cinema di Maselli, ma solamente dieci
film, dieci film in cui si vede meglio l’evolversi o il devolversi dei percorsi tematici e stilistici dell’autore – e una seconda costituita da una
lunga conversazione. Ebbene, anche nella parte teorica sembra che la
scrittura di Colitta voglia ingaggiare idealmente una conversazione sia
con Maselli che con il lettore. Più che pagine di cinema, sono pagine
di amore, di sentimento, di passionalità nei confronti in primis della
donna e sul modo di rappresentarla eticamente sullo schermo. Colitta
descrive i movimenti di macchina non per semplice esibizionismo tecnico, ma per raccontarci l’etica dello sguardo maselliano, attento a costruire dei personaggi femminili a 360 gradi, molto più avanti rispetto
a certe ottusità e miopie maschili. Questo formarsi progressivo, film
dopo film, di un personaggio femminile a tutto tondo corrisponde alla
maturazione non solo registica, ma anche umana, di Maselli. Colitta
sottolinea spesso questo aspetto con una sensibilità rara nel mondo
asfittico della critica cinematografica. Questa “soggettiva al femminile” è evidente nella cosiddetta “Trilogia esistenzialista dell’uomo” (Storia di Caterina, ultimo episodio di Amore in città, 1953; Gli sbandati,
1955; i Delfini, 1960; Gli indifferenti, 1964) per poi approfondirsi
maggiormente nel suo ritorno al cinema con il “Ciclo intimista della donna” (Storia d’amore, 1986; Codice privato, 1988; L’alba, 1991),
dopo il periodo politico in cui il regista, attraverso film come Lettera
aperta a un giornale della sera (1970) e Il sospetto (1975), ha realizzato
una sorta di terapia psicoanalitica sulla natura ossimorica di essere intellettuali e comunisti negli anni Settanta. Ma anche il suo recente Le
ombre rosse (2009), per quanto rientri nel cosiddetto cinema politico,
ci regala una speranza di futuro nel volto e nei corpi di giovani donne
idealiste. Penso che tutti i film di Citto siano di un’epicità gloriosa e
straziante proprio per il suo non darsi autobiograficamente al cinema,
se non nelle vite (inventate?) di altri… riassumendo ontologicamente
la natura del cinema, ovvero quella di mostrare, registrare, narrare le
nostre vite, i nostri volti, fantasmi sovrimpressi alle facce e alle esistenze degli altri. E se il capolavoro di Maselli rimane Gli indifferenti, credo
che il cinema nel quale abbia sperimentato di più sia proprio quello degli anni Ottanta, in cui esiste un’autorialità più precisa, un “codice Maselli”. Se nei film di inizio anni Sessanta Maselli si fondeva felicemente
con certo cinema di Antonioni, ma anche con il Damiano Damiani
del Rossetto (1960), La noia (1963), con il Valerio Zurlini della Ragazza con la valigia (1961), Cronaca familiare (1962), con il Carlo Lizzani
della Vita agra (1964) e con l’esordio di Eriprando Visconti (Una storia milanese, 1961), l’autore acquista una personalità tutta sua proprio
con gli anni Ottanta, dopo cioè aver sperimentato altri linguaggi come
quello della televisione. (Ri)vedere Storia d’amore, Codice privato, ma
anche i film del decennio successivo come Il segreto, L’alba e Cronache del Terzo Millennio significa ripensare e quindi anche riscrivere un
certo cinema italiano e certi autori, che coraggiosamente hanno con
coerenza portato avanti una poetica e un’estetica, discutibili finché si
vuole, ma perfetto riflesso e metafora di un paese mancato chiamato
Italia, sfidando spesso e volentieri le sale vuote con un pubblico sempre
più distratto dai vari Drive In televisivi. Piaccia o non piaccia – e a me
piacciono! –, registi come Francesco Maselli, Peter Del Monte, Salvatore Piscicelli, Silvano Agosti, Nico D’Alessandria ma anche il Paolo
10
Breccia di quel gioiellino invisibile chiamato Cena alle nove (1991) e
il Pasquale Squitieri degli Invisibili (1988) e Il colore dell’odio (1989)
hanno rappresentato una scena molto più poliedrica, più viva nelle sue
riflessioni minimali e ombelicali rispetto al consueto cinema ufficiale e
ai cosiddetti “nuovi comici”.
In questo libro troverete poco del Maselli politico e tanto di quello
umano e cinefilo, con un giovane regista che controbatte, dice la sua,
senza farsi soffocare dal carisma maselliano. Il merito maggiore di
questo volume è quello di trasmettere vita vissuta, come gli entusiasmi
nel discutere per ore e ore di una determinata inquadratura o di un certo
movimento di macchina e se il tutto risulta eticamente accettabile, un
po’ come si faceva un tempo… Impossibile non ricordare le polemiche
rivettiane e daneyane. In questi tempi liofilizzati e svuotati di ogni se e
di ogni ma, scusate, ma non è poco.
Premessa
Francesco Maselli, classe 1930, oltre sessanta film all’attivo fra lunghi, corti e documentari, è stato l’enfant prodige del cinema italiano ed
è, a oggi, una delle voci storiche del nostro panorama cinematografico.
Regista esistenzialista, politico, sempre impegnato e sempre partigiano, a tratti polemico, attento ai dettagli della luce e dell’immagine,
preoccupato della dimensione sociale delle cose, infaticabile membro
anac.1
Aderente alla Resistenza appena quattordicenne, nascondendo le
armi dei gap in casa; membro del pci a 15; iscritto al Centro Sperimentale di Cinematografia a 16; amico e collaboratore di Michelangelo Antonioni e di Luchino Visconti; autore di documentari, belli e
intensi, che gli hanno dato prestigio, mestiere e occhio registico.
La sua carriera è cominciata ufficialmente nel 1948 ed è arrivata
fino ai giorni nostri – Sciacalli, episodio del film collettivo Scossa,2 è
del 2011. Ottantadue anni nel dicembre del 2012 e sessantatré anni di
attività. Non sono pochi.
Questo lavoro nasce nel 2007 come tesi di laurea. È poi proseguito
nel corso degli anni come ricerca personale, fino a oggi in cui ha
incontrato uno sbocco editoriale.
L’anac è la storica Associazione Nazionale degli Autori Cinematografici. Fino a
qualche anno fa unica rappresentante dei registi, oggi le si sono affiancate altre sigle.
La più conosciuta è quella dei 100autori, presieduta da Andrea Purgatori. Sarebbe
bello vederle nuovamente riunite sotto un unico movimento. È questo il momento,
vista la particolare, stringente, complessa situazione della politica culturale italiana
(e mi verrebbe da dire non solo italiana).
2
Oltre al cortometraggio di Maselli, di Scossa fanno parte anche Speranza di Carlo Lizzani, Lungo le rive della morte di Ugo Gregoretti e Sembra un secolo di Nino
Russo.
1
Due gli intenti del volume. Tracciare da un lato, pur con tutte
le lacune di una prima, ancora sommaria disamina delle opere
maselliane, un bilancio;3 arrivare, dall’altro, ad aprire nuovi varchi
esplorativi d’indagine. Perché se è vero, come è vero, che Maselli è
stato soprattutto regista politico, impegnato, ideologico, e come tale
è sempre stato considerato, è altresì vero che di lui si sono trascurate,
almeno in seguito, altre linee. Linee inquiete, di ricerca. Linee che
inducono a fare una lettura filosofica nuova dei suoi film. Lettura
peraltro qui solo accennata, non del tutto esaurita, ma che spero possa
essere seme e prodromo di nuove e più fertili ricerche. Ed è questo il
motivo per cui, del Maselli politico, quello più conosciuto, ho deciso
di occuparmi meno. E però di dire pur qualcosa, di fare dei brevi cenni
nel capitolo dedicato al polittico politico (Lettera aperta, Il sospetto,
Le ombre rosse), perché mi pare che, pur con le dovute differenze nei
risultati, tutti questi film dicano molto anche del pantano politico e
culturale attuale.
Tuttavia credo che il suo cinema, la sua dimensione estetica abbiano
pagato lo scotto di essere stati anche fortemente ideologici. E per
responsabilità diretta del suo autore, peraltro. Sostengo l’importanza
poetica, innanzitutto, dei suoi lavori, estetica e filosofica. È da qui che
bisogna ripartire, forse.
Per molti virtuosistico, per alcuni accademico,4 per me semplicemente un cineasta che ha saputo operare con lo sguardo. Uno sguardo
che ha saputo farsi pensiero. Con il “dono di inventare l’espressione di
ciò che ha da dire, o da mostrare” (Antonioni).
Non ci sono intenti di esaustività, né potrebbero esserci. Ho diviso
il libro sostanzialmente in due parti. La seconda è una lunga conversazione che ho avuto con lui fra il 2007 e il 2008 e i primi mesi del 2011
sul cinema e non solo (letteratura, pittura, politica); la prima parte è,
Da quel che mi risulta, non ci sono monografie su Maselli, eccetto i libri che Stefania Parigi e Giacomo Gambetti gli hanno dedicato e quelli curati da Lino Micciché
e da Mino Argentieri.
4
“Virtuosistico”, “accademico”, “calligrafico”, e poi anche “di maniera”, “educato”, “di
bella fattura”, “estetizzante”, “formalista”, “aristocratico della regia” sono definizioni
che qualche volta m’è capitato d’incontrare nelle recensioni, nuove e vecchie, ai suoi
film.
3
invece, un tentativo contemporaneamente interpretativo e tassonomico di alcuni suoi film.
Roma, novembre 2012
Gianluca Colitta
Maselli è regista che sta crescendo. Certo, non tutto è perfetto, qua e
là c’è un po’ di retorica, un qualche eccesso di tono (penso in particolare
all’arrivo, nel sottofinale, della contessa, a quello dei tedeschi con le
motorette, al dialogo fra madre e figlio), ma il tutto scorre, soprattutto
dal punto di vista della messinscena e della capacità di “vedere”, che
è poi la cosa più importante per un autore. Maselli ha il dono della
sintesi visiva e del gusto figurativo ed è cosa che gli consentirà di farsi
perdonare, per noi estimatori di lui, certe sceneggiature meno riuscite.
Va ricordato inoltre come questo primo film, scritto con
Eriprando Visconti (da una sua idea) e da Aggeo Savioli (futuro
critico cinematografico e teatrale dell’“Unità”) sia un film dalla forte
connotazione politica. Mi pare che dall’analisi fin qui condotta non
sia uscita degnamente la questione. C’è una battuta in particolare
molto interessante, pronunciata da un bracciante quando arrivano gli
sfollati, durante un piccolo battibecco con qualcuno: “Fino al 25 luglio
anche lei ho visto col distintivo!”; è una battuta non fondamentale,
importante perché connota il periodo, la dimensione degli eventi, ma
non necessaria ai fini di una progressione drammaturgica. Eppure ha
il pregio di dire tanto, di porre l’accento su un problema che con ogni
evidenza l’autore sente o ha sentito molto da vicino. Quest’altro côté, il
politico-ideologico, è, accanto a quello estetico, costitutivo di Maselli,
in linea col primo Visconti. La combinazione fra i due, vedremo, non
sempre riuscirà (si guardi Cronache del Terzo Millennio), ma ha il
merito, quando è indovinata, di dar luogo a belle sperimentazioni visive
e di porre grossi interrogativi (penso a Lettera aperta e al Sospetto). Va
detto che è quasi impossibile separare i due lati, sono tutt’uno nella
personalità dell’autore, pur se con qualche contraddizione, pur se a
volte i suoi film si pongono in contrasto (cercato o no, involontario o
meno) con l’ideologia cui il nostro si rifà.
i Delfini (1960)
i Delfini è un nuovo passo verso l’esistenzialismo, verso la vivisezione
di una classe e lo scandaglio psicologico, pure della figura femminile –
o forse soprattutto, per quel che ci interessa. È, in definitiva, un nuovo
capitolo di questa interessante variazione che Maselli conduce intorno
agli Indifferenti di Moravia. Mancano ancora quattro anni a quel
suo capolavoro che lo renderà celebre e soprattutto definitivamente
autore, tuttavia questo film è meglio, più maturo, più compatto del
precedente.
Scritto da Maselli, da Ennio De Concini, ancora dall’amico Aggeo
Savioli e proprio da Alberto Moravia, il film racconta la vita dei figli
degli industrialotti, dei rampolli di buona borghesia ricca che consuma
il proprio vuoto provinciale fra una festa e un giochino, e quella di
chi, questa vita, la sogna soltanto, perennemente ostacolata da un
muro, da una invalicabile barriera che separa i delfini dal resto del
mondo. I primi sono Anselmo, sua sorella Elsa, la sua donna Marina, la
contessina Cheré e Alberto De Matteis; i secondi, Fedora32 e sua madre;
a far poi da trait d’union fra gli uni e gli altri, la figura del dottore,
Mario Corsi, per nulla affascinato dalla possibilità di superare quel
muro (possibilità peraltro fattasi concreta già all’inizio della storia,
per via dell’interesse suscitato nella contessina Cheré) e innamorato
della sua affittacamere, Fedora. Un gioco maldestro, una impudica
scommessa aprono un varco fra un mondo e l’altro, avvicinano
Alberto e Fedora e segnano più o meno l’inizio di una girandola
quasi diabolica, di un vortice di cadute morali, di smascheramenti, di
consapevolezze fragili, di tentativi di riscatto e di definitive sconfitte,
prima di rientrare, più annoiati di prima, ciascuno nei propri ranghi,
ciascuno nella propria vita già inesorabilmente segnata. Ed è proprio
32
Non ne ho mai parlato esplicitamente con Maselli, ma non credo di sbagliarmi nel
ritenere che il nome Fedora derivi direttamente dall’opera omonima di Victorien
Sardou. Fedora Romazoff è una donna dai forti tratti: vendicativa, affascinante, irosa. Vuol vendicare la morte del suo amato sposo Vladimir, ma si innamora del carnefice, Loris; vuol far credere di saper gestire una situazione intricata, ma ben presto vi
si trova risucchiata e vittima lei stessa fino a morirne.
La Fedora di Sardou ha in comune con la Fedora di Maselli probabilmente una certa
passionalità – che nell’opera lirica è naturaliter più accesa (sebbene non credo sia
solo un fatto di mezzo artistico utilizzato), mentre nel film è più spenta – e direi anche un certo senso di colpa e di drammatica accettazione della propria condizione di
cui è causa, che porterà la prima al suicidio e la seconda alla rassegnazione; entrambe, infine, portano alla rovina un uomo che le ama, che loro ignorano e che hanno
valutato diversamente, salvo ravvedersi nel finale, quando tutto è ormai compiuto
e a loro non resta che prenderne atto e portare ogni cosa verso le ultime estreme,
tragiche conseguenze.
questo aspetto a essere molto interessante, questo scacco che sembra
esserci nel film e che è una caratteristica peculiare del primo Maselli,
del Maselli di questa trilogia esistenziale dell’uomo. Un aspetto che
lo avvicina molto a Sartre,33 per il tramite di Moravia, che lo avvicina
a Montale, a Ungaretti.34 Un fatto, questo precipuo dello scacco,
che sembra invece allontanarlo dal marxismo classico o per lo meno
metterlo in contraddizione. Mi rendo conto quanto possa apparire
strano sostenere una tesi di questo tipo a proposito di un regista
come Francesco Maselli, da sempre conosciuto per il suo impegno a
sinistra. Tuttavia non posso fare a meno di evidenziare il mio dubbio
dettato da una mera osservazione delle prime tre opere. C’è in esse
una progressiva discesa verso il nulla dell’inazione, verso il vuoto del
pensiero che blocca e impedisce di agire.35 Tutto visto non in un’ottica
33
Anche se a un aspetto particolare di Sartre. E però non è un caso che il filosofo
francese abbia più volte confidato di essersi ispirato proprio a Moravia e al suo Gli
indifferenti nella concezione della Nausea, ricavandone certo poi altro, soprattutto
liberandosi disinvoltamente della maglia della struttura narrativa e trasferendo il suo
pensiero in pagine romanzesche di rara intensità.
34
Negli sguardi persi e perduti, nella azioni “bloccate” di Andrea, di Anselmo e di
Michele risuonano i lampanti versi ungarettiani: “Tra un fiore colto e l’altro donato
/ l’inesprimibile nulla” (G. Ungaretti, Eterno, ivi, p. 5).
35
“Essere, o non essere, è questo che mi chiedo: / se è più grande l’animo che sopporta / i colpi di fionda e i dardi della fortuna insensata, / o quello che si arma contro un
mare di guai / e opponendosi li annienta. Morire… dormire, / null’altro. […] / […]
Così / la coscienza ci rende codardi, tutti, / e così il colore naturale della risolutezza /
s’illividisce all’ombra pallida del pensiero / e imprese di gran rilievo e momento / per
questo si sviano dal loro corso / e perdono il nome di azioni” (W. Shakespeare,
Amleto, Garzanti, Milano 1999, pp. 113-114). Amleto è, in questo senso, emblema
della trilogia esistenzialista di Maselli: la sua irresolutezza, la sua debolezza di volontà, il suo eterno dubbio erosivo delle facoltà intellettuali fino al limite della pazzia,
sono caratteristiche che ritroveremo anche nella letteratura esistenzialista e quindi
anche in questi primi tre film, sia pure con toni diversi, per quanto ascensionali, dagli
Sbandati ai Delfini agli Indifferenti. Del resto è Anselmo stesso che alla Cheré confessa, parlando di sé: “Il principe Amleto avrà smesso di avere dubbi!” E si noti con quale sguardo divertito assista alla scena della scazzottata fra Corsi e Alberto De Matteis
proprio in casa della contessina Cheré: lui, che ha pressoché rinunciato all’azione,
ora ne vede una sotto i suoi occhi, vede una scena di morte, che però è anche di vita,
che contiene in sé il germe della brutalità istintuale, della bestialità.
di progressione della Storia, di sua ascensione, verso un progresso
dell’umanità, verso una sua idea di riscatto, di palingenesi sociale.36
Nella trilogia il discorso pare radicalmente diverso: più pessimistico,
più incentrato sull’uomo, sull’interiorità, sullo “scoperchiamento
dei teschi” (Debenedetti). Tutto fallisce o si perde. Non c’è nulla in
cui credere, perché tutto appare vuoto, vacuo, desolato. I personaggi
si muovono in atmosfere dechirichiane, avvoltolati nella stessa
indifferenza che anima la “dattilografa” e il “giovanotto foruncoloso”
di T.S. Eliot.37 E se il personaggio di Andrea era appena tratteggiato
in tal senso, per quanto il finale fosse piuttosto esplicito, quello di
Anselmo è lampante (per non parlare di Michele, vero Amleto): di lui
vediamo le stampe di Picasso (Guernìca) e di de Chirico (mi pare di aver
riconosciuto La mattinata angosciosa) appese in camera, a lui spetta
farci da traghettatore in questa indifferente landa desolata che è la sua
cittadella, è lui, infine, che pronuncia alcune battute illuminanti: “C’è
da farsi venire la nausea, credimi, come me la faccio venire io che fino
ad oggi sono rimasto in questa casa!”, dice durante un alterco col padre;
o ancora: “No, la verità, Cheré, è che ci vorrebbe più forza, avere più
coraggio, tutto il resto non sono che banali scuse!”, dice alla contessina
sua amica, rassegnandosi definitivamente a non partire più; o infine:
“Forse ha ragione mio padre: eravamo ragazzi e adesso siamo cresciuti
o forse è invece che chi in un modo chi in un altro eravamo vivi e ora
ci siamo spenti, abbiamo ceduto”, pronuncia nell’intenso e lapidario
finale.38 Tuttavia c’è da dire che la nausea che tutti questi personaggi
36
Cui Maselli, peraltro, mostra di credere (cfr. infra, finale di Francesco Maselli su
Francesco Maselli).
37
“[…] Il pranzo è finito, lei è annoiata e stanca, / Cerca d’impegnarla in carezze /
Che non sono respinte, anche se indesiderate. / Eccitato e deciso, lui l’assale d’un
colpo; / Mani esploranti non incontrano difesa; / La sua vanità non richiede risposta
/ E prende come un benvenuto l’indifferenza” (T.S. Eliot, Il sermone del fuoco da La
terra desolata, traduzione di A. Serpieri, bur, Milano 2009, p. 125). Sono versi di
magnifica forza evocativa. Lancinanti nel darci il peso di questa vita, di tutto il suo
vuoto, di tutta la sua nullità. Leggendo questi versi mi pare di rivedere un paio di scene dei Delfini, appunto, e degli Indifferenti: Alberto che si getta su Fedora, durante la
festa in casa sua, o Carla che si abbandona alle seduzioni morbose di Leo Merumeci.
38
Forse è opportuno riportarlo tutto il monologo finale, perché è bello e perché ci
torna utile. Vedendo ormai sconfitti i suoi sogni, le sue speranze, le proprie possi-
provano, la loro disperazione di fronte all’irrealizzabilità delle proprie
azioni, la loro angoscia si ferma al di qua di una reale consapevolezza, di
una totale responsabilità come la intendeva Sartre, soprattutto il primo
Sartre. E se poi riferimento al marxismo classico vogliam trovare, forse
lo abbiamo in queste battute, proferite da Anselmo sempre durante un
dialogo con la Cheré; battute che delineano una vicinanza col Sartre
della Critica della ragione dialettica (1960), credo del tutto inedito
per Maselli, che prepara e gira il film fra il 1959 e il 1960; battute che
però paiono sempre intrise di sconfitta, di perdita, di totale, definitiva
ineluttabilità: “Già, cosa aspetto? […]. Non è così semplice, Cheré.
Ci sono cose che uno si porta dietro dal giorno stesso che è nato:
nato in una certa famiglia, in una certa città, in una certa posizione
sociale. È come un marchio di fabbrica […]”. Un marchio di fabbrica
che se non avesse questo senso di scacco potrebbe essere interpretato
appunto come l’insieme delle condizioni strumentali e materiali di cui
uno è in possesso, come, per così dire, la base da cui si parte e che può
consentire di raggiungere determinati risultati. Dunque, ecco il nuovo
Sartre, in linea col Marx più antropologico, per quanto un Marx reso
sempre abbastanza solipsistico: non più l’uomo come il frutto di una
sua libera scelta e assoluta, ma l’uomo – e non la classe – come scelta
e libertà in relazione al dato di partenza; e tale dato è l’insieme delle
condizioni che lo costituiscono e lo determinano: la “certa famiglia”, la
“certa città”, la “certa posizione sociale”.39
bilità di riscatto, Anselmo conclude: “L’inverno è finito. Tutto si è sistemato […].
Tutto va avanti come prima, come doveva andare… Tutto mi sembra così lontano,
così difficile… Forse ha ragione mio padre: eravamo ragazzi e adesso siamo cresciuti
o forse è invece che chi in un modo chi in un altro eravamo vivi e ora ci siamo spenti,
abbiamo ceduto. Fra una settimana sposerò Marina e i suoi terreni a perdita d’occhio.
La cerimonia sarà celebrata con la dovuta solennità, nella cattedrale della piazza dove
s’è sposata mia sorella, dove si sono sposati Alberto e Fedora. E adesso devo andare,
è tardi, alle otto devo essere in fabbrica”.
39
E infatti, circoscrivendo meglio il parallelo Sartre-Maselli, a una prima, sommaria
disamina mi pare che Maselli si possa dire più in linea col Sartre della Critica della
ragione dialettica (1960), peraltro più marxista, piuttosto che col Sartre di L’essere e il nulla (1943) o con quello, famosissimo, dell’Esistenzialismo è un umanismo
(1946). Mi pare più in linea per ragioni diciamo di minore assolutismo nel delineare
i concetti di libertà e di scelta, di maggiore relativismo nel definire il “progetto tota-
Il sogno di Anselmo, “di partire, piantare tutto, andare all’estero
per sempre” finisce di pomeriggio su una spiaggia desolata, deserta,
dove lui e Marina sono andati per trascorrere qualche momento in
intimità e dove lei rivela la sua intenzione di entrare nelle industrie
del padre, di diventare un’industriale. È qui che Anselmo cade, quasi
litario” della vita; ragioni, in ultimo, più legate al materialismo storico marxista, più
legate al dato di partenza come condizionante lo sviluppo dell’essenza di ciascuno.
Nella Critica della ragione dialettica, infatti, siamo sempre all’“esistenza che precede
l’essenza”, solo che ora non basta che si abbia un “progetto totalitario”, un progetto
fondamentale, serve anche considerare l’insieme delle condizioni materiali della nostra esistenza e, finanche, della nostra stessa infanzia, serve riflettere sul “campo delle
(effettive, N.d.A.) possibilità strumentali”.
Approfondendo: se, come vedremo, per Roquentin – il protagonista della Nausea
– la coscienza (dell’essere “in-sé” e poi soprattutto della coscienza stessa, del “persé”) genera l’angoscia dell’incompletezza, ma quasi in una dimensione rivelatrice,
caricandosi di quella valenza ottimistica che Sartre preciserà meglio a partire dal ’46,
per i personaggi maselliani la coscienza mi pare restare al di qua di una piena accettazione della propria condizione. Cioè, essi accettano sì il fatto che non ci siano
essenze e valori dati aprioristicamente; che ciò produca sì nausea, ma senza che questo li renda partecipi di quella libertà (angosciante) e di quella piena responsabilità
che la nausea comporta. Sobbarcarsi pienamente, con responsabilità, con impegno,
ciascuno quel suo proprio “progetto totalitario”, dove ognuno ha deciso per sé, dove
l’uomo è quell’essere che desidera, che si mostra bisognoso del completamento, che
“progetta di essere Dio” e che è di per sé già votato al fallimento – “perché l’uomo
non è Dio, (l’uomo) non dispone di un’infinita potenza per realizzarlo” (Abbagnano) – significa abolire qualsiasi certezza, qualsiasi norma, qualsiasi metafisica. “Un
cerchio incompiuto, un quarto di luna, non mancano veramente di nulla (sono “insé”, N.d.A.): sono ciò che sono. Mancano per la coscienza che si aspetta o pretende il
loro completamento. […] L’uomo è un Dio mancato” (N. Abbagnano, Storia della
filosofia, vol. V, Verso il pensiero contemporaneo: dallo Spiritualismo all’Esistenzialismo, Gruppo Editoriale L’Espresso, Roma 2006, pp. 723-727 – il corsivo è mio).
Sì, la nausea quindi, sì, l’angoscia di fronte al nulla, ma come prezzi da pagare per la
libertà (totale o parziale che sia).
Va da sé che lo scacco in Sartre sembra esserci comunque e c’è certamente in questo
Maselli, almeno in questo primo Maselli. La differenza, lo scarto, forse, stanno qui,
nella lettura ottimistica che lo stesso Sartre fa dell’esistenzialismo (in L’esistenzialismo è un umanismo, come detto), intendendolo come una dottrina dell’azione, pessimistica solo nella teoria.
definitivamente. Lui, già così debole, che aveva aspettato il ritorno della
sua donna dalla Svizzera (dove era andata in seguito a un esaurimento
nervoso) proprio per ricominciare con lei una vita nuova, che li
portasse a “uscire di qui”, a “mischiarsi alla gente, ai loro problemi che
quasi non conosciamo, non vediamo…”, le dice. E davanti alle ragioni
utilitaristiche, concretissime di Marina, a quel suo “Non si può” (non
si può buttare tutto all’aria, tutti i sacrifici di una vita), scandito così
perentoriamente e senza altre ragioni, Anselmo non può che obiettare,
senza forze: “Che peccato”. Che peccato, dice Anselmo. Perché lui ci
aveva creduto al progetto di diventare migliori, di poter cambiare, di
potere finalmente sradicarsi. E aveva trovato una donna che pensava
condividesse il suo mondo e che invece ora lo ha tradito, lo ha
abbandonato, lo ha lasciato al suo destino, quello in cui tutto si compie
e “tutto va avanti come prima, come doveva andare”, perché non c’è
riscatto voluto possibile; tutto si compie indipendentemente da noi,
tutto finisce; e Anselmo può ben dire con Cleante: “Conducetemi […]
ovunque […] son destinato e vi servirò senza esitazione: giacché anche
se non volessi, vi dovrei seguire ugualmente da stolto”.40 Maselli qui è
lucido e spietato, severo nel dirci la verità, senza sconti nel mostrarcela.
Già Gli sbandati era il film di una fine, ma anche di un inizio, in
qualche modo; sì, perché la fine era quella individuale di un gruppo di
ragazzi, Andrea, Ferruccio e Carlo, della loro estate,41 della loro libertà
e, se si vuole, della loro deresponsabilizzazione nei confronti di tutto,
ma pure di un inizio, di un cominciamento, di un cammino: quello
dell’Italia, per il tramite della lotta partigiana; quello di un popolo
che doveva riappropriarsi di sé, anche a costi molto alti – e il cadavere
della Bosè alla fine del film sta lì a indicarcelo. I Delfini è il film di
una fine e basta. Ed è la fine di una generazione, di un sogno, di un
mondo d’infinite possibilità. Tutto ora torna a ripetersi, nell’arcano
meccanismo che regola le cose, nel mutarsi meccanico delle stagioni,
delle “mattine […] ancorate come barche in rada” (Montale). Tutto
s’appiattisce e tutto diventa calmo. La vita un lungo lento scorrere di
40
G. Stobeo, Florilegi. Preghiera a Zeus di Cleante, VI, 19, in Abbagnano, Storia
della filosofia, cit., vol. I, Il pensiero greco e cristiano: dai Presocratici alla scuola di
Chartres, p. 35.
41
Gli sbandati ha come sottotitolo proprio Fine d’estate e quest’ultimo, se non ricordo male, mi pare sia stato il titolo di lavorazione del film.
compromessi, di decisioni banali, di meschine furbate per restare a
galla. “Presa la mia lezione / più che dalla tua gloria / aperta, dall’ansare
/ che quasi non dà suono / di qualche tuo meriggio desolato, / a te mi
rendo in umiltà. Non sono / che favilla d’un tirso. Bene lo so: bruciare
/ questo, non altro, è il mio significato”.42
Dentro i Delfini
i Delfini si apre con una voce narrante, come l’aveva pure Gli
sbandati, e con una panoramica iniziale (comune a tutti e tre i film:
esterna, in questo caso, sulla città; interna, nel caso degli Sbandati e
degli Indifferenti). Seguono delle inquadrature della città, che ricordano
alcune pitture di Sironi e de Chirico, belle e oscure. C’è subito un
senso di morbosità e di soffocamento, che diventerà poi tratto del film.
Emerge in modo netto la predilezione di Maselli per i piani lunghi,
per le complesse articolazioni spaziali, per una messinscena costruita
e calibrata, per una profondità di campo totalmente utilizzata.43 C’è
certo la voglia di stupire, ma pure di raccontare. Più volte m’è capitato
di pensare a Maselli come a un pittore cinematografico, nel senso di
un pittore dell’immagine cinematografata, dunque dell’immaginemovimento, dell’immagine-tempo (Deleuze). Più volte ho sentito dire
di Maselli virtuosista. Certamente lo è. Ma i suoi movimenti non sono
movimenti gratuiti, quasi mai. Sono il frutto di un pensiero che cerca
di andare al fondo delle cose, che prova a scrutare l’imperscrutabile (lo
si vedrà soprattutto con i film del ciclo della donna), che cercano di
tracciare vie e strade da seguire. La sequenza del festino dai De Matteis
si apre con un’inquadratura lunga e possiede dentro un segmento
che va da quando vengono spente le luci – cui segue una girandola di
incontri e di fughe, degne metafore della loro società – a quando una
42
E. Montale, Dissipa tu se lo vuoi, da Ossi di seppia – Mediterraneo, in Tutte le poesie, i Meridiani – Mondadori, Milano 1984, p. 61. E sarebbe interessante accostare
questi versi con “Il tuo silenzio è grande come il mare”, l’unico verso di cui ci vien
detto di Anselmo Foresi, appartenente alle sue poesie giovanili, come ci rivela Marina, nel pomeriggio in spiaggia.
43
Maselli mi ricorda più volte come gli obbiettivi utilizzati all’epoca fossero quasi
unicamente il 25mm e il 28mm.
III
Il polittico politico
Lettera aperta a un giornale della sera, Il sospetto,
Le ombre rosse75
Qualche considerazione
Amleto in politica.
Fra il 1967 e il 1980 si collocano gli anni del profondo impegno
politico, tanto nella variante satirica quanto in quella drammatica e
polemica. Penso alle detestate commedie Fai in fretta ad uccidermi…
ho freddo! e Ruba al prossimo tuo, ai significativi Lettera aperta a un
giornale della sera e Il sospetto, al recente Le ombre rosse. E se sulle
pellicole per così dire satiriche si può tranquillamente sorvolare, sulle
quelle politiche no. Sono importanti, poiché riconnettono l’autore
con la società; gli fanno riconsiderare il ruolo dell’intellettuale dentro
la collettività. Gli fanno porre dubbi e interrogativi nient’affatto
superficiali circa la sua opportunità. Presentano figure di personaggi
apparentemente fermi, sicuri, solidi. Di cosa? Della loro fede politica.
Sono dei religiosi, in qualche modo. Dei clericali talmente dentro
la propria pratica devota che è come se ne avessero smarrito il senso
intimo, quello ideologico, astratto,76 se si vuole. Come se la passione
75
Cronologicamente questo film vien molto dopo. Tuttavia mi è parso inutile collocarlo in un a parte e doveroso piuttosto inserirlo in questo capitolo per ragioni
pratiche e di organicità. Pratiche, perché è più semplice, essendo un film politico,
anteporlo ai film degli anni Ottanta e Novanta; organiche, perché credo che faccia
un tutt’uno con gli altri due, Il sospetto e Lettera aperta, essendo tutti maniere diverse
di declinare i medesimi sostantivi di “intellettuale” e di “politica”.
76
Astratto qui per intendere qualcosa di non infestato dalla pratica quotidiana, dalla
concreta necessità, che rompe qualche volta la purezza dell’assunto. Come nella vita
si parte in genere da premesse buone e da lodevoli propositi, così nella fede – politica, religiosa, qualche volta artistica – si è costretti da un certo punto in poi ad aggiustare il tiro, a bilanciare il rapporto fra speranze, attese e traguardi. Perché lo scoglio
sul quale sbattere è lì ad aspettarci, perché c’è sempre qualcosa su cui, contro cui
tutto si sgretola, tutto naufraga. Del resto “[…] si fa sempre naufragio: […] una sposa,
fosse diventata solo un mestiere, ormai lontana anni luce77 dalla missione
che ci si era proposti. Dall’integerrimo Emilio del Sospetto a tutto il
composito gruppo di Lettera aperta, soprattutto, c’è il manifestarsi di
un’irrequietudine. È una specie di angoscia, di arrovellamento. Se si
vuole di soffocamento.
E soffocati saranno gli intellettuali protagonisti dell’ultimo film,
Le ombre rosse. Non più irrequieti, dunque, non più agitati, ma solo
imbolsiti, imborghesiti, invecchiati. Come saldati alle loro convinzioni,
non vibrano più. Sono racchiusi come pesci in un acquario, sono
ombre, appunto, di quel che forse avrebbero voluto essere.
Lettera aperta a un giornale della sera (1970)
“Ne vuoi ancora? Quanti vuoi che te ne trovi? Oppure preferisci degli esempi?
Tutti validi, convincenti, reali. E tutti falsi, invece”.78
Gli intellettuali di Lettera aperta in gabbia lo sono ma non lo
sanno. Per noia79 scrivono una lettera a “Paese sera”, improvvisandosi
un figlio troppo amato, uno di quei tranelli legittimi nei quali restano impigliati i
cuori più timorati e puri; o […] più semplicemente l’età, la malattia, la stanchezza, il
disinganno che ci avverte che, se tutto è vano, lo è anche la virtù?”, dice Adriano nel
malinconico libro della Yourcenar (M. Yourcenar, Memorie di Adriano, Einaudi,
Torino 2002, p. 252). Forse sì, anche la virtù. Ma questo Maselli più politico ci ricorda che non ci sono scuse, né il Partito né la società, non c’è ragione esistenzialista
che tenga, non c’è nessun autocompiaciuto scacco, non c’è famiglia né familismo che
rendano vano l’impegno. Insomma, se ci si arrende, alla fine, la colpa è solo nostra.
“È solo tradimento”, dice la Surina, il personaggio interpretato da Goliarda Sapienza
in Lettera aperta.
77
Anni luce è stato il secondo titolo provvisorio dell’ultimo lungometraggio di Maselli, Le ombre rosse (il primo, Il fuoco e la cenere, è stato a lungo considerato come
l’opzione definitiva). Mi pare il caso di sottolinearlo proprio perché quest’ultima
pellicola – che si segnala anche per un ritorno al cinema di politica e un po’ vicino
al modello di Lettera aperta – è una riflessione sulla sinistra. Sulla necessità di recuperare il nucleo, il centro delle idee. Sull’utilità di tornare alla passione, al senso,
all’impegno.
78
Maselli, Lettera aperta a un giornale della sera, 1970.
79
Noia. Perché proprio la noia, quella esistenziale, ancora, pare essere l’unico vero
Codice da presa, Codice privato (1988)
Anna è la protagonista di Codice privato, di questo secondo film,
interpretato da Ornella Muti. È un personaggio in bilico fra pazzia e
lucidità, fra finzione e realtà, incubo e vita.
Già di per sé la scelta della Muti, dopo aver preso in considerazione
di nuovo l’ipotesi Golino, era abbastanza controcorrente, soprattutto
in quegli anni,105 ma poi anche la struttura del film, così libera e
sospesa, tutta incentrata sul rapporto di una donna con una casa vuota
e con i suoi oggetti, in particolare un computer e un telefono, mostrava
grande voglia di sperimentazione. Il tutto condito da un esplicito
hommage a Jean Cocteau, al cui piccolo La voix humaine (1930)
l’opera è ispirata.106
È certamente il film visivamente più audace, in cui Maselli crea un
vero e proprio studio registico intorno alla figura di Anna. Uno studio
“per macchina da presa e dolly” (Maselli), articolato in circa otto piani
sequenza, spesso camuffati grazie a stacchi e/o dissolvenze incrociate
particolarmente riuscite. Uno studio che seziona, scompone, rompe
l’appartamento di Emilio, l’uomo che ha appena abbandonato Anna,
l’intellettuale che le è stato amante, padre, pigmalione, il quale nel
film non compare mai, ma la cui “assenza (è) più acuta presenza” (A.
Bertolucci). Uno studio in cui la regia si fa possibile di tutto, ove nulla
ha confini, tutto diventa accessibile, penetrabile. L’appartamento
Non che la Muti non avesse fatto cinema d’autore – si pensi per esempio ai film
con Ferreri, L’ultima donna (1976), Storie di ordinaria follia (1981), Il futuro è donna (1984), o con Monicelli, Romanzo popolare (1974) –, ma in quegli anni certo è
coraggiosa la sua scelta per un film così particolare, così bisognoso di una totale fede
del regista nelle capacità attoriali della sua interprete. Ferma restando la straordinaria
forza comunicativa del suo viso, in quegli anni O. Muti era anche la musa di Celentano e di Pozzetto e fa specie che Maselli l’abbia chiamata a interpretare una parte così
complessa come quella del personaggio di Anna.
106
Del 1930, La voix humaine è un dramma in forma di monologo, tutto incentrato
su una donna, la quale probabilmente ha tentato il suicidio, e su una rottura amorosa
che corre lungo il filo del telefono. Quel filo che le si annoda intorno al collo è il filo
attraverso cui passa la voce dell’amato. Un filo e una voce che possono strozzarla.
Una conversazione sempre sincopata, spezzata, intermittente su un amore difficile
e finito.
105
ricostruito da Marco Dentici è un grandissimo open space in cui le
pareti sono fittizie e aperte, i corridoi lunghi e prospettici, le vetrate
gigantesche, le scale senza ringhiera, tese a disegnare geometrie
chiastiche. Tutti i confini sono aboliti, anche quelli fra un’inquadratura
e l’altra; tutto è legato, tutto è un continuum, tutte le cose si
compenetrano. Come nella Casa Kaufmann di Frank Lloyd Wright
o, meglio ancora, come nella più recente House H di Sou Fujimoto,
geometria e tecnica dominano lo spazio (e il tempo, in questo caso).
Il codice privato di Maselli è un codice da presa, che afferra la realtà
voracemente. Più che mai qui vale quanto detto da Mino Argentieri a
proposito della sua macchina da presa, che stringe i personaggi come
“nel cuore di un assedio”, li rinserra e non li lascia più andare.107 Solo
che qui tutto si fa estremo. Non sono solo i personaggi, qui del resto
ridotti a uno, a essere tallonati, ma le cose a essere interrogate, ancora
una volta antonionianamente. Tutto si fa sondare. La realtà diventa
un libro aperto, con le pagine squadernate che la macchina da presa
vuol indagare per cercare qualcosa d’ultimo, un qualche cosa che
racchiuda il senso. Ma il senso non c’è, non lo si trova. Il film si chiude
con un’immagine lapalissiana: la presa del telefono staccata. Anna,
per ottanta minuti, ha parlato a un telefono privo di linea. Per ottanta
minuti Maselli ci ha preso in giro? O forse ci ha dato dell’altro? Un
nuovo passo verso una filosofia che se prima sembrava abbracciare
Sartre, la scelta e il progetto, ora sembra distaccarsene? Ora sembra
più incline verso un’idea addirittura postmoderna (qui si, di più),
di piena riconoscibilità dell’impotenza della Storia e di una storia.
L’improvviso rovesciamento di qualsiasi tentativo di spiegazione
logica, l’annullamento di qualsivoglia costrutto razionale finale,
lo sprofondamento nel nonsense, aprono ancora a uno smacco, a
uno scacco. Solo che mentre nella “trilogia dell’uomo”, e poi pure in
Storia d’amore, lo scacco era ai danni dei protagonisti, che si facevano
rappresentanti di un malessere, che è il malessere dell’uomo, il quale
non può nulla sul nulla che lo circonda, qui lo scacco è ai danni dello
spettatore, oltreché di Anna, s’intende.108 Qui il senso, pure cercato
107
Cfr. nota 74.
Poiché, come ha ben notato Alina Narciso, l’unico atto di rivolta di Anna – la
telefonata al figlio di Emilio – si traduce in un nulla di fatto, a causa del telefono
fuori posto.
108
affannosamente nell’esibizione di una reiterata contemplazione delle
cose, di una ripetuta cosalità, non c’è. O, se c’è, è insondabile, misterioso,
proprio come la casa di Emilio. La casa di Emilio è piena di oggetti senza
senso. È un senso che non si cattura, che non si lascia agguantare. Le
gigantesche, scenografiche mani che stanno lì, in quell’appartamento,
dipinte e scolpite, aperte, concave, vuote, come nell’attesa di qualcosa,
che qualcosa cada loro dal cielo, protese nell’atto di afferrarla, stanno
lì proprio a testimoniare questo: l’attesa di un senso, di qualcosa che
spieghi, che dica. Salvo esser tutto perduto nel drammatico finale.
Cosalità, vuoto, vacuità, le parole chiave di questo Maselli. La realtà è
l’infinitamente possibile e l’interminabilmente inesauribile, anche se
solo apparentemente. L’assenza e il vuoto diventano carburante per
un’interrogazione continua, un eterno dubbio. Non c’è più nessun
sistema, nessuna filosofia che spieghi, che dia certezze, emani principi
rigidi. Solo “mostrazione”.
Messa così, allora, tutto è come se venisse destrutturato, smontato.
Messa così, allora, “il n’y a pas de hors-texte” (Derrida), non ci sono
che testi.109 Derrida fu chiaro a proposito: niente libri, niente logos,
niente presenza. Tutto si dà o, meglio non si dà, che nell’assenza, nella
differenza, nella differanza. Tutto è nel supplemento.110 La parola non
A dire il vero, la traduzione accademicamente accettata è “non c’è fuori-testo”. Però
mi pare che questa qui presentata renda meglio l’idea della scarnificazione, della destrutturazione.
110
Differanza e supplemento, al pari di presenza, logocentrismo e poi, sulla scia di Lacan, Freud, Rousseau e Deleuze, di fallogocentrismo e disseminazione, sono termini
chiave nella filosofia di Derrida.
Derrida è filosofo complesso. Qualsiasi tentativo di analisi in questa sede risulterebbe semplicistico. Entrarvi ora, poi, impossibile. Proverei un cenno, partendo dal Fedro di Platone. Cominciando dall’anziano Socrate che racconta al giovane discepolo
il mito di Thamus, il re egizio che rifiutò l’offerta della scrittura da parte di Theuth,
perché inferiore rispetto all’oralità, alla memoria, alla parola. Essa “procurerà l’oblio
nelle anime di coloro che l’apprendono per mancanza di esercizio della memoria”,
disse Thamus. Essa produrrà falsi sapienti. Ecco, per Derrida, dunque, tutta la storia
della filosofia è finita con l’essere, per dirla con Carmelo Bene – anche se con valenze
decisamente diverse –, storia della phoné. Il tentativo di Derrida parte da qui per
muovere oltre la Filosofia, per sottrarre ogni discorso alla filosofia tradizionale metafisica logocentrica, la filosofia della presenza, e approcciare una Post-filosofia, una
filosofia che faccia tabula rasa anche di quei maestri che pure hanno criticato la me109
è più portatrice di senso, ché non lo è mai stata; la scrittura acquista
valore nuovo; la metafisica della presenza cede il posto all’assenza;
quest’ultima, “sola, può aprire la strada alla rivelazione” (Narciso).
In questa nuova dimensione maselliana il punto di vista
autoritario, normativo, è abolito. Tutto, come detto sopra, è aperto:
scenograficamente, registicamente, narrativamente. Il film fa
dell’apertura e dell’incompiutezza la sua cifra. E soprattutto sembra
rifuggire da qualsiasi tentativo d’ingabbiamento, che determinerebbe
una chiave di senso, proprio per sua propria convinzione filosoficoartistica. “Se Velasquez ha permesso a Bacon di rifarlo vuol dire che
il suo Papa era incompiuto”, dice Emilio in una delle lettere che Anna
legge al computer. “Incompiuto” vale per non finito, per irrealizzato,
per aperto. Che l’arte sia tale solo a patto di non lasciarsi chiudere in
una significazione specifica? Certo, anche. Diciamo che può possedere
un’aura di senso più o meno prestabilito ma difficilmente un significato
univoco. “L’arte come semilavorato”, come ricerca senza fine di una
fine definitiva. Il segreto della Pietà Rondanini e di altri lavori di
Michelangelo sta proprio in questo sublime tentativo di uscire dalla
materia per farsi altro, per farsi senso nuovo, rimanendo però sempre
tafisica logocentrica della presenza, ovvero Nietzsche, Freud, Heidegger e Foucault.
Perché la loro è sì una filosofia contro, ma pur sempre dentro una dialettica logocentrica. Una filosofia nuova è quindi una filosofia che destrutturi, che decostruisca, che
sveli i codici, che penetri dentro e veda dietro. Perché… “non c’è mai stato altro che
scrittura!”, non ci sono stati mai altro che testi. Il segno (grafico) è quello che la voce
non è mai stata: presenza. Ma la presenza del segno è assenza di qualcosa e dunque è
assenza. La presenza, tragicamente, non può che essere differita (nel tempo) e supplita (nello spazio) dal segno che la rappresenta (da qui la differanza, che unisce in sé il
doppio senso di differre, ritardare ed essere altro, essere differente), anche perché (ed
è qui il centro della filosofia di Derrida): “Non c’è mai stato altro che scrittura; non
ci sono mai stati altro che supplementi, significati sostitutivi che non hanno potuto
sorgere che in una catena di rinvii differenziali, in quanto il “reale” non sopraggiunge,
non si aggiunge se non prendendo senso a partire da una traccia e da un richiamo di
supplemento, ecc. E così all’infinito, poiché abbiamo letto, nel testo, che il presente
assoluto, la natura, ciò che designano le parole “madre reale” ecc., si sono già da sempre sottratti, non sono mai esistiti; che ciò che apre il senso e il linguaggio è questa
scrittura come sparizione della presenza naturale” ( J. Derrida, Della grammatologia, in Abbagnano e G. Fornero, Storia della filosofia, cit., vol. VII, Il pensiero
contemporaneo: dall’Ermeneutica alla Filosofia analitica, p. 605).
allo stato grezzo, primordiale, restando cioè incompiuta. Il segreto è
nelle infinite possibilità, nell’“apertura dell’apertura” (Derrida), nella
continua interrogazione appunto. Tutto il film dunque ruota intorno
a questo ganglio concettuale. Si pensi al motivo per cui Anna è
abbandonata da Emilio: “Sento che stai liberandoti da ogni dipendenza
da me”, legge Anna in una lettera indirizzata a lei da Emilio. La fine della
dipendenza è la fine del legame amoroso, in quanto impostato sulla
costruzione culturale e umana di Anna. Quando questa ha appreso a
sufficienza al punto di non avere più bisogno di Emilio, quest’ultimo la
considera “finita”, come fosse un’opera, e quindi non più interessante,
poiché non più dotata di nuove possibilità, di aperture infinite…
chiusa, appunto, da accantonare.
Si può dire che la particolarità di Codice privato sia nell’essere
proprio ciò che rifugge. La compattezza nel dimostrare il suo assunto,
e cioè che non esistono compattezze, che tutto è caotico, che tutto
è labile, ne determina la sua piena organicità. Tale assunto è agito
su tutti i fronti e indaga qualsiasi gamma di rapporti, uomo/donna,
artista/opera, regista/film, ponendoci addirittura in una dimensione
di metalinguaggio, di metacinema, proprio nella misura in cui ci
permette di riflettere sul rapporto fra Maselli e il suo Codice privato,
fra Maselli e il suo cinema.
L’alba (1991)
L’alba è il film definitivo da questo punto di vista. Definitivo per
due motivi: uno, perché è un film che si inserisce perfettamente nel
discorso che ho fatto poco fa; due, perché è un film che chiude questo
lungo percorso di sperimentazione.
Il film è la storia di un’attesa. Ed è, ancora, una storia d’amore, che
attraversa quasi dieci anni di incontri clandestini. Un amore folle che
intreccia frammentariamente due vite senza farle incontrare mai in
via definitiva; sempre in attesa di un qualche cosa che rischiari la loro
unione; ogni volta in attesa di un nuovo incontro, di una nuova alba.
Stretto in una camera d’albergo, “narrativamente ridotto all’osso”,111
111
In tempi in cui il successo è garantito solo dalle storie, in tempi in cui si ha un gran
fiorire di scuole di sceneggiatura e di modelli (Syd Field in testa, che ha rispolverato
I
Francesco Maselli su Francesco Maselli
2007-2011
Conversazioni con Francesco Maselli
Inizi
Vorrei che cominciassimo parlando un po’ dei tuoi inizi, della famiglia
in cui nasci e dei tuoi studi.
Dunque, io ho fatto il liceo, non prendendo la licenza liceale,
perché a sedici anni sono andato al csc (Centro Sperimentatale di
Cinematografia, N.d.A.), ho fatto l’esame, presentando due corti
(cosa che non era normale, all’epoca), uno in 8mm e l’altro in 9,5mm,
e riuscendo a entrare. Due corti che, per fortuna, oggi sono andati
perduti.
Devi sapere che ero molto precoce, dovuto in gran parte alla mia
famiglia. Mio padre1 era un personaggio per alcuni versi insopportabile,
con una totale, nevrotica ripugnanza per il “fare”, come fosse una
squallida forma di semplificazione delle cose. Ma era di una cultura
e intelligenza straordinarie, stimato da Croce e Gentile, oltreché da
Pirandello, per cui tutti si aspettavano che avrebbe prodotto cose
importanti; e lui infatti ha cominciato una specie di suo sistema,
di sua filosofia, però poi non l’ha mai portato a termine. Non gli
andava, gli scocciava. Spesso con mia sorella abbiamo detto che la
nostra precocità (lei in pittura, con le prime cose già a dodici anni,
e io nel cinema, col mio primo corto a quattordici) in realtà era una
sorta di panico di diventare come papà. Cosa che peraltro era molto
1
Ercole Maselli: stimato da Pirandello – che lo considerava quasi un suo figlioccio
– da Croce, da Gentile; uno dei massimi studiosi di Hegel; un intellettuale raffinato;
un fine critico d’arte. Celebre, da sempre, il salotto di casa Maselli, frequentato da
Cecchi, Bontempelli, Alvaro, Savinio. E sarà lo stesso Maselli a ricostruirne in parte
le dinamiche e in parte la storia in quella che potremmo considerare una sorta di
sua autobiografia cinematografica, Frammenti di Novecento (2005), che ricorda, per
lo stile registico, l’altra grande storia che Maselli racconterà per la Rai (Rai Educational), ovvero quegli Appunti (preziosi) per una storia non accademica del cinema
italiano, intitolati Un luogo chiamato cinema.
affascinante: lui passava le giornate a leggere, prendere appunti e dare
consigli, immerso fra i suoi libri. Era un personaggio molto carismatico
e tanto era dovuto anche alla stima che riceveva da Pirandello, che lo
considerava l’intellettuale di genio e che lo accudiva e proteggeva, un
pochino come fece Luchino (Visconti, N.d.A.) con me all’inizio.
Tornando a te, alla tua precocità...
Mah, sai, pensando ai miei quattordici anni, io non mi vedo così
diverso da come sono oggi. Io ho avuto un clic per cui sono passato
dall’infanzia all’età adulta. Il Partito comunista mi aiutò molto; ebbi
una maturazione forzata, in qualche modo. Questo mi ha portato
a degli squilibri molto forti. Ero molto adulto, la scuola già non la
sopportavo più, per cui nel ’47 lasciai il liceo…
E tuo padre che disse?
Non ti dico! “Non è figlio mio!” Capirai! Lui mi aveva fatto
studiare tedesco perché dopo avrei dovuto leggere Hegel e Kant nella
loro lingua.
Ma poi, sai, tutti erano più grandi di me: da Goliarda (Sapienza,2
N.d.A.) ai miei amici, come Aggeo Savioli, tanto per farti un nome.
2
Goliarda Sapienza. Maselli la nomina in quanto sua compagna per diciotto anni.
Nata nel 1924 e morta nel 1996, è stata una delle figure più appartate e tuttavia non
poco originali del panorama artistico e letterario italiano.
Cresciuta in una famiglia estremamente libera (il padre, Giuseppe Sapienza, rifiutò
di iscriverla alla scuola dell’obbligo per evitarle la formazione fascista), studiò recitazione, fu attrice per Blasetti e Visconti, si ritirò dalle scene cominciando a scrivere.
Scrisse febbrilmente opere pervase sempre dal proprio spirito anticonformista e intessute di quella che fu la sua non facile vita (due tentativi di suicidio, l’elettroshock,
la cura psicoanalitica); fu arrestata negli anni Ottanta per furto di gioielli in casa di
una conoscente (“L’ho fatto per rabbia, per provocazione. Lei era molto ricca, io
diventavo sempre più povera. Più diventavo povera più le davo fastidio. Magari mi
invitava nei ristoranti più cari, ma mi rifiutava le centomila lire che miservivano per
il mio libro. Le ho rubato i gioielli anche per metterla alla prova, ma ero sicura che
miavrebbe denunciato”); fu insegnante al Centro Sperimentale di Cinematografia.
Qualche anno fa Paolo Franchi le ha dedicato un film documentario e il suo romanzo
più importante, L’arte della gioia (ma varrebbe la pena menzionare anche, almeno,
L’università di Rebibbia), è stato tradotto in Francia, salutato come il nuovo romanzo dall’iter tumultuoso, alla stregua del Gattopardo e di Horcynus Orca, e lei, Goliarda Sapienza, è stata riconosciuta da “Le Monde” “narratrice meravigliosa nei suoi
slanci a volte razionali, a volte passionali”.
Non avvertivi uno scarto?
No. C’era questo gruppo di amici, più grandi di me di qualche
anno, nei confronti dei quali mi sentivo quasi naturalmente alla pari
per via dell’ambiente nel quale ero cresciuto.
Quindi diciamo che lo scarto anagrafico era compensato dal tuo livello
culturale, quello acquisito naturalmente in famiglia…
Sì, c’era un insieme di cose, per cui tanti modi di ragionare io li
conoscevo fin dall’infanzia. Però hai ragione… Con quelli più grandi
ancora, con Pintor, con Reichlin, che avevano sei, sette anni più di me,
c’era una certa differenza, perché… Non saprei… Ma con loro questo
lo avvertivo. Parlo del Dopoguerra, perché, quando comincio a fare
cinema, la cosa si trasforma. Il mio primo documentario ufficiale,
Bagnaia paese italiano, fatto a diciott’anni, vince a Venezia e io
comincio ad assumere una mia fisionomia e quasi s’inverte la cosa.
Orbita Antonioni e orbita Visconti
Tu sei in qualche maniera figlio del rapporto con Luchino Visconti e
Michelangelo Antonioni. Ti sei mai sentito in soggezione? Non hai mai
avvertito l’esigenza di liberarti dalla loro ala, dal loro modo di fare le
cose? Ci hai mai pensato? È una cosa su cui ti sto facendo riflettere io per
la prima volta?
La domanda è posta molto bene. Bisogna dire che si trattava di due
rapporti radicalmente diversi. Antonioni io l’ho conosciuto che era al
primo film, quindi c’era un rapporto di quasi parità. Lui aveva appena
fatto due documentari, N.U. e Gente del Po, e aveva fatto un aiuto
regia molto formale (mandato dalla Scalera per chiudere il rapporto di
coproduzione) per Marcel Carné.
Magari sbaglio a parlare di parità, perché poi, visto che mi fai
ricordare, in Cronaca di un amore ci fu un episodio significativo.
Un’inquadratura, che lui fece girare a me (una soggettiva che non era
nulla di particolare), non venne bene perché io non mi ero reso conto
che c’era un problema di continuità stagionale e, girata ormai d’estate,
non si poteva montare, per la presenza di passanti in camicia in un
film tutto invernale, per cui dovette rigirarla lui. E mi ricordo di essere
rimasto molto male per il fatto di non averla girata bene. Niente di
drammatico, intendiamoci, però…