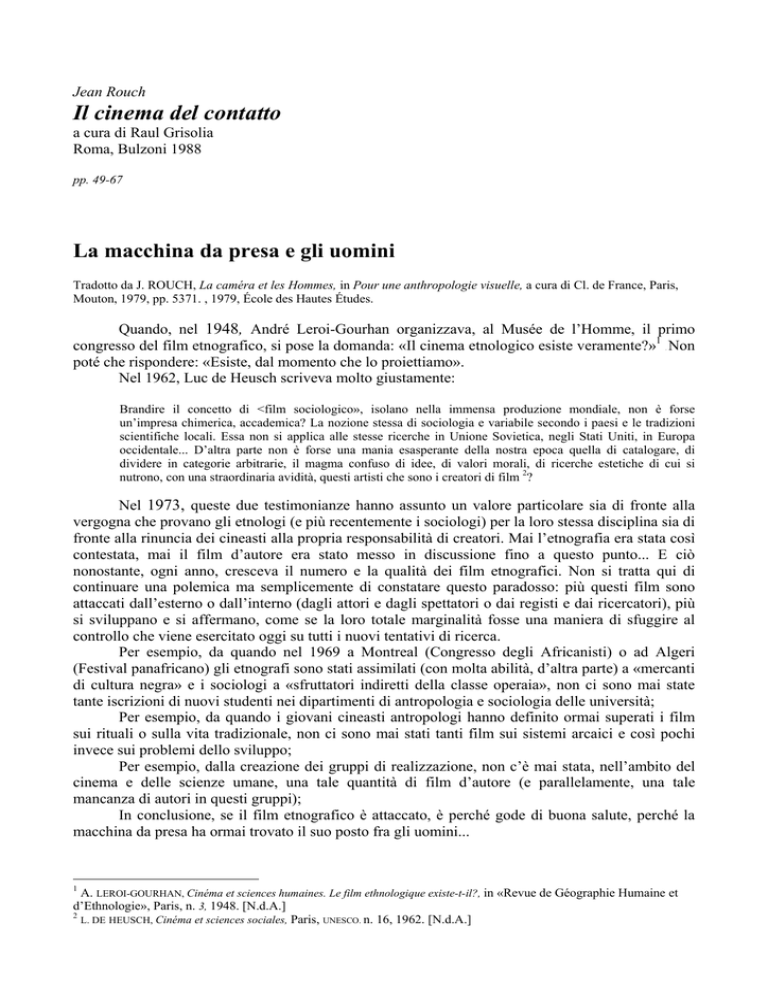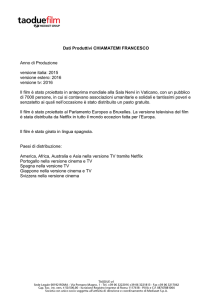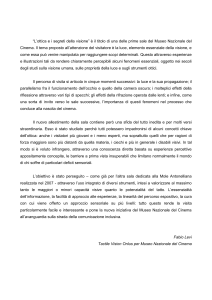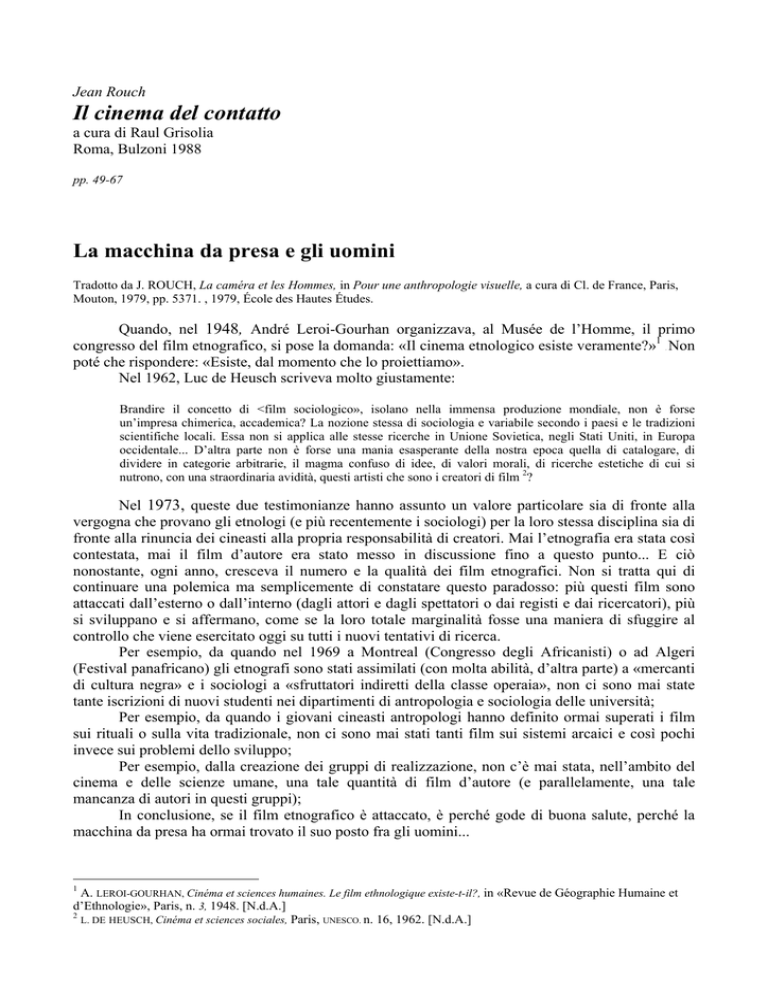
Jean Rouch
Il cinema del contatto
a cura di Raul Grisolia
Roma, Bulzoni 1988
pp. 49-67
La macchina da presa e gli uomini
Tradotto da J. ROUCH, La caméra et les Hommes, in Pour une anthropologie visuelle, a cura di Cl. de France, Paris,
Mouton, 1979, pp. 5371. , 1979, École des Hautes Études.
Quando, nel 1948, André Leroi-Gourhan organizzava, al Musée de l’Homme, il primo
congresso del film etnografico, si pose la domanda: «Il cinema etnologico esiste veramente?»1 Non
poté che rispondere: «Esiste, dal momento che lo proiettiamo».
Nel 1962, Luc de Heusch scriveva molto giustamente:
.
Brandire il concetto di <film sociologico», isolano nella immensa produzione mondiale, non è forse
un’impresa chimerica, accademica? La nozione stessa di sociologia e variabile secondo i paesi e le tradizioni
scientifiche locali. Essa non si applica alle stesse ricerche in Unione Sovietica, negli Stati Uniti, in Europa
occidentale... D’altra parte non è forse una mania esasperante della nostra epoca quella di catalogare, di
dividere in categorie arbitrarie, il magma confuso di idee, di valori morali, di ricerche estetiche di cui si
nutrono, con una straordinaria avidità, questi artisti che sono i creatori di film 2?
Nel 1973, queste due testimonianze hanno assunto un valore particolare sia di fronte alla
vergogna che provano gli etnologi (e più recentemente i sociologi) per la loro stessa disciplina sia di
fronte alla rinuncia dei cineasti alla propria responsabilità di creatori. Mai l’etnografia era stata così
contestata, mai il film d’autore era stato messo in discussione fino a questo punto... E ciò
nonostante, ogni anno, cresceva il numero e la qualità dei film etnografici. Non si tratta qui di
continuare una polemica ma semplicemente di constatare questo paradosso: più questi film sono
attaccati dall’esterno o dall’interno (dagli attori e dagli spettatori o dai registi e dai ricercatori), più
si sviluppano e si affermano, come se la loro totale marginalità fosse una maniera di sfuggire al
controllo che viene esercitato oggi su tutti i nuovi tentativi di ricerca.
Per esempio, da quando nel 1969 a Montreal (Congresso degli Africanisti) o ad Algeri
(Festival panafricano) gli etnografi sono stati assimilati (con molta abilità, d’altra parte) a «mercanti
di cultura negra» e i sociologi a «sfruttatori indiretti della classe operaia», non ci sono mai state
tante iscrizioni di nuovi studenti nei dipartimenti di antropologia e sociologia delle università;
Per esempio, da quando i giovani cineasti antropologi hanno definito ormai superati i film
sui rituali o sulla vita tradizionale, non ci sono mai stati tanti film sui sistemi arcaici e così pochi
invece sui problemi dello sviluppo;
Per esempio, dalla creazione dei gruppi di realizzazione, non c’è mai stata, nell’ambito del
cinema e delle scienze umane, una tale quantità di film d’autore (e parallelamente, una tale
mancanza di autori in questi gruppi);
In conclusione, se il film etnografico è attaccato, è perché gode di buona salute, perché la
macchina da presa ha ormai trovato il suo posto fra gli uomini...
1
A. LEROI-GOURHAN, Cinéma et sciences humaines. Le film ethnologique existe-t-il?, in «Revue de Géographie Humaine et
d’Ethnologie», Paris, n. 3, 1948. [N.d.A.]
2
L. DE HEUSCH, Cinéma et sciences sociales, Paris, UNESCO. n. 16, 1962. [N.d.A.]
1. CENTO ANNI DI FILM DELL’UOMO
I pionieri
Eppure, la strada era stata particolarmente ardua da quando nel 1872, a proposito di una
disputa sui trotto dei cavalli, Edward Muybridge realizzava a San Francisco i primi cronofotografi,
che scomponendo il movimento, avrebbero permesso di riprodurlo, cioè di cinematografarlo.
Fin dall’inizio, dopo gli animali, dopo il cavallo, l’uomo, il cavaliere o l’amazzone (nudi per
favorire l’osservazione dei muscoli), poi il marciatore, le marciatrici a quattro zampe, l’atleta, o lo
stesso Muybridge, completamente nudo, che compiva le sue evoluzioni davanti a trenta apparecchi
fotografici automatici. In queste immagini traspariva la società americana della Costa Ovest di
cento anni fa, come nessun western riuscirà più a mostrarla, un’amazzone certo, ma bianca,
muscolosa, violenta, armoniosamente impudica, pronta ad offrire al mondo il virus della buona
volontà e, innanzitutto, l’American way of Life.
Dodici anni più tardi, nel 1888, quando Marey racchiude i trenta apparecchi fotografici di
Muybridge nel suo fucile cronofotografico, utilizzando la pellicola morbida inventata da Edison,
sarà ancora l’uomo a fare da bersaglio. E, dal 1895, il dottor Felix Regnault, giovane antropologo,
decide di servirsi della cronofotografia per fare uno studio comparato del comportamento umano
(40 anni prima che Marcel Mauss scriva l’indimenticabile saggio Les techniques du corps), sulle
«maniere di camminare, di accovacciarsi, di arrampicarsi» di un Peul, di un Wolof, di un Diula, di
un Malgascio...
Nel 1900, Regnault (e il suo collega Azoulay che, per primo, utilizza i rulli dei fonogrammi
Edison per registrare il suono) concepisce il primo museo audiovisivo dell’uomo: «I musei
etnografici dovrebbero aggiungere alle loro collezioni delle cronofotografie. Non basta possedere
un telaio, un tornio, dei giavellotti... bisogna inoltre conoscere il modo di utilizzarli; ora, questo è
possibile saperlo solo attraverso la cronofotografia>. Sfortunatamente, questo museo etnografico
del documento visivo e sonoro, settant’anni dopo, appartiene ancora al mondo dei sogni.
Dal momento in cui l’immagine animata appare realmente con il cinematografo di Lumière,
è sempre l’uomo ad esserne il soggetto principale: «Gli archivi filmati di questo secolo cominciano
con queste prime realizzazioni naïves. Il cinema sarebbe diventato lo strumento oggettivo capace di
cogliere dal vivo il comportamento dell’uomo? La meravigliosa ingenuità di La sortie des usine, Le
dejeuné du bébè, di La péche à la crevette lo lasciava credere» 3. Ma, fin dall’inizio, la macchina da
presa si rivela come un «ladro di riflessi». Se gli operai che escono dalle fabbriche Lumière non
prestano alcuna attenzione a questa piccola scatola a manovella, quando, qualche giorno più tardi
assistono alla proiezione delle brevi immagini filmate, prendono improvvisamente coscienza di un
rituale magico sconosciuto, ritrovano la paura antica dell’incontro fatale con il «doppio».
Allora appaiono «... gli illusionisti, che tolgono agli scienziati questo nuovo tipo di
microscopio e lo trasformano in giocattolo». E gli spettatori di cinema preferiscono la ricostruzione
truccata da Méliès dell’eruzione del vulcano della Montagne Pelée nelle Antille ai documenti
terribili delle troupe Lumière sulle guerre della Cina.
I precursori geniali
È necessaria la tempesta del 1914-1918, la messa in discussione di tutti i valori, la rivoluzione
sovietica e la rivoluzione intellettuale europea, perché la macchina da presa ritrovi gli uomini.
Due precursori geniali inventano allora la nostra disciplina. Uno è geografo-esploratore, l’altro
poeta futurista, ma tutti e due sono cineasti avidi di realtà: l’uno fa della sociologia senza saperlo, il
sovietico Dziga Vertov, l’altro fa dell’etnografia, sempre senza saperlo, l’americano Robert
Flaherty. Non si incontrano mai, non hanno contatto con gli etnologi o i sociologi che inventavano
3
L. DE HEUSCH Cinéma et sciences sociales, Paris, UNFSCO, n. 16, 1962. [N.d.A.]
allora la loro scienza, probabilmente non si rendono conto dell’esistenza al loro fianco di questi
osservatori infaticabili. E tuttavia, è a loro che dobbiamo tutto ciò che cerchiamo di fare oggi.
Per Robert Flaherty, nel 1920, filmare la vita degli Eschimesi del Grande Nord, significa
filmare un Eschimese particolare, non una cosa, ma un individuo, e un principio elementare di
onestà consiste nel mostrargli ciò che si fa. Quando Flaherty mette in piedi un laboratorio di
sviluppo in una capanna della baia di Hudson, quando proietta le sue immagini al suo primo
spettatore, l’eschimese Nanook, non immagina certo di aver appena inventato, con dei mezzi
irrisori, «l’osservazione partecipante» che i sociologi e gli antropologi utilizzeranno una trentina
d’anni dopo e il feed-back che noi sperimentiamo ancora così maldestramente. Se Flaherty e
Nanook riescono a raccontare la difficile storia della lotta di un uomo contro la natura prodiga di
doni e sofferenze, questo è possibile perché c’è fra loro un terzo personaggio, una piccola macchina
capricciosa ma fedele, con una memoria visiva infallibile, che mostra a Nanook le sue stesse
immagini man mano che vengono impressionate, la macchina da presa che Luc de Heusch ha
magnificamente chiamato «la camera partecipante».
Senza dubbio, quando lo stesso Flaherty sviluppa i suoi spezzoni di pellicola nell’igloo, non
si rende conto che ha condannato a morte più del 90% del documenti filmati che saranno realizzati
successivamente e bisognerà attendere quaranta anni prima che qualcuno segua il nuovo esempio
del vecchio maestro del 1921.
Per Dziga Vertov, nella stessa epoca, si tratta di filmare la rivoluzione. Qui, non conta più la
messa in scena, anche selvaggia, ma la registrazione di blocchi di realtà. Allora il poeta, diventato
militante, rendendosi conto della primitiva struttura cinematografica dei cinegiornali, inventa il
kinok, il «cine-occhio»:
Sono il cine-occhio. Sono l’occhio meccanico. Sono la macchina che vi mostra il mondo così com’è, come
solo io posso vederlo. Da oggi mi libero per sempre dell’immobilità umana. Sono in un ininterrotto
movimento. Mi avvicino agli oggetti e me ne allontano, scivolo sotto di essi, entro in loro, mi muovo accanto
al muso di un cavallo che fugge, fendo in piena corsa la folla, corro dinanzi ai soldati che corrono, mi rovescio
sulla schiena, volo con gli aeroplani, cado e mi alzo con i corpi che cadono e che si alzano (Manifesto dei
Kinok, 1923).
Così questo pioniere visionario predice l’era del «cinema verità»:
Il cinema verità è una nuova forma d’arte, l’arte della vita stessa. Il cine-occhio comprende: tutte le tecniche di
ripresa; tutte le immagini in movimento; tutti i metodi senza eccezione che permettono di cogliere la verità:
una verità in movimento... La «macchina da presa allo stato puro», non nel suo egoismo ma nella sua volontà
di mostrare il popolo senza alcun artificio, di riprenderlo in ogni momento... ma non è sufficiente rappresentare
sullo schermo dei frammenti parziali della verità come briciole sparse. Questi frammenti devono essere
elaborati in un insieme organico che è a sua volta, la verità tematica (Manifesto dei Kinok).
In queste dichiarazioni febbrili c’è tutto il cinema di oggi, tutti i problemi del film
etnografico, del film di inchiesta televisivo e della creazione, molti anni dopo, delle «camere
viventi» di cui ci serviamo adesso.
E tuttavia, nessun cineasta al mondo è stato accolto così male, nessun ricercatore geniale è
stato così solo e sconosciuto; bisogna aspettare gli anni ‘60 perché realizzatori e teorici ritrovino le
tracce dei kinok, di coloro che facevano «dei film che producevano film».
Quando, nel 1920, Flaherty e Vertov avevano dovuto risolvere i problemi che si pongono
sempre al cineasta di fronte agli uomini che filma, la tecnica di ripresa era elementare, essendo la
realizzazione di un film più legata all’artigianato quindi all’arte che all’industria. La macchina da
presa di Nanook, antenato degli Eyemo, non aveva motore, ma possedeva già un mirino «reflex»
con obiettivi accoppiati. La macchina da presa del «cine-occhio», come quella che vediamo in
L‘uomo alla macchina da presa, era anch’essa a manovella, e «l’occhio in movimento» di Vertov
non poteva circolare che in un’automobile scoperta. Flaherty era solo (operatore, regista, addetto al
laboratorio, montatore, proiezionista); Vertov lavorava sempre con un operatore ed era responsabile
—-
—
di una piccola troupe tecnica (stranamente familiare: il fratello Michail alla macchina da presa, la
moglie al tavolo di montaggio anche Flaherty più tardi avrà la sua troupe familiare: il fratello
David alla seconda macchina, la moglie Frances come assistente).
È forse grazie a questa semplicità e a questa ingenuità (anche nella «cine-sofisticazione»),
che questi pionieri scoprirono i problemi essenziali che ci poniamo sempre: bisogna mettere in
scena la realtà, «la messa in scena della vita reale», come Flaherty o filmarla a sua insaputa come
Vertov «la vita colta alla sprovvista».
—
L’eclisse del cinema-industria
Ma, nel 1930, i progressi tecnici (il passaggio dal «muto» al «parlato») trasformano l’arte
cinematografica in industria e nessuno avrà il tempo di riflettere su ciò che fa, nessuno si porrà la
minima domanda sull’altro: il cinema bianco è diventato cannibale; è il momento del cinema
esotico e Tarzan, eroe bianco fra i neri selvaggi, non tarderà ad apparire.
Fare un film significa allora essere il capo di una decina di tecnici, utilizzare molte
tonnellate di materiale visivo e sonoro, essere il responsabile di centinaia di milioni (di franchi).
Quindi, piuttosto che mandare la macchina da presa fra gli uomini, sembra più semplice far
venire gli uomini verso la macchina da presa, in fabbrica. E Johnny Weissmuller, il più famoso re
della giungla, non lascerà il bosco sacro di Hollywood; sono i selvaggi d’Africa e i Tubi piumati
che verranno negli studi cinematografici.
Bisognava essere folli, come qualche etnografo, per tentare di utilizzare uno strumento così
vietato come una macchina da presa. Quando si vedono oggi i primi maldestri tentativi di Marcel
Griaule Au pays des Dogons, Sous les masques noirs o di Patrick O’ Reilly Bougainville, diventato
Popoko île sauvage, si comprende il loro scoraggiamento davanti al risultato di tanti sforzi, dopo il
passaggio di documenti ammirevoli nella macchina da presa, costretti a fare dei film con un
montaggio insensato, musica orientale, con un commento sportivo «newsreel»... Questo tradimento
poterono evitarlo nello stesso periodo (1936-1938) Margareth Mead e Gregory Bateson nella
realizzazione della serie Character formation in different cultures: 1. Bathing babies, 2. Childhood
rivalry in Bali and New Guinea, 3. First days in the life of a New Guinea baby, ma grazie all’aiuto
finanziario delle università americane che avevano compreso prima delle altre università che era
assurdo voler mischiare ricerca e commercio.
La rivoluzione tecnica del dopoguerra
È il nuovo sviluppo tecnico dovuto alla guerra che permetterà al film etnografico di
rinascere: l’arrivo del formato ridotto di 16 mm. Le macchine da presa leggere, che le armate
americane utilizzavano nelle campagne militari, non erano più i mostri da 35 mm ma strumenti
precisi e robusti, usciti direttamente dal cinema amatoriale. Verso la fine degli anni ‘40 alcuni
giovani antropologi, seguendo alla lettera il manuale di Marcel Mauss «Filmerete tutte le
tecniche...» riportano la macchina da presa fra gli uomini e se alcune spedizioni continuano a
sognare super-realizzazioni in 35 mm (fra le quali il bellissimo Pays des Pygmées che, fin dal 1947,
porta con sé dalla foresta equatoriale i primi autentici suoni registrati su disco), il 16 mm non tarda
ad imporsi.
Da allora la situazione cambia rapidamente. Nel 1951 appaiono i primi registratori autonomi
che, nonostante i loro trenta chili e i motori a manovella, sostituiscono un camion di parecchie
tonnellate. Nessuno crede in queste innovazioni tranne qualche antropologo che cominica ad
apprendere l’uso di questi strumenti bizzarri, che un professionista dell’industria cinematografica
non vuole neanche vedere: allora gli etnologici diventano registi, operatori, fonici, montatori e
anche produttori. E stranamente, Luc de Heusch, Ivan Polunin, Henri Brandt, John Marshall e io
stesso, siamo coscienti di inventare nello stesso tempo un nuovo linguaggio. Nell’estate 1955, al
Festival di Venezia, nella rivista di cinema «Positif», così presentavo il film etnografico:
Quali sono questi film? Quale barbaro nome li distingue dagli altri? Esistono davvero? Non saprei dirlo, ma so
che esistono dei rarissimi istanti in cui Io spettatore comprende all’improvviso una lingua sconosciuta senza
l’aiuto di alcun sottotitolo, partecipa a cerimonie misteriose, percorre città o paesaggi che non ha mai visto ma
che riconosce perfettamente... Questo miracolo solo il cinema può produrlo, ma senza che alcuna tecnica
speciale possa provocano: né il sapiente contrappunto di un montaggio, né l’impiego di un qualunque cinerama
stereofonico possono creare tali prodigi. Molto spesso, durante il più banale dei film, nella selvaggia giostra
dell’attualità, nei meandri del cinema amatoriale, un contatto misterioso si stabilisce. Il primo piano di un
sorriso africano, uno sguardo messicano alla macchina da presa, un gesto europeo così banale che nessuno
aveva ancora pensato a filmare, svelano il volto sconvolgente della realtà. E come se ci fossero più apparecchi
di ripresa, più registratori, più cellule fotoelettriche, più accessori e tecnici di quanti formino il grande rituale
del cinema classico. Ma i cineasti di oggi preferiscono non avventurarsi su queste strade pericolose e solo i
maestri, i folli e i bambini osano premere i bottoni vietati.
Ma presto lo sviluppo folgorante della televisione dà ai nostri mezzi irrisori i titoli della
nobiltà professionale. E per soddisfare le nostre esigenze (leggerezza, solidità, qualità) che intorno
al 1.960 i costruttori di registratori e di macchine da presa mettono a punto meraviglie come i
registratori autonomi e le macchine da presa silenziose e portatili. I primi ad usarli sono, negli Stati
Uniti, l’operatore Richard Leacock (Primay e Indianapolis) e in Francia, la troupe composta da
Edgard Morin, da Michel Brault e da me.
2. IL CINEMA ETNOGRAFICO OGGI
Così, oggi, disponiamo di apparecchi straordinari e, dal 1960, il numero e la qualità dei film
etnografici cresce ogni anno (nel 1971 per il primo festival Venezia Genti, più di 70 film recenti
furono inviati al comitato di selezione). Comunque il film etnografico, pur restando marginale e del
tutto particolare, non ha ancora trovato la sua strada, come se, dopo aver risolto i problemi tecnici,
dovessimo reinventare, come Flaherty o Vertov nel 1920, le regole di un nuovo linguaggio che
permetta di aprire le frontiere fra tutte le civiltà.
Non è nelle mie intenzioni fare qui il bilancio di tutte le tendenze e di tutte le esperienze, ma
di esporre quelle che mi sembrano più pertinenti.
Film etnografico e cinema commerciale
Benché non vi si opponga nulla dal punto di vista tecnico, i film etnografici che hanno
ottenuto una larga diffusione sono estremamente rari. Eppure, la maggioranza dei film etnografici
realizzati da qualche anno si presenta sempre come un prodotto di diffusione normale: titoli,
colonna sonora, montaggio sofisticato , commento stile grande pubblico, durata, ecc.
Si ottiene così il più delle volte un prodotto ibrido che non soddisfa né il rigore scientifico né
l’arte cinematografica.
Certo, qualche capolavoro o qualche opera originale sfugge a questa trappola che era
inevitabile (gli etnografi considerano il film come un libro e un libro di etnografia non si differenzia
da un libro ordinario).
Il risultato è un evidente accrescimento del prezzo di costo di questi film che rende ancora
più amara la quasi totale mancanza di diffusione, soprattutto quando il mercato del cinema resta
apertissimo a certi documenti sensazionali del tipo Mondo Cane. Evidentemente ci saranno sempre
delle eccezioni: The Hadza realizzato dal giovane cineasta Sean Hudson, in perfetta simbiosi con
l’antropologo James Woodburn, o Emu Ritual at Rugurie e tutta la serie austrialiana del cineasta
autore Roger Sandall, in collaborazione con un antropologo, o ancora The Feast in cui Timothy
Asch si è perfettamente integrato con l’inchiesta di Napoléon Chagnon presso gli Yanomani.
La soluzione del problema è lo studio di una rete di diffusione di questi film. A partire dal
momento in cui università, istituti culturali, circuiti televisivi non avranno bisogno, per diffondere i
nostri documenti, di renderli conformi agli altri prodotti, ma al contrario ne accetteranno le
differenze, un nuovo tipo di cinema etnografico, con dei criteri specifici, potrà svilupparsi.
Etnografo-cineasta o una troupe di cineasti ed etnografi
E per ragioni analoghe, per darsi «tutte le possibilità tecniche», che da qualche anno gli
etnografi preferiscono non filmare da sé e fare appello a una troupe di tecnici (in effetti, è piuttosto
una troupe di tecnici mandati da una società televisiva, che si rivolge poi all’etnografo).
Personalmente, sono – tranne per causa di forza maggiore – decisamente contro la troupe.
Le ragioni sono molte. Il tecnico del suono deve assolutamente comprendere la lingua della gente
che sta registrando: è dunque indispensabile che appartenga all’etnia filmata e che, inoltre, sia
minuziosamente preparato a questo lavoro. D’altra parte, con le tecniche attuali del cinema diretto
(il suono in sincrono) il regista non può che essere l’operatore. E soltanto l’etnografo, secondo me,
può sapere quando, dove, come filmare, cioè realizzare il film. Infine, e questo è senza dubbio
l’argomento decisivo, l’etnografo passerà un tempo molto lungo sul campo prima di iniziare una
qualunque ripresa. Questo periodo di riflessione, di apprendimento, di conoscenza reciproca può
essere lunghissimo (Robert Flaherty ha passato un anno alle isole Salomone prima di girare il più
piccolo spezzone di pellicola), ma questo è incompatibile con i programmi e i salari di una troupe di
tecnici.
I film di Asen Balikci sugli eschimesi Netsilik o la recente serie dei film di Jan Dunlop sui
Baruya della Nuova Guinea sono l’esempio ben riuscito di quello che non bisogna ricominciare a
fare: l’intrusione di una troupe troppo numerosa di tecnici su un terreno difficile, anche con la
mediazione di un antropologo. La realizzazione di un film è una rottura di divieto, ma, quando il
cineasta-etnologo è solo e non può appoggiarsi al suo gruppo di stranieri (due bianchi in un
villaggio africano sono già una comunità, un corpo estraneo, dunque, che rischia più facilmente il
rigetto...) l’impurità provocata può essere assorbita da lui solo. Mi sono sempre chiesto quale era
stata la reazione del piccolo gruppo di Eschimesi davanti ai pazzi bianchi che gli facevano ripulire il
campo dalle scatole di conserva...
Questa ambiguità, che non appariva nella serie Desert People senza dubbio in seguito al
«pezzo di pista» condiviso dai cineasti e dalla famiglia aborigena incontrata si manifesta
naturalmente nel film della Nuova Guinea, nel momento straordinario della fine della cerimonia, in
cui il gruppo responsabile dell’iniziazione non respinge realmente i cineasti, ma chiede al loro
amico antropologo di limitare la diffusione del film: esso poteva essere mostrato solo fuori della
Nuova Guinea rigetto a posteriori). In ogni caso, la pesantezza del processo tecnico era un ostacolo
alla «camera partecipante».
Per questo motivo mi sembra indispensabile iniziare gli studenti di antropologia alle
tecniche di registrazione dell’immagine e del suono e se i loro film sono tecnicamente molto
inferiori a quelli dei professionisti, avranno la qualità insostituibile di un contatto reale tra colui che
filma e coloro che saranno filmati.
—
—
—
Macchina da presa su supporto fisso o a spalla zoom o focale fissa
-
Quando, dopo la guerra del 1939-1945, le emittenti televisive americane cercavano dei film
(in particolare le serie Adventure di Sol Lesser o della CBS), il fatto di aver girato senza cavalletto
era sempre controproducente, a causa della mancanza di stabilità. Ciò nonostante, la maggior parte
dei reportages di guerra in 16 mm (fra cui lo straordinario Memphis Bell, sulle vere avventure di una
fortezza volante, girato in 16 mm e primo film ingrandito a 35 mm) erano stati filmati con la
macchina da presa a spalla. Ma in effetti, se qualcuno di noi prendeva esempio da questi pionieri e
filmava senza cavalletto, era soprattutto per economia di mezzi e per permettere spostamenti rapidi
fra due riprese, perché la macchina da presa era ferma per la maggior parte del tempo, ogni tanto
«panoramica- va» e, eccezionalmente, si spostava (effetto «gru» provocato dall’inginocchiarsi
dell’operatore o carrellata in automobile).
Ci volle l’audacia della giovane troupe del National Film Board di Montreal perché la
macchina da presa uscisse da questa immobilità. Nel 1954 Corral di Koenig e Kroitor indicò la
strada che nel 1959 avrebbe portato al piano, oggi classico, della carrellata con la macchina in
spalla, seguendo la pistola del guardiano di banca in Bientôt Noël. Quando Michel Brault venne a
girare a Parigi Chronique d’un été, questa fu una rivelazione per tutti noi e per gli operatori della
televisione (il piano di Primary in cui Leacock segue l’entrata in scena di J.F. Kennedy è stato
senza dubbio il capolavoro di questo nuovo stile di ripresa).
I costruttori di macchine da presa hanno poi fatto sforzi considerevoli per migliorare la
maneggevolezza e l’equilibrio degli apparecchi di ripresa. E oggi tutti gli operatori di «cinema
diretto» sanno camminare con la loro macchina da presa, che è diventata «la camera vivente», il
«cine-occhio» di Vertov. Nell’ambito del cinema etnografico, questa tecnica mi sembra
particolarmente efficace, perché permette di adattarsi all’azione in funzione dello spazio, di
penetrare la realtà piuttosto che lasciarla svolgere davanti all’osservatore.
Alcuni cineasti, comunque, continuano a utilizzare molto spesso il cavalletto spesso per
rigore tecnico È questo, secondo me, il maggior difetto dei film di Roger Sandall e soprattutto
dell’ultimo film di Jan Dunlop in Nuova Guinea (e non è un caso che si tratti di cineasti australiani,
perché i migliori cavalletti e le migliori «teste panoramiche» sono fabbricate a Sydney!).
L’immobilità dell’apparecchio di ripresa sembra compensato dalla frequente utilizzazione di
obiettivi a focale variabile (zoom) che permettono un effetto ottico di carrellata. Tuttavia questo
espediente non riesce a far dimenticare la rigidità della macchina da presa che vediamo allontanarsi
o avvicinarsi artificiosamente da un solo punto di vista. Malgrado la seduzione evidente di questi
languidi balletti, bisogna riconoscere che questi movimenti ottici in avanti o all’indietro non
avvicinano la macchina da presa alle persone filmate, ma essa rimane a distanza e l’occhio zoom è
piuttosto simile a quello del voyeur che guarda, che esamina i dettagli dall’alto della sua lontana
postazione.
L’arroganza involontaria della ripresa non soltanto è percepita a posteriori dallo spettatore
attento, ma più ancora dalle persone filmate come un posto di osservazione. Per me, dunque, la sola
maniera di filmare è di camminare con la macchina da presa e di condurla là dove è più efficace e di
improvvisare con lei un altro tipo di balletto, nel quale la macchina diventa viva come le persone
che filma.
—
—.
È questa la prima sintesi tra le teorie vertoviane del «cine-occhio» e la «camera
partecipante» di Flaherty. Questa improvvisazione dinamica che io paragono spesso
all’improvvisazione del torero davanti al toro qui, come in quel caso, niente è stabilito dall’inizio e
la soavità di una faëna non è altro che l’armonia di una carrellata a spalla perfettamente adeguata ai
movimenti delle persone filmate.
Qui, ancora una volta, è un problema di allenamento, di una padronanza del corpo, che una
ginnastica adatta permette di acquisire. Allora, invece di usare lo zoom, l’operatore cineasta penetra
realmente nel suo soggetto, precede o segue il danzatore, il prete o l’artigiano, non è più se stesso
ma un «occhio meccanico» accompagnato da «un orecchio elettronico». È la bizzarra
trasformazione della persona del cineasta che ho chiamato, per analogia con i fenomeni di
possessione la «cine-trance».
—
—
3. MONTAGGIO
Il cineasta operatore del cinema diretto è il suo primo spettatore nel mirino della macchina
da presa. Qualsiasi improvvisazione gestuale (movimenti, inquadrature, durata dei piani) confluisce
in un montaggio al momento della ripresa: ritroviamo qui la concezione di Vertov: «... ‘il cineocchio’ è: monto quando scelgo il mio soggetto (tra i mille soggetti possibili). Monto quando
osservo (filmo) il soggetto (realizzare la scelta utile fra mille osservazioni possibili...» (A.B.C. dei
Kinoki). Infatti lo stesso lavoro sul campo determina la specificità del procedimento del cineastaetnografo, perché invece di elaborare la redazione dei suoi appunti dopo la ricerca sul campo, deve,
a rischio di fallire, tentarne la sintesi nel momento stesso dell’osservazione, condurre, cioè, il suo
racconto cinematografico, ingrandirlo o arrestarlo, di fronte all’avvenimento. Qui non si tratta più di
un piano di montaggio scritto in precedenza, né di macchine da presa che fissano un ordine di
sequenze, ma di un gioco ben più arrischiato dove ogni piano è determinato dal piano precedente e
determina il piano seguente. È evidente che riprese in sincrono di questo tipo richiedono un
affiatamento perfetto fra l’operatore e il tecnico del suono (che, lo ripeto, deve capire bene la lingua
parlata dalle persone filmate e svolge un ruolo essenziale in questa avventura). Se la troupe «cineocchio» e «cine-orecchio» è bene allenata, i problemi tecnici devono essere risolti da semplici
riflessi (messa a fuoco, diaframma) e il cineasta e il suo doppio sonoro sono disponibili a questa
creazione spontanea. «Cine-occhio = cine-vedo (vedo con la macchina da presa) + cine scrivo
(registro con la macchina da presa sulla pellicola) + cine-organizzo (monto)» (A.B.C. dei
Kinoki).
E fin dalla ripresa, con un semplice sguardo nel mirino, con il semplice ascolto delle cuffie,
la troupe di realizzazione riconosce immediatamente la qualità di quello che ha registrato, si ferma
se ha fallito (per prendere un’altra strada), continua se procedere bene, a concatenare le frasi di un
racconto che si crea nel momento stesso dell’azione, è questa, per me, la vera «camera
partecipante».
Il secondo spettatore è il montatore. Non deve mai partecipare alle riprese, ma essere il
secondo «cine-occhio»; non sapendo niente del contesto, vede e sente solo quello che è stato
registrato (quali che siano state le intenzioni del cineasta). Questo significa che il montaggio tra
l’autore soggettivo e il montatore oggettivo è un dialogo aspro e difficile, ma da cui dipende il film.
Anche qui non esiste una ricetta sempre valida: «Associazione (addizione, sottrazione,
moltiplicazione, divisione e messa in parentesi) di spezzoni filmati della stessa natura. Scambio
incessante di questi spezzoni immagine finché non siano collocati in un ordine ritmico dove le
interconnessioni di senso coincidano con le interconnessioni visive». (A.B.C. dei Kinoki). Ma
una tappa supplementare, non prevista da Vertov, mi sembra indispensabile: è la presentazione della
prima versione del film (un «assemblaggio» ordinato) alle persone filmate e la cui partecipazione è
essenziale per me (tornerò più avanti su questo punto).
Commento, sottotitoli, musica…
Non è possibile far passare due messaggi sonori simultaneamente, uno sarà sempre sentito a
svantaggio dell’altro. L’ideale sarebbe realizzare un film il cui suono fosse il suono originale.
Purtroppo il film etnografico presenta in generale delle culture straniere complesse, uomini che
parlano una lingua sconosciuta.
Il commento, derivato direttamente dal film muto o dal film-conferenza, sembra la soluzione
più semplice; è il discorso diretto dell’autore, intermediario fra l’altro e il sé. Questo discorso che
dovrebbe essere soggettivo è molto più spesso oggettivo, in forma di manuale o di esposizione
scientifica, che accumula il massimo di informazioni complementari. Allora, curiosamente, invece
di chiarire le immagini, il commento le oscura, le maschera fino a sostituirsi ad esse: questo non è
più un film, è una conferenza, una dimostrazione su sfondo visivo animato, mentre invece la
dimostrazione dovrebbe essere fatta dalle immagini stesse. Sono rari i film etnografici dove il
commento è il contrappunto delle immagini. Ne citerò due: Terre sans pain di Luis Buñue1, in cui
il testo di Pierre Unik, violentemente soggettivo apporta la crudeltà orale necessaria a una visione
spesso insostenibile; The hunters di John Marshall dove il cineasta ci guida in un racconto molto
semplice sulla pista delle giraffe e dei loro cacciatori: il film, d’altra parte, diventa sia l’avventura
dei cacciatori e della loro preda che quella del cineasta.
Quando la nuova attrezzatura ha permesso di girare in sincrono, i film etnografici, come tutti
i film del cinema diretto, sono diventati loquaci e il commento ha tentato l’operazione impossibile
di un doppiaggio in un’altra lingua. Sempre più spesso, per la preoccupazione di avvicinarsi alle
regole di qualità del cinema di spettacolo, si fa appello ad attori professionisti per dire questo
«commento». Il risultato, tranne rare eccezioni, è penoso; invece di tradurre, di trasmettere, di
avvicinare, questo genere di discorso tradisce, svia, allontana. Personalmente, ho preferito, dopo
alcune brutte esperienze (la versione americana di La chasse au lion à l’arc), dire io stesso, in
cattivo inglese, con un attivo accento, i testi dei miei film (Les maîtres-fous).
Sarebbe comunque molto interessante studiare lo stile dei commenti dei film etnografici
dagli anni ‘30; come siano passati dal barocco coloniale all’esotismo avventuroso, quindi alla
secchezza di un bilancio scientifico, e, di recente, sia alla distanza sdegnosa di antropologi che non
vogliono ammettere il loro interesse per la gente che studiano, sia al discorso ideologico in cui il
cineasta esporta verso l’altro la rivolta che non è stato capace di fare nel proprio paese: si otterrebbe
così un profilo caratteristico nello spazio e nel tempo dei ricercatori della nostra disciplina, che
nessun libro, che nessuna conferenza potrebbe delineare.
I titoli e i sottotitoli appaiono, quindi, come i mezzi più efficaci per sfuggire alla trappola del
commento. È stato John Marshall, secondo me, ad utilizzare per primo questo procedimento nella
serie Kalahari del Peadbody Museum e The pond, un film molto semplice girato in sincrono sulle
chiacchiere e la conversazione raffinata di bushmen su una sorgente d’acqua, resta un modello del
genere. Ciò nonostante non bisogna nascondersi le difficoltà del procedimento: oltre alla
mutilazione dell’immagine, l’ostacolo più difficile è quello del tempo di lettura: come nel cinema di
spettacolo, il sottotitolo non può essere che una sintesi di ciò che è stato detto. Ho cercato di
utilizzarlo per un film in sincrono sui cacciatori di leoni (Un lion nommé l’Americain), ma non è
stato possibile trascrivere in maniera soddisfacente la difficile traduzione del testo essenziale (le
lodi del veleno di freccia), recitato al momento della morte del leone (non ci sarebbe stato il
necessario tempo di lettura); ho dovuto dire io il testo (il tempo di ascolto e molto più corto) che
arriva in sovrimpressione sonora sul testo originale. In effetti, il risultato è deludente, perché anche
se questo testo esoterico assume in quel momento un valore poetico, non aggiunge nessuna
informazione complementare. Oggi sono tornato a una versione senza commento né sottotitoli.
Inoltre sarebbe miracoloso poter accedere in venti minuti a conoscenze e tecniche complesse che
richiedono agli stessi cacciatori decine di anni di apprendimento. Il film, in questo caso, non
sarebbe che una porta aperta su questa scienza; permette a coloro che vogliono saperne di più di
consultare l’opuscolo (l’esemplare Ethnografic companion to film) che deve ormai accompagnare
ogni film etnografico.
Segnalerò, per farla finita con titoli e sottotitoli, l’eccellente tentativo di Timothy Asch in
The feast, in cui, in un preambolo con immagini ferme delle sequenze principali, le spiegazioni
sono date a priori. Il film è poi titolato e sufficientemente sottotitolato per indicare chi agisce e cosa
fa. Certo, questo procedimento demistifica il film dall’inizio, ma è, secondo me, il tentativo più
originale fatto fino ad oggi.
Dirò poco sulla musica di accompagnamento. I brani di musica originale sono stati (e sono
ancora) la base della colonna sonora della maggior parte dei film documentari (e di tutti i film
etnografici degli anni ‘50). Si trattava, una volta di più, di «fare del cinema». Mi sono accorto molto
presto (1953) della falsità di questo sistema proiettando ai cacciatori di ippopotami del Niger il film
Bataille sur le grand fleuve girato dieci anni prima insieme a loro. Nel momento dell’inseguimento
dell’ippopotamo, avevo montato, sulla banda sonora, un commovente «canto dei cacciatori», una
musica di viola su un tema di caccia, che mi sembrava si adattasse particolarmente a questa
sequenza. Il risultato è stato deplorevole: il capo dei cacciatori mi ha chiesto di eliminare la musica
perché l’inseguimento doveva essere assolutamente silenzioso... Dopo questa avventura ho fatto
molta attenzione nell’uso della musica nei film e sono convinto che anche nel cinema di spettacolo
si tratti di una convenzione completamente teatrale e superata: la musica avvolge, addormentata,
copre i cattivi raccordi, dà un ritmo artificioso a immagini che non ne hanno e che non ne avranno
mai, insomma è l’oppio del cinema (purtroppo la televisione sfrutta la mediocrità del
procedimento). Credo che alcuni ammirevoli film giapponesi, come Papua new life e soprattutto
Kula, Argonauts of the Pacific, siano rovinati dalla salsa musicate con la quale sono serviti.
Invece, viva la musica che accompagna realmente un’azione, musica profana o rituale, ritmo
di lavoro o di danza. E, anche se si tratta di un argomento diverso, bisogna qui segnalare la notevole
importanza che ha e avrà la tecnica del film in sincrono nell’ambito dell’etnomusicologia.
Il montaggio sonoro (ambiente, parole, musica) è certamente complesso quanto il montaggio
visivo, ma penso che dobbiamo sbarazzarci di quei pregiudizi che vengono dalla radio e consistono
nel trattare il suono con più rispetto dell’immagine. Molti film recenti di cinema diretto sono
rovinati dall’incredibile rispetto per le chiacchiere delle persone filmate, come se una testimonianza
orale fosse più importante di una testimonianza visiva: là dove un cineasta non esita a tagliare un
gesto in movimento, non oserà tagliare un tema musicale prima dell’ultima nota d’organo. Credo
che questo tic arcaico (di cui la televisione fa largo uso) non tarderà a scomparire e l’immagine
ritroverà la sua priorità.
Il pubblico del cinema etnografico: film di ricerca e di diffusione
Quest’ultimo punto (quest’ultimo anello che potrebbe essere il primo se ci si facesse un
processo alle intenzioni) è oggi essenziale per il cinema etnografico. Dovunque, in Africa, nelle
università, nei centri culturali, in televisione, al Centre National de la Recherche Scientifique, alla
Cinémathèque française, la prima domanda che viene posta dopo la proiezione di un film
etnografico è: «Per chi, perché, avete realizzato questo film?».
Per chi, perché la macchina da presa fra gli uomini? La mia risposta sarà sempre la stessa:
«Per me». Non si tratta di una droga particolare la cui «mancanza» si farebbe sentire regolarmente,
ma perché, in certi momenti, in certi luoghi, presso gente di un certo tipo, la macchina da presa
(soprattutto la macchina da presa per la ripresa in sincrono) mi sembra essere necessaria. Sarebbe
sicuramente possibile giustificare l’impiego per ragioni scientifiche (realizzazione di archivi
audiovisivi di culture in via di trasformazione o di sparizione) o politiche (appoggio alla rivolta di
fronte a una situazione intollerabile) o estetiche (la scoperta del fragile capolavoro di un paesaggio,
di un viso, di un gesto che è impossibile lasciare svanire), ma in effetti, si sente improvvisamente la
necessità di filmare o, in circostanze molto analoghe, la certezza che non bisogna filmare.
La frequentazione delle sale cinematografiche, l’uso intempestivo dei mezzi audiovisivi
faranno di noi dei kinok alla Vertov, dei «cine-occhi», così come una volta c’erano le «mani-penne»
(Rimbaud) che non potevano trattenersi dallo scrivere: «Ero là, mi accadde questo» (La Fontaine).
E se il cine-voyeur della propria società saprà sempre giustificarsi per questa sua particolare
attività, quale motivo possiamo dare noi antropologi agli sguardi che gettiamo, al di là del muro,
sull’altro?
Certo questo processo riguarda tutti gli antropologi, ma mai un libro o un articolo è stato
messo in discussione come un film antropologico. E questa sarà forse la mia seconda risposta: il
film è il solo mezzo di cui dispongo per mostrare all’altro come lo vedo. In altri termini, per me, il
pubblico è innanzitutto (dal piacere della «cine-trance» alla ripresa e al montaggio) l’altro, la
persona che ho filmato.
Allora la posizione è molto più chiara: l’antropologo ha ormai a disposizione un solo
strumento «la camera partecipante» che gli offre questa straordinaria possibilità di comunicazione
con il gruppo studiato, il film che ha realizzato su di esso. Non possediamo ancora tutti gli
accorgimenti tecnici (la messa a punto del proiettore super 8 sonoro, autonomo, con batterie di 12
volts costituirà un serio progresso), ma gli esperimenti che ho potuto fare con un proiettore 16 mm
sistemato alla meglio e un piccolo generatore portatile da 300 watts, sono già decisivi: la proiezione
del film Sigui 69 nel villaggio di Bongo dove era stato realizzato, ha suscitato fra i Dogon della
falesia di Bandiagara reazioni considerevoli e la richiesta della realizzazione di nuovi film, a cui si
sta attualmente lavorando. La proiezione di un film, Horendi, sull’iniziazione dei danzatori di
possessione del Niger, mi ha permesso, studiando il film in moviola, di raccogliere presso i preti
responsabili del rito più informazioni in quindici giorni di lavoro che in tre mesi di osservazione
diretta e di interviste agli stessi informatori. E qui ancora, una nuova richiesta di fare un film.
L’informazione a posteriori sul film non è che all’inizio, ma introduce fra l’antropologo e il gruppo
studiato relazioni completamente nuove, prima tappa di quella che alcuni di noi chiamano già
«l’antropologia condivisa». Finalmente l’osservatore esce dalla sua torre d’avorio; la sua macchina
da presa, il suo registratore, il suo proiettore lo hanno condotto su uno strano cammino iniziatico al
cuore stesso della conoscenza e, per la prima volta, è giudicato sul posto, non da una commissione
di tesi, ma dagli stessi uomini che è venuto ad osservare.
Questa straordinaria tecnica di feed-back (che io tradurrei con «contro-scambio
audiovisivo») non ha ancora rivelato tutte le sue possibilità, ma ormai, grazie ad essa, l’antropologo
non è più l’entomologo che osserva l’altro come un insetto (quindi il niente), ma uno stimolatore di
conoscenza reciproca (quindi di dignità).
La ricerca di una partecipazione totale, per quanto idealistica possa essere, mi sembra oggi,
moralmente e scientificamente, la sola attività possibile per un antropologo. E allo sviluppo degli
aspetti tecnici (super 8, video), che i costruttori devono dedicare i loro sforzi.
Ma sarebbe evidentemente assurdo condannare il film etnografico al circuito chiuso delle
informazioni audiovisive. Perciò la mia terza risposta alla domanda «Per chi?» è: «Per il più gran
numero di gente possibile, per tutti i pubblici». Credo che se la diffusione dei nostri film etnografici
è limitata (tranne rarissime eccezioni) negli spazi discreti delle università, delle società scientifiche
e degli organismi culturali, la causa non risiede nella carenza di distribuzione dei film di spettacolo,
ma proprio nei film che realizziamo. È tempo che i film etnografici divengano dei film.
Se le conferenze di esploratori, se le serie televisive di stile «avventuroso» hanno tanto
successo, questo si deve al fatto che, io ripeto, dietro le immagini maldestre si sente la presenza di
chi le ha girate. Fino a quando l’antropologo-cineasta, per scientismo, per orgoglio ideologico, si
nasconderà dietro un confortevole incognito, castrerà irrimediabilmente i suoi film che finiranno
nelle nostre cineteche fra i documenti di archivio riservati a qualche specialista. Il successo della
pubblicazione in collezione economica (livre de poche) di opere etnografiche fino a quel momento
relegate a una piccola rete di scambi fra biblioteche scientifiche dovrebbe essere l’esempio da
seguire per il film etnografico. E in attesa di realizzare dei veri film etnografici, riprendendo in
questo senso la definizione chiara che gli davamo vent’anni fa: «...film che uniscono al rigore
scientifico il linguaggio cinematografico...», il Comitato del Film Etnografico e Sociologico ha
deciso, all’ultimo Festival di Venezia (Venezia Genti, 1972), di creare con l’aiuto dell’U.N.E.S.C.O.
un fondo di conservazione, di documentazione dei «film dell’uomo». Perché qualcun’altro insieme
a noi crede che il mondo di domani, il mondo che stiamo costruendo, sarà vivibile soltanto se terrà
conto delle differenze esistenti fra le culture, se avrà deciso di non negare l’altro uniformandolo alla
propria immagine. Per questo è necessario conoscerlo e non esiste per questa conoscenza miglior
mezzo del cinema etnografico.
Questo non è un pio desiderio, l’esempio ci viene dall’Estremo Oriente, dove una
compagnia televisiva giapponese, con lo scopo di far uscire i Giapponesi dalla loro insularità, ha
deciso di trasmettere una volta alla settimana, per tre anni, un’ora di film etnografici...
4. CONCLUSIONE. CINE-ANTROPOLOGIA CONDIVISA
Eccoci, quindi, al termine del nostro itinerario sulle tracce della macchina da presa fra gli
uomini, ieri e oggi. La sola conclusione che è possibile trarre per il momento, è che il film
etnografico non ha superato lo stadio sperimentale e se gli antropologi dispongono di uno strumento
fantastico, non sanno ancora servirsene bene.
Non esistono ancora, anche se ci sono tendenze di questo tipo, «scuole di cinema
etnografico». Personalmente, mi auguro che questa situazione marginale continui, al fine di evitare
che una disciplina giovane sia paralizzata da norme capestro o da una burocrazia sterilizzante. È
positivo che i film etnografici americani, canadesi, giapponesi, brasiliani, australiani, olandesi,
inglesi o francesi siano così diversi.
All’universalità dei concetti dell’approccio scientifico, noi opponiamo concezioni diverse:
se i «cine-occhi» di tutti i paesi sono pronti ad unirsi, non è per avere uno sguardo universale. Come
ho già detto, accade che il cinema delle scienze umane sia, in un certo senso, all’avanguardia della
ricerca cinematografica. E se, fin da oggi, nella diversità dei film recenti, si vendono apparire
tendenze simili, come per esempio la moltiplicazione dei «piani sequenza» (ho chiesto a un
costruttore di macchine da presa leggere di realizzare un caricatore di 300 metri in 16 mm che
consenta un’autonomia di ripresa di mezz’ora), significa che qui o altrove le nostre esperienze
hanno condotto alle stesse conclusioni e che così nasce un nuovo linguaggio cinematografico.
E domani? Domani sarà il momento del video autonomo a colori, del montaggio su nastro
magnetico, della restituzione istantanea dell’immagine registrata, quindi, del sogno congiunto di
Vertov e Flaherty, di un «cineocchio-orecchio meccanico» e di una macchina da presa talmente
«partecipante», che passerà direttamente nelle mani di coloro che fino ad ora le stavano davanti.
Allora l’antropologo non avrà più il monopolio dell’osservazione, sarà lui stesso ad essere
osservato, registrato, lui e la sua cultura.
Così il film etnografico ci aiuterà a «condividere» l’antropologia 4.
4
L’autore alla fine del saggio riporta 1e seguenti referenze bibliografiche:
F. REGNAULT, Les attitudes du repos dans les races humaines, in «Revue encyclopédique 1896», 1896, pp. 9
12.
F. REGNAULT, Le grimper, in «Revue encyclopédique 1897», 1897, pp. 904-905.
F. REGNAULT, La chronofotographie dans l’ethnographie, in «Bulletins et Mémoires de la Societé
d’Anthropologie de Paris I», 1900, pp. 421-422:
L. AZOULAY, L’ère nouvelle des sons et des bruits, in «Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie
de Paris 1», 1900, pp. 172-178.
L. AZOULAY, Sur la constitution d’une musée phonographique, in «Bulletins et Mémoires de la Société
d’Anthropologie de Paris 1», 1900, pp. 222-226.
D. VERTOV, Kinoki Perevorot, in «Lef», 1923, ripubblicato in parte in «Cahiers du Cinema», n. 144, 1963
pp. 32-34 [trad. it. I Kinoki. Un rivolgimento, in D. VERTOV, L’occhio della rivoluzione, a cura di P. Montani, Milano,
Mazzotta, 1975, pp. 33-34].
D. VERTOV, History of the Newreel (in russo), in «Kino», 1940, tratto da J, ROUCH, Le film ethnographique,
in «Ethnologie générale», Paris, Gallimard, 1968, pp. 443-444 [i brani riportati sono tradotti in italiano con il titolo: Dal
Kinoglaz al Ragioglaz (Dall’Alfabeto dei Kinoki), in D. VERTOV, L’occhio della rivoluzione, a cura di P.. Montani,
Milano, Mazzotta, 1975, pp. 136-143].
A. LEROI-GOURHAN, Cinéma et sciences humaines: le film ethnographique existe-t-il?, in «Revue de
Géographie Humaines et d’Ethnologie», n. 3, 1948, pp. 42-51.
J. ROUCH, A propos des films ethnographiques, in «Positif», n. 14 15. 1955.
L. DE HEUSCH, The Cinema and Social Science, in «Reports and Papers in the Social Sciences», Paris,
UNESCO, n. 16, 1962. [N.d.T.]
pp. 79-109
Il «cinéma plaisir» *
Ho registrato l’intervista a Jean Rouch il 22 dicembre 1986, a Parigi, nella sede del Comité du Film Ethnographique,
presso il Musée de l’Homme. [Nd.T.]
Vorrei aprire quest’incontro, fissando le tappe essenziali della sua attività di etnologocineasta. Come e quando ha iniziato a interessarsi al cinema e all’etnologia?
Quando frequentavo la Cinémathèque Française, alla fine degli anni Trenta insieme a
Langlois vedevo molti film. Io e i miei amici pensavamo che il cinema fosse qualcosa di
straordinario. Quando vedevamo film come !Que viva Mexico! di Ejzenstejn, l’entusiasmo era così
forte che ci veniva voglia di fare cinema, ma sapevamo che non era possibile.
Il cinema era riservato a un gruppo di persone molto particolare nel quale era difficile
entrare, molto più difficile di oggi. Le incontravamo alla Cineteca, ma non riuscivamo a entrare in
contatto con loro.., era un mondo vietato.
Ma, vedendo questi film, avevamo voglia di farne. Allora durante lunghe passeggiate in
montagna ci fermavamo vicino alle rocce. Ci nascondevamo come gli indios che apparivano nel
film di Ejzenstejn, facevamo delle foto e rimettevamo in scena il film. Giocavamo a fare il cinema,
facendo fotografie. Lo stesso accadeva per Quai des brumes con Michel Morgan e Gabin:
conoscevamo la sceneggiatura a memoria e ci recitavamo i dialoghi fra noi. La lingua di Quai des
brumes non era vera, ma era stata inventata da Prévert, che aveva creato quella specie di dialetto
che i personaggi parlavano nel film e noi cercavamo di imitarlo. Tuttavia non si trattava soltanto di
amore per il cinema, ma anche di una riflessione su di esso. Avevamo dunque una grande curiosità.
Eravamo nell’ambiente del cinema, ma non sapevamo cosa bisognava fare...
Nel 1937, quando venne aperto il Musée de l’Homme, studiavo a l’Ecole de Ponts et
Chaussées per diventare ingegnere, nello stesso tempo seguivo dei corsi di etnologia al museo,
perché questo mi aveva sempre interessato. Poi sono partito per l’Africa con due miei compagni
dell’Ecole des Ponts, perché eravamo stati arrestati dai tedeschi in Bretagna durante le vacanze di
Pasqua. Era la Pasqua del 1941 ed era necessario per noi lasciare ufficialmente la Francia occupata,
altrimenti le nostre famiglie avrebbero rischiato delle ritorsioni. Siamo partiti come ingegneri dei
lavori pubblici delle colonie e quindi la causa del mio primo contatto con l’Africa era dovuto alla
necessità di fuggire dalla Francia. Non era un problema di scelta, ma l’unica maniera per
raggiungere poi l’Inghilterra e quindi De Gaulle e di riprendere la lotta... La sconfitta della Francia
nel ‘39 era stata un avvenimento molto drammatico per giovani come me e i miei compagni, non
potevamo sopportare quest’avventura, non potevamo sopportare di aver abbandonato la guerra
quasi senza combattere. Facevamo saltare i ponti, ma non era sufficiente, non avevamo alle spalle
l’appoggio necessario. A Parigi ci dedicavamo a piccole azioni di sabotaggio, erano atti poetici:
invertivamo i cartelli indicatori dei comandi tedeschi, scrivevamo con il gesso il segno della vittoria
sulle automobili. Queste stupide azioni di sabotaggio potevano diventare gravi nel caso ci avessero
arrestato.
Per questo, partito per l’Africa e dopo un viaggio molto lungo, ho scoperto il Niger. A
Niamey ho cominciato ad essere interessato dalle popolazioni africane e dalle ricerche etnologiche.
La ragione è molto semplice. Non avevamo mezzi, non c’era benzina, avevamo solo camion a gas e
costruivamo le volte dei ponti come gli egiziani e i romani, trasportando il materiale sulla testa. Ero
molto giovane ed ero responsabile dei cantieri di costruzione delle strade, dove lavoravano 20.000
persone. I problemi umani erano di gran lunga i più importanti e il punto di partenza del mio
interesse per l’etnografia è l’agosto 1942, quando in uno dei miei cantieri vicino a Niamey un
fulmine ha ucciso dieci persone. Allora il responsabile di quel cantiere mi ha mandato un messaggio
piegato in un pezzo di legno, una «lettera-telegramma», per avvertirmi. Gli africani che si trovavano
lì, mi hanno detto: «No, questa faccenda non ci riguarda...», «Non ci riguarda, l’uomo folgorato è
un uomo impuro».
Io avevo seguito qualche corso di etnologia tenuto da Marcel Griaule al Musée de l’Homme,
ma prima della guerra l’etnologia era essenzialmente l’arte negra, l’avanguardia, Michel Leiris, il
surrealismo, l’invenzione di forme nuove. Non ne sapevo niente di più.
A questo punto un giovane che lavorava nei servizi, un pescatore che si chiamava Damouré
Zika mi ha detto: «Questo fatto riguarda mia nonna». Siamo partiti insieme per il suo villaggio. Là
ho assistito a fantastiche danze di possessione in cui il genio del tuono è venuto ad aiutare questa
vecchia donna a sputare del latte sui corpi folgorati per purificarli, spiegando le ragioni della sua ira.
Io non capivo niente, vedevo della gente posseduta. Non sapevo altro.
Siamo tornati a Niamey dove ho cominciato a fare domande a Damouré. Poi sono tornato
più volte a trovare la nonna. Qualche giorno dopo un pescatore era stato ucciso nel fiume e non si
sapeva se era stato fulminato durante un temporale oppure se era annegato. Furono riorganizzate
allora altre danze di possessione in riva al fiume di cui Cayà, la nonna, era la responsabile. Il genio
del tuono è venuto e ha detto: «Non sono stato io, ma il genio dell’acqua». Quindi il pescatore era
annegato. Ho subito scritto un resoconto che ho spedito a Griaule, al Musée de l’Homme. E stato il
mio primo lavoro etnografico, corredato dalle fotografie che avevo sviluppato nel gabinetto
radiologico dell’ospedale di Niamey. Nell’ultima lettera ricevuta da Parigi, attraverso la zona non
occupata, Griaule mi rispose, facendomi delle critiche e chiedendomi di porre questa domanda (era
Germaine Dieterlen che l’aveva suggerita): «L’annegato aveva forse l’ombelico o le narici
tagliate?». Ho fatto la domanda a Cayà che mi ha risposto: «Se sai questo, perché mi fai delle
domande?». Dunque mi stavo occupando di qualcosa di misterioso che era per me un segno di ciò
che poteva essere la ricerca etnografica.
E il cinema?
E mi dicevo: «Ho fatto delle foto, ma bisognerebbe filmare queste cose». Avevo in testa
l’idea che si potesse fare un film.
Quando è iniziata la seconda parte della guerra, con lo sbarco alleato, ho percorso il
cammino inverso risalendo la valle del Rodano attraverso tutta la Germania fino a Berlino. Era la
fine della guerra e Berlino era una città straordinaria e vedendo questa Berlino straordinaria ho
deciso di fare un film su di essa, un film che sarebbe stato semplicemente la giornata di una delle
innumerevoli Marlène Dietrich, che si prostituivano per vivere, che scambiavano una notte per una
bottiglia di liquore. in questa situazione sarebbe stato interessante fare del cinema. Ero stato il
primo ad aprire l’insediamento del settore francese e girando per Berlino entravo in contatto con
una grande quantità di cose. Una volta mi trovai in un magazzino del servizio cinematografico
dell’esercito tedesco dove c’era pellicola e alcune macchine da presa Arriflex 35 mm, che era
possibile comprare a buon prezzo scambiandole con alcune bottiglie di liquore.
Sono tornato a Parigi pensando che sarebbe stato possibile realizzare un film. Ho parlato con
gli amici che avevo conosciuto alla Cineteca, fra i quali Yannik Bellon, che è diventato regista e che
ha preso un premio a Venezia proprio nel primo dopoguerra con Goëmons. Yannik Bellon mi disse
che fare un film era una cosa complicata, ci voleva una troupe e una lunga preparazione, sono
tornato a Berlino molto deluso e non ho comprato la cinepresa. Potevo avere la cinepresa, la
pellicola, potevo fare un film muto.., ma ancora una volta era un atto vietato. Non si poteva fare un
film senza un operatore. Ho quindi abbandonato quest’idea e mi sono ritrovato con alcuni amici che
erano partiti per l’Africa con me a studiare per ottenere una laurea in filosofia. C’eravamo
conosciuti in Africa quando io ero stato espulso dal Niger nel 1942 da un governatore legato a
Petain. Avevo risalito una parte del fiume Niger, esplorando così quella zona dell’Africa, mentre un
altro mio amico, che aveva avuto dei problemi politici, lo aveva percorso nell’altro senso. A
Bamaco ci siamo incontrati e abbiamo deciso di discenderlo dopo la guerra in piroga. Oltre alla
laurea in antropologia con Griaule, abbiamo ottenuto anche quella in filosofia morale e psicologia e
abbiamo cominciato a lavorare al nostro progetto. Alla metà del 1946, abbiamo potuto organizzare
una spedizione per discendere il Niger in piroga. Ho deciso di fare un film e per questo mi sono
messo in contatto con le persone che conoscevo nel cinema. All’Institut des Hautes Etudes
Cinématographiques, Sechan, uno dei primi operatori usciti dalla scuola mi consigliò di andare a
parlare con i produttori, di raccontare la mia idea. Uno dei produttori mi ha detto: «Vi do i soldi per
fare il film, ma solo se portate con voi Fernandel a Timbuctù». Non gli interessava fare un film
documentario. Raccontai questo fatto al mio amico Sechan, che partiva anche lui con una
spedizione organizzata dal Musée de l’Homme, verso la regione abitata dai Pigmei. Sechan mi disse
allora di andare al mercato delle Pulci e cercare una cinepresa, perché se ne trovavano di ottime,
provenienti dall’esercito americano e che non costavano care. Effettivamente trovai una BellHowell film 70 con tre eccellenti obiettivi Cook. Insieme agli amici, vendendo una moto,
comprammo della pellicola in bianco e nero, a alta velocità, che dava quindi un’immagine molto
sgranata. In Africa abbiamo deciso di girare un lungometraggio, una storia onirica, ricca di mistero.
Dopo aver fatto il film siamo partiti verso le sorgenti del Niger, impiegando nove mesi per
ripercorrerlo tutto in piroga.
Arrivati al confine del Niger (della nazione del Niger) ci siamo fermati in un villaggio che
conoscevo bene, perché avevo percorso la strada che passava lì vicino. Proprio in quel villaggio
avevo girato il mio primo film di finzione sei mesi prima. Ho detto alla gente che volevo farne un
altro e loro mi hanno chiesto di fare un film sulla caccia all’ippopotamo. Sono tornato dopo sei
mesi, quando la caccia era pronta, quando la grande piroga era stata preparata. Allora ho girato un
film su un rituale di possessione, il mio primo rituale di possessione, e una caccia all’ippopotamo.
In quel momento non avevo ancora molta dimestichezza con la macchina da presa: mi è capitato di
fare delle sequenze da destra e da sinistra che non potevano essere raccordate. Tuttavia avevo un
film. Sono rientrato in Francia e quando ho sviluppato il materiale mi sono reso conto che le
immagini non erano cattive. Ho cominciato a lavorare al montaggio, a tentare di raccontare una
storia, ma in quell’epoca non c’era niente, non c’era niente con cui incollare la pellicola (si
incollava con il pollice), non esisteva il visore per il montaggio, quindi si proiettava il film (muto,
naturalmente) e si cercava di raccontare una storia.
Ho presentato questo film alla prima manifestazione organizzata al Musée de l’Homme da
André Leroi-Gourhan, che in quel momento era il direttore del museo, e questa manifestazione si
chiamava: «Le film ethnographique existe-t-il?». Il titolo del mio film era Chasse à l’hippopotame
au harpon.
In quel momento aveva già riflettuto sul suo modo di filmare?
No, improvvisavo nel mirino e cercavo di raccontare una storia, ma esistevano già film
molto interessanti. Leroi-Gourhan lo aveva capito molto bene, apprezzava molto film come il mio e
altri dello stesso genere. Chasse à l’hippopotame è stato uno dei primi film che ho presentato qui.
La cosa importante era che Leroi-Gourhan, insieme a Griaule, uno dei leader del Musée de
l’Homme, pensava che il mio fosse un lavoro di ricerca. La macchina da presa, quindi, poteva
essere uno strumento di ricerca.
Qualcuno che assisteva alla proiezione del film mi propose di proiettarlo in un Caffè dove
alcuni giovani musicisti suonavano jazz. Il film era muto e io improvvisavo un commento. La
proiezione ebbe luogo con grande successo. Allora il pianista del gruppo jazz, che era il figlio del
direttore delle Actualités Françaises, mi disse che valeva la pena di parlare con il padre. Il
direttore vide il film, decise di comprarlo e di farmi un contratto fantastico (il 60% sugli incassi, che
era moltissimo). Mi disse che bisognava ingrandirlo a 35 mm, mentre ero libero di decidere sul
montaggio, sulla musica e sul commento.
A questo punto il film è uscito nelle sale con il titolo di Au pays des mages noirs, che era
Chasse à l’bippopotame ridotto da 30 a 10 minuti. Il film era uscito contemporaneamente a
Stromboli di Rossellini. Non era un brutto film, ma la musica era insopportabile e il commento era
letto dal cronista del Tour de France.
Il produttore è stato estremamente onesto, alla fine mi ha dato la copia 35 mm flamme 5, da
cui ho potuto fare una copia di 16 mm. Perciò il film esiste ancora.
A questo punto vorrei passare a un film capitale, un film che ha interessato e interessa fra
gli altri molti uomini di teatro. Il film è Les maîtres fous, naturalmente. Lei sa che il film continua a
suscitare reazioni diverse e spesso molto violente...
Sì certo. Chabrol mi ha chiesto come facevo a far recitare così bene quegli attori. Brook,
invece, ha proiettato il film ai suoi attori prima di farli recitare in Marat-Sade e, vedendo questo
film, Jean Genet ha scritto Les Nègres.
Quali sono stati i problemi tecnici e psicologici durante le riprese del film?
Les maîtres fous è stato girato nel ‘54 ed era il settimo o l’ottavo film che avevo fatto. La
differenza che c’era fra questo e gli altri film era che intanto il suono era arrivato. Quindi nel 195354 esistevano registratori autonomi, molto pesanti, che funzionavano su banda magnetica a motore
meccanico. Essi permettevano di registrare il suono reale e potevo disporre, perciò, di strumenti di
registrazione diretta. Da molto tempo ero passato al colore per una ragione essenziale e cioè che è
molto più facile girare a colori che in bianco e nero, perché non è necessario regolare
l’illuminazione. Inoltre quando mostravo le foto in bianco e nero alla gente filmata, essa non poteva
riconoscersi perché non c’era il colore, con le foto a colori la relazione era evidente. Lo stesso è
accaduto per i film. Quando hanno visto i primi che avevo girato in bianco e nero, come Au pays
des mages noirs, le persone stentavano a riconoscersi, con il colore ogni problema è scomparso. in
Les maîtres fous ho utilizzato una pellicola Kodachrome e una cinepresa che bisognava ricaricare
ogni 25 secondi, ma ero abituato a raccontare una storia in questo modo. In quel momento avevo
realizzato un altro film sulla caccia all’ippopotamo, che aveva giocato un ruolo molto importante
nella mia ricerca, perché era il primo film che avevo proiettato alla gente filmata. Un’esperienza
questa che mi aveva insegnato molte cose e che aveva suscitato un grande interesse in Damouré
Zika. Insieme eravamo partiti verso il Ghana, sempre alla ricerca di danze di possessione, avevamo
anche deciso di girare un lungometraggio, Jaguar. Mi ero abituato in questi film a girare e a montare
mentre ricaricavo la inepresa, rendendomi conto cioè, molto rapidamente, nel mirino della
Beil{owell dopo aver girato un piano, che non c’era più motore e che la cinepresa si sarebbe
fermata. Quindi dovevo ricaricare e ricaricando, riflettevo, e, riflettendo, cambiavo l’angolo di
ripresa avendo nell’occhio l’ultima immagine che avevo visto nel mirino. Sperimentavo la
possibilità di fare un montaggio durante le riprese.
Nel 1948 avevo girato un film sulla circoncisione, che dura circa 10 minuti, con 12 minuti di
pellicola, quindi, senza nessuno scarto. C’era solo qualche inquadratura sbagliata a causa del
diaframma. Conoscevo molto bene la Kodachrome, sapevo raccontare una storia spezzettandola,
con molte interruzioni, fermandomi qualche volta molto prima dei 25 secondi con l’idea che quando
ci si annoia bisogna smettere. Ero abituato ad essere il mio primo spettatore nel mirino. Lo
spezzettarsi del film era automatico per me, era la scomposizione del montaggio.
5
Flamme: La pellicola cinematografica, utilizzata negli anni ‘30, era altamente infiammabile. La copia dei film, girati con questo tipo
di pellicola, è chiamata in Francia: copie flamme. [N .d.T.]
È forse per questo che si ha l’impressione di «falso» davanti a Les maîtres fous. La continua
e rapida combinazione dei piani dà l’impressione di un pesante intervento del montaggio nella
struttura del film.
Certo, ma con il montatore abbiamo spesso messo dei fotogrammi bianchi fra un piano e
l’altro, Comunque, tornando ai problemi tecnici, voglio dire che non sono stati particolarmente
difficili da superare.
Sul piano del rapporto con le persone filmate tutto è stato molto facile: sono loro che mi
hanno chiesto di fare un film. Io ho avuto la grande fortuna di portare con me i film che avevo fatto
in Niger e ho proiettato il film sulla caccia all’ippopotamo (in cui avevo filmato anche una
possessione) a Accra nel 1954 ai componenti della setta degli Hauka. Lo hanno visto e mi hanno
detto che bisognava fare un film sulle danze dei geni della forza, gli Hauka, i geni del mondo
nuovo, del mondo coloniale. La festa si sarebbe tenuta a Natale. Ho accettato e sono partito per il
Togo, dove mi hanno mandato un telegramma per invitarmi alla festa. Non c’è stato nessun
problema. Dal punto di vista dell’organizzazione posso dire che sono partito con una cinepresa e un
grosso registratore. Avevo comprato delle bobine di normale pellicola da trenta metri, che si
trovavano in tutti i drugstores di Accra. Damouré Zika registrava il suono praticamente senza
interruzione. Avevamo una quantità sufficiente di bobine sonore, perciò gli ho detto di continuare,
eliminando solo il rumore della cinepresa. Naturalmente il suono non era in sincrono.
Questa era la nostra maniera di lavorare.
Quali sono state le prime reazioni alla visione del film?
Le prime reazioni le ho avute da Damouré e da Lam che erano con me.
Dopo aver finito il film, ho accompagnato a casa i protagonisti, fra cui Gherba, quello che
era posseduto dalla locomotiva. Era tardi ed eravamo abbastanza lontani dalla città. Insieme a
Gherba c’era anche Damouré che mi ha detto: «Abbiamo fatto un film orribile oggi». Per questo ho
deciso di girare la fine, per mostrare come erano quelle stesse persone dopo la possessione.
Sono rientrato a Parigi con questo film, Jaguar e un altro film, Mammy Water. Les maîtres
fous è stato proiettato per la prima volta nel 1955 alla seconda riunione internazionale del film
etnografico, che si teneva al Musée de l’Homme.
Avevo ricevuto una copia per il montaggio, o forse anche l’originale, perché era
Kodachrome ed era possibile proiettano. Ho presentato un’ora con un commento improvvisato di
volta in volta. Erano presenti molti antropologi, c’era il mio professore Marcel Griaule, c’erano
alcuni amici africani. Quando uscii dalla sala di proiezione incontrai Marcel Griaule, rosso di
collera, che mi disse che il film andava distrutto immediatamente. I miei amici africani, loro erano
tutti grigi di collera, confermavano che sì, il film andava distrutto. Fu uno scandalo.
Con quali ragioni hanno motivato questo atteggiamento?
Nessuno me le ha spiegate... Griaule diceva che il film mostrava il sacrificio di un cane, un
sacrificio cruento con immagini insopportabili. Era questo... E gli africani dicevano la stessa cosa.
Era strano vedere un nero e un bianco dire la stessa cosa su un film di questo tipo. Io ero appoggiato
da Luc de Heusch, che era venuto con due film che aveva realizzato in Congo. Ero molto
impressionato da questa reazione. Abbiamo deciso quel giorno di non distruggerlo (io non lo avrei
comunque distrutto), ma, voglio dire, di non metterlo da parte.
Ho riflettuto dopo su questo fatto. La reazione era chiara. Il film mette in scena danze di
possessione, in cui gli dei possessori sono bianchi, siamo noi.
Gli africani vedevano il film soltanto a livello del «cavallo», cioè della persona posseduta. Il
«cavallo», in questo stato selvaggio, uccideva un cane e lo mangiava praticamente crudo e coperto
di sangue. Il significato del film era dunque: «Siamo dei selvaggi».
I bianchi, invece, vedevano gli africani recitare un ruolo che gli apparteneva, erano loro gli
eroi, Era un’immagine dei bianchi non molto divertente e, forse, insopportabile.
Da questo nasce il rigetto completo delle due parti con un transfert sul vero soggetto del
film, che si fosse bianchi o neri.
In che modo ha proceduto nel montaggio?
Ha proiettato prima il film alle persone filmate e poi ha fatto il montaggio vero e proprio?
In genere faccio un pre-montaggio che proietto alle persone filmate. Ma Les maîtres fous è
stato montato senza essere stato mostrato ai suoi protagonisti. Gli Hauka mi avevano chiesto il film
per poterlo utilizzare nel rituale, volevano comprare un proiettore Bell-Howell e proiettarne una
copia. Ma questo io non ho potuto farlo, fortunatamente, perché il film è stato censurato dagli
Inglesi. Allora esisteva ancora la Gold Coast, la censura dipendeva dal governo. L’ho presentato al
British Film Institute, dove non ha ottenuto il visto della censura. Era un insulto alla Regina, perché
sulla statua del governatore viene rotto un uovo e per crudeltà verso gli animali, perché viene ucciso
un cane.
Quindi non avevo nessuna possibilità di proiettare il film sul posto. E dico fortunatamente,
perché, se gli Hauka lo avessero utilizzato, la visione sullo schermo della possessione avrebbe
scatenato immediatamente una possessione. E una specie di elettroshock, estremamente violento,
che può essere estremamente pericoloso. Ho fatto esperienze del genere e non ho più ricominciato.
Vorrei farle ora una domanda di carattere più generale. Quando si parla di «cinema
diretto» molti pensano a un cinema «facile» in cui è sufficiente impugnare una cinepresa e filmare.
È d’accordo con questa tesi? Qual è la sua definizione di «cinema diretto»?
Credo che il «cinema diretto», anche se sono stati risolti i problemi tecnici, anche se si
conosce perfettamente l’equipaggiamento di ripresa e di registrazione sonora, resta un’avventura
niente affatto scontata. E questo perché, anche se sembra un cinema molto semplice, è basato
sull’improvvisazione nel mirino della cinepresa. Una cosa questa che richiede al regista di essere,
nello stesso tempo, il proprio operatore. Nel «cinema diretto» è impossibile dirigere qualcuno,
perché è un cinema in cui le inquadrature cambiano continuamente, si filma qualcosa e poi si è
costretti a cercare una posizione diversa: si è sempre in movimento. Molto spesso è un cinema che
comincia a raccontare una storia senza conoscerne la fine, in cui un film può durare 10 minuti,
come il film che ho presentato questa mattina Pam Kuso Kar, un piano sequenza, oppure 7 anni
come La chasse au lion à l’arc, perché è un cinema nel quale la storia si racconta nello stesso
momento in cui si gira. Qualche volta conduce verso un’altra sequenza, un altro luogo, un altro
tempo. Allora si è costretti a tornare e a ricominciare. Ma con un enorme vantaggio sul libro, sulla
scrittura, cioè che quando si scrive un libro di antropologia sugli usi e i costumi di una popolazione
illetterata, le persone studiate non hanno nessuna possibilità di sapere cosa ha fatto l’antropologo.
Con il film lo sanno. Questo effetto del feed-back è molto importante.
Direi che fare un film è un po’ come fare un ponte alla fine degli anni Trenta quando non
esistevano i computers e si facevano i ponti, in Francia voglio dire, con il metodo delle
approssimazioni successive. Si realizzava il progetto di un ponte e si calcolava tutto quello che
poteva succedere. Si calcolava la tensione, la pressione dei tralicci o la sua resistenza al peso. A
volte capitava che il ponte fosse troppo pesante. Il segreto dell’arte di costruire i ponti consisteva
proprio nell’utilizzare il minimo quantitativo di materiale, perché la struttura del ponte non dovesse
sopportarlo.
L’arte di costruire un film è la stessa. All’inizio si cerca di fare un film nella maniera più
semplice possibile, poi si intuisce che ci sono altre cose, altri avvenimenti. Perciò molto spesso si è
obbligati a fermarsi e a tornare. A questo punto si presenta il film alle persone filmate e insieme ad
esse ci si rende conto che mancano elementi importanti. La proiezione del film poco a poco
conduce a un’ulteriore realizzazione.
Cos’è la «cine-trance»?
«Cine-trance» è un termine che utilizzo a proposito di film come quello di stamattina, che è
un piano sequenza, nel quale, per esempio, mi muovo fra persone che restano immobili,
accovacciate. Io mi comporto nello stesso strano modo in cui si comportano le persone in trance,
come se fossi posseduto da un genio hauka, che potrebbe chiamarsi Cinema, che mi costringe a fare
strani movimenti, nei quali esiste una coreografia visiva e che dall’esterno è simile alla trance.
Le possibilità di disporre di cineprese con un caricatore di 10 minuti e, quindi, la possibilità
di fare lunghi piani sequenza in che misura ha modificato la sua maniera di girare?
All’inizio usavo la macchina da presa come in precedenza, tendevo a girare un piano e
(purtroppo ho perduto questa capacità) a tagliano, a montano durante le riprese. Molto presto, a
partire dal momento in cui ho registrato il suono in sincrono, sono sorte delle difficoltà. Fin quando
c’era un filo che collegava la cinepresa al microfono era ancora possibile, ma poi bisognava fare i
ciak per avere dei punti di riferimento, per saper cosa si stava filmando. Perché se si ha un sistema
di sincronizzazione, che dà un segnale sia sulla pellicola che sulla banda sonora, è necessario che il
fonico sia molto attento.
I ciak che facciamo oggi sono molto semplici e rapidi, in genere si usano appunti su cui si
scrivono i numeri, oppure si mostra il numero nelle immagini. Esiste dunque un sistema di punti di
riferimento e di numerazione che permette di procedere rapidamente, ma queste operazioni devono
essere fatte dal fonico, che è costretto a ridurre il suo livello di vigilanza. I fonici africani, che
hanno lavorato con me, sanno molto bene che obiettivo uso e qual è il campo disponibile per
sistemare il microfono. Se ci si interrompe continuamente è molto difficile lavorare per gli altri. Il
mio tentativo era quello di tentare di fare un film nel quale il climax arrivasse prima di dieci minuti.
Ne ho fatti molti, ma non ci sono riuscito spesso, perché è molto difficile cogliere un avvenimento
che dura solo pochi minuti. Quando succede è effettivamente molto strano. Secondo l’opinione dei
miei amici africani che mi vedevano camminare con una cinepresa intorno al «cavallo» di un genio
e cominciare 4 o 5 minuti prima della possessione, questo voleva dire che avevo uno strumento in
grado di vedere i geni. Quindi anch’io ero partecipe di questa operazione.
L ‘uso del piano sequenza è sempre in funzione di una migliore relazione con le persone
filmate?
Sì, anche. Ma soprattutto una specie di premonizione di quello che accadrà. Ho utilizzato il
piano sequenza molto presto. Quando ho girato per esempio Gare du Nord, un film di finzione
basato su un piano sequenza di 20 minuti, come The Rope, in cui il soggetto era: cosa succede 20
minuti prima di un dramma? I 20 minuti prima che accada qualcosa? I 20 minuti prima del
naufragio del Titanic? I 20 minuti prima dell’arrivo dei soldati americani a Roma? Cosa è successo
20 minuti prima? In generale questo non lo si filma mai. Quindi si tratta di filmare ciò che ha
preceduto l’avvenimento ed è su questo che si innesta la premonizione. Per esempio, assistendo a
un rituale di possessione (fenomeno che conosco molto bene) nasce questa strana sensazione. La
prima volta che ho adoperato il termine premonizione è stato a proposito di un mio film Les
tambours d’avant, Tourou et Bitti, nel quale qualcuno era posseduto quando lo riprendevo, senza
che nessun segno esteriore lo indicasse in precedenza. Succedeva che conoscendo bene l’inizio di
una possessione, potevo accorgermi nel mirino che quella persona stava per essere posseduta e che
io la tenevo, la seguivo in questo modo.
Intorno agli anni ‘60 lei ha girato Jaguar, La pyramide humaine, Chronique d’un été. Sono
film girati in luoghi molto diversi, l’Africa, la Francia. Io credo che in questa diversità ci sia molto
della sua avventura di etnologo-cineasta, della sua maniera di viaggiare fra le culture. In che
misura il suo cinema è stato influenzato da questi passaggi successivi?
Conoscevo molto poco la Francia, perché ogni anno passavo 6 mesi in Africa e 6 mesi in
Francia, dove passavo tutto il mio tempo a montare i miei film. In pratica non lasciavo mai l’Africa.
Quando Edgar Morin mi ha proposto di girare Chronique d’un été per scoprire la mia tribù, la tribù
dei parigini che io non conoscevo, ho iniziato questa esperienza con la sensazione di fare una
scoperta. Ero co-autore del film ed è stato lui a mettere in scena gli elementi con cui Chronique
d’un été è stato costruito. Avevo un più spiccato atteggiamento da etnologo nei miei film parigini
che nei miei film africani.
In cosa differisce essenzialmente il suo lavoro quando gira un film documentario a
prevalente interesse etnologico e un film di finzione?
La differenza consiste nel fatto che in un film documentario non ho da fare nessuna messa in
scena. In genere scelgo un rituale o una tecnica, come nella Chasse à l’hippopotame o la Chasse au
Lion, nel quale il mio lavoro è quello di registrare il più precisamente possibile quello che succede.
E quindi un lavoro di osservazione filmata. La messa in scena è già data dal rituale.
In che modo i suoi attori africani si adeguano alla sceneggiatura di un film?
Jaguar e Mou un Noir erano film di finzione, in cui, per ragioni tecniche, mancava
completamente il suono. I due film sono stati fatti allo stesso modo e cioè proiettandoli alle persone
filmate, per poter registrare contemporaneamente un testo. Scoprendo in questo modo che
Damouré, Lam e gli altri erano capaci di improvvisare un testo straordinario su Jaguar; scoprendo
che il testo di Umam Rouganda, che recitava la parte di Robinson era un testo straordinario, creato
con una facilità incredibile. Avevo registrato Jaguar, che in quel momento durava tre ore, in un
giorno e mezzo al Film Unit di Accra. Ancora una volta non c’erano scarti e i registi presenti non
credevano ai propri occhi, non credevano che fosse possibile improvvisare in questo modo. Allora
ho capito che l’africano entrava direttamente in questo genere di gioco. La loro improvvisazione era
simile alla mia quando giravo Jaguar, che è un film senza sceneggiatura. Io seguivo semplicemente
tre personaggi che partivano e inventavano insieme gli episodi di volta in volta.
In Dyonisos, però, la sceneggiatura esiste. In questo caso ha dovuto dirigere gli attori,
rispettare l’ordine delle sequenze. Ha dovuto fare un lavoro molto diverso.
Certo. Gli attori conoscevano la sceneggiatura, c’erano dialoghi scritti... È vero, è stato un
lavoro molto diverso... Ma comunque era così complicato ed eravamo così numerosi, che il ricorso
all’improvvisazione era costante. Non ho scritto tutti i dialoghi e quelli venuti per caso sono forse i
migliori.
Durante le riprese mi trovavo sul set e ho avuto l’impressione di assistere a un happening, a
un «cine-avvenimento». Si lavorava in una grande confusione e devo dire sinceramente che avevo
qualche dubbio sulla riuscita dell’impresa...
Non ce n’era ragione. Il film era comunque scritto e girato, rispettando l’ordine delle
sequenze. Ho usato il solito metodo. Se si confrontano i testi scritti e quelli recitati, la differenza è
notevole: gli attori non li conoscevano perfettamente.
Ha dato agli attori indicazioni precise sull’interpretazione dei personaggi?
Quasi nessuna. Solo qualche indicazione a Jean Monod, che era Hugh Gray, e alle Menadi,
durante alcune sequenze di danza, ma tutto veniva improvvisato molto rapidamente. C’era
un’azione da girare e la si cominciava. Mi comportavo come in un film documentario.
La differenza che esiste fra questo ed altri film, è che ancora una volta io ero il mio filmmaker, l’operatore e il regista. Quindi vedevo nel mirino della mia cinepresa tutto quello che
sarebbe successo. Sapevo come l’azione si presentava nel mio quadro e vedevo il mio film.
L’enorme vantaggio che offrono le cineprese moderne dalla Beaulieu in poi, ma soprattutto l’Eclair
e la Aaton, è quello di avere mirini eccellenti, che permettono di stare dentro il film.
Il film sembra essere costruito come un dramma teatrale con i suoi «Intermezzo», i suoi atti,
cosa ne pensa?
Ho messo le didascalie per dare un po’ di ordine a quel disordine, non solo apparente che
esisteva sul set. Non c’erano indicazioni e la gente faceva quello che voleva. Nella maggior parte
dei casi non c’erano che due persone che agivano sotto la mia direzione. Nel momento in cui
diventavano più numerosi non si riusciva ad andare avanti. Mi era sufficiente vedere nel mirino
come si comportavano queste due persone, controllare la posizione degli altri e si girava. I tecnici
con i quali ho lavorato erano furiosi. Dicevano di non aver visto niente del genere, che quello non
era cinema. Il fatto che per me fosse sempre buona la prima ripresa era insopportabile per loro.
Naturalmente ho dovuto rifare qualche scena, perché la ripresa era stata talmente cattiva che
si era costretti a rifarla. Filmavo la mia storia, un pezzo dopo l’altro e sapevo bene dove volevo
andare. Voglio farle un esempio molto divertente e molto preciso. C’è una sequenza di Dyonisos
che io amo molto e che è prevista in questo modo: Hugh Gray è assunto in fabbrica con Ariane. Poi
parla con Bruno e va sulla Tour Eiffel. Una conclusione questa che non ha niente a che fare con il
resto, ma era semplicemente l’occasione per permettere a Bruno di riprendere il discorso di Angelo
in Chronique d’un été sulla condizione dei lavoratori, di introdurre quindi il discorso de L’atelier
plaisir. Questo era tutto quello che sapevamo e avevamo come indicazione il gesto di Ariane che
tendeva a Dyonisos uno specchio a due facce, su una il lavoro e sull’altra il piacere. Volevo girare
la sequenza davanti alle fabbriche Renault, non è stato possibile farlo perché non ho avuto
l’autorizzazione. Allora ho deciso di girarla nella Tour Eiffel, dove era prevista una sequenza basata
solo su citazioni sulla storia dell’industria automobilistica, da Eiffel ai nostri giorni.
Girare dentro la Tour Eiffel non è semplice, perché costa più di un milione di lire al giorno.
Allora ho telefonato alla direzione della Tour Eiffel, dicendo che ero ingegnere civile, che volevo
fare un omaggio al suo costruttore e ho avuto l’autorizzazione a girarla gratis. I tecnici erano
contenti, perché non si era pagato, ma nello stesso tempo seccati, perché, in un certo senso, si era
perso il valore delle riprese nella Tour.
Abbiamo cominciato a lavorare la mattina presto. Io potevo disporre di due macchine da
presa. Sono salito sull’ascensore con Hugh Gray, Aria- ne, Bruno e un fonico, mentre l’altra mi
faceva da sicurezza, filmando l’ascensore che saliva dall’esterno.
La salita in ascensore si faceva in due tempi. Fino all’arrivo al primo piano di svolgeva il
monologo di Bruno. Poi, mentre l’ascensore saliva dal primo al secondo piano, il brano dello
specchio a due facce è coinciso proprio con il momento in cui si attraversava una specie di piano
intermedio, in cui c’era una fessura luminosa. Il testo si legava perfettamente all’immagine: «E
come lo specchio a due facce, su una faccia il lavoro, sull’altra la gioia e in mezzo lo spazio stretto
in cui si rifugiano coloro che amano quello che fanno». Ebbene, lo «spazio stretto» è coinciso
esattamente con la fessura luminosa che ho visto passare nel mirino della cinepresa. E stato
straordinario. Poi, come previsto, Gray ha rivolto lo specchio verso di me e mi ha chiesto se amo
quello che faccio e io ho risposto: «Sì, è il cinéma plaisir».
Cosa intende per «cinéma plaisir»?
Significa fare ciò che si desidera. E io ne avevo appena avuto una prova. Avevo girato una
sequenza che avevo immaginato e all’improvviso era accaduto un miracolo. Una frase, che nella
sceneggiatura era una dichiarazione, è diventata una costatazione.
Siamo tornati giù dopo 10 minuti e la segretaria di produzione mi ha chiesto di fare un’altra
ripresa, come sicurezza. Ho risposto di no. I tecnici non erano sicuri che tutto fosse andato bene,
che tutto fosse a fuoco. Quando hanno visto il materiale ne hanno avuto la prova e hanno forse
cominciato a capire che esisteva un’altra maniera di fare cinema. Nessuno avrebbe fatto una cosa
del genere per la semplice ragione, che se ci fosse stato un operatore, l’operatore non mi avrebbe
detto niente, perché non ascolta la gente, ma pensa soltanto alle sue immagini. Io sono allenato in
un altro modo, guardo nel mirino, ma ascolto cosa dice la gente. C’era stata in quel momento una
congiunzione perfetta e non valeva la pena di ricominciare. Non ho voluto rifare la sequenza perché
questo avrebbe abituato le persone a non concentrarsi sulla prima ripresa.
A questo punto vorrei affrontare un altro aspetto del suo lavoro, quello dell’insegnamento
alla Sorbona, nel corso di cinema. Cosa pensa di poter trasmettere alle persone che lavorano e
studiano insieme a lei?
Quello che posso trasmettere è l’insegnamento di Langlois ed è per questo che tengo il corso
del sabato mattina alla Cineteca. Langlois mi ha insegnato a fare film, vedendo altri film. Era lui
che diceva: «Se si vedono tre film al giorno, in un anno si è visto tutto». Non posso tenere questo
ritmo con gli studenti, gli offro due ore alla settimana.
Durante il corso lei si comporta un po’ come i vecchi Dogon, di cui mostra le immagini nei
suoi film. Non dice niente prima, ma aspetta che siano le domande a provocare le risposte.
È vero. Il mio primo maestro è stato Langlois e poi i Dogon. I Dogon mi hanno insegnato a
mettere in circolazione, quelli che chiamo, «oggetti inquietanti» per suscitare delle reazioni. Come
questa mattina, quando quel ragazzo mi ha detto di avere sentito la stessa poesia in tutti i film
presentati. Questo corrisponde alla tesi di Langlois, secondo la quale i film si mettono in scena gli
uni con gli altri. Sono rimasto sorpreso. Non avevo voluto dare io stesso la chiave d’interpretazione,
ma i tre film erano costruiti con la stessa sensibilità.
Un fattore depistante per i suoi allievi è la sua doppia identità di etnologo e cineasta. Voglio
dire che quando ci si attende una reazione da cineasta, lei risponde da etnologo e viceversa, in uno
scambio continuo di ruoli.
Posso rispondere che personalmente non credo che esista qualcuno che sia soltanto un
cineasta. Penso che essere un cineasta significhi sempre essere un autore di film e qualcos’altro. Se
si pensa a come parlava Langlois ci si rende conto che si trattava di un appassionato di cinema e di
pittura, da qui i suoi continui rimandi all’impressionismo. Non faceva film, ma metteva in scena i
registi. I miei corsi sono organizzati su questo modello con la differenza che io ho un complice,
Xavier de France, un teorico. Xavier ha un’intelligenza enciclopedica, è lui che cura la parte teorica
del corso. Io evito di affrontare questi argomenti, perché altrimenti mi annoierei molto. In questo
modo invece è una continua sorpresa.
Lei invita costantemente a osare, a superare i limiti imposti dalle regole empiriche, che
regolano il linguaggio cinematografico. Questo atteggiamento nasconde una trappola però, si ha
cioè l’impressione di poter fare tutto e questo non è possibile. Ha mai pensato a problemi di questo
tipo durante il suo lavoro?
No, la sola cosa a cui penso quando filmo sono i problemi strettamente tecnici. Nel caso
dovessi girare qui dentro, il procedimento che uso, quello che ho imparato dagli operatori, è di
leggere la luce incidente sul mio esposimetro in tutto lo spazio circostante. La differenza è di uno o
due diaframmi. In genere uso un tipo di pellicola a bassa velocità, per evitare di avere filtri troppo
grigi e per lavorare il più possibile con la massima apertura. Regolo il mio diaframma,
controllandone lo stop e quindi guardo lo spazio e i colori che devo filmare. Allora cambio il
diaframma finché non corrisponde alla tonalità che vedo, metto cioè il diaframma nell’occhio.
Faccio lo stesso con gli altri colori lì dove ho 2 diaframmi di meno e passo dall’uno all’altro.
Controllo la posizione delle dita. A quel punto, quando sono certo delle mie misure, so che posso
cominciare a filmare. Naturalmente spesso mi sbaglio. In Pam Kouso Kar, quando esco
dall’orchestra, che si trovava all’ombra, e vado verso la gente vestita con una stoffa bianca, c’era
forse una differenza di quattro diaframmi. Mi sono accorto del cambiamento con una ventina di
secondi di ritardo.
Non pensa che sia necessario conoscere a fondo la tecnica cinematografica, prima di
decidere di infrangere alcune sue regole?
È proprio per questo che è importante vedere i film di finzione ed è per questo che li
inserisco sempre fra i documentari che presento durante il mio corso. Sono stato molto felice di
accogliere una settimana fa William Witney, regista di serial americani, che hanno avuto un
successo considerevole in Africa intorno al 1930. Sono film che ci insegnano come raccontare una
storia.
Quindi fare un film significa sempre raccontare una storia?
Per me è sempre così. Anche fare un’inchiesta etnografica significa raccontare una storia, la
storia di una rete da pesca, di una caccia, di una possessione e del mito che c’è dietro.
Perché sostiene che bisogna cominciare dalla fine nella costruzione di un film?
Certo. Nelle riprese quando ho regolato il mio diaframma e comincio un piano, devo sapere
dove finisce. Guardo quanta pellicola mi resta nel caricatore e quindi so cosa posso fare. Si sente
quando un caricatore sta per finire, la cosa più seccante è cominciare qualcosa che non ha una fine.
Quando usavo una cinepresa a motore meccanico con un’autonomia di 25 secondi sapevo che
dovevo fermarmi per avere un’inquadratura finale. Con una cinepresa che non ha questi limiti è più
difficile. Questa volta ho qualcuno vicino che mi avverte che la pellicola sta finendo, ma in genere
so che ho un margine di 2 secondi al di là della segnalazione di fine pellicola. Spesso finisco il mio
piano proprio su questi 2 secondi per avere una fine. La cosa importante nel cinema è avere una
storia e una fine, per avere nel montaggio un materiale che va da qualche parte, che segue una
direzione. In Dyonisos e in altri miei film, dove esiste una sceneggiatura, anche se vaga, bisogna
saper filmare e nella maggior parte dei casi ci sono molti finali. È necessario allora sapere qual è la
vera fine e come montare in funzione di questa fine. Questo non è semplice.
Se si fa una panoramica a spalla, si mettono in piedi in funzione dell’ultima inquadratura,
mai della prima. Lo stesso accade in una carrellata, qual è il suo scopo, dove finirà? Ci sarà un
arresto a un certo punto oppure continuerà con un’altra carrellata. Bisogna sapere su cosa si finisce.
Nel montaggio è lo stesso. Quello che sostengo è che fin quando non si potrà montare in video,
partendo dalla fine, all’inverso, continuerò a lavorare in pellicola.
Quali sono le altre ragioni per cui non utilizza il video?
La ragione principale è quella di cui parlavo prima e poi perché il film, per me, è un contatto
fisico. Mi piace molto vedere un’immagine. Si prova una sensazione particolare nel montare le
immagini di Vertov, di Ejnzestejn, di Godard. Mi piace molto montare in 35 mm, perché è possibile
fare gli attacchi, senza bisogno dello schermo, spostando i due spezzoni di pellicola, sapendo dove
si potrà passare da un piano all’altro. Anche in 16 mm è piuttosto facile.
Non è possibile vedere una serie di immagini in video, se ne può vedere una soltanto. Un
altro inconveniente è che non si vede l’immagine sulla quale ci si arresta, che è assolutamente
essenziale. È un’immagine molto vicina ed è quella che resta impressa nell’occhio, a causa della
persistenza retinica dell’immagine. Infatti la prima scompare perché è legata alle altre, mentre
l’ultima che è spezzata, resta. È quella che si sceglie per poter montare, ritornando lentamente
all’inizio, per fare l’attacco con l’ultima immagine del piano precedente.
È essenziale per me potere vedere il film al contrario. Si procede come in una dissertazione
in francese: si scrive l’introduzione, poi la prima parte senza sapere dove si vuole arrivare, a metà
della seconda parte si sa quale sarà il suo sviluppo. In quel momento si scrive la conclusione, in
quel momento si è trovato il proprio soggetto. Si scrive la fine per poi rifare, da ultimo,
l’introduzione.
Quindi un inizio, una fine e il resto è da riempire.
Sì, e in genere si ha un inizio che non funziona, ma serve per cominciare. Molto spesso,
durante le riprese di un film, ci si rende conto di questo. Non si sa come cominciare e allora si gira
un piano, che è spesso una citazione etnografica. Nel cinema si lavora al contrario. In uno dei primi
film dei Lumière due tram si incrociano e alla partenza del secondo tram il film, che durava solo un
minuto, finisce. Secondo Langlois e Renoir si trattava proprio di questo, di montare i piani come
sequenze, un procedimento che i cineasti di oggi non sanno sfruttare e che il video non permette di
fare. In video si gira e si aspetta, forse perché il lavoro è più centrato sul suono che sull’immagine.
Non crede che il video vada usato in maniera completamente diversa dalla pellicola
chimica?
È molto diverso.., ma l’unica utilizzazione possibile, secondo me, è il piano sequenza, in cui
non ci sia nessun montaggio, cercando di raccontare una storia di due, cinque, dieci minuti. E una
specie di filo d’acqua, un po’ noioso, ma davvero non credo che si possa fare un vero montaggio in
video. L’immagine video, poi, rischia di scomparire molto rapidamente. I giapponesi sostengono
che dopo quattro anni non si è più garantiti sulla qualità dell’immagine, per un effetto di eco. Si
tratta di una eco visiva che introduce immagini false, che si ritrovano regolarmente. Basta guardare
immagini video un po’ vecchie, per rendersi conto dello scadimento di qualità.
Un altro aspetto, di cui sono venuto a conoscenza in Giappone, è che non si riesce a mettere
a fuoco con le telecamere.
Fino al ‘65 gli operatori professionisti mettevano a fuoco regolando i loro obiettivi. Si
affittava una cinepresa con i suoi obiettivi, si faceva un test di due o tre metri di pellicola, che si
faceva stampare e si controllava la messa a fuoco su un certo oggetto con un decametro per esserne
certi. L’assistente operatore faceva dei segni sull’obiettivo per essere sicuro della messa a fuoco di
un piano. I tecnici non avevano nessuna fiducia in quello che vedevano nel mirino.
Le prime cineprese Arriflex, che avevano mirini straordinari, sono state una grande scoperta,
perché permettevano di mettere a fuoco anche con un obiettivo (li 10 mm. Certo è faticoso. Certo,
quando il diaframma è molto chiuso, è molto più difficile, ma almeno è possibile farlo, la messa a
fuoco si sente. Che qualcuno la controlli per essere sicuri che non ci si sbaglia è vero, resta il fatto
che si è in grado di mettere a fuoco. Questo non può succedere in un visore, proprio perché si tratta
di un’immagine video e quindi non esiste una messa a fuoco ottica. Come si fa a sapere ciò che è a
fuoco con uno schermo così piccolo? In Giappone ho visto che alcuni tecnici passano il loro tempo
in un camion, dove si trova un monitor più grande, e uno di loro si occupa della messa a fuoco,
avvertendo l’operatore di ogni errore. Questo è insopportabile. Una troupe televisiva leggera in
Giappone è formata da otto persone. In più lavorare con una telecamera collegata con un cavo e fare
dei movimenti diventa quasi impossibile. Per questo, i film, girati per la RAI con l’alta definizione,
non hanno per me nessun interesse. Non vedo a che scopo rovinarsi per fare cose del genere. Nel
video si innesca una trappola, la trappola della facilità.
Vorrei che mi parlasse dei film e dei registi, che hanno più attratto la sua attenzione,
iniziando proprio dal cinema italiano.
Ho amato soprattutto Rossellini, perché era un uomo straordinario, un fantastico narratore di
storie... Rossellini ha inventato una grande quantità di procedimenti, naturalmente non da solo, ma
tutto il neorealismo è nato da Roma città aperta, dall’intuizione che se si voleva uscire dagli studi,
bisognava filmare senza suono. Era necessario quindi post-sincronizzare e doppiare i film. Non era
una scelta facile, in Francia questo non è mai successo. Noi abbiamo sempre avuto orrore della
post-sincronizzazione, del doppiaggio e siamo subito passati al suono diretto, ma questo significava
anche avere il problema della presenza del microfono, della sua ombra e tutta un’altra serie di
problemi. La soluzione di Roberto era ammirevole. I suoi film erano girati nelle strade, i suoi
personaggi parlavano continuamente, come lui del resto. Come Fellini, che parla anche lui
continuamente, di cui ho amato molto i primi film, I Vitelloni soprattutto. Ma chi mi ha veramente
impressionato è stato un regista sconosciuto Bellini, che, nel 1940, ha girato Il pianto delle Zitelle,
filmando il primo reportage sonoro con più macchine da presa, primi piani e un suono sincronizzato
di buona qualità.
Uno dei miei maestri è stato Vittorio de Seta. Banditi ad Orgosolo è l’esempio ammirevole
di un film di finzione improvvisato alla macchina da presa. Sfortunatamente ha smesso di fare film.
Abbiamo da poco presentato al cinema Panthéon i suoi film sulla Sicilia, Da Seta ha influenzato
enormemente i top cameramen di oggi e questo senza alcuna pretesa. E poi c’è Olmi, che è stato
anche lui operatore del suoi film. L’atmosfera, che riesce a creare, è estremamente accattivante.
Il rimprovero che faccio ai registi e agli operatori italiani è di ritenersi grandi pittori del
Rinascimento, capaci di realizzare bellissime immagini... Ebbene no! Perché non sono autori.
Risolvono problemi impossibili, realizzando immagini tecnicamente perfette, ma che mancano di
una qualità essenziale, per me, nel cinema: «il cuore». Sono immagini nelle quali manca la
sensibilità, che aveva per esempio Vittorio de Seta. In Banditi ad Orgosolo la scena della caccia è
bellissima, se penso poi che è girata in 35 mm! Tutto quello che è stato fatto dopo con la steadycam è scandaloso.
In questo modo l’operatore diventa una macchina, l’operatore deve funzionare.
Una steady-cam, un dolly, non possono fare un film. Non pensa piuttosto che la qualità di
un film dipenda comunque dalla sensibilità del regista?
Ma il regista non può dirigere il lavoro delle macchine, perché non vede l’immagine.
Quando si fa un movimento di macchina, come potrebbe sapere quello che non ha potuto vedere. È
stato ripetuto, il regista ha guardato nel mirino, ma questo non basta... No, succede una cosa molto
strana. Non so chi mi ha raccontato questa storia, ma a Hollywood, vent’anni fa la macchina era
così perfetta, gli operatori così precisi, le sceneggiature così ben scritte, gli attori conoscevano così
bene il loro lavoro, che il regista non aveva bisogno di essere presente.
Tutto funzionava, i film si facevano in questo modo. Era proprio così che funzionava quel
grandissimo cinema.
Il cinema che, insieme ai miei amici, abbiamo cercato di inventare e che è ancora in via di
definizione, siamo ancora in pochi a farlo. È effettivamente il cinema dell’istante. È un «cinema
diretto» (è stato Mario Ruspoli a chiamarlo così), in presa diretta sulla realtà. Questa è la sua
caratteristica essenziale. Nell’esempio dell’ascensore in Dyonisos, che ho citato prima, nessuno si
renderà conto della coincidenza, ma sentirà che qualcosa è successo in quel momento. Questo non
può essere scritto o disegnato o preparato... Sì, forse è possibile farlo, ma bisogna essere John Ford
e di John Ford non ce ne sono molti.
E cosa pensa del cinema francese?
A parte Vigo, che è un altro dei miei maestri, quello che ho più apprezzato è stata la
diversità dei miei amici della Nouvelle Vague: Truffaut, Godard, Rivette, Rohmer. Erano persone
molto diverse fra loro, ma che avevano lo stesso amore per il cinema, lo stesso maestro (che era
Langlois), che vedevano gli stessi film, che avevano gli stessi modelli. Tutti però hanno saputo
conservare la propria personalità. Si trattava di un cinema d’autore.
In Inghilterra ci sono stati Brook, Lindsay Anderson, Reisz. La scuola del Free Cinema è
stata una cosa molto importante, quando, improvvisamente, sono stati dati finanziamenti ad alcuni
giovani cineasti. Il fenomeno non è durato a lungo, non più di tre anni, ma ha influenzato
profondamente la nostra Nouvelle Vague.
In Germania c’è Sloëndorff, di cui mi è piaciuto molto Il Tamburo di Latta, ma poi è un po’
scaduto... Certamente, la grande follia di Fassbinder e dei suoi amici mi ha molto colpito.
Fitzcarraldo è un film straordinario, anche se ha fatto arrabbiare gli antropologi per la morte di
alcuni indios. Vedendo il documentario girato durante le riprese ci si rende conto che Herzog è un
pazzo, che non aveva bisogno di filmare in quel modo. Poteva usare una nave finta senza alcun
problema, invece ha avuto il coraggio folle di far passare una nave vera oltre una collina. Certo era
molto rischioso, ma lì è accaduto qualcosa di straordinario, perciò merita tutto il mio rispetto.
Qua? è la sua opinione sul cinema fantastico, delle grandi produzioni, quello di Lucas e
Spielberg?
Non mi piace.
Anche Wenders mi lascia piuttosto indifferente. Ha avuto la stessa involuzione di Kubrick.
2001 Odissea nello spazio era un film interessante, manipolava dei miti. In Orizzonti di Gloria la
regia cominciava ad appannarsi. Shining è un film impossibile e io so che Kubrick ha fallito a causa
della steady-cam. Voleva fare carrellate a spalla in un’ambientazione particolare. C’erano bellissimi
hotel barocchi, ma la steadv-cam non riusciva a passare attraverso le porte. Allora ha ricostruito
tutto il décor... A quel punto, era diventata una performance. Non c’era più film. La macchina da
presa scivolava come un’anguilla, ma non c’era più storia. La sequenza del labirinto è
completamente fallita, perché è troppo largo, proprio per permettere alla steady-cam di passare e
questo si vede anche senza essere architetti.Èun po’ triste vedere la gente uccisa dalle sue stesse
macchine.
Vorrei parlare dei film-makers adesso. Leacock non finisce mai di stupirmi. Nel 1960 ha
girato Primary e ci siamo trovati insieme all’interno di un fenomeno, che abbiamo chiamato
«cinema verità», che, in effetti, significava girare in sincrono (immagine e suono) un avvenimento,
di filmarlo dovunque, in autobus, in macchina. Leacock ha un occhio fantastico e poi per me
rappresenta il legame vivente con Flahertv, che resta un maestro per tutti noi. Flaherty è l’unico ad
aver fatto tutto: faceva le riprese, lo sviluppo della pellicola, la stampa delle copie, il feed-back con
Nanook e il montaggio, tutto.
C’è Brault, ma non è un vero e proprio cineasta. È stato lui a insegnarci, qui in Francia, l’uso
del grandangolo, che ci ha insegnato a camminare con una cinepresa, una cosa questa che noi non
sapevamo fare. Lavorava con un obiettivo di 10 mm (in 16 mm). È lui che ci ha insegnato come
utilizzare i microfoni cravatta. Insieme a Brault ho girato Chronique d’un été, che è un film
sperimentale per questa tecnica. Lo aspetto tutte le volte come autore, ma è più simile a Bob
Gardner, che è un grande operatore e film-maker. Vorrei sentire nei loro film un po’ di cuore. Si
tratta di film spettacolari, ma dove non si sente il battito del cuore. Gardner è più regista di finzione
che di cinema reale. Fabbrica una falsa realtà con una vera realtà. È un artista impressionista, ma
non un pittore realista. In Brasile c’è un personaggio straordinario che si chiama Boldanski, che ha
girato un film come Iracema, e ancora Glauber Rocha e il Nelson Pereira dos Santos di Vidas
Secas. Ne rimangono ancora molti, per finire non posso dimenticare Vertov. Se Michail Kaufman
ha lavorato con Vigo ed è diventato poi il top cameramen negli Stati Uniti con Kazan, questo lo
deve a suo fratello.
In altri termini, era un cinema che si reggeva sulle sue forze, ci pensavo rivedendo Zéro de
conduite di Vigo. Il cinema di Vigo era fatto da amici, da gente che si conosceva. Si trattava di una
«cine-mafia» come dicevamo in un’intervista con Stork e Ivens. È questo che rimpiango oggi. La
gente di quel periodo si conosceva tutta: Man Ray, Ivens, Stork, Germaine Dulac facevano parte
dello stesso gruppo ed erano amici di Le Corbusier, dei poeti, degli scrittori. Era un’avanguardia di
cui il cinema era solo un elemento, ma leggevano i libri, le poesie, facevano parte dello stesso
movimento. Ebbene, questo lo abbiamo perduto. L’utopia del mio corso di Cinema e Scienze
Umane è quello di spingere la gente a leggere, per questo faccio spesso delle citazioni letterarie.
Quanta gente ha letto oggi Stendhal?
Mi fa piacere sapere che Leacock una mattina abbia chiesto ai suoi studenti del
Massachusetts Institut of Tecnology chi avesse letto Stendhal. Non ce ne era che uno su venti... Non
si può restare in una situazione del genere, è impossibile. È necessario tentare innanzitutto di
demistificare il cinema di fronte ai giovani d’oggi. Quando io e Brault abbiamo cominciato a
lavorare con l’Eclair-Coutant e parlavamo di cineprese miracolose, silenziose. Rossellini ci diceva:
«È solo una macchina, vale solo per chi la manovra. Se sono io a guidare una Maserati, va bene. Se
la guida un altro finisce nel fosso». Demistificava il cinema in questo modo. D’altra parte non è
sufficiente saper guidare per essere campioni del mondo, ci vuole qualcos’altro. Si entra allora
nell’ambito sorprendente della selezione. La extrema ratio delle scuole di Cinema nel mondo è: 100
allievi per avere un regista. Forse fra gli allievi di questa mattina ci sarà qualcuno che diventerà un
Rimbaud o un Rossellini, qualcuno che farà dei film. Quello che rimprovero alle scuole di cinema e
in particolare all’Università è di favorire la teoria a discapito della pratica. Ho imparato la mia
«teoria» dalla pratica cinematografica, che è assolutamente indispensabile, ma dal momento in cui
la si è appresa non si sa più quello che succederà. Ogni nuovo film è una nuova avventura. Ogni
nuova avventura è un rischio. Se non ci sono rischi non succede nulla.
Mi parli ora delle sue ultime esperienze dì lavoro. A Torino ha girato da poco un film...
A Torino non ho fatto altro che prendere dei rischi. Era la prima volta che lavoravo su una
sceneggiatura in gran parte scritta da altri, anche se poi ho dovuto modificarla, altrimenti non
poteva essere filmata. Due anni fa quando ho presentato Dionysos ai torinesi, ho spiegato loro che
ero stato a Torino parecchie volte per vedere i primi quadri di De Chirico, che amo molto. C’era un
mistero legato a queste pitture, non ero riuscito a trovare a Torino, le architetture dipinte da De
Chirico, come mi era capitato invece a Sabbioneta o a Ferrara. Tutte le volte che andavo a Venezia
attraverso l’Italia del Nord, in queste piccole città, dietro l’angolo di una strada, mi trovavo a
scoprire un paesaggio di De Chirico. I giovani di un atelier mi hanno detto subito di essere disposti
a lavorare sui tema e mi hanno chiesto se ero disposto a collaborare. Ho detto subito a Rondolino e
al responsabile della regione che dal lavoro dell’atelier si poteva ricavare una sceneggiatura e che
ero disposto a tornare a firmarla, in modo che servisse anche come esercizio per i ragazzi.
Allora il gruppo ha scoperto che De Chirico aveva passato a Torino una sola notte in un
treno, colpito da un forte mal di stomaco. Era a Monaco che aveva scoperto Nietzche e Böklin e, a
causa dei testi scritti da Nietzche su Torino, la sua immaginazione era stata colpita da questa città.
Da qui è venuta l’idea di far incontrare un’altra volta Nietzche e De Chirico a Torino. Il gruppo ha
cominciato a scrivere una sceneggiatura. Ogni tanto mi venivano a trovare per spiegarmi lo
sviluppo della storia. Il punto di partenza era semplice: un collezionista chiedeva a un falsario di
venire a Torino per venire a dipingere i quadri che avrebbe dipinto De Chirico se fosse venuto a
Torino. Bruscamente il gruppo ha introdotto nella storia la vicenda di alcuni bambini che avevano
scoperto un sottomarino sulla riva del Po e questo spunto mi ha convinto che si trattava di una storia
interessante.
Erano emersi, quindi, altri personaggi. Alcuni ragazzi che si interessavano all’arte egiziana,
che avevano scoperto un sottomarino e chiedevano al pittore di aiutarli a partire. Poi andavano da
Agnelli e alcuni dei suoi ingegneri si interessavano al progetto, mandando un robot a riparare il
sottomarino. Era un’idea irrealizzabile, ma significativa per chiarire la nostra storia: la tecnica, di
cui il pittore era l’intermediario, interveniva per risolvere un sogno infantile. Ma mancava una
donna. C’era un mecenate, un pittore, un vecchio (che era Nietzche), i bambini, il Museo Egiziano
(l’Egitto in fondo) e mancava una donna. Il mecenate, sospettoso, aveva un autista e un’amante.
Allora ho pensato di creare fra il mecenate, il pittore e l’amante, il triangolo fatale.
Bisognava a questo punto trovare gli attori.
Ho parlato a Philo Breckstein, che aveva già interpretato Nietzche in Dionysos. Philo mi ha
indicato una persona che poteva interpretare Nietzche e che viveva a Parigi. Fortunatamente ho
deciso di non affidargli la parte. Si trattava di un profugo ungherese, che aveva vissuto a lungo a
Torino, ma che era completamente pazzo. Voleva lavorare nel massimo silenzio e questo non era
proprio possibile. Allora ho chiesto a Philo di interpretare la parte di Nietzche, che poi era quello
che più desiderava, perché aveva cominciato a leggere Nietzche dopo Dionysos ed era pronto a
seguirne le tracce a Torino.
Per la parte della ragazza, che doveva essere bella e misteriosa, ho scelto Sabina, che, pur
lavorando a Roma, aveva il vantaggio di parlare un italiano puro (perché quello che ho scoperto in
quest’avventura è stato il problema dei dialetti). Il suo nome poi, Sabina, suggeriva l’idea di un
rapimento. A questo punto la storia era riassumibile nell’incontro fra il mecenate e il pittore, la
presenza di un sottomarino e di una donna, il pittore portava via la donna. Dovevo trovare il
mecenate. Avevo pensato ad Enrico Fulchignoni per questo ruolo, ma poi non ha potuto partecipare.
Quando sono arrivato, l’atelier operava nella casa di campagna di Riccardo Gualino.
L’archittetura della casa era straordinaria. La costruzione era composta da due ali che terminavano
in forma di ettagono. Uno dei responsabili del Festival Giovani di Torino mi ha detto che proprio di
Gualino si era parlato poco tempo prima a Locarno, dandomi un libro su di lui.
Ho letto il libro, affascinato. Era lui il mio mecenate. Era lui che aveva creato la prima
galleria d’arte contemporanea, che aveva fondato la LUX FILM, che aveva fatto venire Diaghilev
per la prima volta, un personaggio assolutamente fantastico. Aveva costruito case popolari a
Leningrado, che aveva finito due o tre giorni prima della rivoluzione, perdendo tutto. Era stato il
solo dei grandi capitalisti del Nord a schierarsi contro Mussolini, scontando il confino, perché
amico di antifascisti rifugiati in Francia. Ho scoperto il suo ritratto fatto da Casorati e ho scelto
come attore qualcuno che gli somigliasse.
Restava il problema del pittore. Avevo scelto Sandro Franchina, regista e figlio di uno
scultore, ma lui non sapeva dipingere. Mi sono sentito perduto, perché non volevo scrivere la
sceneggiatura, ma volevo che si costruisse a poco a poco. In quel momento ho incontrato i ragazzini
e, miracolo, fra loro c’erano due gemelli perfettamente uguali. Ho subito riflettuto su come fosse
possibile sfruttare questa coincidenza. Il Museo Egiziano era pieno di pitture con due personaggi
simili. Ci voleva quindi un pittore che sapesse fare ritratti somiglianti. Improvvisamente mi sono
ricordato di un pittore che era venuto nella regione dei Dogon in Niger e che faceva una pittura
divinatoria. Anni prima dipingeva una volpe e poi andava dai Dogon a cercare questa volpe e i suoi
significati. Non voleva fare il falsa- rio, ma quando gli ho detto che si trattava di falsificare De
Chirico mi ha risposto che poteva farlo, perché anche De Chirico era un falsario.
Quando gli ho chiesto se sapeva fare dei ritratti, mi ha risposto che non ne faceva da molto
tempo, ma che proprio 15 giorni prima aveva ritratto due gemelli, che non erano però molto
somiglianti! La pittura divinatoria era lui! Avevo trovato il pittore.
Ho quindi introdotto alcuni elementi nuovi, ho rinforzato la figura del pittore. Era la sua
pittura che provocava gli avvenimenti. Durante le riprese c’era stato un temporale e i tecnici, tutti
cultori delle belle immagini, non volevano girare perché si trattava di una sequenza non prevista dal
copione. Ho deciso di girare immediatamente. Poi ho detto al pittore di dipingere l’arcobaleno.
Nel montaggio ho cambiato la successione degli avvenimenti: era il pittore, che dipingendo
l’arcobaleno, provocava il temporale. La sua era una pittura premonitrice e lui era un personaggio
pericoloso. L’ho presentato fin dall’inizio, cosa che non era chiara nella sceneggiatura, come un
grande falsario, un virtuoso della doppia immagine, che poteva fare di tutto. Era lui che faceva
funzionare il sottomarino, dipingeva il sottomarino e il sottomarino esisteva. Si entrava dunque in
un gioco fra immaginari complementari.
A che punto è il suo lavoro sul film?
Rondolino mi aveva chiesto di presentarlo all’inaugurazione del Festival Giovani, ma il
tempo a disposizione era troppo poco. Ne ho presentato una versione provvisoria e le reazioni sono
state abbastanza positive.
Sono molto contento perché il film si apre con il ritratto di Gualino dipinto da Casorati. Il
vecchio proiezionista del cinema dove il film è stato proiettato per la prima volta, mi è venuto a
cercare per dirmi che aveva lavorato per Gualino e che era esattamente così, un mecenate. È
fantastico... Un altro avrebbe detto: «Ma cosa c’entra Gualino con questa storia?»... Avevo vinto
dunque, era stato un lavoro duro, ma il film reggeva. Adesso lo sto montando qui a Parigi e sto
facendo delle scelte difficili.
Ha avuto qualche problema durante la ripresa?
Il rischio enorme di questo film è stato di avere avuto un tempo di lavorazione molto breve,
solo 15 giorni. Ho girato il film con due cineprese 16 mm come in Dionysos, lavoravo con un
ottimo operatore, che era anche un po’ regista. Questo è stato un errore, perché non era un vero
regista. Quando filmava da solo e io lo dirigevo, tutto funzionava perfettamente, ma quando
lavoravamo insieme le macchine da presa non erano complementari. Lui non sapeva fare la sua
messa in scena o forse non osava, perché pensava di intralciarmi. Quando abbiamo girato piani fissi,
seduti su sedie a rotelle, tutto ha funzionato bene. In un’altra sequenza, invece, mentre io mi
muovevo perfettamente a mio agio fra i ragazzini, lui continuava a girare piani fissi.
Durante Chronique d’un été mi ero già reso conto che non si può montare un film con due
messe in scena diverse, non ci possono essere due autori, voglio dire. Infatti, quando qualche giorno
fa ho presentato il film ad alcuni amici della scuola di Cinema di Londra, anche loro hanno notato
che il mio secondo operatore non era un film-maker, un cineasta, ma solo un operatore. La sua
messa in scena non si adattava alla mia, il risultato era una specie di ping-pong, un po’ maldestro.
Dal momento che non avevamo preparato le riprese, i due occhi non si raccordavano e perciò è stato
necessario semplificare il materiale. Ed è quello che ho fatto, scegliendo, in alcune sequenze, una
sola macchina da presa. Si è ricostituita l’unità di un piano sequenza, scegliendo un solo sguardo.
Ho ridotto il film da 1h ‘40 a 1h ‘30 e penso che adesso ci siamo.
So che ha appena finito di girare un film su uno spettacolo teatrale. Quali sono le ragioni di
questa scelta?
Uno dei miei studenti, Julius Amedée Laou, è originario delle Antille e un paio d’anni fa ha
scritto una pièce teatrale che si chiama Folies ordinaires d’une fille de chambre ed è stata presentata
al Festival d’Automne. È la storia di una vecchia che vive in un ospedale psichiatrico da
sessant’anni, dopo la morte del marito nella guerra del 1914. Ha avuto un figlio che non ha potuto
tenere con sé. Conosce una ragazza che scambia per sua figlia e insieme a lei condivide i suoi
fantasmi. Il problema vero del testo è quello della razza delle Antille, che è una razza maledetta
discendente da Cam, che per questo è destinata ad essere schiava dei bianchi. L’unica soluzione per
uscire da questo stato di inferiorità è quella di sposare un bianco (meglio se un prete, perché
benedetto) per migliorare la razza. Sono interessato a questo tema, perché l’avevo trattato in La
Pyramide humaine, che era un film sul razzismo.
È una pièce molto violenta di un’ora e un quarto e io ho pensato che sarebbe stato
meraviglioso girare un piano sequenza della stessa durata. Ne ho parlato all’Institut National des
Audio-visuels, che ha deciso di partecipare alla produzione.
L’opera era stata messa in scena da un grande regista di teatro francese, Daniel Mesguish,
che mi ha detto che il primo problema da risolvere era quello del pubblico (cosa sarebbe successo
dalla parte del pubblico?). Allora ho avuto un’idea, buona all’inizio, ma che poi non si è rivelata
molto utile: Charquot e la sua équipe di medici andava in un ospedale a visitare una malata
straordinaria, per una dimostrazione scientifica sulla grande isteria. In questo modo i medici
diventavano i miei spettatori.
Ho cercato allora di avere un’autorizzazione per girare in un ospedale psichiatrico, ma non è
stato possibile, era vietato. Cercando ancora, insieme a uno dei miei assistenti, abbiamo scoperto nei
Jardins de l’Observatoire un piccolo padiglione costruito intorno al 1920 in mattoni, che poteva
sembrare il padiglione di un ospedale psichiatrico. Ottenuta l’autorizzazione attraverso il Centre
National de la Recherche Scientifique, ne abbiamo trasformato la struttura con l’aiuto delle
scenografie teatrali.
Il problema più grave che dovevo affrontare era quello dello spazio per le riprese. Ho deciso
di far seguire l’infermiera da una macchina da presa mentre io ho lavorato con il grandangolo,
muovendomi intorno al letto e avvicinandomi alla malata. I miei centri di attenzione erano la malata
e l’infermiera con i medici alle spalle. Lo spazio d’azione dei due personaggi era delimitato dai
piedi del letto. Essi si parlavano attraverso la spalliera del letto.
Ho girato tutto in piano sequenza, ma senza l’intenzione di fare una performance. Avevo
due cineprese: una con un caricatore di 6 minuti e la mia con un caricatore dì 10 minuti, bisognava
lavorare con uno scarto di 6 minuti. Quando l’altro operatore arrivava alla fine del caricatore, il
fonico, che mi stava vicino, mi avvertiva che ero solo. In quel momento prendevo delle precauzioni,
evitavo di muovermi per non commettere errori irrimediabili. Lo stesso succedeva quando ero io a
finire il caricatore. Dopo questi intervalli continuavamo a lavorare come in precedenza. Abbiamo
girato così quasi per un’ora, senza nessun problema tecnico. Nel mio mirino assistevo a uno
spettacolo teatrale, all’inizio un po’ ripetitivo, che diventava un film. Eravamo molto vicini agli
attori, li seguivamo sulla scena.
Questo tipo di ripresa era legato a questo caso specifico oppure si comporterebbe in modo
analogo anche in uno altro spettacolo teatrale?
Non lo so, so che in questo caso ha funzionato. Poi però ho avuto un problema, una lampada
è scoppiata, perché la sala era illuminata, nonostante le finestre aperte, la luce non era sufficiente.
In realtà, lavorava in studio..
Sì, in studio, in un certo senso... ma con la massima apertura. Uso poco le luci, lavoro
sempre con la massima apertura.
Comunque, è stata cambiata la lampada e stranamente non siamo stati in grado di
ricominciare. Abbiamo continuato a girare per avere una fine, ma sapevo che non avrebbe
funzionato. Siamo tornati il giorno dopo. Gli attori hanno cominciato a recitare alcune scene che
precedevano il punto in cui ci eravamo fermati il giorno prima, allora si è ricreata la giusta
atmosfera e abbiamo girato fino alla fine. Abbiamo finito il film in due giorni.
Secondo lei per filmare uno spettacolo teatrale è sempre necessario stare sulla scena
oppure è possibile utilizzare un’altra strategia di ripresa?
Bisogna filmarlo come un reportage, a spalla, con una macchina da presa mobile, senza
preoccuparsi di altro. Posso fare un paragone fra la mia maniera di girare e una partita di tennis,
cioè, io con un grandangolo posso andare a rete se c’è qualcuno dietro che mi copre.
Rispettando comunque il tempo reale?
Il problema del tempo reale è molto interessante.
Il montaggio è stato piuttosto facile, perché avevo due macchine da presa che lavoravano
insieme. Dopo la sincronizzazione si è cominciato a montare, tenendo conto dei piani obbligatori,
girati con una sola macchina da presa. Ho avuto qualche problema con il mio caricatore e quindi
invece di avere un minuto di intervallo ne ho avuti tre.
Mi sono accorto, però, molto presto che il cambiamento dell’angolo di ripresa, da un
obiettivo da 16 mm a un 10 mm, provocava anche un cambiamento del tempo. Non ho conservato,
quindi, il tempo reale, anche perché ho dovuto aggiungere il suono.
Nel passaggio da un piano medio a un primo piano, l’occhio percepisce in tempi diversi il
loro contenuto (più tempo per il piano medio, meno per il primo piano). Bisogna, allora, allungare i
tempi, usando forse il rallentatore.
Io ho proceduto al contrario, in maniera antirazionale, accorciando i tempi dei piani generali
e allungando quelli dei piani ravvicinati. Per questo ogni attacco fra una macchina da presa e l’altra
non era mai nel tempo esatto. C’era una differenza non enorme, mezzo secondo circa. Agendo
sull’immagine e truccando il suono con dei silenzi, siamo riusciti a combinare gli attacchi fra le due
macchine da presa. Il suono era registrato su due bande magnetiche e il fonico passava dall’una
all’altra oppure le usava insieme per rendere la distanza con una piccolissima eco. I suoni non erano
gli stessi, non erano presi dallo stesso punto, erano missati gli uni con gli altri. Qualche volta il
fonico li spostava uno davanti all’altro per dare una eco, con una differenza di 3 o 4 millesimi di
secondo. In questo modo avevo una specie di ricostruzione sonora del tempo cinematografico.
Abbiamo poi dovuto girare anche dei piani di raccordo.
Comunque io e il mio operatore, eravamo entrambi cineasti e conoscevamo bene il nostro
lavoro, filmando in piena sincronia.
Pensa che sia possibile fare un film su uno spettacolo teatrale come un documentario, senza
intervenire in alcun modo sulla sua struttura?
Adesso sto progettando un film su una commedia musicale, che girerò a Dakar. Lo filmerò
rispettando l’ordine delle scene, ma in un’ambientazione reale.
Collabora a questo lavoro Jean Claude Carrière, lo sceneggiatore di Buñuel, che vorrebbe
fare insieme teatro e cinema.
Uno spettacolo teatrale va trattato come una realtà, va messo nella sua ambientazione
naturale. Bisogna muoversi sulla scena. E poi i cambiamenti d’angolo non consentono raccordi
facili, anche se molti usano le dissolvenze incrociate come collanti per i passaggi temporali che non
funzionano. Ma filmare in un teatro.., no, non saprei come fare.