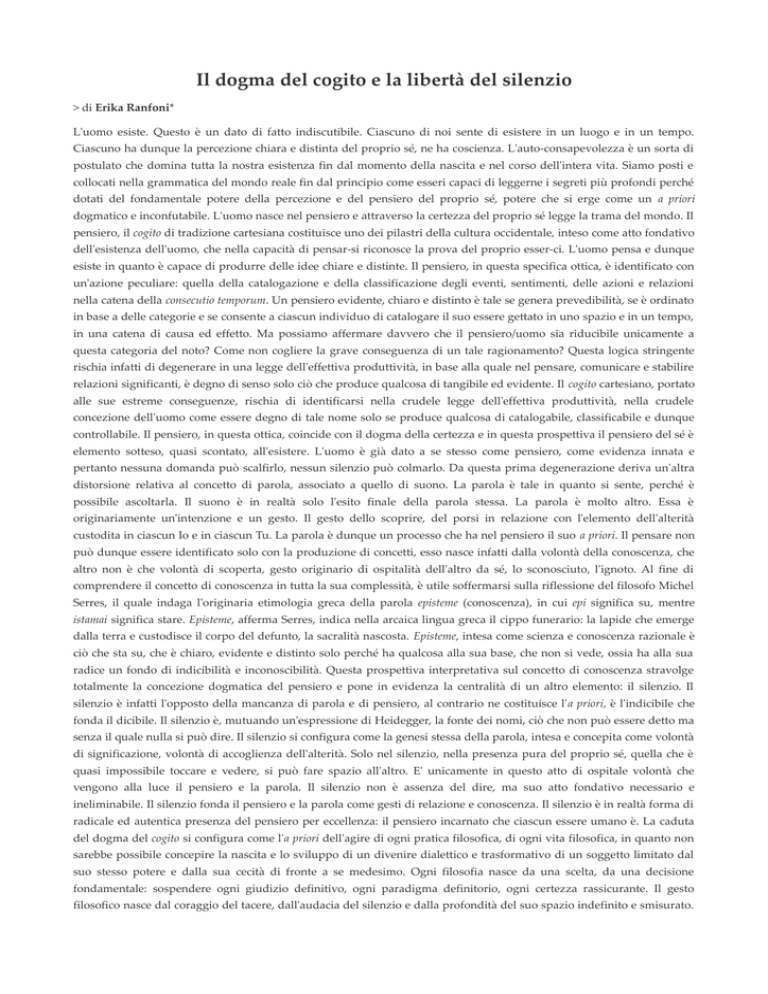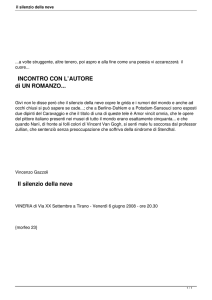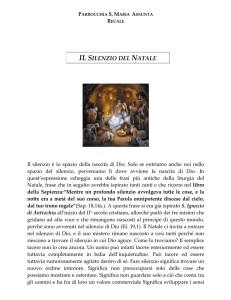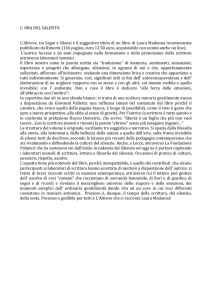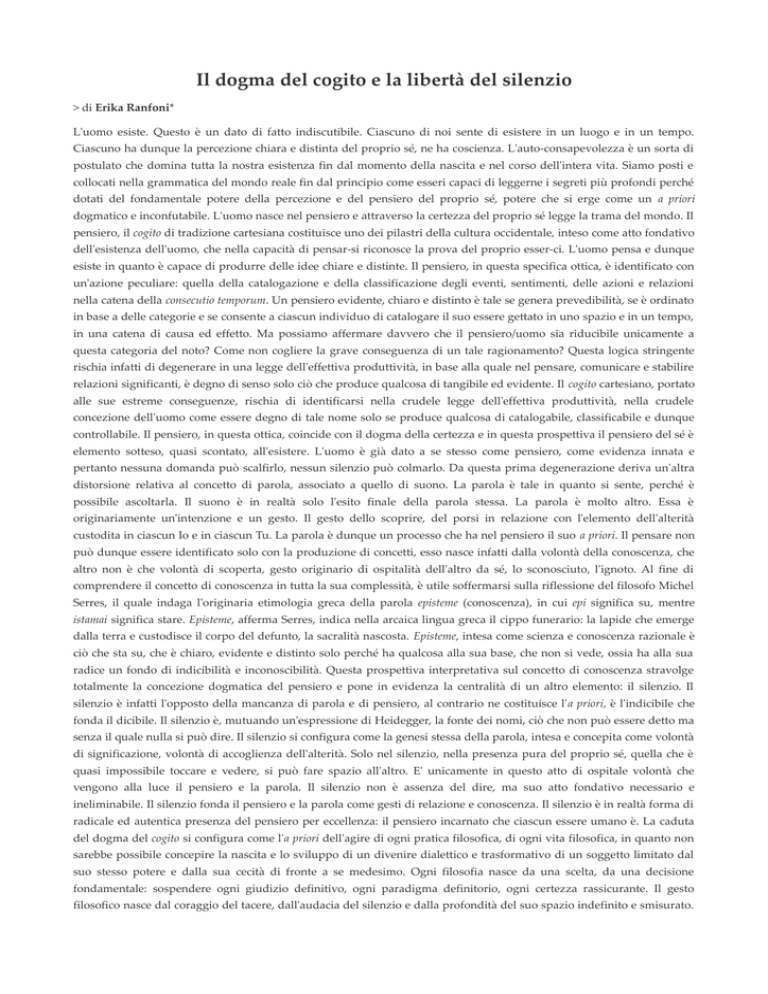
Il dogma del cogito e la libertà del silenzio
> di Erika Ranfoni*
L'uomo esiste. Questo è un dato di fatto indiscutibile. Ciascuno di noi sente di esistere in un luogo e in un tempo.
Ciascuno ha dunque la percezione chiara e distinta del proprio sé, ne ha coscienza. L'auto-consapevolezza è un sorta di
postulato che domina tutta la nostra esistenza fin dal momento della nascita e nel corso dell'intera vita. Siamo posti e
collocati nella grammatica del mondo reale fin dal principio come esseri capaci di leggerne i segreti più profondi perché
dotati del fondamentale potere della percezione e del pensiero del proprio sé, potere che si erge come un a priori
dogmatico e inconfutabile. L'uomo nasce nel pensiero e attraverso la certezza del proprio sé legge la trama del mondo. Il
pensiero, il cogito di tradizione cartesiana costituisce uno dei pilastri della cultura occidentale, inteso come atto fondativo
dell'esistenza dell'uomo, che nella capacità di pensar-si riconosce la prova del proprio esser-ci. L'uomo pensa e dunque
esiste in quanto è capace di produrre delle idee chiare e distinte. Il pensiero, in questa specifica ottica, è identificato con
un'azione peculiare: quella della catalogazione e della classificazione degli eventi, sentimenti, delle azioni e relazioni
nella catena della consecutio temporum. Un pensiero evidente, chiaro e distinto è tale se genera prevedibilità, se è ordinato
in base a delle categorie e se consente a ciascun individuo di catalogare il suo essere gettato in uno spazio e in un tempo,
in una catena di causa ed effetto. Ma possiamo affermare davvero che il pensiero/uomo sia riducibile unicamente a
questa categoria del noto? Come non cogliere la grave conseguenza di un tale ragionamento? Questa logica stringente
rischia infatti di degenerare in una legge dell'effettiva produttività, in base alla quale nel pensare, comunicare e stabilire
relazioni significanti, è degno di senso solo ciò che produce qualcosa di tangibile ed evidente. Il cogito cartesiano, portato
alle sue estreme conseguenze, rischia di identificarsi nella crudele legge dell'effettiva produttività, nella crudele
concezione dell'uomo come essere degno di tale nome solo se produce qualcosa di catalogabile, classificabile e dunque
controllabile. Il pensiero, in questa ottica, coincide con il dogma della certezza e in questa prospettiva il pensiero del sé è
elemento sotteso, quasi scontato, all'esistere. L'uomo è già dato a se stesso come pensiero, come evidenza innata e
pertanto nessuna domanda può scalfirlo, nessun silenzio può colmarlo. Da questa prima degenerazione deriva un'altra
distorsione relativa al concetto di parola, associato a quello di suono. La parola è tale in quanto si sente, perché è
possibile ascoltarla. Il suono è in realtà solo l'esito finale della parola stessa. La parola è molto altro. Essa è
originariamente un'intenzione e un gesto. Il gesto dello scoprire, del porsi in relazione con l'elemento dell'alterità
custodita in ciascun Io e in ciascun Tu. La parola è dunque un processo che ha nel pensiero il suo a priori. Il pensare non
può dunque essere identificato solo con la produzione di concetti, esso nasce infatti dalla volontà della conoscenza, che
altro non è che volontà di scoperta, gesto originario di ospitalità dell'altro da sé, lo sconosciuto, l'ignoto. Al fine di
comprendere il concetto di conoscenza in tutta la sua complessità, è utile soffermarsi sulla riflessione del filosofo Michel
Serres, il quale indaga l'originaria etimologia greca della parola episteme (conoscenza), in cui epi significa su, mentre
istamai significa stare. Episteme, afferma Serres, indica nella arcaica lingua greca il cippo funerario: la lapide che emerge
dalla terra e custodisce il corpo del defunto, la sacralità nascosta. Episteme, intesa come scienza e conoscenza razionale è
ciò che sta su, che è chiaro, evidente e distinto solo perché ha qualcosa alla sua base, che non si vede, ossia ha alla sua
radice un fondo di indicibilità e inconoscibilità. Questa prospettiva interpretativa sul concetto di conoscenza stravolge
totalmente la concezione dogmatica del pensiero e pone in evidenza la centralità di un altro elemento: il silenzio. Il
silenzio è infatti l'opposto della mancanza di parola e di pensiero, al contrario ne costituisce l'a priori, è l'indicibile che
fonda il dicibile. Il silenzio è, mutuando un'espressione di Heidegger, la fonte dei nomi, ciò che non può essere detto ma
senza il quale nulla si può dire. Il silenzio si configura come la genesi stessa della parola, intesa e concepita come volontà
di significazione, volontà di accoglienza dell'alterità. Solo nel silenzio, nella presenza pura del proprio sé, quella che è
quasi impossibile toccare e vedere, si può fare spazio all'altro. E' unicamente in questo atto di ospitale volontà che
vengono alla luce il pensiero e la parola. Il silenzio non è assenza del dire, ma suo atto fondativo necessario e
ineliminabile. Il silenzio fonda il pensiero e la parola come gesti di relazione e conoscenza. Il silenzio è in realtà forma di
radicale ed autentica presenza del pensiero per eccellenza: il pensiero incarnato che ciascun essere umano è. La caduta
del dogma del cogito si configura come l'a priori dell'agire di ogni pratica filosofica, di ogni vita filosofica, in quanto non
sarebbe possibile concepire la nascita e lo sviluppo di un divenire dialettico e trasformativo di un soggetto limitato dal
suo stesso potere e dalla sua cecità di fronte a se medesimo. Ogni filosofia nasce da una scelta, da una decisione
fondamentale: sospendere ogni giudizio definitivo, ogni paradigma definitorio, ogni certezza rassicurante. Il gesto
filosofico nasce dal coraggio del tacere, dall'audacia del silenzio e dalla profondità del suo spazio indefinito e smisurato.
Può apparire un paradosso accostare il concetto del tacere allo stile filosofico da sempre associato al dire. Il termine
paradosso è in realtà quello più adeguato a questa associazione semantica dal momento che esso nella sua originaria
etimologia greca indica ciò che va oltre la doxa, ossia oltre l'opinione comune. Una riflessione filosofica è sempre fondata
sulla messa in atto di questo gesto, ossia sull'andare oltre ogni opinione e ogni luogo comune su cui essa si fonda per
decostruirla, per comprenderla e capovolgerla. Ma ogni capovolgimento, ogni audace sconvolgimento del reale non
parte sempre dal silenzio muto e devastante dell'incertezza e del dubbio? Ogni metamorfosi non nasce forse dalla
coraggiosa e dolorosa libertà del non sapere? «La vita filosofica richiede infatti un cambiamento nel nostro modo
d'essere, non è un'azione (mentale-fisica) che si aggiunge alle tante altre nostre azioni quotidiane. Si tratta piuttosto di
mutare la nostra stessa presenza. (…) Il filosofico della vita ha il carattere della sospensione, che si concretizza nella vita
esaminata, nella interrogazione; investe il campo della presenza attraverso le coordinate del tempo e dello spazio; si
sviluppa attraverso il colloquio e può essere reso più ricco attraverso l'esercizio» [1]. Il gesto filosofico per eccellenza è
dunque il pensare che nasce da un interrogativo radicale sul pensiero stesso, ossia la domanda di senso che il soggetto
pone in relazione alla sua stessa presenza e che richiede come punto di partenza il coraggioso tacere di ogni certezza.
L'abbandono di ogni atteggiamento dogmatico è un atto complesso, doloroso, perché comporta la perdita di ogni
apparente determinatezza e chiarezza d'essere e di esistere, ogni certa presenza. La caduta di ogni forma di assolutismo
ontologico relativo a convinzioni, idee, scelte, valori, è la premessa necessaria, l'incipit originario di una presenza, ossia di
un modo d'essere e di pensare che voglia definirsi filosofico. La consapevolezza della a-dogmaticità dell'essenza del
pensiero è in realtà la scoperta della vera e autentica natura dell'uomo, del suo essere un inesauribile divenire, un infinito
cominciamento così come afferma Hannah Arendt: «E' nella natura del cominciamento che di nuovo possa iniziare senza
che possiamo prevederlo in base ad accadimenti precedenti. (...) Il nuovo si verifica sempre contro la tendenza prevalente
delle leggi statistiche e della loro probabilità, che a tutti gli effetti pratici e quotidiani corrisponde alla certezza; il nuovo
appare sempre alla stregua di un miracolo. Il fatto che l'uomo sia capace di azione significa che da lui ci si può attendere
l'inatteso, che è in grado di compiere ciò che è infinitamente improbabile. E ciò è possibile solo perché ogni uomo è unico
e con la nascita di ciascuno viene al mondo qualcosa di nuovo nella sua unicità» [2]. Pensare, alla luce di quanto detto, e
soprattutto pensare filosoficamente significa vedere la realtà con gli occhi della meraviglia propria di ogni nuovo
cominciamento, propria dell'unicità che ogni esistenza umana possiede come fondamento del suo poter sempre essere
oltre se stessa.
[1] Stefano Zampieri, Introduzione alla vita filosofica, Mimesis, Milano-Udine, 2010, p. 36.
[2] Hannah Arendt, Vita Activa, Bompiani, 2004, p. 129.
* Erika Ranfoni (1978) opera come Docente di Filosofia e come Filosofo pratico nella realizzazione di percorsi di
consulenza e formazione per privati ed organizzazioni. Nel 2004 consegue la Laurea magistrale in Filosofia presso
l'Università degli studi di Lecce e nel 2007 inizia la sua esperienza professionale come docente di Storia e Filosofia nella
scuola secondaria. Appassionata allo studio del pensiero e della mente nel 2011 consegue la Laurea in psicologia presso
l'Università Internazionale Uninettuno e nel marzo 2012 l'abilitazione professionale come Dottore in tecniche psicosociali
presso l'Università degli studi di Bari. Dal 2010 è curatrice di seminari di formazione e di studio nell'ambito dell' ethics of
care e di percorsi di consulenza nell'ambito delle Pratiche filosofiche.
Filosofia e nuovi sentieri/ISSN 2282-5711
http://filosofiaenuovisentieri.it/2013/07/13/il-dogma-del-cogito-e-la-liberta-delsilenzio/
© Filosofia e nuovi sentieri 2013. Tutti i diritti riservati