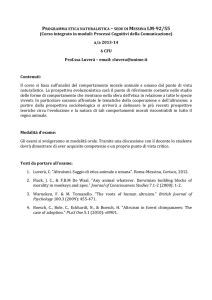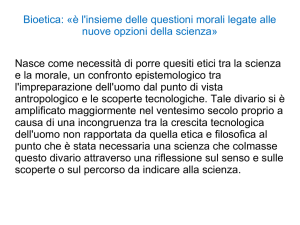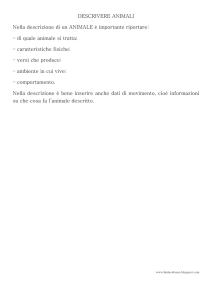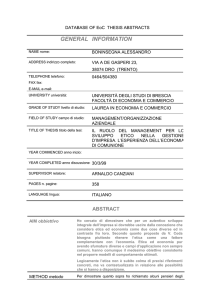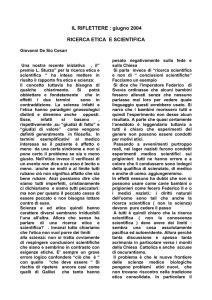Da Luisella Battaglia, Un’etica per il mondo vivente. Questioni di bioetica medica,
ambientale, animale, Ed. Carocci , Roma 2011
Uomo, natura, animali. Questioni di confine
Benessere animale e salute umana
L’etologia è forse la scienza che, nella mappa odierna del sapere, ha svolto un ruolo essenziale
nell’eliminare la cesura tra l’uomo e gli altri esseri. La crescita delle nostre informazioni sulla vita
animale ha suscitato importanti interrogativi circa i confini dell’universo cui si riferisce il nostro
discorso morale; del pari, l’esigenza di rivisitare e ridefinire taluni concetti cruciali – vita, esistenza,
persona – ha preso forma all’interno di un processo che ha visto l’etica impegnata a promuovere
una riflessione multidisciplinare sulle implicazioni concettuali e normative delle conoscenze
etologiche. Ci si chiede se la morale debba essere circoscritta solo alle relazioni interumane o se i
nostri doveri si estendano anche verso l’ambiente e le altre specie; si discute sull’ambito di
applicazione delle principali categorie etiche – prossimo, giustizia, responsabilità. Quali valori
morali potrebbero configurare un corretto comportamento verso i non umani? Come ripensare le
nozioni etiche tradizionali, ormai inadeguate rispetto alle informazioni scientifiche nel frattempo
acquisite?
Se la medicina veterinaria fornisce un corredo indispensabile di conoscenze scientifiche, di dati,
di informazioni fattuali relative alla vita e al benessere degli animali, la filosofia è in grado di offrire
un quadro categoriale necessario per porre in prospettiva teorica e per sostanziare di precisi
riferimenti culturali il problema del rapporto umano/non umano. In tal modo, sarà possibile
approntare un codice etico più conforme ai dati scientifici di recente emersi e più rispettoso della
nuova sensibilità nel frattempo maturata. Siamo alla ricerca di un quadro di riferimento teorico che
tenga conto delle implicazioni, sul piano etico, della rivoluzione darwiniana e degli apporti di
scienze come l’etologia e la medicina veterinaria, per interrogarci sulla nuova immagine dell’uomo
che ne è scaturita. È questa, forse, una delle più affascinanti sfide intellettuali del nostro tempo.
L’etica della biocultura. Un contratto tra uomo e animale
Negli anni ottanta, sulla scia anche dell’accresciuta attenzione per le sofferenze che la nostra specie
può provocare alle altre con l’allevamento e la sperimentazione, si registra l’introduzione in molte
facoltà di veterinaria di discipline come Etologia e Benessere animale. Uno tra i maggiori
protagonisti di questa svolta è Bernard Rollin, docente di filosofia e di fisiologia, il quale ha dato
vita, presso la Colorado State University, al primo corso al mondo di Etica veterinaria e diritti
animali. Così egli descrive il profondo mutamento della nostra etica sociale:
Venticinque anni fa sarebbe stato culturalmente inconcepibile suggerire un’estensione della comunità morale
che includesse gli animali nell’ambito della considerazione etica [...]. L’attenzione della società era limitata
alla proibizione della crudeltà non necessaria, dolore intenzionale ed evidente e a un vacuo incoraggiamento
della benevolenza. Quest’etica minimalista era formalmente incorporata nelle leggi contro la crudeltà [...].
Anche il tradizionale movimento per il benessere degli animali era impelagato nelle categorie di benevolenza
e di crudeltà. Nel corso dei due decenni passati, la società ha cominciato palesemente a spingersi oltre la
troppo superficiale etica della crudeltà e della benevolenza e ha iniziato ad aspirare a un insieme di categorie
morali più adatte a guidare, valutare e disciplinare il nostro trattamento degli altri animali. Forse l’intuizione
che sta dietro a questo cambiamento è la comprensione di come la stragrande maggioranza delle sofferenze
che gli umani infliggono agli animali non sia frutto di crudeltà ma derivi, invece, dall’uso “normale” degli
animali e da motivi socialmente accettabili.
Nel fare particolare riferimento ai laboratori di ricerca e agli allevamenti industriali, due contesti in
cui alla legittimità degli scopi – gli ideali della scienza, da un lato, e la ricerca della produttività,
dall’altro – fa riscontro una quantità di sofferenza inimmaginabile degli animali utilizzati, Bernard
Rollin ricorda che
l’uso primario degli animali è sempre stato agricolo. Gli animali venivano tenuti in ambienti conformi alla
loro natura e per cui essi erano evoluti attraverso una selezione naturale o artificiale. In altre parole,
l’agricoltura era un implicito contratto tra umano e animale: “Io prendo cura degli animali ed essi si
prendono cura di me”, come sottolineano molti tradizionali allevatori. Il principio di trattare bene gli animali
della fattoria era insieme una massima etica e prudenziale. Danneggiare gli animali significava danneggiare
se stessi [...]. Pertanto l’etica sociale non vedeva alcun bisogno di focalizzarsi sul trattamento animale
“normale” e limitava la sua attenzione alla “crudeltà” non necessaria.
Secondo il docente americano, negli ultimi cinquant’anni, in seguito agli allevamenti industriali, si è
verificato un mutamento drammatico della situazione che ha reso inadeguata la prospettiva
tradizionale basata sulla prevenzione della crudeltà. La scienza e la tecnologia consentono infatti di
tenere gli animali in condizioni per cui essi non sono adatti né biologicamente né psicologicamente,
traendone tuttavia un profitto: gli animali, infatti, per quanto infelici siano, possono ancora essere
produttivi. In tal modo, viene spezzato il contratto tradizionale tra umani e animali. L’etica della
biocultura – che si occupa dei problemi morali relativi al rapporto di gestione da parte dell’uomo di
altri esseri non umani – intende «prendere sul serio» quel contratto, implicito ma operante per
millenni. Per biocultura s’intende, infatti, quell’insieme di istituzioni, pratiche sociali e attività
organizzate (allevamenti, laboratori ecc.) in cui gli uomini fanno uso di animali per realizzare le
loro finalità, sfruttandoli sistematicamente a loro esclusivo beneficio .
Tali attività sono caratterizzate da due aspetti: il dominio totale da parte dell’uomo (gli animali
sono programmati attraverso metodi di controllo genetico) e la riduzione degli animali a mezzi.
In che senso possiamo parlare di etica in un settore che è contraddistinto dal dominio e dallo
sfruttamento di altri esseri viventi? In realtà, l’esigenza di un discorso etico nasce proprio dal
riconoscimento del potere assoluto dell’uomo sui non umani, un potere che deve essere regolato da
norme e che implica l’assunzione di precise responsabilità. Quali? Innanzitutto, la responsabilità
storica della domesticazione. Uno dei punti fondamentali dell’etica della biocultura è costituito dal
legame tra potere e responsabilità. Il fatto che esercitiamo potere su altri esseri – si osserva – non
significa che abbiamo assoluta licenza di fare ciò che vogliamo o che ci conviene; tale esercizio di
potere comporta, infatti, una precisa responsabilità per il loro benessere. Si afferma che, se
alleviamo animali per usare i loro prodotti o i loro corpi, la nostra responsabilità nei loro confronti
non solo non diminuisce ma, anzi aumenta.
Si tratta di osservazioni, a prima vista, sconcertanti: siamo, infatti, abituati a pensare a una nostra
responsabilità nei confronti degli animali che ci appartengono o di cui ci prendiamo cura (i
cosiddetti pets). In che senso dovremmo essere responsabili nei confronti degli animali da reddito?
La risposta potrebbe essere duplice. In primo luogo, occorre distinguere tra sfera affettiva e sfera
morale. In analogia con l’etica umana, i nostri doveri verso gli altri non dipendono dai nostri
sentimenti di affetto o di simpatia: non siamo tenuti a essere morali solo verso chi ci è simpatico,
verso parenti e amici ecc. Il comportamento morale presuppone, infatti, l’imparzialità, l’assenza di
ogni discriminazione arbitraria. In secondo luogo, riconoscere che questi animali ci rendano dei
“servizi”, che usiamo i loro prodotti, i loro corpi e che quindi viviamo su di loro e di loro, dovrebbe
farci sentire la responsabilità del loro benessere, assicurando un trattamento, almeno adeguato ai
servizi da essi resi. Siamo dinanzi a un problema fondamentale per la nostra collettività giacché
riguarda non solo gli zoofili – gli amici degli animali – ma anche, e forse soprattutto, i loro
consumatori, i loro detentori, ogni persona, in altri termini, che ha un rapporto diretto o indiretto di
sfruttamento con essi.
Gli animali sono attualmente al servizio dell’uomo: questa è la realtà della domesticazione. Il
riconoscimento di tali servizi – ci ricorda l’etica della biocultura – dovrebbe conferire loro dei diritti
anche all’interno di una prospettiva antropocentrica, nei termini cioè di una giustizia intraspecifica,
valida all’interno della nostra specie: una giustizia di uomini e per uomini, che non voglia tuttavia
essere incoerente con i suoi assunti e tradire i presupposti fondamentali su cui afferma di basarsi.
L’etica della biocultura comporta, pertanto, alcune conseguenze assai rilevanti: a) il passaggio da
una prospettiva puramente economica a una morale. In questo quadro, gli animali non sono
unicamente risorse da sfruttare, merce da amministrare razionalmente ma appaiono come esseri
dotati di interessi, di bisogni, meritevoli di tutela; b) il cambiamento del ruolo umano,
contraddistinto dal passaggio dalla cultura del dispotismo a quella della custodia. A causa delle
conquiste della scienza e della tecnica abbiamo acquisito la consapevolezza di un potere che ci
rende di fatto non solo arbitri della nostra evoluzione ma, altresì, responsabili del destino della terra
e delle specie che la abitano. Il nostro essere la specie vincente non ci dà carta bianca, assoluta
licenza: su di noi incombono responsabilità gravi, legate alla nostra schiacciante presenza
dominatrice.
Una pratica, se ne deduce, non può venire ammessa solo perché produttiva, né il nostro interesse
di specie può giustificare qualunque azione. Le domande a cui rispondere saranno: quali sacrifici
implica una certa pratica per il benessere animale? Quali interessi fondamentali vengono negati?
L’allevamento zootecnico è diventato ormai un processo industriale in cui tutto è finalizzato
all’incremento della produzione: a una determinata quantità di calorie, proteine, carboidrati
somministrati al bestiame o al pollame devono corrispondere tante uova, litri di latte, chili di carne .
L’etica della biocultura prescrive che gli allevamenti siano realizzati in modo da garantire agli
animali una determinata misura di benessere, il che presuppone la conoscenza scientifica delle loro
necessità fisiologiche e comportamentali, in base a studi etologici appositamente condotti. In questa
maniera è possibile adottare metodologie di allevamento che, pur sfruttando le capacità produttive
degli animali, non ne alterino le condizioni fondamentali di benessere. Tale istanza sembra recepita
nella voce Bioetica del Manuale Merck veterinario:
Mentre i principali obiettivi delle pratiche di benessere sono legati all’attenuazione della sofferenza, la
promozione di uno stato di felicità (o dello stato di benessere dell’animale) è un obiettivo etico. I due
termini: benessere e stato di benessere non sono sinonimi. Lo stato di benessere è una condizione intrinseca
dell’animale; è rappresentato da uno stato di buona salute e di armonia dell’animale con l’ambiente. Il
benessere comprende molti attributi tendenti allo stato di benessere ma è rappresentato principalmente da
pratiche che tendono ad adattare l’ambiente. In altre parole, il benessere è esogeno mentre lo stato di
benessere è endogeno. [...] Le pratiche etiche nel mondo dell’allevamento devono avere come base il
benessere esteriore degli animali stessi. Non dev’essere promosso l’allevamento in condizioni che possono
produrre stress [...]. Anche condizioni ambientali normali di allevamento, in una situazione urbana o in
laboratorio, possono risultare stressanti.
Tali rilievi sembrano confermare la necessità di compiere un’analisi costi/benefici e, soprattutto, di
decidere quale modello di biocultura scegliere, cercando un equilibrio tra la nostra utilità e il
benessere animale. Ma un altro elemento essenziale di cui tenere conto è rappresentato
dall’ambiente.
Imprese umane ed ecosistema. Nuovi modelli di integrazione ambientale.
Nell’etica della biocultura si persegue un modello di integrazione ambientale, espressione con cui si
intende il deliberato tentativo di adattare le imprese umane all’ambiente naturale, in modo tale da
preservarne l’integrità ecologica. Com’è noto, l’allevamento degli animali si è profondamente
modificato, in questi ultimi decenni, sulla spinta delle innovazioni tecnologiche e per la necessità di
accrescere la produttività. Si sono avute: una progressiva concentrazione delle strutture produttive
in zone ritenute particolarmente idonee; un aumento delle dimensioni degli allevamenti, con una
concentrazione di animali impensabili fino a un’epoca recente; lo sviluppo di una zootecnia senza
terra, con un conseguente allentamento del legame tradizionale tra settore zootecnico e settore
agronomico.
Caratteristiche salienti degli allevamenti intensivi sono dunque una massima intensità di animali
sulla superficie occupata, un ampio ricorso alla meccanizzazione, un basso utilizzo di manodopera.
Il settore zootecnico aveva un’impellente necessità di tecnologie e gli allevamenti intensivi si sono
sviluppati in seguito alle pressioni delle industrie alimentari di avere prodotti a basso prezzo e,
quindi, concorrenziali sul mercato. Il costo di produzione calava notevolmente concentrando gli
animali in spazi ristretti ma, a fronte di tale risultato, si alterava irreparabilmente il caratteristico
ciclo dell’azienda agricola che legava, in un sistema che aveva raggiunto un proprio equilibrio, gli
animali allevati, la coltivazione del suolo e le produzioni vegetali. Per questi motivi, le deiezioni
animali che, per millenni, erano state considerate essenziali per garantire la fertilità del terreno sono
ora diventate tra le maggiori fonti di inquinamento.
Dal confronto interdisciplinare tra etologi, veterinari e bioeticisti sono sorti all’interno della
bioetica, fin dagli anni ottanta, settori di ricerca attinenti allo specifico tema del rapporto
zootecnia/ambiente denominati Farm Animals and Bioethics. In particolare, il filosofo ed etologo
Michael Fox, in Philosophy, Ecology, Animal Welfare and the “Rights’ Question”, avanza
l’esigenza di un approccio olistico che consideri l’intera biosfera come una sola comunità morale.
La chiave per un’etica genuinamente umana sta in un armonico equilibrio tra diritti e doveri: al
diritto primario degli animali di sviluppare il proprio potenziale naturale in un ambiente adatto
corrisponde il dovere, da parte degli uomini, di una limitazione delle pretese, non solo nei confronti
degli esseri senzienti ma dell’intera comunità biotica. S’intende, in tal modo, mettere in luce la
convergenza tra interessi dell’ecosistema e interessi dell’umanità, mostrando come l’economia
mondiale debba basarsi su un’etica della responsabilità per il pianeta. La salute e il benessere della
terra –sostiene Fox in Agricide (1986)—sono inseparabili e interdipendenti: il nostro benessere e la
nostra sicurezza, come quelle delle generazioni future, dipendono, in ultima istanza, da una
responsabile gestione del pianeta. A parere dell’autore, continuare a gratificare la crescente
domanda di carne da parte del mondo industrializzato e incoraggiare il terzo mondo ad adottare
questo modello significa compromettere irrimediabilmente la qualità della vita. Tra le conseguenze
distruttive, sul piano ambientale, del sistema di allevamento intensivo, vengono segnalate, in
particolare, quelle causate dalla deforestazione. Si tratta di una questione che riguarda l’intera
comunità mondiale, giacché, senza una riduzione del tasso di distruzione delle foreste e una
concomitante decrescita della produzione della carne, l’ecosistema della terra risulta
irreparabilmente colpito. Si sottolinea, altresì, come guadagni a breve termine compromettano un
patrimonio comune – quello delle foreste tropicali – che attualmente è sotto controllo di potenti
organizzazioni multinazionali e di governi locali, mentre la preservazione delle foreste deve essere
riconosciuta come una tra le priorità della cooperazione internazionale.
Sacrificare la qualità globale dell’ambiente al consumo crescente di carne è, per Fox, assurdo ed
ecocida. Il neologismo ecocidio configura un delitto contro l’ecosistema: ciò testimonia, ancora una
volta, l’esigenza di uscir fuori dal vecchio quadro di riferimento della moralità individuale e di
elaborare un’etica della responsabilità su scala planetaria come sola adeguata ad affrontare i
problemi di una umanità intesa ormai come una comunità di destino. Studiando i collegamenti tra
produttività e benessere animale, gli etologi hanno stabilito che agli animali da reddito debbano
essere assicurate le cinque seguenti libertà fondamentali: 1) libertà dalla fame e dalla sete; 2) libertà
dal disagio fisico e termico; 3) libertà dai traumi e dalle malattie; 4) libertà dalla paura e dagli
stress; 5) libertà dall’annullamento del comportamento normale .
È molto importante che tali conclusioni siano basate sulle ricerche di etologi, veterinari e
agronomi, professionisti certo non sospettabili di sentimentalismo zoofilo. Le affermazioni per cui i
moderni sistemi di allevamenti industriali non sono affatto adeguati ai bisogni fondamentali degli
animali non possono più essere liquidate con sufficienza come approcci soggettivi o antropomorfici
al problema del benessere animale. Una proposta praticabile, avanzata al fine di pervenire a una
definizione intersoggettivamente valida della sofferenza animale può considerarsi il cosiddetto
antropomorfismo critico, metodo che intende usare criticamente l’esperienza umana per riconoscere
le manifestazioni della sofferenza, ponendo a confronto le nostre più immediate intuizioni
soggettive con i dati e le nozioni desunte dagli studi di neurofisiologia comparata, etologia,
zoologia. In tal modo l’empatia, caratteristica dell’antropomorfismo classico, risulta temperata e
integrata dalle conoscenze scientifiche oggettive relative alla vita e al comportamento di
determinate specie. Bioeticisti, veterinari ed etologi si sono dunque trovati uniti nel sostenere la
necessità di un cambiamento. Inoltre, in linea con i nuovi orientamenti accolti da tempo anche a
livello legislativo, conflittualità e scontri tra allevatori del settore zootecnico e difensori dei diritti
degli animali potrebbero tendere, almeno in parte, ad attenuarsi. Rileva Barbara De Mori:
La riflessione bioetica sul benessere animale si propone sia di promuovere l’assunzione di un’ottica allargata
(in cui rientri anche quella dell’animale) che scaturisca da un dialogo e da un confronto tra le parti, sia di
orientare l’aumentata sensibilità verso un approfondimento delle conoscenze sul tema del benessere. Il tutto
al fine di ridurre quanto più possibile la sofferenza animale e di migliorarne le condizioni di vita, in un
progressivo allargamento – il cerchio di espansione – della considerazione etica .
La letteratura su tale problematica, ormai assai vasta, vede un graduale spostamento dall’attenzione
dai parametri fisiologici del benessere – rilevabili tramite misurazioni quantitative – agli aspetti
qualitativi delle esigenze animali, attraverso una valutazione delle preferenze e delle capacità di
sentire. Ancora una volta è la bioetica a porre in primo piano la questione della soggettività animale
con tutte le implicazioni sul piano civile che ne derivano. Tra gli anni settanta e novanta, da una
definizione negativa del benessere come “assenza di malattie” si passa infatti progressivamente a
quella di “soddisfazione piena dei bisogni” per giungere infine al cosiddetto “approccio dei
feelings” in cui ci si riferisce agli stati soggettivi e alle sensazioni degli animali.
Tale linea di tendenza è stata favorita da un complesso di fattori, tra cui una progressiva
sensibilizzazione dell’opinione pubblica per le questioni relative al benessere animale, non più
riguardato come un problema di zoofilia, ma di etica sociale e un interesse crescente dei cittadini
per i problemi della salute e di una sana alimentazione. In risposta a queste esigenze, si sono avviati,
in molti paesi della CEE, esperimenti di allevamenti alternativi ispirati a criteri ecologici e umanitari,
che si stanno rivelando imprese commercialmente assai valide. All’accresciuta domanda di prodotti
di origine animale ottenuti con sistemi alternativi e con attenzione alle filiere etiche potrebbe far
seguito una corrispondente riconversione degli allevamenti intensivi: eccellente esempio
dell’importanza del mercato, del ruolo dell’opinione pubblica e del movimento dei consumatori,
nonché della possibilità di realizzare, su questa base, una convergenza – impensabile sul piano dei
principi – tra attori sociali tradizionalmente antagonisti.
A causa dei numerosi problemi di ordine economico, tecnico, igienico e ambientale, l’esigenza
di una razionalizzazione dei sistemi di allevamento, in rapporto ai problemi dell’ambiente, è oggi
avvertita come indilazionabile. Si tratta non solo di formulare aggiornamenti normativi e di
sollecitare proposte operative che facilitino il razionale svolgimento delle attività zootecniche e
tengano conto delle diseconomie indotte quanto ai guasti ambientali e igienico-sanitari, alla
diminuita gestibilità dei terreni, al peggioramento della qualità della produzione zootecnica, quanto
di pervenire a una valutazione globale che esamini il problema alla luce di un più ampio e
lungimirante concetto di vantaggio per la società nel suo complesso.
Serviamoci di un esempio assai concreto. Molte delle questioni relative al trattamento degli
animali – dall’allevamento alla sperimentazione all’ingegneria genetica – coinvolgono problemi
importanti per la salute dell’uomo e dell’ambiente. Si pensi alla zootecnia – venuta
drammaticamente alla ribalta con la vicenda della “mucca pazza” – che ha mostrato un legame assai
stretto tra le questioni relative al benessere degli animali da carne, la salute dei consumatori e
l’impatto ambientale degli allevamenti (dalla deforestazione all’inquinamento delle acque e delle
falde acquifere). Nella prospettiva di una qualità della vita da intendersi nell’ottica della
complessità, si tratta di uscire dalla logica della scialuppa di salvataggio tentando di comporre gli
interessi o, se si vuole, i diritti di tutti i soggetti – umani e non umani – coinvolti. Occorre pervenire
a una valutazione globale che esamini il problema contestualmente, nel rispetto dell’ambiente
naturale, del benessere degli animali, della salute degli uomini.
Buono da mangiare. Quale etica per l’alimentazione?
Il caso mucca pazza è sembrato assumere dimensioni apocalittiche, scatenando lo stesso timore che
si è impossessato di noi dopo gli incidenti di Seveso, di Bopal, di Chernobyl e ora di Fukushima: il
timore di una contaminazione generalizzata della nostra vita quotidiana. Le catastrofi che ormai
temiamo maggiormente sono quelle indotte dalle nostre tecnologie, dal nostro sistema socioeconomico, dal nostro modo di vivere: non sono più un’espressione della natura ma del nostro
rapporto tecnico e simbolico con essa. Il morbo di Creutzfeldt-Jacob ci ha costretto a prendere
coscienza della centralità dell’alimentazione: un tema solo in apparenza residuale, in realtà di
grande rilevanza politica e culturale giacché se, da un lato, riguarda la vita quotidiana di milioni di
consumatori, dall’altro, chiama in causa le enormi questioni della globalizzazione dei mercati e gli
stessi equilibri politici ed economici del mondo. Se è vero che l’hamburger è l’icona
dell’imperialismo commerciale, la mucca pazza ne rappresenta, forse, il male oscuro.
Edgar Morin ha sottolineato l’inderogabile necessità di tenere nel dovuto conto alcuni fattori
fondamentali dello sviluppo, come la qualità della vita contro la dittatura della tecnocrazia, che si
basa, invece, sui grandi numeri e sulla quantità. A suo avviso, occorrerebbe disegnare una politica
di civiltà, intesa come interesse alle molteplici dimensioni che compongono la vita sociale dai
problemi ambientali a quelli relativi alla sfera personale .
L’allarme mucca pazza ha offerto un esempio assai concreto di tale necessità: è in nome dello
stesso diritto alla salute che occorre esigere un’ampia informazione sulla “storia” del nostro cibo, in
ogni stadio della catena alimentare, dalla produzione primaria al consumo, sugli ingredienti che
esso contiene (obbligo di una chiara etichettatura), sui costi – economici ma anche ecologici – che
esso comporta. Fin dagli anni ottanta, la zootecnia è diventata un’attività di riciclaggio, la cui
“vocazione ecologica” è così sintetizzata da Roberto Marchesini in Homo sapiens, mucca pazza:
non c’è sostanza che non possa essere utilizzata per placare la fame del grande golem zootecnico: paglia
trattata con ammoniaca, farine animali realizzate con scarti di macelleria, carogne animali, sottoprodotti
dell’industria ittica, lettiere animali etc.
Se lo scandalo della mucca pazza ha fatto scoprire nel 1996 all’uomo della strada che i bovini
mangiano le pecore, lo scandalo dei polli e dei maiali alla diossina, nel 1999, gli ha insegnato che
gli oli esausti dei motori entrano nella sua catena alimentare attraverso i mangimi animali. Nel suo
libro più recente, Le nuove frontiere della giustizia, Martha Nussbaum affronta esplicitamente il
problema di come conciliare i nostri standard di giustizia con i maltrattamenti inflitti agli animali,
specie nella catena alimentare e industriale.
Dobbiamo estendere la giustizia al di là dei confini della specie umana per occuparci della spaventosa
situazione degli animali non umani, molti dei quali (quelli allevati dall’industria alimentare, ad esempio)
vivono esistenze di grande dolore e privazione solo per soddisfare gli esseri umani .
Quali sono dunque i costi etici della nostra alimentazione? È irrilevante, dal punto di vista morale,
quello di cui ci nutriamo? In realtà, non esiste, forse, comportamento più carico di simbolismo di
quello alimentare: atto sacrale, momento di socializzazione, espressione culturale ma anche
fantasia, emozione, memoria. Parlare di alimentazione è in qualche modo parlare dell’uomo nella
sua interiorità, nella sua storia, nella sua religiosità, nella sua identità etico-sociale. L’alimentazione
oggi, per la sua stessa complessità, diventa cartina di tornasole per testimoniare costumi, stili di
vita, scelte morali, appartenenze, reciproci riconoscimenti, rapporti con il proprio corpo, la terra e le
altre specie, consapevolezza di nuovi diritti e di inedite responsabilità. Se è vero che abbiamo
superato le due angosce primordiali che ci hanno accompagnato dalla notte dei tempi – trovare cibo
e non divenire cibo per gli altri – oggi siamo assaliti da altre paure. Il cibo è ormai ritornato a essere
un problema: l’alimentazione è una questione troppo importante per affidarla ai soli nutrizionisti.
Per questo la bioetica è chiamata in causa. Proprio per la sua natura interdisciplinare essa può
costituire la prospettiva più adeguata per affrontare tale problematica in quanto prevede il confronto
e l’integrazione di diverse competenze: medico-sanitaria, psicosociale, giuridico-economica, eticonormativa.
Riflettiamo sul termine buono, cui ci si riferisce nel titolo del paragrafo: esso, evidentemente, ha
un duplice significato giacché non riguarda solo ciò che è commestibile, soddisfa il palato,
obbedisce a criteri gastronomici e dietetici ma anche, e soprattutto, ciò che esprime le nostre
opzioni di valore, corrisponde alla nostra idea di vita buona e, insieme, è conforme a determinati
requisiti etici di correttezza e di trasparenza della filiera produttiva. Ogni scelta alimentare parla di
noi, rivela chi siamo, manifesta i nostri orientamenti, le nostre preferenze ma, nello stesso tempo,
sul piano dell’etica pubblica, contribuisce a rafforzare e a consolidare certe politiche di produzione
cui, consapevolmente o meno, come consumatori diamo il nostro assenso. Sta a noi ormai, nel
quadro di un’etica della responsabilità planetaria, sostenere un utilizzo delle risorse naturali
compatibile con il mantenimento delle capacità rigenerative dell’ambiente, contro quelle culture che
aumentano lo sfruttamento e il degrado del pianeta.
A questa responsabilità ci richiama Jeremy Rifkin, denunciando i costi nascosti della cultura
della carne. Nel saggio Ecocidio. Ascesa e caduta della cultura della carne si descrive un mondo in
cui una parte considerevole dei cereali viene utilizzata come mangime per rendere la carne bovina
più grassa e quindi più gradita ai cittadini delle nazioni ricche – i quali, anche a causa di questo tipo
di alimentazione, rischiano infarto, tumore e diabete – ma, insieme, si mette in guardia dai temibili
effetti ecologici dell’ampia diffusione del consumo di carne: foreste abbattute, terre fertili
trasformate in deserti, minacce di modifiche climatiche devastanti .
Attualmente il nostro pianeta è popolato da ben oltre un miliardo di bovini. Questa immensa
mandria occupa, direttamente o indirettamente, il 24% della superficie terrestre e consuma una
quantità di cereali sufficiente a sfamare centinaia di milioni di persone. In quello che può
considerarsi un vero e proprio atto di accusa contro una “cultura della carne” che ha in larga misura
caratterizzato il mondo in cui viviamo, Rifkin, spaziando dall’antropologia alla storia,
dall’economia all’ecologia, disegna un lungo percorso che parte dagli albori della civiltà umana –
quando si riteneva che i bovini avessero un potere mistico e la loro carne fosse dotata di proprietà
magiche – per giungere ai giorni nostri in cui McDonald simboleggia un’altra forma di moderno
misticismo. Opporsi alla cultura della carne, per lo scienziato americano, è avere a cuore la propria
salute e il destino del nostro pianeta. È dunque in nome dello stesso diritto alla salute che occorre
esigere un’ampia informazione sulla storia del nostro cibo in ogni stadio della catena alimentare,
dalla produzione primaria al consumo, sugli ingredienti che esso contiene (obbligo di una chiara
etichettatura), sui costi economici ma anche etici ed ecologici che esso comporta.
Peter Singer ha recentemente elaborato una vera e propria “teoria critica” del nostro cibo. In The
Way We Eat. Why our food matter conduce una riflessione etica globale sulle ricadute per
l’ecosistema (e quindi, per gli esseri umani, i non umani e l’ambiente) delle nostre scelte in materia
di nutrizione . Il suo punto di partenza è empirico: attraverso l’analisi dei modelli alimentari di tre
diverse tipologie di famiglie statunitensi – una vegetariana radicale, una seconda formata da
“onnivori coscienziosi” e la terza che si ciba seguendo la dieta americana standard – valuta, in base
alla sua impostazione filosofica rigorosamente utilitaristica, le conseguenze di ciascuna scelta.
Vengono quindi considerati i costi dell’agrobusiness – l’impatto ambientale, la spoliazione delle
risorse naturali, le minacce per la salute dei consumatori, la negazione del benessere animale – e,
contestualmente, i benefici del commercio etico e dell’agricoltura biologica. Pur essendo un
vegetariano rigoroso – un’opzione etica che deriva del tutto conseguentemente dalla sua filosofia –,
Singer non si fa illusioni su una conversione generale al vegetarianesimo e pertanto indica le
condizioni e le possibilità concrete aperte a un’etica del rispetto e della responsabilità in campo
alimentare, un impegno, questo, che dovrebbe essere da tutti condiviso.
Su questa linea può collocarsi anche la proposta che Luigi Lombardi Vallauri elabora nel saggio
Animali. Istruzioni per il non uso, illustrando i fondamenti e le implicazioni di un’etica del
riconoscimento estesa a tutti gli esseri senzienti. Se riconosco nell’altro un soggetto, un tu, è
ineludibile la questione del suo diritto a vivere, e quindi il problema del vegetarianesimo, da
intendersi come dovere di pietà e di giustizia dell’uomo verso gli animali ma anche – aspetto questo
in genere meno considerato – dell’uomo verso l’uomo. Lombardi ricorda che nella tradizione
filosofica esiste una linea di pensiero che critica il carnivorismo anche per i suoi aspetti negativi
sull’animo umano, in particolare per la disumanizzazione che esso comporta. La crudeltà verso gli
animali – è la ben nota tesi di Tommaso e poi di Kant – è scuola di crudeltà verso l’uomo. Se
inseriamo il vegetarianesimo nel contesto globale della non violenza, esso esige, oltre a una grande
compassione per ogni essere senziente, un disancoramento di tutti gli atteggiamenti di prepotenza,
biologicamente ma soprattutto culturalmente connaturati all’uomo. Come realizzare tale svolta, si
chiede l’Autore, richiamandosi all’insegnamento di Capitini, ma anche di Buber e di Lévinas?
Come attuare l’uscita dalla dominante cultura antropocentrica della strumentalità della vita
animale? La risposta è contenuta in un vero e proprio decalogo che programmaticamente non
distingue tra atti “doverosi” e atti “consigliabili”, proprio per il suo rivolgersi non a militanti
animalisti ma a un gruppo molto più ampio di persone desiderose di ridurre almeno un po’ la
sofferenza e il danno inflitti agli animali. Si potrebbe parlare di “raccomandazioni”, che vanno
dall’invito a resistere alla persuasione mediatica, alla pubblicità commerciale che propaganda stili
di vita e di consumo nemici del benessere animale, alle pretese di autorevolezza etica delle religioni
che legittimano tutte le forme di violenza su uomini e animali fino all’esortazione a leggere testi, sia
di scienza che di poesia, che evidenzino la bellezza e il rango ontologico degli animali non umani.
Sempre nel contesto di una fondamentale opzione non violenta, possono collocarsi gli inviti a
informarsi sulla cucina vegetariana, a esercitare il consumo critico, selezionando i prodotti meno
lesivi del benessere animale, a boicottare i prodotti ottenuti con metodi brutali o crudeli. Scelte
queste che, nella loro ragionevolezza e accessibilità, si inquadrano in una visione della vita
eticamente ma anche esteticamente ispirata: il progetto non violento di “poeticizzazione
dell’esistenza” rinvia infatti a una diversa impostazione del nostro vivere che avrebbe conseguenze
benefiche, oltre che per noi, anche per gli altri animali.
La questione generale dell’alimentazione dà straordinaria evidenza al conflitto tra ricerca del
profitto e tutela del fondamentale diritto alla salute. Un’inchiesta seria, dettagliata e inesorabile sul
modo in cui gli animali diventano il nostro cibo è contenuta nel libro di Jonathan Safran Foer Se
niente importa. Perché mangiamo gli animali? Si tratta di un documento frutto di tre anni di
indagini meticolosissime sulla carne che mangiamo: non solo quali processi subisce, ma soprattutto
quali sono gli effetti della zootecnia moderna su animali, ambiente ed esseri umani. L’allevamento
intensivo, si ribadisce, è un elemento chiave nella creazione di nuove pandemie in cui si superano le
barriere invisibili che ci hanno sempre protetto. Ma, oltre a ciò, sappiamo ormai che questo tipo di
allevamento contribuisce al proliferare di agenti patogeni resistenti agli antimicrobici
semplicemente perché in esso se ne fa grandissimo uso: gli animali ricevono infatti farmaci a ogni
pasto proprio perché allevati in condizioni tali che le malattie sono inevitabili. «Il settore» scrive
Foer «ha individuato il problema fin dalla sua comparsa, ma invece di accettare la possibilità di
allevare animali meno produttivi, controbilancia l’immunità degli animali, ormai compromessa per
sempre, con nuovi farmaci. Di conseguenza, gli animali cresciuti negli allevamenti intensivi
ricevono antibiotici per motivi non terapeutici. In pratica, li assumono prima di ammalarsi». Le
implicazioni per la creazione di agenti patogeni resistenti ai farmaci sono evidenti e gli studi
puntualmente confermano che la resistenza antimicrobica subentra rapidamente, subito dopo
l’introduzione di nuovi farmaci negli allevamenti intensivi. Perché allora non è ancora entrato in
vigore il divieto totale di utilizzo di antibiotici non terapeutici? La ragione, secondo Foer, è
lapalissiana: il settore dell’allevamento intensivo, alleato con l’industria farmaceutica, ha più potere
dei professionisti della salute pubblica.
Ancora una volta si riafferma che il cibo è cultura, identità. La logica riveste sicuramente un
ruolo di primo piano nelle nostre decisioni relative all’alimentazione ma di rado è essa a indurci a
determinate scelte. Per Foer mangiare carne che proviene da un allevamento intensivo rende l’uomo
meno essere umano: se niente importa – afferma – non c’è niente da salvare... Se decidiamo di
parlare del nostro cibo in termini di consapevolezza e di responsabilità, se rinunciamo a invocare,
come comodo alibi, le abitudini, le tradizioni familiari, le “voglie”, potremo finalmente riflettere
razionalmente e assumere decisioni conseguenti. Perché mangiare ancora quella carne, anche se
sappiamo che ci fa male? Come continuare a desiderarla quando è evidente che quel sistema
impone a miliardi di animali un’esistenza di assoluto dolore? Né potremmo obiettare che il
consumo della carne industriale è più economico, dal momento che i veri costi dovrebbero
includere quelli della salute, diretti e indiretti, e quelli ambientali.
Una bioetica dell’alimentazione, oltre a riguardare l’individuo in primo luogo come cittadino,
coinvolge diversi soggetti (famiglie, scuola, istituzioni, gruppi di interesse, associazioni di
consumatori, organizzazioni non governative ecc.) per stimolarne la partecipazione attiva alle scelte
collettive e promuovere una discussione ad ampio raggio su temi quali la sicurezza e le sue
garanzie, la valutazione del rischio, il diritto all’informazione, il principio di precauzione, la libertà
di scelta, il ruolo dell’educazione, la qualità della vita, nel quadro di una sempre più ampia
democrazia deliberativa. L’emersione di una civiltà del consumatore nasce, oltreché da tali
preoccupazioni, dal comune rifiuto che la società diventi un laboratorio sperimentale permanente
delle tecnologie, senza che nessuno sia responsabile dei risultati. Si tratta di attivare una riflessione
critica sui problemi posti dalle biotecnologie agro-alimentari (sicurezza, impatto ambientale,
implicazioni etiche, risvolti giuridici) tale da generare dubbi salutari ma, insieme, da aprire nuovi
orizzonti e favorire scelte consapevoli. È appunto quanto si propone la bioetica la quale non deve
diventare un luogo per gli “addetti ai lavori” di una particolare scuola di pensiero o disciplina
accademica ma essere un campo di ricerche reso comprensibile e accessibile a tutti i cittadini,
giacché tutti, individualmente e collettivamente, siamo ormai chiamati a scegliere e a prendere
posizione.