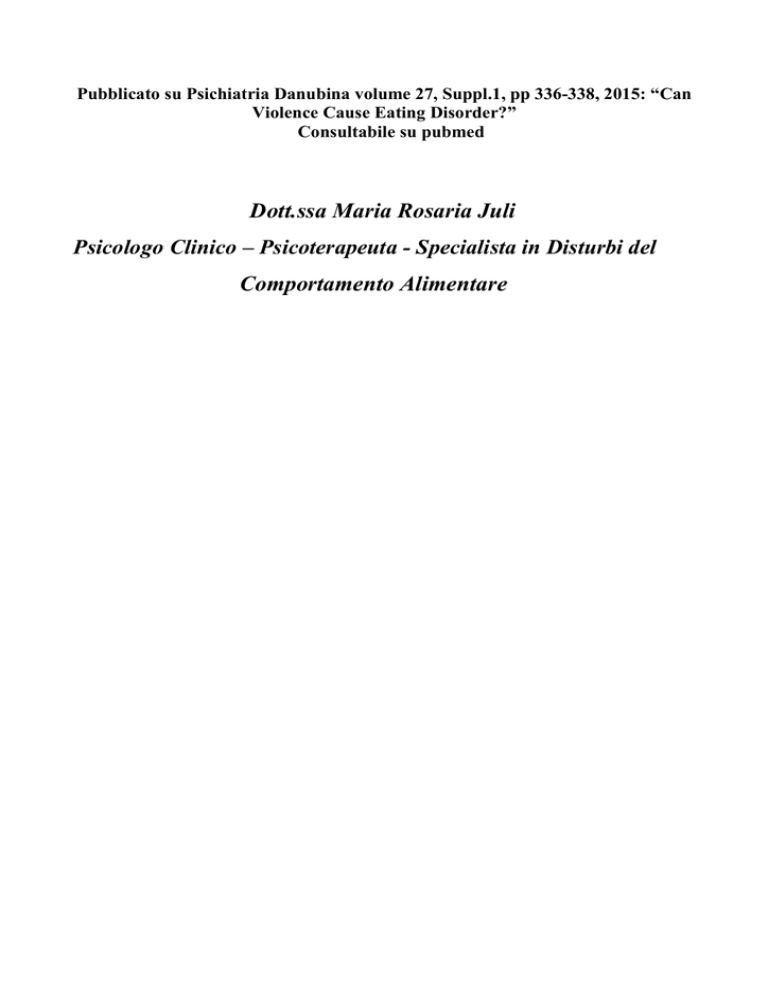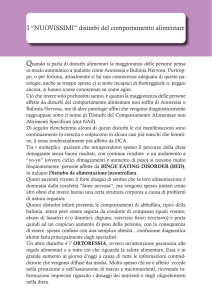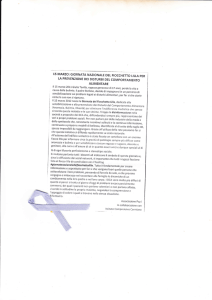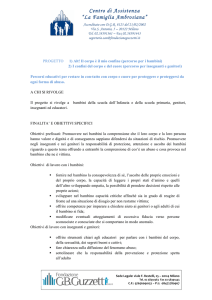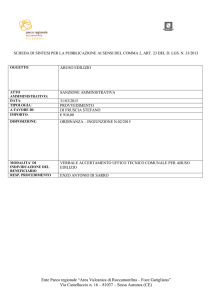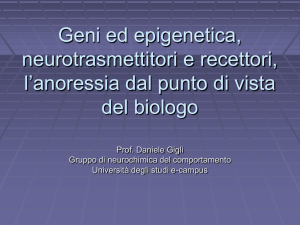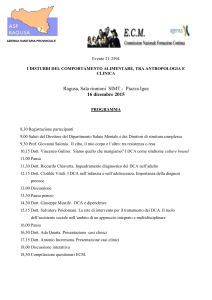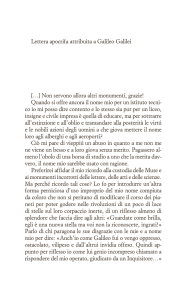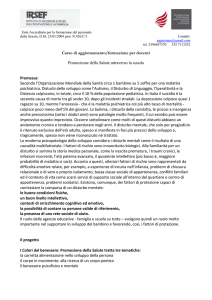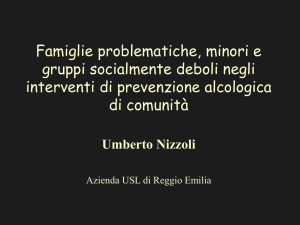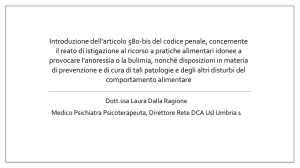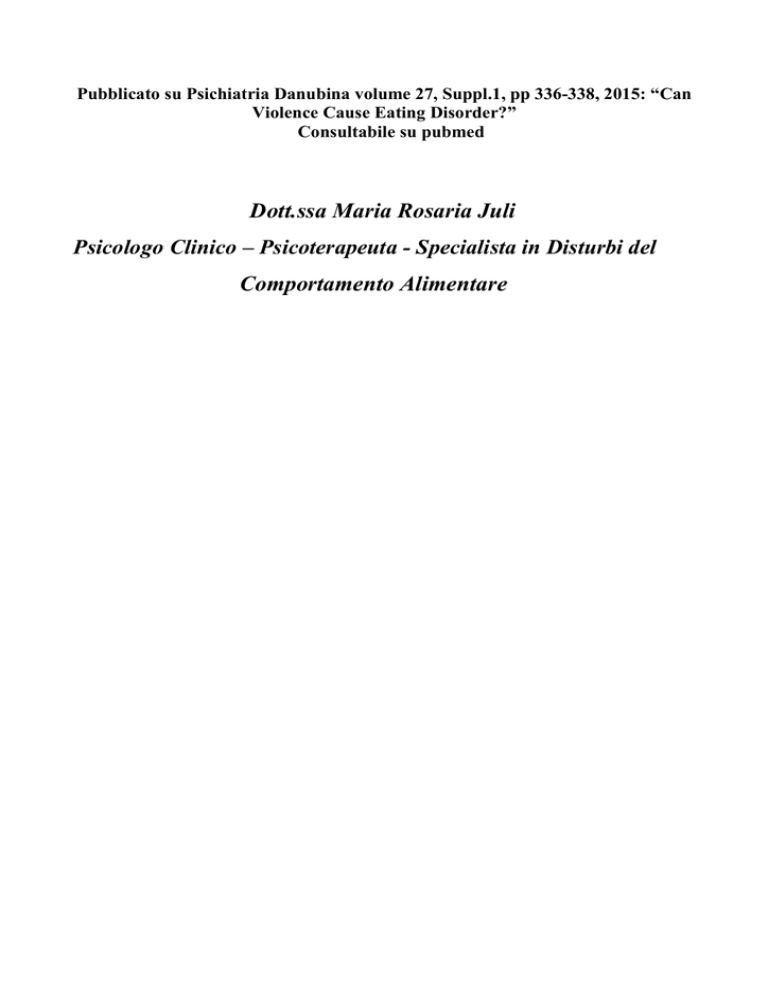
Pubblicato su Psichiatria Danubina volume 27, Suppl.1, pp 336-338, 2015: “Can
Violence Cause Eating Disorder?”
Consultabile su pubmed
Dott.ssa Maria Rosaria Juli
Psicologo Clinico – Psicoterapeuta - Specialista in Disturbi del
Comportamento Alimentare
I Disturbi del Comportamento Alimentare, possibile causa di violenza subita?
Abstract
Origine e decorso dei Disturbi dell’Alimentazione e della nutrizione hanno
eziopatogenesi multifattoriale e pertanto vanno considerati fattori psicologici,
evolutivi, biologici e socio–culturali (M.R., Juli 2012). Tra i fattori psicologici
focalizzeremo l’attenzione sulla violenza subita (in qualsiasi forma) ed in particolare
sulle conseguenze più o meno gravi che comporta nella donna. Recenti studi
dimostrano che le donne si ammalano più degli uomini, sia di depressione che di
disturbi alimentari, con un rapporto di 2:1; tale differenza ha inizio nell’adolescenza e
si protrae per tutto il corso della vita (Niolu C., Ambrosio A., Siracusano A. 2010).
La causa di questa differenza rimane tuttavia poco chiara. Molti studi concordano che
le ragazze in adolescenza hanno sentimenti negativi più frequenti e di durata
maggiore dopo eventi di vita stressanti e difficili (abuso, violenza). Ciò determina
una maggiore esposizione a sviluppare un sintomo che si consoliderà in disturbo
alimentare e/o depressione. Il cibo, da sempre, ha assunto un significato simbolico ed
una speciale carica emotiva di calore, rifugio, identificazione. Mangiare vuol dire
incorporare, assimilare, anche in senso ideale, le caratteristiche proprie degli alimenti
che diventano parte dell'individuo. Per questi significati attribuiti al cibo, spesso si
assiste, a seguito di abusi o violenza subita, ad un comportamento “anomalo” con
esso: si manipola, si rifiuta, si consuma voracemente, si elimina, fino a stare male,
malissimo. Le ricerche confermano che il 30% di pazienti a cui è stata effettuata una
diagnosi di Disturbo dell’Alimentazione, soprattutto con diagnosi di Bulimia,
presentano nella loro storia un episodio di abuso sessuale in età infantile, che
sottaciuto e rimosso può portare in età adolescenziale allo scatenarsi di una patologia
che trova nel corpo il suo teatro espressivo (S. Mencarelli, 2008).
A fare da “collaboratore” alla possibilità di sviluppare una patologia sono l’età della
paziente al momento dell’abuso ed il suo protrarsi nel tempo. I successivi effetti
psicologici possono includere sintomi dissociativi e disturbi dell’Alimentazione
E’ noto, a clinici e non, che la violenza subita (in qualsiasi forma) comporti delle
conseguenze più o meno gravi nella donna.
Alcuni studi dimostrano che le donne si ammalano più degli uomini, ad esempio di
depressione e di disturbi alimentari, con un rapporto di 2:1; tale differenza ha inizio
nell’adolescenza e si protrae per tutto il corso della vita (Niolu C., Ambrosio A.,
Siracusano A. 2010), con particolari picchi nella gravidanza, nel postpartum, nella
premenopausa o appunto a seguito di violenza subita.
La causa di questa differenza rimane tuttavia poco chiara.
Sono stati ipotizzati diversi fattori che potrebbero essere alla base di questa maggiore
prevalenza: ad esempio la diversità nella struttura cerebrale (Stevens JS.,Hamann
S.2012), differenze nelle strategie di coping, nella vulnerabilità personale (Yoo KL.
et al2012), nella frequenza di esposizione e nella qualità degli eventi stressanti; in
particolare, tra questi fattori, sono stati considerati eventi di vita stressanti di
separazione o di perdita traumatica (passati o recenti), tra cui la perdita di un amore,
abuso sessuale, difficoltà in una relazione affettiva, l’assistenza ai bambini ed ai
genitori anziani, difficoltà economiche, violenza subita (spesso domestica).
Ma allora perché le donne si ammalano più degli uomini? Alcuni studi dimostrano
come le ragazze in adolescenza hanno sentimenti negativi più frequenti e di durata
maggiore dopo eventi di vita stressanti e difficili (abuso, violenza), suggerendo che
hanno una maggiore esposizione a sviluppare un sintomo che si consoliderà in
disturbo alimentare e/o depressione. Uno studio (Calvete et al. 2005) effettuato su
856 adolescenti (491 femmine e 365 maschi) ha rilevato, che le ragazze tendono a
dubitare di se stesse, delle proprie capacità di risolvere i problemi e ritenere i loro
problemi maggiormente irrisolvibili più di quanto facciano i ragazzi. Tendono anche
ad aver bisogno di maggior grado di approvazione e di successo per sentirsi più
sicure rispetto ai ragazzi. Più del 70% delle ragazze che presentavano i primi sintomi
hanno sperimentato una difficoltà o un evento stressante nella vita (nella maggior
parte dei casi era violenza) rispetto al 14% dei ragazzi (Cyranowsky et al. 2000). E’
evidente che se i sintomi sorgono in adolescenza, una accurata diagnosi e presa in
carico favorisce una prognosi migliore nella vita adulta.
Quando il life event colpisce la donna durante il ciclo della vita, spesso assistiamo
all’emergere di un sintomo o di più sintomi che hanno maggiore espressione nel
corpo; il disturbo sul corpo, pertanto, si va ad instaurare là dove la sofferenza
psichica va a minare l'integrità fisica, e più è forte la difesa e la rimozione della
sofferenza psichica, più è grave e profondo l'attacco al corpo.
A livello individuale, fin dall'età neonatale, l'alimentazione ha un ruolo fondamentale
nella sopravvivenza e nell'instaurare validi rapporti col mondo esterno. La
soddisfazione dei bisogni alimentari è l'occasione per la madre, d'insegnare il piacere
al figlio. Attraverso la relazione alimentare vengono sperimentate le prime esperienze
di soddisfazione, di frustrazione, di piacere e di dispiacere. Si stabiliscono così le
preferenze alimentari che assumono significato di scelte morali, di adesione a valori e
modelli, diventano attributi di identità di individui e gruppi. L'affettività correlata alle
prime esperienze alimentari può influire sul comportamento alimentare, assai più
delle caratteristiche organolettiche dell'alimento. Il cibo, da sempre, ha assunto un
significato simbolico ed una speciale carica emotiva di calore, rifugio,
identificazione. Mangiare vuol dire incorporare, assimilare, anche in senso ideale, le
caratteristiche proprie degli alimenti che diventano parte dell'individuo. Proprio per
questi significati attribuiti al cibo, spesso o addirittura nella stragrande maggioranza
dei casi si assiste, a seguito di abusi o violenza subita ad un comportamento
“anomalo” con il cibo; dal un lato il vuoto che il life event ha lasciato, quindi la
voglia di riempirlo per dimenticarlo (BED), di rimetterlo (BN) per allontanare il
dolore dal proprio corpo, dall’altra il rifiuto estremo di qualsiasi cosa ti mantenga in
vita (Anoressia Nervosa) e della vita stessa. In una percentuale del 30% di pazienti a
cui è stata effettuata una diagnosi di DCA, soprattutto con diagnosi di Bulimia, si
riscontra nella storia della paziente un episodio di abuso sessuale in età infantile, che
sottaciuto e rimosso può portare in età adolescenziale allo scatenarsi di una patologia
che trova nel corpo il suo teatro espressivo (S. Mencarelli, 2008).
Già negli anni Novanta alcuni studi dimostravano il nesso tra DCA ed Abuso. La
maggior parte dei pazienti che a causa di un abuso affettivo o sessuale hanno
sviluppato un DCA, nella maggior parte dei casi una Bulimia Nervosa, perché
cercano con il corpo di espiare il peccato. Ovvero con il vomito cerca di allontanarsi
dalla sensazione di vuoto e con il lavarsi in maniera ossessiva, mima l’abuso. In
questo caso è difficile mantenere una affettività stabile nelle relazioni interpersonali.
In tal caso può accadere che la struttura di personalità di questi soggetti viri da
passivo - aggressivo all’istrionico all’antisociale.
Nelle anoressiche restrittive che hanno subito abuso la lettura è: “visto che sono stata
abusata e l’atto sessuale è un piacere mi tolgo il piacere e quindi non mangio”. E’
consigliabile nella raccolta anamnestica differenziare se la paziente ha subito
molestie o abuso sessuale; se ciò avviene in età pre – puberale o puberale l’episodio
di abuso tende a cristallizzarsi nella mente, il ricordo è più importante rispetto
all’accaduto reale. Bisogna tenere presente inoltre, che visto l’atteggiamento
manipolatorio del disturbo, potrebbe focalizzarsi su un “evento abusivo” per trovare
necessariamente una causa (sono dinamiche inconsapevoli).
Il DCA infatti non evolve solo a seguito di violenza subita, l’esordio ha cause
multifattoriali, spesso esso si inserisce in soggetti con bassa autostima nucleare,
fragilità emotiva, difficoltà di problem solving. Dal punto di vista clinico bisogna fare
attenzione all’insorgenza del sintomo senza dimenticare le caratteristiche di
personalità, solo così riusciamo a capire su che cosa dobbiamo intervenire. E’ stato
dimostrano come alcune manifestazioni alimentari patologiche siano associate a
caratteristiche di personalità, sintomatologia in Asse I e qualità della vita
riconducibili a tipologie specifiche di funzionamento globale (M.R., Juli 2012).
Spesso il DCA diventa una soluzione alla violenza subita ma poco dopo si trasforma
in disfunzione, in terapia è importante parlare della violenza ed aiutare la paziente
nell’elaborazione di ciò che ha subito. Solo in seguito è preferibile intervenire sulla
patologia alimentare per arginare l’emotività espressa al fine di discernere il DCA
dall’Abuso.
I soggetti affetti da DCA ed Abuso Sessuale hanno maggiore possibilità di
sviluppare disturbi psichiatrici di natura ossessiva o fobica rispetto ai soggetti non
abusati; i soggetti invece abusati con “Addiction” (percorse fisiche ripetute) risultano
invece più depresse (a causa della violazione dello spazio peri personale
dell’individualità). Questo spiegherebbe la presenza dei rituali cioè il soggetto può
lavarsi fino a cinquanta volte al giorno, il rituale funge da difesa, ci si difende dal
vissuto corporeo che si fa avanti perché nei DCA il corpo è il palcoscenico della
mente ecco perché è definito come: “Atto comunicativo mancato”: esprimo con il
corpo ciò che non riesco a verbalizzare; se non riesco a verbalizzare un bisogno lo
mimo in maniera arcaica con il cibo.
Il comportamento autodistruttivo, ad esempio l’autolesionismo, è il predittore più
importante sia per l’Abuso Sessuale o Fisico sia per i DCA, in particolare è stata
dimostrata una forte correlazione tra abuso di sostanze Bulimia Nervosa e grave
storia di Abuso Sessuale. L’autolesionismo è parte integrante del DCA perché ha a
che fare con il piacere, oltre ad avere un aspetto punitivo; esso ripristina il concetto
fondamentale dell’l’integrità psichica: provo piacere quando mi faccio del male.
Nelle bambine sotto i 12 anni sessualmente abusate, spesso si verifica la cronicità dei
DCA connessi ad atti impulsivi (condotte antisociali, iperattività) e successivamente
con abuso di sostanze.
I fattori di mediazione tra DCA e Abuso è l’età della paziente al momento dell’abuso
e la durata dell’abuso con i suoi successivi effetti psicologici inclusi i sintomi
dissociativi e il disturbo del comportamento alimentare.
Una conseguenza a lungo termine di un abuso preadolescenziale è un disturbo
dell’attaccamento (attaccamento atipico accaduto in una fase adolescenziale per
lungo tempo) che con l’abuso appunto è stato intaccato; inoltre potrebbe verificarsi,
nelle adolescenti una scelta di genere difensiva e non intenzionale, l’omosessualità,
per cui la paziente decide che la figura rassicurante è la donna perciò decide di
concedersi il piacere nell’attaccamento e nella relazionalità con la figura femminile
elidendo completamente l’uomo. Dal punto di vista clinico è consigliabile modificare
il comportamento sul piano cognitivo.
Quando l’abuso è stato effettuato da un parente maschio il sintomo che si farà strada
sarà il BED (Binge Eating Disorder) o Vomiting: perché queste due modalità
rappresentano un anestetico per dimenticare, associate a senso di colpa, bassa
autostima, credenze negative: “mi merito il DCA”, “ho fatto qualcosa di sbagliato”.
Nei Disturbi del Comportamento Alimentare, il corpo si trasforma in una prigione,
vedendo ridursi sempre più gli spazi e le modalità di espressione e di relazione con il
sé e con il mondo. Accade che il corpo, a seguito di ciò che ha subito, cessa di essere
un veicolo di emozioni, di creatività, di comunicazione, di vita e si incastri in un
sentiero, più spesso un cunicolo, che porta in un’unica, immodificabile direzione: è la
strada dell’ossessione che percorsa all’interno di un mezzo (il corpo) monadico non
lascia intravedere e trasparire (P., Bianchini 2008).
Per tornare a percepire altro e ricostruire la relazione con il mondo è necessario
“affacciarsi”, a volte fermarsi, provare a mettere un piede fuori da sé ed esplorare
altre modalità, altre vie, facendo un passo- anche solo uno- in un’altra direzione. I
Disturbi del Comportamento Alimentare costituiscono oggi una delle emergenze
sanitarie più preoccupanti dell’emisfero occidentale. La diffusione della patologia ha
una rapidità ed una rilevanza sconcertanti, non si ha alcun altro esempio di
malattia psichiatrica con una simile propagazione e con le caratteristiche di una
vera epidemia sociale (Gordon, 1990). Si tratta del primo fenomeno di malattia
globalizzata, legata a ciò che comunemente viene definito come modernità, che
si espande a macchia d’olio in concomitanza al diffondersi di modelli, stili di
vita, cultura del corpo. E’ stato affermato più volte che ogni epoca storica tende
a privilegiare una determinata malattia (la tisi nell’Ottocento, la sifilide nel
Settecento) che tende a diventare l’immagine metaforica di una determinata
società, di un determinato mondo. Non c’è dubbio che il disturbo del
comportamento alimentare si presta a rappresentare perfettamente questa nostra
epoca, per i suoi legami con l’identità corporea, con il cibo, amico e nemico,
abbondanza e mancanza nello stesso tempo, con l’ossessiva, con la sofisticata
capacità di evolvere e mimetizzarsi che ricorda quella dei virus. (Dalla Ragione,
2008).
I DCA sono aumentati ma si sono anche modificati dando vita a forme nuove e
complesse, il manuale Diagnostico e statistico delle patologie mentali (DSM V)
suddivide in Bulimia Nervosa, Anoressia Nervosa, Binge Eating e Disturbi non
Altrimenti
Specificati;
oggi
assistiamo
all’insorgere
della
Bulimia
Multicompulsiva, Disturbo da abbuffata compulsiva, l’Ortoressia e le condotte
ad essi associati come autolesionismo, tossicomanie, disturbi della condotta,
disturbi della personalità.
Non bisogna, a tal proposito, dimenticare la presenza di fattori facilitanti, ad
esempio le pressioni sociali, che agiscono attraverso messaggi contraddittori sul
ruolo della donna comunemente filtrati dai mass-media e dagli imperativi
sociali subliminali: la si vorrebbe votata ai valori della famiglia e della casa
(come la donna di ieri), ma le vengono richieste, oltre alle doti di tipo più
tradizionale,
anche
i
caratteri
dell’autonomia
e
dell’indipendenza
-
competitività, tipicamente maschili. Questo primo livello contribuisce a creare
un autentico disagio psicologico in soggetti vulnerabili, che viene amplificato
dalla preferenza, questa volta più evidente, per l’immagine della donna magra e
scattante, super attiva (wonder woman). Perché la magrezza sia divenuta un
ideale culturale dominante nel ventesimo secolo è oggetto di discussione; per il
sesso femminile, l’anoressica incarna in modo estremo, una battaglia
psicologica tipica della situazione attuale delle donne, una situazione in cui
l’azione congiunta di fattori sociali, economici e psicologici diversi ha prodotto
una generazione di donne che si considerano piene di difetti, si vergognano
delle proprie esigenze e non si sentono autorizzate ad esistere, se non a
condizione di trasformare se stesse in persone nuove e degne (cioè senza
esigenze, senza bisogni, senza corpo).
L’anoressia rappresenta uno degli estremi di un continuum sul quale oggi si
trovano tutte le donne, in quanto tutte più o meno vulnerabili alle esigenze della
costruzione culturale della femminilità, per cui la cultura ha un ruolo importante
nel produrli. Ne sono conferma di ciò due aspetti singolari dei disturbi del
comportamento alimentare: in primo luogo essi sono più frequenti nella
popolazione femminile (circa il 90% delle persone che ne soffrono è composto
da ragazze o donne); in secondo luogo, i DCA rappresentano un fenomeno
culturalmente e storicamente situato nelle società industriali, sindromi
cosiddette “ culture bound”. E' per ciò che viene enfatizzato il valore di una
prevenzione, di una attenta individuazione delle situazioni a rischio e di una
precocità della diagnosi all'esordio del disturbo per intraprendere un intervento
corretto multidisciplinare integrato fin dall'inizio (L. Juli,2010). L'integrazione
di più specialisti nella presa in carico e gestione di queste pazienti rimane la
forma di intervento d'elezione. L'intervento quindi non deve essere incentrato
sull'alimentazione, ma deve spostare l'interesse sulla problematica psicologica e
relazionale di cui è semplice espressione.
Bibliografia
Bianchini P., Dalla Ragione L. Il Vaso di Pandora, Cesvol, 2008.
Calvete E., Cardenoso O. Gender differences in cognitive vulnerability to
depression and behavior problems in adolescents. Abnorm Child Psychol,
2005.
Gordon AR., Anoressia e bulimia, anatomia di una epidemia sociale, Cortina,
1990.
Juli L., I Nuovi Disturbi del Comportamento Alimentare, 2010.
Juli M.R. Analisi multi strumentale dei disturbi alimentari: Anoressia e
Bulimia a confront, Psichiatria Danubia, 2011.
Niolu C., Ambrosio A., Siracusano A., La Depressione nel Ciclo vitale
Femminile,
NOO§, 2010.
Stevens JS, Hamann S. Sex differences in brain activation to emoziona
stimuli:a meta- analysis of neuroimaging studies. Neuropsychologia, 2012.
Yoon KL., Maltby J., Joormann J. A pathway from neuroticism to depression:
examining the roleof emotionregulation.Anxiety Stress Coping, 2012.