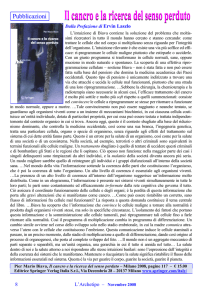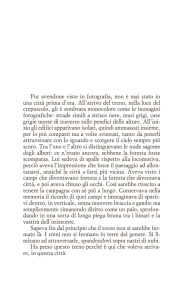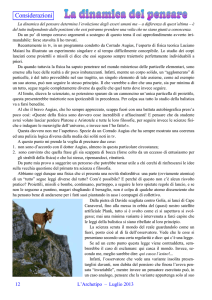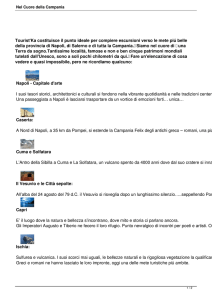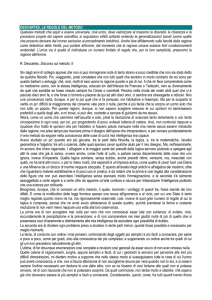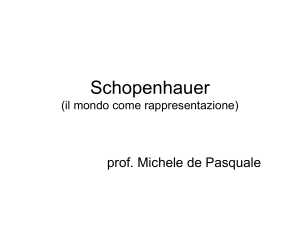Platone, VII Lettera (da Opere complete, Volume VIII, Laterza 1986, traduzione di A.
Maddalena)
PLATONE AI FAMILIARI E AGLI AMICI DI DIONE CON L’AUGURIO DI STARE BENE
Mi avete scritto ch’io devo considerare identico a quello di Dione il vostro pensiero, e mi pregaste di essere
con [324a] voi, e di darvi tutto il mio aiuto d’opera e di parola. Ed io, se il vostro pensiero e le vostre intenzioni
sono davvero gli stessi di Dione, prometto d’essere con voi: se no, ci penserò parecchio. E dunque dirò che
cosa Dione pensava e che intenzioni aveva, perché non per congettura, ma per certa conoscenza io le
conosco. Quando io, a circa quarant’anni, giunsi a Siracusa per la prima volta, Dione aveva l’età che Ipparino
ha oggi: allora si formò in lui quella [b] concezione, che da allora egli non modificò mai più: voleva che i
Siracusani fossero liberi e avessero le leggi migliori. Nulla di strano ci sarebbe, quindi, se qualche iddio
facesse nascere anche in costui lo stesso pensiero politico. Come questo si formò in Dione, vale la pena che
ascoltino giovani e non giovani: pertanto cercherò di spiegarvi come s’originò, comunicando dal principio; le
circostanze me ne dànno l’occasione.
Quando ero giovane, io ebbi inesperienza simile a quella di molti altri: pensavo di dedicarmi alla vita politica,
[c] non appena fossi divenuto padrone di me stesso. Or mi avvenne che questo capitasse allora alla città: il
governo, attaccato da molti, passò in altre mani, e cinquantun cittadini divennero i reggitori dello stato. Undici
furono posti a capo del centro urbano, dieci a capo del Pireo, tutti con l’incarico di sovraintendere al mercato e
di occuparsi dell’amministrazione, e, sopra costoro, trenta ma-[d] gistrati con pieni poteri. Tra costoro erano
alcuni miei familiari e conoscenti, che sùbito mi invitarono a prender parte alla vita pubblica, come ad attività
degna di me. Io credevo veramente (e non c’è niente di strano, giovane come ero) che avrebbero purificata la
città dall’ingiustizia traendola a un viver giusto, e perciò stavo ad osservare attentamente che cosa avrebbero
fatto. M’accorsi così che in poco [e] tempo fecero apparire oro il governo precedente: tra l’altro, un giorno
mandarono, insieme con alcuni altri, Socrate, un mio amico più vecchio di me, un uomo ch’io non esito a dire il
più giusto del suo tempo, ad arrestare un cittadino [325a] per farlo morire, cercando in questo modo di farlo
loro complice, volesse o no; ma egli non obbedì, preferendo correre qualunque rischio che farsi complice di
empi misfatti. Io allora, vedendo tutto questo, e ancor altri simili gravi misfatti, fui preso da sdegno e mi ritrassi
dai mali di quel tempo.
Poco dopo cadde il governo dei Trenta e fu abbattuto quel regime. E di nuovo mi prese, sia pure meno
intenso, il desiderio di dedicarmi alla vita politica. [b] Anche allora, in quello sconvolgimento, accaddero molte
cose da affliggersene, com’è naturale, ma non c’è da meravigliarsi che in una rivoluzione le vendette fossero
maggiori. Tuttavia bisogna riconoscere che gli uomini allora ritornati furono pieni di moderazione. Se non che
accadde poi che alcuni potenti intentarono un processo a quel mio amico, a Socrate, accusandolo di un delitto
nefandissimo, il più [c] alieno dall’animo suo: lo accusarono di empietà, e fu condannato, e lo uccisero, lui che
non aveva voluto partecipare all’empio arresto di un amico degli esuli di allora, quando essi pativano fuori
della patria. Vedendo questo, e osservando gli uomini che allora si dedicavano alla vita politica, e le leggi e i
costumi, quanto più li esaminavo ed avanzavo nell’età, tanto più mi sembrava che fosse diffi-[d] cile
partecipare all’amministrazione dello stato, restando onesto. Non era possibile far nulla senza amici e
compagni fidati, e d’altra parte era difficile trovarne tra i cittadini di quel tempo, perché i costumi e gli usi dei
nostri padri erano scomparsi dalla città, e impossibile era anche trovarne di nuovi con facilità. Le leggi e i
costumi si corrompevano e si dissolvevano straordinariamente, sicché [e] io, che una volta desideravo
moltissimo di partecipare alla vita pubblica, osservando queste cose e vedendo che tutto era completamente
sconvolto, finii per sbigottirmene.
Continuavo, sì, ad osservare se ci potesse essere un [326a] miglioramento, e soprattutto se potesse
migliorare il governo dello stato, ma, per agire, aspettavo sempre il momento opportuno, finché alla fine
1
m’accorsi che tutte le città erano mal governate, perché le loro leggi non potevano essere sanate senza una
meravigliosa preparazione congiunta con una buona fortuna, e fui costretto a dire che solo la retta filosofia
rende possibile di vedere la giustizia negli affari pubblici e in quelli privati, e a lodare solo essa. Vidi [b] dunque
che mai sarebbero cessate le sciagure delle generazioni umane, se prima al potere politico non fossero
pervenuti uomini veramente e schiettamente filosofi, o i capi politici delle città non fossero divenuti, per
qualche sorte divina, veri filosofi. Così pensavo, quando per la prima volta venni in Italia ed in Sicilia. Giunto,
non mi piacque affatto quella vita cosiddetta beata che vi si conduceva, piena di banchetti italioti e siracusani,
quel riempirsi due volte al giorno, e non dormire mai la notte senza compagnia, e tutto il resto [c] che
s’accompagna con tal genere di vita. Perché non v’è uomo al mondo che, abituato a vivere così fin
dall’infanzia, possa acquistare sapienza (nessuno può avere una natura così meravigliosa) e neanche
avvicinarsi a vivere in temperanza: lo stesso si può dire per le altre virtù. Né v’è città che possa vivere
tranquilla, quali che siano le sue leggi, quando i cittadini pensano di dover spendere sempre [d] a profusione,
e di non dover far altro che banchettare e bere e affaticarsi nelle cure d’amore.
Queste città non possono che trapassare continuamente tra tirannidi e oligarchie e democrazie, e i loro capi
neppure il nome vorranno sentire di una costituzione giusta e senza privilegi. Così, quando passai a Siracusa,
queste considerazioni s’aggiungevano ai pensieri che avevo già. Fu forse per un [e] caso che vi venni, ma
forse fu un dio che volle dar inizio a quello che ora è successo a Dione e a Siracusa: e c’è pericolo che altri
guai capitino ancora se voi non mi darete ascolto, ora che per la seconda volta io espongo il mio consiglio. E
dunque, perché mai dico che la mia venuta [327a] in Sicilia segnò il principio di tutto quello che avvenne? Io
ebbi delle conversazioni con Dione, allora giovane, e gli mostravo coi miei discorsi quello che, a mio giudizio,
è l’ottimo per gli uomini, e lo esortavo a vivere secondo questo ottimo; ignoravo che così, senza
accorgermene, preparavo in qualche modo l’abbattimento della tirannide. Infatti Dione, giovane di viva
intelligenza anche per altre cose, ma soprattutto atto a comprendere i discorsi ch’io allora gli facevo, mi si fece
discepolo e mi seguì con una passione [b] che io non trovai mai in altro giovane, e volle vivere tutto il resto
della vita in modo diverso dalla gran parte degli Italioti e dei Siciliani, preferendo la virtù al piacere e a ogni
altro genere di mollezza. Perciò fino alla morte di Dionisio fu sempre più odiato da quanti vivevano negli usi
della tirannide. In seguito pensò che questo suo convinci-[c] mento originato da sani ragionamenti non doveva
restar chiuso in lui, e quindi, vedendo ch’esso nasceva in altri, non molti per verità, ma tuttavia in alcuni, tra i
quali, se gli dèi lo aiutavano, credette che sarebbe stato facilmente anche Dionisio, si disse che, se questo
fosse avvenuto, straordinariamente felice sarebbe divenuta la sua vita e [d] quella degli altri Siracusani.
E allora, ricordandosi con quanta prontezza le conversazioni avute con me gli avevano fatto nascere il
desiderio della vita più nobile e più bella, e sperando assai di poter introdurre in tutto il paese, senza stragi,
senza uccisioni e senza tutti quei malanni che sono ora accaduti, una vita vera e felice, solo che avesse
potuto compiere la stessa cosa con Dionisio come aveva cominciato, pensò ch’io dovevo assolutamente
venire a Siracusa al più presto per aiutarlo nella sua opera. Con questo giusto intendimento, egli persuase
Dionisio ad invitarmi, e mi mandò dei messi lui stesso, pregandomi di partire al più [e] presto e ad ogni costo,
prima che Dionisio trovasse altri amici che lo distogliessero dalla vita migliore per una vita diversa. Queste
sono le parole che egli mi scrisse e ch’io ripeterò, a costo di dilungarmi: "Che occasione stiamo ad aspettare scriveva, -che ci sia più favorevole di questa, che ci è offerta da una sorte divina?". E mi parlava dell’impero
[328a] dell’Italia e della Sicilia, della potenza che egli vi aveva, e insisteva sulla giovinezza di Dionisio, sul suo
vivo desiderio d’educazione, sul suo amore per la filosofia, e mi diceva quanto era facile istillare nei suoi nipoti
e nei suoi familiari la concezione di vita di cui io non cessavo di parlare, e come, per mezzo di costoro, si
poteva agevolmente indurre anche Dionisio a seguire il medesimo modo di vita, sicché mai come allora - egli
diceva - v’era la possibilità che si attuasse completamente la nostra speranza di veder congiunti nelle stesse
persone filosofi e reggitori [b] di grandi città. Con questi e con molti altri simili discorsi egli m’invitava.
2
Tuttavia mi tratteneva un certo timore, per la opinione che avevo dei giovani, quale mai sarebbe stato il
risultato del nostro sforzo: perché i giovani sono volubili e spesso contraddittori nei loro desideri. D’altra parte
sapevo che il carattere di Dione era grave per natura, e maturo per età. Perciò esitavo e tra me consideravo
se dovevo dargli ascolto e andare, oppure no: alla fine mi decisi, perché mi pareva che, se si doveva [c]
tentare di tradurre in atto le mie dottrine sulle leggi e sullo stato, quello appunto era il momento. Bastava
persuadere un uomo solo, e avrei compiuto tutto il bene possibile. Questo era il mio pensiero e questa la mia
speranza quando partii. Non v’andai per le ragioni che altri credettero, ma per un senso di vergogna che
provavo, soprattutto al pensiero d’essere soltanto un facitor di parole, incapace di intraprendere di mia volontà
opera alcuna; e poi avrei rischiato di tradire Dione, l’ospite ed amico mio, [d] che si trovava realmente in
grande pericolo. Pensavo: e se gli capitasse qualche disgrazia o fosse bandito da Dionisio e dagli altri suoi
nemici, e mi si presentasse e mi chiedesse: "O Platone, io sono venuto qui, esiliato, non perché avessi
bisogno di opliti o mancassi di cavalieri che mi difendessero dai miei nemici: di quei discorsi persuasivi avevo
bisogno, coi quali io so che tu puoi così bene indurre i giovani all’amore del buono e del giusto, e stabilire
ognora [e] tra di loro salde amicizie. Ma questo aiuto per parte tua mi mancò, e per questo ho lasciato
Siracusa e ora sono qui. Non è però la mia sorte quella che ti fa maggior vergogna: ma la filosofia, insieme
con me, non l’hai forse tu tradita per parte tua, la filosofia che tu pur sempre esalti e che dici disonorata dagli
altri uomini? Certo, s’io fossi [329a] stato a Megara, avresti ascoltato la mia preghiera e saresti accorso in mio
aiuto, e se no, consìderati il peggiore degli uomini: e dunque credi tu che ti possa giustificare dalla fama di viltà
il pretesto del lungo viaggio e della grande fatica della traversata? Neanche per sogno"; se dunque mi avesse
fatto un tal discorso, che onesta risposta avrei potuto dargli? Nessuna. V’andai dunque per le più giuste e per
[b] le migliori ragioni del mondo, e per queste ragioni abbandonai le mie belle occupazioni e andai a vivere
sotto una tirannide, che pur sembrava sconvenire a me ed alle mie dottrine.
Così, andandovi, feci il mio dovere verso Zeus Ospitale, e non venni meno al dovere del filosofo, mentre sarei
stato biasimato a ragione, se, per mollezza o per viltà, mi fossi macchiato di turpe vergogna. Dunque, per non
dilungarmi troppo, andai, e trovai grandi discordie [c] alla corte di Dionisio, e Dione calunniato presso il tiranno.
Io feci quanto potei per difenderlo, ma la mia autorità era scarsa: dopo tre mesi all’incirca, Dionisio accusò
Dione di voler rovesciare la tirannide, lo imbarcò su di una piccola nave e lo cacciò ignominiosamente. Tutti
noi altri amici di Dione, tememmo allora che egli ci accusasse, o l’uno o l’altro, di complicità con lui e ci
punisse: si diffuse anzi per Siracusa la voce ch’io ero stato ucciso da Dionisio, come complice di tutta la trama
ch’era stata [d] ordita. Egli invece, accorgendosi di questa nostra paura e temendo ch’essa ci suggerisse
qualche azione disperata, ci trattava tutti benevolmente; ed anzi, quanto a me, mi faceva coraggio e mi diceva
di star di buon animo e mi pregava in ogni modo di rimanere: perché non la mia partenza gli avrebbe fatto
onore, ma la mia dimora. Per questo appunto egli mostrava di pregarmi vivamente. Ma le preghiere dei tiranni,
si sa, sono la maschera d’una costrizione:[e] egli prese le sue misure perché non potessi partire: mi condusse
nell’acropoli e lì stabili la mia abitazione, lì, donde nessun capitano di nave mi avrebbe condotto via se avesse
avuto il divieto di Dionisio, anzi in nessun modo, a meno che non ne avesse ricevuto l’ordine espresso; né
v’era mercante, né comandante di frontiera che mi avrebbe lasciato passare da solo, ma mi avrebbero subito
arrestato e condotto da Dionisio, tanto più che s’era diffusa una voce [330a] contraria a quella di prima, la
voce che Dionisio mi amava moltissimo. E dunque, come andavano le cose? Bisogna dire la verità. Mi amava
davvero sempre di più col passare del tempo, man mano che imparava a conoscere il mio carattere e i miei
costumi; voleva anzi ch’io apprezzassi più lui che Dione, e gli fossi più amico. E faceva ogni sforzo per questo.
Ma esitava a scegliere la via giusta, quella per cui avrebbe potuto, se l’avesse seguita, raggiun-[b] gere meglio
il suo fine; perché non mi frequentava per ascoltare i miei discorsi di filosofia, ed imparare: irretito dalle parole
dei calunniatori, temeva di poter essere da quei discorsi impacciato nelle sue azioni, e che fosse tutta una
macchinazione di Dione. Io sopportavo tutto, fermo nell’intenzione con la quale ero venuto, di vedere se mai
sorgesse in lui l’amore per la vita del filosofo: vinse invece la sua riluttanza.
3
[c] Così andarono le cose quando io venni e mi fermai la prima volta in Sicilia. In seguito io partii, e poi ritornai
un’altra volta, insistentemente chiamato da Dionisio. Le ragioni per cui ritornai, e come fu giusta e ragionevole
la mia condotta, le dirò in seguito per rispondere a chi mi domanda perché mai io venni a Siracusa una
seconda volta: ma prima voglio darvi i consigli che la situazione presente richiede, per non fare della parte
secondaria la parte principale della mia lettera. I miei consigli son questi. Quando un uomo è ammalato, e
segue un regime di vita non sa-[d] lutare, bisogna, per prima cosa, consigliargli di cambiar vita: poi, se egli è
disposto ad obbedire, gli si daranno altri consigli: se non è disposto, uno che sia veramente un uomo e un
medico, cesserà, a mio giudizio, di consigliarlo, mentre chi facesse il contrario, io lo considererei un vile e un
ignorante. Lo stesso vale per una città, sia essa governata da una o da più persone. Se essa ha un governo
che segue regolarmente la retta via, e domanda un [e] consiglio che possa portarle utilità, è assennato colui
che a uomini così governati non nega il suo consiglio; ma se sono assolutamente lontani dal buon governo e
non vogliono in alcun modo seguirne la giusta traccia, se impongono ai loro consiglieri di lasciar stare e non
toccare la co-[331a] stituzione, pena la morte, ma comandano di servire ai loro desideri e ai loro voleri
mostrando il modo di soddisfarli sempre il più rapidamente e il più facilmente ch’è possibile, colui che accetta
di fare il consigliere in tali condizioni, io lo considero un vile, colui che non accetta un uomo. […]
Ho detto i miei consigli, oggetto della lettera, e ho detto del mio primo viaggio alla corte di Dionisio. Quanto al
secondo e alla seconda traversata, per quali giuste e buone ragioni furono fatti, può ora sentire chi lo
desidera. Ché, [338a] come ho passato il tempo della mia prima dimora in Sicilia, l’ho detto prima di dare il mio
consiglio agli amici e ai parenti di Dione. Or bene, in seguito riuscii ad ottenere da Dionisio il permesso di
partire; avevamo tuttavia convenuto che, quando fosse finita la guerra (ché allora v’era guerra in Sicilia) e
fosse ritornata la pace, Dionisio, rafforzato il suo potere, mi avrebbe richiamato insieme con Dione: egli diceva
che Dione non doveva considerare la [b] sua partenza come un esilio, ma come un cambiamento di residenza.
A queste condizioni io promisi di ritornare. Sennonché, venuta la pace, egli richiamò me solo, dicendo che
Dione aspettasse ancora un anno e io andassi ad ogni costo. Dione mi pregava ed insisteva ch’io andassi,
perché s’era diffusa dalla Sicilia la voce che Dionisio era di nuovo preso da uno straordinario amore per la
filosofia: ed era appunto per questo che Dione mi supplicava insistentemente di non opporre un rifiuto alla
chiamata. Quanto a me, io [c] non ignoravo che spesso i giovani si trovano in questa disposizione di spirito
riguardo alla filosofia; e tuttavia mi sembrava più sicuro di non occuparmi più, per allora, di Dione e di Dionisio,
onde risposi ch’io ero vecchio e che nessuno degli accordi era stato rispettato. Così m’inimicai entrambi.
Sembra che in seguito sia andato da Dionisio Archita, il quale, insieme con i capi di Taranto, era di-[d] venuto
prima ch’io partissi, per opera mia, suo ospite ed amico; poi v’erano a Siracusa alcuni che avevano sentito
parlare Dione, altri che avevano sentito costoro ed erano imbevuti di formule filosofiche. Costoro, io credo,
vollero parlare di tali cose con Dionisio, giudicando che egli sapesse tutto quello ch’io pensavo. Ora, Dionisio
ha una facilità naturale d’apprendere, ed è straordinariamente desideroso d’onore. Quello che gli si diceva gli
era dunque, forse, gradito; e forse si vergognava di mostrare che non [e] aveva imparato niente durante la mia
dimora alla sua corte; perciò da una parte gli nasceva il desiderio di sentire più chiaramente il mio pensiero, e
dall’altra lo spingeva il punto d’onore (le ragioni per cui non m’aveva prima ascoltato, le ho spiegate or ora). E
dunque, quando io, dopo essere tornato in patria, opposi un rifiuto al suo secondo invito, come ho detto dianzi,
Dionisio mi pare si sia fatto un punto d’onore di questo: voleva che nessuno pensasse ch’io lo avessi in uggia
e non volessi ritornare più da lui, [339a] perché disprezzavo la sua natura e il suo carattere e avevo
sperimentato il suo modo di vivere. Devo ora dire la verità, anche se qualcuno, udendo il mio racconto,
disprezzerà la mia filosofia e giudicherà intelligente il tiranno. Dionisio mi invitò per la terza volta, e mi mandò
una trireme per facilitarmi il viaggio, e in essa Archedemo, un [b] amico di Archita ch’egli pensava ch’io
apprezzassi sopra tutti gli altri Siciliani, ed altri Siciliani ancora, miei conoscenti: e tutti ci ripeterono la stessa
storia, che Dionisio aveva fatto straordinari progressi nella filosofia. Mi mandò anche una lunghissima lettera,
sapendo qual era la mia amicizia per Dione, e che Dione stesso desiderava ch’io partissi e andassi a
Siracusa: tenendo conto di tutto questo, mi scrisse appunto una lettera che, cominciava così: "Dionisio [c] a
Platone"; poi vi erano le espressioni abituali, e poi sùbito: "Se mi darai ascolto e verrai ora in Sicilia, per prima
4
cosa Dione sarà trattato come tu desideri, perché so che non mi domanderai cose irragionevoli e io non
opporrò difficoltà: in caso contrario, niente sarà fatto di quello che tu desideri per lui e per i suoi affari". Il resto
[d] della lettera è troppo lungo e non vale la pena di ripeterlo. Mi giungevano intanto anche altre lettere, di
Archita e di quelli di Taranto, e tutti esaltavano l’amore di Dionisio per la filosofia, e tutti mi dicevano che, se
non fossi andato sùbito, avrei distrutto l’amicizia che per opera mia avevano stretta con lui, amicizia di grande
importanza politica. Tali erano le pressioni che mi si facevano perché partissi; da una parte mi trascinavano gli
amici d’Italia e di Sicilia, dall’altra veramente mi spingevano per dir così, gli ami-[e] ci d’Atene con le loro
preghiere; e sempre mi ripetevano gli stessi discorsi, che non dovevo tradire Dione e gli amici e gli ospiti di
Taranto: del resto, io stesso non trovavo strano che un giovane intelligente, sentendo esporre pensieri
profondi, fosse preso dal desiderio di vivere nel modo più bello: dovevo dunque sperimentare come stavano le
cose, e non disinteressarmene, rendendomi colpevole di così grande vergogna, ché tale sarebbe [340a]
effettivamente stata, se qualcuno aveva detto la verità. Vi andai dunque, nascondendomi la verità con questo
ragionamento, ma, com’è naturale, temendo assai e mal presagendo: e per la terza volta dovetti ringraziare
Zeus Salvatore, perché ebbi fortuna e mi salvai ancora. Ne devo grazie, oltre che al dio, anche a Dionisio,
perché, contro il parere di molti che mi volevano uccidere, ebbe per me un [b] certo riguardo. Appena giunto,
pensai di dover per prima cosa sperimentare se davvero Dionisio era acceso dall’ardore filosofico come da un
fuoco, o erano infondate le molte notizie giunte ad Atene. Ora, v’è un modo non affatto volgare per fare questa
prova, ma veramente opportuno quando s’ha a che fare con tiranni, soprattutto quando sono imbevuti di
formole imparate: ed era appunto questo il caso di Dionisio, come sùbito m’accorsi. A questa gente bisogna
mostrare che cos’è davvero lo studio filosofico, e [c] quante difficoltà presenta, e quanta fatica comporta.
Allora, se colui che ascolta è dotato di natura divina ed è veramente filosofo, congenere a questo studio e
degno di esso, giudica che quella che gli è indicata sia una via meravigliosa, e che si deva fare ogni sforzo per
seguirla, e non si possa vivere altrimenti. Quindi unisce i suoi sforzi con quelli della guida, e non desiste se
prima non ha raggiunto completamente il fine, o non ha acquistato tanta forza da poter progredire da solo
senza l’aiuto del maestro. Così [d] vive e con questi pensieri, chi ama la filosofia: e continua bensì a dedicarsi
alle sue occupazioni, ma si mantiene in ogni cosa e sempre fedele alla filosofia e a quel modo di vita
quotidiana che meglio d’ogni altro lo può rendere intelligente, di buona memoria, capace di ragionare in piena
padronanza di se stesso: il modo di vita contrario a questo, egli lo odia. Quelli invece che non sono veri
filosofi, ma hanno soltanto una verniciatura di formole, come la gente abbronzata dal sole, vedendo quante
cose si devono imparare, [e] quante fatiche bisogna sopportare, come si convenga, a seguire tale studio, la
vita regolata d’ogni giorno, giudicano che sia una cosa difficile e impossibile per loro; sono [341a] quindi
incapaci di continuare a esercitarsi, ed alcuni si convincono di conoscere sufficientemente il tutto, e di non
avere più bisogno di affaticarsi. Questa è la prova più limpida e sicura che si possa fare con chi vive nel lusso
e non sa sopportare la fatica; sicché costoro non possono poi accusare il maestro, ma se stessi, se non
riescono a fare tutto quello ch’è necessario per seguire lo studio filosofico. In questo modo parlai anche a
Dionisio. Non gli spiegai [b] ogni cosa, né, del resto, egli me lo chiese, perché presumeva di sapere e di
possedere sufficientemente molte cognizioni, e anzi le più profonde, per quello che aveva udito dagli altri. In
seguito, mi fu riferito, egli ha anche composto uno scritto su quanto allora ascoltò, e fa passare quello che ha
scritto per roba sua, e non affatto come una ripetizione di quello che ha sentito; ma di questo io non so nulla.
Anche altri, io so, hanno scritto di queste cose, ma chi essi siano, neppure essi sanno. Questo tuttavia io [c]
posso dire di tutti quelli che hanno scritto e scriveranno dicendo di conoscere ciò di cui io mi occupo per averlo
sentito esporre o da me o da altri o per averlo scoperto essi stessi, che non capiscon nulla, a mio giudizio, di
queste cose. Su di esse non c’è, né vi sarà, alcun mio scritto. Perché non è, questa mia, una scienza come le
altre: essa non si può in alcun modo comunicare, ma come fiamma s’accende [d] da fuoco che balza: nasce
d’improvviso nell’anima dopo un lungo periodo di discussioni sull’argomento e una vita vissuta in comune, e
poi si nutre di se medesima. Questo tuttavia io so, che, se ne scrivessi o ne parlassi io stesso, queste cose le
direi così come nessun altro saprebbe, e so anche che se fossero scritte male, molto me ne affliggerei. Se
invece credessi che si dovessero scrivere e render note ai più in modo adeguato e si potessero comunicare,
che cosa avrei potuto fare di più bello nella mia vita, che scriver queste cose utilissime per gli uomini, traendo
5
alla luce [e] per tutti la natura? Ma io non penso che tale occupazione, come si dice, sia giovevole a tutti; giova
soltanto a quei pochi che da soli, dopo qualche indicazione, possono progredire fino in fondo alla ricerca: gli
altri ne trarrebbero soltanto un ingiustificato disprezzo o una sciocca e superba presunzione, quasi avessero
appreso qualche cosa [342a] di augusto. Ma di questo voglio parlare ancora e più a lungo, e forse, dopo che
avrò parlato, qualcuna delle cose che dico riuscirà più chiara. V’è infatti una ragione profonda, che sconsiglia
di scrivere anche su uno solo di questi argomenti, ragione che io ho già dichiarata più volte, ma che mi sembra
opportuno ripetere. Ciascuna delle cose che sono ha tre elementi attraverso i quali si perviene a conoscerla;
quarto è la conoscenza [b]; come quinto si deve porre l’oggetto conoscibile e veramente reale. Questi sono gli
elementi: primo è il nome, secondo la definizione, terzo l’immagine, quarto la conoscenza. Se vuoi capire
quello che dico, prendi un esempio, pensando che il ragionamento che vale per un caso, vale per tutti. Cerchio
è una cosa che ha un nome, appunto questo nome che abbiamo ora pronunciato. Il secondo elemento è la
sua definizione, formata di nomi e di verbi: quella figura che ha tutti i punti estremi ugualmente distanti dal
centro, questa è la definizione di ciò che [c] ha nome rotondo, circolare, cerchio. Terzo è ciò che si disegna e
si cancella, che si costruisce al tornio e che perisce; nulla di tutto questo subisce il cerchio in sé, al quale si
riferiscono tutte queste cose, perché esso è altro da esse. Quarto è la conoscenza, l’intuizione e la retta
opinione intorno a queste cose: esse si devono considerare come un solo grado, ché non risiedono né nelle
voci né nelle figure corporee, ma nelle anime, onde è evidente che la conoscenza è altra cosa dalla natura del
cerchio e dai tre [d] elementi di cui ho già parlato. La intuizione è, di esse, la più vicina al quinto per parentela
e somiglianza: le altre ne distano di più. Lo stesso vale per la figura diritta e per la figura rotonda, per i colori,
per il buono per il bello per il giusto, per ogni corpo costruito o naturale, per il fuoco per l’acqua e per tutte le
altre cose simili a queste, per ogni animale, per i costumi delle anime, per ogni cosa che [e] si faccia o si
subisca. Perché non è possibile avere compiuta conoscenza, per ciascuno di questi oggetti, del quinto,
quando non si siano in qualche modo afferrati gli altri quattro. Oltre a questo, tali elementi esprimono non
meno [343a] la qualità che l’essenza di ciascuna cosa, per causa della inadeguatezza dei discorsi; perciò
nessuno, che abbia senno, oserà affidare a questa inadeguatezza dei discorsi quello ch’egli ha pensato, e
appunto ai discorsi immobili, come avviene quando sono scritti. Bisogna però che io spieghi di nuovo quello
che ho detto. Ciascun cerchio, di quelli che nella pratica si disegnano o anche si costruiscono col tornio, è
pieno del contrario del quinto, perché ogni suo punto tocca la linea retta, mentre il cerchio vero e proprio non
ha in sé né poco né molto della natura contraria. Quanto ai loro nomi, diciamo che nessuno ha [b] un briciolo
di stabilità, perché nulla impedisce che quelle cose che ora son dette rotonde si chiamino rette, e che le cose
rette si chiamino rotonde; e i nomi, per coloro che li mutassero chiamando le cose col nome contrario,
avrebbero lo stesso valore. Lo stesso si deve dire della definizione, composta com’è di nomi e di verbi:
nessuna stabilità essa ha, che sia sufficientemente e sicuramente stabile. Un discorso che non finisce mai si
dovrebbe poi fare per ciascuno dei quattro, a mostrare come sono oscuri; ma l’argomento principale è quello
al quale ho accennato poco fa, e cioè che, essendoci due princìpi, la realtà e la [c] qualità, mentre l’anima
cerca di conoscere il primo, ciascuno degli elementi le pone innanzi, nelle parole e nei fatti, il principio non
ricercato; in tal modo ciascun elemento, quello che si dice o che si mostra ce lo presenta sempre facilmente
confutabile dalle sensazioni, e riempie ogni uomo di una, per così dire, completa dubbiezza e oscurità. E
dunque, là dove per una cattiva educazione non siamo neppure abituati a ricercare il vero e ci accontentiamo
delle immagini che ci si offrono, non ci rendiamo ridicoli gli uni di fronte agli altri, gli interrogati di fronte agli
interro-[d] ganti, capaci di disperdere e confutare i quattro; ma quando vogliamo costringere uno a rispondere
e a rivelare il quinto, uno che sia esperto nell’arte di confutare può, quando lo voglia, avere la vittoria, e far
apparire alla gran parte dei presenti che chi espone un pensiero o con discorsi o per iscritto o in discussioni,
non sa alcunché di quello che dice o scrive; e questo avviene appunto perché quelli che ascoltano ignorano
talvolta che non è l’anima di chi scrive o parla che viene confutata, ma la imperfetta na-[e] tura di ciascuno dei
quattro. Solo trascorrendo continuamente tra tutti questi, salendo e discendendo per ciascuno di essi, si può,
quando si ha buona natura, generare a gran fatica la conoscenza di ciò che a sua volta ha buona natura. Se
invece uno non ha una natura buona, come avviene per la maggior parte degli uomini, privi d’una naturale
disposizione ad apprendere e incapaci di vivere [344a] secondo i cosiddetti buoni costumi, e questi sono
6
corrotti, neppure Linceo potrebbe dar la vista a gente come questa. In una parola, chi non ha natura
congenere alla cosa, né la capacità d’apprendere né la memoria potrebbero renderlo tale (ché questo non può
assolutamente avvenire in nature allotrie); perciò quanti non sono affini e congeneri alle cose giuste e alle altre
cose belle non giungeranno a conoscere, per quanto è possibile, tutta la verità sulla virtù e sulla colpa, anche
se abbiano capacità d’apprendere e buona memoria chi per questa e chi per quella cosa, né la conosceranno
quelli che, pur avendo tale natura, man-[b] cano di capacità d’apprendere e di buona memoria. Infatti insieme
si apprendono queste cose, e la verità e la menzogna dell’intera sostanza, dopo gran tempo e con molta
fatica, come ho detto in principio; allora a stento, mentre che ciascun elemento (nomi, definizioni, immagini
visive e percezioni), in dispute benevole e in discussioni fatte senza ostilità, viene sfregato con gli altri, avviene
che l’intuizione e l’intellezione di ciascuno brillino a chi com-[c] pie tutti gli sforzi che può fare un uomo. Perciò,
chi è serio, si guarda bene dallo scrivere di cose serie, per non esporle all’odio e all’ignoranza degli uomini. Da
tutto questo si deve concludere, in una parola, che, quando si legge lo scritto di qualcuno, siano leggi di
legislatore o scritti d’altro genere, se l’autore è davvero un uomo, le cose scritte non erano per lui le cose più
serie, perché queste egli le serba riposte nella parte più bella che ha; mentre, se egli mette per iscritto proprio
quello che ritiene il suo pensiero più [d] profondo, "allora, sicuramente", non certo gli dèi, ma i mortali "gli
hanno tolto il senno".
Chi ha seguito questo mito e questa digressione, capirà bene che se Dionisio, o qualche altra persona
maggiore o minore di lui, ha scritto sui principi primi e supremi della natura, non può aver appreso né aver
ascoltato, secondo il mio pensiero, alcunché di sano sulle cose di cui ha scritto: altrimenti le avrebbe rispettate
quanto me, e non le avrebbe esposte a un pubblico inadatto e disforme. Perché non ha certo scritto per
richiamarsele alla memoria nel futuro; son [e] cose che non si possono dimenticare, una volta penetrate
nell’animo, ché si riducono a brevissime formule: se l’ha fatto, l’ha fatto per una biasimevole ambizione, sia
che abbia detto che son sue e sia che le abbia scritte come seguace di una scuola filosofica, alla quale era
indegno d’appartenere, se desiderava la gloria che nasce dal farne parte. [345a] Se poi Dionisio ha appreso la
dottrina in quella sola conversazione, ha fatto presto: come poi ci sia riuscito, lo sa Zeus, come dicono i
Tebani. Perché, come ho già detto, io ne ho parlato con lui una sola volta, allora, e poi non più. Chi vuol
sapere come andarono le cose, si domanderà perché mai io non abbia avuto con lui una seconda e una terza
ed altre conversazioni: si domanderà se fu perché Dionisio, dopo avermi ascoltato una volta, pensava di
saper-[b] ne e ne sapeva abbastanza, sia che avesse trovato la verità da sé, sia che l’avesse appresa prima
da altri; o anche se fu perché gli sembrava che fossero sciocchezze le cose ch’io gli dicevo; o infine se fu
perché le giudicava non adatte a lui, ma troppo difficili, e sé stimava realmente incapace di occuparsi della
sapienza e della virtù. Ora, se le considerava sciocchezze, si troverà in contrasto con molti che testimoniano il
contrario, e sono, per queste cose, giudici assai più autorevoli di lui: se invece pensava di averle scoperte o
imparate, e le considerava utili alla educazione [c] di un animo libero, come si può considerarlo un uomo
ragionevole, quando disprezzava con tanta leggerezza la guida e il maestro di questa dottrina? Come mi
disprezzò, lo dirò ora. Non molto tempo dopo i fatti ora raccontati, Dionisio, che fino allora aveva lasciato a
Dione il possesso dei suoi beni e il godimento delle rendite, proibì ai suoi amministratori di mandargliene mai
più nel Peloponneso; pareva che si fosse completamente dimenticato della sua lettera. Diceva che non
appartenevano a Dione, ma al di lui figlio, ch’era suo nipote, e di cui egli era, per legge, il [d] tutore. Fino a
quel momento le cose erano andate così, e allora, dopo questo fatto, io vidi chiaramente in che cosa
consisteva l’amore di Dionisio per la filosofia, e non potei non affliggermene, volente o no. Era già estate, il
tempo propizio alla navigazione: e mi pareva di non dover essere risentito con Dionisio, tanto quanto con me
stesso e con [e] chi mi aveva spinto a venire per la terza volta allo stretto di Scilla, "per affrontare ancor
Cariddi infausta". Dissi allora a Dionisio che non potevo più rimanere, quando Dione era così maltrattato: ed
egli cercò di calmarmi e mi pregò di restare, perché gli pareva inopportuno ch’io stesso andassi sùbito a
raccontare quello che aveva fatto: non persuadendomi, promise che si sarebbe occupato lui stesso [346a] del
mio viaggio. Perché io volevo partire sulla prima nave da trasporto che avessi trovata, irato com’ero e ben
deciso ad affrontare qualunque rischio, se si fosse cercato d’impedirmi di partire: ché era evidente che non io
7
facevo un torto ad altri, ma gli altri a me. Dionisio allora, vedendo che volevo assolutamente andarmene,
escogitò questo mezzo per trattenermi fino a che fosse passato il tempo della navigazione: venne da me il
giorno dopo, e mi tenne questo discorso persuasivo: "Tra me e te non ci siano più [b]- disse - Dione e gli affari
suoi a renderci spesso per essi discordi: pertanto farò questo per lui, per amor tuo. Riabbia egli i suoi beni, e
resti nel Peloponneso, non come esule, ma con la possibilità di ritornare qui, quando saremo tutti d’accordo,
lui, io, e voi suoi amici. Metto come condizione ch’egli non cospiri contro di me; ne sarete garanti tu e i tuoi
familiari e i familiari di Dione che sono qui: a voi darà garanzia lui stesso. Il denaro che gli sarà [c] inviato, sarà
depositato nel Peloponneso e ad Atene, presso persone scelte da voi; Dione ne godrà il frutto, ma non potrà
toccare il capitale senza il vostro consenso. Perché io non mi fido troppo di lui, che delle sue ricchezze, che
non saranno poche, non voglia servirsi contro di me: mi fido piuttosto di te e dei tuoi. Vedi dunque se queste
proposte ti piacciono, e resta a queste condizioni ancora un anno; [d] poi con la buona stagione prenderai il
denaro e te ne andrai. Sono certo che Dione ti sarà gratissimo se farai questo per lui". Questo discorso mi
dispiacque assai; e tuttavia risposi che avrei riflettuto e gli avrei fatto sapere la mia decisione il giorno dopo.
Per allora restammo d’accordo così. Rimasto solo, cominciai a riflettere tutto sconvolto. Il mio primo pensiero,
quello che guidò la mia deli-[e] berazione, fu questo: "Or bene, se pur Dionisio non ha in animo di mantenere
la promessa, e tuttavia, una volta ch’io sia partito, fa conoscere a Dione, sia scrivendogli direttamente, sia
facendogli scrivere da molti altri suoi amici, la proposta che ora mi fa; e gli fa credere ch’egli era disposto a
mantener fede all’accordo, ma ch’io non volli fare quello che mi chiedeva perché non mi importa niente degli
affari suoi; e se, oltre a questo, non mi lascerà partire, pur senza vietare ai capitani di accogliermi nella [347a]
loro nave, ma mostrando a tutti chiaramente che non vuole ch’io me ne vada, chi ci sarà che voglia
accogliermi nella sua nave e condurmi via, quando io esca dalla casa di Dionisio?". (Agli altri guai
s’aggiungeva poi questo, ch’io abitavo nel giardino circostante la reggia, sicché neppure il portiere mi avrebbe
lasciato uscire senza un ordine di Dionisio.) "Se invece - pensavo- rimango per questo anno, potrò far sapere
ogni cosa a Dione, in che condizione ancora mi trovo e quello che faccio. Quindi se Dionisio mantiene poi
davvero, anche soltanto in parte, le sue pro-[b] messe, non si dirà ch’io sono stato sciocco a rimanere, dato
che la sostanza di Dione, se si fa una stima esatta, ammonta a non meno di cento talenti: se invece le cose
andranno come è verosimile che vadano, io certo non so che farò; e tuttavia è forse necessario portar
pazienza ancora per un anno, e tentare di svelare coi fatti le astuzie di Dionisio." Così dunque decisi; e il
giorno dopo dissi a [c] Dionisio: "Resto: ma tu non devi credere ch’io abbia il diritto di disporre a mio talento
delle cose di Dione; perciò mandiamogli insieme una lettera annunciandogli quello che abbiamo stabilito tra di
noi, e domandiamogli se ha obiezioni da muovere. Se egli non è contento, ma desidera che si faccia in modo
diverso, ce lo faccia sapere al più presto. Nel frattempo sia lasciato tutto così com’è ora". Questo è, presso a
poco, quello che dicemmo e concordammo allora. Dopo questo le navi partirono, e io non avevo più la possi[d] bilità d’andarmene, quando Dionisio si ricordò di dirmi che Dione aveva diritto soltanto alla metà della
sostanza, perché l’altra metà era di suo figlio; e che avrebbe venduto tutto, e poi metà del ricavato l’avrebbe
data a me perché gliela portassi, metà l’avrebbe lasciata al figlio di Dione: questa, egli diceva, era la soluzione
più giusta. Indignato per queste parole, per quanto capissi ch’era ridicolo muovere obiezioni, dissi tuttavia che
dovevamo aspettare la risposta di Dione, per fargli poi sapere questa novità. Egli [e] vendette invece sùbito,
senza alcun riguardo, tutta la sostanza di Dione, dove, come e a chi volle: e a me non ne parlò più; e
altrettanto feci io: non gli parlai più degli affari di Dione, convinto com’ero di non poter far nulla.
E dunque fino a questo punto io compii così il mio dovere verso la filosofia e i miei amici. Dopo d’allora, io e
[348a] Dionisio vivevamo così: io guardavo fuori, come un uccello che desidera di volarsene via, lui cercava di
placarmi senza restituire a Dione i suoi beni: tuttavia fingevamo d’essere amici dinanzi a tutta la Sicilia. […].
[352a] Il mio consiglio dopo quanto vi ho raccontato, ve l’ho già dato ed è bastevole. Per questa ragione ho
raccontato il secondo viaggio in Sicilia, che mi sembrava opportuno dirlo, per la stranezza e la novità di quanto
è avvenuto. Se qualcuno giudica ragionevole quello che ho raccontato, e trova sufficientemente giustificato
quello che ho fatto, ho ottenuto quello che volevo, e non v’è bisogno che dica di più.
8
La Repubblica (da Opere complete, Volume VI, Laterza 1986, traduzione di F. Sartori)
L’UOMO HA MOLTI BISOGNI
Platone affronta il tema della giustizia. Data la complessità del problema Socrate, propone di ampliare la
discussione spostando l’attenzione dall’individuo allo Stato. Il fondamento del vivere in comune sono i bisogni
degli individui. Stando insieme e specializzandosi nelle singole attività, si riesce a soddisfarli piú facilmente.
L’interlocutore di Socrate è Adimanto.
Repubblica, 368 e-371 b
1 [368 e] – [...] Noi affermiamo che esiste una giustizia del singolo individuo e in certo senso anche quella di
uno stato intero, no? – Senza dubbio, ammise. – Ora, uno stato non è maggiore di un individuo? – Maggiore,
sí, rispose. – Ebbene, in un àmbito maggiore ci sarà forse piú giustizia e la si noterà piú facilmente. Perciò, se
volete, [369 a] cerchiamo prima negli stati che cosa essa sia. Esaminiamola poi con questo metodo anche in
ogni individuo e cerchiamo di cogliere nelle caratteristiche del minore la somiglianza con il maggiore. – Cosí
va bene, mi sembra, rispose. – Ora, ripresi io, se non di fatto, ma a parole assistessimo al processo di nascita
di uno stato, non vedremmo nascere pure la giustizia e l’ingiustizia? – Forse sí, ammise. – E se ciò avviene,
non possiamo sperare di scorgere piú agevolmente il nostro obiettivo? – Molto [b] di piú, certo. – Ora, secondo
voi, dobbiamo tentar di andare sino in fondo? Non la credo una impresa da poco, e quindi pensateci su! – Ci
abbiamo già pensato, disse Adimanto. Via!, fa’ come hai detto.
2 – Secondo me, ripresi, uno stato nasce perché ciascuno di noi non basta a se stesso, ma ha molti
bisogni. O con quale altro principio credi che si fondi uno stato? – Con nessun altro, rispose. – Cosí per un
certo [c] bisogno ci si vale dell’aiuto di uno, per un altro di quello di un altro: il gran numero di questi bisogni fa
riunire in un’unica sede molte persone che si associano per darsi aiuto, e a questa coabitazione abbiamo dato
il nome di stato. Non è vero? – Senza dubbio. – Quando dunque uno dà una cosa a un altro, se gliela dà, o da
lui la riceve, non lo fa perché crede che sia meglio per sé? – Senza dubbio. – Suvvia, feci io, costruiamo a
parole uno stato fin dalla sua origine: esso sarà creato, pare, dal nostro bisogno. – Come no? – Ora, il primo e
maggiore [d] bisogno è quello di provvedersi il nutrimento per sussistere e vivere. – Senz’altro. – Il secondo
quello di provvedersi l’abitazione, il terzo il vestito e simili cose. – Sí, sono questi. – Ebbene, dissi, come potrà
bastare lo stato a provvedere tutto questo? Non ci dovranno essere agricoltore, muratore e tessitore? E non vi
aggiungeremo pure un calzolaio o qualche altro che con la sua attività soddisfi ai bisogni del corpo? – Senza
dubbio. – Il nucleo essenziale dello stato sarà di quattro o cinque [e] persone. – È evidente. – Ebbene,
ciascuna di esse deve prestare l’opera sua per tutta la comunità? Cosí, per esempio, l’agricoltore, che è uno,
deve forse provvedere cibi per quattro e spendere quadruplo tempo e fatica per fornire il grano e metterlo in
comune con gli altri? o deve evitarsi questa briga e produrre per sé soltanto un [370 a] quarto di questo grano
in un quarto di tempo? e impiegare gli altri tre quarti del tempo uno a provvedersi l’abitazione, uno il vestito,
uno le calzature? e non prendersi per gli altri i fastidi che derivano dai rapporti sociali, ma badare per conto
proprio ai fatti suoi? Rispose Adimanto: – Forse, Socrate, la prima soluzione è piú facile della seconda. – Nulla
di strano, per Zeus!, io dissi. Le tue parole mi fanno riflettere che anzitutto ciascuno di noi nasce per natura
completamente diverso da ciascun altro, [b] con differente disposizione, chi per un dato compito, chi per un
altro. Non ti sembra? – A me sí. – Ancora: agirà meglio uno che eserciti da solo molte arti o quando da solo ne
eserciti una sola? – Quando da solo ne eserciti una sola, rispose. – È chiaro d’altra parte, credo, che se uno si
lascia sfuggire l’occasione opportuna per una data opera, questa opera è perduta. – È chiaro, sí. – L’opera da
compiere non sta ad aspettare, credo, i comodi di chi la compie. E chi la compie deve starle [c] dietro, senza
considerarla un semplice passatempo. – Per forza. – Per conseguenza le singole cose riescono piú e meglio
con maggiore facilità quando uno faccia una cosa sola, secondo la propria naturale disposizione e a tempo
opportuno, senza darsi pensiero delle altre. – Perfettamente. – Occorrono dunque, Adimanto, piú di quattro
cittadini per provvedere quanto dicevamo: ché l’agricoltore, come sembra, non si costruirà lui stesso da solo
9
l’aratro, se ha da essere un buon aratro, né la zappa né [d] gli altri attrezzi agricoli. Né d’altra parte si costruirà
i propri arnesi il muratore: gliene occorrono molti. E cosí il tessitore e il calzolaio. No? – È vero. – Ecco dunque
che carpentieri, fabbri e molti altri simili artigiani verranno a far parte del nostro staterello e lo renderanno
popoloso. – Senza dubbio. – Ma non sarebbe ancora troppo grande se vi aggiungessimo bovai, pecorai e le
altre categorie [e] di pastori: ciò perché gli agricoltori possano avere buoi per l’aratura, e i muratori servirsi,
insieme con gli agricoltori, di bestie da tiro per i loro trasporti, e i tessitori e i calzolai disporre di pelli e di lane.
– Ma con tutta questa gente, ribatté, non sarebbe neanche piccolo il nostro stato. – D’altra parte, ripresi io, è
pressoché impossibile fondarlo in un luogo che renda superflue le importazioni. – Impossibile. – Occorreranno
quindi altre persone ancora per portargli da un altro stato la roba che gli abbisogna. – Occorreranno, sí. – E se
il nostro agente si presenta a mani vuote senza alcuno dei prodotti occorrenti a chi ci fornisce le merci
d’importazione [371 a] necessarie per i nostri cittadini, se ne verrà via a mani vuote, non è vero? – Mi sembra
di sí. – La produzione interna deve dunque non solo bastare ai cittadini stessi, ma anche rispondere per
qualità e quantità alle esigenze di coloro dei quali i nostri cittadini possono avere bisogno. – Deve, sí. – Al
nostro stato occorre perciò un maggiore numero di agricoltori e di altri artigiani. – Sí, un numero maggiore. – E
anche di altri agenti, a mio avviso, destinati a importare e ad esportare le singole merci. Sono questi i
commercianti, non è vero? – Sí. – Ci abbisogneranno dunque anche i commercianti. – Senza dubbio. – E se
poi il commercio si svolge per mare, [b] occorreranno ancora molti altri, pratici del lavoro marittimo. – Molti
altri, certo. [...]
IL COMUNISMO
L’argomento ha attratto l’interesse dei filosofi sia nel secolo scorso, sia in questo. In realtà sembra che Platone
nel delineare il modello del regime perfetto si sia ispirato a quello spartano, che allora godeva di grande favore
sia per la compattezza sociale, che tutta la Grecia invidiava a Sparta, sia perché questa città era uscita
vincitrice dallo scontro trentennale con Atene.
Repubblica, 416d-417b
[416 d] [...] prima di tutto nessuno deve avere sostanze personali, a meno che non ce ne sia necessità
assoluta; nessuno deve poi disporre di un’abitazione o di una dispensa cui non possa accedere chiunque lo
voglia. Riguardo alla quantità di provviste occorrenti ad atleti di guerra temperanti e coraggiosi, devono
ricevere dagli altri cittadini, dopo [e] averla determinata, una mercede per il servizio di guardia, in misura né
maggiore né minore del loro annuo fabbisogno. Devono vivere in comune, frequentando mense collettive
come se si trovassero al campo. Per quello che concerne l’oro e l’argento, occorre dire loro che nell’anima
hanno sempre oro e argento divino, per dono degli dèi, e che non hanno alcun bisogno di oro e argento
umano; e che non è pio contaminare il possesso dell’oro divino mescolandolo a quello dell’oro mortale: perché
numerose sono [417 a] le empietà che si sono prodotte a causa della moneta volgare, mentre integra resta
quella che portano entro di loro. Anzi a essi soli tra i cittadini del nostro stato non è concesso di maneggiare e
di toccare oro ed argento, e di entrare sotto quel medesimo tetto che ne ricopra; né di portarli attorno sulla
propria persona né di bere da coppe d’argento o d’oro. E cosí potranno salvarsi e salvare lo stato. Quando
però s’acquisteranno personalmente terra, case e monete, invece di essere guardiani, saranno amministratori
[b] e agricoltori; e diventeranno padroni odiosi anziché alleati degli altri cittadini. E cosí condurranno tutta la
loro vita odiando e odiati, insidiando e insidiati, temendo molto piú spesso e molto di piú i nemici interni che gli
esterni; ed eccoli già correre sull’orlo della rovina, essi e il resto dei cittadini. Per tutto ciò, continuai, diciamo
pure che cosí debbono essere organizzati i guardiani per quanto riguarda l’abitazione e gli altri bisogni; e
siano queste le nostre leggi. No? – Senza dubbio, rispose Glaucone.
10
ANIMA RAZIONALE, CONCUPISCIBILE, IRASCIBILE
Partendo da uno dei fenomeni ben noti all’esperienza umana – la sete –, Platone presenta una concezione
dell’anima fra le piú famose della storia della filosofia. Vengono affermate la non coincidenza dell’anima con la
Ragione, e la presenza nell’anima di componenti irrazionali che la Ragione ha il dovere di controllare.
L’interlocutore di Socrate è Glaucone.
Repubblica, 439 a-441 e
1 [438 d] [...] [Socrate] Questo, ripresi, intendevo allora dire, puoi bene affermarlo, se adesso hai compreso:
tutte le cose che sono in relazione con un oggetto, considerate in sé e da sole hanno relazione con gli oggetti
presi in sé e da soli; ma cose dotate di una determinata qualità l'hanno con oggetti [e] dotati di quella qualità. E
non dico che siano esattamente quali sono i loro oggetti; non dico che, per esempio, la scienza delle cose
sane e malate è sana e malata, e quella delle cattive e buone cattiva e buona; ma poiché essa è divenuta
scienza non di ciò che costituisce l’oggetto della scienza, ma di un oggetto determinato, ossia del sano e del
malato, eccola divenuta anch’essa una scienza determinata; e perciò non la si è piú chiamata semplicemente
scienza, ma, per l’aggiunta della specificazione, scienza medica. – Ho compreso, rispose, e mi sembra che sia
cosí. [439 a] – E la sete, feci io, non porrai tu che quello che essa è, lo è nel numero delle cose “che sono di
qualcosa”? Essa è, non è vero?, sete di ... – Sí che la porrò, rispose; è sete di una bevanda. – Ora, per una
bevanda determinata non c'è anche una determinata sete? E non è vero che la sete in sé non è sete né di
molta né di poca bevanda, né di una bevanda buona né di una cattiva, né, in una parola, di una bevanda
determinata? E invece, sete come sete, non è per natura soltanto sete di una bevanda in quanto bevanda? –
Assolutamente. – Perciò l’anima di chi ha sete, in quanto ha sete, non desidera altro [b] che bere e tende e
mira a questo. – È chiaro. – Ebbene, se, quando ha sete, c’è qualche altra cosa che la tira in senso opposto,
non ci sarà in lei un elemento diverso da quello che ha sete e che, come una bestia, la spinge a bere? Perché,
come s’è detto, l’identico oggetto non può effettuare nel medesimo tempo azioni opposte con la stessa sua
parte e rispetto all’identico oggetto. – No certamente. – Cosí, credo, se si parla dell’arciere, non sta bene dire
che le sue mani al tempo stesso allontanano e avvicinano al corpo l’arco, ma dovremo dire che una lo
allontana, l’altra lo avvicina. – [c] Perfettamente, ammise. – Ora, possiamo dire che ci sono persone che, per
quanto assetate, non vogliono bere? – Certo, rispose, ce ne sono molte, e non di rado. – E che se ne potrà
dire?, feci io. Non forse che nell’anima loro c’è un elemento che incita e un altro che vieta di bere? e che
questo è diverso e prevale sul primo? – Mi sembra di sí, rispose. – E quello che cosí vieta, quando sorge, [d]
non sorge dalla ragione? E gli impulsi e le attrazioni non sono dovuti a passioni e sofferenze? – È evidente. –
Non avremo torto, dunque, continuai, a giudicare che si tratti di due elementi tra loro diversi: l’uno, quello con
cui l’anima ragiona, lo chiameremo il suo elemento razionale; l’altro, quello che le fa provare amore, fame,
sete e che ne eccita gli altri appetiti, irrazionale e appetitivo, compagno di soddisfazioni e piaceri materiali. –
No, anzi [e] cosí avremmo ragione, rispose. – Ecco dunque definiti, ripresi, questi due aspetti che sono
nell’anima nostra. Il terzo è forse quello dell’animo, quello che ci rende animosi? o avrà esso la stessa natura
di uno dei due precedenti? – Forse, rispose, del secondo, l’appetitivo. – Però, dissi, una volta sentii raccontare
un aneddoto, per me attendibile: Leonzio, figlio di Aglaione, mentre saliva dal Pireo sotto il muro settentrionale
dal lato esterno, si accorse di alcuni cadaveri distesi ai piedi del boia. E provava desiderio di vedere, ma
insieme non tollerava quello spettacolo e ne distoglieva lo sguardo. Per un poco lottò [440 a] con se stesso e
si coperse gli occhi, poi, vinto dal desiderio, li spalancò, accorse presso i cadaveri esclamando: “Eccoveli,
sciagurati, saziatevi di questo bello spettacolo”. – L’ho sentito raccontare anch’io, rispose. – Ora, conclusi,
questo racconto significa che talvolta l’impulso dell’animo contrasta con i desidèri: si tratta di cose tra loro
diverse. – Sí, significa questo, ammise.
2 E non notiamo, ripresi, anche in numerose [b] altre occasioni che, quando una persona è dominata da
violenti desidèri che contrastano con la ragione, essa si rimprovera e prova un senso di sdegno contro
l’elemento violento che è in lei? e che, in questo contrasto a due, il suo animo si allea alla ragione? Ma
quando esso fa causa comune con i desidèri, in quanto la ragione decide che non deve contrastarli, non credo
11
tu possa affermare di accorgerti che sia mai accaduto in te e nemmeno in altri alcunché di simile. – No, per
Zeus!, disse. – E [c] che succede, feci, quando uno crede di essere in torto? Non è vero che, quanto piú è
nobile di cuore, tanto meno è capace di arrabbiarsi per la fame, il freddo o qualsiasi altro simile disagio gli
venga da chi, secondo lui, fa questo giustamente? e che, come dico, l’animo suo non vuol eccitarsi contro
codesta persona? – È vero, rispose. – E quando uno pensa di subire un torto? Non è vero che allora ribolle
d’ira, si stizzisce e si fa alleato di quella che gli sembra giustizia? e, attraverso la fame, il freddo [d] e ogni
simile patimento, tenacemente resistendo vince, senza desistere dai suoi nobili sforzi finché non riesce o
muore o si ammansisce alla voce della ragione che è in lui, come si ammansisce un cane alla voce del
pastore? – Il paragone è senza dubbio calzante, rispose; e veramente nel nostro stato abbiamo stabilito che
gli ausiliari, come cani, siano soggetti ai governanti, come a pastori dello stato. – Tu comprendi bene, dissi, il
mio pensiero. Ma vuoi [e] riflettere su quest’altro punto? – Quale? – L’elemento animoso si rivela l’opposto di
come pensavamo poco fa. Allora noi lo credevamo una specie di appetito, adesso invece affermiamo che c’è
notevole differenza e preferiamo assai dire che quando l’anima è discorde, esso combatte in difesa della
ragione. – Senz’altro, disse. – Ed è diverso anche da questa o ne è un aspetto, sí che nell’anima esistono non
tre, ma due aspetti, il razionale e l’appetitivo? Oppure, come nello stato erano tre classi a [441 a] costituirlo
(affaristi, ausiliari e consiglieri), cosí anche nell’anima questo terzo elemento è l’animoso? E non aiuta esso
naturalmente la ragione, a meno che non lo guasti una cattiva educazione? – È necessariamente il terzo,
rispose. – Sí, feci io, sempre che risulti diverso dall’elemento razionale, come risultò differente dall’appetitivo.
– Ma non è difficile questo, disse; anche nei bambini si potrebbe notare che fino dalla nascita sono pieni
d’animo, ma, in quanto alla ragione, taluni di essi, a mio parere, [b] ne sono totalmente privi, i piú ne
acquistano col tempo. – Sí, per Zeus!, risposi, hai detto bene. E il fenomeno che citi si potrebbe constatare
anche nelle bestie. Lo confermerà ulteriormente il verso di Omero che piú sopra abbiamo ripetuto:
“percotendosi il petto rimproverava il suo cuore”. Lí Omero, come se si trattasse di due cose di cui una
rimbrotta l’altra, ha chiaramente rappresentato l’elemento [c] razionale, che riflette sul meglio e sul peggio,
mentre rimbrotta quello che s’eccita irragionevolmente. – Parli benissimo, disse. – Ecco, feci io, che, pur a
stento, abbiamo superato queste difficoltà e ci siamo resi ben conto che le parti che costituiscono lo stato e le
parti che costituiscono l’anima di ciascun individuo, sono le stesse e in numero eguale. – È cosí. – Ora,
conseguenza necessaria e immediata non è che anche il privato individuo sia sapiente come lo era lo stato e
per via del medesimo elemento? [d] – Sí, certamente. – E che, dunque, anche lo stato sia coraggioso nel
modo in cui lo è un privato, e con il medesimo elemento? e che identica sia la loro condizione in qualunque
altro rapporto con la virtú? – Per forza. – E dunque, Glaucone, dovremo dire giusto, io credo, un uomo allo
stesso modo in cui lo era lo stato. – Anche questo, per forza. – Non ci siamo però dimenticati che quello stato
era giusto in quanto ciascuna delle tre classi che lo costituivano adempiva il compito suo. – Non ce ne siamo
dimenticati, mi sembra, rispose. – Dobbiamo allora ricordare che anche ciascuno di noi, se ciascuno dei [e]
suoi elementi adempie i suoi compiti, sarà un individuo giusto che adempie il suo compito. – Sí, fece,
dobbiamo ricordarcene. – Ora, all’elemento razionale, che è sapiente e vigila su tutta l’anima, non toccherà
governare? e all’elemento animoso essergli suddito e alleato? – Senza dubbio
SULLE DONNE IN COMUNE
Platone presenta una concezione della donna e dei suoi rapporti con l’uomo in un contesto di negazione della
proprietà, anche del corpo e dei figli, che ci appare assurda e carica di violenza. Nello stesso tempo però
l’uomo e la donna sono posti sullo stesso piano di fronte allo Stato, che deve fare le sue scelte senza
accettare discriminazioni sessuali.
a) Sulla comunione delle donne e dei figli (Repubblica, 457d-e)
[457 d] – Queste donne di questi nostri uomini siano tutte comuni a tutti e nessuna abiti privatamente con
alcuno; e comuni siano poi i figli, e il genitore non conosca la propria prole, né il figlio il genitore. – Questa
norma, disse, assai piú dell’altra susciterà diffidenza, per la sua possibilità come per la sua utilità. – Non
credo, risposi, che, almeno per quanto concerne l’utile, si contesterà che non sia massimo bene avere comuni
12
le donne e i figli, sempre che la cosa sia possibile; ma credo che ci sarà una grandissima contestazione se sia
o no possibile. [e] – Ambedue i punti, fece, si potranno contestare molto. [...]
b) Sul rapporto uomo-donna (Repubblica, 451c-452e)
1
[451 c] [...] Forse sarebbe bene, dopo aver completamente esaurito la rappresentazione maschile,
svolgere a sua volta quella femminile, soprattutto perché a questo tu inviti.
2
Per uomini nati ed educati come abbiamo detto non c’è, a mio avviso, altro modo di possedere e
godere rettamente figli e donne se non procedendo nel senso da noi indicato fin dal principio: nel nostro
discorso abbiamo cominciato a farne come tanti guardiani di un gregge. – Sí. – Ebbene, siamo coerenti e
attribuiamo alle [d] donne analoga nascita e analogo allevamento, ed esaminiamo se la cosa ci conviene o no.
– Come?, chiese. – Cosí. Non crediamo che le femmine dei cani da guardia debbano cooperare a custodire
ciò che custodiscono i maschi, cacciare insieme con loro e fare ogni altra cosa in comune? O crediamo che le
femmine debbano starsene dentro a casa perché impedite dalla figliazione e dall’allevamento dei cuccioli e i
maschi faticare per tutte le cure degli armenti? [e] – Ogni attività dev’essere comune, rispose; con l’eccezione
che li impieghiamo tenendo presente che le une sono piú deboli, gli altri piú vigorosi. – È dunque possibile,
ripresi, impiegare un dato animale per identici scopi, se non lo sottoponi all’identico allevamento e all’identica
educazione? – Non è possibile. – Se dunque impiegheremo le donne per gli identici scopi per i quali
impieghiamo gli uomini, identica dev’essere l’istruzione che [452 a] diamo loro. – Sí. – Ora, agli uomini si sono
date musica e ginnastica. – Sí. – E allora anche alle donne si devono assegnare queste due arti e i compiti
bellici, e le dobbiamo impiegare con gli stessi criteri. – È una conclusione ovvia, da quel che dici, ammise. –
Però, ripresi, molti punti di questo nostro discorso, se verranno messi in pratica nel modo che diciamo, forse
potranno apparire contro la tradizione e ridicoli. – Certo, disse. – Di questo discorso, feci io, che cos’è che tu
vedi come molto ridicolo? Non è, evidentemente, scorgere le donne far ginnastica ignude nelle palestre
insieme con gli uomini, [b] non soltanto le giovani, ma perfino le anziane? Sono come quei vecchi che trovi nei
ginnasi, quando, tutti grinzosi e poco piacevoli alla vista, tuttavia amano fare ginnastica. – Sí, per Zeus!,
rispose; sarebbe uno spettacolo ridicolo, almeno per i nostri tempi. – Ora, dissi, poiché s’è cominciato a
parlare, non si devono temere i motteggi degli spiritosi: lasciamo pure che ne dicano quanti e quali vogliono
per una simile trasformazione verificatasi nei [c] ginnasi, nella musica e specialmente nel maneggio delle armi
e nell’equitazione. – Hai ragione, disse. – Ma, ora che abbiamo avviato il discorso, dobbiamo procedere verso
il punto piú scabroso della legge; e preghiamo questi motteggiatori di rinunciare al loro mestiere e di
comportarsi seriamente, ricordando che non è passato molto tempo da quando agli Elleni sembravano brutte
e ridicole certe cose che ora sembrano tali alla maggior parte dei barbari, cioè che si vedessero uomini nudi; e
che quando i Cretesi per primi e poi i Lacedemoni iniziarono gli esercizi [d] ginnici, gli spiritosi di allora
potevano beffarsi di tutto questo. Non credi? – Io sí. – Ma quando, come penso, durante gli esercizi sembrò
piú opportuno svestirsi che coprire il corpo, anche quello che agli occhi era ridicolo sparí di fronte all’ottima
soluzione che la ragione indicava. Anzi questo fatto dimostrò che è un superficiale chi ritiene ridicola tutt’altra
cosa che il male; e che chi si mette a suscitare il riso guardando, come a visione di cosa ridicola, a una visione
che non sia quella della stoltezza e del male, [e] persegue inoltre seriamente anche una visione del bello con
uno scopo diverso da quello del bene. – Perfettamente, rispose.
FILOSOFI E FILODOSSI
Il passo è tratto dal quinto libro della Repubblica, nel quale Platone dà una definizione del filosofo come
amante della Verità, cui fa seguire la distinzione fra “scienza” (gnôsis), “ignoranza” (agnosía) e “opinione”
(dóxa), e tra “filosofi” e “filodossi”. A quest’ultima si riferiscono le righe che seguono. L’interlocutore di Socrate
è Glaucone.
Repubblica, 475 e-480 a
1
[475 e] [...] [Glaucone] Ma quali sono per te i veri filosofi?, chiese. – Quelli, feci io, che amano
13
contemplare la verità. – Anche in questo, ammise, hai ragione; ma che intendi dire? – Non è facile rispondere,
ripresi, davanti a un’altra persona, ma credo che sarai d’accordo con me su questo. – Su che cosa? – Che
bello e brutto, essendo opposti, [476 a] sono cose distinte. – Come no? – E se sono due, ciascuna di esse non
sarà anche una? – Giusto anche questo. – Lo stesso discorso vale per il giusto e l’ingiusto, per il bene e il
male, e per ogni altra idea: ciascuna in sé è una, ma, comparendo dovunque in comunione con le azioni, con i
corpi e l’una con l’altra, ciascuna si manifesta come molteplice. – Hai ragione, disse. – Ecco dunque la mia
distinzione, feci io; da un lato metto gli individui che or ora dicevi amatori di spettacoli, amanti delle arti e
uomini di azione; dall’altro quelli di cui stiamo [b] parlando, gli unici che si potrebbero dire rettamente filosofi. –
Come dici?, chiese. – Secondo me, risposi, gli amanti delle audizioni e degli spettacoli amano i bei suoni, i bei
colori, le belle figure e tutti gli oggetti che risultano composti di elementi belli; ma il loro pensiero è incapace di
vedere e di amare la natura della bellezza in sé. – È cosí, appunto, rispose. – E coloro che sono capaci di
giungere alla bellezza in sé e di vederla unicamente come [c]bellezza non saranno rari? – Certamente. – Chi
dunque riconosce che esistono oggetti belli, ma non crede alla bellezza in sé e, pur guidato a conoscerla, non
è capace di tenere dietro alla sua guida, ti sembra che viva in sogno o sveglio? Su, esamina. Sognare non
vuole dire che uno, sia dormendo sia vegliando, crede che un oggetto somigliante a una cosa non è simile, ma
identico a ciò cui somiglia? – Io direi proprio, fece, che una tale persona sta sognando. – E chi invece crede
all’esistenza del bello in sé ed è [d] capace di contemplare sia questo bello sia le cose che ne partecipano, e
non identifica le cose belle con il bello in sé né il bello in sé con le cose belle, costui ti sembra che viva sveglio
o in sogno? – Sveglio, certamente, rispose. – E il suo pensiero, in quanto pensiero di uno che conosce, non
avremmo ragione di chiamarlo conoscenza? e quello di un altro, in quanto pensiero di uno che opina,
opinione? – Senza dubbio. – E se costui al quale attribuiamo opinione e non conoscenza, si arrabbiasse con
noi e [e] sostenesse che non diciamo il vero? Potremo un po’ calmarlo e persuaderlo con le buone,
nascondendogli la sua infermità mentale? – Sí, rispose, è nostro dovere. – Su dunque, esamina che cosa gli
diremo; o vuoi che, dicendogli che nessuno gli invidia ciò che eventualmente sappia, e che anzi saremmo lieti
di trovare chi sappia qualcosa, lo interroghiamo cosí: “Su, rispondi a questa nostra domanda: chi conosce,
conosce qualcosa o niente?”. Rispondimi tu al suo posto. – Risponderò, disse, che conosce qualcosa. – Una
cosa che è o una che non è? – Che è: come potrebbe conoscerne una che non è? [477 a] – Ecco dunque un
punto bene acquisito, anche se piú volte ripetessimo il nostro esame: ciò che è in maniera perfetta è
perfettamente conoscibile, ma ciò che assolutamente non è, è completamente inconoscibile. – Conclusione
perfettamente soddisfacente. – Bene: ma se una cosa è tale da essere e non essere nello stesso tempo, non
sarà intermedia tra ciò che assolutamente è e ciò che non è in nessun modo? – Intermedia. – Ora, la
conoscenza non si riferisce a ciò che è, e la non conoscenza, necessariamente, a ciò che non è? E per questa
forma intermedia non si deve cercare anche qualcosa di intermedio [b] tra l’ignoranza e la scienza, sempre
che esista qualcosa di simile? – Senza dubbio. – E l’opinione, diciamo, è qualcosa? – Come no? – Una facoltà
diversa dalla scienza o la medesima? – Diversa. – Quindi, a una cosa è ordinata l’opinione e a un’altra la
scienza: ciascuna secondo la facoltà sua propria. – Cosí. – Ora, per sua natura la scienza non ha per oggetto
ciò che è, ossia conoscere come è ciò che è? Mi sembra anzi che occorra una distinzione preliminare, cosí. –
Come?
2 [c] – Definiremo le facoltà un genere di enti che permettono, sia a noi sia a qualunque altro soggetto che
possa, di fare ciò che possiamo. Dico, ad esempio, che alle facoltà appartengono la vista e l’udito, se pur
comprendi quale specie intendo dire. – Ma sí che comprendo, rispose. – Senti dunque che cosa penso delle
facoltà. Di una facoltà io non vedo né colore né figura alcuna né alcuna simile proprietà, come invece la vedo
di molte altre cose che mi basta guardare per definirle fra me, queste in un modo, quelle in un altro. Quanto
alla facoltà, [d] ne guardo soltanto l’oggetto e l’effetto, e in questa maniera a ciascuna facoltà ho dato il suo
nome: questa, ordinata all’identico oggetto e dotata dell’identico effetto, la chiamo identica; quella, ordinata a
un oggetto diverso e dotata di diverso effetto, la chiamo diversa. E tu, come fai? – Cosí, disse. – Torniamo
dunque al punto, mio ottimo amico, ripresi. La scienza, per te, è una facoltà? O come la classifichi? – Cosí,
rispose, anzi tra tutte le facoltà è la piú [e] potente. – E l’opinione, la riporteremo a una facoltà o a un’altra
specie? – Per nulla, disse; perché ciò che ci permette di opinare non è altro che opinione. – Ma poco prima
14
convenivi che scienza e opinione non s’identificano. – Già, rispose, come potrebbe mai chi ha senno
identificare l’infallibile con quello che non lo è? – Bene, feci io; noi siamo evidentemente d’accordo che [478 a]
l’opinione differisce dalla scienza. – Sí, ne differisce. – Ora, ciascuna di esse, dato che diverso è il suo potere,
non ha naturalmente un oggetto diverso? – Per forza. – E la scienza non ha per oggetto ciò che è, ossia
conoscere come è ciò che è? – Sí. – E l’opinione quello, diciamo, di opinare? – Sí. – Conosce forse l’identico
oggetto della scienza? e l’identico sarà conoscibile e insieme opinabile? O è una cosa impossibile? –
Impossibile, rispose, in base a quello che s’è convenuto: se una facoltà, per sua natura, ha un oggetto e
un’altra un altro, e se opinione e scienza sono ambedue facoltà e ambedue, come diciamo, [b] diverse, queste
premesse non ci autorizzano a concludere per l’identità di conoscibile e opinabile. – E se il conoscibile è ciò
che è, l’opinabile non sarà diverso da ciò che è? – Diverso. – Ora, l’opinione opina forse ciò che non è? O è
pure impossibile opinare ciò che non è? Su, rifletti. Chi ha un’opinione non la riferisce a una cosa? O è
possibile avere un’opinione anche senza riferirla a un oggetto? – Impossibile. – Ma chi ha un’opinione l’ha di
una cosa almeno? – Sí. – D’altra parte, a rigore, si potrebbe dire che ciò che non è, non è una cosa, ma è
nulla? – Senza dubbio. – Però a ciò che non è, non abbiamo dovuto per forza assegnare l’ignoranza, e a ciò
che è, la conoscenza? – Esattamente, disse. – Allora, l’opinione non opina né ciò che è né ciò che non è. –
No. – E l’opinione non potrà dunque essere né ignoranza né conoscenza. – Sembra di no. – È forse al di fuori
di esse, superando in chiarezza la conoscenza o in oscurità l’ignoranza? – Non è né questo né quello. – E
allora, feci io, l’opinione ti sembra piú oscura della conoscenza, ma piú luminosa dell’ignoranza? [d] – Sí,
certo, rispose. – E sta tra le due? – Sí. – L’opinione sarà dunque intermedia tra scienza e ignoranza. –
Precisamente. – Ma prima non affermavamo che, se una cosa risultasse, per modo di dire, nel medesimo
tempo come essere e non essere, sarebbe intermedia tra ciò che assolutamente è e ciò che non è affatto? e
che non sarebbe l’oggetto né della scienza né dell’ignoranza, ma di ciò che risultasse a sua volta come
intermedio tra l’ignoranza e la scienza? – Giusto. – E ora appunto non risulta intermedia tra le due quella che
chiamiamo opinione? – Sí, risulta.
3 [e] – Ci rimane dunque da scoprire, sembra, quest’altro elemento, che partecipa insieme dell’essere e del
non essere e che, rettamente parlando, non si potrebbe dire né l’uno né l’altro in senso assoluto, affinché, se
si manifesterà, possiamo dire a buon diritto che è l’opinabile, e assegnare quindi ai termini estremi gli estremi,
agli intermedi gli intermedi; non è cosí? – Cosí. – Con queste premesse, dirò, mi dica e mi risponda quel bravo
[479 a] uomo che non crede al bello in sé né ad alcuna idea del bello in sé che permanga sempre
invariabilmente costante; e che invece ammette la molteplicità delle cose belle; quell’amatore di spettacoli che
non sopporta in nessun modo chi eventualmente gli vada a parlare dell’unicità del bello e del giusto, e cosí via.
Di queste molte cose belle, diremo, ce n’è qualcuna, nostro ottimo amico, che non ti apparirà brutta? e tra le
giuste qualcuna che non ti apparirà ingiusta? e tra le pie qualcuna che non ti apparirà empia? – No, disse, è
inevitabile che le stesse [b] cose belle sotto qualche aspetto appaiano anche brutte, e cosí tutte le altre che mi
chiedi. – E le molte cose doppie? Non appaiono tanto mezze quanto doppie? – Sicuro. – E per le cose grandi
e piccole, e per le leggere e pesanti si useranno di piú questi nomi che diciamo che i nomi opposti? – No,
rispose, ma per ciascuna andranno bene sia questi sia quelli. – E ciascuna di queste molte cose, piuttosto che
non essere, è forse ciò che la si dice essere? – Questo, disse, sembra uno di quei giochi a doppio senso che
si fanno nei banchetti, e quell’enigma che si propone [c] ai bambini sull’eunuco e sul colpo tirato al pipistrello,
dove c’è da indovinare con quale oggetto e dove lo colpisce. Anche queste cose sembrano a doppio senso, e
di nessuna di esse si può avere certezza che sia o non sia, né che sia le due cose insieme, né alcuna delle
due. – Ebbene, feci io, sai ciò che ne dovrai fare? Dove meglio le potrai collocare che tra l’essere e il non
essere? Perché non appariranno [d] piú scure di ciò che non è, in quanto non ne superano il grado di non
essere, né piú luminose di ciò che è, in quanto non ne superano il grado di essere. – Verissimo, disse. –
Allora, sembra, abbiamo scoperto che i molti luoghi comuni della maggioranza a proposito della bellezza e di
tutto il resto vagano, in certo modo, nella zona intermedia tra ciò che assolutamente non è e ciò che
assolutamente è. – L’abbiamo scoperto. – Ma prima avevamo convenuto che, se una simile cosa fosse venuta
fuori, bisognava definirla opinabile, ma non conoscibile, perché a coglierla vagante nella zona intermedia è la
facoltà intermedia. – Sí, d’accordo. – Allora, coloro che contemplano la [e] molteplicità delle cose belle, ma
15
non vedono il bello in sé e non sono capaci di seguire chi colà li guidi, e che contemplano la molteplicità delle
cose giuste, ma non il giusto in sé, e cosí via, diremo che su tutto hanno opinioni, senza però conoscere
niente di quello che opinano. – È una conclusione necessaria, disse. – E coloro che contemplano le singole
cose in sé, sempre invariabilmente costanti? Non diremo che conoscono e non opinano? – conclusione
necessaria anche questa. – E non diremo pure che essi fanno festa e amano gli oggetti della conoscenza, e
gli altri [480 a] invece quelli dell’opinione? Non ricordiamo di avere detto che questi ultimi amano e apprezzano
belle voci, bei colori e simili cose, ma non tollerano affatto che il bello in sé sia una cosa reale? – Ce ne
rammentiamo. – Sbaglieremo dunque se li chiameremo amanti d’opinione, cioè filodossi, anziché amanti di
sapienza, cioè filosofi? E se la prenderanno molto con noi se li definiremo cosí? – No, se mi danno retta,
rispose; ché non è lecito prendersela per ciò che è vero. – E quelli che amano ciascuna cosa che è, essa per
se stessa, li dobbiamo chiamare filosofi, ma non filodossi? – Senz’altro. [...]
UN’UTOPIA REALIZZABILE
Il progetto politico di Platone: uno Stato ordinato, governato dai filosofi, nel quale ognuno realizza le sue
inclinazioni naturali, può sembrare incredibile, in termini moderni una utopia. Però, se l’utopia non è un sogno,
ma un progetto, un “ideale” – anche se certamente molto difficile da realizzare –, allora non è impossibile.
Platone credeva nella realizzazione di uno Stato governato secondo le norme della sapienza filosofica, e lo
dimostrò durante tutta la sua vita: fece ripetuti viaggi in Sicilia allo scopo di convincere i tiranni di Siracusa a
mettere in pratica il suo programma politico; ma i risultati, come egli stesso ammette nella Settima Lettera,
furono fallimentari.
Repubblica, 502 a-c
[502 a] [...] – Ammettiamo pure, feci io, che essi siano convinti di questo. Ma potrà uno contestare quest’altro
punto, che cioè da re o signori non possano nascere figlioli con naturale disposizione alla filosofia? –
Nessuno, rispose. – E può uno dire che, anche se nati con questa disposizione, devono necessariamente
essere corrotti? Anche noi riconosciamo che è difficile che si salvino, ma c’è chi oserà [b] sostenere che
nell’intero corso del tempo tra tutti non se ne salvi mai nemmeno uno? – E come? – Certo che, continuai, se
ce n’è anche uno solo e dispone di uno stato obbediente, sarà capace di realizzare tutto ciò che ora è
incredibile. – Sí, capace, rispose. – Se, ripresi, un uomo di governo impone quelle leggi e quelle forme di vita
che abbiamo descritte, non è certamente impossibile che i cittadini consentano a osservarle. – No,
assolutamente. – Ma è strano e impossibile che anche per gli altri valgano le norme che valgono per noi? –
Credo di no, [c] disse. – Ebbene, che si tratti di norme ottime, sempre che realizzabili, l’abbiamo dimostrato
esaurientemente, credo, nella discussione di prima. – Sí, in modo esauriente. – Ora, come sembra, possiamo
concludere che le nostre norme legislative sono ottime, se realizzabili; ma difficili a realizzare, per quanto non
impossibili. – Possiamo concludere proprio cosí, rispose.
L’IDEA DI BENE
Platone afferma la necessità di cogliere con il ragionamento l’Idea di Bene, perché essa sta a fondamento
della visione intellettuale della realtà, cosí come il Sole sta a fondamento della visione degli enti sensibili.
Importante il breve riassunto della dottrina delle Idee (507 b-c). Socrate parla in prima persona; i suoi
interlocutori sono Adimanto e Glaucone, fratelli di Platone.
Repubblica, 504 e-508 e
1 [504 e] Non è ridicolo fare di tutto perché cose da poco siano le piú esatte e pure possibile, e giudicare le
maggiori indegne della maggiore esattezza? – Certamente, disse [il concetto è degno]. Ma veniamo a quella
16
che tu dici la massima disciplina e al suo oggetto. Credi che ti si potrà lasciar andare, continuò, senza
chiederti che cosa è? – No certamente, feci io, ma chiedilo pure. Comunque ne hai sentito parlare non di rado:
adesso o non ci rifletti oppure mediti di crearmi delle [505 a] noie con le tue obiezioni. E inclino piuttosto a
questa seconda supposizione, poiché hai sentito dire spesso che oggetto della massima disciplina è l’idea del
bene; è da essa che le cose giuste e le altre traggono la loro utilità e il loro vantaggio. E pressappoco tu sai
ora che voglio dire questo, e inoltre che di essa non abbiamo una conoscenza adeguata; ma se non ne
abbiamo conoscenza, anche ammesso che conoscessimo perfettissimamente tutto il resto senza di questa,
vedi bene che non ne ritrarremmo alcun giovamento, come non lo ritrarremmo se possedessimo una cosa
senza il bene. [b] Credi che ci sia vantaggio a possedere una qualunque cosa, se non è buona? o a intendere
tutto ad eccezione del bene, senza intendere per nulla il bello e il bene? – Per Zeus!, rispose, io no.
2 D’altra parte tu sai anche che per i piú il bene è piacere, ma per i piú raffinati è intelligenza. – Come no? –
E che, mio caro, coloro che pensano cosí, non possono spiegare che cosa sia l’intelligenza, ma sono costretti
infine a dichiarare che è quella del bene. – Ed è molto ridicolo!, rispose. – Come non può esserlo, feci [c] io,
se, mentre ci rimproverano di non conoscere il bene, ce ne parlano come se lo conoscessimo? Dichiarano che
è intelligenza del bene, come se noi comprendessimo ciò che intendono dire quando pronunciano il nome del
“bene”. – Verissimo, rispose. – E coloro che definiscono bene il piacere? Forse che sbagliano meno degli
altri? Non sono costretti anche loro a riconoscere che esistono piaceri cattivi? – Sicuro. – Si trovano dunque a
riconoscere, credo, che le identiche cose sono buone e cattive. Non è [d] vero? – Indubbiamente. – E qui non
sorgono evidentemente grandi e numerose dispute? – E come no? – Ancora: non è pure evidente che,
trattandosi di cose giuste e belle che sono soltanto apparenza senza essere effettivamente tali, molti tuttavia
sceglierebbero di farle, di possederle e di far credere di possederle? mentre, se si tratta di beni, nessuno si
contenta piú di ottenere i beni apparenti, ma cerca quelli effettivi? e che, in questo àmbito, ognuno non esita a
sprezzare l’apparenza? – Certo, rispose. – Ora, l’oggetto che ogni anima persegue e che pone come mèta di
tutte le sue azioni, indovinandone [e] l’importanza, ma sempre incerta e incapace di coglierne pienamente
l’essenza e di averne una salda fede come ha negli altri oggetti, onde perde anche l’eventuale vantaggio [506
a] di questi, dobbiamo dire che un tale oggetto, tanto importante, deve rimanere ugualmente ignorato anche
da quelle eminenti personalità dello stato alle quali rimetteremo ogni cosa? – No, affatto, rispose. – Credo
però, continuai, che per le cose giuste e belle, se si ignora in che relazione siano con il bene, sarebbe un
guardiano ben scarso chi ignorasse tale relazione. E profetizzo che prima di conoscere questa relazione
nessuno le conoscerà bene. – Giusta profezia, rispose. – Godrà dunque [b] di un ordine perfetto la nostra
costituzione, se le sovrintende un simile guardiano, che abbia queste conoscenze?
3 Per forza, rispose. Ma tu ora, Socrate, dici che il bene sia scienza o piacere o qualcosa di diverso? – Oh!,
caro il mio uomo, replicai, lo sapevo bene, ed era palese da tempo che non ti avrebbe soddisfatto l’opinione
degli altri a questo proposito. – Non mi sembra giusto, Socrate, disse, che uno che da tanto tempo si occupa
di questi argomenti sappia riportare le opinioni altrui e la [c] propria no. – E ti sembra giusto, feci io, che uno
parli delle cose che non sa come se le sapesse? – Come se le sapesse, rispose, no, affatto. È giusto però
voler parlare da uomo veramente convinto della sua opinione. – E non ti sei accorto, continuai, che le opinioni
non accompagnate dalla scienza sono tutte brutte? Di esse le migliori sono cieche. Ti sembra che coloro che
hanno una vera opinione su qualcosa, ma sono sprovvisti di intelletto, presentino qualche differenza da ciechi
che camminano dritto per una strada? – Nessuna differenza, rispose. Vuoi dunque contemplare cose brutte,
cieche e storte, quando ti è possibile sentirne da altri di splendide e belle? – No, per Zeus!, Socrate, fece
Glaucone, non ritirarti come se fossi alla fine. Noi ci sentiremo soddisfatti se tratterai del bene allo stesso
modo con cui hai trattato della giustizia, della temperanza e delle altre virtú. – Anch'io, risposi, mio caro amico,
ne sarò molto soddisfatto, ma temo che non ci riuscirò e che, pur mettendocela tutta, farò una brutta figura e
mi esporrò allo scherno. Su, benedetti [e] amici, lasciamo stare per il momento che cosa sia mai il bene in sé:
mi sembra una cosa troppo alta perché possiamo raggiungere ora, con lo slancio presente, il concetto che ne
ho io. Invece voglio dire, se ne siete contenti pure voi, quello che sembra la prole del bene, cui molto somiglia.
17
Se però non ne siete contenti, lasciamolo perdere. – Su, dillo!, fece. Pagherai il tuo debito un'altra volta, [507
a] spiegandoci che cosa è il padre. - Vorrei poter pagarvelo, risposi, e che voi poteste riscuoterlo tutto,
anziché, come adesso, i soli frutti. Prendetevi dunque questo frutto e la prole del bene in sé. State però attenti
che, senza volere, in qualche modo non vi imbrogli, rendendovi falsificato il computo del frutto. - Staremo
attenti, rispose, come potremo. Ma tu limitati a parlare. - Lo farò, dissi, soltanto quando mi sarò messo
d'accordo con voi e vi avrò fatto ricordare quello che s'è detto prima e quello che già s'è detto piú volte in altre
occasioni. - Che cosa?, [b] chiese. – Noi affermiamo che ci sono molte cose belle, e belle le definiamo col
nostro discorso; e diciamo che ci sono molte cose buone e cosí via. – Lo affermiamo. – E poi anche che
esistono il bello in sé e il bene in sé; e cosí tutte le cose che allora consideravamo molte, ora invece le
consideriamo ciascuna in rapporto a una idea, che diciamo una, e ciascuna chiamiamo “ciò che è”. – È cosí. –
E diciamo che quelle molte cose si vedono, ma non si colgono con l’intelletto, e che le idee invece si colgono
con l’intelletto, ma non si vedono. – Senza [c] dubbio. – Ora, qual è in noi l’organo che ci fa vedere le cose
visibili? – La vista, rispose. – E, continuai, non è l’udito che ci fa udire le cose udibili? e non sono gli altri sensi
a farci sentire tutte le cose sensibili? – Sicuramente. – Ora, hai riflettuto, feci io, quanto maggiore pregio
l’artefice dei sensi abbia voluto conferire a quello di vedere e di essere visti? – No proprio, rispose. – Ma
esamina la cosa in questo modo. L’udito e la voce richiedono il concorso di un elemento diverso, il primo per
udire, la seconda per essere udita? – E se questo [d] terzo elemento non è presente, forse che l’uno non udrà
e l’altra non sarà udita? – Non richiedono il concorso di nulla, rispose. – E, credo, feci io, nemmeno molte altre
facoltà, per non dire nessuna, richiedono alcunché di simile. O ne puoi citare qualcuna? – Io no, rispose. – Ma
non pensi che lo richiede la facoltà della vista e del visibile? – Come? – Ammettiamo che negli occhi abbia
sede la vista e che chi la possiede cominci a servirsene, e che in essi si trovi il colore. Ma se non è presente
un terzo elemento, che la natura riserva proprio a questo [e] cómpito, tu ti rendi conto che la vista non vedrà
nulla e che i colori resteranno invisibili. – Qual è questo elemento di cui parli? – Quello, risposi, che tu chiami
luce. – Dici la verità, ammise. – Di una specie non insignificante sono dunque il senso della vista e la facoltà
[508 a] di essere veduti, se sono stati congiunti con un legame piú prezioso di quello che tiene insieme le altre
combinazioni, a meno che non sia cosa spregevole la luce. – Spregevole?, disse. Tutt’altro!
4 – A quale dunque tra gli dèi del cielo puoi attribuire questo potere? un dio la cui luce permette alla nostra
vista di vedere nel miglior modo e alle cose visibili di farsi vedere? – Quello, rispose, che tu e gli altri
riconoscete: è chiaro che la tua domanda si riferisce al sole. – Ora, il rapporto tra la vista e questo dio non è
per natura cosí? – Come? – La vista, né come facoltà in se stessa né come organo in cui ha sede e che
chiamiamo [b] occhio, non è il sole. – No, certamente, – Eppure, a mio parere, tra gli organi dei sensi è quello
che piú ricorda nell’aspetto il sole. – Sí, certo. – E la facoltà di cui dispone non l’ha perché dispensata dal sole,
come un fluido che filtra in essa? – Senza dubbio. – E non è vero anche che il sole non è la vista, ma,
essendone causa, è da essa stessa veduto? – È cosí, ammise. – Puoi dir dunque, feci io, che io chiamo il sole
prole [c] del bene, generato dal bene a propria immagine. Ciò che nel mondo intelligibile il bene è rispetto
all’intelletto e agli oggetti intelligibili, nel mondo visibile è il sole rispetto alla vista e agli oggetti visibili. –
Come?, fece, ripetimelo. – Non sai, ripresi, che gli occhi, quando uno non li volge piú agli oggetti rischiarati nei
loro colori dalla luce diurna, ma a quelli rischiarati dai lumi notturni, si offuscano e sembrano quasi ciechi,
come se non fosse nitida in loro la vista? – Certamente, rispose. – Ma [d] quando, credo, uno li volge agli
oggetti illuminati dal sole, vedono distintamente e la vista, che ha sede in questi occhi medesimi, appare
nitida. – Sicuro! – Allo stesso modo considera anche il caso dell’anima, cosí come ti dico. Quando essa si
fissa saldamente su ciò che è illuminato dalla verità e dall’essere, ecco che lo coglie e lo conosce, ed è
evidente la sua intelligenza; quando invece si fissa su ciò che è misto di tenebra e che nasce e perisce, allora
essa non ha che opinioni e s’offusca, rivolta in sú e in giú, mutandole, le sue opinioni e rassomiglia a persona
senza intelletto. – Le somiglia proprio. – Ora, [e] questo elemento che agli oggetti conosciuti conferisce la
verità e a chi conosce dà la facoltà di conoscere, di’ pure che è l’idea del bene; e devi pensarla causa della
scienza e della verità, in quanto conosciute.
18
QUATTRO GRADI DELLA CONOSCENZA
In questo passo del sesto libro della Repubblica Platone sottolinea la distinzione fra il mondo visibile e quello
intelligibile, all’interno dei quali si procede a una ulteriore distinzione fra gli enti (sensibili e intelligibili) e la loro
immagine. La separazione fra mondo dei sensi e mondo dell’intelletto non esclude una forma di
comunicazione tra le due realtà, quella comunicazione garantita dalla dialettica della partecipazione. Cosí,
anche sul piano della conoscenza è possibile individuare una forma di continuità: il segmento proposto da
Platone è sí diviso in quattro, ma rimane uno. Al livello piú basso sta l’immaginazione (eikasía), cui segue la
credenza (pístis). A livello intelligibile troviamo la conoscenza matematica (diánoia) e la filosofia (nóesis). La
diánoia si viene a trovare in una “zona intermedia” fra la nóesis e la dóxa. La conoscenza filosofica (nóesis),
una volta raggiunta, non ha piú bisogno di “punti di appoggio”: essa è completamente autonoma nel procedere
dialettico, in un movimento che va dalle Idee alle Idee. Socrate ha qui come interlocutore Glaucone.
Repubblica, 509d-511e
1 [509 d] – Ebbene, ripresi, immagina che, come stiamo dicendo, siano essi due princípi, e che reggano
uno il genere e il mondo intelligibile, l’altro quello visibile. Mi esprimo cosí perché dicendo “mondo celeste” non
ti día l’impressione di sofisticare sul nome. ti rendi conto di queste due specie, visibile e intelligibile? – Me ne
rendo conto. – Supponi ora di prendere una linea bisecata in segmenti ineguali e, mantenendo costante il
rapporto, dividi a sua volta ciascuno dei due segmenti, quello che rappresenta il genere visibile e quello che
rappresenta il genere intelligibile; e, secondo la rispettiva chiarezza e oscurità, tu avrai, [e] nel mondo visibile,
un primo segmento, le immagini. Intendo per immagini in primo luogo le ombre, poi i [510 a] riflessi nell’acqua
e in tutti gli oggetti formati da materia compatta, liscia e lucida, e ogni fenomeno simile, se comprendi. – Certo
che comprendo. – Considera ora il secondo, cui il primo somiglia: gli animali che ci circondano, ogni sorta di
piante e tutti gli oggetti artificiali. – Lo considero, rispose. – Non vorrai ammettere, feci io, che il genere visibile
è diviso secondo verità, ossia che l’oggetto simile sta al suo modello come l’opinabile [b] sta al conoscibile? –
Io sí, disse, certamente. – Esamina poi anche in quale maniera si deve dividere la sezione dell’intelligibile. –
Come? – Ecco: l’anima è costretta a cercarne la prima parte ricorrendo, come a immagini, a quelle che nel
caso precedente erano le cose imitate; e partendo da ipotesi, procedendo non verso un principio, ma verso
una conclusione. Quanto alla seconda parte, quella che mette capo a un principio non ipotetico, è costretta a
cercarla movendo dall’ipotesi e conducendo questa sua ricerca senza le immagini cui ricorreva in quell’altro
caso, con le sole idee e per mezzo loro. – Non ho ben compreso, rispose, queste tue parole. – Ebbene, [c]
ripresi, torniamoci sopra: comprenderai piú facilmente quando si sarà fatta questa premessa. Tu sai, credo,
che coloro che si occupano di geometria, di calcoli e di simili studi, ammettono in via d’ipotesi il pari e il dispari,
le figure, tre specie di angoli e altre cose analoghe a queste, secondo il loro particolare campo d’indagine; e,
come se ne avessero piena coscienza, le riducono a ipotesi e pensano che non meriti piú renderne conto né a
se stessi né ad [d] altri, come cose a ognuno evidenti. E partendo da queste, eccoli svolgere i restanti punti
dell’argomentazione e finire, in piena coerenza, a quel risultato che si erano mossi a cercare. – Senza dubbio,
rispose, questo lo so bene. – E quindi sai pure che essi si servono e discorrono di figure visibili, ma non
pensando a queste, sí invece a quelle di cui queste sono copia: discorrono del quadrato in sé e della
diagonale in sé, ma non di quella che tracciano, e [e] cosí via; e di quelle stesse figure che modellano e
tracciano, figure che danno luogo a ombre e riflessi in acqua, si servono a loro volta come di immagini, per
cercar di [511 a] vedere quelle cose in sé che non si possono vedere se non con il pensiero, dianoeticamente.
– È vero quello che dici, rispose.
2 – Ecco dunque che cosa intendevo per specie intelligibile, e dicevo che, ricercandola, l’anima è costretta
a ricorrere a ipotesi, senza arrivare al principio, perché non può trascendere le ipotesi; essa si serve, come
d’immagini, di quegli oggetti stessi di cui quelli della classe inferiore sono copie e che in confronto a questi
ultimi sono ritenuti e stimati evidenti realtà. – Comprendo, disse, che ti [b] riferisci al mondo della geometria e
delle arti che le sono sorelle. – Allora comprendi che per secondo segmento dell’intelligibile io intendo quello
cui il discorso attinge con il potere dialettico, considerando le ipotesi non princípi, ma ipotesi nel senso reale
19
della parola, punti di appoggio e di slancio per arrivare a ciò che è immune da ipotesi, al principio del tutto; e,
dopo averlo raggiunto, ripiegare attenendosi rigorosamente alle conseguenze che ne derivano, e cosí
discendere alla conclusione senza [c] assolutamente ricorrere a niente di sensibile, ma alle sole idee,
mediante le idee passando alle idee; e nelle idee termina tutto il processo. – Comprendo, rispose, ma non
abbastanza. Mi sembra che tu parli di una operazione complessa. Comprendo però il tuo desiderio di
precisare che quella parte dell’essere e dell’intelligibile che è contemplata dalla scienza dialettica è piú chiara
di quella contemplata dalle cosiddette arti, per le quali le ipotesi sono princípi; e coloro che osservano gli
oggetti delle arti sono costretti, sí, a osservarli con il pensiero senza ricorrere ai sensi, ma [d] poiché li
esaminano senza risalire al principio, bensí per via d’ipotesi, a te sembrano incapaci d’intenderli, anche se
questi oggetti sono intelligibili con un principio. E, a mio avviso, tu chiami pensiero dianoetico, ma non
intelletto, la condizione degli studiosi di geometria e di simili dotti, come se il pensiero dianoetico venisse a
essere qualcosa di intermedio tra l’opinione e l’intelletto. – Hai capito benissimo, feci io. Ora applicami ai
quattro segmenti questi quattro processi che si svolgono nell’anima: applica [e] l’intellezione al piú alto, il
pensiero dianoetico al secondo, al terzo assegna la credenza e all’ultimo l’immaginazione; e ordinali
proporzionalmente, ritenendo che essi abbiano tanta chiarezza quanta è la verità posseduta dai loro rispettivi
oggetti. – Comprendo, rispose, sono d’accordo e li ordino come dici.
IL MITO DELLA CAVERNA
All’inizio del settimo libro della Repubblica Platone narra il mito della caverna, uno dei piú famosi ed
affascinanti. In esso si ritrova – espressa nel linguaggio accessibile del mito – tutta la teoria platonica della
conoscenza, ma anche si ribadisce il rapporto tra filosofia e impegno di vita: conoscere il Bene significa anche
praticarlo; il filosofo che ha contemplato la Verità del Mondo delle Idee non può chiudersi nella sua torre
d’avorio: deve tornare – a rischio della propria vita – fra gli uomini, per liberarli dalle catene della conoscenza
illusoria del mondo sensibile. Proponiamo la lettura di queste pagine senza ulteriori osservazioni e commenti,
convinti che lo scritto platonico non li richieda. Socrate parla in prima persona; il suo interlocutore è Glaucone.
Repubblica, 514 a-517 a
1 [514 a] – In séguito, continuai, paragona la nostra natura, per ciò che riguarda educazione e mancanza di
educazione, a un’immagine come questa. Dentro una dimora sotterranea a forma di caverna, con l’entrata
aperta alla luce e ampia quanto tutta la larghezza della caverna, pensa di vedere degli uomini che vi stiano
dentro fin da fanciulli, incatenati gambe e collo, sí da dover restare fermi e da [b] poter vedere soltanto in
avanti, incapaci, a causa della catena, di volgere attorno il capo. Alta e lontana brilli alle loro spalle la luce d’un
fuoco e tra il fuoco e i prigionieri corra rialzata una strada. Lungo questa pensa di vedere costruito un
muricciolo, come quegli schermi che i burattinai pongono davanti alle persone per mostrare al di sopra di essi i
burattini. – Vedo, rispose. – Immagina di vedere uomini che portano lungo il muricciolo oggetti [c] di ogni sorta
sporgenti dal margine, e statue e altre [515 a] figure di pietra e di legno, in qualunque modo lavorate; e, come
è naturale, alcuni portatori parlano, altri tacciono. – Strana immagine è la tua, disse, e strani sono quei
prigionieri. – Somigliano a noi, risposi; credi che tali persone possano vedere, anzitutto di sé e dei compagni,
altro se non le ombre proiettate dal fuoco sulla parete della caverna che sta loro di fronte? – E come possono,
replicò, se sono costretti a tenere immobile il [b] capo per tutta la vita? – E per gli oggetti trasportati non è lo
stesso? – Sicuramente. – Se quei prigionieri potessero conversare tra loro, non credi che penserebbero di
chiamare oggetti reali le loro visioni? – Per forza. – E se la prigione avesse pure un’eco dalla parete di fronte?
Ogni volta che uno dei passanti facesse sentire la sua voce, credi che la giudicherebbero diversa da quella
dell’ombra che passa? – Io no, per Zeus!, [c] rispose. – Per tali persone insomma, feci io, la verità non può
essere altro che le ombre degli oggetti artificiali. – Per forza, ammise. – Esamina ora, ripresi, come potrebbero
sciogliersi dalle catene e guarire dall’incoscienza. Ammetti che capitasse loro naturalmente un caso come
questo: che uno fosse sciolto, costretto improvvisamente ad alzarsi, a girare attorno il capo, a camminare e
20
levare lo sguardo alla luce; e che cosí facendo provasse dolore e il barbaglio lo rendesse incapace di [d]
scorgere quegli oggetti di cui prima vedeva le ombre. Che cosa credi che risponderebbe, se gli si dicesse che
prima vedeva vacuità prive di senso, ma che ora, essendo piú vicino a ciò che è ed essendo rivolto verso
oggetti aventi piú essere, può vedere meglio? e se, mostrandogli anche ciascuno degli oggetti che passano,
gli si domandasse e lo si costringesse a rispondere che cosa è? Non credi che rimarrebbe dubbioso e
giudicherebbe piú vere le cose che vedeva prima di quelle che gli fossero mostrate adesso? – Certo, rispose.
2 [e] – E se lo si costringesse a guardare la luce stessa, non sentirebbe male agli occhi e non fuggirebbe
volgendosi verso gli oggetti di cui può sostenere la vista? e non li giudicherebbe realmente piú chiari di quelli
che gli fossero mostrati? – È cosí, rispose. – Se poi, continuai, lo si trascinasse via di lí a forza, su per l’ascesa
scabra ed erta, e non lo si lasciasse prima di averlo tratto alla luce del sole, non ne soffrirebbe e non
s’irriterebbe [516 a] di essere trascinato? E, giunto alla luce, essendo i suoi occhi abbagliati, non potrebbe
vedere nemmeno una delle cose che ora sono dette vere. – Non potrebbe, certo, rispose, almeno
all’improvviso. – Dovrebbe, credo, abituarvisi, se vuole vedere il mondo superiore. E prima osserverà, molto
facilmente, le ombre e poi le immagini degli esseri umani e degli altri oggetti nei loro riflessi nell’acqua, e infine
gli oggetti stessi; da questi poi, volgendo lo sguardo alla luce delle stelle e della luna, [b] potrà contemplare di
notte i corpi celesti e il cielo stesso piú facilmente che durante il giorno il sole e la luce del sole. – Come no? –
Alla fine, credo, potrà osservare e contemplare quale è veramente il sole, non le sue immagini nelle acque o
su altra superficie, ma il sole in se stesso, nella regione che gli è propria. – Per forza, disse. – Dopo di che,
parlando del sole, potrebbe già concludere che è esso a produrre le stagioni e gli anni e a governare tutte le
cose del mondo visibile, e ad essere [c] causa, in certo modo, di tutto quello che egli e i suoi compagni
vedevano. – È chiaro, rispose, che con simili esperienze concluderà cosí. – E ricordandosi della sua prima
dimora e della sapienza che aveva colà e di quei suoi compagni di prigionia, non credi che si sentirebbe felice
del mutamento e proverebbe pietà per loro? – Certo. – Quanto agli onori ed elogi che eventualmente si
scambiavano allora, e ai primi riservati a chi fosse piú acuto nell’osservare gli oggetti che passavano e piú [d]
rammentasse quanti ne solevano sfilare prima e poi e insieme, indovinandone perciò il successivo, credi che li
ambirebbe e che invidierebbe quelli che tra i prigionieri avessero onori e potenza? o che si troverebbe nella
condizione detta da Omero e preferirebbe “altrui per salario servir da contadino, uomo sia pur senza
sostanza”, e patire di tutto piuttosto che avere quelle opinioni e vivere in quel modo? – Cosí penso anch’io,
rispose; [e] accetterebbe di patire di tutto piuttosto che vivere in quel modo. – Rifletti ora anche su quest’altro
punto, feci io. Se il nostro uomo ridiscendesse e si rimettesse a sedere sul medesimo sedile, non avrebbe gli
occhi pieni di tenebra, venendo all’improvviso dal sole? – Sí, certo, rispose. – E se dovesse discernere
nuovamente quelle ombre e contendere con coloro che sono rimasti sempre prigionieri, nel periodo in cui ha la
vista offuscata, prima [517 a] che gli occhi tornino allo stato normale? e se questo periodo in cui rifà l’abitudine
fosse piuttosto lungo? Non sarebbe egli allora oggetto di riso? e non si direbbe di lui che dalla sua ascesa
torna con gli occhi rovinati e che non vale neppure la pena di tentare di andar su? E chi prendesse a sciogliere
e a condurre su quei prigionieri, forse che non l’ucciderebbero, se potessero averlo tra le mani e ammazzarlo?
– Certamente, rispose. [...]
IL GOVERNO DELLO STATO
Nel passo, dedicato al problema del governo dello Stato, sono presenti vere e proprie ingenuità, come la
convinzione che il filosofo non sia per nulla attratto dal fascino del potere, anzi lo eviti tenacemente, per cui lo
si debba costringere ad esercitarlo. La storia della filosofia smentisce questa illusione. E non può che lasciare
stupiti l’idea che tanto meno uno abbia desiderio di governare, tanto piú è probabile che egli sappia farlo
benissimo.
Repubblica, 519e-521b
21
[519 e] – Ti sei dimenticato di nuovo, mio caro, replicai, che alla legge non interessa che una sola classe dello
stato si trovi in una condizione particolarmente favorevole. Essa cerca di realizzare questo risultato nello stato
tutto: armonizza tra loro i cittadini persuadendoli e [520 a] costringendoli, fa che si scambino i vantaggi che i
singoli sappiano procurare alla comunità; e creando nello stato simili individui, la legge stessa non lo fa per
lasciarli volgere dove ciascuno voglia, ma per valersene essa stessa a cementare la compattezza dello stato.
– È vero, rispose; me ne sono dimenticato. – Considera poi, Glaucone, continuai, che non faremo torto
nemmeno a quelli che nel nostro stato nascono filosofi; ma che saranno giuste le cose che loro diremo
costringendoli a curare e custodire gli altri. [b] Parleremo cosí: coloro che nascono filosofi negli altri stati, è
naturale che non partecipino alle fatiche politiche, perché sorgono spontanei, indipendentemente dalla
costituzione dei singoli stati; e ciò che è spontaneo, non dovendo il nutrimento ad alcuno, è giusto che non si
senta spinto a pagare ad alcuno le spese. Voi però, vi abbiamo generato per voi stessi e per il resto dello
stato, come negli sciami i capi e i re; avete avuto educazione migliore e piú perfetta [c] che non quegli altri
filosofi, e maggiore attitudine a svolgere ambedue le attività. Ciascuno deve dunque, a turno, discendere nella
dimora comune agli altri e abituarsi a contemplare quegli oggetti tenebrosi. Abituandovi, vedrete infinitamente
meglio di quelli laggiú e conoscerete quali siano le singole visioni, e quali i loro oggetti, perché avrete veduto
la verità sul bello, sul giusto e sul bene. E cosí per noi e per voi l’amministrazione dello stato sarà una realtà,
non un sogno, come invece oggi avviene nella maggioranza degli stati, amministrati da persone che si battono
fra loro per ombre e si disputano il potere, come se fosse [d] un grande bene. La verità è questa: lo stato in cui
chi deve governare non ne ha il minimo desiderio, è per forza amministrato benissimo, senza la piú piccola
discordia, ma quello in cui i governanti sono di tipo opposto, è amministrato in modo opposto. – Senza dubbio,
rispose. – Ebbene, credi che, udendo questi discorsi, i nostri pupilli ci disobbediranno e vorranno non
collaborare alle fatiche politiche, ciascuno a turno, e abitare la maggior parte del tempo in reciproca
compagnia nel mondo puro? [e] – È impossibile, disse; perché a persone giuste come sono essi,
prescriveremo cose giuste. La cosa piú importante di tutte è che ciascuno di essi va al governo per obbligo,
mentre chi governa oggidí nei singoli stati si comporta in modo opposto. – E cosí, amico, dissi; se per [521 a]
chi dovrà governare troverai un modo di vita migliore del governare, ottima potrà essere l’amministrazione del
tuo stato, perché sarà il solo in cui governeranno le persone realmente ricche, non di oro, ma di quella
ricchezza che rende l’uomo felice, la vita onesta e fondata sull’intelligenza. Se invece vanno al potere dei
pezzenti, avidi di beni personali e convinti di dover ricavare il loro bene di lí, dal governo, non è possibile una
buona amministrazione: perché il governo è oggetto di contesa e una simile guerra civile e intestina rovina con
loro tutto il resto dello stato. – Verissimo, rispose. – Conosci dunque, ripresi, [b] qualche altro modo di vita che
spregi le cariche pubbliche e non sia quello del vero filosofo? – No, per Zeus!, rispose. – D’altra parte, al
governo devono andare persone che non amino governare. Altrimenti la loro rivalità sfocerà in contesa. –
Come no? – Chi dunque costringerai ad assumersi la guardia dello stato se non coloro che meglio conoscono
quali sono i modi per la migliore amministrazione di uno stato, e che possono avere altri onori e una vita
migliore di quella politica? – Nessun altro, rispose.
L’EDUCAZIONE
Per capire il ruolo che ciascun cittadino deve svolgere all’interno della società occorre ricevere una
educazione che faccia risaltare la naturale predisposizione di ciascuno. All’educazione è dedicato il settimo
libro della Repubblica: Platone presenta un piano di studi piuttosto accurato, uno dei piú importanti e discussi
esempi di paideía greca. Di esso riportiamo la parte finale, dedicata all’insegnamento della dialettica a coloro
che sono destinati a diventare filosofi e a governare gli stati. Socrate parla in prima persona; il suo
interlocutore è Glaucone.
Repubblica, 538 d-541 b
1
[538 d] – Supponiamo ora, feci io, di andar a chiedere a una persona cosí educata che cosa è il bello e
22
che essa dia la risposta che ha sentito dal legislatore; e che la si critichi e piú volte e in piú modi si rinnovi la
critica e che si riesca a trascinare quella persona a pensare che quel bello è indifferentemente bello [e] o
brutto (e cosí per il giusto, per il bene e per i valori da lei particolarmente apprezzati). Come credi che essa si
comporterà poi per quanto concerne il rispetto e l’obbedienza a questi valori? – È inevitabile, disse, che non li
rispetterà né seguirà piú come prima. – Ebbene, ripresi, quando non li giudichi piú degni di rispetto e
confacenti a sé come prima e non riesca a trovare i valori [539 a] veri, quale altra condotta di vita potrà essa
naturalmente assumere se non quella di un adulatore? – Non avrà altra possibilità, rispose. – Allora, credo, da
rispettosa della legge ne sembrerà divenuta nemica. – Per forza. – Ora, continuai, non è naturale che cosí si
venga a trovare chi affronta in questo modo la dialettica? e, come dicevo poco fa, non merita grande
indulgenza? – Anzi compassione, disse. – E perché questa compassione non circondi i tuoi trentenni, non si
dovrà affrontare la dialettica con ogni cautela possibile? – Certamente, rispose. [b] – E non è già una notevole
cautela non farla gustare loro da giovani? Credo non ti sia ignoto che i giovincelli, non appena assaporano la
dialettica, se ne servono come per gioco, usandola sempre per contraddire; e, imitando chi li confuta,
confutano poi essi stessi altre persone e si divertono come cuccioli a tirare e a dilaniare con il discorso chi via
via venga loro a tiro. – Sí, si divertono straordinariamente, rispose. – E quando hanno essi stessi confutato
molti e da molti sono stati confutati, [c] eccoli precipitarsi, impetuosi e rapidi, a rinnegare tutto quello che
credevano prima. Ecco perché di fronte agli altri sono screditati essi stessi e coinvolgono nello scredito l’intero
mondo della filosofia. – Verissimo, disse. – Una persona piú matura, ripresi, non potrà dunque consentire a
partecipare a una simile follía; ma preferirà imitare chi vuole coltivare la dialettica e cercare il vero anziché chi
scherza e contraddice per gioco; e sarà, essa [d] stessa, piú moderata, e farà rispettare di piú la sua
occupazione anziché farla spregiare. – Giusto, rispose. – Ora, anche tutto ciò che s’è detto prima non è
dovuto a cautela? Cioè che coloro che si faranno partecipare alla dialettica devono avere natura ordinata e
ferma; e che non le si deve accostare, come avviene ora, il primo che càpita, per di piú senza la minima
disposizione. – Indubbiamente, rispose.
2 – Ora, è forse sufficiente praticare la dialettica, assiduamente e intensamente senza altre attività, ma
esercitandovisi in maniera corrispettiva agli esercizi del corpo, per il doppio di anni che in quelli? – Intendi dire
sei [e] o quattro anni?, chiese. – Non ha importanza, risposi, poni che siano cinque. Piú tardi i tuoi giovani
dovranno ridiscendere in quella caverna ed essere forzati ad assumere i comandi bellici e tutte le cariche
pubbliche che toccano a persone giovani, affinché non restino inferiori agli altri nemmeno per l’esperienza. E
anche in queste [540 a] congiunture si dovranno ancora saggiare, per vedere se, pur subendo pressioni da
ogni parte, rimarranno fermi, o se ne saranno turbati anche solo un poco. – E questo periodo, chiese, quanto
lo fai durare? – Quindici anni, risposi. Poi, quando hanno raggiunto i cinquant’anni, quelli che ne siano usciti
sani e salvi e si siano dimostrati dovunque e in ogni modo primi, nelle varie opere e scienze, si devono ormai
guidare alla mèta ultima: verranno costretti a volgere in su il raggio dell’anima e a guardare a ciò che a ogni
cosa dà luce; e dopo aver veduto il bene in sé, a usarlo come un modello e a ordinare, ciascuno a turno, per il
resto della vita, lo stato e i privati [b] cittadini e se stessi; e passeranno la maggior parte del tempo immersi
nella filosofia, ma, quando venga il loro turno, dovranno affrontare le noie della vita politica e governare
ciascuno per il bene dello stato, non perché sia bello questo loro compito, ma necessario. E cosí, avendo via
via educato altri a propria somiglianza e avendoli lasciati al loro proprio posto come guardiani dello stato,
andranno ad abitare nelle isole dei beati; e lo stato dovrà [c] fare loro monumenti e sacrifici a pubbliche spese,
come a dèmoni, se è d’accordo anche la Pizia; e se non lo è, come a persone felici e divine. – Sono
veramente splendidi, Socrate, disse, questi governanti che hai foggiati, come uno scultore. – E anche le donne
di governo, Glaucone, replicai. Devi pensare che le mie parole si riferiscono tanto agli uomini quanto alle
donne, tutte quelle che nascono naturalmente adatte. – Giusto, rispose, se, come abbiamo detto, avranno
ogni cosa eguale e in comune [d] con gli uomini. – Ebbene?, continuai; siete d’accordo che non sono affatto
utopie quelle che abbiamo dette sullo stato e sulla costituzione? Sono, sí, cose difficili, ma in qualche modo
possibili (e possibili solo come s’è detto), quando entro lo stato divengano signori, uno o piú d’uno, i veri
filosofi e disprezzino gli onori in voga oggidí, giudicandoli banali e di nessun conto; e apprezzino moltissimo la
dirittura morale e gli onori che le [e] conseguono, considerando la giustizia come la cosa piú importante e
23
indispensabile; e servendola e accrescendola organizzino ordinatamente il loro stato. – In che modo?, chiese.
– Manderanno via, risposi, in campagna, tutti [541 a] i cittadini che abbiano compiuto i dieci anni; ne
prenderanno i figlioli sottraendoli all’influsso degli odierni costumi, che sono pure quelli dei genitori, e li
alleveranno secondo i loro modi e leggi, che sono quelli da noi esposti prima. Non siete d’accordo che cosí
molto rapidamente e facilmente s’instaureranno lo stato e la costituzione che dicevamo? e che sarà uno stato
felice e offrirà i maggiori vantaggi alla popolazione entro cui sorga? – Certo, [b] rispose. E credo che tu,
Socrate, abbia detto bene come sorgerebbe, se mai potesse sorgere. – Ora, continuai, non abbiamo già detto
abbastanza di questo stato e dell’individuo che gli somiglia? Anche per costui è chiaro quali doti gli dovremo
attribuire. – È chiaro, rispose; e, come dici con la tua domanda, l’argomento mi sembra esaurito.
LA CRITICA DELL’ARTE
In nome della “teoria delle Idee” l’arte subisce una condanna inappellabile: essa non ha diritto ad alcuna
libertà o autonomia. Socrate parla in prima persona; il suo interlocutore è Glaucone.
Repubblica, 597 a-598 d
[597 a] – E il fabbricante di letti? Non dicevi poco fa che non costruisce la specie in cui diciamo consistere “ciò
che è” letto, ma costruisce un determinato letto? – Lo dicevo, sí. – Se dunque non fa “quello che è” letto, non
farà ciò che è, ma un oggetto che è esattamente come ciò che è, ma che non è. E chi asserisse che l’opera
del costruttore di letti o di un altro operaio è cosa perfettamente reale, non rischierebbe di dire cose non vere?
– Non vere, certamente, rispose; cosí almeno potrà credere chi si occupa di simili argomenti. – Allora non
meravigliamoci affatto se anche questa opera è, rispetto [b] alla verità, qualcosa di vago. – No, certo. –
Ebbene, ripresi, vuoi che, servendoci di questi medesimi esempi, ricerchiamo chi mai è questo imitatore? – Se
vuoi ..., disse. – Questi nostri letti si presentano sotto tre specie. Uno è quello che è nella natura: potremmo
dirlo, credo, creato dal dio. O da qualcun altro? – Da nessun altro, credo. – Uno poi è quello costruito dal
falegname. – Sí, disse. – E uno quello foggiato dal pittore. Non è vero? – Va bene. – Ora, pittore, costruttore di
letti, dio sono tre e sovrintendono a tre specie di letti. – Sí, tre. – Ebbene, il dio, sia che non l’abbia voluto [c]
sia che qualche necessità l’abbia costretto a non creare nella natura piú di un solo e unico letto, si è limitato
comunque a fare, in unico esemplare, quel letto in sé, ossia “ciò che è” letto. Ma due o piú letti di tal genere il
dio non li ha prodotti, e non c’è pericolo che li produca mai. – Come?, chiese. – Perché, ripresi, se ne facesse
anche due soli, ne riapparirebbe uno di cui ambedue quelli, a loro volta, ripeterebbero la specie. E “ciò che è”
letto sarebbe quest’ultimo, anziché quei due. – Giusto, [d] rispose. – Conscio di questo, credo, il dio ha voluto
essere realmente autore di un letto che realmente è, non di un letto qualsiasi; né ha voluto essere un
qualunque fabbricante di letti. E perciò ha prodotto un letto che fosse unico in natura. – Può darsi. – Vuoi
dunque che lo chiamiamo naturale creatore di questa cosa, o con un titolo consimile? – È proprio giusto,
rispose; perché sia questa sia tutto il resto l’ha fatto in natura. – E il falegname? Non dobbiamo chiamarlo
artigiano del letto? – Sí. – E anche il pittore artigiano e autore di questo oggetto? – No, assolutamente. – Ma
come lo definirai rispetto al letto? – Secondo me, disse, [e] l’appellativo che piú gli si addice potrebbe essere
“imitatore dell’oggetto di cui quegli altri sono artigiani”. – Bene, risposi. Allora chiami tu imitatore chi è artefice
della terza generazione di cose a partire dalla natura? – Senza dubbio, rispose. – Tale sarà dunque anche
l’autore tragico, se è vero che è un imitatore. Per natura egli è terzo a partire dal re e dalla verità. E tali
saranno tutti gli altri imitatori. – Può essere. – Eccoci dunque d’accordo sull’imitatore. Ora veniamo al pittore.
Dimmi: ti [598 a] sembra che egli cerchi di imitare il singolo oggetto in sé che è nella natura, oppure le opere
degli artigiani? – Le opere degli artigiani, rispose. – Quali sono o quali appaiono? Fa ancora questa
distinzione. – Come dici?, chiese. – Cosí: un letto, che tu lo guardi di lato o di fronte o in un modo qualsiasi,
differisce forse da se stesso? O non c’è nessuna differenza, anche se appare diverso? E analogamente gli
altri oggetti? – È cosí, rispose; appare diverso, ma non c’è alcuna differenza. [b] – Esamina ora quest’altro
24
punto. A quale di questi due fini è conformata l’arte pittorica per ciascun oggetto? A imitare ciò che è cosí
come è, o a imitare ciò che appare cosí come appare? È imitazione di apparenza o di verità? – Di apparenza,
rispose. – Allora l’arte imitativa è lungi dal vero e, come sembra, per questo eseguisce ogni cosa, per il fatto di
cogliere una piccola parte di ciascun oggetto, una parte che è una copia. Per esempio, il pittore, diciamo, ci
dipingerà un calzolaio, un falegname, gli altri [c] artigiani senza intendersi di alcuna delle loro arti. Tuttavia, se
fosse un buon pittore, dipingendo un falegname e facendolo vedere da lontano, potrebbe turlupinare bambini
e gente sciocca, illudendoli che si tratti di un vero falegname. – Perché no? – Ma, mio caro, di tutti costoro si
deve, credo, pensare cosí. Quando, a proposito di un certo individuo, uno venga ad annunziarci di avere
incontrato un uomo che conosce tutti i mestieri e ogni altra nozione propria dei singoli specialisti, e tutto
conosce piú [d] esattamente di chiunque altro, a tale persona dovremo replicare che è un sempliciotto e che
con ogni probabilità ha incontrato un ciarlatano, un imitatore, da cui è stato turlupinato; e cosí gli è sembrato
onnisciente, ma solo perché è lui incapace di vagliare scienza, ignoranza e imitazione. – Verissimo, disse. [...]
25