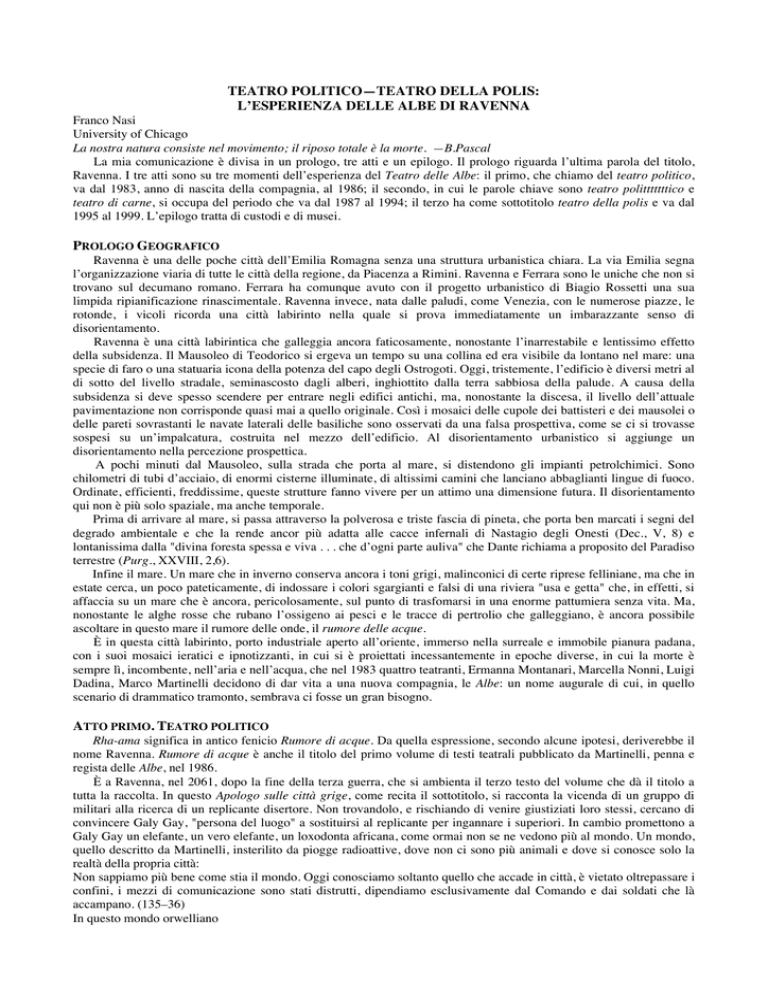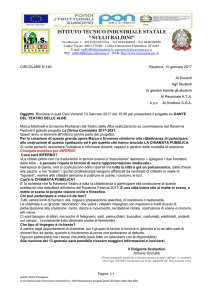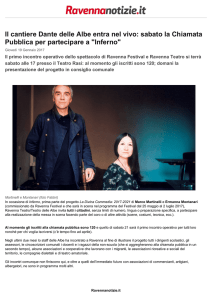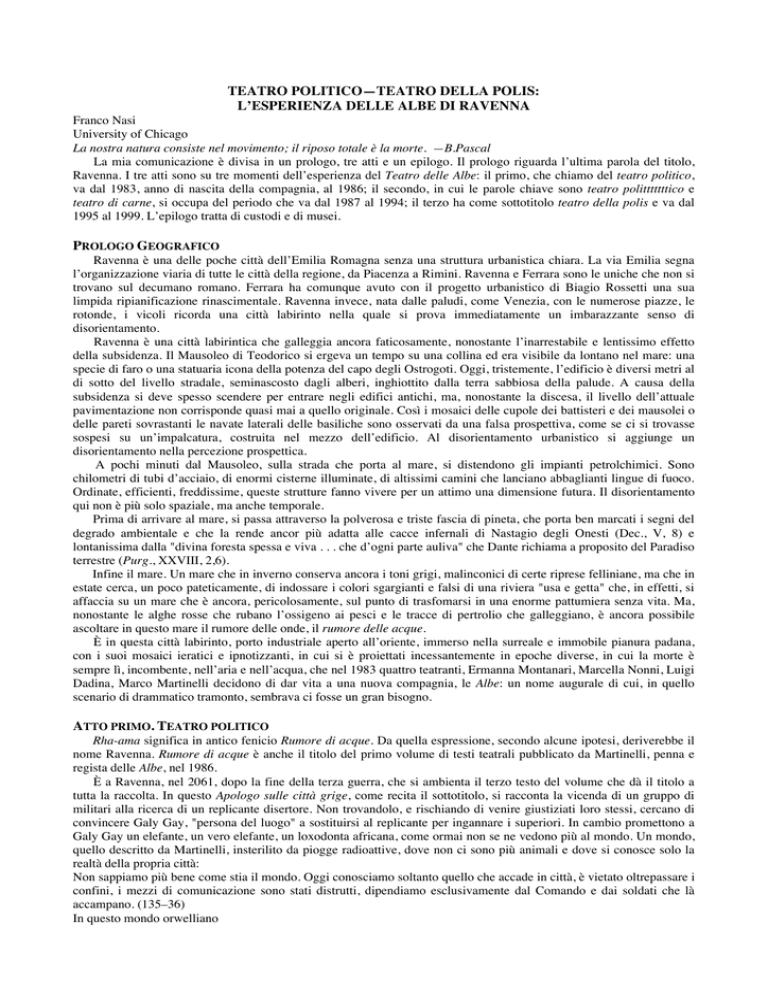
TEATRO POLITICO—TEATRO DELLA POLIS:
L’ESPERIENZA DELLE ALBE DI RAVENNA
Franco Nasi
University of Chicago
La nostra natura consiste nel movimento; il riposo totale è la morte. —B.Pascal
La mia comunicazione è divisa in un prologo, tre atti e un epilogo. Il prologo riguarda l’ultima parola del titolo,
Ravenna. I tre atti sono su tre momenti dell’esperienza del Teatro delle Albe: il primo, che chiamo del teatro politico,
va dal 1983, anno di nascita della compagnia, al 1986; il secondo, in cui le parole chiave sono teatro politttttttico e
teatro di carne, si occupa del periodo che va dal 1987 al 1994; il terzo ha come sottotitolo teatro della polis e va dal
1995 al 1999. L’epilogo tratta di custodi e di musei.
PROLOGO GEOGRAFICO
Ravenna è una delle poche città dell’Emilia Romagna senza una struttura urbanistica chiara. La via Emilia segna
l’organizzazione viaria di tutte le città della regione, da Piacenza a Rimini. Ravenna e Ferrara sono le uniche che non si
trovano sul decumano romano. Ferrara ha comunque avuto con il progetto urbanistico di Biagio Rossetti una sua
limpida ripianificazione rinascimentale. Ravenna invece, nata dalle paludi, come Venezia, con le numerose piazze, le
rotonde, i vicoli ricorda una città labirinto nella quale si prova immediatamente un imbarazzante senso di
disorientamento.
Ravenna è una città labirintica che galleggia ancora faticosamente, nonostante l’inarrestabile e lentissimo effetto
della subsidenza. Il Mausoleo di Teodorico si ergeva un tempo su una collina ed era visibile da lontano nel mare: una
specie di faro o una statuaria icona della potenza del capo degli Ostrogoti. Oggi, tristemente, l’edificio è diversi metri al
di sotto del livello stradale, seminascosto dagli alberi, inghiottito dalla terra sabbiosa della palude. A causa della
subsidenza si deve spesso scendere per entrare negli edifici antichi, ma, nonostante la discesa, il livello dell’attuale
pavimentazione non corrisponde quasi mai a quello originale. Così i mosaici delle cupole dei battisteri e dei mausolei o
delle pareti sovrastanti le navate laterali delle basiliche sono osservati da una falsa prospettiva, come se ci si trovasse
sospesi su un’impalcatura, costruita nel mezzo dell’edificio. Al disorientamento urbanistico si aggiunge un
disorientamento nella percezione prospettica.
A pochi minuti dal Mausoleo, sulla strada che porta al mare, si distendono gli impianti petrolchimici. Sono
chilometri di tubi d’acciaio, di enormi cisterne illuminate, di altissimi camini che lanciano abbaglianti lingue di fuoco.
Ordinate, efficienti, freddissime, queste strutture fanno vivere per un attimo una dimensione futura. Il disorientamento
qui non è più solo spaziale, ma anche temporale.
Prima di arrivare al mare, si passa attraverso la polverosa e triste fascia di pineta, che porta ben marcati i segni del
degrado ambientale e che la rende ancor più adatta alle cacce infernali di Nastagio degli Onesti (Dec., V, 8) e
lontanissima dalla "divina foresta spessa e viva . . . che d’ogni parte auliva" che Dante richiama a proposito del Paradiso
terrestre (Purg., XXVIII, 2,6).
Infine il mare. Un mare che in inverno conserva ancora i toni grigi, malinconici di certe riprese felliniane, ma che in
estate cerca, un poco pateticamente, di indossare i colori sgargianti e falsi di una riviera "usa e getta" che, in effetti, si
affaccia su un mare che è ancora, pericolosamente, sul punto di trasfomarsi in una enorme pattumiera senza vita. Ma,
nonostante le alghe rosse che rubano l’ossigeno ai pesci e le tracce di pertrolio che galleggiano, è ancora possibile
ascoltare in questo mare il rumore delle onde, il rumore delle acque.
È in questa città labirinto, porto industriale aperto all’oriente, immerso nella surreale e immobile pianura padana,
con i suoi mosaici ieratici e ipnotizzanti, in cui si è proiettati incessantemente in epoche diverse, in cui la morte è
sempre lì, incombente, nell’aria e nell’acqua, che nel 1983 quattro teatranti, Ermanna Montanari, Marcella Nonni, Luigi
Dadina, Marco Martinelli decidono di dar vita a una nuova compagnia, le Albe: un nome augurale di cui, in quello
scenario di drammatico tramonto, sembrava ci fosse un gran bisogno.
ATTO PRIMO. TEATRO POLITICO
Rha-ama significa in antico fenicio Rumore di acque. Da quella espressione, secondo alcune ipotesi, deriverebbe il
nome Ravenna. Rumore di acque è anche il titolo del primo volume di testi teatrali pubblicato da Martinelli, penna e
regista delle Albe, nel 1986.
È a Ravenna, nel 2061, dopo la fine della terza guerra, che si ambienta il terzo testo del volume che dà il titolo a
tutta la raccolta. In questo Apologo sulle città grige, come recita il sottotitolo, si racconta la vicenda di un gruppo di
militari alla ricerca di un replicante disertore. Non trovandolo, e rischiando di venire giustiziati loro stessi, cercano di
convincere Galy Gay, "persona del luogo" a sostituirsi al replicante per ingannare i superiori. In cambio promettono a
Galy Gay un elefante, un vero elefante, un loxodonta africana, come ormai non se ne vedono più al mondo. Un mondo,
quello descritto da Martinelli, insterilito da piogge radioattive, dove non ci sono più animali e dove si conosce solo la
realtà della propria città:
Non sappiamo più bene come stia il mondo. Oggi conosciamo soltanto quello che accade in città, è vietato oltrepassare i
confini, i mezzi di comunicazione sono stati distrutti, dipendiamo esclusivamente dal Comando e dai soldati che là
accampano. (135–36)
In questo mondo orwelliano
Ravenna è tornata a brulicare di orientali, come ai tempi in cui l’armata romana del Levante assicurava la difesa
dell’Adriatico: cinesi e americani, mezzisangue e replicanti, la popolazione di Ravenna / Rha-ma realizza la sua antica
vocazione cosmopolita, ma a quale prezzo! In qual modo! (135)
La trilogia drammaturgica che segna l’inizio dell’esperienza delle Albe si ispira dall’opera di Philip Dick: Mondi
Paralleli (1983), Effetti Rushmore (1984) e Rumore di acque (1986). L’opera di Dick ha offerto grandi sollecitazioni al
gruppo per riflettere sui temi del doppio, della maschera, dell’apparenza, che già Martinelli e Montanari avevano
sondato con compagnie precedenti (Teatro Maranathà, 1977–1981, e Linea Maginot, 1981–1983), con la realizzazione,
tra le altre, di opere di Beckett e Büchner.
Accanto a questi temi, si viene configurando sempre più precisamente l’impegno per l’ecologia. Il mondo, o meglio
Ravenna, è un cimitero:
Descrivere Ravenna, quello che ne è rimasto, quello che poi è stato ricostruito, è un’impresa noiosa. La risparmio a me
e a voi. Posso solo dirvi che degli antichi monumenti sono rimasti Teodorico, perfettamente integro, e un brandello di
Galla Placidia . . . Come dire, solo tombe! (134–35)
Nel cielo della città delle acque ci sono due lune, una delle quali falsa, accesa e spenta da chissà chi, in modo che gli
abitanti possano scommettere su quale delle due sia quella vera. Le stagioni non esistono più: ci sono solo le piogge
radioattive e i locali in cui rifugiarsi "Temporale estivo? Chissà. Chi riesce più a distinguerle, le stagioni?" (160). Anche
il ciclo dell’anno è confuso, irriconoscibile.
Accanto a queste opere, nel 1986, le Albe producono uno spettacolo apparentemente minore, con due soli attori in
scena: Confine. È una sorta di monologo di Ermanna Montanari, ispirato da una raccolta di racconti su un circo minimo
di Marco Belpoliti. Confine, e siamo di fronte di nuovo a un riferimento topografico, è per il gruppo un punto di svolta,
un limite da superare.
Se posso semplificare: in Rumore di acque c’è una ricerca teatrale fatta di parole, di sdegno, di sogni, di ironia, di
ragione. È un teatro che parla con la testa e con il cuore, in cui Philip Dick sta accanto a Dante, Bateson e Brecht. È un
teatro politico, con una sola "t"; scritto con grande sensibilità e amore per le parole, in cui già si individuano alcune
caratteristiche della scrittura dram-maturgica di Martinelli: capacità di giocare con le parole e di renderle leggere e
pesantissime allo stesso tempo; accostamenti di lacerti e citazioni colte a frasi idiomatiche o tratte dalla pubblicità
televisiva secondo certe modalità proprie della pop art; dialogo diretto tra palcoscenico e platea, con frequenti e ironici
straniamenti dall’azione drammatica; commistione dei generi teatrali e di stili; e, nei testi pubblicati, presenza di una
voce narrante che non si limita soltanto a dare le indicazioni di scena tra un dialogo e l’altro, ma che interviene
narrativamente e criticamente nella vicenda. Un teatro politico che non si accontenta certo delle soluzioni
propagandistiche o riduttive (è lontano per questo dal teatro di Fo, al quale il lavoro di Martinelli è stato a volte
accostato e semmai ricorda per certe "azioni in strada" il Living), ma che tende a mostrare i problemi con uno sguardo
prospettico d’insieme, uno sguardo filosofico, apocalittico, in cui l’esistenzialismo ante litteram di Büchner si mescola a
un inquieto panteismo francescano, l’intento didascalico di Brecht si intreccia al disincantanto interrogarsi sull’essere e
l’apparire di Beckett o di Dick. Un teatro che non dà risposte né ricette, ma che solleva questioni. Scrive Claudio
Meldolesi nel 1988:
Quando due anni fa si è cominciato a parlare di teatro politico, le Albe hanno potuto mettere in campo un’esperienza
decennnale. Da sempre [. . .] erano su quella linea: in senso prima cattolico-goscista, poi büchneriano, maoista,
dickiano, blochiano, verde, antirazzista. Tanti sensi per un unico impegno, costante nel tempo, di rifiuto delle
separatezze intellettuali ed estetiche. (116)
Con Confine bussa alla porta un altro mondo: il mondo della fisicità, della mitologia più occulta, degli archetipi. Il testo
di Belpoliti sulla pagina è kafkiano; l’ossessione del corpo che accomuna gli artisti minori di un circo minimo di
provincia è lucida, mentale, adamantina nella sua razionalità. Ermanna Montanari lo trasforma riscrivendolo col proprio
corpo, con la propria voce. Scrive la Montanari in una pagina biografica apparsa su Il semplice:
Cominciai a far teatro. Non avevo, allora, un’idea precisa di cosa volesse dire far teatro. Conoscevo solo il teatro
cosiddetto tradizionale [. . .] Mi esaltava vedere in scena gli attori e le attrici, persone in carne e ossa che si muovevano,
agivano, che recitavano davanti al pubblico. Ma come recitavano? Qui il mio entusiasmo diminuiva. L’impressione era
che stessero facendo il compito, come a scuola, senza energia, senza piacere profondo, che parlassero con parole di altri
senza sentirle proprie [. . .] Quegli attori mi apparivano senza dramma, superflui, forse non gli era mai capitato di
sentirsi estranei, rospi. Grotowski un giorno ci ha detto che se non avvertiamo profondamente il nostro essere rospi, non
diventiamo mai principi, non saremo mai baciati. ("Mi sono ridotta" 60–61)
Con Confine, il teatro delle Albe affianca e intreccia alla mente e al cuore la carne: il corpo dell’attore viene gettato
sulla scena, sulla pagina, nella mente dello scrittore. Il testo drammaturgico non basta più a se stesso, non può scriversi
indipendentemente dal corpo che lo fa vivere sulla scena. Il teatro delle Albe vuole diventare l’altro, il rospo, l’estraneo.
Questo volere è un imperativo etico, un dovere-volere morale ed estetico ad un tempo. Il teatro si deve sporcare e,
secondo Martinelli, per farlo deve
Esibire il corpo, il corpo dell’animale, di noi animali. Non esibisce la razionalità, la testa. Anche quella, ad un secondo
livello, ma il primo impatto vero con un attore è come si muove, la faccia che ha il tono di voce. Tutte caratteristiche
animali. Il teatro è una scienza della vita, della biologia del sangue, dei nervi. Non solo di chi fa ma anche di chi ascolta,
di chi recepisce l’evento.[. . . ] Non possiamo creare se non scendiamo dentro alla profondità. Anche di noi stessi. E
questo per forza di cose è doloroso. Per forza di cose ci si ammacca i ginocchi. E solo l’artista che ha i ginocchi
sbucciati è un vero artista. ("Il cammino dall’idea all’opera" 56–57).
ATTO SECONDO.
TEATRO POLITTTTTTTICO, TEATRO DI CARNE
Tra il 1987 e il 1988 le Albe producono due spettacoli che cercano di sviluppare le intuizioni di Confine e di inglobare
nella poetica del gruppo alcune nuove sollecitazioni. Se come spettacoli sollevano alcune perplessità, essi costituiscono
tuttavia due chiari manifesti di quello che il gruppo intendeva sperimentare: I brandelli della Cina che abbiamo in testa,
ispirato a Diario di un pazzo dello scrittore cinese Lu Hsün e Ruh. Romagna più Africa uguale. In una Breve nota delle
Albe sulle Albe stesse—Aprile ‘87, pubblicato nel libretto di sala de I Brandelli, si trovano due concetti chiave che
saranno presenti nella poetica del gruppo negli anni a venire: teatro di carne e teatro politttttttico. In Ruh la direzione
del viaggio si sposta: dalla Cina all’Africa. All’origine dello spostamento una scoperta geologica e un incontro che
portano al teatro interetnico. In entrambi gli spettacoli si inizia un lavoro di scavo verso le radici linguistiche, verso il
dialetto, che diventerà un altro nodo fondamentale della poetica delle Albe.
Teatro di carne
L’attore è al centro della scena esplosa: è l’animale-anomalo: vive sulla sua superficie e nel suo profondo le distruzioni
di fine millennio: non incarna l’uomo soltanto, incarna il vivente [. . .]
L’attore del teatro di carne lotta contro i fantasmi invisibili: sente i morsi sulla pelle, tenta di decifrarli, tracce, per
capire a chi appartengano i denti che mordono, e comunque: non vuole essere mangiato!!!
Insieme a lui gridano animali e foreste, la Terra divorata dai pesticidi, l’Aria arrugginita, il Mare avvelenato, il Vento
che non soffia, i Popoli merce di scambio. Si dirà: ma questa è ideologia! No, questa è ribellione che si fa carne, teatro,
pensiero. (I Brandelli 4–5)
Il teatro di carne inizia non tanto da una teorizzazione astratta, anche se indubbiamente nella citazione il tono è
quello della dichiarazione perentoria. Come avviene spesso nelle dichiarazioni di poetica, la definizione è una
esplicitazione di un modo del fare. I fantasmi con cui lottano gli attori sono gli stessi spiriti con cui aveva lottato Raffé,
la protagonista di Confine, così come gli attori che non vogliono essere divorati sono quelli che Martinelli mette in
scena ispirandosi a Lu Hsün. I personaggi di Martinelli sono persone (e qui ci aiuta l’ambiguità della parola che vale
come essere individuale reale, ma anche, etimologicamente, come maschera di scena) in carne e ossa molto prima di
essere maschere sulla carta. Il teatro di carne nasce da una presenza reale, da una commistione o con—fusione
inscindibile tra corpo e parola, tra attore e testo, tra persona e maschera. Una con-fusione che è tratto comune a tutta la
storia del teatro occidentale, come sostiene Martinelli citando Goldoni (e si veda "Luci e mondo" 7) e ricordando
l’opera di Terenzio, Shakespeare, Pirandello, e che è fortemente presente nella sperimentazione teatrale novecentesca,
con toni e accenti diversi, da Stanislavskij a Grotowski, dal Living Theater ad Artaud. Proprio Artaud dedica un breve
scritto alla "Situation of the flesh" e alla poetica dello scrittore attore regista francese le Albe guarderanno con sempre
più attenzione a partire dalla seconda metà degli anni ottanta.
Teatro politttttttico
Perché politttttttico? Sette possibili risposte:
1. Polittico, con due t, etimologicamente significa "dalle molte piegature": con sette t esalta le innumerevoli piegature
del reale: non di ideologie i fervidi abbisognano, ma di un pensiero forte, complesso, politttttttico!!!!!!
2. È l’errore di un tipografo impazzito.
3. È una licenza poetica.
4. È l’arrotarsi del grido sui denti e sulla lingua, sulle t come lame, un bimbo che si incaglia, un irriducibile entusiasta,
un guerrigliero nel Terzo Mondo.
5. È il sapere che non possiamo "cambiare il mondo" (leggi: RIVOLUZIONE), ma "qualcosa in qualche angolo,
qualcosa di noi, di un qualcun altro, dispersi su un pianetino che ruota attorno a un sole di periferia di una galassia tra le
tante, arrestare una lacrima, curare qualche ferita, sopravvivere, essere odiosi a qualcuno, saper dire di no, piantare il
melo anche se domani scoppiano le bombe, perdersi in un quadro di Shiele, aver cura agli amici, scrivere certe lettere
anziché altre (leggi: RIVOLUZIONE).
6. È pensare che "la poeticità è una battaglia disperata."
7. È umor nero. (I Brandelli 11–12)
Ci sono due modi di pensare la filosofia e la politica che questa programmatica elencazione sembra avere di mira: da un
lato il dogmatismo di un certo teatro ideologico e settario, così di moda negli anni settanta, ma che ancora resiste negli
anni ottanta, quelli del craxismo egemone (magari camuffato e ormai inserito nelle spartizioni di potere), dall’altro il
pensiero debole, postmoderno. Si parla qui di un pensiero forte che sappia sognare, un pensiero capace di sollecitare
quesiti, inquietudini, per nulla tranquillizzante. Un pensiero, dunque, che percuota la realtà e la faccia apparire per
quello che è, con le sue contraddizioni, le maledizioni, gli incantamenti. In una recente pagina Ermanna Montanari
ritorna su quel manifesto:
A Marco e a me, ai nostri compagni delle Albe, il teatro politico non è mai piaciuto. Almeno quel teatro politico
conosciuto in gioventù, negli anni ‘70. Arrogante, dava risposte facili agli orrori della polis e pretendeva l’assenso dello
spettatore. Non si curava degli abissi della psiche, dei suoi "desideri infiniti" (Santa Teresa D’Avila), sapeva già tutto in
anticipo, come un maestro pedante ci faceva la lezione, omologando la scena a un comizio. Al contrario [ . . .] in Italia
gli anni ‘80 sono stati anni di amnesia collettiva, di rifugio nella stupidità e nel conto in banca. Neanche questo ci
piaceva; gli orrori, i nodi della polis erano ancora lì, sotto i nostri occhi, dentro i nostri cervelli, irrisolti [. . .]. Da questo
doppio rifiuto nacque, lentamente, il politttttttico [. . .] Il politttttttico non era un teatro di risposte. Chi era in scena non
aveva soluzioni da offrire, ma solo ferite da esibire, infezioni che riguardavano al tempo stesso la psiche e la polis. Il
politttttttico era questa immedicabile relazione, e proprio lì stava la sua testarda, asinina ragion d’essere. ("The open
page" 19)
Teatro interetnico
L’esperienza di collaborazione con un gruppo di giovani senegalesi che entrano a far parte della cooperativa delle
Albe inizia con una scoperta geologica. Riprendo dallo spettacolo Ruh. Romagna più Africa uguale uno dei numerosi
racconti di questa scoperta:
Il Prologo va rifatto / perché ho dimenticato un particolare decisivo: / la Romagna è Africa! / Questa è scienza, non
fantascienza / è qualità costante nel tempo. / Il sottosuolo / che regge Ravenna e Bagnacavallo / Godo e tutte le altre
città romagnole / è africano! / Secondo le ultime avanzate ricerche geologiche / la Romagna è un pezzo d’Africa /
andato alla deriva in epoche antichissime / una zattera scura / che si è staccata dal continente madre / e ha veleggiato fin
qua. / Questa spiaggia / e il mare che qui sotto ribolle / sono neri, sono neri, sono neri! (Ravenna africana 84)
Dopo avere appreso che la madre terra romagnola è africana (una specie di illuminazione sulla via di Damasco),
l’incontro con la comunità dei senegalesi a Ravenna fu un fatto naturale. Tre di loro Iba Babou, Abibou Ndiaye e
Khadmin Thiam, venditori ambulanti fino al 1987, divennero soci della cooperativa delle Albe, e Ruh, lo spettacolo
d’esordio in cui le Albe Bianche e le Albe Nere (come poi si chiamarono) lavoravano insieme, divenne il primo
spettacolo prodotto da un teatro interetnico in Italia.
Con teatro interetnico non si intende soltanto il fatto che accanto ad attori bianchi ci sono attori neri, o che gli
argomenti trattati nelle rappresentazioni riguardano la condizione di sfruttamento degli immigrati e il colonialismo
europeo in Africa. Non basta fare iniziare uno spettacolo con attori senegalesi che rappresentano se stessi mentre
cercano di vendere accendini tra le file della platea, sconcertando il pubblico, che è venuto a teatro, in un ambiente
dorato e vellutato, anche per trovare un luogo di evasione dalle seccature del mondo. Nè basta lasciare che un gruppo di
senegalesi indossi i vestiti dei rivoluzionari e con striscioni e inni, dal pulpito del palcoscenico, educhi il pubblico
occidentale sui misfatti coloniali antichi e passati e sulle connivenze che ancor oggi i politici del Nord del mondo
mantengono con i criminali governanti dell’Africa. Queste cose in Ruh ci sono; ma il teatro interetnico, nelle intenzioni
delle Albe, non vuole essere solo un teatro "politically correct," dove assicurata l’inoffensività dell’apparenza (o del
significante), e recitato un convenzionale e rassicurante mea culpa, la vita al di fuori della rappresentazione artistica è
lasciata a se stessa; né vuole essere un teatro genericamente impegnato o di denuncia. Il teatro interetnico è piuttosto
un’esperienza totalizzante, "di gruppo" o "di base," come si diceva negli anni settanta e come le Albe hanno voluto
intendere la vita teatrale sin dall’inizio: un teatro che non termina il suo compito né cessa di esistere quando cala il
sipario:
Le leggi compositive di una comunità teatrale come la nostra non riguardano soltanto l’arte scenica, riguardano da
vicino la struttura produttiva. Non siamo solo quello che recitiamo, siamo anche ciò che mangiamo. Si recita come si
mangia, si mangia come si recita. Quando abbiamo pensato alla Romagna africana, la prima domanda che ci siamo
posti, immediatamente, riguardo al lavoro, non era attorno ai problemi formali, ma: in che modo Iba, Abib e Khadim
entrano a far parte delle Albe? La risposta non ha tardato: Iba, Abib, Khadim saranno Albe fino in fondo, come noi, con
il nostro stipendio, in un rapporto da pari a pari. (Ravenna africana, 12)
Nel giro di poco più di un anno ai primi tre attori senegalesi subentrano nella cooperativa Mandiaye N’Diaye, Mor Awa
Niang e El Hadiy Niang. La sostituzione non è indolore: il teatro interetnico diventa luogo di scambio ma anche di
contrasti, di dubbi, di tensioni (si vedano per questo le belle pagine di Luigi Dadina, in Ravenna Africana, e di
Martinelli e Mandiaye N’Diaye in Saltatori di muri). Negli interventi del gruppo di quegli anni si parla sempre più
spesso di meticciato. Il termine sembra pertinente e si accorda con la poetica del teatro politttttttico, così come viene
tratteggiata da Martinelli:
La mescolanza degli opposti genera il politttttttico, perché mescolare gli opposti è segno di vitalità: sacro e profano,
magia e razionale, corpo e scrittura, e quindi bianco e nero, la lingua di Dante e della televisione e le lingue dei villaggi,
wolof e romagnolo, il tragico e il comico. (Ravenna africana, 14–15)
Forse non è un caso che Martinelli ponga l’accento sull’espressione "mescolanza degli opposti": il rapporto che si dà è
dialettico, nel senso di attraversamento, di superamento, ma anche di mantenimento. Questo atteggiamento dialettico
giustifica, credo, da un lato l’apertura al diverso, ma anche il rifiuto risoluto a una consolante omogeneizzazione e la
conseguente, e quasi inizialmente imprevista, indagine sulla propria identità. L’esperienza delle Albe diviene un
momento di maggiore presa di contatto con la propria cultura ancestrale, ctonia, con i riti del proprio luogo, con la forza
della propria lingua più antica. E questo vale sia per gli attori delle Albe bianche, che si immergono nella rilettura della
propria tradizione (e da qui la riscoperta dei Maggi dell’Appennino tosco-emiliano, del Fulêr romagnolo, dei dialetti),
sia per le Albe nere (con le storie popolari che trovano il loro fuoco espressivo nella figura del Griot e degli animali).
All’immagine del viaggiatore che con curiosità si avvicina all’altro, che entra nei luoghi dell’altro, li visita, li assaggia e
li soppesa, si affianca la figura dello speleologo, di colui che, sollecitato dalla scoperta delle differenze, ritorna a casa,
nel proprio territorio e si inabissa nel sottosuolo, alla ricerca della propria identità più nascosta e, eventualmente, di una
affinità elettiva profonda, archetipica con l’altro.
Le maschere e le voci
Negli anni che seguono, i frutti di questa ricerca bidirezionale, dello spostamento geografico di superficie fra Dakar
e Ravenna e dell’inabissamento nel sottosuolo, sono incredibilmente abbondanti. Tra il 1988 al 1995 sono prodotte
numerose opere che si possono forse convenientemente organizzare secondo i seguenti accorpamenti:
1. La trilogia dell’Arlecchino senegalese (Siamo asini o pedanti, Lunga vita all’albero, I 22 infortuni di Mor
Arlecchino)
2. La trilogia delle maschere romagnole (Bonifica, I Refrattari, Incantati)
3. La ricerca sulla voce di Ermanna Montanari (Rosvita, Cenci, Lus)
4. La ricerca sulla narrazione di Luigi Dadina e Mandiaye N’Diaye (Nessuno può coprire l’ombra, Griot Fulêr,
Narrazione della pianura).
Non c’è spazio per entrare nei dettagli di ciascuno di questi spettacoli. Dovrò pertanto limitarmi ad alcuni rilievi
piuttosto generici relativi a questa vasta produzione, partendo dalla maschera più popolare delle Albe.
1. L’arlecchino senegalese nasce in un sogno, nella "farsa filosofica" Siamo asini o pedanti (1989). Un "uomo in
completo," vestito cioè in giacca e cravatta, ma anche in-completo, capace cioè di vedere e sentire solo una parte delle
cose che gli stanno attorno, è interessato all’acquisto di un animale prodigioso, un asino parlante, per ricavarne poi
proventi con la televisione. L’asino, che oltre a parlare, per via delle enormi orecchie asinine è condannato ad ascoltare
tutto quello che succede, soprattutto i lamenti, e a commuoversi, è di proprietà di tre immigrati senegalesi che, a
malincuore, decidono di venderlo. L’uomo in completo arriva alla casa dei tre immigrati, contratta a lungo per
l’animale, lo acquista; ma intanto si fa tardi e gli immigrati vogliono trascorrere con l’animale un’ultima notte,
imponendo così all’uomo di restare a dormire. Durante il sonno l’uomo ha un incubo in cui i ruoli sociali si ribaltano:
gli uomini neri diventano carabinieri, controllori dell’ordine e dei permessi di soggiorno mentre l’uomo in completo
deve dimostrare di avere le carte in regola per esistere. In un altro momento del sogno, sotto un immaginario tendone
del circo Watutsi, quello stesso sotto cui si esibiva Raffé di Confine, compare un Arlecchino senegalese, "unico
inimitabile artista" del circo, che inizia una sfrenata danza africana:
Io Arlecchino vengo dalle montagne / dove la fame è nera nera nera / tanto nera da mangiarsi le unghie le mani / le
braccia / il petto la pancia le gambe le caviglie / tutto quanto fino a scomparire!
Io Arlecchino sono venuto in questa città / perché m’han detto / c’è lavoro c’è lavoro c’è lavoro. / Cancaro! Se c’è
lavoro per gli altri / ci sarà anche per me! [. . .]
Io Arlecchino cerco un padrone / che sia gentile dolce mieloso tiramisù / mascarpone zuppa inglese torta nuziale!!!!!! /
Sono disposto a tutto per lui / purché mi dia da mangiare quando ho fame / da bere quando ho sete / e da . . . (gesto
eloquente) insomma, ci siamo capiti! (Siamo asini o pedanti 33)
L’Arlecchino, nella tradizione originaria della commedia dell’arte, è un bergamasco che lascia i territori poveri della
Lombardia per cercare lavoro nella ricca Repubblica di Venezia. È perennemente affamato, afflitto dalla fame atavica
dello zanni, usa un linguaggio approssimativo, è astuto e ingenuo ad un tempo. Mor Awa Niang, griot e "vu cumprà"
autentico, con il proprio corpo, la propria voce, la propria fame rivitalizza la maschera di Arlecchino, che già nel teatro
settecentesco aveva cominciato a smarrire le caratteristiche originarie dell’emigrato "morto di fame" per assumere le più
tranquillizzanti movenze "aristocratiche" e melanconiche degli arlecchini francesi alla Watteau o Picasso. Mor non si
nasconde dietro una maschera: è lui stesso la maschera: la soglia fra il vero immigrato e il prototipo è talmente stretta
che i due coincidono. Che l’attore si identifichi con la maschera, con la sua storia, è difficile a dirsi, ma che la maschera
si identifichi con l’attore è assai evindete: coerentemente con la poetica del teatro di carne, la maschera assume le
sembianze dell’attore, il tipo (l’Arlecchino africano) diventa l’attore, con il rischio (e questo potrebbe essere un limite
della poetica stessa del teatro di carne) che la maschera viva unicamente in quell’attore. È difficile immaginare un altro
attore recitare Mor Arlecchino.
La figura dell’Arlecchino nero diventa una sorta di icona del teatro delle Albe e raggiunge la sua piena maturità
artistica nello spettacolo I ventidue infortuni di Mor Arlecchino tratto da un canovaccio di Goldoni riscritto da
Martinelli, e messo in scena dalle compagnie delle Albe e del Tam di Padova, con la regia Michele Sambin. Qui
innovazione e tradizione sembrano intrecciarsi in modo assai fecondo sia per lo spettacolo in sé, sia per le direttrici
future del gruppo (per questo si rimanda a An African Harlequin in Milan e ai saggi critici che accompagnano la
traduzione inglese del testo di Martinelli e del canovaccio di Goldoni).
2. Sempre figli di Confine e della "ricerca dello speleologo" sono le altre due maschere rappresentative delle Albe;
maschere anch’esse di carne, attori-autori che si fanno persone di scena: Daura e Arterio. Compaiono per la prima volta
nel "polittico in sette quadri" Bonifica (1989) che rappresenta, come ha scritto Antonio Attisani, una sorta di viaggio in
un "inferno" che abbiamo dentro casa, in "una realtà più vera e più profonda che sta dietro cose note, vicine, anzi
nostre" (7). Daura è la madre, una figura esile, sensibile, che crede ai sogni e che desidera che nulla cambi nella sua
terra: una sorta di vestale della lingua, dei riti, delle credenze della Romagna. Arterio è il figlio, una figura possente,
accecato dalla pubblicità della televisione e del progresso, che vorrebbe risolvere i problemi del mondo, a cominciare da
quelli ecologici, con la stessa spavalda, risoluta insensatezza dei cavalieri delle gesta boiardesche. Le due figure
sembrano agli antipodi, a cominciare dalla differente struttura dei loro mondi mentali, che si palesa, con evidenza, nello
stile diversissimo del loro parlare. I monologhi di Arterio hanno un andamento incalzante e vigoroso, basato su
elencazioni spesso in crescendo, farciti dei luoghi comuni del linguaggio giornalistico più dozzinale. Le meditazioni di
Daura sembrano stemperare la concitazione della voce di Arterio, con il loro tono salmodiante, la struttura sintattica
lineare, il lessico ingenuo. Vale la pena di leggere un monologo di Arterio, recitato tutto d’un fiato, nel quale Martinelli,
ritorna su un tema, quello della morte del mare (che in Bonifica sembra coincidere drammaticamente con la figura della
madre Daura), già centrale in Rumore di acque:
Per anni ho portato avanti questo bagno con mia madre che dal nome di lei abbiamo chiamato Bagno Daura. Adesso
non si guadagna più il mare si è ridotto al vomito di un gigante alla gente non piace non ha tutti i torti bagnarsi nel
vomito di un gigante non è affare di tutti i giorni non sempre le novità risultano gradevoli. I turisti tedeschi sono
diminuiti del trantaquattro per cento i russi sono aumentati del diciotto gli ungheresi vanno benino e presto arriveranno
cecoslovacchi e bulgari e vivaddio anche i rumeni. Sto riflettendo sulla storica apertura dell’est è l’occasione del
prossimo secolo ma per ora il flusso della perestroika è insufficiente a garantire solidità per l’immediato futuro ergo
vendo il bagno come anni fa vendemmo la terra per acquistare questo bagno e chiamarlo Bagno Daura [. . .] (25)
Penso a una bonifica totale a una bonifica che passi alla storia non un coperchio di terra non tiene seppellire quell’orrore
sotto una stesa lucida e precisa di cemento armato (44).
A questa ininterrotta proposizione fa da contrappunto la voce oracolante, con prestiti lessicali dai Salmi, il Cantico dei
Cantici, il Nuovo testamento, di Daura, la madre, che spiega in un sogno allo scettico Arterio la possibilità che perfino
nel deserto ci siano temporali:
Quest’acqua che viene giù a torrenti / è benedetta e santa / e tutti la benedicono / I cristiani e i musulmani / e quelli che
non ci credono / e tutte le bestie e tutti gli alberi / e tutte le pietre del deserto la benedicono / il sole e la luna la
benedicono / e anch’io la benedico / perché è un’acqua santa e benedetta / farà crescere diecimila vigne nel deserto /
ogni vigna porterà diecimila rami / ogni ramo diecimila sarmenti / ogni sarmento diecimila grappoli / ogni grappolo ci
darà venticinque misture di vino. / Sì, mio diletto, il miracolo si rinnova / perché in queste nozze del drago con il
deserto / l’acqua si tramuta in vino, del più buono / quelli che verranno e ne berranno / o troveranno ottimo / il deserto
si riempirà di ubriachi / che ballano . . . ballano . . . ballano (35).
Non si potrebbe pensare a due maschere più in antitesi, eppure, in questo inferno romagnolo, il legame di sangue fra i
due è morboso e sembra possa sciogliersi solo nel sangue. Bonifica, in cui i sogni di Daura si intrecciano con i quadri di
vita quotidiana, si conclude con un deragliamento del sogno nella realtà e con un oniricoreale matricidio.
3. Parallelamente Ermanna Montanari, Luigi Dadina e Mandiaye N’Diaye svolgono un percorso di ricerca personale
come attori-autori-registi. Montanari sposta il luogo della rappresentazione in spazi appartati, intimi. Rosvita (1991) e I
Cenci (1993) sono presentati per la prima volta nella piccola soffitta di un antico palazzo rinascimentale di
sant’Arcangelo, alla presenza di un numero limitato di spettatori. In questa sorta di cella monastica o carceraria
medievale, oscura e raccolta, l’azione drammatica si trasforma in un rito liturgico in cui si rappresentano
espressivamente, non tanto narrativamente, gli incubi di Beatrice Cenci o le riflessioni della monaca Rosvita sulla
scrittura, il peccato, la malattia. Montanari mette in gioco qui tutte le potenzialità del suo corpo e della sua voce: "Io mi
arrovello. Mi arrovello su me stessa. / Di me stessa cerco la misura. / Sono diventata per me un terreno aspro / che mi fa
sudare" (Rosvita, 28), recita l’attrice-autrice mentre impersona Rosvita, la fragile monaca che, senza successo, vorrebbe
reggere le tavole della legge con la stessa sicurezza mostrata dall’allegoria della Sinagoga, una splendida figura
femminile di Konrad Witz, meticolosamente riprodotta per lo spettacolo sul muro della cella.
Continua in Rosvita la ricerca sul corpo come strumento rituale iniziato in Confine e che giungerà agli esiti
felicissimi del canto di Lus (1995), attraverso un lungo lavoro sull’espressività del dialetto romagnolo (lingua terrigna e
aspra, con poeti come Raffaello Baldini e Nevio Spadoni a ispirare storie e parole), sulle modulazioni della voce, che
spazia dai suoni nasali più acuti alle note più basse del diaframma, sul rapporto strettissmo fra tensione del corpo e delle
corde vocali, fra nervi e suoni. Con la ricerca fonetica della Montanari, che ricorda seppure in modi personalissimi
quella di Carmelo Bene, e in cui la parola a volte si dà come puro suono, giunge a compimento una delle intuizioni
programmatiche esplicitate nella dichiarazione di poetica di I brandelli della Cina, quando Martinelli scriveva di un
"Teatro in-cantato," in cui la musica non fosse una ancilla del testo, ma momento essenziale di un teatro
"polisensoriale" (6). Qui addirittura la narrazione delle storie di Rosvita, di Beatrice Cenci, di Belda diventa una sorta di
pre-testo, una conoscenza che lo spettatore aquisisce attraverso fogli di sala, recensioni, altri testi che pre-ludono alla
espressività e interpretatività dell’azione scenica (play).
Montanari ripropone inoltre da un’ottica diversa (e si veda il saggio di Teresa Picarazzi) il conflitto madre/figlio che
costituiva il polo centrale di tensione narrativa nelle vicende di Daura e Arterio. Spesso i personaggi femminili della
Montanari rivivono in modo drammatico il rapporto della figlia con l’autorità paterna sia essa di sangue (nel parricidio
di Beatrice Cenci) oppure spirituale (nella scena dell’ex prostituta Taide e del suo mentore religioso Panfunzio in
Rosvita o nel maleficio della strega/guaritrice Belda nei confronti del prete/giudice in Lus) Come avveniva nel teatro
politico delle Albe, Ermanna Montanari non assume l’atteggiamento riduttivo e ideologizzato di chi vuole ordinare il
mondo per categorie chiuse e manichee. Il contrasto padre figlia pure lacerante non è tipizzato: sulla scena il rapporto è
sempre sofferto, a volte surreale, spesso tragico, sia per le figlie, che agiscono, sia per i padri, chiusi nei loro silenzi
tetragoni, spesso immobili e spettrali. É in questa angosciosa compresenza di disgusto e di amore, di dichiarazioni e
dinieghi, di suoni sospirati e di urla agghiaccianti che sta la forza magnetica dei canti di Ermanna Montanari.
4. Sempre nel breve manifesto de I brandelli della Cina si parlava anche di "teatro di scrittura"(8). Allora Martinelli
esplicitamente auspicava un teatro capace di confrontarsi con la pagina degli scrittori. Credo di non forzare le cose se
intendo quel "teatro di scrittura" come teatro di narrazione, epico; un modo di fare teatro che talune nuove convenzioni
della post-avanguardia avevano nascosto in soffitta. Recentemente Martinelli è ritornato su quel punto chiave della
poetica del gruppo:
Già dalla prima metà degli anni Ottanta, io e i miei compagni delle Albe eravamo presi dal fascino delle storie: da un
teatro che fosse anche narrazione. All’epoca, pochi volevano sentir parlare in questo modo: del testo e della parola si
diffidava parecchio. ("É finito il tempo" 100–101)
In questa direzione particolarmente feconda sembra andare la ricerca di Dadina e N’Diaye, che segue alla produzione di
Lunga vita all’Albero (1990). Nel "Maggio epico" sono in scena due cantastorie: "Durante Verduzzi, questo è il mio
nome / cantastorie da sette generazioni / nell’Appennino ho vissuto e cantato / di piazza in piazza in cortile in contrada /
vagabondo come Ulisse / prima con mio nonno e con mio padre / poi solo con mio padre / poi solo con me stesso /
adesso solo e basta / perché non so neanche più / me stesso dove sia / a raccontare storie di santi e paladini" (17–8); e
Mor Arlecchino Batocio, anche lui cantastorie per elezione: "La nostra è una famiglia di griot: Mio nonno era griot,
anche il nonno di mio nonno era griot. Andavano nei villaggi, ballavano nelle feste, cantavano tante storie alla gente.
Mio babbo non ha fatto il griot: perché? [. . .] Perché non si guadagnava abbastanza. Non si mangiava più, capisci
questa parola Verduzi? Ma-gna-re!" (21). Mentre Dadina sposta la ricerca dall’Appennino dei maggiarini alla Romagna
dei fulêr (i raccontatori di favole itineranti), N’Diaye e gli altri attori delle Albe nere indagano invece la tradizione dei
Maestri della parola dell’Africa occidentale. Il lavoro prevede oltre alla fase di scavo nel proprio territorio, un confronto
continuo con l’altro. Questo porta alla creazione di uno spettacolo, Griot Fulêr, che debutta a Diourbel, in Senegal nel
1993 e che vede in scena tre artisti italiani e tre senegalesi. Le coincidenze fra i due tipi di narratore, sia a livello
diegetico che contenutistico, sono sorprendenti. Non solo ci sono affinità fra i ritmi del raccontare o le strutture
profonde delle narrazioni, ma sono simili perfino certe pratiche rituali, come, ad esempio, "il maleficio dell’orma
tagliata" praticata sia nella tradizione popolare senegalese che in quella romagnola (e che viene descritto sia in Griot
Fulêr che in Lus). "L’incontro tra il griot e il fulêr è stato magico" (Dadina, N’Diaye 21): una specie di incontro tra due
speleologhi che, partiti da caverne diverse, si trovano inaspettatamente insieme in una galleria profonda al di fuori del
tempo, oscura, defilata, dove la lingua parla con il ritmo del respiro e del battito del cuore anziché con quello dello spot
pubblicitario, dove le parole si portano addosso il suono straordinario della ingenuità e non la presuntuosa vuotaggine
della letteratura industriale.
TERZO ATTO. IL TEATRO DELLA POLIS
Ho assistito a Griot Fulêr, poco dopo la prima di Diourbel, al "Rasi" di Ravenna. Il teatro era stato preso d’assalto
da un numero incredibile di giovani vestiti come si vestono i giovani quando vanno a un concerto punk-rock: giubbotti
di pelle nera, borchie, capelli colorati ecc. Un pubblico insolito per uno spettacolo interetnico di cantastorie. E infatti i
giovani non erano lì per quello. La serata prevedeva due momenti: la performance teatrale delle Albe e il concerto dei
Mau Mau, un gruppo musicale torinese fra i più innovativi e seguiti nei primi anni novanta. Una trovata apparentemente
bizzarra da parte degli organizzatori che sembravano chiedere ai fans del gruppo di pagare, oltre al biglietto, l’ulteriore
sacrificio di dover assistere, prima del concerto, a uno spettacolo di teatro, luogo che per la maggior parte di loro è
sinonimo di noia. Quando i tamburi hanno cominciato a suonare e le fiaccole dei cantastorie a illuminare la scena, è
successo un piccolo miracolo, uno di quelli che, come dice una poetessa, "certo non cambieranno il mondo," ma che si
vedono con piacere e sorpresa. Il pubblico ha cominciato subito a inter-agire con i cantastorie, come avrebbe fatto di lì a
poco con i musicisti rock. Il teatro, tempio della finzione e della menzogna, con un piccolo trucco, era riuscito a rapire
per un poco dei giovani (e siamo certi che per alcuni era la "prima volta"), e aveva offerto loro uno spettacolo teatrale
che condivideva con la musica dei Mau Mau molte affinità poetiche (dalla narratività, alla ricerca sulla lingua e sulle
musiche etniche).
Questo aneddoto ci porta al terzo atto, in cui racconterò brevemente come il teatro politico delle Albe trovi una sua
concreta attuazione nella pratica di gestione delle attività e degli spazi teatrali di una città.
Nel 1991 il Teatro delle Albe e la Compagnia Drammatico Vegetale danno vita a una nuova cooperativa, alla quale
il Comune di Ravenna, con una lungimiranza non frequente nelle amministrazioni pubbliche, dà in gestione i due
maggiori teatri della città. La cooperativa programma le attività teatrali del comune, produce spettacoli propri e,
soprattutto cerca di rivitalizzare la città con il teatro o, viceversa, il teatro con la città. Martinelli non perde l’occasione
per stilare una nuova dichiarazione di intenti, un altro piccolo manifesto:
La scommessa di Ravenna Teatro è quella di uno stabile corsaro. Uno stabile che corre, alla lettera! Uno stabile in
movimento! Non un carrozzone fermo, impantanato, lottizzato come ce ne sono tanti. Ma una casa del teatro:
fuorilegge. Fuori dalle leggi mortali della noia, del teatro come museo delle cere, del potere dei mestieranti." ("Per uno
stabile corsaro" 3).
Il titolo del manifesto è paradossale in sé, con i due termini in antitesi: "stabile" come luogo di stabilità, di solidità
statuaria, e "corsaro," che designa il veliero che combatte di corsa, velocemente, senza arrestarsi.
Il termine "corsaro" rimanda immediatamente a Pier Paolo Pasolini, un autore certamente da sempre molto presente
nella poetica di Martinelli, basti pensare a Incantati o all’ultimo Polacchi, e sulla cui influenza occorrerebbe soffermarsi
più a lungo. Venne utilizzato per la prima volta nella collaborazione teatrale fra le Albe e il Kismet di Bari, organizzatori
di una rassegna teatrale intitolata "Silenzi Corsari" che aveva luogo contemporaneamente nelle due città. Voleva essere
un modo per accorciare l’Italia legando Nord e Sud, per interrogarsi su che cosa si possa fare in questi anni novanta,
così atrocemente rumorosi e inutilmente loquaci:
Una convinzione ci sorreggeva e ci sorregge: è necessario per sopravvivere saper praticare il silenzio, una forma attiva,
personale, meditata, di silenzio: non rifugiandoti tra i monti, ma restando in città, dentro al Grande Rumore, creandoti
una tua silenziosa disciplina di lavoro, in modo da riuscire a sentire la tua voce, prima di tutto, e poi anche quella degli
altri. Se sentirai le voci in mezzo al Gran Rumore (mica quello dei santi: almeno quella del vicino, per cominciare),
allora forse sarai sulla strada giusta, e potrai cominciare a muoverti, ma sì, a correre e creare, e solo allora il tuo sarà
diventato un vero silenzio corsaro. ("Per uno stabile corsaro" 3)
"Stabile" rimanda ad altri termini altrettanto significativi per le Albe come casa e città. Il teatro come casa è un’idea
alla quale la compagnia è particolarmente affezionata, legata a un modo di fare teatro che deriva dalle esperienze dei
gruppi di base degli anni settanta. Ricordiamo ancora la splendida Casa Büchner a Rimini, all’interno del Festival di
Sant’Arcangelo che l’allora Linea Maginot allestì nel 1982. In una casa teatrale l’atto performativo rimane senz’altro il
momento culminante, tuttavia il prima e il dopo dello spettacolo sono momenti altrettanto vitali. Wordsworth, un autore
spesso citato da Martinelli, era solito dire che i poeti non dovrebbero preoccuparsi di rispondere alle aspettative del
pubblico, ma piuttosto di crearsi un proprio pubblico, educandolo al nuovo. La casa del teatro è il luogo in cui questo
lentamente può avvenire. Lo si può fare offrendo nella stagione del teatro "istituzionale" anche spettacoli di ricerca a un
pubblico che si aspetta di vedere soltanto gli autori consacrati dalla tradizione e gli attori consacrati dalla televisione. Lo
si può fare mettendo a disposizione delle scuole della città la professionalità e l’entusiasmo di attori e registi, le strutture
e gli strumenti per l’allestimento di spettacoli e, soprattutto, per contribuire alla formazione di un gusto per il teatro (ma
per questo si rimanda all’articolo di Cristina Ventrucci). Il prima e il dopo dello spettacolo hanno dunque
profondamente a che fare con la città:
Se dico polis non intendo un’astrazione storica: so bene che viviamo nell’epoca dei grandi media e delle metropoli,
nell’epoca del virtuale, ma se dico polis intendo realtà fisiche visibili. Facce. Le facce dei trecento adolescenti che a
Ravenna partecipano ai laboratori delle scuole superiori, dai licei agli sitituti tecnici: le conosco tutte. Fanno parte della
mia vita di regista, di direttore artistico, di scrittore, così come le facce di tanti ateniesi erano parte viva
dell’immaginario e della scrittura di Aristofane. [. . .] Con questi adolescenti costruiamo insieme eventi scenici
sorprendenti. Giochiamo, affrontiamo il tutto con la stessa vitalità che richiede una partita di calcio, un concerto rock.
[. . .] Io amo tutto questo, credo che contenga un segreto essenziale del teatro. Ma forse questo è possibile solo in realtà
medio-piccole, circo-scritte, città come Ravenna coi suoi 130.000 abitanti (130.000 come gli abitanti, schiavi compresi,
dell’atene del V secolo)? ("Per uno stabile corsaro" 3)
Con una struttura organizzativa più consistente (coordinata da Marcella Nonni, una dei quattro fondatori del
gruppo), Le Albe possono allestire spettacoli di maggiore impegno scenico. Dal 1995 al 1999 i progetti principali
riguardano classici della tradizione occidentale. L’interesse di Martinelli per Aristofane (già autore di riferimento ne I
Refrattari) o di Montanari per Euripide è coerente con l’idea di un teatro per la polis (Ravenna come Atene), ed è affine
a quanto fatto da altre realtà teatrali della ricerca, dai Magazzini a Thierry Salmon a Mario Martone.
Il percorso di avvicinamento di Martinelli "trittico da Aristofane" parte da un seminario sulla commedia arcaica di
Aristofane, tenuto a Cisternino, con il Teatro Kismet di Bari, nell’estate del 1994, che porta all’adattamento, sempre con
il Kismet, degli Uccelli di Aristofane, per giungere alla fine al debutto di All’inferno!, un nuovo testo tratto da Pluto,
Uccelli, Lisistrata, nel quale sono chiamate a collaborare tre gruppi teatrali: Albe, Tam, Kismet. Martinelli non vuole
solo metter in scena Aristofane né svolgere su di lui una operazione di filologia. La sua intenzione è
di resuscitare lo spirito vivo dei suoi testi, tagliando, allargando, riscrivendo, spunti dall’ansia di dialogare con gli
antenati. Aristofane non è polvere da museo: quando comincia a scrivere, a diciassette anni, Aristofane è un adolescente
infuriato contro la guerra e gli orrori civili, ebbro di vita, devoto di Dioniso. Il comico non è per lui un diversivo
superficiale: è l’altra faccia del tragico, è lo squillo di tromba contro la morte. Per resuscitare Aristofane c’è bisogno di
Totò e dei fratelli Marx come di Artaud" (Foglio di sala, 5)
Anche lo spettacolo I Polacchi (una rivisitazione dell’Ubu Roi di Jarry) è il punto di arrivo di un percorso di
avvicinamento articolato. Il lavoro su Jarry segna, oltre che a un unanime ed entusiastico consenso della critica, anche
una verifica concreta che il lavoro sulla città ha una ricaduta evidente non solo nel prima e dopo l’evento teatrale, ma
anche nello stesso spettacolo. Mentre ne I polacchi sono in scena come palottini, l’esercito di padre e madre Ubu, dodici
ragazzi delle scuole che avevano partecipato ai workshop e agli allestimenti di cui si è detto, Perhindérion (prologo e
viaggio iniziatico a Jarry percorso durante Ravenna Festival 1998), prende fisicamente possesso della città, e di alcune
sue pratiche di spettacolo come se fosse un Mistery Play medievale. Nel "trittico peregrinante," che si svolge attorno e
dentro al teatro, sono coinvolti la banda comunale, quattro giovani sciucarèn che a torso nudo fanno cantare le loro
fruste nell’aria, otto coppie di bambini della scuola di ballo liscio che, vestiti da scheletrini, eseguono polche e mazurke
attorno a una enorme testa di Dioniso; questi tre gruppi fungono da intermezzo che accompagna il pubblico-orante alle
tre stazioni della misteriosa rappresentazione della storia di una madre (Varia, Madonna, Daura) e di un figlio
(Emmanuel, San Giorgio, Arterio). Sono i temi di Bonifica (che viene ripresa alla nella seconda "stazione" del
pellegrinaggio), rivisitati con lo sguardo di Jarry, raccontati ora come rito teatrale originario, coralmente, con la lingua
della città (il dialetto di Varia e Daura), nei suoi luoghi, con le sue pratiche di spettacolo e il suo drappello di accoliti.
Come ha scritto Quadri "questa affascinante storia [. . .] ha disegnato con la sua crudeltà una discesa agl’inferi da
rappresentazione medievale, ma al di fuori del tempo e dentro al mito."
In questa ritualità urbana sembra consistere la nuova nozione delle Albe di teatro politico: esso diventa il teatro della
polis, un teatro della polis in movimento, capace di leggersi dentro, a fondo, di guardare alla propria tradizione più
comunale, più campanilistica, più carnale, più terrigna, ma anche di ascoltare quello che viene da fuori, le narrazioni dei
nuovi abitanti provenienti dall’Africa, le voci delle vie dei canti, delle dee. Questo profondo radicamento nella città è
elemento comune a molte altre esperienze per certi versi omologhe a quella delle Albe (pensiamo ai Teatri Uniti di
Napoli, al Kismet di Bari, alla Valdoca o la Raffaello Sanzio di Cesena, al Tam di Padova, al prolifico panorama
palermitano): l’obiettivo è di produrre una cultura teatrale che sia coltura di vita. Ancora Martinelli:
Penso al Rasi (uno dei due teatri della città) come a un luogo di Coltura Teatrale. Mi piace questo parlare del nostro
lavoro come un lavoro contadino. Mi piace la lentezza, la necessità della lentezza, biologica, stagionale, straniera in
un’epoca che si sacrifica alla velocità industriale e modaiola, usa e getta, produci e consuma e dimentica. Penso a un
teatro che nasce dagli antichi riti di fertilità della terra, penso a un teatro di terra, dialettale e epico (la terra è sempre un
dialetto!), penso alla possibilità del racconto e della visione. [. . .] Mi piace la con-fusione. Penso che un’autentica
Coltura Teatrale la si fa se non si ha l’animo dei mercanti, ma nello stesso tempo se si accetta la sfida di far vivere un
teatro Dentro la città, non come corpo separato, isola felice e infelice, ma come luogo ricco di tensioni vitali,
battagliero, spazio per incroci e innesti, organismo vivente, animale che Respira insieme alla città. Penso a un impegno
vero, politico, per quel che politico vuol dire, legato alla polis. ("Coltura teatrale" 19–20)
EPILOGO SUL CUSTODE E LA POLVERE
Da Ravenna, una città labirinto, negli anni settanta, cominciarono a muoversi alcuni giovani: pensavano, forse
ingenuamente, di vivere di teatro in una città che voleva vivere di chimica e che invece sprofondava sempre più nelle
sue sabbie mobili e nel suo mare pieno di alghe rosse. Dopo vent’anni quel gruppo di teatranti continua a muoversi
sullo stesso palcoscenico. "Vive ai margini," come del resto tutto il teatro vive ai margini. "Fa il custode" ma non di una
città museo, non il custode che ogni tanto dà "una spazzolata ai monumenti, una riverniciatina ai capolavori del
passato": è un "custode" che si "aggira inquieto come in un labirinto" che "interroga se stesso e i monumenti, il tempo
presente e le opere antiche, e in quest’ansia di conoscenza, crea: soffre, gode, capisce, non capisce, si interroga: crea."
("È finito il tempo . . ." 106).
Questi teatranti hanno assunto il ruolo di custodi della città labirinto, dei suoi monumenti, della sua lingua. Ne
custodiscono il fuoco e la carne, ne celebrano la liturgia fatta di tragedia e di comicità, ne ripetono il rito eterno di odio
amore per i padri e le madri, ossessionati dalla consapevolezza che la chiusura in sé, la mancanza di movimento, la
polvere sono sinonimo di morte. Ancora Martinelli, nel libretto di sala della sua ultima regia del Miles di Plauto, del
Teatro Kismet di Bari:
Questa dovrebbe essere la nostra ossessione, la preghiera quotidiana degli attori e dei registi e di tutti coloro che
lavorano nel teatro: Signore, liberaci dalla polvere! La polvere non ricopre soltanto i classici, ma invade pure le nostre
scene, il nostro lavoro, le nostre relazioni, facendo del teatro un’attività stanca e inutile, fredda, lontana dagli interessi e
dai grovigli della comunità umana, la polis di fine millennio. Liberaci dalla polvere che ci fa opachi. Che, privandoci di
luce, impedisce di mantenere viva la funzione essenziale del teatro, quella di celebrare il mistero della vita: come canta
il coro delle Rane di Aristofane, "mescolare cose gravi e cose buffe, questo significa celebrare i nostri misteri."
("L’ultima cena del soldato . . ." 5)
Testi citati
Alighieri, Dante. La divina commedia. Ed. N. Sapegno. Firenze: La Nuova Italia, 1968.
Attisani, Antonio. "Il verde e il nero." Martinelli, Marco. Bonifica. 7–10.
Antonine Artaud, "Situation of the Flesh." Collected Works. Ed. V Corti. London: Calder & Boyars, 1968, Vol. I.
Belpoliti, Marco. Confine. Vite immaginarie del clown. Reggio Emilia: Elitropia, 1986.
Boccaccio, Giovanni. Decameron. Ed. V. Branca. Milano: Mondadori, 1985.
Dadina, Luigi. "La torta in cielo." Martinelli, Marco. Ravenna africana. 53–55.
Dadina. Luigi. N’Diaye, Mandiaye. Griot Fulêr. San Marino: AIEP-Guaraldi, 1994.
Lorenzini, Franco. Martinelli, Marco. Saltatori di muri. La narrazione orale come educazione alla convivenza. Cesena:
Macro edizioni, 1998.
Martinelli, Marco. Rumore di acque. Ravenna: Edizioni Essegi, 1986.
–––. Ravenna africana. Il teatro politttttttico delle Albe. Ravenna: Essegi, 1988.
–––. "Breve nota delle Albe sulle Albe stesse—aprile ‘87." I brandelli della Cina che abbiamo in testa. Libretto di sala.
Bagnacavallo: Teatro Goldoni, 1987. 4–12.
–––. Siamo asini o pedanti? Farsa filosofica. Ravenna: Essegi, 1989.
–––. Lunga vita all’albero. Maggio epico. Ravenna: Essegi, 1991.
–––. Bonifica. Polittico in sette quadri. Ravenna: Essegi, 1991.
–––. I Refrattari. Drammetto edificante. Ripatransone: Sestante, 1992.
–––. "Coltura teatrale." Montanari, Ermanna. Ventrucci, Cristina. 19–21
–––. I ventidue infortuni di Mor Arlecchino. Tre atti impuri. Ravenna: Essegi, 1993.
–––. "Incantati. Parabola dei fratelli calciatori." Sipario 550 (1994): 35–49.
–––. "Per uno stabile corsaro." Ravenna Teatro 2 (1994): 3.
–––. "È finito il tempo in cui il tempo non contava." Dadina Luigi. N’Diaye, Mandiaye. 99–114.
–––. "Luce, e mondo." Spadoni, Nevio. 7–9.
–––. Moor Harlequin’s 22 Misfortunes. Picarazzi, Teresa. Feinstein, Wiley. 17–71.
–––. "Il cammino dall’idea all’opera si fa in ginocchio." Rustichelli, Luigi. 48–64.
–––. Teatro impuro. Ravenna: Danilo Montanari. 1997.
–––. "Frontiere e abissi. Il meticciato del teatro delle Albe." Lorenzoni, Franco. 113–32.
–––. "L’ultima cena del soldato: un mondo in croce." Miles. Libretto di sala. Gioia del Colle: Teatro comunale Rossini,
1999. 3–5.
Meldolesi, Claudio. "Dal vissuto delle Albe al teatro vivente dei senegalesi." Martinelli, Marco. Ravenna africana.
115–16.
Montanari, Ermanna. Rosvita. In-spirato alle opere di Rosvita di Gandersheim. Ravenna: Essegi, 1992.
–––. (Ventrucci, Cristina.) 1992—Centenario del teatro Rasi. Ravenna: Edizioni Ravenna Teatro, 1992.
–––. "Mi sono ridotta a credere di non esserci neanche tutta." Il semplice. Almanacco delle prose 4 (1996): 54–63.
–––. "Politttttttical Theatre." The Open Page. Odin teatres Forlag 3 (1998): 18–23.
N’Diaye, Mandiaye. "Il drammaturgo dei miei sogni." Lorenzoni, Franco. 83–112.
Picarazzi, Teresa. "Ermanna Montanari’s Voices. Crossing the Borders between Language and Magic." Spadoni, Nevio.
Lus. The Light. Ermanna Montanari Performs Nevio Spadoni.
Picarazzi, Teresa. Feinstein, Wiley, eds. An African Harlequin in Milan. Marco Martinelli Performs Goldoni. West
Lafayette: Bordighera Press, 1997.
Quadri, Franco. "É il matricidio il sacrificio supremo." La Repubblica. 29 Giugno 1998.
Rustichelli, Luigi, a cura di. Seminario sulla drammaturgia. West Lafayette: Bordighera Press,1998.
Spadoni, Nevio. Lus. Monologo. Faenza: Moby Dick, 1995.
–––. Lus. The Light. Ermanna Montanari Performs Nevio Spadoni. Ed. Teresa Picarazzi. West Lafayette: Bordighera
Press, 1999.
Ventrucci, Cristina. "La non-scuola delle albe." Prove di Drammaturgia 2 (1998): 25–27.