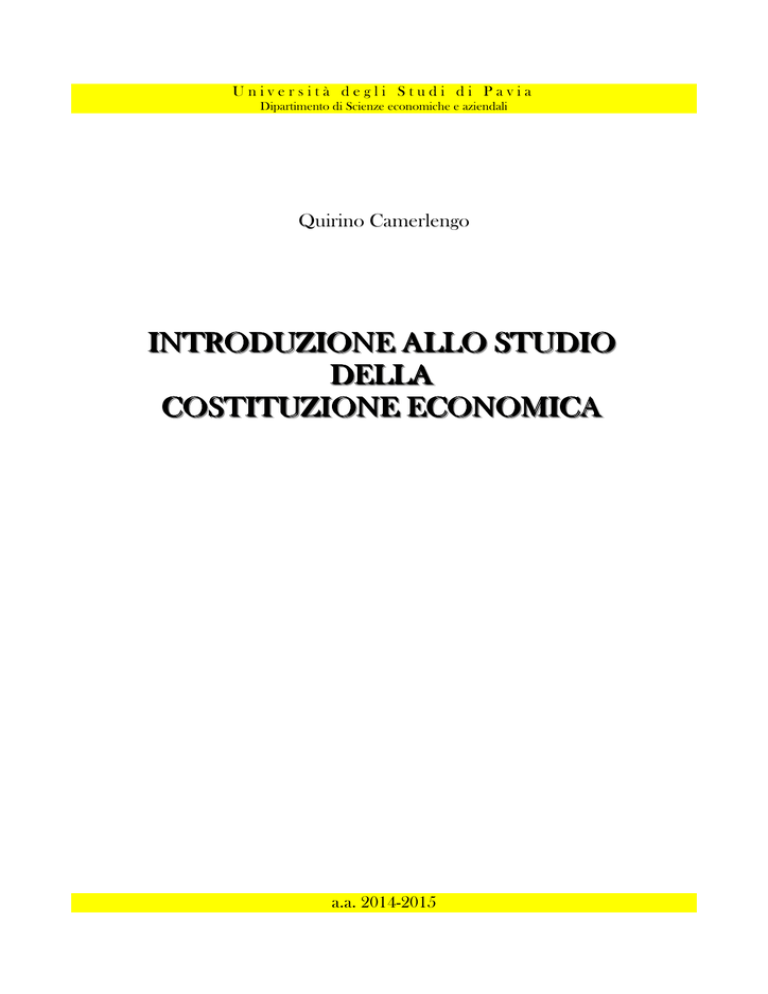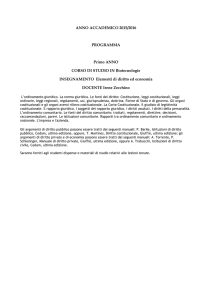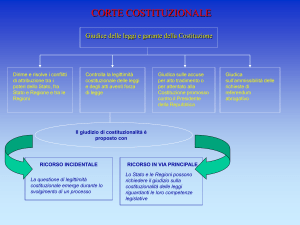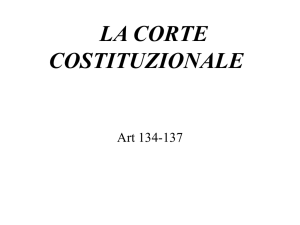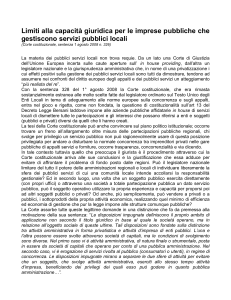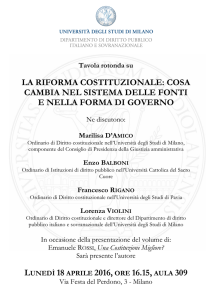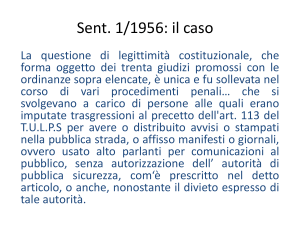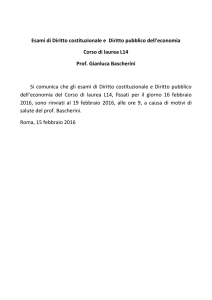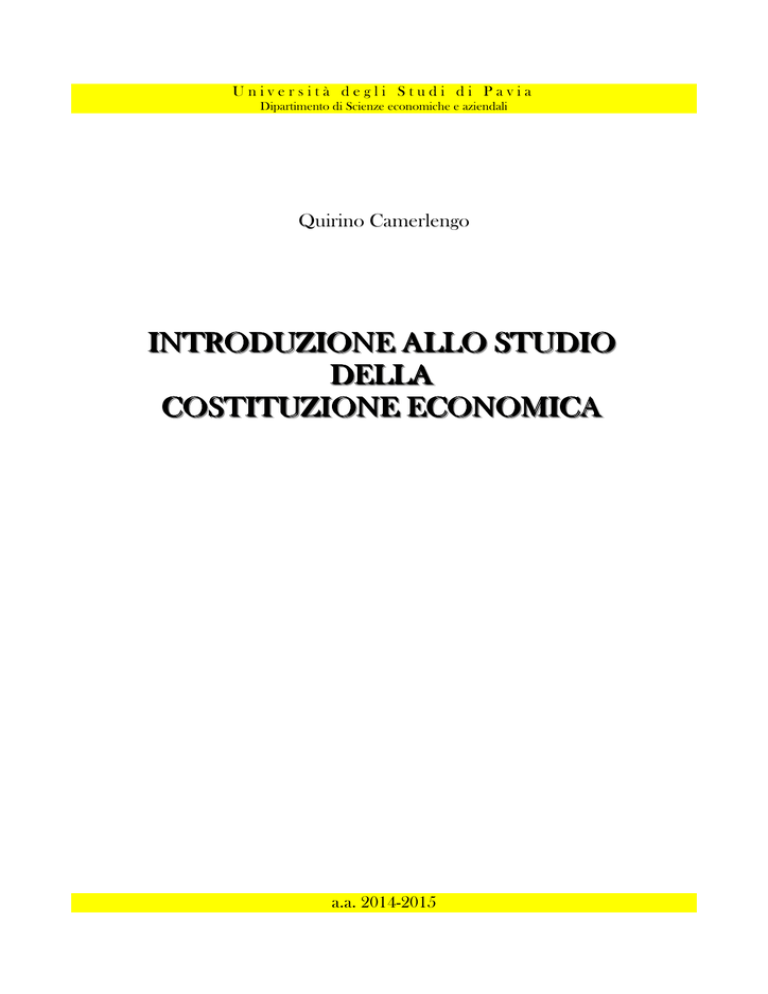
Università degli Studi di Pavia
Dipartimento di Scienze economiche e aziendali
Quirino Camerlengo
INTRODUZIONE ALLO STUDIO
DELLA
COSTITUZIONE ECONOMICA
a.a. 2014-2015
2
Presentazione della dispensa
Il corso di “Costituzione economica” (6 CFU), affine-integrativo collocato al secondo anno
della laurea triennale in Management, aspira a fornire gli strumenti necessari per interpretare il senso
e la portata delle disposizioni della Cara fondamentale in tema di rapporti economici. Questi
strumenti si rivelano necessari per affrontare il corso di “Diritto dell’economia” (6 CFU),
caratterizzante collocato al terzo anno del medesimo corso di laurea triennale in Management.
L’indice di questa dispensa chiarisce bene il percorso seguito. Da una introduzione di carattere
generale sul senso della “costituzione economica”, passando attraverso l’analisi del sistema delle fonti
del diritto, si approderà ad uno studio degli elementi qualificanti tale disciplina: i protagonisti della
costituzione economica (pubblici e privati), i mezzi utilizzati nello svolgimento delle attività
economiche, i poteri attribuiti dall’ordinamento a tali soggetti. L’epilogo sarà la descrizione di quella
vocazione sociale del sistema costituzionale con la quale dovrà fare i conti la disciplina della libertà di
iniziativa economica privata.
L’eterogeneità dei contenuti ha imposto una trattazione spesso trasversale, tale cioè da
attraversare molte branche dell’ordinamento giuridico: quindi, non solo il diritto costituzionale, ma
anche il diritto privato, il diritto commerciale, il diritto amministrativo, il diritto del lavoro e il diritto
sindacale. Non deve, perciò, destare sorpresa imbattersi in istituti e in categorie concettuali proprie di
settori scientifico-disciplinari diversi dal diritto costituzionale.
In fondo, è la stessa complessa nozione di “costituzione economica” ad imporre un simile
approccio. Che senso avrebbe studiare la libertà di iniziativa economica privata senza i necessari
rudimenti di diritto privato e, soprattutto, di diritto commerciale ? Che senso avrebbe occuparsi dei
limiti e delle condizioni che influenzano l’esercizio concreto di tale libertà senza attingere alle
categorie del diritto amministrativo ?
Quanto al metodo seguito, la dispensa è articolata in ricostruzioni e analisi condotte
direttamente dall’autore, spesso (ma non sempre) integrate da saggi, attinti da alcune fonti
bibliografiche espressamente identificate, di cui sono autori importanti studiosi. Tramite questi scritti
è possibile acquisire i necessari approfondimenti, lasciando al lettore la libertà di decidere sino a che
punto addentrarsi nei meandri di tematiche spesso complesse e intricate, persino per gli operatori del
diritto.
Nel confezionare questa dispensa il mio pensiero va a tutti gli studenti e a tutte le studentesse di
Economia a Pavia che in questi anni hanno contribuito, con la loro vivace, intelligente e, soprattutto,
tenace partecipazione ai corsi di Diritto pubblico e dell’economia e di Diritto dell’economia, a
stimolare l’interesse verso una materia complessa e multiforme come quella della costituzione
economica. Naturalmente, questa dispensa è un contenitore di idee sempre aperto. Dunque, sono
ben accette osservazioni, critiche, suggerimenti, anche semplici correzioni formali, per rendere questo
scritto sempre più congeniale alle esigenze formative di questo corso ([email protected]).
Pavia, 31 ottobre 2014
3
INDICE
Capitolo I
DIRITTO ED ECONOMIA
In questo capitolo è introdotto il tema dei rapporti tra diritto ed economia, spesso conflittuali.
La comunità e le sue regole
(pag. 8)
Le frequenti tensioni tra diritto ed economia (pag. 10)
Capitolo II
IL DIRITTO OGGETTIVO E LA NORMA GIURIDICA
Il secondo capitolo mira a descrivere il concetto di “diritto oggettivo” e la nozione di “norma giuridica”, mettendo in luce
le differenze rispetto ad altre forme di regolamentazione sociale.
Il diritto oggettivo come insieme di norme giuridiche (pag. 12)
Capitolo III
LE FONTI DEL DIRITTO
Questo capitolo illustra il concetto di “fonte del diritto” e tratta del problema dei contrasti tra fonti, esaminando i diversi
criteri di risoluzione.
Introduzione (pag. 15)
Il diritto oggettivo come sistema normativo e il problema delle antinomie tra fonti del diritto (pag. 16)
I criteri di risoluzione delle antinomie (pag. 18)
Alcune riflessioni e precisazioni (pag. 22)
Capitolo IV
VERSO LO STUDIO DELLA COSTITUZIONE ECONOMICA
Partendo dalla nozione generale di “costituzione” e passando attraverso lo studio dei caratteri propri della Costituzione
italiana, questo capitolo focalizza l’attenzione sulla controversa nozione di “costituzione economica”
Sezione I
LA COSTITUZIONE IN GENERALE
La nozione di costituzione nella teoria generale (pag. 37)
S. BARTOLE, voce Costituzione (dottrine generali e diritto costituzionale), in Dig. IV ed.,
Disc. pubbl., vol. IV, Utet, Torino, 1989, pp. 288 ss.
Sezione II
LA COSTITUZIONE ITALIANA
Storia, caratteri e princìpi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana (pag. 50)
V. ONIDA, voce Costituzione italiana, in Dig. IV ed., Disc. pubbl., vol. IV, Utet, Torino,
1989, pp. 321 ss.
4
Sezione III
LA COSTITUZIONE ECONOMICA
Il fattore economico nella Costituzione (pag. 66)
M. LUCIANI, voce Economia nel diritto costituzionale, in Dig. IV ed., Disc. pubbl., vol. V,
Utet, Torino, 1990, pp. 373 ss.
L’evoluzione della costituzione economica italiana (pag. 76)
Capitolo V
I SOGGETTI DELLA COSTITUZIONE ECONOMICA
Il capitolo quinto è dedicato ai protagonisti, sia sul versante pubblico sia su quello privato, della costituzione economica.
In particolare, nella parte dedicata agli organi di garanzia è trattato il tema, centrale nella costituzione economica, delle
autorità amministrative indipendenti. Quanto ai soggetti privati, partendo dalla distinzione tra persone fisiche e persone
giuridiche, una breve disamina è dedicata alle società.
Sezione I
I SOGGETTI PUBBLICI
Lo Stato (pag. 80)
L. ORNAGHI, voce Stato, in Dig. IV ed., Disc. pubbl., vol. XV, Utet, Torino, 1999, pp. 25
ss.
Considerazioni sul concetto tradizionale di Stato (pag. 91)
Il Parlamento (pag. 92)
Il Governo (pag. 94)
La pubblica amministrazione (pag. 95)
L’ordine giudiziario (pag. 96)
Gli organi di garanzia (pag. 97)
M. POTO, voce Autorità amministrative indipendenti, in Dig. IV ed., Disc. pubbl., Agg.,
vol. III, Utet, Torino, 2008, pp. 54 ss.
Le autonomie territoriali e funzionali (pag. 103)
Le istituzioni dell’Unione europea (pag. 104)
Sezione II
I SOGGETTI PRIVATI
Persone fisiche e persone giuridiche (pag. 105)
5
Q. CAMERLENGO, Lobbies e processi di decisione politica, in F. Rigano (a cura di), La
Costituzione in officina. Il primo intervento urgente, Pavia University Press, Pavia, 2013,
pp. 37 ss.
Capitolo VI
GLI OGGETTI DELLA COSTITUZIONE ECONOMICA
Il capitolo sesto è dedicato ai beni (pubblici, privati, comuni) quali strumenti per l’attività svolta dia diversi protagonisti
della costituzione economica.
Sezione I
I BENI PRIVATI (pag. 115)
F. MACARIO, Commento all’art. 42, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di),
Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 864 ss.
Sezione II
I BENI PUBBLICI (pag. 122)
Sezione III
I BENI COMUNI (pag. 123)
L. RAMPA, Q. CAMERLENGO, I beni comuni tra diritto ed economia: davvero un tertium
genus ?, in Politica del diritto, 2014, pp. 253 ss.
Capitolo VII
GLI STRUMENTI DELLA COSTITUZIONE ECONOMICA
Sezione I
I POTERI DEI SOGGETTI PUBBLICI
Nella parte dedicata alla funzione legislativa saranno esaminate diverse forme di trasformazione della “legge” (leggiprovvedimento, leggi incentivo, leggi di interpretazione autentica). C’è poi la parte dedicata alla manovra di bilancio e alla
legge di stabilità. Una specifica attenzione è poi riservata alla legge regionale, anche in ambito finanziario. Quanto alla
funzione amministrativa, una specifica attenzione verrà dedicata al concetto di discrezionalità amministrativa.
La funzione legislativa (pag. 139)
L. ANTONINI, L’autonomia finanziaria delle Regioni tra riforme tentate, crisi economica e
prospettive, in RivistaAIC, 2014.
La funzione amministrativa (pag. 163)
I servizi pubblici (pag. 171)
A. LUCARELLI, Commento all’art. 43, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di),
Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 883 ss.
giurisdizionale
La funzione giu
risdizionale (pag. 186)
Sezione II
I POTERI DEI SOGGETTI PRIVATI
6
Questa sezione è dedicata al concetto di diritto soggettivo e alle sue classificazioni. Si passerà quindi all’analisi del negozio
giuridico (con classificazione dei contratti) e della responsabilità. Una specifica attenzione verrà naturalmente dedicata
all’analisi dell’art. 41 Cost. e allo studio delle più importanti previsioni relative al diritto al lavoro.
Le posizioni giuridiche soggettive (pag. 187)
legittimo
imo (pag. 192)
Diritto soggettivo e interesse legitt
La libertà di iniziativa economica privata (pag. 195)
R. NIRO, Commento all’art. 41, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di),
Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 846 ss.
Il diritto al lavoro (pag. 206)
A. CARIOLA, Commento all’art. 4, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di),
Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 114 ss.
I sindacati e la contrattazione collettiva (pag. 219)
A. D’ALOIA, Commento all’art. 39, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di),
Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 796 ss.
C. COLAPIETRO, Commento all’art. 36, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di),
Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 739 ss.
O. ROSELLI, Commento all’art. 40, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di),
Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 825 ss.
Capitolo VIII
LA DIMENSIONE SOCIALE DELLA COSTITUZIONE ECONOMICA
In quest’ultimo capitolo la costituzione economica dovrà confrontarsi con l’anima sociale del sistema costituzionale, con
particolare riferimento all’impatto prodotto su di essa dal principio di eguaglianza sostanziale. Al termine, verrà esposta la
tesi della promozione sociale quale valore costituzionale volto a stimolare la mobilità sociale.
Introduzione (pag. 257)
I princìpi costituzionali ad alta valenza sociale (pag. 257)
A. GIORGIS, Commento all’art. 3, secondo comma, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti
(a cura di), Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 88 ss.
I diritti sociali (pag. 272)
Dall’eguaglianza sostanziale alla promozione sociale (pag. 280)
Q. CAMERLENGO, Costituzione e promozione sociale, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 337
ss.
7
Capitolo I
DIRITTO ED ECONOMIA
La comunità e le sue regole
Ogni comunità organizzata non può fare a meno di regole per garantire la propria
sopravvivenza. La vita della comunità, infatti, si manifesta attraverso relazioni tra i propri componenti,
i cosiddetti “consociati”. Tali relazioni riflettono interessi,
interessi di diversa natura, di cui i singoli consociati
sono titolari. A loro volta, questi interessi possono entrare in conflitto,
conflitto risultando tra di loro
incompatibili. Il contrasto tra interessi, se non risolto, può turbare la pacifica convivenza e, se esteso
su vasta scala, può condurre all’anarchia ed al caos. Sono, dunque, necessarie regole per decidere
quale, tra gli interessi in conflitto, merita di prevalere (→ dirimere una controversia; comporre una
lite).
Un esempio può aiutare a comprendere questa dinamica. Il proprietario (Tizio) di un terreno ha diritto di
godere pienamente di tale bene: in particolare, egli ha diritto, com’è intuibile, di impedire agli altri l’accesso al suo
terreno. Un altro soggetto (Caio), proprietario del terreno confinante, vanta gli stessi diritti. Diversamente dal
primo, però, per la particolare posizione del fondo di sua proprietà, non ha accesso diretto alla strada pubblica. In
pratica, tra il terreno e la strada pubblica c’è di mezzo proprio il fondo di Tizio. È altrettanto intuibile che Caio
abbia, come qualsiasi consociato, diritto di utilizzare la strada pubblica e, quindi, di raggiungere il proprio fondo.
Caio inizia ad attraversare il terreno di Tizio con l’automobile. Tizio per un po’ di tempo tollera, ma ad un certo
punto non sopporta più i continui passaggi di Caio e fa recintare il terreno, munendolo di un cancello di accesso
provvisto di serratura. Nasce un conflitto tra Tizio e Caio: il primo ha interesse a che il suo terreno non sia rovinato
dai continui attraversamenti di altre persone; il secondo ha interesse a raggiungere il proprio fondo dalla strada
pubblica. Il conflitto rischia di degenerare in atti di violenza (in verità, già la repentina realizzazione del recinto
chiuso potrebbe considerarsi quale atto di “violenza”). Come prevenire il conflitto ? Come risolvere un conflitto
eventualmente nato tra i due contendenti ?
I conflitti, all’interno di una determinata comunità sociale, possono essere prevenuti e, se del
caso, risolti attraverso la fissazione di regole. Una regola è uno schema astratto di qualificazione entro
il quale ricondurre un concreto fatto della vita che pone in contrasto i titolari di interessi confliggenti
(→ sussunzione del caso concreto). La regola, cioè, stabilisce che, in presenza di determinate
situazioni, si hanno altrettanto determinate conseguenze. In estrema sintesi, la regola descrive un
rapporto di causa/effetto (→ rapporto di causalità; nesso eziologico).
Facciamo qualche esempio di regole volte a dirimere contrasti all’interno della comunità. Chiunque cagiona
la morte di un uomo, è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Così recita l’art. 575 del codice
penale. Questa regola pone in relazione un comportamento (l’uccisione di un uomo) con una reazione (la
reclusione dell’omicida): in altri termini, se uccidi un uomo (causa), finirai in prigione (effetto). Altro esempio,
meno cruento. Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare (ad esempio,
perché minore d’età). Questa è la previsione dell’art. 1425 del codice civile. Ciò significa che un contratto stipulato
da una persona incapace secondo la legge (causa) può essere annullato (effetto). O, ancora: secondo l’art. 68 della
Costituzione, i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti
dati nell’esercizio delle loro funzioni. Pertanto, un deputato che, nel corso di una seduta alla Camera, esprime
dichiarazioni offensive in merito all’operato di un magistrato (causa), non può essere processato e, quindi,
condannato da alcun giudice (effetto).
Già da questi pochi esempi affiora chiaramente l’importanza delle regole. In una comunità che
ha raggiunto un sufficiente livello di civiltà, ogni contrasto deve essere risolto da un soggetto terzo
rispetto ai contendenti (un giudice, un arbitro, una giuria, una commissione di esperti, ecc.). è
fondamentale, però, che la persona investita del compito di dirimere una lite possa decidere secondo
regole predeterminate, in modo tale da garantire un giudizio equo e neutrale. La condizione ideale
8
sarebbe, comunque, che ogni consociato conoscesse in anticipo le regole e le rispettasse, in modo tale
da evitare conflitti.
Il giudice, quindi, una volta conosciuti i fatti reali, in base alle “prove” allegate dalle parti in
conflitto, ricostruisce in maniera puntuale l’effettiva dinamica degli eventi controversi e procede al
raffronto tra il concreto comportamento contestato ed il comportamento previsto in astratto dalla
regola.
Alla luce di tale raffronto, il giudice darà ragione ad una delle parti e dichiarerà soccombente
l’altra.
Torniamo all’esempio dei due proprietari di terreni confinanti. Il problema da risolvere è il seguente: può
Tizio impedire a Caio il passaggio sul proprio terreno ? Il giudice, al quale i due litiganti si rivolgono (→ adire il
giudice), una volta ricostruita la realtà, cerca la regola da applicare al caso concreto. E la trova nel codice civile. Gli
articoli 1027 e seguenti stabiliscono, a carico del fondo che si frappone tra una strada pubblica ed un altro fondo
(→ fondo intercluso), un “peso”, consistente nell’obbligo, per il proprietario, di consentire l’attraversamento a
favore del fondo intercluso (→ servitù di passaggio). In particolare, la regola che il giudice applicherà è la seguente:
“il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela
senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il
conveniente uso del proprio fondo” (art. 1051 del codice civile). Ponendo la recinzione e non consegnando al
vicino le chiavi del cancello, Tizio impedisce a Caio di esercitare il diritto previsto dalla citata regola (causa). Il
giudice condannerà, quindi, Tizio a consentire il passaggio a Caio, ai sensi dell’art. 1079 del codice civile (effetto).
In verità, spesso senza rendercene conto, siamo circondati da regole. Viviamo applicando e
rispettando, talvolta subendo, regole.
Quando giochiamo a briscola con gli amici, rispettiamo regole (l’asso vale più del tre). Il matematico che
calcola l’area di un triangolo applica una regola (base per altezza diviso due). Il chimico che armeggia nel suo
laboratorio tra elementi e composti sa che unendo il sodio al cloro (causa) otterrà il sale (effetto). Il chirurgo, prima
di affondare il bisturi nella carne del paziente, deve rispettare severissime regole d’igiene: la carente pulizia delle
mani (causa) può provocare infezioni a danno del malcapitato paziente (effetto). E così via. Provate a lasciare
un’autovettura in sosta vietata, e vi accorgerete della ... funzionalità delle regole !
L’esperienza dimostra, dunque, la complessità delle regole che ogni giorno definiscono rapporti
di causalità tra situazioni e conseguenze. Tuttavia, non tutte le regole hanno la stessa natura.
Pensiamo agli esempi dapprima riferiti. Se, nel corso di una partita a briscola, il mio avversario butta l’asso
di briscola e io rispondo con un asso di bastoni, mi ritroverò con undici punti in meno, ma la mia vita continuerà
ad essere felice. Se un matematico non applica o applica male una regola di trigonometria farà una brutta figura
con i suoi colleghi nel tentativo di dimostrare la fondatezza di una determinata congettura. Il discorso cambia se,
guidando imprudentemente, investiamo sulle strisce un pedone o se non paghiamo le tasse o se non restituiamo il
libro che il nostro amico ci ha gentilmente prestato.
Dalle esemplificazioni appena riportate emerge una prima, importante sensazione.
Le regole si differenziano tra di loro per il tipo di reazione provocata dalla loro inosservanza.
In effetti, di fronte ad una regola, il singolo consociato sa che per ottenere un determinato
risultato o per evitare una determinata conseguenza negativa (effetto) dovrà oppure non dovrà
assumere un certo comportamento (causa).
Così, se non voglio procurarmi una ustione dovrò evitare di infilare la mano nel forno acceso. Se voglio
evitare che il concessionario si riprenda la splendida decappottabile che ho appena acquistato, dovrò pagare
regolarmente tutte le rate del prezzo. Se voglio scongiurare l’esplosione del laboratorio in cui lavoro come chimico,
dovrò usare una certa cautela nel mischiare determinate sostanze. Se voglio evitare di passare il resto della mia vita
nel penitenziario di Opera, dovrò fare a meno di provocare la morte dei miei nemici.
Si tratta, dunque, di identificare le caratteristiche che permettono di classificare i diversi tipi di
regole applicate e rispettate all’interno di una data comunità.
9
Le frequenti tensioni tra diritto ed economia
Di recente, uno dei maggiori studiosi di diritto costituzionale ha così osservato: «economia e
diritto parrebbero dislocarsi su due fronti contrapposti: la prima richiama la competitività, il secondo
evoca le garanzie» (Michele Ainis, in federalismi.it).
La tensione tra diritto ed economia è particolarmente forte quando sono coinvolti i diritti
fondamentali. Sovente, l’economia contesta al diritto di approntare troppe garanzie alle posizioni
individuali vantate dai consociati: si contesta alle persone di evocare diritti insaziabili. Senonché, pare
aver ragione Stefano Rodotà quando, in un articolo apparso su Repubblica del 20 ottobre 2014,
ammonisce che «non sono i diritti ad essere insaziabili, lo è la pretesa dell’economia di stabilire quali
siano i diritti compatibili con essa». E questa compatibilità è valutata non alla stregua di princìpi
giuridici condivisi o di valori morali comuni, ma alla luce di criteri economici quali quelli associati
all’analisi costi-benefici. Così, si finisce coll’affermare che, di fronte ad una crisi economica, i diritti
diventano un lusso che una società non può permettersi, al pari dell’eguaglianza.
L’Ilva di Taranto è la più grande acciaieria d’Europa, e vanta una storia pluridecennale.
Nel 2012 la procura della Repubblica di Taranto sottopone ad indagine i vertici della società
che gestisce l’Ilva con accuse pesanti: disastro doloso e colposo, avvelenamento di alimenti, omissione
dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, danneggiamento di beni pubblici, sversamento di
sostanze inquinanti. A supporto di tale accusa le perizie di parte mettono in luce la diffusione di
patologie, anche mortali, a livelli decisamente superiori rispetto alla media nazionale.
Nel corso delle indagini, al fine di evitare la reiterazione dei reati contestati e in attesa del
giudizio finale, la stessa procura dispone il sequestro cautelare degli impianti con conseguente
sospensione delle attività lavorative in esse svolte.
Interviene, quindi, il Governo, che con un apposito decreto legge revoca le misure adottate dai
magistrati requirenti. La Corte costituzionale, adìta dai giudici tarantini, rigetta la questione di
incostituzionalità sollevata contro il decreto legge. Secondo la Corte, l’intervento legislativo del
Governo rappresenta un adeguato bilanciamento tra gli interessi in gioco (→ sentenza n. 85 del
2013).
Questo episodio mette in evidenza la tensione tra diritto ed economia. Da un lato, il diritto
oggettivo impone alle imprese l’assunzione di misure volte a prevenire l’inquinamento: dunque,
misure dirette a salvaguardare il bene salute. D’altro canto, l’imprenditore, che intende massimizzare
il profitto rendendo più ampio possibile il divario tra ricavi e costi, tende a contenere le uscite. Le
misure antinquinamento costano, e anche tanto e, dunque, fino a quando può l’imprenditore, in
quanto attore economico, è indotto a limitare le proprie spese da questo punto di vista. In breve, il
diritto impone alle imprese costi che queste farebbero volentieri a meno di sostenere.
Nel caso dell’Ilva di Taranto, il quadro si complica perché oltre al bene “salute” e al bene
“iniziativa economica” entra in gioco anche il bene “lavoro” (peraltro, come vedremo, tutti beni
riconosciuti e protetti dalla nostra Costituzione): una impresa che inquina, superando le soglie
accettabili e non adottando i necessari accorgimenti, è una impresa che deve chiudere, perché lo
impone il diritto. Ma un’impresa che chiude è anche un’impresa che licenzia, perché l’imprenditore
non ha più bisogno di manodopera.
Si pone, quindi, in questo come in tantissimi altri casi analoghi, un problema di bilanciamento
tra beni ed interessi che, talvolta, confliggono. Diritto ed economia entrano in tensione in quanto il
punto di equilibrio cercato da entrambi può anche non coincidere. Il diritto opera secondo criteri
politici. L’economia opera secondo criteri di efficienza. Il diritto riflette l’indirizzo politico di chi
governa, di chi ha il potere, di chi dunque decide attraverso le leggi. L’economia segue altri percorsi,
segnati dalla ponderazione dei ricavi, dei costi, delle esternalità, delle efficienti allocazioni delle risorse
disponibili, dell’incontro tra domanda e offerta, delle utilità.
10
Un altro esempio è particolarmente significativo. Nell’ottobre 2014 il Governo Renzi mette in
pericolo il rapporto fiduciario con la sua maggioranza parlamentare perseguendo l’obiettivo di
modificare l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. L’art. 18 della legge n. 300 del 1970 mira a garantire
la stabilità del posto di lavoro. Nelle aziende con più di quindici dipendenti, in caso di licenziamento
illegittimo è previsto il reintegro nel posto di lavoro. Il Governo Renzi intende circoscrivere l’obbligo
di reintegro solo a casi eccezionali (ad es., in caso di licenziamento discriminatorio). I sindacati e
persino una parte del partito di maggioranza insorgono, denunciando il venir meno di una
importante, vitale garanzia per i lavoratori subordinati, i quali, quand’anche venisse riconosciuta dal
giudice l’illegittimità del licenziamento, dovrebbero accontentarsi di un indennizzo per la perdita del
lavoro.
Il diritto oggettivo, tramite l’art. 18, ha inteso condizionare le scelte dell’imprenditore quanto al
dimensionamento della propria azienda sul versante della manodopera. Il datore di lavoro, dal canto
suo, comportandosi da attore economico, vorrebbe poter contare su ampi margini di manovra,
ponendo fine ai rapporti di lavoro quando una situazione di crisi o una esigenza di riconversione o di
ammodernamento della struttura produttiva dovessero richiederlo.
Eliminando l’obbligo di reintegro nel caso dei licenziamenti cd. “economici” (cioè, per ragioni
di ristrutturazione dell’azienda), il punto di equilibrio tra beni in conflitto tende a spostarsi sul
versante dell’impresa, nel convincimento che una maggiore libertà nella gestione dei rapporti di
lavoro possa favorire la ripresa del sistema produttivo italiano.
Ancora. Tutte le volte che la legge prevede una autorizzazione, una concessione, una licenza,
un permesso, e via discorrendo, per intraprendere un’attività economica, il diritto oggettivo finisce col
porre dei costi alle imprese. Quanto più pesante è la burocrazia, tanto più complicato sarà svolgere
un’attività economica. E si pensi, poi, ai requisiti logistici, alle incombenze burocratiche per la
gestione del personale, ai certificati da presentare, ai controlli cui sottoporsi periodicamente.
Invece, una volta imboccata la strada delle liberalizzazioni, gli oneri burocratici a carico delle
imprese tenderanno a diminuire significativamente, spostando il punto di equilibrio verso le ragioni
delle imprese.
Pertanto, alla luce di questi esempi, e di tanti altri che l’immaginazione e la conoscenza reale
dei fatti aiuterebbero a intercettare, appare importante descrivere e analizzare il rapporto, spesso
controverso, tra diritto ed economia.
11
Capitolo II
IL DIRITTO OGGETTIVO E LA NORMA GIURIDICA
Il diritto oggettivo come insieme di norme giuridiche
Il diritto oggettivo è l’insieme delle norme giuridiche vigenti in un dato ordinamento.
L’ordinamento
ordinamento giuridico è a sua volta l’insieme delle istituzioni e delle norme che operano all’interno
di uno Stato. Lo Stato è l’organizzazione giuridica complessa in cui sono presenti tre elementi
costitutivi: il territorio, il popolo, il governo.
Il diritto positivo è l’insieme delle norme giuridiche che, all’interno di uno Stato, sono prodotte dalle
istituzioni titolari del potere normativo (dal latino positum, ossia “posto”, prodotto). È una nozione che,
sostanzialmente coincide con quella di diritto oggettivo, anche se viene in essa rimarcata l’origine delle norme dalle
istituzioni che l’ordinamento statale autorizza a produrre norme giuridiche. Il diritto positivo diverge dal diritto
naturale.
naturale Questo è l’insieme di regole che aspirano a disciplinare i rapporti umani in quanto espressione di
razionalità (dimensione laica) oppure in quanto espressione della volontà di una divinità superiore agli uomini
(dimensione spirituale). Negli attuali ordinamenti occidentali, i giudici applicano il diritto positivo, e non il diritto
naturale, in quanto solo il primo è espressione della volontà manifestata da istituzioni sulle quali il popolo può
esercitare poteri di delega e di controllo. Margini significativi di azione del diritto naturale si hanno
nell’ordinamento internazionale, che regge i rapporti tra gli Stati. In altri ordinamenti vi è una tale
compenetrazione tra norme giuridiche e precetti religiosi da non poter distinguere il diritto positivo dal diritto di
matrice religiosa (si pensi alla sharī’ah nei paesi di area islamica).
A sua volta, la norma giuridica è lo schema di qualificazione che associa una determinata
conseguenza ad una determinata causa. La norma giuridica definisce un rapporto di causalità tra
comportamento ed effetto giuridico, secondo lo schema, se A, allora B.
Tutte le regole sociali definiscono questo rapporto, allo scopo di garantire l’ordinato e pacifico
svolgimento delle relazioni tra i membri di una data comunità. Tuttavia, la norma giuridica presenta
alcune caratteristiche proprie, diverse da quelle delle altre norme sociali:
a) esteriorità:
esteriorità la norma giuridica è prodotta sempre da un soggetto diverso da quello che è
chiamato a rispettarla;
b) generalità e astrattezza:
astrattezza la norma giuridica non si riferisce a situazioni specificamente e
puntualmente identificate, ma descrive una determinata condotta attraverso l’individuazioni di alcuni
elementi essenziali. Così, solo se ricorrono nel caso concreto tutti quegli elementi, allora si farà
applicazione di quella norma.
Si pensi, ad esempio, al reato di furto. La norma giuridica non dice: «se Mario Bianchi, nato a Milano il 28
febbraio 1975, sottrae il motorino a Giulio Rossi, nato a Pavia il 25 dicembre 1980, è punito con la reclusione fino
a tre anni». La norma giuridica, invece, stabilisce: «chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a
chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da euro 154 a euro 516» (art. 624 del codice penale). Il furto semplice è descritto in termini generali e
astratti: perché possa trovare applicazione la norma giuridica è necessario verificare che, in concreto: a) qualcuno
abbia compiuto un atto di impossessamento; b) che oggetto di tale atto sia un bene mobile; c) che tale bene mobile
sia di altri; d) che vi sia stata sottrazione del bene a danno di chi lo detiene; e) che chi ha agito lo abbia fatto per
trarne, per sé o per altri, un profitto. È sufficiente che difetti anche uno solo di questi elementi, che il giudice non
condannerà il presunto ladro.
c) coattività:
coattività la norma giuridica è assistita da una sanzione,
sanzione vale a dire da una conseguenza
negativa che affligge colui che ha violato la norma stessa. Chi subisce una sanzione è giuridicamente
responsabile
responsabile in quanto ha posto in essere un comportamento divergente da quanto stabilito dalla
12
norma giuridica. Anche le norme sociali hanno una sanzione (così, ad esempio, chi non ricambia il
saluto può subire una reazione di biasimo da parte degli altri). Tuttavia, la sanzione della norma
giuridica ha una caratteristica particolare: può essere imposta anche contro la volontà del trasgressore
mediante l’uso della forza (in ciò sta la coattività).
Così, chi commette il reato di furto subirà un processo e, una volta condannato in via definitiva, subirà la
sanzione prevista dalla norma, anche contro la sua opposizione: le forze di polizia potranno costringerlo
legittimamente ad andare in carcere o a corrispondere la somma di denaro a titolo di multa. Chi non restituisce
una somma avuta a prestito da un istituto di credito, sarà condannato dal giudice a corrispondere la somma dovuta,
con gli interessi e le spese processuali. In caso di rifiuto, i suoi beni potranno essere pignorati e, cioè, venduti
all’asta, così che il ricavato sarà destinato a estinguere il debito verso la banca.
Relativamente a due dei tre caratteri essenziali della norma giuridica appena descritti bisogna,
però, fare alcune precisazioni.
1) Quanto alla generalità e astrattezza, questo requisito è il riflesso del principio di eguaglianza.
In effetti, per evitare discriminazioni tra soggetti che versano in condizioni sociali, economiche,
culturali, diverse, la norma giuridica si applica in maniera uniforme, indirizzandosi alla moltitudine
indistinta dei membri che compongono una data comunità. Tuttavia, come si avrà modo di notare
più avanti a proposito delle trasformazioni della legge, non mancano norme giuridiche che, pur
essendo tali, si rivolgono direttamente a soggetti o situazioni specificamente identificati.
2) Quanto alla coattività, non tutte le norme giuridiche sono assistite da una sanzione. «La
capacità giuridica si acquista al momento della nascita»: così recita l’art. 1 del codice civile. In questo
caso la sanzione non c’è. La norma giuridica, che tale è in quanto prodotta da un atto idoneo a creare
diritto oggettivo, stabilisce che l’attitudine degli individui a diventare soggetti di diritti soggettivi e di
doveri si acquista pienamente con la venuta al mondo. In altri casi, poi, la norma giuridica è sì
presidiata da una sanzione, ma questa è diversa dalla concezione tradizionale di sanzione. Così, un
contratto stipulato da un minorenne è annullabile in quanto senza capacità di agire (che si acquista al
compimento del diciottesimo anno di età) non si possono concludere validamente negozi giuridici.
Pertanto, pur senza sanzione, una regola ben può essere considerata quale norma giuridica se
stabilisce un rapporto di causalità tra un determinato fatto e un effetto giuridico, ossia una
conseguenza rilevante per il diritto oggettivo.
La coattività delle norme giuridiche segna il passaggio da una condizione di anarchia, in cui ogni
individuo esercita le proprie libertà anche avvalendosi della forza contro gli altri, ad una comunità
organizzata in cui la forza viene assegnata e gestita da apposite autorità o istituzioni o strutture. Più
precisamente, nelle comunità sociali più avanzate, lo Stato è l’ente dotato del monopolio dell’uso
della forza. Solo lo Stato, attraverso i propri apparati (giudici, forza di polizia, esercito ecc.), può
legittimamente ricorrere alla forza per ottenere il rispetto (per l’appunto coattivo) delle norme
giuridiche. Solo in casi assolutamente eccezionali, il singolo consociato può ricorrere alla forza per
preservare i propri diritti.
La legittima difesa e lo stato di necessità, ad esempio, sono situazioni in cui il singolo consociato ricorre alla
forza in caso di necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta
oppure se è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona
(pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile). In questo modo, egli non sarà responsabile
per i danni così provocati (→ Cause di giustificazione o esimenti o scriminanti). Ovviamente, il ricorso alla forza da
parte dell’individuo non dovrà oltrepassare la soglia dell’uso arbitrario o sproporzionato dei propri mezzi di difesa.
In effetti, il codice penale punisce il cd. esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392) o
sulle persone (art. 393). È tale, ad esempio, il caso di chi, imbattendosi in una autovettura parcheggiata in un passo
carraio posto davanti alla propria abitazione, usa la forza fisica per rimuoverla: occorre, invece, chiedere
l’intervento della polizia municipale.
In altri casi, anch’essi tassativamente ed eccezionalmente previsti, è la stessa norma giuridica che attribuisce
al singolo consociato il potere di ricorrere alla forza per ripristinare l’ordine violato. Così, l’art. 383 del codice di
procedura penale stabilisce che, nei casi in cui sia obbligatorio l’arresto in flagranza di reato (art. 380), ogni persona
13
è autorizzata a procedere all’arresto. L’arresto è una limitazione coattiva della libertà personale e, dunque,
rappresenta una delle modalità più incisive di ricorso alla forza per ottenere il rispetto delle norme giuridiche.
14
Capitolo III
LE FONTI DEL DIRITTO
Introduzione
La nozione di “fonte
fonte del diritto”
diritto è associata alla produzione e alla conoscenza delle norme
giuridiche. In effetti:
a) per fonte di produzione del diritto s’intende qualsiasi atto o fatto al quale l’ordinamento
attribuisce l’idoneità a produrre norme giuridiche;
b) per fonte sulla produzione del
del diritto s’intende l’atto che individua i soggetti e le modalità di
produzione del diritto;
c) per fonte di cognizione s’intende l’atto che consente, in via ufficiale, la conoscenza delle
norme giuridiche.
Più nel dettaglio...
a) Si definiscono fonti di produzione del diritto oggettivo gli atti o i fatti abilitati
dall’ordinamento a porre norme giuridiche. Questa definizione riflette una prima distinzione:
- le fontifonti-atto sono manifestazioni di volontà, tradotte in documenti, poste in essere da organi o
autorità legittimate a produrre norme giuridiche.
È questa la figura tipica di fonte di produzione del diritto oggettivo. Si pensi, ad esempio, ad una legge
approvata dal Parlamento. Il Parlamento, assemblea composta dai rappresentanti dell’elettorato, organo supremo
dello Stato, è legittimato dall’ordinamento italiano ad esercitare la funzione legislativa. Quest’ultima si realizza
attraverso l’approvazione di leggi che, a loro volta, sono manifestazioni di volontà idonee a produrre norme
giuridiche (norme legislative, come si suol dire). O, anche, un decreto-legge è una fonte-atto di produzione di
norme giuridiche che il Governo, espressione della sola maggioranza parlamentare, organo supremo dello Stato,
titolare del potere esecutivo, può adottare in casi straordinari di necessità ed urgenza. E gli esempi potrebbero
continuare: decreti legislativi, statuti e leggi regionali, regolamenti del Governo, statuti e regolamenti di Province e
Comuni, decreti ministeriali. La stessa Costituzione è qualificabile come fonte-atto. Tutte manifestazioni di volontà,
imputabili ad organi qualificati, che confluiscono in atti redatti, per l’appunto, per iscritto. Si badi bene: la scrittura
è elemento costitutivo di tali fonti, e non assolve semplicemente una funzione conoscitiva.
- le fontifonti-fatto sono comportamenti che, in presenza di determinati presupposti, sono abilitati a
produrre norme giuridiche. La fonte-fatto per eccellenza è la consuetudine. La consuetudine consiste
in un comportamento, reiterato in modo uniforme dalla generalità dei consociati per un certo lasso di
tempo, e sorretto dalla convinzione di osservare una norma giuridica. Come si deduce da questa
definizione, affinché si abbia una consuetudine, come fonte-fatto di produzione del diritto oggettivo, è
necessario il concorso di due presupposti:
- elemento materiale: ripetizione di una condotta uniforme da parte della grande maggioranza
dei consociati. Non è stabilito quanto lungo debba essere il lasso di tempo ai fini della formazione di
una regola consuetudinaria, né quanto diffuso, presso i consociati, debba essere il comportamento
obbligatorio. Spetterà ai giudici verificare, caso per caso, la nascita della consuetudine, tenuto conto
del contesto, dell’incisività della regola, del tipo di rapporti regolati, e via dicendo;
- elemento psicologico: la ripetizione della condotta uniforme da sola non basta. È
indispensabile che i consociati tengano quel dato comportamento convinti di rispettare una norma
giuridica, cioè una regola che impone loro quel comportamento pena l’applicazione di una sanzione.
Anche in questo caso il ruolo dei giudici sarà decisivo nel verificare l’avvenuta creazione di una
consuetudine.
15
La stragrande maggioranza degli italiani inizia la giornata con la colazione, più o meno ricca. Si può,
dunque, affermare che la colazione costituisce un comportamento ripetuto nel tempo, in modo uniforme, dalla
generalità dei consociati. Ma è una consuetudine ? Siamo, cioè, in presenza di una fonte-fatto del diritto ? In
questo caso, manca senz’altro l’elemento psicologico. I consociati fanno colazione per iniziare bene la giornata, per
acquisire le risorse energetiche indispensabili per non svenire in ufficio, ma non certo per osservare una regola
giuridica. Astenersi da fare colazione non comporta l’applicazione di alcuna sanzione giuridica, ma solo il biasimo
di familiari o del medico.
Diversamente dai sistemi normativi più antichi, negli ordinamenti moderni, a parte rarissime seppur
importanti eccezioni, la consuetudine è divenuta la fonte “meno importante” (più avanti preciseremo questa
qualificazione). Infatti, l’esigenza fondamentale di certezza del diritto, in forza della quale i consociati possono
prevedere le conseguenze giuridiche delle loro azioni, appare meglio soddisfatta da norme scritte, agevolmente
accessibili, piuttosto che da fatti di problematica identificazione. L’affermazione della fonte-atto, come modello
privilegiato di strumento normativo, è contestuale alla consacrazione del Parlamento come organo legislativo: una
assemblea che rappresenta il popolo. Al contrario, la consuetudine valorizza eccessivamente il ruolo dei giudici,
che invece sono preposti all’esercizio della funzione giurisdizionale. Allo stato attuale, dunque, nel nostro
ordinamento le consuetudini sono rinvenibili soltanto in relazione ad alcuni settori commerciali o agricoli. Talora,
è lo stesso codice civile che fa esplicito rinvio agli “usi locali”, ma sempre in caso di mancanza di regolamentazione
da parte di altre fonti (ad esempio, l’art. 892 del codice civile in materia di distanze degli alberi dai confini dei
terreni).
b) Quanto alle fonti sulla produzione, ci si limita ad osservare che ad esse spetta il compito di
identificare l’organo al quale è attribuito il potere di produrre norme giuridiche e di disciplinare la
procedura di produzione delle norme stesse. Così, ad esempio, la Costituzione è una fonte sulla
produzione in tutte le previsioni che regolano, dal punto di vista soggettivo e dal punto di vista
procedurale, la produzione di norme giuridiche.
c) Quanto alle fonti di cognizione, nel nostro ordinamento sono tali la Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana e, in ogni Regione, il Bollettino ufficiale. Le fonti di produzione del diritto
iniziano a produrre i loro effetti (e, dunque, devono essere rispettate) solo con la pubblicazione in
questi documenti. La conoscenza del diritto oggettivo è la condizione indispensabile affinché operi
l’obbligo di rispettare le norme giuridiche. La conoscenza si acquisisce dal momento della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale o, nel caso delle fonti regionali di produzione del diritto, nel
rispettivo Bollettino ufficiale. Tutto ciò è connesso al valore fondamentale della certezza del diritto:
diritto
ogni individuo deve poter conoscere in anticipo le conseguenze giuridiche delle proprie azioni. Ciò
che si richiede agli individui è di adoperarsi per conoscere il diritto, in quanto ignorantia legis non
excusat.
Con una sentenza del 1988 la Corte costituzionale ha precisato che, fermo restando che la mancata
conoscenza di una norma giuridica non può giustificare chi l’ha violata, nondimeno se un individuo,
comportandosi diligentemente, ha fatto tutto il possibile per conoscere il diritto applicabile alle proprie azioni (ad
esempio, rivolgendosi ad uno specialista di quel settore), allora il suo errore è scusabile e, dunque, non subirà
alcuna sanzione.
Il diritto oggettivo come sistema normativo
e il problema delle antinomie tra fonti del diritto
In un ordinamento complesso come il nostro sono molteplici le fonti di produzione del diritto.
Senza ambizione di completezza, si pensi alle seguenti fonti: costituzione, leggi di revisione
costituzionale, leggi costituzionali, statuti regionali speciali, leggi statutarie delle regioni a statuto
speciale, leggi ordinarie del Parlamento, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti di Camera e di
Senato, statuti regionali ordinari, leggi regionali (e delle province autonome di Trento e di Bolzano),
regolamenti governativi, regolamenti regionali, regolamenti provinciali, regolamenti comunali,
regolamenti delle autorità amministrative indipendenti, decreti ministeriali, consuetudini. E questo è
un elenco incompleto, sol che si pensi che nel nostro ordinamento producono effetti anche fonti del
16
diritto poste in essere al di fuori del nostro paese: così, ad esempio, i regolamenti e le direttive
comunitarie.
Si suole affermare che il nostro sistema delle fonti è policentrico in quanto il potere di produrre
norme giuridiche non è concentrato in capo ad una sola istituzione, ma è distribuito tra più autorità: il
Parlamento, il Governo, i Consigli e le Giunte regionali, gli organi di governo degli enti locali, le
amministrazioni indipendenti. Il pluralismo delle fonti del diritto è congeniale ad una migliore cura
degli interessi generali, in quanto si tiene conto delle specificità di alcune materie e delle peculiarità
dei processi decisionali presso determinate istituzioni.
Tuttavia, c’è anche il rovescio della medaglia. La proliferazione di fonti del diritto spesso
conduce ad una situazione conflittuale, nel senso che il medesimo caso della vita risulta regolato in
modo difforme da due o più fonti di produzione del diritto.
diritto Ebbene, quando lo stesso fatto, posto
all’attenzione di un giudice o di un pubblico funzionario, si rivela regolato da (almeno) due diverse
norme giuridiche, allora si è in presenza di una antinomia tra fonti del diritto.
diritto
Prima di procedere oltre soccorrono due importanti precisazioni:
a) un fatto è regolato in modo diverso da due distinte norme giuridiche (prodotte da due
diverse fonti del diritto) quando le due norme prevedono lo stesso fatto, ma ad esso attribuiscono
conseguenze diverse.
Ecco un esempio. Lo stesso fatto è: apertura di un esercizio commerciale. La norma A, prodotta da una
legge regionale, stabilisce che: «chi intende intraprendere una attività commerciale deve chiedere l’autorizzazione al
sindaco competente». La norma B, prodotta da un regolamento comunale, stabilisce che: «chi intende
intraprendere una attività commerciale deve darne comunicazione al sindaco competente». Sussiste una antinomia,
ossia un contrasto, tra le norme A e B in quanto esse associano al medesimo fatto due conseguenze diverse;
b) si hanno diverse fonti del diritto, che producono differenti norme giuridiche, non solo
quando le fonti appartengono a tipologie diverse (antinomia eterogenea), ma anche quando si tratta di
fonti dello stesso tipo, ma poste in essere in momenti temporali distinti (antinomia omogenea).
Si ha, quindi, antinomia sia nel caso di contrasto, come nell’esempio prima descritto, tra una legge regionale
e un regolamento comunale (antinomia eterogenea), sia nel caso di contrasto, ad esempio, tra una legge del
Parlamento del 2001 e una legge del Parlamento del 2009.
Ebbene, le antinomie impediscono al diritto oggettivo di funzionare come fattore di ordine
nelle relazioni sociali in quanto producono incertezza e caos. Quale norma giuridica dovrà applicare
il giudice chiamato a risolvere una controversia che riguarda un fatto disciplinato in maniera diversa
da due o più norme giuridiche ? Quale norma giuridica dovrà applicare il pubblico funzionario al
quale si rivolge una persona che intende svolgere un’attività economica ? Quale norma giuridica
dovrà rispettare il singolo individuo intenzionato a porre in essere una determinata azione ?
Affinché il diritto oggettivo possa davvero funzionare come fattore di ordine nelle relazioni
sociali, nel pieno rispetto della certezza del diritto, è indispensabile che esso sia strutturato come un
sistema.
sistema Tale è, infatti, un insieme organico di elementi eterogenei i quali, seppur differenti, sono
coerenti tra di loro, ossia non si contraddicono.
Pertanto, la condizione ultima di equilibrio e di funzionalità del diritto oggettivo come sistema
normativo è la seguente:
ogni fatto, giuridicamente rilevante, deve essere disciplinato da una, e una sola,
sola norma giuridica.
Il diritto oggettivo è un sistema normativo non quando non vi sono antinomie. Le antinomie ci
saranno sempre, vista la pluralità multiforme di fonti del diritto. Il diritto oggettivo è sistema
17
normativo quando al suo interno sono presenti regole per risolvere le antinomie: regole, quindi, che
consentono al giudice, al pubblico funzionario, al singolo individuo di identificare la norma da
applicare al caso concreto,
concreto con esclusione dell’altra.
Queste regole sono definite criteri di risoluzione delle antinomie.
antinomie
I criteri di risoluzione delle antinomie
Benché, come si è detto, il nostro ordinamento sia caratterizzato da una moltitudine variegata di
fonti del diritto, nondimeno esiste un ordine tale da consentire la loro unificazione nella medesima
struttura.
struttura
Il modello teorico più diffuso per descrivere questa struttura è ancora oggi quello costruito da
uno dei più grandi studiosi del diritto del XX Secolo: HANS KELSEN (Praga, 1881 – Berkeley, 1973).
Il sistema normativo è stato rappresentato con una struttura piramidale o costruzione a gradi.
gradi
Questa struttura si sviluppa in verticale e si compone di diversi livelli.
livelli Dal vertice si scende, di gradino
in gradino, sino a raggiungere la base. Le fonti del diritto sono collocate nei diversi livelli. Più ci si
avvicina al vertice, maggiore è la “importanza” della singola fonte (più avanti, cercheremo di capire
quali ragioni giustificano la collocazione delle diversi fonti di cui si compone un ordinamento
giuridico).
Pertanto...
1) ci sono fonti collocate su piani diversi;
2) ci sono fonti collocate sullo stesso piano.
Questo significa che l’antinomia può esserci...
1) tra fonti collocate su piani diversi (antinomia verticale);
2) tra fonti collocate sullo stesso piano (antinomia orizzontale).
Se ne deduce che il sistema normativo contempla...
1) un criterio per risolvere le antinomie tra fonti collocate su piani diversi;
2) un criterio per risolvere le antinomie tra fonti collocate sullo stesso piano.
In verità, come vedremo in seguito, i criteri non sono soltanto due…
1) ANTINOMIE TRA FONTI COLLOCATE SU PIANI DIVERSI
La scelta della struttura piramidale, a “gradi”, non riflette ragioni estetiche. L’idea di una
costruzione che si sviluppa verticalmente su più livelli allude e, nel contempo, presuppone differenti
gradi di “importanza” degli elementi collocati sui diversi piani. Si può, dunque, affermare (e penso
che lo abbiate già intuito) che tra le fonti collocate su piani diversi vi è un vero e proprio rapporto
gerarchico, tale per cui la fonte (collocata sul livello) superiore prevale (in questo senso, è più
“importante”) sulla fonte (collocata sul livello) inferiore.
Ecco, dunque, il criterio gerarchico,
gerarchico applicabile per risolvere le antinomie tra fonti collocate su
piani diversi:
IN CASO DI CONTRASTO TRA NORME GIURIDICHE PRODOTTE DA FONTI DEL
DIRITTO
COLLOCATE
SU
PIANI
DIVERSI,
PREVALE
QUELLA
GERARCHICAMENTE SOVRAORDINATA (O SUPERIORE)
18
Il funzionamento del criterio gerarchico è particolarmente semplice. Occorre individuare la
posizione delle fonti della struttura piramidale. Se una è posta ad un livello più alto rispetto a quello
occupato dall’altra, allora la prima prevale e, dunque, si applica al caso concreto.
Criterio gerarchico significa, anche, che la fonte inferiore non può violare la fonte superiore. La
fonte inferiore non può contraddire la fonte superiore. Dato un certo fatto, giuridicamente rilevante,
la fonte inferiore non può prevedere una conseguenza giuridica diversa da quella prevista dalla fonte
superiore. In questi casi, il contrasto determina l’applicazione di una sorta di “sanzione” a danno della
fonte inferiore.
2) ANTINOMIE TRA FONTI COLLOCATE SULLO STESSO PIANO
L’individuazione della posizione occupata, nella struttura piramidale, dalle due fonti in conflitto
potrebbe, però, condurre anche ad un esito diverso da quello appena riferito. In effetti, sullo stesso
piano possiamo trovare più fonti, anche di diversa natura e fisionomia. Pertanto, l’antinomia può
sorgere tra fonti collocate sul medesimo piano.
Che fare ? Qual è la fonte più “importante”, destinata, dunque, a prevalere sull’altra ? Qui la
risposta non è così immediata, in quanto si tratta pur sempre di fonti che hanno lo stesso rango
gerarchico (se due capitani impartiscono ordini diversi, quale prevale ?).
È facile constatare come i rapporti sociali siano mutevoli, nel senso che essi, sollecitati da una
serie di fattori di diversa natura, tendono a cambiare nel tempo. Mutano le convinzioni diffuse presso
la comunità, varia il contesto politico di riferimento, si registra un graduale progresso delle
conoscenze scientifiche e delle relative applicazioni tecnologiche: il lento, regolare, ineluttabile fluire
del tempo segna l’evoluzione della società.
Se, in un dato frangente, per la gestione dei certi rapporti sociali furono concepite determinate
norme giuridiche, non appare difficile intuire che, una volta mutati quei rapporti, le norme giuridiche
originarie si rivelano inappropriate e, dunque, si rende necessaria una loro sostituzione con nuove
norme giuridiche.
Pertanto, se il contrasto è tra due norme giuridiche “nate” in momenti diversi, prevale la norma
“più giovane”: tra la norma precedente e quella successiva prevale quest’ultima. Questo tipo di
antinomia è, dunque, risolto con il criterio cronologico:
cronologico
IN CASO DI CONTRASTO TRA NORME GIURIDICHE PRODOTTE DA FONTI DEL
DIRITTO COLLOCATE SULLO STESSO PIANO, PREVALE QUELLA SUCCESSIVA
NEL TEMPO
Il criterio cronologico è, in effetti, anche definito come criterio della successione delle norme
nel tempo. Nella “successione” tra norme – una più vecchia, l’altra più recente – prevale quella più
vicina dal punto di vista cronologico.
È importante sottolineare che (oltre all’eccezione che descriveremo nel successivo punto 3)), il
criterio cronologico NON si applica nei rapporti tra fonti collocate su piani diversi: in questo caso,
l’unico criterio applicabile (tale da escludere gli altri) è quello gerarchico.
Le ragioni sottese a questa eccezione sono molteplici. Per semplificare, si può osservare come man mano
che ci si avvicina al vertice della piramide delle fonti del diritto, aumenta il bisogno di stabilità, anche nel tempo,
delle norme giuridiche. Una fonte del diritto, superiore rispetto ad un’altra, aspira a conseguire un tasso di stabilità
maggiore. Si pensi, ad esempio, alla Costituzione, fonte del diritto posta al vertice della scala gerarchica, e ai suoi
rapporti con le “comuni” (ordinarie) leggi del Parlamento: la prima aspira a garantire stabilità all’assetto
19
fondamentale del nostro Stato, specie in ordine ai rapporti che intercorrono tra le istituzioni e le libertà. Non
necessariamente i cambiamenti sociali sono destinati ad intaccare le norme costituzionali, l’evoluzione delle quali è
soggetta a tempi più lunghi. Le leggi ordinarie del Parlamento, invece, sono destinate a seguire le trasformazioni
sociali (talvolta provocandole, altre volte semplicemente assecondandole).
La “sostituzione” della vecchia norma con la nuova è definita abrogazione.
abrogazione La norma giuridica
più recente abroga la norma più vecchia.
Più nel dettaglio, sono conosciute tre forme di abrogazione:
a) abrogazione espressa: si ha quando la nuova norma giuridica individua, in maniera esplicita e
puntuale, la norma giuridica abrogata;
Es. L’art. 36 del d.lgs. 112/1998, in materia di miniere, stabilisce l’abrogazione degli artt. 44 e 53 del d.P.R.
396/1991. La norma più recente (del 1998) che abroga norme precedenti (del 1991), provvedendo ad identificarle
in maniera precisa.
b) abrogazione tacita: si ha quando la nuova norma giuridica risulta incompatibile con la norma
giuridica più vecchia. Incompatibile significa che la nuova norma tratta in maniera diversa fatti e
situazioni regolati da una norme precedente.
Es. L’art. 20 della legge 142/1990 attribuisce al consiglio comunale il potere di disciplinare “l’istituzione e
l’ordinamento dei tributi”. Il successivo d.lgs. 504/1992 attribuisce alla giunta comunale il potere di determinare
l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Relativamente a questo particolare tributo, la norma nuova
(il d.lgs. del 1992) ha tacitamente abrogato la norma vecchia (la l. del 1990), in quanto giunta e consiglio comunale
sono organi diversi: la nuova norma è incompatibile con la vecchia, ma prevale in virtù del criterio cronologico
(legge e decreto legislativo sono fonti dello stesso livello).
c) abrogazione implicita: si ha quando interviene una nuova disciplina giuridica di un’intera
materia. Diversamente da quella tacita, nel caso dell’abrogazione implicita l’incompatibilità è tra interi
gruppi di norme giuridiche.
Es. Quanto alla disciplina del condominio (materia), le norme giuridiche poste dal codice civile del 1942
hanno sostituito le norme giuridiche poste dal codice civile del 1865.
Riassumendo. L’abrogazione è il risultato dell’applicazione del criterio cronologico, che fa
prevalere, tra due fonti collocate sullo stesso piano, quella successiva nel tempo (ossia, più vicina a
noi). Diversamente dall’abrogazione espressa, le altre due forme di abrogazione richiedono un
notevole sforzo ai fini della loro individuazione, in quanto si tratta di verificare, caso per caso,
l’effettiva incompatibilità tra norme (a. tacita) o discipline (a. implicita).
È necessaria, comunque, una precisazione. La norma abrogata non scompare
dall’ordinamento. Semplicemente essa, di regola (ossia, normalmente: v. l’eccezione più avanti), si
applica ai fatti o ai rapporti che si sono materialmente realizzati sino all’entrata in vigore della nuova
norma.
Es. L’art. X della legge N del 1990 è stato abrogato dall’art. Y della legge M del 2006. La nuova norma (Y) è
entrata in vigore il 30 giugno 2006. Nel momento in cui leggiamo questo esempio, l’art. X è stato abrogato e,
dunque, non può più essere applicato. Ma per un fatto accaduto il 20 maggio 2006, quale norma applicherebbe
oggi il giudice ? La risposta è l’art. X, in quanto la norma abrogante (art. Y), come visto, si applica per i fatti
accaduti a partire dalla sua entrata in vigore (30 giugno 2006).
3) ancora ANTINOMIE TRA FONTI COLLOCATE SULLO STESSO PIANO
MA…
Il criterio gerarchico si applica per risolvere antinomie tra fonti collocate su piani diversi
(prevale la fonte superiore).
20
Il criterio cronologico si applica per risolvere antinomie tra fonti collocate sullo stesso piano
(prevale la fonte successiva nel tempo).
Tuttavia, l’ordinamento giuridico talvolta riserva a particolari fonti del diritto la disciplina di
determinate materie o complessi organici di fatti e rapporti. Questa riserva è giustificata dalla
maggiore attitudine che una determinata fonte ha, rispetto alle altre, di regolare certi fatti o
comportamenti.
L’esempio classico è quello dei rapporti tra leggi statali e leggi regionali. In effetti, nel nostro ordinamento la
funzione legislativa è esercitata non solo dallo Stato, ma anche dalle Regioni: ossia da enti pubblici territoriali che,
in condizioni di autonomia, tutelano gli interessi delle rispettive comunità anche approvando leggi.
Quando furono pensate le Regioni, e quando si immaginò di conferire loro la stessa funzione legislativa
assegnata allo Stato, si rese necessario rispondere ad un quesito molto semplice: quando interviene la legge statale
? e quando interviene la legge regionale ? Il criterio prescelto dalla Costituzione è quello fondato proprio sul
concetto di materia.
materia Allo stato attuale (quindi, a seguito della riforma costituzionale del 2001), la Costituzione (→
art. 117) individua:
- una serie di materie (es. difesa, ordinamento penale, ordine pubblico e sicurezza, immigrazione, ecc.) riservate
alla legge statale (→ potestà legislativa statale esclusiva);
- una serie di materie in cui intervengono leggi statali (per fissare i princìpi fondamentali) e leggi regionali (per
attuare quei princìpi) (es. commercio con l’estero, istruzione, tutela della salute, ecc.) (→ potestà legislativa
concorrente);
- mentre tutte le altre materie, non indicate espressamente, sono riservate alla legge regionale (→ potestà legislativa
regionale residuale).
Pertanto, ad es., in una materia come l’agricoltura, non inclusa nei due elenchi previsti dalla Costituzione,
c’è spazio solo per leggi regionali. La Costituzione “ritaglia”, nell’ambito di tutte le materie disciplinate
dall’ordinamento italiano, alcuni settori da riservare alle Regioni. Perché ? La risposta è intuibile: si ritiene (per
esperienza e per altre ragioni) che in determinati settori della vita sociale, economica, culturale ecc., le Regioni,
meglio dello Stato, possono soddisfare i bisogni della comunità innanzitutto facendo leggi. Al contrario, vi sono
materie in cui le esigenze da tutelare sono riferibili a tutto il popolo italiano e, dunque, è preferibile che se ne
occupi la legge statale. Quando vi è il dubbio circa la prevalenza degli interessi nazionali o degli interessi regionali,
allora opera il modello, già richiamato, della potestà legislativa concorrente.
Un altro esempio importante. La Costituzione (→ art. 64) stabilisce che ogni ramo del Parlamento (Camera
e Senato) abbia un proprio regolamento. Una fonte del diritto, questa, destinata a disciplinare l’organizzazione ed il
funzionamento di tali organi (appunto, la “materia parlamentare”), ad esclusione di tutte le altre fonti di pari o più
basso livello.
Domanda: se l’ordinamento riserva ad una specifica fonte del diritto la disciplina di una
determinata materia, si applicano ancora i due criteri (gerarchico e cronologico) in caso di antinomia
?
Risposta:
1) continua a trovare applicazione il criterio gerarchico, sebbene la fonte “inferiore” sia
competente a regolare una determinata materia. Si è già detto che nei rapporti tra fonti collocate su
piani diversi si applica sempre e solo il criterio gerarchico. La competenza, vantata da una fonte del
diritto in un data materia, non può essere invocata per contraddire l’ordine gerarchico delle fonti.
Peraltro, avete notato qualcosa dai due esempi appena illustrati ? Quale fonte stabilisce che una
materia spetti alla legge statale o alla legge regionale ? Quale fonte stabilisce che la “materia
parlamentare” sia regolata dai regolamenti di Camera e Senato ? In entrambi i casi, la Costituzione,
vale a dire una fonte superiore rispetto alla legge statale, alla legge regionale, ai regolamenti
parlamentari.
Ciò significa che la distribuzione per materie della potestà normativa può essere fatta solo da
una fonte superiore rispetto a quelle che partecipano alla distribuzione. Così, ad esempio, una legge
regionale non potrebbe mai autoqualificarsi unica ed esclusiva fonte di disciplina di una data materia
(e lo stesso vale per la legge statale);
2) NON si applica il criterio cronologico. Se una fonte è competente in via esclusiva, e l’altra no,
non importa quale sia la più recente: in caso di antinomia prevale sempre la fonte competente. In
questo caso si applica il criterio della separazione delle competenze:
competenze
21
IN CASO DI CONTRASTO TRA NORME GIURIDICHE PRODOTTE DA FONTI DEL
DIRITTO COLLOCATE SULLO STESSO PIANO, MA DI CUI UNA COMPETENTE IN
VIA ESCLUSIVA PER MATERIA, PREVALE PROPRIO QUEST’ULTIMA, ANCHE SE
PIÙ “VECCHIA”
Quindi, in caso di antinomia tra fonti collocate sullo stesso piano, occorre prima verificare se
una delle due sia competente per materia (ad es., nei rapporti tra legge statale e legge regionale – che
sono fonti del diritto di pari grado – occorre verificare se c’è una fonte superiore che riservi ad una
delle due una determinata materia: e, infatti, c’è la Costituzione): in caso affermativo, si applica il
criterio della separazione delle competenze. Altrimenti, si ricorre al criterio cronologico.
RIASSUMENDO...
1) se vi è una antinomia tra fonti collocate su piani diversi, si applica sempre e solo il criterio
gerarchico:
gerarchico prevale la fonte superiore
2) se vi è una antinomia tra fonti collocate sullo stesso piano, si applica il criterio cronologico:
cronologico
prevale la fonte successiva nel tempo, a meno che …
3) se vi è una antinomia tra fonti collocate sullo stesso piano, MA una è competente in via
esclusiva a regolare un determinato fatto o rapporto, si applica il criterio della separazione
delle competenze:
competenze prevale la fonte competente per materia
Alcune riflessioni e precisazioni
A) Sul criterio gerarchico
Si è detto più volte che il sistema delle fonti del diritto può essere raffigurato come una
piramide o anche come una scala: comunque, come una struttura a più livelli. Le diverse fonti sono
poste su questi livelli con tutte le conseguenze derivanti dall’applicazione dei descritti criteri di
risoluzione delle antinomie.
La collocazione delle diverse fonti non è casuale, in quanto riflette una logica precisa. Ed è
proprio individuando tale logica che è possibile ricostruire la piramide delle fonti, dal momento che
manca, nel nostro ordinamento, una “fonte sulle fonti” che, una volta per tutte, stabilisca una simile
gerarchia (la Costituzione aiuta molto, ma non contempla tutte le fonti del diritto italiano).
A quale logica risponde, dunque, la sistemazione gerarchica delle fonti di produzione del diritto
oggettivo ?
Non è un quesito semplicemente teorico. Se, davanti ad un giudice chiamato a dirimere una
controversia, un consociato fonda la propria pretesa su di una fonte, e la controparte (per difendersi)
invoca l’applicazione di un’altra fonte (che gli darebbe ragione), non è indifferente il modo in cui
l’antinomia si risolve. Colui che fonda la propria pretesa su di una fonte gerarchicamente superiore
vincerà sull’avversario, che ha invece invocato una fonte di rango (forza o valore) inferiore. Perché,
dunque, una fonte è “più importante” (in termini gerarchici) di un’altra ?
Per cogliere la logica sottesa all’ordine gerarchico prescelto dal nostro ordinamento, proviamo a
percorrere la strada più semplice, attivando un procedimento induttivo (ossia, dal particolare al
generale). Dapprima, quindi, ricostruiremo, quanto meno nei suoi elementi fondamentali, il vigente
assetto gerarchico e, poi, cercheremo una spiegazione plausibile.
Pertanto:
22
a) al vertice della piramide troviamo la Costituzione. Per questa ragione, essa viene
comunemente definita la fonte superprimaria del diritto. La Costituzione (semplificando al massimo)
aspira a garantire la stabilità nel tempo dei princìpi fondamentali che reggono, da un lato, i rapporti
tra autorità e libertà (diritti e doveri, limiti ai poteri restrittivi delle istituzioni) e, dall’altro, i rapporti tra
gli organi istituzionali di vertice (forma di governo; rapporti con le autonomie territoriali). È
necessario preservare la stabilità di questi princìpi in modo da garantire la permanenza nel tempo
dell’identità del nostro Stato nonostante il cambiamento continuo di maggioranze e di orientamenti
politici. La Costituzione, salvo il suo “nocciolo duro” o “nucleo forte”, non è immodificabile. Le sue
norme possono sì essere modificate o persino abrogate, per adattarle alle trasformazioni più rilevanti
della società, ma solo seguendo una procedura parlamentare particolarmente complessa, se
raffrontata col comune procedimento di formazione delle leggi ordinarie (→ revisione costituzionale;
art. 138 della Costituzione; procedura aggravata; costituzione rigida). Alla Costituzione sono
equiparate le leggi costituzionali, in quanto pur sempre deliberate con la procedura aggravata: e, tra
queste, spiccano gli statuti delle Regioni speciali, che sono appunto adottati con legge costituzionale;
b) sul gradino immediatamente inferiore troviamo le leggi ordinarie del Parlamento e gli atti
aventi forza di legge. Questi atti vengo usualmente definiti come fonti primarie del diritto. Il
Palamento, con una procedura meno complicata rispetto a quella prevista per modificare la
Costituzione, approva le leggi ordinarie. Il Governo, sulla base di una legge-delega del Parlamento
(che stabilisce princìpi e criteri direttivi, oggetto, termine: ossia limiti vincolanti il Governo), approva i
decreti legislativi. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il Governo può adottare i decreti-legge,
che, tuttavia, per poter consolidare nel tempo la loro efficacia normativa, debbono essere convertiti in
legge dal Parlamento entro sessanta giorni: in mancanza di conversione, essi perdono efficacia sin
dall’inizio. Le Regioni ordinarie, tramite i loro Consigli (organi legislativi), producono statuti (con una
procedura aggravata) e leggi (con la procedura ordinaria);
c) al di sotto delle leggi e degli atti aventi forza di legge sono collocate le fonti secondarie del
diritto. L’esempio più rilevante è costituito dai regolamenti che il Governo può adottare per dare
attuazione o integrazione o esecuzione alle fonti primarie o anche, sia pure in presenza di determinate
condizioni, per sostituire leggi in determinate materie (→ delegificazione). Anche a livello regionale,
le Giunte (organi esecutivi) possono adottare regolamenti. Gli enti locali, poi, (principalmente i
Comuni e le Province), pur privi della funzione legislativa, possono approvare statuti e regolamenti;
d) ci sono, poi, altri livelli, ancora inferiori, in cui troviamo, ad esempio, i decreti ministeriali,
che sono pur sempre assimilabili ai regolamenti, ma sono gerarchicamente inferiori a questi in quanto
approvati da un solo ministro e non da tutto il Governo;
e) l’ultimo livello è, infine, occupato dalla consuetudine.
Quella descritta è, approssimativamente, la struttura piramidale del sistema delle fonti del
diritto italiano.
A questo punto, però, occorre identificare le ragioni poste a fondamento di tale gerarchia.
Potremmo, a tal fine, utilizzare tre indicatori o parametri per “misurare” l’ “importanza” di ogni
singola fonte, in vista della collocazione di ognuna nella predetta struttura:
a) tasso di rappresentatività: questo indicatore misura la capacità, di ogni fonte, di rappresentare
la comunità. Più precisamente. Si è detto che le norme giuridiche non vengono prodotte a caso, bensì
per realizzare determinati obiettivi. Queste finalità sono strettamente connesse agli interessi espressi
dalla comunità. Non tutti gli interessi, però, sono disciplinati dal diritto: si procede, in effetti, ad una
selezione alla luce di vari fattori (politici, economici, culturali, ecc.). È intuibile come questa scelta
23
non sia indolore, in quanto i portatori degli interessi non ritenuti meritevoli di protezione giuridica
resteranno privi di una tutela molto forte nell’ambito delle relazioni sociali.
Questa selezione è rimessa ai soggetti legittimati dall’ordinamento a produrre il diritto oggettivo
(vi ricordate le fonti sulla produzione ?). A loro volta, questi soggetti producono le norme giuridiche
attraverso appositi procedimenti (un procedimento è una serie di atti ed operazioni coordinati in vista
del conseguimento di un determinato obiettivo).
Questi procedimenti hanno una configurazione spiccatamente politica, nel senso che il
principale fattore che guida la selezione degli interessi è costituito proprio dall’indirizzo politico
seguito dagli organi titolari della funzione normativa. L’indirizzo politico riflette la concezione ideale
della società prescelta dai soggetti che producono diritto.
Il liberalismo, da un lato, e la socialdemocrazia, dall’altro, hanno concezioni ideali molto diverse quanto, ad
esempio, agli spazi di manovra da concedere agli imprenditori che producono ricchezza: per il primo indirizzo
occorre lasciare loro molto spazio; per il secondo indirizzo è necessario che le istituzioni pubbliche controllino le
iniziative economiche e, talora, che le stesse siano direttamente coinvolte in attività produttive e commerciali. Il
liberalismo persegue obiettivi di affermazione individuale; la socialdemocrazia si preoccupa della giustizia e
dell’equità sociale.
Soprattutto con la Rivoluzione francese si afferma l’idea che la produzione del diritto sia
attribuita ad un organo collegiale composto dai rappresentanti del popolo (→ democrazia
rappresentativa). Il Parlamento (o assemblea o congresso o altra denominazione di significato
equipollente) è la sede in cui si confrontano (oggi sicuramente) tutte le componenti della comunità:
infatti, il Parlamento è composto da cittadini eletti dal popolo. Il Parlamento (salvo nei regimi
dittatoriali) non è omogeneo e compatto: in esso sono rappresentate più formazioni politiche (→
partiti politici), che hanno concezioni ideali anche profondamente diverse.
Come in ogni organo collegiale, però, le decisioni sono assunte dalla maggioranza. Nei sistemi
politici “semplici”, caratterizzati cioè dalla contrapposizione tra due grandi partiti (democratici contro
repubblicani negli Stati Uniti, laburisti contro conservatori in Gran Bretagna), uno solo decide. Nei
sistemi politici “complessi”, invece, ci sono tanti partiti e questi, per governare, sono costretti a
coalizzarsi (→ coalizioni di governo): è il caso dell’Italia, della Germania, della Francia, ad esempio.
In questi sistemi, vi è una contrapposizione tra una coalizione di maggioranza e l’opposizione (o
minoranza). Anche in questo caso, è la maggioranza a decidere.
Ebbene, nei procedimenti che si svolgono in Parlamento, se è vero che alla fine decide la
maggioranza, è altrettanto vero che comunque la minoranza può partecipare: come ? Presentando
richieste di modifica del testo da approvare (→ emendamenti), chiedendo la parola e adottando
strategie legittime per ritardare la conclusione de procedimento (→ ostruzionismo), sollecitando
l’attenzione dell’opinione pubblica e, infine, semplicemente votando contro. In questo modo, si può
affermare che all’interno dell’assemblea eletta dal popolo il procedimento di produzione del diritto è
congegnato in modo tale da permettere a tutte le componenti della comunità di far valere le rispettive
ragioni. In questi casi, perciò, si ha un alto tasso di rappresentatività.
In epoca più recente, però, anche per ragioni di efficienza e di rapida soluzione di problemi
sociali ed economici, gli ordinamenti hanno iniziato a “decentrare” la funzione normativa
coinvolgendovi l’organo esecutivo, ossia il Governo. Pensiamo ai regolamenti. In alcuni Stati, come il
nostro, è stato persino deciso di riconoscere al Governo la capacità di fare atti aventi la stessa forza e
lo stesso valore della legge del Parlamento: in Italia, i decreti legislativi e i decreti-legge.
Questa distribuzione della funzione legislativa, però, è stata accompagnata da una serie di limiti:
il decreto legislativo deve essere preceduto da una delega legislativa del Parlamento. Il decreto-legge
deve essere convertito in legge dal Parlamento, entro un determinato termine, altrimenti decade.
Perché questi limiti ? Per una ragione molto semplice: il Governo rappresenta la sola maggioranza.
L’organo esecutivo è espressione del solo partito o coalizione di maggioranza. Quando il Governo
decide, selezionando gli interessi, interpreta la volontà dei soli partiti che hanno vinto le elezioni.
L’opposizione non partecipa al procedimento. Con gli “accorgimenti” della legge delega e della
24
conversione in legge, però, il Parlamento (e, dunque, l’opposizione) intervengono nel procedimento
legislativo del Governo: o prima (nel caso del decreto legislativo) o dopo (nel caso del decreto-legge).
Lo stesso, invece, non può dirsi per i regolamenti. Questi sono approvati soltanto dal Governo
(e, dunque, dalla sola maggioranza).
Si può, pertanto, affermare che gli atti legislativi del Governo (considerato l’intervento
parlamentare) hanno un tasso di rappresentatività diverso e superiore rispetto a quello dei
regolamenti.
Nel nostro Stato, poi, anche le Regioni possono produrre diritto, attraverso statuti, leggi e
regolamenti. Anche le Regioni hanno un organo legislativo (il Consiglio regionale) che rappresenta
l’intero elettorato, ed un organo esecutivo (la Giunta regionale, guidata da un Presidente) che esprime
la sola maggioranza politica.
Dunque, le riflessioni dapprima sviluppate sono applicabili anche alle Regioni, tenuto conto,
però, che:
- nelle Regioni NON sono previsti atti aventi forza di legge della Giunta;
- in alcune Regioni, alcuni tipi di regolamenti sono affidati al Consiglio e non all’organo
esecutivo.
Gli enti locali (Comuni, Province, città metropolitane, ecc.) possono produrre diritto oggettivo,
ma senza l’ausilio dello strumento legislativo: quindi, non esistono leggi comunali o provinciali (il
discorso è diverso per le Province autonome di Trento e di Bolzano che, in realtà, sono equiparabili
alle Regioni). Gli unici strumenti normativi sono gli statuti ed i regolamenti.
In definitiva, l’intensità del tasso di rappresentatività di una fonte del diritto è maggiore nei
procedimenti in cui anche le minoranze possono partecipare.
Provate a riflettere sull’importanza di questa affermazione. Le norme giuridiche sovente limitano taluni
diritti per favorirne altri. Ad esempio, rafforzare i poteri del datore di lavoro significa indebolire la posizione del
lavoratore dipendente. E una maggioranza politica, per gli ideali cui si ispira, potrebbe volere proprio questo
obiettivo: sostenere i produttori di ricchezza, anche sacrificando i diritti delle categorie più deboli. Pertanto, non è
indifferente che anche l’opposizione possa partecipare al procedimento normativo, usando tutti gli strumenti
previsti dall’ordinamento. Facendo “opposizione”, alcuni partiti potrebbero riuscire a convincere gli elettori a non
votare più per le formazioni che hanno vinto le precedenti elezioni. L’emarginazione dell’opposizione o persino il
suo annullamento sono i chiari sintomi dell’avvento di una dittatura.
b) tasso di complessità del procedimento: questo parametro misura il “peso” di ogni
procedimento culminante nella adozione di una determinata fonte del diritto, in termini di fasi e
obblighi procedurali, organi coinvolti, tempi, controlli.
Di regola, i procedimenti che si svolgono dinanzi alle assemblee elette dal popolo sono
particolarmente complessi, in quanto occorre garantire all’opposizione la possibilità di parteciparvi in
maniera non simbolica. Diversamente, nei procedimenti che si svolgono dinanzi all’organo esecutivo,
la compattezza (almeno in astratto) delle forze politiche di maggioranza e il numero relativamente
esiguo dei soggetti coinvolti rendono senza dubbio più celere il procedimento: è il caso dei
regolamenti governativi. Quando, poi, la fonte del diritto è rimessa ad un solo organo monocratico
(cioè, costituito da una sola persona), il procedimento è particolarmente veloce: si pensi ai decreti
ministeriali.
Si è già ricordato che la nostra Costituzione può essere modificata (salvo il suo nucleo forte)
con un procedimento più complicato e lungo rispetto a quello previsto per le ordinarie leggi del
Parlamento.
Inoltre, se è vero che il decreto legislativo ed il decreto-legge sono adottati dal Governo, con
procedimenti poco complessi, è altrettanto vero, però, che sia la legge delega che la legge di
conversione richiedono l’attivazione dell’ordinario procedimento legislativo davanti al Parlamento
(accelerato, semmai, nel caso dei decreti-legge da convertire in legge).
c) tasso di stabilità: quest’ultimo indicatore misura l’aspirazione, di ogni fonte, a conservare nel
tempo l’efficacia delle norme giuridiche da essa prodotte.
25
La Costituzione, come fonte che definisce i pilastri dell’ordinamento giuridico, manifesta una
spiccata inclinazione a mantenersi inalterata nel tempo, così da resistere ai continui tentativi di
revisione anche solo progettati dalle contingenti maggioranze politiche. Le leggi e gli atti aventi forza
di legge sono, invece, più sensibili alle trasformazioni in atto nella società, soprattutto sul piano dei
rapporti economici. I regolamenti, poi, sono strumenti normativi particolarmente snelli che vengono
solitamente adottati per fronteggiare, con rapidità, anche piccole variazioni dei fatti o comportamenti
disciplinati dal diritto.
È chiaro che il tasso di stabilità, pur all’interno dello stesso livello gerarchico, non è uniforme: vi
sono leggi che resistono nel tempo, e leggi che, invece, sono sottoposte a continui ritocchi o
aggiustamenti. Tuttavia, per la nostra ricostruzione occorre affidarsi a piccole approssimazioni e,
dunque, occorre accontentarsi di dati tendenziali.
Ebbene, una volta fissati i descritti indicatori, si può procedere ad una analisi delle diverse e
principali fonti del diritto italiano. I dati così acquisiti possono essere raccolti nella seguente tabella.
26
TABELLA
FONTI
TIPOLOGIA E ORGANI
Costituzione (AC)
Leggi di revisione
Superprimari costituzionale (P*)
e
Leggi costituzionali, in
particolare
statuti
regionali speciali (P*)
Leggi ordinarie (P)
Decreti legislativi (P +
G)
Primarie
Decreti-legge (G + P)
Statuti
regionali
ordinari (CR*)
Leggi regionali (CR)
Regolamenti
governativi (G)
Secondarie Regolamenti regionali
(CR o GR)
Statuti locali (CP, CC)
Regolamenti
locali
(CP o GP, CC o GC)
Altre
Decreti
ministeriali
(M)
Fonti-fatto Consuetudini
TASSO DI
TASSO DI
TASSO DI
RAPPRESENTATIVITÀ
RAPPRESENTATIVITÀ
COMPLESSITÀ DEL
PROCEDIMENTO
stabilità
ALTISSIMO
ALTISSIMO
ALTISSIMO
ALTO
ALTO
MEDIO-ALTO
BASSO
BASSO
MEDIO-BASSO
MOLTO BASSO
MOLTO BASSO
BASSO
MASSIMO
MASSIMO
MASSIMO
* Eventuale consultazione referendaria (partecipazione degli elettori)
Legenda: AC = Assemblea costituente (organo legislativo); P = Parlamento (organo legislativo); G = Governo (organo esecutivo); M =
Ministro (esecutivo); CR = Consiglio regionale (organo legislativo); GR = Giunta regionale (organo esecutivo); CP = Consiglio
provinciale; GP = Giunta provinciale (esecutivo); CC = Consiglio comunale; GC = Giunta comunale (esecutivo).
27
Come si nota dalla tabella, maggiori sono i tassi utilizzati come indicatori, più alta è la
collocazione della fonte nella struttura piramidale.
Così, tra le fonti primarie troviamo solo atti che prevedono, non necessariamente in via
esclusiva, l’intervento delle assemblee legislative (anche a livello regionale).
È anche vero, tuttavia, che talvolta assume un ruolo decisivo l’elemento formale, nel senso che
in alcuni casi è lo stesso ordinamento giuridico ad adottare specifiche denominazioni per collocare
una determinata fonte ad un certo livello piuttosto che ad un altro. È il caso dei regolamenti regionali
approvati dal Consiglio regionale: sono atti deliberati dall’assemblea legislativa, ma vengono distinti
dalle leggi, che lo stesso organo può approvare, in relazione all’efficacia che s’intende riconoscere
loro.
Un cenno meritano i regolamenti che ciascuna Camera deve adottare per disciplinare la propria
organizzazione ed il proprio funzionamento. In questo caso, la denominazione non è decisiva. La Corte
costituzionale (che, come vedremo tra poco, è un “giudice” un po’ particolare) ha stabilito che tali regolamenti
attuano direttamente la Costituzione nella materia “parlamentare”. Sicché, essi sono inclusi tra le fonti primarie.
Inoltre, ai regolamenti parlamentari la stessa Costituzione riserva in via esclusiva una determinata materia e,
dunque, in caso di contrasto con fonti di pari grado, ma successive nel tempo, essi prevalgono sempre.
A.1) Ancora sul criterio gerarchico...
Il criterio gerarchico assume diverse denominazioni e contenuti a seconda del livello al quale
esso si applica. Così:
1) nei rapporti tra fonti superprimarie e fonti primarie, il criterio gerarchico è definito principio
di costituzionalità.
costituzionalità Le fonti primarie non possono essere in contrasto con le fonti superprimarie, a
cominciare dalla Costituzione, altrimenti sono illegittime. Così, ad esempio, una legge ordinaria in
contrasto con la Costituzione è una legge costituzionalmente illegittima.
La illegittimità costituzionale di una fonte primaria, nel nostro ordinamento, è dichiarata da un
apposito organo, creato apposta per esercitare tale funzione di difesa o custodia della Costituzione: la
Corte costituzionale.
costituzionale Quando si ha il sospetto che una fonte primaria abbia prodotto una norma
giuridica in contrasto con una norme prodotta dalla Costituzione, allora ci si rivolge alla Corte
costituzionale. Questa, attraverso un apposito procedimento (→ giudizio di legittimità costituzionale),
verifica se il sospetto è fondato (→ sentenza di accoglimento della questione di legittimità
costituzionale) oppure no (→ sentenza di rigetto della questione di legittimità costituzionale). Se
davvero la fonte primaria contraddice la Costituzione, allora la norma illegittima viene “eliminata”
dall’ordinamento e, dunque, non può più essere applicata.
Abbiamo visto, in precedenza, un altro caso di “eliminazione” di una norma dall’ordinamento:
l’abrogazione. Che differenza c’è tra l’abrogazione e l’illegittimità costituzionale ?
1. una norma abrogata viene eliminata non perché in contrasto con la Costituzione, ma perché ritenuta non
più opportuna o adeguata o coerente con un determinato indirizzo politico;
2. una norma abrogata continua a trovare applicazione per i fatti che si sono storicamente verificati prima
dell’entrata in vigore della norma abrogante. La norma dichiarata incostituzionale, invece, non si applica più:
quindi, non si applica neppure ai fatti che si sono storicamente verificati prima della sentenza di accoglimento della
Corte costituzionale.
La Corte costituzionale è uno degli organi meno “popolari”, nel senso che i mezzi di
comunicazione non le prestano sufficiente attenzione. Quanti di voi, sinceramente, hanno mai sentito
parlare di questo organo prima di aver letto queste pagine ? Parlamento, Governo, Presidente della
Repubblica, forse persino il C.S.M. (Consiglio superiore della Magistratura): ma della Corte
costituzionale se ne parla effettivamente poco. Eppure, la Corte costituzionale è un organo
fondamentale per la sopravvivenza del nostro Stato democratico. La Corte custodisce un tesoro
prezioso, posto a presidio delle nostre libertà fondamentali: la Costituzione. La Costituzione
impedisce alle forze di polizia, salvo casi assolutamente straordinari, di arrestare una persona senza
28
una apposita autorizzazione motivata del giudice. La Costituzione previene perquisizioni improvvise e
senza garanzie nei domicili di ognuno di noi (vi ricordate la frase ricorrente nei film polizieschi: “ce
l’ha il mandato ?”). La Costituzione stabilisce che una persona, pur sospettata di aver commesso un
crimine efferato, non può considerarsi colpevole sino a che la sentenza di condanna non diventi
definitiva e irrevocabile (→ presunzione di non colpevolezza). La Costituzione riconosce il diritto di
difesa nei processi. Insomma, la Costituzione protegge le nostre libertà fondamentali (integrità fisica e
psichica, domicilio, circolazione, pensiero, ecc.) anche nei confronti del Parlamento, e delle varie
maggioranze che lì si avvicendano. Le dittature nascono proprio quando le forze (o la singola forza) di
maggioranza possono liberamente disporre delle libertà fondamentali, a cominciare dalla
manifestazione del pensiero. La presenza di un apposito “tribunale costituzionale” o, comunque, la
configurazione di un apposito sistema di giustizia costituzionale garantiscono la supremazia della
Costituzione e, dunque, la sopravvivenza del patrimonio minimo di ogni consociato quanto a libertà e
diritti.
Un esempio significativo per cogliere l’importanza fondamentale del sistema di giustizia costituzionale. La
democrazia è garantita, tra l’altro, quando tutti possono esprimere liberamente le opinioni personali, magari anche
criticando l’operato di chi detiene il potere. Al contrario, una dittatura non ammette che si dissenta pubblicamente
dall’operato del governo. La nostra Costituzione (→ art. 21) riconosce e tutela la libertà di manifestazione del
pensiero, tra l’altro, vietando la censura. Se il Parlamento, “dominato” da forze politiche che aspirano ad instaurare
una dittatura, approvasse una legge di autorizzazione alle forze dell’ordine di operare la censura sulla stampa e
sugli altri mezzi di comunicazione, allo scopo di far tacere l’opposizione, quella legge sarebbe senza dubbio in
contrasto con la Costituzione. La Corte costituzionale, dichiarando l’illegittimità di questa legge, contribuirebbe a
garantire l’assetto democratico del nostro Paese. E non è poco... In Germania ed in Italia, prima della Seconda
Guerra mondiale, l’avvento dei regimi dittatoriali è stato agevolato proprio dalla mancanza di un sistema di giustizia
costituzionale posto a presidio della Costituzione (all’epoca, in Italia, vigeva lo Statuto albertino del 1848), e ,
dunque, delle libertà fondamentali. Oggi, che fine farebbe una legge ordinaria che vietasse agli appartenenti da una
determinata confessione religiosa di partecipare, ad esempio, ai concorsi pubblici ? Provate a leggere gli artt. 3, 7,
8, 19 e 20 della Costituzione...
2) nei rapporti tra fonti primarie e fonti secondarie, il criterio gerarchico è definito principio di
legalità.
legalità Le fonti secondarie non possono essere in contrasto con le fonti primarie. Così, ad esempio,
un regolamento del governo in contrasto con un decreto legislativo è illegittimo: pertanto, il
regolamento verrà annullato (dal giudice amministrativo) o disapplicato (dal giudice amministrativo o
dal giudice ordinario).
Il custode del principio di legalità è, dunque, qualsiasi giudice: ordinario (il giudice di pace, il
tribunale, la corte d’appello ecc.) e amministrativo (il T.A.R., tribunale amministrativo regionale, ed il
Consiglio di Stato).
Il principio di legalità contribuisce a garantire le libertà fondamentali contro gli arbitri delle
istituzioni a cominciare proprio dal legislatore. Ciò può sembrare paradossale: il principio di legalità,
che sancisce la superiorità delle leggi rispetto ai regolamenti, costituisce anche un limite alla stessa
legge. In realtà, il paradosso è soltanto apparente...
Consideriamo il seguente esempio. La Costituzione prevede che le libertà (personale, di domicilio, di
comunicazione, ecc.) possano essere limitate “nei soli casi e modi stabiliti dalla legge”. Spetta, perciò, ad una fonte
primaria individuare le condizioni affinché, ad esempio, una persona possa subire una misura restrittiva (→
custodia cautelare o arresti domiciliari). Supponiamo che il Parlamento approvi una legge che autorizza le
intercettazioni telefoniche (limitazione della libertà fondamentale di comunicazione) da parte delle forze di polizia,
“per ragioni di ordine pubblico”: nel contempo, tale legge rinvia ad un regolamento governativo il compito di
decide i requisiti, le modalità, le garanzie, l’uso processuale dei dati così acquisiti, i tempi, ecc. Al regolamento è
stato, perciò, affidato un compito molto importante: dalla sua disciplina dipende l’uso delle intercettazioni
telefoniche, mentre la legge è stata decisamente laconica al riguardo. In altri termini, una persona potrà subire,
presso la sua utenza telefonica, intercettazioni secondo quanto disposto da un regolamento del Governo.
Domanda: chi decide, in generale e astratto, come, perché, quando, effettuare intercettazioni all’insaputa dei privati
? La sola maggioranza, attraverso regolamenti del Governo.
29
Ora, in un ordinamento democratico, retto da una Costituzione che si prefigge l’obiettivo di
tutelare le libertà fondamentali anche e soprattutto nei confronti delle autorità pubbliche, le misure
limitative delle predette libertà debbono essere previste e disciplinate da fonti del diritto il cui
procedimento di formazione preveda la partecipazione anche dell’opposizione. Le libertà non sono
assolute: possono subire limitazioni per garantire agli altri la fruizione delle rispettive libertà. Le
limitazioni possono essere accettate ove coloro che le subiscono siano stati messi nelle condizioni,
anche per il tramite dei propri rappresentanti in Parlamento, di partecipare alla formazione delle
norme giuridiche che contemplano quelle restrizioni. È la democrazia, nel suo più nobile ed effettivo
significato !
Per questa ragione, la Costituzione è disseminata di riserve di legge.
legge Con questa espressione
s’intendono i casi in cui la Costituzione riserva alla legge la disciplina di determinate materie: in
questo modo, da un lato, la Costituzione obbliga la legge a regolare certi rapporti e, dall’altro, limita lo
spazio di intervento di fonti, quali i regolamenti del Governo, che sono a disposizione della sola
maggioranza.
Più precisamente:
- per “legge” s’intende, in realtà, “fonte primaria”. È ben vero che in alcuni casi la Costituzione
riserva alla sola legge ordinaria del Parlamento la disciplina di determinati rapporti o situazioni (ad
es., la legge di bilancio, la legge di amnistia e indulto, la legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati
internazionali, la legge di conversione dei decreti-legge, ecc.). Tuttavia, di regola qualsiasi fonte
primaria è in grado di soddisfare una riserva di legge.
Si pensi, ad esempio, alla materia penale. Una materia, questa, strategica in quanto incide fortemente sulle
libertà fondamentali (“per colpa” del diritto penale una persona rischia di finire in galera: restrizione della libertà
fondamentale). Ebbene, il codice penale fu adottato, nel 1930, con un decreto legislativo. E la stessa fonte è stata
utilizzata, verso la fine degli anni Ottanta, per il nuovo codice di procedura penale, che decide, ad esempio,
quando una persona può subire una perquisizione domiciliare.
- la Costituzione, in verità, prevede due tipologie di riserva di legge: assoluta e relativa. La
Costituzione, però, non dice espressamente se una determinata riserva sia assoluta o relativa. Un dato
è, però, certo: la riserva assoluta è posta a presidio delle libertà fondamentali.
Come distinguere le due tipologie di riserva di legge ?
All’esame di diritto costituzionale o di diritto pubblico, lo studente medio risponde nel seguente
modo: in caso di riserva assoluta, tutta la materia è disciplinata dalla legge. Nel caso della riserva
relativa, c’è spazio anche per i regolamenti del Governo.
Ebbene, questa risposta si avvicina molto alla risposta corretta, ma non coglie esattamente i
termini della questione.
Consideriamo il seguente esempio. Un testo unico del 1990, adottato con decreto legislativo, si occupa
della repressione dei reati connessi alle sostanze stupefacenti. Materia penale: riserva assoluta di legge, dunque. Ed
in effetti, questa fonte primaria prevede reati e commina sanzioni, compresa la reclusione (che è la sanzione più
severa, in quanto limita la libertà personale). Nel contempo, la stessa fonte primaria assegna al Ministro della salute
il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente, con proprio decreto (fonte subordinata alla legge), l’elenco
delle sostanze da considerarsi, a tali effetti, droga. Come si spiega questo ? Siamo in una materia soggetta a riserva
assoluta di legge, eppure c’è spazio anche per una fonte di grado inferiore: con un compito, peraltro, decisivo, in
quanto se una sostanza non figura nell’elenco, il suo consumo o il suo commercio non possono essere sanzionati.
In verità, anche alla luce dell’esempio appena riportato, la riserva di legge, sia essa assoluta o
relativa, non impedisce l’intervento di fonti subordinate alla legge.
La differenza risiede, piuttosto, nell’ampiezza dello spazio di intervento di tali fonti. E questo
spazio può misurarsi in relazione al tipo di norme giuridiche che possono essere prodotte dalle fonti
secondarie.
Consideriamo, infatti, il seguente schema:
30
NORME DI PRINCIPIO
⇓
NORME DI SVOLGIMENTO
⇓
NORME DI SPECIFICAZIONE
Nello schema sono riportate tre distinte tipologie di norme giuridiche. Infatti:
a) norme di principio: sono le norme che definiscono le linee generali di una disciplina
giuridica. Esse dettano le direttive per il raggiungimento di determinati obiettivi. Per ricorrere ad una
metafora, le norme di principio definiscono l’intelaiatura di un edificio e le sue fondamenta. Sono i
pilastri di una costruzione giuridica. Sono gli elementi basilari che conferiscono una certa identità ad
un complesso di norme giuridiche.
Si è detto che le norme giuridiche sono schemi di qualificazione entro i quali ricondurre fatti
giuridicamente rilevanti, secondo lo schema causa/effetto. Ebbene, le norme di principio non
operano in questo modo. Esse sono talmente generiche da precludere una simile operazione. In altri
termini, le norme di principio sono così generiche da non identificare in maniera puntuale rapporti,
fatti, situazioni, comportamenti. Esse, al contrario, tracciano i binari che altre fonti dovranno seguire
per disciplinare determinati fatti in armonia con certo obiettivi da realizzare.
Un esempio può aiutare. Una norma di principio stabilisce, in materia sanitaria, quanto segue: “Il sistema
sanitario deve essere organizzato e disciplinato in modo da garantire la concorrenza tra strutture pubbliche e
strutture private”. È un chiaro esempio di norma di principio. Essa è una norma giuridica, perché vincola
giuridicamente al conseguimento di un dato obiettivo. È, poi, di principio, per la sue latitudine o genericità. Essa,
infatti, non impone di garantire la concorrenza tra pubblico e privato, ma non dice in che modo.
Una delle caratteristiche salienti della norma di principio è di concedere a future norme
giuridiche più o meni ampi margini di scelta circa le modalità per realizzare l’obiettivo racchiuso nel
principio.
Torniamo al nostro esempio. La concorrenza tra pubblico e privato può essere realizzata percorrendo
diverse strade. Erogando sovvenzioni ai privati o negando contributi economici a tutte le strutture, in modo che
anche quelle pubbliche siano costrette a reperire i propri mezzi di finanziamento oppure, ancora, assegnando ai
pazienti dei buoni (equivalenti a somme di denaro) da spendere presso la struttura che si preferisce, pubblica o
privata che sia. Si tenga presente che, nel nostro ordinamento, la Costituzione impone alle istituzioni pubbliche di
garantire “cure gratuite agli indigenti”, in modo tale da assicurare l’assistenza sanitaria anche a chi non se lo può
permettere (→ art. 32).
La genericità, nel senso appena chiarito, della norma di principio ha ripercussioni sul piano
processuale. In effetti, il giudice NON applica la norma di principio per risolvere la controversia. Egli
ha sempre bisogno della regola, sia pure generale e astratta, da applicare al caso concreto: la regola,
cioè, che nel rispetto del principio, ha individuato il mezzo per raggiungere l’obiettivo.
Supponiamo che un imprenditore intenda aprire una clinica privata e che l’assessore regionale alla sanità
glielo vieti. L’imprenditore, convinto di aver subito un torto, si rivolge al giudice per avere giustizia. Il giudice, per
risolvere questa controversia, potrà applicare il principio secondo cui “il sistema sanitario deve essere organizzato e
disciplinato in modo da garantire la concorrenza tra strutture pubbliche e strutture private” ? Oppure, ha bisogno
di una norma più specifica che stabilisca in che modo realizzare l’obiettivo della concorrenza ?
Ebbene, la regola da applicare al caso concreto è data dalle …
b) norme di svolgimento: sono tali le norme giuridiche che attuano il principio stabilendo
schemi di qualificazione entro i quali ricondurre il singolo caso concreto. “Svolgere” o “sviluppare”
31
un principio significa proprio questo: scegliere, tra le diverse soluzioni possibili quanto all’attuazione
del principio, quella che si ritiene più opportuna o conveniente o efficace. Il giudice risolverà le
controversie applicando le norme di svolgimento.
Nell’esempio qui esaminato, norma di svolgimento sarà quella che così stabilisce: “L’assistenza sanitaria
può essere garantita anche da strutture private, che abbiano ottenuto la necessaria autorizzazione da parte
dell’ufficio regionale competente. L’autorizzazione può essere concessa soltanto alle strutture che presentino i
seguenti requisiti: a)...; b) ...; c) ...”. Il giudice, perciò, verificherà se il diniego opposto dall’assessore regionale sia
fondato o meno sulla mancanza di uno dei requisiti stabiliti dalla norma di svolgimento.
Tuttavia, i rapporti giuridici sono spesso molto complessi e, dunque, è necessaria una disciplina
particolarmente dettagliata e capillare. Per disciplinare questi aspetti così minuti intervengono, quindi,
le …
c) norme di specificazione: sono tali le norme giuridiche che, per l’appunto, regolano
nell’estremo dettaglio i fatti considerati dalle norme di svolgimento.
È di specificazione, nel nostro esempio, la norma che, in relazione all’autorizzazione all’apertura di una
clinica privata, stabilisce i moduli da compilare, i documenti da consegnare, ecc.
Nel loro complesso, le tre tipologie di norme concorrono a definire un assetto normativo
compiuto: più semplicemente, la disciplina giuridica di una data materia. Ognuna di esse, però,
assolve a diversi ruoli.
Ritornando all’immagine metaforica del palazzo. I princìpi sono le fondamenta, i pilastri, le mura maestre,
insomma tutti gli elementi architettonici necessari affinché un edifico stia in piedi secondo una particolare
configurazione. Le norme di svolgimento sono gli infissi, le porte, gli impianti elettrici e idraulici, insomma tutti gli
elementi necessari a garantire l’abitabilità dell’edificio. Le norme di specificazione sono i decori esterni, le
piastrelle, i singoli mobili, insomma tutto ciò che completa nel dettaglio l’edificio.
In questo assetto normativo, le norme di principio hanno un ruolo fondamentale. Esse
rappresentano l’origine dell’intera disciplina. Esse orientano la successiva produzione delle norme
giuridiche che poi i giudici applicheranno per risolvere le controversie. Esse indicano gli obiettivi
verso i quali tende la regolamentazione di una data materia. Senza i princìpi non potrebbero
intervenire norme di svolgimento coerenti tra di loro e funzionali rispetto al fine da raggiungere.
Quindi, la maggiore “importanza” delle norme di principio, rispetto alle altre due categorie di norme
giuridiche, può essere dimostrata proprio in questi termini.
E ad analoghe conclusioni si può pervenire in ordine al rapporto tra le norme di svolgimento e
le norme di specificazione.
Siamo sulla buona strada per distinguere tra riserva assoluta e riserva relativa di legge.
L’interrogativo è il seguente: quale, tra la fonte primaria e la fonte secondaria, deve produrre le tre
tipologie di norme in una determinata materia ?
Una prima risposta è facilmente intuibile: data la loro “importanza”, nel senso dapprima
chiarito, le norme di principio debbono essere prodotte da fonti primarie, e solo da queste. Basta
osservare che gli obiettivi di una data disciplina debbono essere decisi con un procedimento che
garantisca anche alle minoranze di partecipare, per le ragioni illustrate in precedenza.
Pertanto, la differenza tra riserva assoluta e riserva relativa riguarda le norme di svolgimento e le
norme di specificazione. E qui soccorre la logica:
- se una riserva è “assoluta”, ciò significa che la fonte primaria è decisamente da preferire
rispetto alla fonte secondaria;
- se una riserva è “relativa”, il divario tra fonte primaria e fonte secondaria tende a diminuire;
32
- la riserva di legge non preclude, come dimostrato dall’esempio delle sostanze stupefacenti,
l’intervento di fonti secondarie: pertanto, alle fonti secondarie bisogna pur sempre “concedere”
qualcosa. Ma cosa ? Solo l enorme di specificazione o anche quelle di svolgimento ?
Considerando questi tre elementi di riflessione, si può logicamente affermare che:
a) nella riserva assoluta, anche le norme di svolgimento sono riservate alla fonte primaria,
mentre le fonti secondarie possono produrre solo norme di specificazione;
b) nella riserva relativa, le fonti secondarie possono essere “autorizzate” dalla fonte primaria a
produrre sia norme di svolgimento che norme di specificazione.
Proviamo a sintetizzare questo ragionamento nella seguente tabella:
Tipologia di norme
RISERVA ASSOLUTA
RISERVA RELATIVA
Norma di PRINCIPIO
FONTE PRIMARIA
FONTE PRIMARIA
Norma di
SVOLGIMENTO
FONTE PRIMARIA
FONTE SECONDARIA
FONTE
SECONDARIA
FONTE SECONDARIA
Norma di
SPECIFICAZIONE
È, però, necessaria una precisazione: la tabella indica lo spazio che la fonte primaria non può
mai cedere alla fonte secondaria. Pertanto, in una materia coperta da riserva assoluta, la fonte
primaria potrebbe anche produrre le norme di specificazione, così come in una materia coperta da
riserva relativa, la fonte primaria potrebbe lasciare alle fonti secondarie soltanto le norme di
specificazione.
Alla luce di questa tabella, e, soprattutto, del complessivo ragionamento prima sviluppato, si
può affermare che:
1) nelle materie coperte da riserva assoluta di legge possono intervenire anche fonti secondarie,
ma solo per porre norme di specificazione, essendo quelle di principio e quelle di svolgimento
riservate alla fonte primaria;
2) nelle materie coperte da riserva relativa di legge possono intervenire anche fonti secondarie,
per porre sia norme di svolgimento che di specificazione, ma mai norme di principio, essendo queste
ultime riservate alla fonte primaria.
B) Sul criterio cronologico
Per evidenti ragioni di certezza del diritto, la norma giuridica dovrebbe essere applicata soltanto
a fatti e comportamenti successivi alla sua entrata in vigore. Solo in questo modo, infatti, è per noi
possibile pianificare le nostre azioni prevedendo le conseguenze giuridiche associate ad esse.
Tuttavia, non mancano norme giuridiche, per lo più prodotte da leggi, che pretendono di
trovare applicazione anche in relazione a fatti e comportamenti che si sono verificati prima della loro
entrata in vigore. Quando una legge, oltre a disporre per il futuro (com’è naturale), regola anche fatti
già avvenuti (com’è, invece, innaturale), allora si parla di retroattività della legge.
33
Una legge retroattiva è un problema per la certezza del diritto, perché spesso impone sacrifici e
oneri a carico di comportamenti che, quando furono posti in essere, erano disciplinati da regole
meno gravose.
Un imprenditore decide di intraprendere una certa attività commerciale puntando sul favorevole regime
fiscale a cui tale attività è sottoposta. Dopo qualche anno interviene una legge che, retroattivamente, introduce un
regime fiscale più pesante. Questo significa che l’imprenditore dovrà pagare più tasse per il futuro e dovrà anche
pagare la differenza tra quanto pagato in passato e quanto dovrà pagare per effetto della nuova legge (cd.
conguaglio). Non è improbabile che se avesse conosciuto in anticipo il nuovo e più pesante regime fiscale, questo
imprenditore avrebbe fatto altro. Altro esempio. In un dato momento coloro che svolgono una certa attività
economica devono rispettare alcuni oneri burocratici: licenza del questore, rispetto di alcuni requisiti relativi
all’immobile adibito a questa attività. Interviene, quindi, una nuova legge che aggiunge nuovi oneri burocratici:
occorre ottenere anche una autorizzazione del comune, sono introdotti requisiti più rigorosi quanto all’immobile.
Questa nuova disciplina si applica non solo alle nuove attività economiche, ma anche a quelle già operanti. I
“vecchi” imprenditori dovranno, quindi, chiedere l’autorizzazione al sindaco e dovranno conformare i locali ai
nuovi e più rigorosi requisiti. Tutto ciò comporta nuove ed ingenti spese che non tutti riescono a fronteggiare.
Dunque, molte imprese chiudono.
Ebbene, sono legittime le leggi retroattive ?
Per rispondere a questo interrogativo occorre cercare nell’ordinamento un eventuale divieto,
non prima di aver precisato che stiamo parlando di fonti primarie del diritto (ossia leggi e atti aventi
forza di legge). Per semplicità, d’ora in avanti si farà riferimento alla “legge”.
L’art.
art. 11 delle cd. Preleggi stabilisce che «la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha
effetto retroattivo».
C’è, dunque, una norma che pone un divieto generale di retroattività della legge.
Occorre, però, domandarsi se questo divieto è in grado di vincolare, ossia di obbligare il
legislatore a produrre norme giuridiche non retroattive.
Le cd. Preleggi furono approvate contestualmente al codice civile del 1942. Tecnicamente le
Preleggi (Disposizioni sulla legge in generale) sono state adottate con regio decreto, una sorta di
decreto legislativo. Come tali, le Preleggi sono fonti primarie del diritto, dunque equiparate alla legge.
Ora, stando ai criteri di composizione delle antinomie dapprima descritti, può una fonte
primaria vincolare future fonti primarie ? Se una legge successiva al 1942 è retroattiva, allora si ha una
antinomia tra questa e l’art. 11 delle Preleggi. Trattandosi di fonti collocate sul medesimo piano,
siamo in presenza di una antinomia orizzontale. Le Preleggi non sono una fonte a competenza
riservata, dal momento che di essa non v’è traccia nella Costituzione del 1948. Dunque, non si
applica il criterio di competenza bensì quello cronologico. Ne consegue che le Preleggi non possono
vincolare le leggi future. Il divieto di cui all’art. 11 delle Preleggi, per quanto ispirato al fondamentale
valore della certezza del diritto, non è applicabile alle leggi.
L’art.
art. 25, secondo comma, della Costituzione stabilisce che «nessuno può essere punito se non
in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».
Questa disposizione fissa un chiaro divieto di retroattività. Una persona può essere punita solo
se, quando ha materialmente commesso il fatto, questo era previsto come reato.
Tale divieto, in quanto stabilito dalla Costituzione, che è fonte superprimaria, è idoneo a
vincolare e obbligare le leggi e le altre fonti primarie.
Tuttavia, siamo davvero in presenza di un divieto generale di retroattività, ossia di un divieto
valido per tutte le leggi ? La risposta è negativa.
Infatti, questo divieto riguarda solo una specifica tipologie di leggi, vale a dire le leggi che
prevedono reati. Più precisamente, siamo nel campo del diritto penale,
penale cioè in quel settore del diritto
oggettivo dove alcuni comportamenti non solo sono vietati, ma sono puniti con le sanzioni più severe:
la reclusione (quindi, limitazione della libertà personale) e/o la multa (sacrifico in denaro).
Pertanto, affinché un giudice possa condannare un individuo è necessario che, al momento
della commissione del fatto, quel fatto fosse previsto come reato (→ illecito penale).
34
La legge penale, che introduce nuove figure di reato, può farlo solo per il futuro e mai per il
passato.
In definitiva, il divieto di retroattività, di cui all’
all’art. 25, secondo comma, della Costituzione, si
applica alle solo norme penali
penali incriminatrici.
incriminatrici
L’aggettivo “incriminatrici” è importante. Infatti, il diritto penale non è composto solo da
norme penale che prevedono reati. Esso include anche norme che impediscono ad un giudice di
condannare una persona: così le norme penali che prevedono le già menzionate cause di
giustificazione: legittima difesa, stato di necessità, adempimento del dovere, consenso dell’avente
diritto. Non solo. A volte la legge penale interviene non per introdurre nuovi reati, ma per eliminare
vecchi reati. Queste norme “alleggeriscono” la posizione degli individui di fronte al diritto penale,
consentendo loro comportamenti leciti: o perché c’è una causa di giustificazione o perché un dato
reato è stato abrogato. Queste norme vengono definite norme penali di favore e sono sempre
retroattive.
retroattive Nel diritto penale, infatti, tutto ciò che è negativo per le persone vale solo per il futuro, e
tutto ciò che è positivo per le persone vale anche per il passato. Ciò in quanto è in gioco il bene
fondamentale della libertà personale.
Riassumendo:
- la Costituzione non prevede un divieto generale di retroattività;
- il divieto generale di retroattività stabilito dalle Preleggi non è vincolante per le fonti primarie
del diritto (lo è invece per le fonti secondarie, quali i regolamenti, in forza del criterio gerarchico);
- la Costituzione:
- vieta la retroattività delle norme penali incriminatrici (che producono un effetto
sfavorevole a danno degli individui);
- impone la retroattività delle norme penali di favore (che producono un effetto
favorevole a vantaggio degli individui).
Ebbene, ciò significa che le leggi italiane possono essere sempre e comunque retroattive ?
Sì, le leggi possono essere retroattive, anche quelle più “antipatiche” come le leggi tributarie.
Tuttavia, la Corte costituzionale ha fissato alcune condizioni e alcuni limiti affinché le leggi
retroattive siano legittime.
1) Condizioni.
Condizioni
Le leggi retroattive compromettono il legittimo affidamento di ogni persona quanto alla stabilità
del diritto oggettivo.
Ogni individuo è consapevole che le leggi possono cambiare, anche in peggio.
Tuttavia, egli deve poter prevedere in anticipo le conseguenze giuridiche delle proprie azioni e
quando una legge interviene retroattivamente questa pianificazione viene impedita. Pertanto, la Corte
costituzionale, nella ricerca di un difficile bilanciamento tra le ragioni del legislatore (che deve sentirsi
libero di cambiare le leggi) e le ragioni delle persone (che devono poter confidare su una certa
stabilità delle leggi), sottopone le leggi retroattive ad un rigoroso giudizio di ragionevolezza.
ragionevolezza
La ragionevolezza è un limite generale delle leggi. La Corte costituzionale ne fa un uso
frequente. La ragionevolezza è uno strumento di controllo delle leggi molto invasivo perché permette
alla Corte non certo di entrare nel merito delle scelte politiche del legislatore, ma di effettuare
controlli che vanno oltre il semplice confronto tra la legge e la Costituzione. Così, una legge non è
irragionevole, ad esempio:
- quando è strettamente necessaria in relazione agli interessi in gioco;
- quando le misure in essa previste sono proporzionate rispetto al fine da raggiungere;
- quando un eventuale divieto è la extrema ratio, ossia l’unica soluzione possibile per
fronteggiare un determinato problema;
- quando riflette correttamente la realtà su cui è destinata ad incidere con mezzi appropriati.
35
Ebbene, ove si tratti di legge retroattiva, la Corte diviene molto più severa nel verificare la sua
ragionevolezza.
Spesso, per garantire il rispetto della ragionevolezza, la Corte esige che il passaggio retroattivo
da un regime favorevole ad un regime meno favorevole sia graduato attraverso l’introduzione di
norme transitorie.
transitorie Per alcuni rapporti, cioè, pur verificatisi in passato, rimane la vecchia disciplina
oppure ad essi si applica una disciplina intermedia tra il vecchio e il nuovo regime. Tutto ciò serve a
rendere più graduale la transizione tra due discipline.
2) Limiti.
Limiti
Le leggi retroattive non possono mai modificare i rapporti giuridici
giuridici esauriti.
esauriti
Sono tali i rapporti che, in presenza di determinati atti o fatti, si consolidano a tal punto che
neanche la legge può più modificarli. In effetti, ancora una volta in ragione della certezza del diritto,
arriva un momento in cui un rapporto giuridico controverso raggiunge una forma definitiva, non più
scalfibile, così che i soggetti interessati conoscano con certezza le implicazioni giuridiche di quella
situazione.
Ebbene, quando un rapporto giuridico può considerarsi “esaurito” ?
a) Una sentenza
sentenza civile passata in giudicato esaurisce un rapporto giuridico. Una volta esauriti
tutti i rimedi processuali, una data controversia può considerarsi conclusa quando il giudice emette
una decisione definitiva, vale a dire una sentenza che non può più essere messa in discussione.
Attenzione ! Il discorso è diverso per le sentenze penali passate in giudicato. Se una persona
viene condannata in via definitiva per un reato, e questo, in seguito, viene abrogato, egli verrà
immediatamente liberato. Si suol dire che l’abrogazione di un reato travolge anche il giudicato.
Perché questa differenza rispetto alle sentenze civili passate in giudicato ? Per le stesse ragioni in
precedenza esposte, relativamente al diritto penale (ripeto: nel diritto penale tutto ciò che è negativo
per le persone vale solo per il futuro, e tutto ciò che è positivo per le persone vale anche per il
passato).
b) La prescrizione esaurisce un rapporto giuridico. Se un individuo non esercita un potere a lui
attribuito dal diritto oggettivo entro un determinato termine, questo potere viene meno: e viene meno
in maniera definitiva, in quanto il soggetto non può cambiare idea e “ricordarsi” in ritardo di avvalersi
di quel potere. Lo stesso vale per l’istituto affine della decadenza.
decadenza
c) I diritti
diritti quesiti esauriscono un rapporto giuridico. Partiamo da un esempio. Tizio, dopo aver
maturato il diritto alla pensione, inizia a ricevere dall’istituto previdenziale una certa somma di denaro
ogni mese, calcolata secondo le regole applicabili quando egli lavorava. Ebbene, il diritto al
conseguimento di quella pensione è un diritto quesito, nel senso che è stato acquisito definitivamente
nel patrimonio giuridico del pensionato. È un diritto inattaccabile, che dunque la legge non potrà
eliminare retroattivamente. La consistenza della pensione potrà essere intaccata, ad esempio,
dall’aumento delle tasse o dalla diminuzione delle detrazioni. Tuttavia, Tizio avrà sempre diritto a
quella pensione.
36
Capitolo IV
VERSO LO STUDIO DELLA COSTITUZIONE ECONOMICA
Sezione I
LA COSTITUZIONE IN GENERALE
La nozione di Costituzione nella teoria generale
Di seguito è riportato un estratto della voce Costituzione, scritta da S. Bartole per il Digesto, IV
ed., Discipline pubblicistiche.
La nozione di costituzione è relativamente recente. Le prime carte costituzionali furono redatte
alla fine del Settecento negli Stati Uniti, per suggellare il patto che ha unito le ex colonie britanniche
che avevano dato vita ad un nuovo Stato, e in alcuni Stati europei, a cominciare dalla Francia
rivoluzionaria.
È proprio l’art.
art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’
dell’uomo e del cittadino del 1789 a definire
l’essenza e la funzione della Costituzione: «ogni società, che non tutela i diritti e che non prevede la
separazione dei poteri, non ha una costituzione».
Da questo enunciato si desume che il compito fondamentale della costituzione è tutelare i diritti
dei consociati. In verità, i diritti soggettivi sono sempre stati tutelati, in misura più o meno intensa, sin
dalle più risalenti esperienze giuridiche (diritto greco e diritto romano). Questi diritti, però, erano
tutelati nei rapporti tra individui: si pensi solo alle molteplici forme di protezione che hanno
presidiato nel tempo la proprietà privata, ossia l’archetipo dei diritti soggettivi.
Con la rivoluzione francese si assiste ad un vero e proprio salto di qualità. I diritti sono protetti
anche, e innanzitutto, nei confronti del potere, dell’autorità. Sino a quel momento, il sovrano, tramite
i propri funzionari, poteva disporre arbitrariamente delle libertà dei sudditi, a cominciare dalla libertà
personale. Solo in Inghilterra, questo bene giuridico aveva ricevuto una qualche protezione già
parecchi secoli prima. Nel resto d’Europa non era così. L’autorità, incarnata nel monarca assoluto
titolare della sovranità e detentore di tutti i poteri, poteva liberamente disporre arresti, perquisizioni,
espropri, limitazioni o divieti alla circolazione delle persone, e via dicendo.
Con l’avvento del costituzionalismo,
costituzionalismo alla costituzione è affidato il compito di proteggere i diritti
pubbliche: diritti che, per l’appunto, furono
fondamentali delle persone nei confronti delle istituzioni pubbliche
definiti fondamentali in quanto libertà prediate dalla costituzione verso gli abusi del potere.
Così, una costituzione stabilisce se e come si possano limitare i diritti inviolabili: libertà
personale, domicilio, corrispondenza, circolazione, manifestazione del pensiero, riunione,
associazione, libertà di culto. Ciò significa che, per ragioni di ordine pubblico, tali diritti ben possono
essere “violati” dalle autorità statali (ossia limitati: si pensi all’arresto, alle perquisizioni, alle
intercettazioni, ai divieti), ma solo nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla costituzione.
Si noti che il pericolo per i diritti fondamentali non si annida solo dietro le attività delle forze di
polizia (che procedono agli arresti, alle perquisizioni, alle intercettazioni, ai sequestri, ecc.) (→ potere
esecutivo) e degli organi giudiziari (che indagano sui reati, che condannano gli imputati) (→ potere
giudiziario). Infatti, anche la legge può diventare un’arma da brandire contro i diritti fondamentali (→
potere legislativo).
La legge è il prodotto di un processo decisionale che si svolge in un parlamento, vale a dire in
una assemblea composta dai rappresentanti del popolo scelti tramite una competizione elettorale.
Alla fine della discussione, decide comunque la maggioranza. Quest’ultima ha un obiettivo da
raggiungere: conservare il potere il più a lungo possibile, dunque, vincendo anche le nuove elezioni e
quelle successive ancora. A contrastare questo fine ci pensa l’opposizione, che si avvarrà di tutti i
37
mezzi leciti per criticare l’operato della maggioranza e, quindi, per spingere l’opinione pubblica a
votare contro. Stando così le cose, è tangibile la tentazione della maggioranza di approvare leggi con il
solo scopo di indebolire l’opposizione, e la strada più congeniale da seguire potrebbe essere proprio
quella della limitazione forte dei diritti fondamentali. Si pensi, così, a leggi che limitano la libertà
diparola, o il diritto di riunirsi o di associarsi, e così via.
Ecco perché anche il potere legislativo può diventare un’arma impropria nelle mani della
maggioranza per conservare il potere nel tempo a danno della minoranza.
La costituzione, quindi, per evitare abusi da parte delle autorità, limitano tutti e tre i poteri dello
Stato: legislativo, esecutivo, giudiziario.
Questo spiega l’altro elemento costitutivo della nozione di costituzione di cui al citato art. 16,
ossia la separazione dei poteri.
poteri I tre poteri dello Stato sono attribuiti a organi diversi. La diversità tra
organi non sta solo nel nome (parlamento, governo, magistratura), ma nella differente modalità di
scelta di coloro che sono chiamati a ricoprire quegli incarichi istituzionali. Il parlamento è eletto dal
popolo, il governo ha una investitura variabile ma comunque diversa da quella dell’assemblea
legislativa, i magistrati sono reclutati tramite concorso.
La separazione dei poteri è un ingrediente indispensabile nella ricetta che la costituzione ha
elaborato per proteggere i diritti fondamentali. Infatti, i diversi organi si controllano a vicenda, pur
operando entro sfere distinte. Da sempre la concentrazione del potere in capo ad un solo organo è
stata la minaccia più seria ai diritti fondamentali, dal momento che questo organo (il più delle volte un
monarca assoluto) poteva agire indisturbato, essendo sottratto a qualsiasi forma di controllo.
Prima si è fatto riferimento al costituzionalismo: questa è la corrente di pensiero che ha esaltato
il ruolo della costituzione quale baluardo difensivo dei diritti fondamentali.
In realtà, a partire dal 1803 si registra una divaricazione tra il costituzionalismo nordamericano
e il costituzionalismo dell’Europa continentale.
Nel 1803 la Corte suprema degli Stati Uniti (organo di vertice del’apparato giudiziario federale)
ha per la prima volta dichiarato una legge del Congresso (l’equivalente del nostro Parlamento) in
contrasto con la Costituzione. L’antinomia è stata risolta, quindi, a favore della fonte del diritto
ritenuta di più alto livello. I giudici della Corte suprema, infatti, hanno ammesso che solo non
applicando leggi contrarie alla Costituzione questa avrebbe davvero potuto operare quale atto
normativo fondamentale degli Stati Uniti (→ caso Marbury versus Madison).
Contemporaneamente, nella Francia rivoluzionaria si afferma l’idea che la legge votata dal
Parlamento sia la fonte de diritto più importante. Il Parlamento è composto dai rappresentanti del
popolo sovrano. La legge è, quindi, espressione della volontà della nazione. Pertanto, la costituzione
fu considerata a lungo come una fonte equiparata alla legge, come tale modificabile dalle maggioranze
a seconda della evoluzione degli indirizzi politici e dei rapporti sociali. Tutti gli altri stati europei
finirono con l’aderire a questa concezione della costituzione.
Il divario tra queste due forme di costituzionalismo scompare con la fine della seconda guerra
mondiale. Le nefaste esperienze del nazismo e del fascismo dimostrarono la debolezza di costituzioni
(la Costituzione di Weimar in Germania, lo Statuto albertino in Italia) considerate alla stessa stregua
delle comuni leggi. L’epilogo di tali regimi segnò finalmente l’affermazione della costituzione quale
fonte suprema dell’ordinamento, come tale idonea a vincolare e a limitare le leggi volute dalla
maggioranza. Si afferma, così, lo Stato costituzionale di diritto:
diritto i tre poteri dello Stato sono
egualmente sottomessi alla costituzione.
S. BARTOLE, voce Costituzione (dottrine generali e diritto costituzionale), in Dig. IV ed., Disc. pubbl.,
vol. IV, Utet, Torino, 1989, pp. 288 ss.
1. Molteplicità di significati del termine costituzione. La Costituzione come carta costituzionale: ragioni e
conseguenze del ricorso alla redazione scritta della costituzione.
38
È frequente la constatazione che la parola costituzione viene usata in una molteplicità di significati,
anche quando non viene ulteriormente qualificata con il ricorso ad uno degli aggettivi cui abitualmente si
accompagna (formale, materiale, rigida, flessibile, politica, vivente, ecc.)(1). Questo dato non può essere
formalmente trascurato, assumendo a priori questo o quel punto di vista, giacché frequentemente al termine
costituzione vengono assegnati significati diversi pur all’interno di una stessa disciplina: all’esperienza ormai
scontata della scienza giuridica costituzionalistica, cui ha in particolare riguardo, ovviamente, questa voce, si è
aggiunta di recente la constatazione in sede politologica che «there is no doubt considerable frustation in being
confronted with so wide a term» (2). Ambiguità e confusione travalicano i confini linguistici, come quelli fra le
discipline scientifiche, tanto più che pare di scarsa utilità la comune ascendenza latina delle parallele parole
italiana (costituzione), francese (constitution) e inglese (constitution)(3). E però, d’altra parte, non è nemmeno
sufficiente limitarsi ad una mera elencazione dei diversi significati possibili(4), eventualmente accompagnata da
una trattazione separata e distinta degli stessi. Il fatto è che quei significati rimandano a differenti e
differentemente argomentate teorie cui corrispondono concezioni diverse della costituzione. Proprio perché
tutte sono volte a comprendere e spiegare lo stesso ordine di problemi, tali teorie non possono costituire
oggetto di trattazioni separate e distinte, e vanno invece esaminate all’interno di un unico discorso, non solo
per arrivare da diversi punti di vista ad una comprensione complessiva e sintetica dei fenomeni esaminati. Si
tratta anche di verificare se fra le varie teorie e, quindi, fra le varie concezioni della costituzione corrano fili più
o meno appariscenti che tutte le colleghino nella trama dello sviluppo della ricerca scientifica. Il che, fra l’altro,
potrebbe essere al tempo stesso sintomo e conseguenza del fatto della perenne attualità del problema della
costituzione: «tout groupement politique comporte une constitution qui exprime sa manière d’être» (5).
Questa ipotesi è stata, però, revocata in dubbio autorevolmente da chi sostiene che nel xviii secolo il
termine costituzione «era da lungo termine vacante», disponibile, quindi, per un uso che, ripartendo per così
dire da zero, gli assegnasse un significato tutto proprio e originale, teleologicamente collegato agli obiettivi del
filone di pensiero che ha preso il nome di costituzionalismo(6). Gli intendimenti sottostanti a tale presa di
posizione sono molteplici. Vi è anzitutto il proposito di riproprorre il legame fra l’avvento delle costituzioni
moderne nell’America del Nord e nell’Europa del ‘700 e le dottrine politiche che quell’avvento hanno
favorito.
È certo che quel legame era andato via annebbiandosi ed era destinato a restare dimenticato nella
misura in cui è venuto prendendo piede, specialmente fra i giuristi, un significato «cosmico e formale» di
costituzione: «‘costituzione’ è qualsiasi forma che uno Stato si dà» (7). Con la diffusione delle costituzioni
scritte, con la loro sempre più frequente utilizzazione da parte di regimi politici che nulla hanno a che fare con
le dottrine costituzionalistiche(8), e con i loro più recenti svolgimenti non ha più riscontro nella realtà la
dichiarazione dell’art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789 per cui «toute societé dans la quelle la garantie
des droits, n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution». Reagendo a
questi svolgimenti contemporanei e sottolineando l’incongruenza con la tradizione del pensiero
costituzionalistico delle posizioni di quanti, fermandosi all’apparenza formale delle costituzioni, ne trascurano i
contenuti, Sartori mira a porre in evidenza le finalità garantistiche che hanno accompagnato l’introduzione
delle costituzioni settecentesche(9).
Lo spunto è stimolante, e tuttavia non aiuta un pieno chiarimento del problema che ci sta di fronte.
Certamente soddisfa anche all’ulteriore proposito, forse non esplicitamente formulato ma chiaramente
evidente; di dare adeguata collocazione all’apporto dato in materia, accanto e prima della vicenda
rivoluzionaria francese, dall’esperienza americana. È però contemporaneamente, coinvolgendo nel discorso
anche il tema della costituzione inglese, ove la realizzazione degli obiettivi garantistici resta principalmente
affidata a strumenti di ordine politico e sociale(10), confonde in parte i termini della questione. Non è, cioè,
possibile prescindere dal fatto che sia in America che in Francia il fenomeno è strettamente legato all’adozione
di costituzioni scritte, cioè alla redazione scritta di documenti giuridicamente rilevanti. Non è consentito
liquidare il fatto con la considerazione che «sia come sia, una costituzione tutta codificata in un unico
documento è soltanto un mezzo» (11). L’adozione delle costituzioni scritte pare essere un aspetto significante e
imprescindibile del costituzionalismo settecentesco, nella misura in cui comporta la giuridicizzazione dei
rapporti costituzionali nei termini di una delimitazione del potere arbitrario e della garanzia di un governo
limitato. Questo processo di giuridicizzazione trova stabilità e certezza nel documento scritto, al tempo stesso
recuperando in queste peculiari caratteristiche un supporto, un sostegno al ruolo che la costituzione è chiamata
a svolgere in quanto legge fondamentale.
Il punto si coglie molto bene nella sequenza che segna gli sviluppi del pensiero politico nordamericano
antecedente e contemporaneo all’adozione degli Articoli della Confederazione prima (1776), e della
39
Costituzione poi (1787). Il punto di arrivo è l’idea di «a written superior law set above the entire government
against which all other law is to be measured», con la quale — a detta di Gordon Wood — «so enthralled have
Americans become... that it is difficult to appreciate a contrary conception» (12). Ma questa idea non nasce
senza un travaglio ed è proprio cogliendo questo travaglio che riusciamo a meglio apprezzare il risultato
raggiunto. Al momento dello scoppio della controversia con l’Inghilterra la concezione della costituzione
prevalente fra i coloni era quella che essi avevano ereditato dalla tradizione del pensiero politico inglese. Con
la parola costituzione non si alludeva né ad un documento scritto né ad «an unwritten but deliberately
contrived design of government and a specification of rights beyond the power of ordinary legislation to alter»
(13).
Se John Adams poteva scrivere che una costituzione politica è simile alla costituzione del corpo umano,
egli non faceva che riprendere l’idea che la costituzione non era nulla di anteriore o superiore al sistema di
governo e alla stessa legge ordinaria, giacché si identificava con quell’insieme di leggi, costumi e istituzioni che
formava il sistema generale, secondo il quale i diversi poteri dello stato venivano distribuiti, e ai singoli membri
della comunità erano assicurati i rispettivi diritti(14). Agli inizi, dunque, l’idea di costituzione non si discostava
da quella dell’assetto attuale del potere e dei rapporti tra il potere e il popolo, che, del resto, era l’unica idea
praticabile e comprensibile dal pensiero politico inglese del ‘700, in mancanza di una costituzione scritta, e in
presenza della ferma convinzione che, consuetudini e leggi in vigore di un paese dovendo corrispondere a
ragione, erano anche il più sicuro criterio attuale di ciò che per ragione doveva intendersi(15). Il riferimento
alla ragione consentiva che si parlasse di «animating principles... stamina vitae», capaci di dare scopo e
direzione al complesso delle leggi e dei costumi, ma non era in sostanza pensabile che vi fosse una qualche
contraddizione fra la costituzione e quelle leggi e costumi, sì da dare alla prima una propria, autonoma e
distinta identità e da differenziarla così dagli assetti attuali e vigenti(16).
Una siffatta concezione era però destinata ad entrare in crisi nel momento in cui, venendo in conflitto
con il Parlamento inglese, i coloni ne giungevano a contestare le determinazioni. Gli atti del Parlamento che
erano oggetto di contestazione non potevano più essere considerati «declaratory of the ancient principles of the
Common law» e, perciò, espressivi di una razionalità direttamente discendente da Dio: non era così più
accettabile la stessa idea che se a Dio spettava lo jus dare, al Parlamento competeva di jus dicere(17). Il potere
del legislativo doveva essere assoggettato a vincoli e limitazioni, e ci si doveva garantire che quando questi
risultassero violati, i suoi atti si potessero considerare viziati(18). Ma per giungere ad un esito siffatto quei
vincoli e limiti dovevano essere anzitutto enunciati in forma espressa ed essere, quindi, contrassegnati da
caratteristiche di certezza e stabilità. È su questi motivi che si sviluppa una svolta nell’idea di costituzione.
Supremazia e continuità della costituzione sono due facce della stessa medaglia, e, proprio perché la
costituzione è qualcosa di permanente, il Parlamento non può fare leggi in ispregio di essa. Fra costituzione e
forma attuale di governo non vi può essere confusione: tutte le nazioni hanno un governo, ma solo poche
hanno realmente una costituzione. Sulla scorta di questa posizione così drastica e chiara si poteva giungere
addirittura a prendere le distanze dall’esperienza inglese, portando alle ultime conseguenze il già ricordato
conflitto con quel Parlamento: se la funzione primaria della costituzione è quella di fissare «the boundaries of
governmental powers», il potere del legislativo in Inghilterra non conosce limiti, perché ivi «there was no
constitution» (19).
...
A considerazioni diverse si presta l’esperienza costituzionale della Rivoluzione francese, e però anche
dal suo esame si traggono indicazioni che permettono di meglio precisare e sviluppare, se non parzialmente
superare l’indicazione data da Sartori. Anche in Francia all’inizio ritroviamo una concezione meramente
esistenziale della costituzione, subito però integrata e corretta da preoccupazioni più immediatamente
operative. Il regno ha già una costituzione, che è quella consegnata al suo assetto tradizionale, ma essa è però
caduta in oblìo sicché bisogna restaurarla. E per restaurarla fa d’uopo passare ad una sua stesura scritta: è
questo il compito che i cahiers affidano ai delegati alla riunione degli Stati Generali del 1789(21). L’esigenza
della formulazione espressa così si sovrappone al retaggio di una legge fondamentale che pure anche in Francia
la tradizione consegna ai tempi moderni(22). E, però, all’atto stesso in cui il Terzo Stato si costituisce in
Assemblea Costituente, i termini propri del problema si rovesciano: la stesura della costituzione non ha più da
essere soltanto la ricognizione formale (eventualmente sorretta dai crismi dell’intervento regio) del tradizionale
assetto del potere(23), ma deve essere qualche cosa di più. Alla costituzione, infatti, si attribuisce ormai un
significato più pregante: essa esprime sì «un ordine fisso e stabilito nella maniera di governare», e però
quest’ordine deve appoggiarsi «su delle regole fondamentali, create dal consenso libero e formale di una
nazione o di coloro che essa ha scelto per rappresentarla», sicché all’origine vi ha da essere una scelta esplicita.
«Quando la maniera di governare non deriva dalla volontà del popolo chiaramente espressa, esso non ha una
40
costituzione» (24). Prende così piede una concezione normativa di costituzione, frutto di una volontà destinata
a progettare e conformare di sé il futuro della comunità che l’adotta. Non si ammette più che la costituzione si
faccia lentamente, nei secoli, nel sedimento della tradizione. Essa ha da essere il frutto di una decisione
responsabile. Ancora una volta la rottura con l’esperienza inglese non potrebbe essere più netta (e, del resto,
ciò è confermato in qualche modo dallo stesso Sartori)(25). Tuttavia, il distacco e la contrapposizione delle sue
esperienze non si ferma qui.
Quanto meno nel modello interpretativo che l’abate Sieyès proponeva ai suoi contemporanei doveva
esserci una netta distinzione e separazione fra potere costituente e potere legislativo. Quest’ultimo non era
collocato in una posizione di supremazia all’interno del sistema, come invece avveniva in Inghilterra, giacché
una tale posizione spettava al primo, cioè al potere costituente. La costituzione era opera del potere
costituente, ad essa le leggi prodotte dal legislatore ordinario non potevano derogare, giacché «nessuna specie
di potere delegato può introdurre dei cambiamenti nelle condizioni della sua delega» (26).
Vi è una concordanza di orientamento di fondo fra la teoria di Sieyès e le posizioni che abbiamo trovato
espresse dai coloni americani. In un caso e nell’altro la costituzione è considerata come la legge fondamentale,
essa stessa una legge positiva e però sovraordinata alle leggi ordinarie. Ma il costituzionalismo americano,
accennando alla possibilità che la legge ordinaria contrastante con la costituzione possa definirsi viziata, poneva
le premesse per il controllo di costituzionalità, ovvero per una sua ripresa (nella forma del judicial review) per
chi vede un antecedente di questo nel famoso Bonham’s Case(27). Era solo uno spunto che avrebbe, tuttavia,
dato di lì a poco i suoi frutti(28). D’altra parte, comune in qualche modo era la giustificazione della peculiare
resistenza alle modifiche della costituzione: la specialità del potere da cui la costituzione traeva origine. E però,
mentre l’abate francese idealizzava il ruolo del popolo parlando di nazione e, perciò, di popolo esistente e
presupposto come unità politica(29), molto più concretamente in America, pur riconoscendo che «the
constitution should be the avowed act of the poeple at large», si ammetteva con maggiore concretezza che la
revisione della costituzione poteva anche non coinvolgere l’originario potere costituente, in quanto si poteva
ritenere che la carta era «irrepeable and unalterable by any authority but the express consent of a majority of
the citizens collected by such regular mode as may be therein provided» (30). Infine analoga divaricazione,
sempre sul fronte della rivedibilità della costituzione, poteva cogliersi fra l’atteggiamento più pragmatico delle
dottrine americane, per cui il tema della garanzia dei diritti naturali era anzitutto quello della ricerca di una
chiara e adeguata linea divisoria fra i poteri concessi dalla costituzione all’autorità costituita e la sfera di
autonomia e libertà che doveva comunque restare radicata in capo ai consociati, e una certa quale astrattezza
del disegno di conservazione dei diritti sotteso alla concezione francese della costituzione e, in particolare, delle
relative dichiarazioni(31).
...
2. (Segue). Contenuto e posizione fra le fonti delle costituzioni scritte.
Le conclusioni che abbiamo raggiunto consentono di affrontare il problema della definizione della
costituzione su un terreno più squisitamente giuridico, senza per questo perdere di vista i fattori di ordine
storico ed ideologico che hanno accompagnato l’avvento delle prime costituzioni scritte e hanno in effetti
caratterizzato il nostro problema con riguardo ad esse.
L’adozione delle prime carte scritte s’impone all’attenzione non tanto per il solo fatto tecnico della loro
redazione in documenti ufficiali promananti da determinate autorità formalmente legittimate in base ai canoni
più diversi, quanto per la circostanza che esse rappresentano il frutto di una scelta consapevole, diretta a dare
norma in via previa e continuativa all’assetto delle istituzioni governanti di uno stato e dei rapporti di queste
con i membri della collettività che in quello stato si riconosce. Si tratta, quindi, di atti giuridici aventi un
contenuto tipizzato, che rispondono ad esigenze di tecnica giuridica motivata da una teoria dei rapporti
costituzionali diversa da quella che identifica la costituzione con l’assetto presente delle istituzioni di un certo
stato, e ne affida l’avvento e lo sviluppo ad un processo di lenta sedimentazione di usi, prassi e convenzioni,
cioè ad un insieme di fatti inconsapevoli della loro connessione, anche se risultanti, ciascuno individualmente,
da scelte volontarie e consapevoli(32).
Se ne ricava che almeno due sono gli ordini di problemi che alla dottrina giuridica le costituzioni scritte
pongono al momento del loro avvento. Da un lato, c’è la questione dei contenuti della costituzione, che è
strettamente correlata a quella della funzione della costituzione stessa, e c’è, dall’altro lato, il tema della
posizione di quest’ultima fra gli atti fonte, anch’essa a sua volta collegata al profilo funzionale, restando così
dimostrata la connessione che lega questi, che non sono che i molteplici aspetti dell’unico e complesso
argomento che andiamo sviluppando.
41
Di per sé considerata, la questione della funzione non dà luogo a particolari interrogativi, una volta che
si accetti la riconduzione delle costituzioni all’ampia categoria degli atti giuridici, e ovviamente di quelli
normativi in particolare (e nulla nell’esperienza storica considerata smentisce questa ipotesi). L’elemento di
novità sta tutto nella già rilevata, consapevole assunzione della disciplina di una materia per l’innanzi rilasciata a
un sistema di fonti più o meno casuale. Si attua, così, un tentativo di dare assetto unitario alle istituzioni e ai
rapporti fra le istituzioni e i cittadini, sicché essenziale è proprio cogliere — per usare una terminologia certo
poco e per nulla conosciuta dagli autori delle prime costituzioni — le materie e le submaterie per le quali
l’esigenza di una disciplina unitaria si fa sentire. Ed è fin d’ora palese che l’individuazione dell’ambito operativo
delle carte costituzionali non potrà non rivelarsi rilevante ai fini della definizione dell’altro ordine di problemi
testé accennato.
Fin dall’inizio vi è, ad esempio, in America sufficientemente radicata l’idea che, in quanto atto
normativo, la costituzione non si distingua dagli atti similari, se non per la particolare natura e la superiore
importanza della materia trattata: dovendo costituire termine e misura dell’attività di governo, essa riguarda tale
attività nel suo complesso, anche se con speciale attenzione al potere legislativo, e contiene quindi l’insieme
delle regole fondamentali sulle quali è destinato a reggersi il supremo potere di uno stato(33). Analogo
richiamo alla fondamentalità delle regole costituzionali ritroviamo in Francia, ove si parla di una forma
determinata e costante di governo, ovvero — con una visione che realisticamente si allarga a quelli che oggi
definiremmo i problemi della forma di governo — si allude alla costituzione come espressione dei diritti e degli
obblighi dei diversi poteri che lo compongono(34). Per i suoi stessi contenuti, una costituzione è dunque
destinata ad imporsi agli atti di autorità, giacché in essa debbono travare enunciazione tutti i limiti che si
appongono ai poteri delegati(35). «Giammai le leggi non saranno eseguite», dice Monnier all’Assemblea
Nazionale, «finché non si avrà distrutto il potere arbitrario mercé una precisa forma di governo... quando una
volta la libertà sarà fissata... e il potere legislativo sarà determinato, le buone leggi si presenteranno
naturalmente» (36).
È dunque il contenuto stesso della costituzione ad assegnare a quest’ultima la posizione che è destinata
ad occupare fra le fonti del diritto. Se da essa debbono discendere le regole costanti dell’attività di governo e,
pertanto, dell’esercizio del potere, è inimmaginabile che da questo promanino — in quanto potere costituito —
atti che si sostituiscono o si sovrappongono alla costituzione medesima. L’argomento è di ordine logico, ma ha
anche una sua valenza giuridica, nella misura in cui parte dal presupposto che una regola di diritto s’impone
all’osservanza dei suoi destinatari almeno in tanto e fin quando sia in vigore. È pertanto consentito di
discostarsi dalle regole costituzionali solo in quanto si sia prima provveduto alla loro revisione. Si tratta di un
principio di comune accettazione, che trova nella destinazione alla permanenza e continuità della costituzione
un ulteriore motivo di conferma e giustificazione.
Ma il problema della collocazione della costituzione fra le fonti trova ulteriori elementi di precisazione e
arricchimento su ambedue le coste dell’Atlantico, nella misura in cui, da un lato, si accenna alle giuridiche
conseguenze del conflitto fra costituzione e legge ordinaria e, dall’altro lato, si collega il discorso della
costituzione a quello sul potere costituente e sul ruolo che questo è chiamato a svolgere. L’idea che la legge del
Parlamento contrastante con la costituzione sia viziata costituisce un elemento di garanzia dell’osservanza della
costituzione e, quindi, della sua continuità e stabilità. In qualche modo questo risultato è anche raggiunto
quando il potere di revisione della costituzione non viene separato dal potere costituente e, quindi, la sua
attivazione può aversi solo alle condizioni eccezionali e speciali che hanno contrassegnato l’adozione della
costituzione, ovvero quando si addivenga alla convocazione dello stesso organo cui si deve la deliberazione
della costituzione. Esperienza americana e teorizzazione francese tendono di massima a convergere nei
risultati, ma è una convergenza di breve periodo, giacché, mentre oltre oceano la teoria del judicial review
completa il tema garantistico connesso alla prevalenza della costituzione come legge fondamentale, in Europa
altre e diverse dottrine spingono sullo sfondo la teoria del potere costituente, riducendo la portata della
garanzia costituzionale. Resta quello che potremmo chiamare il valore o peso specifico che alla costituzione
deriva dai contenuti che le sono propri e, quindi, dal carattere per così dire preliminare della decisione che in
essa trova manifestazione, ma la sua forza giuridica è tutta e soltanto legata al rispetto del principio per cui una
regola non può essere disapplicata sinché non venga abrogata o modificata. Gioverà aspettare le meditazioni di
Bryce perché al di qua dell’Oceano vi sia una ripresa di consapevolezza del tema della garanzia della
costituzione(37), anche se già con le leggi della Terza Repubblica — e quindi dieci anni prima che Bryce
richiamasse l’attenzione sulla distinzione fra costituzioni flessibili e costituzioni rigide — si era ripreso il
principio che alla revisione della costituzione, rectius delle leggi costituzionali si poteva addivenire soltanto
attraverso una procedura speciale e aggravata, diversa da quella seguita per l’adozione delle leggi ordinarie(38).
42
È, però, importante osservare che se l’idea di una gerarchia formale che consentisse di porre la
costituzione al vertice delle fonti del diritto conosce fortune diverse, ed è più dura a giungere a maturazione in
Europa, andamento diverso ha l’opinione che, almeno in sede interpretativa, colloca comunque la costituzione
in posizione di primazia fra le fonti e le assegna una posizione di vertice nel contesto di una gerarchia
sostanziale o dei valori che, badando tuttavia, più che agli atti, alle norme che da essi si ricavano, gradua queste
ultime in ragione dei loro contenuti e dei dati assiologici che in esse trovano manifestazione(39).
Così impostato, il problema si amplia e finisce per investire anche i rapporti tra le carte costituzionali e i
loro preamboli o le dichiarazioni che in varia guisa le precedono. Tra gli uni e le altre vi è tendenzialmente
somiglianza, anzi la ricerca storica ha dimostrato a sufficienza che è il preambolo della costituzione americana
l’ascendente al quale già si era rivolta l’attenzione degli autori dei cahiers de doléances, in cui dapprima
comparve la richiesta di una dichiarazione dei diritti(40). Ma proprio per il carattere proemiale che a
quest’ultima si intendeva dare, la si voleva sin dall’inizio strettamente collegata al testo della carta, ad evitare il
rischio «che delle idee contrarie e filosofiche, se non fossero accompagnate dalle conseguenze,
permetterebbero di supporne altre da quelle che saranno ammesse dall’Assemblea» (41). La preoccupazione
vale più per quello che lascia intendere nel bene e nel male che per quello che espressamente dice. Alla
dichiarazione si pensa come ad una guida per l’implementazione del disegno di garanzia, alla cui persecuzione
l’intera operazione costituente è rivolta. Si sente, quindi, l’esigenza di orientare e dirigere e il lavoro degli autori
della futura costituzione e l’attività dei suoi futuri interpreti. Non ci si vuole tuttavia affidare alle clausole aperte
dagli enunciati della dichiarazione, ma ci si propone di valorizzarne il valore direttivo fermandone il significato,
bloccandone le potenzialità semantiche, ancorando quegli enunciati alle più concrete e circostanziate
disposizioni della costituzione. Ci si può chiedere quale utilità possa avere un disegno normativo siffatto,
destinato quasi ad invertire l’ordine abituale dell’argomentazione giuridica che vuole le dichiarazioni di
principio destinate ad arricchire e definire il senso delle norme di specie, e non viceversa(42). E però va detto
che non siamo probabilmente in presenza di una vera e propria inversione del genere di quella ipotizzata.
L’utilità ermeneutica della dichiarazione è fuori discussione, ma è anche fuori discussione che essa non
può essere dilatata al di là dei significati attuali dei principi ad essa sottesi, quali si inverano nelle disposizioni
costituzionali: tanto è che si propose di rinviare la definitiva adozione della dichiarazione stessa ad esame
avvenuto di tutti gli articoli della costituzione(43).
L’impostazione la dice lunga sulla diffidenza dei costituenti francesi nei confronti degli interpreti. La
discrezionalità di questi va, per così dire, controllata con una manovra a tenaglia, attribuendo, cioè, alla
dichiarazione — come osservava Barnave — due utilità pratiche: «la prima è di fissare lo spirito della
legislazione, affinché non la si cambi in avvenire; la seconda è di guidare lo spirito sul completamento di questa
legislazione, che non può prevedere tutti i casi...» (44). Per quanto avulsi dal testo della costituzione, i principi
della dichiarazione sono destinati a collocarsi in una posizione (forse di primazia sostanziale, ma in ogni caso)
di parità materiale nei confronti delle norme costituzionali. Il che, ovviamente dà per scontata e fuori
discussione la loro prevalenza nei riguardi della legislazione ordinaria, prevalenza che è dunque costruibile
indipendentemente da qualsiasi riferimento ai profili formali delle fonti di diritto in esame.
Il discorso che si è fatto può ripetersi pari pari, ed anzi con maggiore agevolezza per gli enunciati stessi
delle costituzioni e, quindi, per le norme che da essi si ricavano. Ancora una volta incidono nella direzione
indicata e il contenuto delle prescrizioni in oggetto e la struttura stessa di queste. Sia per la loro formulazione
largamente onnicomprensiva, sia per la loro afferenza a profili costitutivi e fondamentali esse si prestano ad
essere utilizzate come strutture portanti di un discorso argomentativo volto a conformare ad esse la legislazione
ordinaria e l’attività esecutiva, anziché viceversa. È certamente innegabile che a conferire speciale autorità e
rilevanza, anche in sede ermeneutica, alle norme della costituzione abbia pesato non poco il fatto che erano
considerate, specialmente nella seconda metà del secolo xviii, un’emanazione o proiezione del diritto
naturale(45). E però è anche vero che questa autorità si è progressivamente — per così dire — laicizzata. Ciò ha
dato luogo a quel fenomeno di dissociazione fra teoria politica e teoria costituzionale, da cui è partito il
ragionamento di Sartori, sul quale ci siamo soffermati in apertura di questa voce. Ma, essendo questa una
vicenda di non breve periodo, nel frattempo l’autorità della costituzione si è mantenuta e conservata anche in
ragione (se non principalmente a motivo) dei fattori cui si è fatto dianzi riferimento. Se è indubbio che — come
insegnava una non recente dottrina, peraltro molto attenta alle indicazioni desumibili dalla storia — «a cagione
dell’elemento politico, il diritto costituzionale muta... rapidamente» (46), è anche patrimonio
dell’insegnamento storico del diritto costituzionale che in questo campo si deve accordare speciale
considerazione «allo spirito delle leggi medesime, ai fini che il legislatore si propose» (47). E l’intento dei padri
costituenti era un tempo, più ancora che oggi(48), quello di dare stabilità, ordine e continuità al sistema
costituzionale: è quanto intendeva dire John Marshall, allorché, forte dell’esperienza derivantegli dal contributo
43
dato alla formazione della costituzione americana, espresse il nucleo forte della sua dottrina affermando: «it is a
constitution we are expounding» (49). E, del resto, come già abbiamo avuto occasione di ricordare, ben faceva
parte della tradizione del pensiero giuridico anglosassone l’idea che la legge fondamentale, anche se
insuscettibile di essere utilizzata per dedurne l’incostituzionalità delle leggi con essa contrastanti, doveva
comunque essere utilizzata per trarre da queste ultime una interpretazione ad essa conforme, e secondo i suoi
principi orientata. È noto, infatti, che, a stare con una interpretazione autorevolmente sostenuta del Dr.
Bonham’s Case, in esso Coke si sarebbe limitato a sostenere che i giudici debbano interpretare le leggi «in such
a way as not to conflict with those same accepted principles of reason and justice which... were presumed to
underlie all law» (50).
3. (Segue). L’ordinamento complessivo della materia costituzionale. Le costituzioni flessibili.
Le pagine che precedono possono dare l’impressione di enfatizzare fuori misura l’importanza della
distinzione tradizionale fra carte costituzionali scritte e costituzioni non scritte, esaltando quindi la svolta storica
rappresentata dal costituzionalismo del ‘700, e attardandosi su una linea ricostruttiva apparentemente destinata
all’obsolescenza, a causa del maggiore rilievo oggi attribuito alla prospettiva ermeneutica che muove dalla
distinzione fra costituzioni flessibili e costituzioni rigide.
In effetti, a chi scrive pare di scarsa utilità il tentativo che talvolta viene fatto di recuperare antecedenti
delle costituzioni scritte settecentesche, ora giuocando su assonanze linguistiche che consentirebbero di
guardare all’indietro sino ai tempi di Roma antica(51), se non alla Grecia(52), ora insistendo molto
sull’importanza delle carte medioevali e sulle loro idoneità a configurarsi come modelli delle carte americane o
francesi(53). A parte l’Instrument of Government del 1653, giustamente definito «un esempio ante litteram di
carta costituzionale nel senso moderno» (54), non si può certo dire che, ad esempio, le constitutiones imperiali
romane si propongano (anche a non volerle considerare come il frutto dell’esercizio arbitrario della nuda
volontà dell’imperatore (55) di dare stabile e continuativo assetto all’ordinamento complessivo del potere
nell’Impero(56); ovvero che la Magna Charta e altre ad essa similari rappresentino qualche cosa di più di un
patto giurato fra re e vassalli (e sudditi (57) destinato più ad avere rilevanza nei loro rapporti intersubiettivi che
ad assumere una funzione ordinamentale conformativa della comunità politica nel suo complesso(58). Resta,
pertanto, utile discriminare fra avvento delle costituzioni scritte e precedenti esperienze storiche, ravvisando
nelle prime i modelli di costituzioni nel senso moderno a noi noto. Solo allora prende piede e si concreta
l’idea di ridurre in un unico documento formalmente adottato l’ordinamento dei pubblici poteri: «tel est la vrai
sens du mot constitution», disse l’abate Sieyès all’Assemblea Nazionale, «il est relatif à l’ensemble et à la
séparation del pouvoirs publics» (59).
E però non ha senso annettere a questo evento un significato esclusivamente politico, quasi che il rilievo
giuridico delle costituzioni scritte si risolva tutto nell’appartenenza di queste alla categoria delle costituzioni
rigide, e la riflessione giuridica su di esse si riduca alla presa di coscienza della distinzione delle costituzioni
rigide, appunto, e delle costituzioni flessibili. Ciò può valere per chi, come Bryce(60), tende seppure
insensibilmente ad identificare le costituzioni flessibili con le «so called ‘unwritten’» costituzioni. In fin dei conti
considerare quella distinzione come il punto di partenza della riflessione sulle costituzioni scritte significa
mettere in dubbio la rilevanza giuridica delle costituzioni flessibili e, in particolare, di quelle fra le costituzioni
scritte apparse nella piena maturità dell’esperienza costituzionalistica che rientrano in tale categoria(61).
Quando si è scritto che «l’assimilazione assoluta della legge costituzionale alla legge ordinaria condusse a
rinnegare quasi nello Stato l’elemento politico, esagerando l’elemento giuridico» (62), si è indubbiamente colto
un aspetto importante, ma si è trascurato il fatto che quella assimilazione conduceva a sottovalutare anche
profili giuridici esclusivamente propri delle costituzioni scritte, indipendentemente dalla loro appartenenza alla
categoria delle costituzioni flessibili o di quelle rigide. È certamente vero che la peculiare posizione di
supremazia che caratterizza le carte connotate da rigidità ha consentito gli sviluppi caratteristici del judicial
review, da un lato, ed è strettamente connessa alle teorizzazioni in tema di potere costituente, dall’altro lato.
Tuttavia non si può negare che quella supremazia è in rapporto di diretta dipendenza con l’essere le
costituzioni scritte appunto dedicate ad un’ordinamento complessivo degli elementi basilari dell’assetto del
potere e dei rapporti di questo con la collettività.
Agli albori del ricorso alla stesura scritta delle costituzioni troviamo anche — come si è detto — la
consapevolezza della utilità, anzi della necessità di includere in un unico atto quella che veniva individuata
come la normazione fondamentale dello Stato. Il che quasi automaticamente consentiva di annettere alle
costituzioni scritte una importanza prioritaria, collocandole al vertice di una gerarchia sostanziale delle fonti e
facendole, quindi, suscettibili di una utilizzazione tutta particolare in sede ermeneutica e di argomentazione
44
giuridica. Sembra, cioè, che — contrariamente a quanto è stato rilevato da Luigi Rossi (63) — il dato della
materia costituzionale, l’elemento del contenuto delle costituzioni abbia assunto una importanza particolare già
a monte del radicarsi della distinzione fra costituzioni flessibili e costituzioni rigide, distinzione che appunto
Rossi vede giustificata non solo da elementi meramente formali, ma anche dal carattere intrinseco e materiale
della categoria delle leggi costituzionali «dotata di speciali caratteristiche... anche sostanziali, diverse dalle
comuni».
Solo in un secondo momento questa visione confidente nella prevalenza materiale della costituzione
viene meno, e con essa viene meno la tranquilla certezza che una fonte siffatta (indipendentemente dagli
strumenti della rigidità e dalle connesse teorizzazioni sul judicial review e sul potere costituente) potesse di per
sé assicurare ordine, stabilità e continuità ai rapporti costituzionali. È questa una vicenda che con riguardo alla
dottrina italiana è stata di recente partitamente analizzata (64) con l’occhio anzitutto rivolto al recupero che essa
avrebbe consentito delle dottrine della costituzione in senso materiale o sostanziale e dei suoi precedenti
istituzionistici. È questo un discorso che troverà sede più avanti nello svolgimento di questa voce.
Per intanto giova qui rilevare che la svolta rappresenta la eclissi dell’idea che la riconduzione dell’intera
materia costituzionale in un unico atto fonte, formalmente caratterizzato solo in funzione dell’unicità che gli
deriva dalla speciale sua intitolazione, sia di per sé sufficiente ad assicurare «tenuta» all’ordinamento del potere.
Ciò spiega come, ad esempio, proprio nella dottrina italiana quell’eclissi conduca ad una divaricazione di
posizioni. Da una parte, Racioppi e Brunelli arrivano ad insistere per un irrigidimento della costituzione sulla
base della considerazione che «una costituzione o è rigida, o non è» (65). Dall’altra parte Orlando segue un
ragionamento più articolato; contesta addirittura la suscettibilità della materia costituzionale a trovare piena e
completa sistemazione in una carta costituzionale che perciò mancherà, di necessità, di giuridica precisione, né
potrà offrire criteri obiettivi di giudizio; ammette quindi la possibilità di un concorso di fonti nella materia
medesima e non ne trova ragione di scandalo; si affida, infatti, in qualche modo, ancora, all’idea che anche la
legge ordinaria sia idonea a conformarsi alla natura delle cose e, comunque, confida che il giuoco dei pesi e
contrappesi politici sia atto a garantire il sistema dall’adozione di leggi inique o ingiuste(66).
Da quanto precede si ricava agevolmente la considerazione che fecalizzata sull’esperienza assorbente
dello Statuto albertino la dottrina costituzionalistica italiana a cavallo fra l’800 e il ‘900 ha finito per attestarsi su
una nozione per così dire laica della costituzione scritta, non mitizzandone ruolo e posizione, se si eccettua una
isolata opinione orientata a considerarla irretrattabile da parte del sovrano, anche se emendabile con legge
ordinaria(67). D’altra parte, salvo questa sola eccezione, non può neanche dirsi che abbiano avuto una qualche
rilevanza nel nostro ambiente le ricostruzioni contrattualistiche della costituzione. L’idea che aveva preso largo
piede, anche per evidenti ascendenze culturali, nel dibattito che condusse alla costituzione americana(68), «a
perdu tout crédit depuis la Révolution» francese(69), trovando la sua esplicita reiezione sul piano concettuale e
teorico nella critica di Carré de Malberg, volta — da un lato — a dimostrare l’inutilizzabilità della figura del
contratto là dove «volontés parallèles ont un contenu identique(70), e — dall’altro lato — a contestare la
possibilità di far «intervenir le facteur juridique contrat à un moment, où la société est à fonder et où par
conséquent il ne saurait encore exister ni droit social, ni davantage contrat ayant une valeur juridique
quelconque» (71).
La costituzione — diceva Compagnoni — è il «primo atto della volontà generale» (72). Con linguaggio
meno ideologicamente impegnativo possiamo dire che è un atto fonte, frutto della volontaria e consapevole
decisione di dare disciplina conformativa unitaria ai rapporti costituzionali. Ha quindi un contenuto tipico, e
comporta il ripudio di affidare l’instaurazione e lo sviluppo dell’ordinamento costituzionale ad una congerie di
fonti-atto, ovvero di consuetudini e convenzioni.
Il discorso sui contenuti rinvia al concetto di materia costituzionale. Quello che oggi è anzitutto un
problema di diritto positivo, da analizzare — come vedremo — in rapporto ai singoli ordinamenti vigenti, è stato
nei tempi passati l’altra faccia del discorso sulla funzione della Costituzione. In seguito si potrà affermare che
«nessuna caratteristica obiettiva giustifica giuridicamente l’esistenza di un’ipotetica categoria di leggi
costituzionali» (73). Ma ai primordi era necessario e importante discriminare ciò che apparteneva alla maniera
di governare e, quindi, alla forma di governo, cui si voleva dare un ordine fisso e stabilito, assicurandone
determinatezza e costanza(74). Era un’operazione irrinunciabile, se si voleva che quella che era destinata ad
essere «the first and fundamental law of the State» potesse efficacemente prescrivere «the limits of all delegated
powers» (75). Questo aspetto del nostro problema è stato di recente avvertito da alcuni dei partecipanti al
dibattito cui ha dato vita il già ricordato contributo di Sartori. Non si è potuto fare a meno di rilevare che gli
strumenti usati per porre limiti agli arbitri del potere differiscono da paese a paese, come differiscono le idee
che di questi limiti si hanno(76). E si è, però, anche aggiunto che non vi è soltanto questione di limiti, ma
anche di assetto del governo: «the telos of a constitution is to get government business done, or to see that
45
affairs of state are handled in an orderly manner» (77). Il che rinviava di necessità — in un contesto
anglosassone — al tema dell’articolarsi del rapporto fra gubernaculum e jurisdictio, così come sviluppato da Mc
Ilwain(78). Si potrà dire che si tratta di rilievi di buon senso, scontati quasi nella loro ovvietà. Vi è, tuttavia,
anche qualche cosa di più, nella misura in cui la preoccupazione per una ordinata e fattiva attività di governo
veniva a coinvolgere il tema dei limiti, sottolineando la esigenza di procedure decisionali in cui giorno per
giorno restassero inverati i valori cui le carte costituzionali erano improntate. Il governo doveva funzionare, ma
il suo funzionamento doveva rispettare i canoni di costituzionalismo. In fin dei conti, la garanzia non era solo
affidata alla jurisdictio, ma anche ai pesi e contrappesi in cui si articolava il gubernaculum(79).
4. Costituzioni flessibili e costituzioni rigide: loro succedersi nel tempo.
«Quando le prime carte furono emanate, era opinione comune che la solennità delle forme di cui si
rivestivano e la consacrazione in un documento scritto dei principi che contenevano dovessero servire ad
accrescere la loro stabilità»: così Santi Romano, nel discorso inaugurale sulle prime carte costituzionali(80),
chiaramente enunciava il nucleo centrale della dottrina delle costituzioni scritte. Di recente è stato addirittura
fatto notare che in Marbury v. Madison Chief Justice Marshall avrebbe dato particolare peso all’esistenza di
una costituzione scritta, alla «writteness of the constitution» ai fini della teorizzazione del judicial review, là dove
viene indicato come un possibile tradimento dei principi sottesi all’adozione di una costituzione scritta il rifiuto
di far prevalere quest’ultima su ogni ordinario atto del Parlamento con essa contrastante(81).
Ma la costituzione americana appartiene al novero delle costituzioni rigide, ha quindi una sua particolare
stabilità, di cui il judicial review può essere visto come una conseguenza, e però anche — forse più
correttamente — come una garanzia(82). La sottolineatura di questa peculiare caratteristica e la sua
teorizzazione è fatta abitualmente risalire a Bryce(83): contrapponendo costituzioni flessibili a costituzioni
rigide, egli muoveva dalla constatazione che queste ultime traggono origine «from a source different from that
whence spring the other laws», si collocano in una posizione di supremazia o sovraordinazione e possono
essere assoggettate a revisione non già ad opera dell’organo di legislazione ordinaria ma da quella stessa «higher
or specially empowered person or body» da cui promanano(84). La ricostruzione è a ben vedere solo in parte
condivisibile e sembra, in particolare, risentire della dottrina del potere costituente. Vi è molta enfasi sulla
necessità di una coincidenza fra l’autorità che ha adottato la costituzione e quella a cui è dato il potere di
modificarla o rivederla. Più elastica è la definizione fornita al riguardo da Dicey, formulata — com’è — in
termini negativi e tali, comunque, da superare quella coincidenza. «A ‘rigid’ constitution is one under which
certain laws generally known as constitutional or fundamental laws cannot be changed in the some manner as
ordinary laws» (85): non vi è palesemente preoccupazione sulla perpetuazione nel tempo del potere
costituente, la rigidità della carta costituzionale discendendo non già dalla sua assoggettabilità al potere di
revisione dell’autorità costituente ma dalla inapplicabilità delle procedure di legislazione ordinaria alle
modifiche o revisioni della carta medesima. Il potere di revisione può anche spettare all’organo che ha la
potestà di legislazione ordinaria, questa circostanza non esclude che si possa parlare di rigidità della
costituzione, purchè per la revisione siano seguite procedure diverse e normalmente aggravate rispetto a quelle
richieste per la adozione delle leggi ordinarie. La differenza fra le due definizioni è notevole. Se ci teniamo a
quella fornita da Bryce, ad esempio, la vigente costituzione italiana non rientra necessariamente nella categoria
delle costituzioni rigide, mentre vi appartiene senza ombra di dubbio se muoviamo dall’opinione di Dicey.
Questa pare, dunque, meno storicamente datata e perciò più attenta agli sviluppi del costituzionalismo a noi
più vicini.
Giova a questo punto rimuovere l’impressione, che talora si trae dalla lettura dei manuali, che la storia
del costituzionalismo comporti una sorta di evoluzione rettilinea, per cui si passerebbe dalle meno raffinate e
più elementari costituzioni flessibili alle tecnicamente più agguerrite e perciò operativamente più efficienti
costituzioni rigide. Anzitutto è bene osservare che questa opinione contrasta con l’altra e consolidata credenza
che l’idea di costituzione rigida è connaturata agli ordinamenti federali, poiché in questi ultimi sia gli organi
legislativi della intera federazione che quelli degli Stati membri sono limitati nei loro poteri e indipendenti gli
uni dagli altri(86). Il che implicherebbe che l’idea di costituzione rigida si è perpetuata, senza variazioni di
fortuna, nel tempo dal momento dell’avvento dei primi stati federali, ovvero dalla prima adozione di
costituzioni scritte ad opera degli stessi(87). La circostanza non ha però molto significato se riguardata nella
prospettiva della prima metà del secolo xix. L’esempio svizzero ha indubbiamente pesato sul processo di
compattamento delle colonie americane, ma queste hanno avuto prima della Svizzera una costituzione scritta
in comune ed, a sua volta, l’esempio americano ha pesato sulla storia svizzera soltanto con l’adozione della
46
costituzione del 1848(88). E, del resto, il problema della writteness della costituzione americana si è posto —
come abbiamo visto — in termini che trascendevano la definizione dei rapporti fra centro e periferia.
Non bisogna poi dimenticare che le costituzioni rigide sono state esse stesse oggetto di perplessità e
diffidenza. Secondo Romano col tempo «il principio delle costituzioni rigide si è andato mano a mano, e nella
teoria e nella pratica, attenuando e talvolta, come in Italia, è quasi svanito» (89). L’affermazione è forse troppo
azzardata, specie ad una visione retrospettiva. È tuttavia vero che, mentre le prime costituzioni scritte «erano
state tutte quante rigide», successivamente se ne ebbero numerose di flessibili. Contrapponendo le costituzioni
degli stati nordamericani dopo il 1776, quella federale degli Stati Uniti del 1787 e quelle francesi del 1791, del
1793 e del 1795 alle costituzioni francesi del 1799, del 1814 e del 1830 e allo Statuto Albertino, ce lo ricorda
l’indagine compararistica sempre accurata di Biscaretti di Ruffia(90), il quale tuttavia addebita la novità a «solo
ragioni contingenti». Ma minimizzare uno svolgimento storico di questa portata significa, come al solito,
lasciare inappagato chi vuol comprendere a fondo lo sviluppo delle istituzioni e non è disposto a lasciare al
caso il merito di esso. In fin dei conti, Bryce, al contrario di Romano, aveva visto bene allorché aveva rilevato
che nel mondo moderno le costituzioni flessibili stavano divenendo rare(91). Vi debbono, dunque, essere state
delle ragioni serie, che hanno reso più difficile questo avvento. E vi è da chiedersi se per avventura non abbia
avuto per altro verso ragione Romano quando rilevava che il principio delle costituzioni rigide, «così com’era
posto a base delle prime carte, riusciva ad uno scopo diametralmente opposto a quello cui mirava» (92).
Benché attestata sulla linea delle teorizzazioni del potere costituente e favorevole alla rigidità delle
costituzioni, la Rivoluzione francese non ha mai messo in discussione le prospettive di una revisione, facendo
espressamente cenno nella costituzione del 1791 al «diritto di riformare gli articoli, i cui inconvenienti
l’esperienza avrebbe fatto sentire» (art. 1, titolo VII)(93), ovvero espressamente riconoscendo nell’art. 28 della
costituzione del 1793 che «un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria
costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future» (art. 28).
Dalla considerazione dell’esperienza francese si è però anche tratta l’impressione (da cui il giudizio di
Romano testè riportato) che «the rigidity, in short, of a constitution tends to check gradual innovation; but, just
because it impedes change, may, under unfavourable circumstances, occasion or provoke revolution» (94). La
preoccupazione che in definitiva la sede della funzione costituente potesse risultare spostata «dallo stato
organizzato nella massa inorganica, mobile e scomposta degli individui» (95), poteva dunque ingenerare
diffidenza nei confronti dell’artifizio della rigidità. E poteva anche suggerire di abbandonare sostanzialmente la
strada prescelta, recependo l’insegnamento inglese della piena sovranità del Parlamento, e quindi a questo
consentendo di rivedere e modificare la costituzione. Tale era, ad esempio, l’opinione dominante durante la
vigenza della carta francese del 1830, quando si ammetteva (come sotto la Restaurazione) che la costituzione
poteva essere modificata, almeno parzialmente, con l’accordo del re e delle due camere(96). Né è da escludere
che sul formarsi di un orientamento siffatto abbia anche pesato il fatto rilevato da Burdeau, che nel caso di
specie la costituzione era il risultato dell’appropriazione del potere costituente da parte di un organo legislativo
già costituito, la Camera dei Deputati(97).
La ricostruzione è confermata dalla teorizzazione di Constant, il quale inclinava a distinguere nel
contenuto delle carte costituzionali un nucleo forte da una parte debole. Questa comprendeva tutte le materie
occasionalmente prese ad oggetto dalla costituzione e non facenti, quindi, parte del suo contenuto necessario:
senza preoccupazioni la revisione delle norme relative poteva essere rilasciata all’accordo del re e delle due
Camere. A diversa conclusione si doveva, invece, pervenire per quella che si poteva definire la materia
costituzionale in senso stretto, da Constant individuata nella somma delle attribuzioni rispettive dei poteri e nei
diritti fondamentali dei cittadini: qui entrava in giuoco il principio di ragione, da cui le scelte relative si
dovevano far dipendere, sicché — quando necessaria — l’opera dell’artefice costituzionale al riguardo andava
protetta anche contro la coalizione di tutti i poteri dello stato, tramite il meccanismo della rigidità (98).
Vi è stato, dunque, un elemento di strumentalità nell’accantonamento della rigidità, ad essa si è ritenuto
di potere rinunciare quando ragioni di convenienza e opportunità venivano a prevalere sulle esigenze di
garanzia e la revisione della disciplina di materie formalmente inserite nella costituzione poteva senza danno,
ed anzi con vantaggio essere rilasciata al legislatore ordinario. D’altro canto, Constant si collocava su una
posizione mediana, nella misura in cui non spingeva l’accantonamento della rigidità alle sue ultime
conseguenze e per una parte si manteneva fedele al principio della incompetenza del legislatore ordinario. Il
quale principio trovava, invece, pieno accoglimento nel pensiero di chi, come Tocqueville, considerava non
casuale l’assenza di una qualsiasi normazione sulla revisione costituzionale nella costituzione del 1830,
addebitandola al carattere pattizio della stessa che ne avrebbe comportato l’immodificabilità (99).
Già con la costituzione rigida del 1848 la Francia ritorna al vecchio orientamento (cfr. l’art. 111 della
stessa), cui del resto aveva ancor prima aderito il Belgio con la costituzione del 1831. Si comprende, così,
47
perché successivamente la dottrina (100) indicherà come peculiare, avvicinandola all’esperienza inglese, la
scelta fatta a favore della elasticità sia dalla costituzione prussiana del 1850 sia dal nostro Statuto albertino, in
questo discostatosi dal modello belga che gli viene spesso attribuito(101).
L’orientamento a favore della rigidità prevalse, infine, ancora in Francia nel 1875. L’insieme delle leggi
costituzionali di quell’anno offre, anzi, un peculiare esempio di connessione fra costitutizione rigida e
compromesso politico: «l’oeuvre de monarchistes résignés acceptée avec tristesse par les républicains» (102) si
concreta in un complesso di documenti brevi e non dogmatici, la cui fortuna ben si può spiegare con
l’osservazione di Georges Burdeau: «a quoi bon réviser un texte si accomodant?». Tale impianto lascia
ovviamente comprendere che nell’occasione molti problemi non furono completamente definiti, né si
prefigurarono delle indicazioni per i problemi che il futuro avrebbe portato all’attenzione delle istituzioni
governanti: a detta di Esmein ciò condusse ad uno sviluppo del diritto costituzionale francese a cavallo dei due
secoli affidato anzitutto all’interpretazione, il che consentirebbe di assimilare quella esperienza a quella più
longeva della costituzione degli Stati Uniti d’America(103).
Questa evoluzione è comunque interessante in quanto ci lascia intravvedere un modo di gestione di
compromessi politici costituzionali nuovo e diverso rispetto a quello che si ebbe a riscontrare con le
costituzioni ottriate(104). Sia per la costituzione francese del 1814 sia per il nostro Statuto albertino la via
prescelta fu quella della carta flessibile emendabile dal legislatore ordinario nel concorso del Re e delle due
camere, con esclusione, quindi, dell’ammissibilità di una revisione ad opera del solo Re ottriante(105). Si era
finito, in sostanza, per aderire al dogma inglese dell’onnipotenza parlamentare, il che, però, ha comportato,
alla resa dei conti, la prevalenza del Parlamento sul monarca con conseguente alterazione dell’equilibrio
sottostante all’originaria concessione regia(106).
5. Le moderne costituzioni di compromesso: rigidità formale e problemi interpretativi.
Contrariamente agli esempi ottocenteschi, caratterizzati dalla brevità delle costituzioni e, quindi, dalla
tendenziale limitazione della loro normativa alla disciplina degli apparati di governo e dei loro rapporti e alla
proclamazione e garanzia dei diritti politici e delle essenziali libertà civili(107), le costituzioni di compromesso
di questo secolo sono, oltre che rigide, lunghe(108). Se si guarda a quello che è indicato come il primo e più
appariscente esempio di tale tendenza, cioè alla costituzione di Weimar, balza subito agli occhi la correlazione
fra la espansione dei compiti dello Stato, la crescita della domanda sociale, l’allargamento del suffragio e la
proliferazione di disposizioni costituzionali riguardanti in particolare i rapporti sociali ed economici(109). Il
catalogo dei diritti viene molto ampliato, vi è una più pronunciata attenzione ai problemi del governo
dell’economia, in sostanza — dunque — vi è una attenzione particolare ai problemi dell’intervento pubblico,
che nelle costituzioni ottocentesche mancava per la stessa scelta ideologica di queste di rimettere al mercato e
agli spontanei equilibri di esso la composizione dei conflitti sociali e la tutela degli interessi economici e
sociali(110). È stato detto che tali novità hanno provocato una degradazione della formulazione tecnica delle
norme costituzionali, anche se giustamente è stato fatto notare che non sempre in questi casi è corretto
addossare le colpe delle difficoltà di «rendimento» delle costituzioni ai soli conditores(111). Del resto la
doglianza non è nuova, in quanto già Romano osservava che lo stato ancor fluido del diritto pubblico e
l’assenza di un «grado di maturità e di perfezione», quale quello riscontrabile nel campo del diritto privato,
rendevano più difficile e meno soddisfacente la formulazione scritta dei testi costituzionali(112). Il che può
risultare tanto più vero e credibile con riguardo alle norme delle costituzioni concernenti i rapporti economici
e sociali, per i quali spesso non esiste e ancor meno esisteva agli inizi o alla metà di questo secolo una
consolidata tradizione legislativa.
Ma il punto è più complesso di quanto si voglia far credere adducendo soltanto considerazioni di ordine
tecnico e difficoltà di lavoro redazionale. Le moderne costituzioni lunghe di compromesso differiscono da
quelle ottocentesche non solo per le loro dimensioni. Poichè in esse il compromesso non si realizza limitando
al massimo gli enunciati normativi e concentrando la loro portata regolativa sui tratti essenziali dell’assetto delle
istituzioni governanti, il componimento delle posizioni contrastanti viene conseguito allargando di molto il
complesso delle materie considerate ed evitando di dare agli enunciati normativi precisione e puntualità di
dettato. L’estensione degli oggetti disciplinati corrisponde all’esigenza di tenere conto di tutti (o quasi) gli
interessi emergenti, di fare un catalogo il più completo possibile delle domande sociali, laddove
l’indeterminatezza o latitudine degli enunciati soddisfa alla necessità di trovare formulazioni normative non
impegnative, capaci di riscuotere un largo arco di consensi in quanto espressive della necessità della tutela di
certi interessi, ma al tempo stesso inadatte a formalizzare di per sé una compiuta e definitiva soluzione del
sottostante conflitto economico e sociale.
48
Vi è un rapporto di mutuo condizionamento fra i modi degli enunciati delle moderne costituzioni di
compromesso e la loro scelta a favore della rigidità. La costituzione viene indubbiamente rafforzata
dall’«esistenza stessa di meccanismi atti a tutelare il contenuto storicamente dato» della stessa(113).
Ciò ha un particolare significato quando quel contenuto è il risultato di una mediazione fra concorrenti
forze politiche, ed è quindi naturale che si opti per l’irrigidimento della carta. Ma al tempo stesso l’accettazione
di questa opzione è il sintomo che la costituzione affida le sue sorti ad un più ampio consenso, ad uno
schieramento di forze più esteso della sola maggioranza delle forze politiche presenti ed operanti in un dato
ordinamento. Ed al conseguimento di questo più ampio consenso è certamente indirizzata la stessa
formulazione dei testi costituzionali, i cui principi, «non tutti aventi valore definitivo», sono appunto il risultato
dell’apporto di forze politiche diverse e contrapposte(114).
In effetti, quello che è oggi il più frequente fattore di irrigidimento, cioè l’introduzione del requisito di
maggioranze qualificate è da Kelsen indicato come una significativa approssimazione dell’idea di libertà nella
disciplina delle procedure di revisione costituzionale(115). Egli parte dal presupposto che «in origine sembrava
che fosse il principio della maggioranza assoluta a rispondere relativamente all’idea democratica», per suggerire
che il principio della maggioranza qualificata rappresenterebbe una certa tendenza all’unanimità nella
formazione della volontà generale» (116). Il riferimento alla volontà generale, così, meglio qualifica il
compromesso che si realizza nella deliberazione costituzionale, che è ancora vista — secondo un filone
tradizionale di pensiero — come una autolimitazione che nella procedura di un’assemblea parlamentare ritrova
il connotato ulteriore della razionalità (117). La mediazione è, dunque, una mediazione razionale, la
costituzione può perdere il suo significato mitico ma conserva ed esalta la sua qualità di atto consapevole di
conformazione degli assetti di una convivenza collettiva.
Seppure mediate da preoccupazioni politiche, quando non partitiche contingenti, e comunque espresse
in forma più diretta e operativa, considerazioni di questo tipo ritornano — ad esempio — nello stesso dibattito
dell’Assemblea costituente che ha dato all’Italia la costituzione repubblicana del 1948(118). Così le ritroviamo
nelle posizioni dei costituenti comunisti tesi a valorizzare il ruolo che la rigidità consentiva di pretendere per il
loro partito; nelle affermazioni di Basso che, la Costituzione essendo un autolimite della sovranità popolare,
deve essere in ogni caso tale da impedire il permanere di posizioni di privilegio; nel discorso di Moro che
sottolinea l’importanza del concorso di più partiti alla elaborazione di una formula di convivenza; nelle
preoccupazioni di Bozzi e Calamandrei che avrebbero voluto meglio approfondito il discorso sulla rigidità ai
fini di una più congrua definizione dei connotati giuridici delle norme in elaborazione.
Il problema del rapporto fra rigidità e formulazione degli enunciati costituzionali è stato ripreso anche in
dottrina, quando si è osservato che l’irrigidimento di formule normative equivoche ed elusive «equivarrebbe a
rendere difficile o addirittura impossibile quell’adattamento e quell’evoluzione (in vista del superamento del
carattere compromissivo e di una definitiva stabilizzazione) che esse — per loro natura — esigerebbero ed
implicherebbero» (119). Il rilievo si riconnette evidentemente alla meditazione di Schmitt sulle costituzioni di
compromesso, le cui disposizioni avrebbero talora una mera apparenza compromissoria nascondendo un reale
intento dilatorio, giacché le parti interessate converrebbero di aggiornare la decisione e di lasciarsi aperte le
interpretazioni e le possibilità più disparate(120). In realtà, tali riflessioni non colgono appieno il significato dei
fenomeni di cui andiamo discorrendo. Per quanto generiche possano sembrare le dichiarazioni costituzionali
compromissorie, esse non sono mai completamente vuote di significati. Anche quando si risolvono
sostanzialmente in una delegazione della decisione sul punto ad autorità ulteriori(121), esse contengono
tuttavia indicazioni di principio da valere quali direttive per tali autorità e, quindi, non sono completamente
prive di rilievo normativo. Enunciano e consacrano una determinata scelta di valore e sono, semmai, reticenti
quanto ai modi ed ai termini della sua implementazione, sia con riguardo al valore stesso di per sè, sia per
quanto ha tratto all’eventuale bilanciamento fra il valore così garantito e altri e diversi valori affermati e garantiti
nello stesso testo costituzionale. Ciò lascia intendere che non è ipotizzabile — per restare all’immagine della
delega — un deferimento delle decisioni ulteriori ad un’autorità non inclusiva di tutto l’arco delle forze
stipulanti il compromesso. Questo ha un senso se garantisce a tutte le parti una posizione eguale nel processo
decisionale di implementazione dei valori in compromesso.
La rigidità è funzionale a questo risultato, tutela i soggetti del compromesso all’atto della decisione
costituzionale e negli stadi ulteriori del suo articolarsi. Contrariamente a quanto pensava Schmitt, non siamo in
presenza di una non-decisione, ma di una decisione in cui profili sostanziali e profili formali sono fra loro
strettamente interrelati e bilanciati.
Giustamente, del resto, Mortati rileva in proposito che, ad esempio, il nostro costituente ha chiaramente
voluto escludere, con la richiesta di maggioranza qualificata e di una procedura aggravata per la revisione, la
possibilità «che la revisione sia espressione di volontà contingenti, di prevalenza (di una certa forza sulle altre)
49
puramente momentanea» (122). L’irrigidimento del compromesso vuole la sua perpetuazione, e certamente
non sarebbe più un compromesso quello che rilasciasse all’una o all’altra parte gli strumenti per imporre la
propria volontà al di fuori di qualsiasi mediazione e bilanciamento. Né bisogna dimenticare che le moderne
costituzioni di compromesso sono al tempo stesso costituzioni lunghe, le quali, pertanto, consacrano un’intesa
su un vasto raggio di questioni controverse, coinvolgendo valori molteplici, la cui attuazione è — come si diceva
— inestricabilmente collegata.
Superate le difficoltà derivanti dall’irrigidimento del processo di revisione, restano comunque da
affrontare i problemi che si pongono sul fronte della applicazione in sede giurisdizionale degli anfibologici e
sfuggenti enunciati delle moderne costituzioni di compromesso. Se tali enunciati vanno considerati come una
sorta di delega all’interprete o all’autorità preposta alla loro attuazione, vi è sempre il rischio che gli organi
giurisdizionali se ne avvalgano per sovvertire in sostanza il significato delle disposizioni di cui andiamo
discorrendo. Né vale obiettare che in realtà un risultato siffatto è dato per scontato, se non propriamente
voluto dai padri costituenti. È difficile credere che, avendo scelto la via di un irrigidimento costituzionale,
questi abbiano poi inteso rimettere la concretizzazione del compromesso e i suoi ulteriori sviluppi ad autorità
non elettive, istituzionalmente estranee alle parti stipulanti il compromesso medesimo. Vero è che questi
enunciati sono vere e proprie norme, ma è anche vero che essi vanno utilizzati come tali nei limiti del
compromesso(123). L’attuazione delle disposizioni di principio delle moderne costituzioni di compromesso ad
opera dei giudici non può risolversi nella completa enunciazione di una conseguente disciplina attuativa. Può,
però, favorire un approccio in progress a quegli sviluppi del compromesso che, impossibili all’atto della
adozione della costituzione, possono essere richiesti dall’evoluzione dei tempi e delle cose(124). Così stando le
cose, si pone all’interprete una grave questione. Ci si può, cioè, chiedere come sia possibile vincolare questo
processo di progressiva specificazione dei significati dei precetti costituzionali, evitando che termini e significato
del compromesso originario siano traditi e surrettiziamente modificati. Ed è appunto in vista di questo risultato
che si è fatto ricorso alla teoria della costituzione materiale.
Sezione II
LA COSTITUZIONE ITALIANA
Storia, caratteri e princìpi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana
Prima di leggere la voce redatta da V. Onida, è opportuno introdurre l’argomento.
La Costituzione italiana fu approvata dall’Assemblea
Assemblea costituente il 22 dicembre 1947, per poi
entrare in vigore il successivo 1° gennaio 1948.
A sua volta, l’Assemblea costituente fu istituita a seguito delle elezioni svolte il 2 giugno 1946
contestualmente al referendum su repubblica o monarchia.
In Assemblea costituente arrivarono esponenti dei partiti politici che avevano combattuto il
fascismo: la democrazia cristiana, il partito comunista, il partito socialista, e altre formazioni minori
solo per consistenza numerica e non per importanza, a cominciare dal partito d’azione di Piero
Calamandrei.
L’Assemblea fu creata al fine di redigere la nuova costituzione, che avrebbe preso il posto del
debole e vulnerabile Statuto albertino. Il testo fu votato da una ampia maggioranza (453 voti a favore,
62 contrari), e ciò dimostra quanto la Costituzione sia il frutto di un compromesso equilibrato tra
diverse concezioni ideologiche.
Il nostro ordinamento riposa su solidi princìpi fondamentali:
fondamentali alcuni espressamente enunciati
dalla Costituzione, altri desumibili dal sistema attraverso la lettura combinata di più disposizioni.
Principio repubblicano.
repubblicano In armonia con il voto popolare del 2 giugno 1946, l’Italia è una
Repubblica. È stato prescelto un assetto istituzionale che vede nella investitura popolare e nella
50
temporaneità delle cariche i pilastri fondamentali. Peraltro, l’art. 139 espressamente prevede che la
forma repubblicana non è soggetta a revisione costituzionale.
Principio della sovranità popolare.
popolare Come recita il secondo comma dell’art. 1 Cost., «la sovranità
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». La sovranità è la
matrice, la base, l’origine, la fonte dei tre poteri dello Stato. Con il passaggio dal re al popolo si
consacra quest’ultimo come la fonte di legittimazione di tutti i poteri assegnati alle istituzioni.
Legittimazione significa che i singoli si riconoscono nell’ordinamento e ne rispettano le norme, dal
momento che esse promanano dalla sovranità popolare. Questa, però, non è illimitata e assoluta: si
svolge, infatti, con le modalità e nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti dalla Costituzione. In
questo modo, si impedisce un suo uso demagogico e strumentale.
Principio democratico.
democratico L’Italia è una repubblica democratica in quanto il potere legislativo e
quello esecutivo poggiano su fondamenta popolari. Il parlamento è composto da rappresentanti del
popolo scelti tramite libere elezioni, che si svolgono ad intervalli prestabiliti, con voto espresso a
suffragio universale e diretto. Il governo deve godere della fiducia delle camere, mentre i suoi membri
sono nominati dal Presidente della Repubblica a sua volta eletto dal Parlamento in seduta comune. I
magistrati sono reclutati tramite concorso, ma sono comunque soggetti al rispetto della legge, dunque
alla osservanza delle norme giuridiche poste in essere dagli organi rappresentativi del popolo (→
democrazia rappresentativa). In alcuni casi previsti tassativamente dalla Costituzione, il popolo può
direttamente manifestare la volontà dello Stato: è il caso del referendum abrogativo (→ democrazia
diretta).
Principio di eguaglianza.
eguaglianza «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali» (art. 3, primo comma, Cost. → eguaglianza formale). «È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese» (art. 3, secondo comma, Cost. →
eguaglianza sostanziale).
Principio della separazione dei
dei poteri.
poteri Pur non essendo espresso in maniera testuale, anche la
separazione dei poteri caratterizza i rapporti tra gli organi dello Stato. La separazione non è rigida in
quanto la Costituzione configura forme di controllo reciproco (→ checks and balances) e talvolta
richiede o presuppone meccanismi di raccordo e di coordinamento (→ principio di leale
collaborazione).
Principio di legalità.
legalità È inteso sia come principio di legalità costituzionale, nel senso che tutti i
poteri sono vincolati al rispetto della Costituzione, sia come principio di legalità ordinaria, nel senso
che il potere esecutivo e il potere giudiziario sono soggetti al rispetto della legge. L’Italia si riconosce
nei princìpi dello Stato di diritto,
diritto il cui corollario fondamentale è l’indipendenza e autonomia
dell’ordine giudiziario rispetto al potere politico.
Principio pluralista.
pluralista Le differenze esistenti all’interno della società sono un patrimonio da
valorizzare, non un problema da risolvere. Tutte le diverse anime della società (in campo politico,
economico, culturale) hanno pari dignità e devono avere le stesse opportunità di realizzazione e di
rappresentazione nelle sedi istituzionali.
Principio personalista.
personalista La Repubblica riconosce e garantisce i diritti dell’uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali, affinché ogni soggetto possa liberamente e pienamente sviluppare
51
la propria personalità. La Costituzione, quindi, presidia la libertà di autorealizzazione e di
autodeterminazione delle persone.
Principio lavorista.
lavorista L’Italia è una Repubblica democratica «fondata sul lavoro» (art. 1, primo
comma, Cost.). Il lavoro è un diritto e, nel contempo, un dovere (art. 4). Il lavoro è la condizione
ideale dell’individuo quale soggetto che interagisce con gli altri consociati. La ricchezza si accumula
attraverso il lavoro.
Principio autonomista.
autonomista «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali» (art. 5 Cost.). Se lo Stato è sovrano (→ sovranità come potestà originaria), le Regioni e gli enti
locali, che al pari del primo formano, ai sensi dell’art. 114 Cost., la Repubblica, sono autonomi (→
autonomia come potestà derivata). L’autonomia politica è la capacità delle Regioni e degli enti locali
di soddisfare gli interessi delle comunità di cui essi sono enti esponenziali secondo un proprio
indirizzo politico, in ipotesi anche diverso da quello dello Stato. In questo modo, si possono avere
norme giuridiche differenziate, di territorio in territorio, quando lo richiedano le specifiche
caratteristiche delle comunità locali.
Principio di laicità.
laicità L’Italia è uno Stato laico, nel senso che non riconosce alcuna religione di
Stato. Non è dunque uno Stato confessionale, dal momento che tutte le confessioni religiose, pur
diverse, sono eguali davanti alla Costituzione. La Chiesa cattolica può solo vantare una struttura
specifica di relazioni con lo Stato, basata sui Patti lateranensi (cfr. gli artt. 7 e 8 Cost.).
V. ONIDA, voce Costituzione italiana, in Dig. IV ed., Disc. pubbl., vol. IV, Utet, Torino, 1989, pp.
321 ss.
1. Una Costituzione «longeva».
La Costituzione della Repubblica italiana fu approvata dall’assemblea costituente, col voto finale, nel
pomeriggio del 22-12-1947: votarono a favore, su 515 presenti e votanti, 453 deputati, contrari furono 62(1).
Non vi furono, prima del voto, dichiarazioni finali dei rappresentanti dei gruppi politici, né di singoli deputati,
ma solo un breve intervento dell’on. Ruini, presidente della «commissione dei settantacinque», che aveva
redatto il progetto, e del comitato di redazione che provvide fino all’ultimo al coordinamento del testo
definitivo, sottoposto poi al voto per scrutinio segreto. Ultima ad essere discussa, prima del voto finale, fu la
proposta avanzata la mattina dello stesso 22 dicembre dall’on. Giorgio La Pira, di far precedere il testo dalla
formula: «In nome di Dio il popolo italiano si dà la presente Costituzione». Dopo alcuni misurati interventi
degli on.li Palmiro Togliatti, Concetto Marchesi, Piero Calamandrei, Francesco Saverio Nitti, nonché del
Presidente Umberto Terracini (che ritenne la proposta preclusa dalla scelta già fatta dall’assemblea, di non
dare alla Costituzione alcun preambolo), lo stesso on. La Pira accolse infine l’invito a ritirare la proposta,
constatando che essa avrebbe provocato dissenso(2). La larghissima maggioranza con cui avvenne
l’approvazione, l’assenza di dichiarazioni di voto a nome dei partiti, lo stesso tono e il contenuto dell’ultimo
dibattito cui si è accennato, sottolineano emblematicamente lo spirito di convergenza e di unità nel quale ebbe
luogo, per lo più, l’elaborazione della Costituzione.
Questa fondamentale unità d’intenti è probabilmente alla base della «longevità» ormai dimostrata dalla
nostra Costituzione. Questa, che qualcuno alla costituente — da posizioni di minoranza — arrivò a definire (in
sede di discussione del progetto) una «Costituzione interlocutoria» (3), si è in realtà rivelato un testo, se non
«scolpito nel bronzo», come ironicamente si espresse un altro costituente(4), certo dotato di saldezza e stabilità,
così da entrare ormai nel novero delle Costituzioni scritte che sono in vigore da maggior tempo, conservando
sostanzialmente intatta la sua struttura e il suo contenuto, sottoposto a poche e abbastanza modeste
revisioni(5).
Vero è che, mentre fino alla fine degli anni settanta l’idea stessa di profonde revisioni della Costituzione
veniva avanzata solo nell’ambito di ristrette o ristrettissime fasce di opinione (tanto che si poteva perfino
parlare di una sorta di «tabù» della Costituzione), oggi viceversa la tesi del riformismo costituzionale è assai più
diffusa. Potrebbe dunque ritenersi che si stia per entrare in una fase di minore stabilità del testo costituzionale,
52
coincidente storicamente con il tramonto della generazione di uomini polici e di tecnici del diritto che
collaborarono più o meno direttamente all’opera costituente.
Tuttavia, paradossalmente, proprio questa caduta del «tabù» e questa diffusione dell’ipotesi riformista
sembrano invece indicare un definitivo consolidamento della Costituzione. Questa non appare ormai, solo il
prodotto più felice di una precisa congiuntura storica, legato ai caratteri e alle esigenze che di essa furono
propri; ma, conservando nel tempo, in condizioni tanto diverse, carattere di stabilità e insieme di elasticità,
essa, al pari delle altre Costituzioni storiche più longeve, manifesta la propria idoneità a sorreggere l’evoluzione
dell’ordinamento, assicurando insieme la saldezza dei riferimenti fondamentali e gli spazi per i mutamenti
necessari. Ciò che corrisponde al ruolo essenziale, di saldatura e integrazione fra passato e avvenire, affidato
dalla collettività alle regole giuridiche che ne organizzano la convivenza.
Per questo, oggi, un discorso generale sulla Costituzione italiana non deve più necessariamente essere
incentrato in prevalenza sulle sue origini e sulla dialettica attuazione-inattuazione, che ha caratterizzato i primi
decenni di vita del testo (come, ad esempio, accadeva nella voce corrispondente alla presente, pubblicata nella
precedente edizione del Digesto, scritta da Paolo Barile nel 1958, a soli dieci anni dalla promulgazione della
Costituzione); ma può volgersi a cercare di cogliere, nell’attuale fase di sviluppo dell’ordinamento, il senso
generale dei principi e delle norme contenute in quel testo.
2. La Costituzione italiana nella tradizione del costituzionalismo contemporaneo.
Ciò non significa, naturalmente, che si possa prescindere, nell’esame della Costituzione, dal profilo
storico attinente alla sua origine e alle sue vicende. Ogni Costituzione è il frutto di un determinato processo
costituente, e ne porta i segni, anche se le sue norme si rivelano spesso capaci di durare ben oltre l’esaurimento
della fase storica in cui quel processo si inseriva.
Le Costituzioni rappresentano per lo più il frutto di un travaglio, che epoche generalmente di grande
trasformazione consegnarono alla storia successiva; se durano, è perché le ragioni e i principi ispiratori di quel
travaglio si solidificano e divengono patrimonio relativamente stabile di una collettività.
Questo spiega l’esistenza di una vera e propria tradizione costituzionale, caratteristica di determinate
aree geopolitiche, e nelle quali si distilla, per così dire, la parte non caduca dell’evoluzione degli ordinamenti
politici.
Per quanto ci riguarda, non è difficile individuare, nella storia del costituzionalismo democratico
dell’Europa occidentale, le tappe fondamentali di questa tradizione, che troviamo riecheggiata nella
Costituzione repubblicana del 1948: i principi delle rivoluzioni liberali della fine del ‘700; le regole istituzionali
proprie delle monarchie parlamentari sorte fra la fine del ‘700 e la metà dell’800; i concetti e i principi dello
Stato democratico-sociale quali si formarono tra la metà dell’800 e l’inizio di questo secolo; le forme di
pluralismo sociale e istituzionale, di perfezionato garantismo, e di apertura verso il superamento dei limiti dello
Stato nazionale, maturate nell’Europa tra il primo e il secondo dopoguerra.
Questa è la tradizione in cui si inserisce a pieno titolo la Costituzione italiana del 1948, nel cui testo non
è difficile trovare riecheggiate talvolta in modo puntuale formulazioni di altri testi appartenenti alla medesima
tradizione. In particolare, la nostra può essere definita una Costituzione appartenente alla «famiglia» della
Costituzione degli Stati di tipo democratico-sociale, che a loro volta si innestano nel tronco della tradizione
costituzionale liberal-democratica, rinnovandola e integrandola.
Così troviamo nella Costituzione del 1948 la riaffermazione dei principi liberali circa i diritti inviolabili
dell’uomo (art. 2, comma 1, Cost.), le libertà civili (artt. 13-28 Cost.), l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla
legge (art. 3, comma 1, Cost.), la supremazia della legge nel sistema delle fonti (con le numerose «riserve di
legge» disposte da diverse norme della Costituzione), il principio rappresentativo con la conseguente
attribuzione al Parlamento di funzioni fondamentali di indirizzo politico (artt. 56, 57, 67, 70, 76, 77, 80, 81
Cost.), il principio di legalità dell’azione amministrativa (art. 97, Cost. art. 100, comma 2, Cost., art. 113 Cost.),
le classiche forme liberali di divisione e di coordinamento fra poteri (artt. 87-96 Cost.), e il principio di
indipendenza della magistratura (artt. 101, 104, 108 Cost.).
Troviamo, per altro verso, la consacrazione dei nuovi principi dello Stato sociale, con il riconoscimento
dei relativi diritti (art. 4 Cost., artt. 29-38 Cost.) e dell’uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.), nonché
dei compiti di giustizia sociale attribuiti ai poteri pubblici (artt. 41-47 Cost., art. 53 Cost.), nonché il
perfezionamento e l’estensione dei principi democratici (art. 1 Cost., artt. 48-51 Cost., art. 75 Cost.).
Troviamo infine le garanzie delle diverse forme del pluralismo sociale (artt. 2, 6, 7, 8, 39 e 40 Cost.),
l’estensione e il rafforzamento delle autonomie locali (art. 5 Cost., artt.114-133 Cost.) e i nuovi istituti di
garanzia della «rigidità» della Costituzione (artt. 134-138 Cost.).
53
3. L’ispirazione ideale della Costituzione.
L’ispirazione della Costituzione italiana trova le sue radici nelle posizioni ideali e politiche delle forze
che contribuirono alla sua elaborazione.
Il fatto che la nostra (a differenza di molte Costituzioni dell’era liberale) non sia una Costituzione
«ottriata», cioè concessa da un Sovrano, ma sia stata deliberata da un’assemblea costituente, e il tipo di
processo costituente da cui essa trasse origine, nel quale il ruolo di protagonisti fu assunto dai partiti presenti
nell’assemblea, fanno sì che sia particolarmente evidente il nesso fra i suoi contenuti e le idee e i programmi di
tali partiti, soprattutto delle tre maggiori forze politiche — la democrazia cristiana, il partito socialista e il partito
comunista — che da sole avevano oltre i tre quarti dei deputati nell’assemblea costituente(6).
Peraltro la «cultura costituzionale» dei partiti e dei loro esponenti alla costituente non era all’epoca
molto sviluppata. Si trattava per lo più di organizzazioni politiche con una storia recente alle spalle: a parte le
minoranze liberali e repubblicane, che si richiamavano a tradizioni risorgimentali, tutti i partiti erano di origine
recente o recentissima: il partito socialista risaliva alla fine dell’800, il comunista era nato nel 1921, il
democristiano si ricollegava all’esperienza del partito popolare dei primi anni venti, ma come tale era nato nel
1942-1943; nello stesso periodo erano nati il partito d’azione e la democrazia del lavoro, altre due componenti
del Comitato di liberazione nazionale in cui si riunirono quasi tutti i partiti antifascisti.
Inoltre la lunga parentesi fascista aveva troncato ogni libera esperienza di tipo istituzionale, quando non
ogni sviluppo delle stesse organizzazioni politiche; e i primi anni dopo la caduta del fascismo, caratterizzati
dalla provvisorietà, dalle esigenze della lotta armata, dalla precarietà della situazione economica e sociale, non
si prestavano certo ad una tranquilla elaborazione di temi costituzionali.
Così che i partiti nel periodo costituente riproposero le proprie fondamentali ispirazioni ideali, talvolta
formularono programmi specifici anche di ordine istituzionale, ma in ogni caso le scelte concrete si formarono
in base ai materiali culturali e istituzionali allora disponibili, dentro e fuori di essi: le riflessioni degli studiosi
presenti nei vari partiti, le ascendenze culturali e le esperienze politiche o professionali dei loro esponenti, ma
anche la cultura istituzionale propria di alcuni corpi professionali, come la magistratura o il Consiglio di
Stato(7).
Spesso si è visto nella Costituzione il frutto della confluenza o del «compromesso» fra tre grandi correnti
ideali e di pensiero: quella cattolico-democratica, quella di ispirazione marxista, quella liberal-democratica.
In effetti questa confluenza vi fu, attraverso strumenti e con modi diversi. Il filone cattolico-democratico
trovava diretta espressione nel partito di maggioranza relativa all’assemblea, la democrazia cristiana, in cui
quella tradizione ideale era culturalmente e politicamente egemone. La DC fu anche il partito che forse più di
ogni altro elaborò uno specifico programma costituzionale(8), una parte del quale trovò sbocco nella
Costituzione.
L’ispirazione personalista e l’attenzione per la tematica delle «comunità intermedie» (cfr., art. 2 Cost.);
l’idea di una comunità sovranazionale che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni (cfr., art. 11 Cost.);
l’esplicita considerazione delle confessioni religiose come organizzazioni sociali (art. 8 Cost.), e più
specificamente la riconferma dei patti lateranensi (art. 7 Cost.); l’attenzione per i diritti della famiglia (artt. 2930 Cost.) per la libertà scolastica (art. 33 Cost.) e assistenziale (art. 38 Cost.); il favore per le forme di attività
economiche in cui capitale e lavoro sono nelle stesse mani (cfr., artt. 44, 46, 47 Cost.), sono tutti aspetti per i
quali la Costituzione è palesemente debitrice di questa ispirazione. Parimenti, per quanto riguarda
l’organizzazione dei poteri, l’impronta pluralista e garantista, la scelta per il regime parlamentare e per il
primato del Parlamento, il regionalismo politico e legislativo, gli istituti di democrazia diretta, la garanzia
giurisdizionale della Costituzione, sono tutti aspetti in cui il testo della Carta riflette largamente postulati e
programmi del cattolicesimo democratico: rimasero invece fuori della Costituzione, fra i punti fondamentali di
tali programmi, la rappresentanza professionale e il sindacato di diritto pubblico.
Meno evidenti sono le tracce dell’ispirazione propria della sinistra marxista: sia perché i due partiti che
la rappresentavano — il socialista e il comunista — avevano un’elaborazione e una cultura istituzionale più
limitate e meno univoche; sia perché questi partiti non intesero rivendicare una Costituzione modellata sui loro
programmi, limitandosi a favorire e a reclamare un ordinamento in cui fossero garantiti i diritti di libertà e
potesse trovare libera espressione la sovranità popolare mediata dai partiti di massa, convinti com’essi erano
che questo fosse il contesto più favorevole per una eventuale successiva trasformazione del paese in senso
socialista(9).
Tuttavia sui temi, ben presenti nella Costituzione, dell’uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.),
del diritto al lavoro e dei diritti del lavoro (artt. 4 e 35 Cost., ss.), del governo pubblico dell’economia (artt. 41,
54
42, 43 Cost.), del ruolo dei partiti politici (art. 49 Cost.), non sono mancati apporti specifici riconducibili
all’ispirazione di queste correnti politiche. Sul piano dell’organizzazione statale, certamente, la Costituzione è
fondamentalmente ispirata più alla visione di un articolato pluralismo di poteri e di un insieme di reciproci
freni e di garanzie, che non a quella — propria della visione della sinistra marxista — di una democrazia
assembleare, in cui la sovranità popolare mediata dai partiti di massa si esprimesse per intero, senza troppi
frazionamenti del potere e senza troppe remore e vincoli. Tuttavia il peso di queste componenti (oltre che
concorrere in modo decisivo a far prevalere, nel referendum istituzionale, l’ipotesi repubblicana) influì
certamente, se non altro in negativo, nell’ostacolare soluzioni di ancor più accentuata ripartizione dei poteri
(così le sinistre non fecero prevalere il monocameralismo, ma ottennero un Parlamento fondato
esclusivamente sulla rappresentanza politica nazionale).
La terza grande corrente ideale, quella liberal-democratica, non era rappresentata in assemblea da
alcuno dei grandi partiti. Tuttavia essa fu tutt’altro che assente o recessiva: sia perché ad essa si rifacevano
componenti minoritarie ma partecipi, con esponenti di primissimo piano, del processo costituente (si pensi a
deputati come Einaudi, Perassi, Calamandrei); sia perché il bagaglio ideale liberal-democratico, che affondava
le sue origini nelle rivoluzioni borghesi della fine del ‘700, si ritrovava in misura e forme diverse nella
tradizione delle altre correnti: la cattolico-democratica, in cui soprattutto il filone cattolico-liberale aveva
largamente assimilato postulati tipici di quel bagaglio ideale; e anche la tradizione delle correnti marxiste, che
quei postulati in parte facevano propri, pure iscrivendoli e integrandoli in un altro contesto, e che accettavano il
quadro liberal-democratico come condizione favorevole per l’affermarsi delle spinte verso una trasformazione
socialista della società.
La cultura istituzionale dei costituenti aveva dunque radici profonde nel passato, non solo italiano: ma
guardava al futuro.
La classe politica che volle e che approvò la Costituzione fu (a parte la parentesi fascista) la prima classe
politica post-liberale nel nostro Paese. Ciò sia per ragioni anagrafiche, data l’interruzione imposta dal fascismo
all’evoluzione politico-costituzionale del paese; sia per ragioni politiche, data l’affermazione come forze
dominanti di partiti estranei all’esperienza liberale prefascista o eredi di correnti minoritarie nell’ambito di
questa.
Certo vi erano degli uomini che facevano da ponte, per così dire, fra le due ere: basti pensare agli ex
«popolari» della DC, o a liberali come Einaudi o De Nicola. Ma l’avvento di una nuova classe politica fu
evidente: è significativo che alcuni dei maggiori esponenti della classe politica liberale prefascista, pur presenti
in assemblea (come Orlando, Nitti, Croce), pure autorevoli e ascoltati, siano rimasti fondamentalmente
estranei "alle decisioni costituenti, e spesso si ritrovassero su posizioni critiche nei confronti delle scelte
dell’assemblea(10).
4. Caratteri del processo costituente: il «compromesso » costituzionale.
Proprio la tensione al superamento di un passato vicino e meno vicino e al rinnovamento delle
istituzioni e della società rappresentava uno dei fattori di quell’unità di intenti che, come si è notato all’inizio,
caratterizzò la nascita della nostra Costituzione.
Forze politiche e correnti ideali diverse e anche profondamente divise fra loro trovavano una ragione di
convergenza anzitutto nell’intento di superare definitivamente, con la nuova Costituzione, ciò che il fascismo
aveva rappresentato sul terreno istituzionale: la compressione delle libertà civili e politiche, l’abolizione del
pluralismo politico, il controllo autoritario del pluralismo sociale, il totalitarismo statale, la concentrazione del
potere in un unico vertice, l’autarchia e il bellicismo nei rapporti con gli altri Stati. Tutto ciò si esprimeva nella
volontà di dar vita ad una Costituzione «antifascista», non semplicemente «afascista» (11), emergente non solo
nelle norme speciali e derogatorie con cui si volle precludere qualsiasi reviviscenza dell’esperienza del
ventennio (XII disp. trans. fin.), ma nella cura con cui si vollero circondare di garanzie le libertà che il fascismo
aveva concellato, e si volle creare un ordinamento in grado di evitare ritorni di autoritarismo (fattore, questo,
non estraneo all’ispirazione fortemente garantista della carta).
Ma le maggiori forze costituenti erano anche unite dall’intento, sia pure generico, di dar vita ad un
ordinamento costituzionale che superasse i limiti dello Stato liberale prefascista, rispetto alla cui esperienza
esse si consideravano largamente estranee e in posizione di sia pur meno radicale antagonismo.
Le linee e le direzioni di questo superamento dello Stato liberale non erano certo le stesse per le varie
correnti, e non erano sempre chiaramente tracciate. Tuttavia nella Costituzione è ben visibile questa tensione
verso una nuova forma di Stato — lo Stato democratico-sociale — nel quale i principi dello Stato liberale
dovevano essere integrati e in parte corretti: si pensi ad esempio al tema delle «comunità intermedie», in
55
contrapposizione all’individualismo liberale fondato sul rapporto individuo-Stato nazionale (art. 2 Cost.), o alla
«Costituzione economica» in cui i diritti di proprietà e d’iniziativa individuale venivano bensì ribaditi ma in un
quadro di limiti e vincoli intesi a perseguire più equi rapporti sociali, e di interventi dei poteri pubblici diretti a
guidare lo sviluppo economico e la ripartizione delle risorse (artt. 41, 42, 43, 44, 53 Cost.).
A questa ispirazione unitaria «in negativo» — antifascismo, superamento dello Stato liberale — non
corrispondeva peraltro, come si è accennato, alcun programma comune in positivo. Di qui in poi, per così
dire, gli intenti e le vedute delle varie forze e correnti divergevano anzi nettamente, e la fase costituente
appariva perciò una premessa sulla cui base si sarebbe dovuta giocare poi una nuova decisiva partita per la
trasformazione della società, partita affidata al prevalere, nella competizione democratica, di una o dell’altra
delle forze.
Ciò fece sì che l’incontro e la convergenza delle grandi forze sui capisaldi della nuova Costituzione fosse
talvolta un incontro su obiettivi generici (espressi in formule come «fini sociali», «equi rapporti sociali», e simili:
cfr. artt. 41, 44 Cost.), piuttosto che su programmi d’azione specifici: il che contribuì ad imprimere alla carta
quel carattere «programmatico» del quale si dirà, e che da taluni è visto come negativo.
La presenza di spinte e di istanze differenti e contrapposte talvolta emerge nell’uso di formule «
antagoniste» o di segno diverso: si vedano ad es. il comma 1 e il 2 dell’art. 41 Cost. (libertà di iniziativa
economica e utilità sociale), il comma 1 e il 3 dell’art. 42 Cost. (proprietà privata e limiti alla stessa); o anche il
comma 1 e il 6 dell’art. 21 Cost. (libertà di manifestazione del pensiero e divieto delle manifestazioni contrarie
al buon costume).
Più in generale, già in assemblea costituente varie voci si levarono a indicare il carattere
«compromissorio» o addirittura «tripartito» della Costituzione(12). E sia nella storiografia sia nella polemica
politica successiva, specie negli anni di maggior vivacità di movimenti culturali e politici di impronta radicale, la
polemica contro il «compromesso» costituzionale venne spesso ripresa.
In realtà non è raro nella storia che i processi costituenti si sostanzino di «patti» o di «compromessi» fra
forze e interessi diversi (basti pensare ai patti fra «Re e popolo», cioè tra autorità regia e classe politica borghese
liberale, da qui nacquero molte Costituzioni ottocentesche).
Questo carattere di «patto» corrisponde del resto al ruolo proprio della Costituzione, di offrire una
cornice relativamente stabile per lo svolgersi di processi politici non predeterminati, e nei quali il confronto e
anche lo scontro fra diverse ipotesi e diversi obiettivi collettivi si possa svolgere senza trasformarsi in puro
confronto di forza, privo di regole e senza esclusione di colpi.
La Costituzione italiana nasce anch’essa da un patto consapevole stretto da forze diverse e anche
antagoniste fra loro. Non fu all’origine, e non è mai stata, una Costituzione «di maggioranza», in cui alcune
forze vincenti si riconoscessero pienamente e altre, perdenti, non potessero riconoscersi; ma piuttosto una
Costituzione «di tutti», alla quale le diverse forze, pur rimanendo antagoniste, potevano e possono appellarsi ad
egual titolo.
È stato tante volte osservato che il processo costituente, avviatosi in assemblea e nella «commissione dei
settantacinque» quando ancora erano al Governo i tre maggiori partiti, non si interruppe e non subì radicali
svolte nemmeno dopo che, nel maggio 1947, la collaborazione tripartita venne meno, e si formò il primo
Governo dell’era «centrista», con la democrazia cristiana e i suoi alleati laici, mentre i due grandi partiti della
sinistra marxista andarono all’opposizione.
È vero che quando ciò accade l’elaborazione del testo costituzionale nell’ambito della commissione era
ormai conclusa, si era concluso il dibattito generale in assemblea ed erano stati già approvati gli articoli dei
principi fondamentali e della prima parte della Costituzione(13). Tuttavia resta significativo che la fase di dura
contrapposizione politica apertasi allora, e riflessa anche nei dibattiti politici in assemblea costituente, non
abbia provocato meccanicamente (come pure avrebbe potuto accadere, e come non di rado accade nella prassi
dei partiti) una rottura della collaborazione ai fini del varo del testo costituzionale.
È assai probabile che conseguenze della nuova situazione, nel processo costituente, non siano mancate,
e si siano riflesse anche nelle modifiche che al testo del progetto vennero apportate dall’assemblea plenaria.
Resta però vero che, complessivamente, continuò un processo costituente che vedeva collaborare e trovare
punti di incontro forze ormai schierate su fronti opposti nell’esperienza parlamentare e di governo.
Del resto tutte le forze che diedero vita alla Costituzione erano storicamente, allora, forze di minoranza,
che pensavano o temevano di essere o di poter essere tali anche nel futuro, e perciò erano portate a
preoccuparsi di garantire, nel nuovo ordinamento, spazi e garanzie per le minoranze, oltre che, o prima che, la
possibilità per la maggioranza di far prevalere il proprio punto di vista.
Ciò spiega perché nell’esperienza repubblicana tanto spesso alla Costituzione si siano appellate le forze
di opposizione, per invocarne le garanzie, per chiederne l’attuazione, magari per accusare le forze di governo e
56
di maggioranza o comunque quelle dotate di maggiori poteri decisionali di violazione o di «tradimento» della
stessa Costituzione; e perché in talune fasi si sia assistito al paradosso per cui forze, che alla Costituente erano
state principali assertrici e artefici di certi istituti (ad esempio, l’ordinamento regionale), abbiano svolto in
seguito un ruolo di ostacolo o di freno alla loro attuazione (tanto che qualcuno parlò di «ostruzionismo della
maggioranza»)(14); mentre forze che alla Costituente erano diffidenti o avverse nei confronti degli stessi istituti
si siano fatte più tardi paladine della loro attuazione. Questi atteggiamenti delle forze politiche si spiegano
storicamente, tenendo conto delle diverse prospettive che per esse rappresentavano l’essere o il prevedere di
essere al Governo o viceversa in posizione di minoranza.
Ma fu probabilmente una circostanza felice quella per cui al momento dell’elaborazione della
Costituzione tutti i partiti scontavano la possibilità di essere destinati a rimanere minoranza, e favorirono quindi
la scelta di un sistema costituzionale nell’ambito del quale potessero essere salvaguardate le loro esigenze
essenziali anche in tale eventualità.
5. I «programmi» della Costituzione.
Tutto ciò, peraltro, non significa che la Costituzione italiana possa configurarsi solo come un insieme di
«regole del gioco» a garanzia di tutti i protagonisti, a cui rimangono estranee scelte sostanziali.
Essa è anche «tavola di valori», esprime aspirazioni e obiettivi largamente condivisi, indica traguardi da
raggiungere e non solo limiti da osservare. In ciò, ancora, emerge il carattere «programmatico» della
Costituzione.
All’assemblea qualcuno osservò che la Costituzione non avrebbe dovuto essere «un programma per il
futuro» (15). Ma prevalse l’idea che, invece, non ci si dovesse limitare a sancire garanzie per le conquiste già
raggiunte (le libertà civili) ma si dovessero indicare anche gli obiettivi da raggiungere, per distanti che potessero
apparire rispetto alla realtà del momento.
Di qui dichiarazioni programmatiche come quella dell’art. 3, comma 2, Cost. sull’uguaglianza
sostanziale, o come la proclamazione di diritti (al lavoro, all’istruzione) la cui piena attuazione richiedeva e
richiede molto di più che la semplice consacrazione in un testo normativo, e non può passare se non in piccola
parte attraverso i tipici mezzi dell’enforcement giudiziario.
Ciò riduce, certo, ma non annulla la portata giuridica di tali proclamazioni. Non l’annulla, poiché resta il
valore interpretativo che esse assumono rispetto alle altre norme della Costituzione e a quelle ordinarie; e resta
il vincolo nei confronti del legislatore ordinario, cui è precluso di dettare discipline le quali appaiano in
positivo contrasto con quelle indicazioni programmatiche. Onde anche queste norme «programmatiche» della
Costituzione, come chiarì la Corte Costituzionale fin dalla sua prima sentenza (sent. n. 1 del 1956), possono
costituire e costituiscono parametro per il giudizio di legittimità di disposizioni di legge, anteriori o posteriori
alla Costituzione.
Il riferimento alle norme «programmatiche» della Costituzione, nei primi anni di applicazione di questa,
aveva costituito, nella giurisprudenza dei giudici comuni, la base — impropria — di una costruzione che in
sostanza tendeva a relegare molti precetti costituzionali (considerati, appunto, solo «programmatici» e non
precettivi) nel limbo delle proclamazioni prive di concreta rilevanza nel diritto vigente, in quanto la loro
attuazione sarebbe spettata solo al legislatore ordinario(16).
Questa teoria era pericolosa soprattutto perché, di fatto, conduceva talvolta i giudici a includere fra le
«programmatiche» non solo le norme costituzionali che effettivamente indicavano traguardi lontani,
raggiungibili solo a mezzo di complessi interventi del legislatore, ma anche principi di garanzia assolutamente
idonei a trovare applicazione già nell’ambito del diritto vigente (come ad esempio i principi dell’art. 21 Cost. in
tema di libertà di manifestazione del pensiero)(17).
Comunque il chiarimento, prodotto con l’entrata in funzione della Corte Costituzionale, circa la piena
idoneità di tutte le norme costituzionali a fungere da parametro per il sindacato di legittimità delle leggi
ordinarie, anteriori e posteriori, neutralizzò il potenziale «eversivo» della rigidità della Costituzione, implicito
nella costruzione accennata.
Resta il fatto della limitata attuabilità in via giudiziaria dei veri «programmi» costituzionali, là dove —
come per l’attuazione del diritto al lavoro — occorrono misure positive e risorse che il giudice non può
surrogare.
Comunque anche questi «programmi», oltre al valore di limite al legislatore e di canone interpretativo, di
cui si è parlato, valgono talora a consentire o a rendere più facile l’evoluzione dell’ordinamento.
Così può non essere privo di significato il fatto che in Italia non sia accaduto, almeno in larga misura, ciò
che è accaduto in altri ordinamenti, e cioè che le norme della Costituzione e i poteri di controllo sulla
57
costituzionalità delle leggi siano stati invocati e utilizzati per contrastare, talora con successo almeno immediato,
l’attuazione di programmi legislativi di più penetrante intervento pubblico nell’economia (nazionalizzazioni,
espropriazioni).
Ciò può più facilmente accadere in presenza di norme di garanzia, tipiche delle Costituzioni (in tema di
proprietà e di iniziativa economica privata) non accompagnate da indicazioni pure di livello costituzionale a
favore di interventi pubblici incidenti sull’economia privata a scopi collettivi (i «fini sociali» o 1’«utilità sociale»
di cui parla l’art. 41 della Costituzione italiana).
In Italia è verosimile che la presenza delle indicazioni programmatiche, pur generiche, della
Costituzione (artt. 41, 42, 43, 44) abbia reso più facile il superamento delle obiezioni e del controllo di
costituzionalità in occasione delle (non molte) riforme legislative che hanno inciso sulla proprietà e l’iniziativa
economica privata (come la riforma fondiaria degli anni ‘50 e la nazionalizzazione dell’energia elettrica del
1962)(18).
E anche quando taluni interventi legislativi non hanno invece, superato positivamente il vaglio di
costituzionalità (come nel caso della legislazione sui vincoli urbanistici e sugli espropri delle aree fabbricabili)
ciò è accaduto in ragione degli effetti sperequanti che aveva la disciplina dettata dal legislatore, e non perché
siano apparsi costituzionalmente preclusi interventi anche drasticamente innovativi sul regime proprietario(19).
Naturalmente i «programmi» costituzionali sono tendenzialmente generici e «aperti», nel senso che non
se ne possono far discendere indicazioni stringenti a favore di determinati concreti assetti normativi, ma solo
indicazioni di obiettivi, da conseguirsi con mezzi e per strade lasciate largamente alla discrezionalità del
legislatore ordinario.
Ma questo carattere di «apertura» a diversi contenuti concreti, proprio del quadro costituzionale,
costituisce un carattere e diremmo un pregio tipico delle Costituzioni di lunga durata: le quali in tanto possono
rimanere ferme nel tempo nonostante i cambiamenti anche profondi della realtà economica, sociale e politica,
in quanto siano abbastanza «elastiche» per conciliarsi con diversi programmi politici e legislativi.
Proprio certe «ambivalenze» e apparenti contraddizioni spesso segnalate nelle norme della Costituzione,
specie sul terreno economico (come l’affermazione della libertà di iniziativa economica e la contemporanea
affermazione dei limiti discendenti dall’utilità sociale e dalla sicurezza, libertà e dignità umana: art. 41, comma
1 e 2), conferiscono al quadro costituzionale quel carattere «aperto» che, almeno fino a quando non giunge a
rendere irrilevanti le norme costituzionali, vanificandone l’essenziale funzione di garanzia, costituisce un
pregio, come si è detto, delle Costituzioni «longeve».
La funzione garantistica della Costituzione si esplica attraverso la fissazione di «limiti di tolleranza» alle
variabili scelte legislative, più che imponendo scelte legislative rigidamente univoche. Certo, vi sono ambiti —
come quelli delle libertà civili — in cui l’esigenza di garanzia deve prevalere e quindi non si può ammettere
un’eccessiva larghezza di tali limiti di tolleranza; mentre in altri ambiti, come quello della regolazione e del
governo dell’economia, deve prevalere l’elasticità. Non a caso la nostra Costituzione, conformemente
all’ispirazione «interventista» dello Stato democratico-sociale, conferisce carattere più rigido alle libertà civili e
politiche, che non a quelle economiche.
Oggi non manca chi indica la necessità di fissare limiti più rigidi anche all’intervento pubblico
nell’economia — e così ad esempio alla crescita delle spese pubbliche — a tutela dei caratteri fondamentali di
un assetto economico-sociale in cui il comparto privato mantenga un ruolo essenziale: caratteri che certamente
si riflettono anche sul tasso di effettiva libertà e democraticità dell’ordinamento nel suo complesso(20).
L’esigenza non è priva di fondamento, ma è almeno dubbia la possibilità e l’opportunità di adottare, per
soddisfarla, la classica tecnica garantista delle Costituzioni, sancendo per via di norme costituzionali vincoli
rigidi e assicurandone l’osservanza mediante strumenti analoghi a quelli della giurisdizione costituzionale (una
sorta di «Corte Costituzionale economica» da taluno prospettata). Dubbia perché la realtà economica richiede
grande flessibilità di interventi, e perché la tecnica dei parametri rigidi, garantiti giurisdizionalmente — al di là
dei consueti canoni di eguaglianza e di ragionevolezza, che anche in questo campo possono svolgere il proprio
ruolo —, poco sembra adattarsi a governare i complessi congegni dell’economia e degli interventi pubblici
nell’economia.
6. La sistematica; i principi fondamentali e il loro valore giuridico.
La carta, come si sa, è suddivisa in «principi fondamentali» (artt. 1-12 Cost.) una prima parte intitolata ai
«diritti e doveri dei cittadini» (artt. 13-54 Cost.), una seconda parte intitolata all’«ordinamento della
Repubblica», e infine 18 norme transitorie e finali.
58
La parte I è suddivisa in quattro titoli: rapporti civili (artt. 13-28 Cost.), rapporti etico-sociali (famiglia,
salute, scuola: artt. 29-34 Cost.), rapporti economici (artt. 35-47 Cost.), rapporti politici (artt. 48-54 Cost.).
La parte II a sua volta si suddivide in sei titoli, dedicati rispettivamente: il primo al Parlamento
(suddiviso in due sezioni: «le Camere» e «la formazione delle leggi»); il secondo al Presidente della Repubblica;
il terzo al Governo (suddiviso in tre sezioni: «il Consiglio dei Ministri», «la pubblica amministrazione», «gli
organi ausiliari»); il quarto alla Magistratura (suddiviso in due sezioni: «ordinamento giurisdizionale» e «norme
sulla giurisdizione»); il quinto alle Regioni, Province e Comuni; il sesto alle garanzie costituzionali (suddiviso in
due sezioni, dedicate a «la Corte Costituzionale» e a «revisione della Costituzione. Leggi costituzionali»).
L’architettura del testo risale a una precisa impostazione: dopo i principi fondamentali, la prima parte
muove dall’individuo, visto prima come singolo, poi nelle diverse forme di vita sociale in cui è inserito
(famiglia, scuola, organizzazioni economiche e di lavoro), fino all’organizzazione politica; nella seconda parte si
disciplinano prima i poteri attivi e di indirizzo (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo) poi i poteri
di garanzia (Magistratura), quindi gli istituti del decentramento politico, concludendo con la Corte
Costituzionale (organo di garanzia dell’intero sistema costituzionale) e con la revisione della Costituzione(21).
I principi fondamentali della Costituzione non sono espressi né per intero, né soltanto nei primi dodici
articoli, pure ad essi intitolati. Essi si ricavano piuttosto dall’intero testo. La loro individuazione non ha mero
valore ricognitivo, ma anche normativo, poiché essi non solo costituiscono linee guida per l’interpretazione del
testo costituzionale o per l’esplicitazione di regole in esso implicite, ma da un lato sfuggono, secondo una
diffusa opinione, allo stesso potere di revisione, anche al di là dell’espresso divieto, sancito nell’art. 139, di
sottoporre a revisione la forma repubblicana dello Stato; dall’altro lato costituiscono il nucleo inderogabile
dell’ordinamento costituzionale, così che anche nei casi in cui la Costituzione ammette la possibilità di disporre
delle discipline speciali derogatorie rispetto alle norme costituzionali, quei principi non possono essere
intaccati.
Così la Corte Costituzionale ha ritenuto che la «specialità» delle autonomie delle Regioni a ordinamento
differenziato (art. 116 Cost.), espressa nei rispettivi statuti adottati con leggi costituzionali, non può giungere
fino a intaccare principi fondamentali come l’unità della giurisdizione costituzionale (e su questa base ha
ritenuto che la previsione di un’Alta Corte per la Regione siciliana, pur contenuta nello statuto speciale, sia
venuta meno con l’avvento della stessa Corte Costituzionale: sentt. n. 38 del 1957 e n. 6 del 1970); che le
deroghe al diritto costituzionale comune che possono essere introdotte in esecuzione dei patti lateranensi e
degli accordi di revisione degli stessi non possono comunque contrastare con i «principi supremi
dell’ordinamento costituzionale» (e così ad esempio con il nucleo essenziale del diritto alla tutela giudiziaria:
sentt. n. 30 e 31 del 1971, n. 18 del 1982); e parimenti che le deroghe alle competenze costituzionalmente
stabilite, discendenti dall’adesione dell’Italia ai trattati e all’organizzazione delle Comunità europee, in tanto
valgono in quanto siano rispettati i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale (onde rimane questa
l’unica riserva di sindacato costituzionale interno [indiretto] nei confronti delle norme comunitarie, che hanno
efficacia diretta nell’ordinamento interno italiano, prevalendo sulle fonti interne di grado legislativo o perfino
su norme costituzionali: sentt. n. 98 del 1965,n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 399 del 1987).
Proprio perché i principi fondamentali della Costituzione non sono espressi in specifiche disposizioni
del testo, la loro individuazione è affidata all’interprete (anzitutto alla giurisprudenza della Corte Costituzionale,
che però in tema non è certo abbondante), e può presentare un certo grado di variabilità: e infatti gli autori che
hanno tentato tale individuazione giungono a risultati parzialmente diversi, anche se c’è largo consenso sulla
sostanza di questi principi.
7. Il primato della persona e le formazioni sociali.
In tema di rapporti fra individui e gruppi da un lato e poteri pubblici dall’altro, o di rapporti fra società e
Stato, la Costituzione si ispira anzitutto all’idea-forza della centralità e del primato della persona umana,
considerata come soggetto di diritti in certo senso anteriori a qualsiasi riconoscimento da parte dello Stato, e
quindi non condizionati a finalità collettive di qualsiasi genere, anche se limitati e limitabili — ma non in
qualsiasi direzione e misura — in vista di esigenze degli altri individui e della comunità, e quindi in vista
dell’adempimento dei «doveri inderogabili di solidarietà» (art. 2).
La Costituzione infatti riconosce e afferma solennemente a vari propositi la dignità e l’inviolabilità della
persona (artt. 2, 3, comma 1, 13, commi 1 e 4, 32, comma 2, 41, comma 2) ; sancisce i vari diritti di libertà
(artt. 13-28 Cost.) e le garanzie giudiziarie dei diritti (art. 24 Cost.), con norme il cui «nucleo fondamentale»
(Corte Cost., sent. n. 18 del 1982) costituisce principio inderogabile dell’ordinamento costituzionale; e pone «il
pieno sviluppo della persona umana» come mèta rispetto alla quale il potere non solo deve astenersi da
59
interventi ostili, ma deve operare positivamente per superare gli ostacoli di fatto che vi si frappongono (art. 3,
comma 2).
Al principio «personalista» si collegano quello di eguaglianza, essendo la parità giuridica (non solo dei
«cittadini», ma, per quanto riguarda il godimento dei diritti fondamentali, di tutti gli esseri umani; Corte Cost.,
sentt. n. 120 del 1967; n. 104 del 1969) e l’obiettivo dell’eguaglianza «sostanziale» (art. 3, comma 2), corollari
del primato della persona umana in quanto tale.
Al principio «personalista» si collegano quello di eguaglianza, essendo la parità giuridica (non solo dei
«cittadini», ma, per quanto riguarda il godimento dei diritti fondamentali, di tutti gli esseri umani; Corte Cost.,
sentt. n. 120 del 1967; n. 104 del 1969) e l’obiettivo dell’eguaglianza «sostanziale» (art. 3, comma 2), corollari
del primato della persona umana in quanto tale.
Al riconoscimento dei diritti individuali si accompagna nella Costituzione il riconoscimento esplicito
delle «formazioni sociali» ove si svolge la personalità del singolo (art. 2). Questo principio «pluralista» è
espressione tipica dello Stato democratico-sociale, che, pur innestandosi sul principio liberale dell’abolizione
dei privilegi di categoria o di gruppo, lascia alle spalle l’impostazione «individualistica» del primo liberalismo,
ispirata a diffidenza per ogni forma di organizzazione sociale che si frapponesse fra l’individuo e la collettività
politica organizzata a Stato.
Peraltro anche le formazioni sociali sono riconosciute in quanto strumenti per lo sviluppo della persona,
e non viceversa (infatti l’art. 2 pone l’accento sui diritti «dell’uomo... nelle formazioni sociali»).
Il riconoscimento delle formazioni sociali e il favor nei confronti di esse comportano da un lato
l’attribuzione alle stesse di posizioni di libertà e di protezione nell’ordinamento statale, dall’altro lato l’esigenza
del rispetto da parte dei poteri statali della loro autonomia, intesa come libertà di darsi una propria
organizzazione e di determinare i modi della propria attività.
Da ciò discende fra l’altro l’inammissibilità di intromissioni statali nell’ambito delle organizzazioni
sociali, dirette a sottoporle a un regime pubblicistico, asservendole agli interessi statali, e trasformandole in
organi «ausiliari» dello Stato (secondo una vicenda non di rado rinvenibile nella legislazione a proposito di
formazioni associative). Qui sta anche il limite ad ogni intervento legislativo di «regolazione» autoritaria di
formazioni sociali, sia pure effettuato in nome della rilevanza sociale nella loro attività: quello che si
chiamerebbe «giurisdizionalismo» nei confronti delle confessioni religiose, ma che può assumere forme e
modalità non dissimili nei confronti, ad esempio, dei sindacati o delle associazioni di categoria o dei partiti.
C’è un limite, peraltro, anche all’obbligo di non interferenza dello Stato nella vita interna delle
formazioni sociali, ed è quello nascente dal dovere di assicurare tutela ai diritti fondamentali della persona,
anche contro gli attentati che possono derivare dai «poteri privati» che si esercitano nell’ambito di
organizzazioni sociali. Vero è che normalmente la tutela del singolo si realizza attraverso la piena libertà di
aderire o di non aderire ad una formazione associativa (donde l’essenziale profilo della libertà «negativa» di
associazione), e quindi di recedere dal vincolo associativo e di dar vita eventualmente ad altre formazioni. Ma
ciò non toglie che in certi casi (e per esempio quando si tratti di formazioni «ad appartenenza necessaria»,
come la famiglia, ma non soltanto in questa ipotesi) sia necessario l’intervento pubblico a tutela dei diritti
fondamentali del singolo lesi o messi in pericolo nell’ambito della formazione sociale.
Ma l’aspetto più problematico del pluralismo è forse un altro, e si ricollega all’ipotesi in cui talune
formazioni sociali chiedano ed ottengano dallo Stato non tanto il rispetto della loro libertà, ma regimi di
agevolazione o di favore, o discipline speciali di sostegno (si pensi, per esempio, alla legislazione di sostegno
dei sindacati, o di certe associazioni di categoria, o dei partiti, o delle confessioni religiose).
I limiti invalicabili (ma forse talvolta valicati) in questo campo dovrebbero essere rappresentati dal
rispetto del principio di uguaglianza e di parità di possibilità (la Chancengleichheit dei tedeschi) nel trattamento
delle varie formazioni sociali operanti sullo stesso terreno o perseguenti i medesimi interessi collettivi,
indipendentemente dalla loro consistenza maggioritaria o minoritaria; dal divieto per lo Stato di conferire veri e
propri privilegi o di far partecipare singole formazioni sociali all’organizzazione pubblicistica o all’esercizio dei
poteri pubblici, trasformandole così per altra via (sia pure di favore) in organismi ausiliari dello Stato o
prestando ai poteri sociali privati il «braccio secolare» dello Stato; dal rispetto dei diritti e dell’uguaglianza
fondamentale fra tutti gli individui, appartenenti e non appartenenti alle spontanee organizzazioni sociali.
Questi dovrebbero anche essere i limiti della produzione di norme statali fondate su accordi fra poteri
pubblici e organizzazioni sociali, o sulla recezione di accordi fra diverse organizzazioni sociali; fenomeno
caratteristico del pluralismo contemporaneo, riconosciuto e fatto proprio anche dalla nostra Costituzione (si
pensi al rinvio a norme pattizie per la disciplina dei rapporti dello Stato con le confessioni religiose: artt. 7 e 8;
o al conferimento di efficacia generale ai contratti collettivi di lavoro: art. 39 Cost.); fenomeno esteso nella
pratica legislativa sia attraverso la previsione di nuove ipotesi normative (si pensi agli accordi che disciplinano il
60
rapporto di servizio dei pubblici impiegati, ai sensi della l. 29 marzo 1983, n. 93), sia attraverso la frequente
«negoziazione» di contenuti normativi fra autorità pubbliche e organizzazioni, ad esempio sindacali o di
categoria.
Fenomeno che però, in base al principio pluralistico, ma anche a quello di fondamentale eguaglianza fra
le persone, emergenti dalla Costituzione, dovrebbe appunto trovare il suo limite invalicabile non solo
nell’esigenza di non asservire il potere pubblico a interessi particolari, ma anche nel divieto di dar vita a
privilegi o a «statuti personali» differenziati in relazione all’appartenenza o meno dei singoli alle formazioni
sociali cui essi liberamente aderiscono.
Il principio di eguaglianza «davanti alla legge» (art. 3, comma 1) non comporta certo divieto di discipline
diversificate, e anzi esige tale diversificazione, in rapporto a situazioni oggettivamente diverse, apprezzate
secondo i canoni (cui fa costante riferimento la ricca giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di
eguaglianza) della ragionevolezza e della non arbitrarietà.
Ma la differenza ragionevole di discipline non può diventare discriminazione nel godimento dei diritti
fondamentali da parte dei singoli, né privilegio o sperequazione di possibilità fra gruppi sociali aventi analoghi
scopi e caratteristiche.
Fermo questo limite invalicabile, il principio di eguaglianza «sostanziale» (art. 3, comma 2) impone di
tener conto delle disparità di fatto, derivanti dalle condizioni economiche e sociali, per dettare discipline
tendenti ad eliminarle o a ridurle, creando condizioni di migliore «giustizia sociale», anche compensando con
posizioni di vantaggio legali la condizione di svantaggio in cui si trovano le parti (individuali e sociali) più deboli
nei rapporti economici e sociali.
Questo è anche il significato della proclamazione secondo cui la Repubblica è «fondata sul lavoro».
Non nel senso che l’attività lavorativa sia riconosciuta come aspetto assolutamente preminente della
persona (è l’uomo o la donna in quanto tale, con la sua dignità, indipendentemente dalla sua produttività, che è
al centro del sistema costituzionale), né nel senso che in funzione dell’attività lavorativa si possano introdurre
discriminazioni nel godimento dei diritti fondamentali o nella partecipazione al governo dello Stato (come
avviene in talune Costituzioni degli Stati socialisti): ma nel senso che è il lavoro, come contributo di ciascuno
«al progresso materiale o spirituale della società» (art. 4, comma 2), e non già requisiti di nascita, di censo o di
altro genere, che fonda il ruolo sociale degli individui; e che l’ordinamento riconosce il primato del lavoro nei
rapporti di produzione, in quanto elemento più direttamente attinente alle persone partecipi di quei rapporti.
Da qui, infine, il fondamento costituzionale delle discipline volte a realizzare una redistribuzione della
ricchezza e dei redditi (cfr., artt. 42, 44, 53 Cost.).
Al medesimo criterio dell’uguaglianza «di fatto» si ispira il principio costituzionale che impone la tutela,
con apposite norme, delle minoranze linguistiche (art. 6 Cost.), come gruppi che, proprio per la loro
consistenza minoritaria, potrebbero vedere i propri componenti ostacolati o sfavoriti nel pieno sviluppo della
propria personalità (ma naturalmente, ancora una volta, dovrebbe valere il limite derivante dal divieto di
«statuti personali» discriminatori in ordine al godimento dei diritti fondamentali).
8. Principio democratico e principio garantistico nell’organizzazione costituzionale: gli organi di indirizzo
politico.
In tema di struttura dei poteri pubblici, i principi-base della Costituzione sono quelli — propri della
tradizione liberale-democratica — secondo cui l’autorità si fonda sul consenso dei governati (principio
democratico) e deve essere organizzata in modo da garantire i diritti di tutti (principio garantistico).
L’appartenenza della sovranità «al popolo», e la precisazione secondo cui essa si esercita «nelle forme e
nei limiti della Costituzione» (art. 1, comma 2, Cost.), esprimono sinteticamente questi principi.
La scelta repubblicana effettuata col referendum istituzionale del 2-6-1946 ha eliminato l’istituto di
governo — la monarchia — che non fondava la propria legittimazione sul principio rappresentativo, ma sul
possesso ereditario del trono.
Tutti gli organi cui è affidato il compito di effettuare le scelte di indirizzo e le scelte concrete per la cura
degli interessi pubblici, nei limiti e nelle forme della Costituzione, sono organi che ripetono la loro
legittimazione dal popolo, attraverso la periodica elezione diretta (come per il Parlamento e per le assemblee
degli enti territoriali), o indiretta (come per il Presidente della Repubblica o per gli organi esecutivi degli enti
territoriali) o attraverso il vincolo fiduciario che impone la conformità degli indirizzi alla volontà delle
maggioranze di organi elettivi (come per il Governo): quando addirittura le decisioni non siano demandate al
popolo stesso, attraverso gli istituti di democrazia diretta (il referendum, nazionale o locale).
61
A questa fondamentale regola per l’organizzazione dei poteri pubblici si aggiungono varie forme di
concorso dei cittadini, nelle diverse sedi e in funzione delle loro diverse qualifiche e attività, alla formazione di
organi pubblici o di manifestazioni di volontà aventi rilievo nell’ambito dello Stato: dalle forme di autogoverno
di taluni comparti dell’apparato pubblico (tipico quello della magistratura ordinaria previsto dall’art. 104 della
Costituzione, e sul quale la legge ha modellato analoghe forme di autogoverno delle altre magistrature; ma si
pensi ad esempio anche agli ordini professionali o alle Università), alle forme più recenti di partecipazione
degli operatori e degli utenti di determinati servizi pubblici alla gestione degli apparati creati per la loro
erogazione (ad esempio le scuole).
Tutto ciò è riconducibile al principio per cui la Repubblica promuove «l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3, comma 2).
Tuttavia, anche nell’organizzazione e nel funzionamento dei poteri «di indirizzo», al principio
democratico-maggioritario si accompagna il principio garantistico e di diffusione del potere.
Di per sé, in astratto, il principio democratico-rappresentativo potrebbe essere attuato anche mediante
l’attribuzione di tutti i poteri politici di indirizzo ad un unico individuo, eletto periodicamente da tutto il
popolo. La Costituzione italiana però è ben lontana da una siffatta democrazia «plebiscitaria», perché fonda
invece l’organizzazione dello Stato su criteri di massima diffusione del potere, sulla tradizionale concezione dei
freni e dei contrappesi fra poteri diversi, anche fra quelli aventi carattere rappresentativo.
Così, i poteri normativi fondamentali sono attribuiti alle assemblee parlamentari (artt. 70, 76, 77, 78, 80,
81 Cost.), che per la loro stessa composizione assicurano una rappresentanza meno sintetica e più articolata del
corpo sociale (e ciò anche a prescindere dalla scelta di sistemi elettorali che garantiscano in modo più o meno
largo la rappresentanza delle minoranze, posto che la Costituzione non fa alcuna scelta in proposito). Il
massimo potere rappresentativo, il Parlamento, è articolato in due Camere poste in condizione di parità (e ciò
fu voluto essenzialmente in funzione garantistica, oltre che di maggiore articolazione della rappresentanza).
L’organizzazione interna del Parlamento è ispirata al principio proporzionalistico e di tutela delle
minoranze (art. 72, comma 3, Cost.; art. 82, comma 2, Cost.; art. 83, comma 2, Cost.). Sono previsti poteri di
equilibrio e di coordinamento del Presidente della Repubblica, concepito come organo rappresentante
dell’«unità nazionale» (art. 87 comma 1, Cost.; art. 74 Cost.).
Lo stesso Parlamento può essere sciolto anticipatamente, rimettendo così al corpo elettorale le scelte
fondamentali di indirizzo (art. 88 Cost.), o la sua volontà può essere verificata o contraddetta da una pronuncia
diretta del corpo elettorale (artt. 75, 138 Cost.).
Il potere pubblico, pur nell’ambito di uno Stato unitario, è articolato sul territorio in enti di autogoverno
dotati di competenze costituzionalmente garantite (artt. 5, 114, 128, 134 Cost.).
Così che la concezione stessa della democrazia cui si ispira la nostra Costituzione si fonda
sull’affermazione del principio maggioritario e sulla contestuale affermazione del principio di tutela delle
minoranze. Tra la preoccupazione di dar vita ad apparati pubblici capaci di efficienza e di immediatezza
decisionale ed operativa, e quella di garantire un corretto uso del potere e prevenire arbitrii e sopraffazioni,
non vi è dubbio che la nostra Costituzione dia maggior peso a questa seconda, come rilevano criticamente
coloro che reputano il sistema istituzionale italiano troppo complicato e farraginoso, e poco idoneo a produrre
decisioni. Ma si dovrebbe osservare, in proposito, che il ruolo fondamentale delle Costituzioni è proprio
quello di assicurare un sistema di garanzia e di tutela perché il potere — anche quello democraticamente
legittimato — sia esercitato correttamente e senza sacrificare essenziali diritti e interessi di nessun individuo e di
nessuna parte.
Il costituzionalismo moderno è nato e si è sviluppato proprio come insieme di regole atte a controllare e
limitare il potere politico, nella convinzione che un potere limitato e controllato sia meglio di qualsiasi
dispotismo anche «illuminato» o anche plebiscitariamente legittimato.
In questo quadro, la Costituzione ha fatto un’opzione per la forma di governo parlamentare, nella quale
cioè ad una distinta legittimazione e ad una più netta separazione fra Parlamento ed esecutivo si preferisce il
coordinamento fra i due poteri, attraverso il vincolo fiduciario che lega il secondo al primo (art. 94 Cost.).
Un sistema parlamentare — secondo gli intenti del costituente — caratterizzato da «dispositivi
costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di governo e ad evitare le degenerazioni del
parlamentarismo», come si esprimeva l’ordine del governo presentato dall’on. Perassi e approvato dalla
seconda sottocommissione della commissione per la Costituzione(22).
Che tale intento sia riuscito, o sia riuscito pienamente, è assai discusso.
È noto, comunque, che nella vita concreta del sistema parlamentare italiano, e più in generale delle
istituzioni repubblicane, ha assunto un’importanza crescente e sempre più evidente il ruolo dei partiti politici.
Ruolo che la Costituzione non ignora, perché anzi considera i partiti strumento fondamentale a disposizione
62
dei cittadini «per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale» (art. 49 Cost.), ma
che si è sviluppato in forme e in campi, e con una incidenza, sconosciuti in altre epoche storiche e
probabilmente nella maggior parte degli altri ordinamenti statali simili al nostro.
Di per sé questo è un fenomeno che attiene non tanto alla struttura costituzionale dello Stato quanto al
concreto atteggiarsi delle forze sociali che nelle istituzioni operano, e in qualche misura possono piegarne il
funzionamento a proprie esigenze e atteggiamenti. Poiché però i partiti condizionano proprio il modo di
operare delle massime istituzioni costituzionali, è evidente che non si può, nel considerare e nel valutare
l’«edificio» costituzionale, trascurarne il ruolo, e trascurare il modo concreto in cui si atteggia il sistema dei
partiti.
Anzi, è sempre aperto l’interrogativo se i difetti o gli inconvenienti che spesso vengono segnalati nel
funzionamento del sistema costituzionale siano, e in che misura, imputabili ai congegni previsti dalla
Costituzione, o se essi risalgano, e in che misura, ai comportamenti delle forze politiche e sociali, e in special
modo dei partiti; se quindi le riforme da tante parti auspicate si debbano perseguire essenzialmente attraverso
l’affermazione di nuove regole costituzionali, o se piuttosto non dovrebbero passare attraverso una modifica
degli atteggiamenti e dei comportamenti prevalenti nel sistema politico.
Vero è, peraltro, che, le forze in campo essendo quelle che sono, nuove regole formali potrebbero
apparire (non è però detto che sempre siano) strumento necessario per indurre o incentivare tali nuovi
comportamenti.
9. (Segue). Gli organi di garanzia.
Se poi si ha riguardo agli organi cui la Costituzione attribuisce direttamente funzioni di garanzia —
fondamentalmente il potere giudiziario (titolo IV della parte II) e la giurisdizione costituzionale (titolo VI della
parte II, sez. I), domina il principio garantistico, prevalendo su quello democratico.
Se infatti anche l’esercizio della giurisdizione viene ricondotto in linea di principio al popolo (art. 101,
comma 1, Cost.), il proprium di tale funzione viene però indicato espressamente nell’applicazione della legge
in posizione di indipendenza rispetto agli altri poteri (art. 101, comma 2, Cost., art. 104 Cost.), e,
implicitamente, in posizione di estraneità rispetto agli interessi coinvolti, così da assicurare a tutti l’essenziale
tutela giudiziaria dei diritti e degli interessi (artt. 24 e 113 Cost.).
Nella formazione e nell’attività degli organi giudiziari il principio dominante è quello di una selezione su
basi di competenza tecnica e con criteri di imparzialità, e di un’assenza di condizionamenti sia pure provenienti
dalla collettività o da organi rappresentativi: onde il principio elettivo nella nomina dei giudici, pur non escluso,
ha un’applicazione circoscritta (art. 106, comma 2, Cost.), e incontra i limiti derivanti dall’esigenza di assicurare
comunque l’indipendenza e l’imparzialità del giudicante.
La stessa volontà del massimo organo rappresentativo, espressa nella legge, non è incondizionatamente
efficace, potendo essere sindacata sotto il profilo della sua conformità alla Costituzione dall’apposito organo di
giustizia costituzionale, nella cui composizione il principio rappresentativo, pur non ignorato, cede rispetto ai
principi dell’indipendenza e dell’imparzialità.
L’istituzione della giurisdizione costituzionale, col compito, oltre che di giudicare sulla costituzionalità
degli atti legislativi, di garantire il rispetto delle sfere costituzionali di competenza dei poteri e delle articolazioni
centrali e periferiche della Repubblica, rappresenta senza dubbio uno degli aspetti più significativi e più incisivi
del quadro costituzionale cui si è dato vita con la carta del 1948: portando in qualche modo a compimento
l’attuazione dei principi di tutela dei diritti, di garanzia e di diffusione del potere, che sono alla base del
costituzionalismo moderno.
L’inderogabilità della tutela giudiziaria dei diritti (art. 24 Cost.), da un lato, la garanzia giurisdizionale
della Costituzione, con quello che è stato chiamato il «principio di legittimità costituzionale» (23), dall’altro lato,
segnano le «clausole generali», le pietre miliari che assicurano l’effettività e la rigidità della Costituzione.
In un senso più ampio e comprensivo, il principio democratico è destinato a informare di sé tutto
l’ordinamento. Così esso comporta che i poteri — tutti i poteri, anche quelli che non sono organizzati sulla base
del principio rappresentativo maggioritario — operino secondo regole prestabilite, e in modo visibile, alla luce
del sole. La «trasparenza» del potere, si potrebbe dire, è uno dei postulati di questo principio.
Esso comporta la possibilità di conoscere e controllare ogni manifestazione d’esercizio del potere, di
sottoporla a discussione e a critica.
Non ci possono essere, da questo punto di vista, immunità assolute, né zone franche sottratte al
controllo.
63
Così devono essere controllate le decisioni di politica estera, in passato appannaggio prevalente
dell’esecutivo e protette spesso da prassi di diplomazia segreta (art. 80 Cost.); i segreti di Stato devono essere
limitati e posti sotto la responsabilità degli organi democraticamente legittimati; la pubblicità è la regola non
solo per i lavori dell’assemblea rappresentativa, ma anche per i dibattimenti giudiziari; perfino nell’ambito degli
apparati tradizionalmente più ispirati a criteri di gerarchia, come le forze armate, l’ordinamento deve
informarsi «allo spirito democratico della Repubblica» (art. 52, comma 3, Cost.).
10. L’apertura sovranazionale.
La Costituzione italiana non manca infine di allargare lo sguardo alla collocazione della Repubblica nel
sistema internazionale, ispirandosi all’idea che anche la comunità internazionale degli Stati debba essere
costruita sulla base del diritto e secondo principi di pacifica cooperazione. Anche in ciò si manifesta un ideale
costituzionale più maturo e più completo di quello che emergeva dalle Costituzioni degli Stati nazionali
dell’Ottocento.
In particolare, da un lato è espressamente riconosciuta l’esigenza che lo Stato si adegui anche all’interno
agli obblighi che discendono dalla sua appartenenza alla comunità internazionale (art. 10 Cost.). Dall’altro lato,
la Costituzione apre esplicitamente le porte, sia pure a condizioni di parità con gli altri Stati, alle «limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni», e alle «organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo» (art. 11 Cost.).
È così intaccato il mito dell’assolutezza e dell’esclusività della sovranità statale; vi sono spazi (e sono in
concreto, ad esempio, quelli configurati dai trattati istitutivi delle Comunità europee) in cui lo stesso
ordinamento giuridico interno per così dire si ritira, per fare posto a norme e a poteri sovranazionali, capaci di
vincolare direttamente i cittadini, e la cui autorità è direttamente riconosciuta e garantita dagli apparati esecutivi
e giudiziari della Repubblica.
Sono in tal modo anche poste le premesse per giungere, se la politica di unificazione progredirà, a
forme più strette di unione, fino ad una federazione europea, la cui nascita troverebbe già, nella carta del 1948,
fondamento e legittimazione costituzionale.
11. La lenta attuazione della Costituzione.
Si è accennato all’inizio al lungo e travagliato processo dell’attuazione costituzionale.
Sorta sulle rovine del vecchio Stato, la Repubblica ne ha ereditato peraltro quasi tutte le strutture; così
che per molti anni e decenni, e in parte tuttora, la Costituzione ha rappresentato l’avanguardia «presbite» —
perché guardava lontano (24) — di un ordinamento largamente ancora fermo al passato.
Sostituite col referendum le istituzioni repubblicane a quelle monarchiche, varata la Costituzione del
1948, con la sua struttura essenziale di Camere, Governo e Capo dello Stato, all’inizio però molte delle
istituzioni nuove da essa previste rimasero sulla carta, più o meno a lungo.
Così che i primi bilanci dell’età repubblicana — a cinque o dieci anni dall’entrata in vigore della carta,
scaduti invano vari termini che la carta aveva previsto per il completamento del nuovo ordinamento (VI, VIII,
IX, XVI disp. trans. fin.) - furono necessariamente in gran parte bilanci di una inattuazione costituzionale(25).
Tale situazione si è protratta molto a lungo, e in parte perdura tuttora.
Si pensi che fino al 1971 lo stesso regolamento della Camera dei deputati era ancora, rimaneggiato,
quello risalente al 1920-22; che fino al 1988 le norme legislative sull’organizzazione e sull’attività del governo
risalivano alla fine dello scorso secolo o al primo trentennio di questo(26); che solo nel 1981 si è realizzata, in
modo peraltro incompiuto, la riforma della giustizia penale militare, mentre solo nel 1986 si è realizzata una
forma di autogoverno e quindi la piena indipendenza della magistratura amministrativa; che tuttora non è stato
sostituito l’ordinamento giudiziario del 1941(27), né la legge comunale e provinciale, risultante ancora, nei suoi
nuclei fondamentali, dai testi unici del 1915 e del 1934(28). Ma anche la legislazione non di diretta attuazione
della Costituzione, ma pur sempre bisognosa di adeguamento ai nuovi principi, è rimasta largamente e a lungo,
e in molta parte è tuttora, quella delle epoche precedenti.
Così solo nel 1988 è entrato in vigore (...) il nuovo codice di procedura penale(29), mentre il codice
civile, il codice di procedura civile e il codice penale (per non parlare del codice penale militare) sono ancora
quelli di prima, salvo novelle parziali; la legge di pubblica sicurezza è ancora il testo unico del 1931(30),
«sbrindellato» da numerose dichiarazioni di incostituzionalità.
Tuttavia, nonostante il permanere, sotto il nuovo tetto, di tante vecchie mura più o meno rabberciate,
l’edificio costituzionale si è pian piano, se non compiuto, certo delineato secondo il disegno della carta. Non è
64
il caso di ripercorrere qui analiticamente tutte le tappe legislative (e giurisprudenziali) di quest’opera di
attuazione. Basterà ricordare le principali.
Negli anni Cinquanta prendono vita la Corte Costituzionale(31), il Consiglio superiore della
Magistratura previsto dall’art. 104 Cost.(32), il Consiglio superiore di difesa (33) e il Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro(34), e si realizza un modesto decentramento di funzioni amministrative(35). Negli
anni sessanta molta parte dell’attenzione delle forze politiche è volta alla legislazione in materia di
programmazione economica(36); solo alla fine di questo periodo vengono varate le leggi di attuazione
dell’ordinamento regionale(37).
L’inizio degli anni settanta vede, oltre all’avvento delle Regioni ordinarie, l’attuazione dell’istituto del
referendum (38) la cui applicazione conoscerà subito fasi di grande vivacità, l’istituzione dei Tribunali
amministrativi regionali (39) e il varo dei nuovi regolamenti delle Camere(40).
Al 1981, come si è ricordato, risale la riforma dei tribunali militari(41).
Si dovrà attendere il 1988 per vedere finalmente la legge sull’ordinamento della Presidenza del
Consiglio promessa dall’art. 95, comma 3, della Costituzione(42). Manca ancora, è incorso d’esame, una legge
regolatrice dello sciopero (art. 40 Cost.).
Si può dire oggi che l’ultima area rimasta di schietta inattuazione costituzionale sia quella
dell’ordinamento sindacale: i meccanismi previsti dall’art. 39 per la registrazione dei sindacati e la stipulazione
di contratti collettivi con efficacia generale non solo non sono stati attivati, ma le forze sindacali ne contestano
apertamente l’attuazione, mentre il legislatore batte varie strade più o meno apertamente distanti o elusive
rispetto a quella previsione (così quando fonda sulla maggior rappresentatività, anziché sulla proporzionalità, il
rilievo dato alle organizzazioni sindacali nell’ambito pubblicistico).
Si tratta forse dell’unica scelta costituzionale esplicitamente contestata dalla maggioranza delle forze
politiche sociali.
Così che, a questo proposito, l’alternativa all’inattuazione (che tuttavia sussiste) appare, anziché
l’attuazione, la modifica dello stesso disposto costituzionale (eppure nemmeno questo processo di revisione è
ancora concretamente avviato). Andrebbero poi ricordate le leggi, se non di diretta attuazione costituzionale,
quanto meno incidenti in settori di grande rilevanza costituzionale, come le misure di prevenzione(43), le
associazioni vietate(44), le garanzie di difesa nel processo penale(45), l’ordinamento penitenziario(46), i
trattamenti sanitari obbligatori(47), l’informazione(48), la revisione del concordato lateranense(49), le intese
con i culti acattolici(50), la tutela delle libertà nei luoghi di lavoro(51), la condizione della donna nel rapporto
di lavoro e nell’accesso ai pubblici uffici(52), la disciplina del rapporto di pubblico impiego(53), il
finanziamento pubblico dei partiti(54), il riconoscimento dell’obiezione di coscienza(55); e ancora, nel campo
organizzativo, la legislazione elettorale(56), il servizio sanitario nazionale(57), i servizi segreti(58), la disciplina
militare(59), l’ordinamento della pubblica sicurezza(60), e altre(61).
In complesso, una produzione legislativa ormai imponente, anche se per lo più, oltre che tardiva,
parziale e frammentaria, e non sostitutiva, inmolti casi, della legislazione preesistente.
12. I protagonisti dell’attuazione.
I protagonisti dell’attuazione (o volta a volta dell’inattuazione) della Costituzione sono molteplici.
Anzitutto, certamente, le istituzioni investite di compiti legislativi, e, in esse le forze politiche che ne
concretano e ne orientano la volontà.
Il richiamo alla Costituzione, come quadro da attuare o come limite da non varcare, è stato sempre, ed è
tuttora, molto frequente nel lavoro legislativo e nel dibattito politico, in Parlamento e nel Governo. Non
altrettanto costanti si può dire siano stati l’attenzione e l’impegno dedicati dal legislatore al compito di adeguare
l’ordinamento alla Costituzione.
Tra gli organi di garanzia, in senso ampio, il Presidente della Repubblica ha spesso svolto un ruolo di
esplicito richiamo all’esigenza di attuazione costituzionale. Sono rimasti celebri gli inviti del Presidente
Gronchi, già nel suo discorso di insediamento del 1955(62), ad accelerare il processo di attuazione. Per lo più,
tuttavia, il ruolo del Capo dello Stato non è andato al di là di questa funzione di richiamo e di stimolo, secondo
il modello di un Presidente «magistrato di persuasione e di influenza» (63).
Più limitati sono stati gli interventi del Presidente volti direttamente a scongiurare violazioni della
Costituzione: i non numerosissimi casi di rinvii presidenziali di leggi sono stati, è vero, quasi tutti motivati da
ragioni di incostituzionalità (per lo più da riscontrate violazioni del precetto costituzionale della copertura
finanziaria delle nuove spese: art. 81, comma 4, Cost.), ma hanno avuto luogo in genere nei riguardi di leggi di
non rilevante importanza politica. Assai più significativo è il concorso, nel processo di attuazione della
65
Costituzione, degli organi giurisdizionali. Per la verità, nei primi anni dopo l’entrata in vigore della carta, la
magistratura non dimostrò un grado particolarmente elevato di sensibilità costituzionale, mostrandosi spesso
propensa ad appoggiare la continuità nell’applicazione delle vecchie leggi in gran parte ereditate dal passato
ordinamento.
Varate nel 1953 le leggi sulla Corte Costituzionale, con il 1956 poteva entrare in funzione questo organo
dal ruolo particolarmente rilevante ai fini della garanzia e dell’applicazione della Costituzione. Da allora
l’attuazione di quest’ultima è passata talora più largamente attraverso le pronunce della Corte, che dichiaravano
incostituzionali (spesso non senza «manipolazioni» atte a salvarne in parte la portata) disposizioni legislative
precedenti o affermavano interpretazioni correttive delle stesse in nome della Costituzione, che non attraverso
le deliberazioni legislative del Parlamento.
Osservando complessivamente le vicende di questi quarant’anni, si deve riconoscere che buona parte
dell’adeguamento dell’ordinamento ai nuovi principi e alle nuove regole è avvenuta in virtù dell’affermazione
(inizialmente non scontata) secondo cui il controllo giurisdizionale della costituzionalità delle leggi (che pure
era stato pensato in funzione di garanzia nei confronti del legislatore futuro) si esercitava egualmente anche nei
confronti delle leggi anteriori alla Costituzione; nonché in forza della giurisprudenza — ora più coraggiosa, ora
più cauta — della Corte Costituzionale.
Nel frattempo, certamente anche in virtù dell’opera della Corte Costituzionale, ma anche in virtù di altri
fattori culturali e strutturali concernenti gli apparati giudiziari, la magistratura — o meglio le magistrature —
hanno manifestato una crescente sensibilità all’esigenza di adeguamento costituzionale della legislazione.
Questo atteggiamento si è riflesso sia nell’uso molto più largo — e che talora può perfino essere giudicato
eccessivo — della Costituzione ai fini di argomentare interpretazioni innovative delle leggi, interpretazioni
appunto «conformi a Costituzione»; sia nella frequente rimessione alla Corte Costituzionale di questioni di
costituzionalità, relative sia a leggi anteriori che a leggi posteriori alla Costituzione.
Così che il timore espresso da alcuni, che il sistema incidentale di introduzione del giudizio sulle leggi
costituisse una «porta stretta» che i giudici avrebbero aperto con troppa parsimonia, è stato sostituito dalla
constatazione di una sovrabbondanza di incidenti sollevati, non sempre con buon fondamento: onde la stessa
Corte è stata indotta negli anni più recenti a verificare con rigore i requisiti delle questioni sollevate, ricorrendo
spesso a dichiarazioni di inammissibilità o di manifesta infondatezza che hanno voluto costituire anche un
implicito richiamo ai giudici perché impiegassero con più rigore e misura questo loro potere.
Va infine osservato che, nel clamoroso ritardo manifestatosi in molti campi nell’adeguamento legislativo
alla Costituzione, ha probabilmente avuto un ruolo, fra i vari fattori concorrenti, anche l’opera di «supplenza»
che la Corte Costituzionale ha intrapreso, attraverso tecniche di decisione che evitano quanto possibile il vuoto
legislativo, «manipolando» le leggi esistenti per adeguarle alle esigenze minime della Costituzione: opera che ha
tolto al Parlamento l’incomodo di dover intervenire per forza a colmare i vuoti.
Sezione III
LA COSTITUZIONE ECONOMICA
Il fattore economico nella Costituzione
Il diritto oggettivo si occupa di rapporti economici. Ci sono norme sulla proprietà dei fattori di
produzione. Ci sono norme che disciplinano i contratti stipulati nello svolgimento di attività
economiche. Ci sono norme che regolano i rapporti di lavoro. Ci sono norme che prevedono oneri
burocratici a carico delle imprese. Ci sono norme che definiscono il diritto delle società e
dell’impresa in generale. Ci sono norme che individuano forme di intervento dello Stato in ambito
economico. Senza, infine, trascurare le norme che prevedono e disciplinano imposte, tasse, tributi.
Il diritto oggettivo si occupa, dunque, del fattore economico.
economico
Un conto, però, è che se ne occupi il legislatore ordinario, vale a dire l’insieme delle istituzioni
abilitate dall’ordinamento a porre in essere fonti primarie del diritto (leggi, decreti legge, decreti
legislativi, leggi regionali). Altro è che se ne occupi la costituzione, quale fonte superprimaria del
diritto.
In effetti, nel primo caso, la disciplina del fattore economico risentirà delle vicende legate alla
alternanza politica. Ad ogni elezione si insedierà una maggioranza, o diversa da quella precedente o
66
uguale ma con qualche sfumatura differente, che avrà una propria “idea” dell’economia, e in base a
questa idea deciderà se e come regolare, con fonti primarie, le attività economiche. In altri termini,
ogni maggioranza avrà un indirizzo politico, e alla luce di questo cercherà di definire l’assetto dei
rapporti tra diritto ed economia. Pertanto, in caso di vittoria di una coalizione di centrodestra, ci si
potrà attendere l’approvazione di leggi orientate verso il mercato, la libera concorrenza, la riduzione
dell’intervento pubblico in campo economico, una disciplina dei rapporti di lavoro più sensibile alle
ragioni dell’imprenditore. In caso di vittoria di una coalizione di centrosinistra, sarà lecito attendersi
provvedimenti di segno diverso: più tutele per il lavoro, più Stato nei rapporti economici, più controlli
sulle imprese, maggiore sicurezza sociale anche a costo di aumentare le tasse. In definitiva, ad ogni
tornata elettorale si avrà un mutamento del diritto dell’economia.
Se, invece, è la stessa costituzione ad occuparsi del fattore economico, anche solo sotto forma
di princìpi generali, il diritto dell’economia si evolverà su fondamenta più stabili. Saremmo in
presenza, cioè, di alcuni “pilastri” che nessuna maggioranza, di un colore o dell’altro, potrà ignorare o
alterare. Ciò perché la costituzione è vincolante per le leggi approvate dalle maggioranze che si
avvicenderanno al potere nel corso degli anni.
Nello Stato liberale classico dell’Ottocento, le costituzioni ignorarono il fattore economico o,
comunque, ad esso dedicarono uno spazio insignificante. Il pensiero liberale era incline a considerare
lo Stato quale organizzazione preposta a garantire la sicurezza delle relazioni economiche, non a
condizionarle direttamente o in via mediata. Allo Stato il liberalismo chiede forze di polizia, tribunali,
esercito, difesa dei confini, gestione della moneta, regolamentazione dei contratti: non si aspetta certo
interventi idonei ad alterare la “spontaneità” delle relazioni economiche. Uno Stato leggero, quindi,
chiamato ad occuparsi solo delle condizioni minime di corretto, ordinato e pacifico svolgimento delle
attività economiche.
Stando così le cose, e tenuto conto anche della concezione di costituzione che si era affermata
nell’Europa continentale, la costituzione non avrebbe dovuto occuparsi del fattore economico: una
minimo.
costituzione minima per uno Stato altrettanto minimo
La situazione cambia quando i fallimenti del mercato dimostrano la necessità impellente di un
massiccio intervento dello Stato in economia allo scopo di garantire una maggiore giustizia sociale in
termini di più equa distribuzione della ricchezza. Su questo punto ci si soffermerà anche più avanti.
Sta di fatto che cambia la percezione del ruolo delle istituzioni pubbliche in campo economico. Non
più uno Stato leggero, passivo spettatore dei rapporti tra gli attori economici, bensì uno Stato
protagonista, chiamato ad intervenire per fornire beni e servizi che, altrimenti, il mercato non
offrirebbe in quanto non idonei a produrre profitto.
Se muta il ruolo dello Stato, allora cambia anche la sensibilità delle costituzioni rispetto al
fattore economico: una costituzione pesante per uno Stato altrettanto pesante.
pesante
Le carte costituzionali approvate dopo la fine della seconda guerra mondiale sono ricche di
disposizioni che riguardano direttamente o condizionano il fattore economico. In particolare, la
nostra Costituzione si occupa del fattore economico:
- l’art. 1 fonda sul lavoro la democratica Repubblica italiana;
- l’art. 2 esige anche l’adempimento dei doveri di solidarietà economica;
economica
- l’art. 3 impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che, di fatto,
impediscono il pieno sviluppo della personalità e l’effettiva partecipazione dei lavoratori alla vita
comunitaria;
- l’art. 4 definisce il lavoro come diritto/dovere per concorrere anche al progresso materiale
della società;
- il Titolo III della parte I è intitolato “Rapporti
Rapporti economici”:
economici in esso sono presenti sia norme sul
lavoro (artt. 35-40), sia norma sull’impresa
impresa (artt. 41 e 43), sulla proprietà (art. 42), e su altri profili
rilevanti dal punto di vista economico (artt. 44-47);
- tributi, imposte, tasse,
tasse sono contemplati dagli artt. 23 e 53;
67
- l’art. 81 si occupa del bilancio dello Stato e delle leggi di spesa;
- l’art. 99 prevede il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel
Cnel),
Cnel composto da esperti
e rappresentanti delle categorie produttive;
- con la riforma costituzionale del 2001 sono stati rivisti i rapporti tra la legge statale e quella
regionale (art. 117): alla prima è assegnato il compito di provvedere alla «tutela
tutela della concorrenza»,
concorrenza
alla seconda sono concessi molti spazi di intervento in campo economico;
- il nuovo art. 120 autorizza la sostituzione statale, in caso di inerzia delle Regioni e degli enti
locali, anche quando sia in gioco la «tutela dell’unità
unità economica»;
economica
- lo stesso art. 120 vieta alle Regioni l’istituzione di dazi e l’adozione di misure volte ad impedire
o ostacolare la libera circolazione di beni e persone tra i diversi territori.
La proliferazione di carte costituzionali che si occupano direttamente, e massicciamente, del
fattore economico, ha indotto molti studiosi, soprattutto in Germania, a parlare di costituzione
economica.
economica
Ebbene: qual è il senso di questo concetto ?
Al tema è dedicata la voce, redatta da M. Luciani, che potrà essere letta di qui a poco.
Prima, però, appare introdurre il tema in questi termini.
Per “costituzione economica” si potrebbe intendere l’insieme delle disposizioni che, per
l’appunto, si occupano del fattore economico, considerato in senso ampio. Tuttavia, questa
definizione avrebbe una portata meramente descrittiva,
descrittiva utile quindi a fini didattici o per
l’organizzazione del contenuto di un manuale di diritto costituzionale o di diritto pubblico
dell’economia.
In alternativa, si potrebbe pensare alla “costituzione economica” come una nozione prescrittiva,
prescrittiva
tale quindi da indurre a considerare la parte economica della costituzione come un corpo autonomo
di norme, disgiunto dal resto del testo costituzionale. Un corpo autonomo di norme, questo, in grado
di muoversi liberamente nell’ordinamento legittimando scelte del legislatore ordinario anche
disarmoniche rispetto a tutti gli altri princìpi enunciati nella costituzione.
In breve:
- la “costituzione economica” in senso descrittivo rischia di essere inutile, vuota;
- la “costituzione economica” in senso prescrittivo rischia di esse pericolosa, fuorviante.
M. LUCIANI, voce Economia nel diritto costituzionale, in Dig. IV ed., Disc. pubbl., vol. V, Utet,
Torino, 1990, pp. 373 ss.
1. La «Costituzione economica»: una formula non convincente.
La Costituzione italiana dedica ai «Rapporti economici» l’intero Titolo III della Parte I, e cioè gli artt. da
35 a 47. Questi — integrati da poche altre disposizioni (in particolare, dagli artt. 4, 53, 81 e 99 Cost.) —
comporrebbero secondo un indirizzo piuttosto diffuso la cosiddetta Costituzione economica. Con questa
espressione si possono intendere — e di fatto si intendono — almeno due cose. In una prima accezione, si usa
«Costituzione economica» (non a caso in genere tra virgolette...) solo come formula riassuntiva per indicare
sinteticamente ed allusivamente l’insieme delle norme costituzionali in materia economica. In una seconda,
per la verità poco fortunata nella dottrina italiana (che in genere dà «letture» più o meno unitarie della
Costituzione), si parla di Costituzione economica come di un complesso normativo in qualche misura
autonomo rispetto all’insieme della Costituzione, della quale peraltro sarebbe il nocciolo essenziale, il dato
realmente infungibile attorno al quale finiscono per ruotare i (viceversa) contingenti contenuti delle
disposizioni relative ai rapporti politici, sociali, ecc.
Né l’uno né l’altro di questi indirizzi — del resto spesso commisti negli scritti dei singoli studiosi — può
essere condiviso.
Le maggiori perplessità le suscita evidentemente il secondo, più netto e radicale dell’altro nelle sue
affermazioni. Anzitutto, è stato già osservato (1) che isolare una sfera dell’«economico» rispetto agli altri
contesti nei quali si esplicano le attività sociali dell’uomo è quantomeno problematico, e che
68
conseguentemente lo è ancora di più postulare un’autonomia delle disposizioni «in materia economica» (2)
all’interno di testi normativi come quelli costituzionali, che hanno l’ambizione di dettare le regole fondamentali
di un sistema sociale nella sua intierezza. La tesi presuppone in secondo luogo — più o meno avvertitamente —
una separazione, una contrapposizione fra società e politica, fra Stato e mercato, che non può essere accettata
nelle Costituzioni degli odierni Stati sociali(3). È infine, per ciò che specificamente riguarda l’esperienza
italiana, in contrasto con il diritto positivo. Una «Costituzione economica» che aspirasse ad essere realmente
autonoma, infatti, dovrebbe ruotare attorno ad almeno un principio fondamentale effettivamente «economico».
E mentre questo, ad esempio, non manca nella Legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania
(4) — che agli artt. 104a, 109 e 115 esige il raggiungimento e il mantenimento dell’equilibrio economico
generale, del gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht (5) — nulla di simile è riscontrabile da noi(6). Tutt’al
contrario: sono proprio quelle che dovrebbero fungere da norme-cardine della «Costituzione economica» — gli
artt. 41 e 42 Cost. — (7)che fanno riferimento a valori specificamente sociali (utilità sociale, fini sociali, funzione
sociale) quali condizioni e limiti (interni o esterni, non importa qui precisare) delle situazioni economiche di
vantaggio. Limiti che — come si vedrà in seguito — si ricollegano a quella disposizione evocativa di un progetto
di generale trasformazione sociale che è l’art. 3, comma 2, Cost.
Questi argomenti non possono evidentemente essere impiegati anche per la critica del primo
atteggiamento riscontrabile in dottrina(8). Questo, tuttavia, deve ritenersi egualmente pericoloso, o almeno
poco concludente. Pericoloso, perché si serve di un’espressione linguistica che — pur se usata con tutti i dovuti
distinguo — è comunque fortemente evocativa e può essere fraintesa. Poco concludente, perché se è vero —
come è vero — che la Costituzione è un tutto unitario(9), il riferimento alla Costituzione economica non ha
alcun pregio euristico.
Parlare della disciplina costituzionale dell’« economia», dunque, si può solo se non si perde di vista
l’impianto unitario della nostra Costituzione; se non si postula un’autonomia di questo settore nei confronti
degli altri oggetti delle norme costituzionali(10); se non si dimentica che le interconnessioni fra la disciplina del
sottosistema economico e quella del sistema sociale nel suo complesso sono così profonde(11), che la prima
può essere isolata solo per comodità di analisi e — comunque — non altro che in prima approssimazione.
2. La Costituzione italiana e la materia economica.
Il modello di struttura economica disegnato in Costituzione è dunque intimamente legato al sistema
costituzionale dei rapporti sociali e politici. Quali ne sono, comunque, le linee fondamentali? Si scontrano, in
proposito, due linee interpretative(12). La prima — maggioritaria — rileva nella Costituzione la compresenza di
una molteplicità di ispirazioni ed ideologie economiche (segnatamente, la socialista, la cattolica e la liberale),
ciascuna delle quali è incapace di prevalere sulle altre(13), con cui deve invece armonizzarsi in forme
compromissorie(14). La seconda — che accusa l’altra di essere «oggetto di una stanca e trita ripetizione» —
afferma invece che «non vi sono disposizioni normative accolte nel testo della Costituzione le quali... non
possano essere con tutta naturalezza ricondotte nel quadro di un’accettazione piena del modello economico
della democrazia sociale», e cioè del modello dell’«economia mista» (15), che in Assemblea costituente
sarebbe stato sostanzialmente imposto alle sinistre dalla maggioranza centrista, e non sarebbe in nulla originale
e diverso da quello di qualunque democrazia occidentale.
Ora, non v’è dubbio che il modo di produzione disegnato dalla Costituzione sia quello capitalistico,
sicché, al contrario di quanto ha scritto qualcuno(16), l’introduzione del modo di produzione socialista non
sarebbe possibile restando all’interno del quadro costituzionale(17). E non meno certo è che la Costituzione
abbia allo stesso tempo circondato l’iniziativa economica privata di incisivi limiti e controlli (affiancandole
anche una significativa iniziativa pubblica), sicché può a ragione parlarsi di un riconoscimento costituzionale
dell’«economia mista». Questo, però, non può far dimenticare alcuni dati essenziali, che caratterizzano
specificatamente il modello costituzionale italiano. Anzitutto che, se è pur vero che le aspirazioni delle sinistre
furono alla Costituente in qualche modo ridimensionate — specie dopo la reiezione dell’emendamento
Montagnana — (18)ricerche recenti hanno mostrato come in esse — anche e forse soprattutto in campo
comunista — l’accettazione del principio dell’economia mista fosse maturata già prima del (e a prescindere dal)
dibattito in Assemblea costituente (nel corso del quale, peraltro, non mancarono significative conferme)(19), e
sulla base di realistiche considerazioni sulle condizioni interne del Paese e sulla sua collocazione
internazionale(20). In secondo luogo, che è assai dubbio che i risultati del dibattito alla Costituente sarebbero
stati proprio quelli che conosciamo, se anche la maggioranza centrista non avesse dovuto fare i conti con un
contraddittore e non avesse saputo di non poter avere mano interamente libera(21). Da ultimo, che per quanto
sia esatto dire che è l’economia mista la struttura su cui poggiano praticamente tutte le democrazie sociali, ciò è
69
del tutto insufficiente per la loro comprensione. Il comune denominatore che così le unisce è infatti troppo
tenue: il genere «economia mista», infatti, può ricomprendere tali e tante specie, e soprattutto è compatibile
con assetti dei rapporti sociali così vari, che evidenziarne la presenza serve a poco(22). Come negare, ad
esempio, la peculiare ricchezza del catalogo dei diritti sociali esibito dalla Costituzione italiana, che la rende
imparagonabile, per menzionare una stregua importante, alla Legge Fondamentale di Bonn(23)? E come non
cogliere la «forza» peculiare di quei diritti, sempre più chiaramente consolidati da una giurisprudenza
costituzionale molto audace(24), anche perché non impacciata da ostacoli come quelli che sono presenti ad
esempio nella Costituzione spagnola(25)? Come non notare, infine, che la normativa costituzionale sui diritti
sociali è una chiave di lettura essenziale di quella in materia economica, per i legami strettissimi che come detto
le uniscono, e sui quali torneremo fra poco?
In realtà, ci si può accontentare di evidenziare la natura «mista» della struttura economica propria degli
Stati sociali, soltanto se, da un lato, si ritiene che il modello dell’economia mista sia più unitario di quanto in
effetti non mostri di saper essere(26), e dall’altro si finisce per accogliere — anche se inavvertitamente — la tesi,
già criticata in precedenza, della tendenziale autonomia delle norme in materia economica rispetto alle altre
norme costituzionali. È proprio la complessità dei fenomeni economici e sociali, dunque, che suggerisce di
battere altre strade.
3. Norme costituzionali in materia economica e valori sociali.
Lo stretto collegamento con gli interessi sociali che è presente in due norme centrali come gli artt. 41 e
42 Cost. è significativamente una costante nella gran parte delle norme costituzionali in materia economica.
Così come l’art. 41 richiama l’«utilità sociale» (e i «fini sociali») e l’art. 42 la «funzione sociale», infatti, l’art. 43
si riferisce all’«utilità generale» e all’«interesse generale» sottesi alle nazionalizzazioni e alle
collettivizzazioni(27); l’art. 44 agli «equi rapporti sociali» alla cui instaurazione deve mirare la regolamentazione
della proprietà terriera; l’art. 45 alla «funzione sociale» della cooperazione; l’art. 46 alla «elevazione economica
e sociale» del lavoro che dovrebbe derivare dalla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende; l’art.
99 alla materia «economica e sociale» cui si estende la competenza del CNEL.
Questa insistenza della Costituzione nel richiamare interessi sociali nell’ambito della disciplina
dell’economia dà anzitutto quella preziosa indicazione in negativo che abbiamo già sottolineato, e cioè che la
normativa in materia economica non si ispira ad una logica autonoma e differenziata da quella che caratterizza
l’intera Costituzione nel suo complesso. In positivo, poi, essa sollecita la definizione di quale sia la realtà cui la
Costituzione si riferisce predicando della qualifica di «sociali» certi interessi che fanno sentire il loro peso
(anche) in materia economica.
A questo proposito, sembra anzitutto certo che la Costituzione intenda per «sociale» ciò che è proprio
della società tutta intiera (28) e non di una sua parte soltanto (29) o dello Stato e dei poteri pubblici(30).
Inoltre, la società i cui interessi sono posti dalla Costituzione al centro della disciplina dei rapporti economici
non è la società dell’«oggi costituzionale» (e cioè dal momento in cui la Costituzione veniva materialmente
redatta) e non è neppure la società del futuro, della quale manca in Costituzione il compiuto disegno, ma
quella che è protagonista del processo di trasformazione indicato dall’art. 3, comma 2(31). Così, sarà
socialmente «utile» nella logica dell’art. 41 solo ciò che corrisponderà alle esigenze della trasformazione (di
quella trasformazione che è voluta dell’art. 3, comma 2); saranno «equi» ai sensi dell’art. 44, tra i rapporti
sociali connessi all’assetto della proprietà terriera, non tanto quelli che verranno ritenuti tali secondo la
coscienza sociale d’oggi(32), quanto quelli la cui instaurazione si mostrerà funzionale alle esigenze del processo
ispirato dall’art. 3, comma 2, ecc. In altri termini, l’efficienza economica non è, in sé, un valore(33), e la
disciplina dell’economia che la Costituzione vuole sia dettata dal legislatore ordinario, non può essere ispirata
solo dall’intento di perseguire scopi immediatamente economici (aumento della produzione, equilibrio
finanziario, ecc.), ma deve essere invece guidata dalla necessità di attivare e favorire il processo di
trasformazione sociale le cui grandi linee sono tracciate dall’art. 3, comma 2.
Tutto questo, si badi, non vuol dire che la Costituzione sia indifferente nei confronti delle esigenze di
buon funzionamento del sistema economico e consenta al legislatore ordinario di compiere qualunque scelta
che produca effetti antieconomici(34). Il progresso economico, infatti, è — realisticamente — una condizione
necessaria, anche se non sufficiente, della rimozione degli «ostacoli di ordine economico e sociale, che
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Non è
meno evidente, però, che in molti casi concreti le necessità del mero calcolo economico (della cui oggettività si
può del resto sempre dubitare) possono essere in contraddizione con il raggiungimento degli obiettivi indicati
70
dal citato comma 2 dell’art. 3 Cost. In queste evenienze sarà dunque compito del legislatore ordinario
assicurare la salvaguardia di quegli obiettivi, anche se con il minor pregiudizio possibile dell’efficienza e della
stabilità economica: già Laski, del resto, ammoniva che «liberty needs an expanding economy as its primary
condition» (35).
Nell’ineguale bilanciamento fra le ragioni del calcolo economico e quelle (connesse ma come detto
talora confliggenti) dello sviluppo sociale, sta dunque quell’originalità della Costituzione italiana che taluno
nega: un’originalità che è al contrario espressamente implicata dalla norma-guida dettata dal comma 2 dell’art.
3 Cost., vero e proprio token caratterizzante della nostra Carta fondamentale(36).
Questa ispirazione di fondo della Costituzione si riverbera con particolare nettezza sul regime delle
situazioni economiche di vantaggio. Qui, a prima vista, la Costituzione sembra soffrire di una strisciante
contraddizione. Da un lato, infatti, le situazioni economiche di vantaggio, in quanto elemento costitutivo della
struttura che assicura il progresso economico che è funzionale alla trasformazione sociale, paiono così
intimamente collegate a questa da non potere e dovere essere limitate allo scopo di favorirla. Dall’altro, in
quanto espressione delle diseguaglianze di fatto che la Costituzione si propone di eliminare, paiono il più ovvio
dei candidati a subire limiti in funzione del raggiungimento degli obiettivi costituzionali. La contraddizione,
però, è solo apparente. Abbiamo già detto, infatti, che le esigenze del puro progresso economico sono spesso
in disarmonia con quelle di sviluppo e crescita sociale che in teoria dovrebbero esserne invece favorite. Ove
ciò avvenga, s’è pure visto, sono le seconde a dover comunque prevalere, e conseguentemente a potersi
affermare (sia pure nei limiti dei principi di non eccessività e proporzionalità) a spese non solo delle esigenze
«oggettive» del sistema economico, ma anche di quelle soggettive dei titolari delle singole situazioni di
vantaggio(37). La chiave di lettura essenziale della disciplina di queste ultime è dunque obbligata: la misura
delle loro garanzie e dei loro limiti è data soltanto dalla corrispondenza o meno con le esigenze costituzionali
della trasformazione, sicché — pure esclusa ogni «funzionalizzazione» delle libertà economiche — le une e gli
altri in tanto si giustificano, in quanto siano preordinati al perseguimento di quelle esigenze. Questo è un punto
molto importante, perché qui si chiarisce non solo che le situazioni economiche di vantaggio possono essere
compresse in funzione della protezione dei valori costituzionali ricordati, ma anche che sono proprio e
soltanto questi (e gli altri di volta in volta menzionati quali valori-guida del campo di attività di ciascuna
situazione economica di vantaggio o con esso interferenti)(38), i fattori che giustificano l’imposizione dei limiti
nei confronti di quelle situazioni(39). Sicché — non proprio paradossalmente — la soggezione di queste alle
esigenze imposte da quei valori costituzionali, finisce per essere allo stesso tempo una garanzia, perché esclude
che una limitazione possa essere giustificata dal perseguimento di interessi d’altro genere e di minore pregio.
4. Le situazioni economiche di vantaggio.
La disposizione che più di ogni altra segna l’ancoraggio costituzionale del modo di produzione
capitalistico (nella forma dell’«economia mista») è certo l’art. 41 Cost.(40). Dall’art. 42, in effetti, una scelta di
questo tipo non è chiaramente desumibile, perché esso potrebbe tranquillamente essere letto come se
consentisse al legislatore ordinario di limitare la garanzia dell’appropriazione privata a quella dei soli beni d’uso
personale, negandola invece per ciò che riguarda i mezzi di produzione o i beni destinati allo scambio. In
assenza della qualificazione dell’iniziativa economica privata come «libera» da parte del comma 1 dell’art. 41, la
disciplina della proprietà privata dettata dall’art. 42 sarebbe dunque aperta anche alla più riduttiva delle
interpretazioni. E perciò molto importante definire l’ambito di operatività delle due disposizioni, identificando
le situazioni soggettive che ne sono — rispettivamente — oggetto.
Chi volesse, a questo proposito, valersi delle indicazioni offerte dalla giurisprudenza costituzionale,
resterebbe deluso. Sin dalle sue più vecchie decisioni, infatti, la Corte costituzionale ha lasciato indistinte la
sfera degli atti di esercizio di iniziativa economica e quella degli atti di mero godimento della proprietà,
sovrapponendo le indicazioni normative degli artt. 41 e 42 Cost. ed evocando di volta in volta le une piuttosto
che le altre sulla base di opzioni lasciate ad un sostanziale empirismo. Di recente, in verità pare cogliersi
qualche segnale di ripensamento (41) — la Corte ha meglio chiarito, infatti, il rapporto dell’art. 41 con l’art. 42
e con l’art. 44 Cost. — (42), ma è indubbio che la vivacità e la ricchezza del dibattito sviluppatosi in dottrina
hanno trovato scarsa eco nella giurisprudenza costituzionale(43).
Questo sembra vero soprattutto per ciò che riguarda l’analisi del concetto di iniziativa economica
privata. Come è noto, la dottrina è, su questo punto, assai divisa. Così, mentre alcuni affermano che l’iniziativa
si identifica con qualunque atto che esprime l’intento di raggiungere un fine economicamente rilevante(44),
altri ritengono che sia soggetto attivo di vera iniziativa economica solo chi esercita attività di impresa(45), ed
altri infine — ed è posizione in certo senso intermedia — che l’iniziativa economica di cui parla l’art. 41 Cost. sia
71
solo quella di colui che promuove un’attività di produzione (e non di mera erogazione) finalizzata allo
scambio(46). La giurisprudenza costituzionale, per suo canto, ha mostrato di aderire sostanzialmente alla prima
di queste tesi, ma come premesso l’ha fatto in modo piuttosto disattento e senza prospettarsi espressamente le
diverse alternative interpretative elaborate in dottrina(47).
In realtà, isolare l’iniziativa economica della quale parla il comma 1 dell’art. 41 Cost. entro l’insieme
indifferenziato degli atti economicamente rilevanti sembra tanto corretto quanto inevitabile. Corretto sul piano
teorico, perché non farlo significa ottundere le diversità che intercorrono fra atti che — pur se tutti «economici»
— sono incomparabili dal punto di vista dei loro contenuti, come ad esempio la decisione di investire i capitali
necessari per la creazione di una nuova impresa e quella di alienare la propria forza-lavoro per assicurarsi i
mezzi necessari per mantenere sé e la propria famiglia. Inevitabile sul piano del diritto positivo, perché è la
stessa Costituzione a differenziare entro la (non più unitaria) sfera dell’«economico», distinguendo fra attività
ricollegabili all’iniziativa economica in senso proprio, attività di prestazione di lavoro subordinato o d’opera
intellettuale, attività di godimento della proprietà privata. E siccome ciascuna di queste attività gode di garanzie
e soffre di limiti suoi propri, la distinzione fra l’una e l’altra assume un rilievo non solo teorico, ma anche ricco
di riflessi pratici.
Non meno divisa è la dottrina costituzionalistica italiana in riferimento alla risposta da offrire al quesito
sul rapporto fra commi 1 e 2 dell’art. 41 Cost. Se alcuni, infatti, ritengono che l’oggetto di entrambi sia
identico, essendo impossibile distinguere fra l’«iniziativa» cui si riferisce il comma 1 ed il suo «svolgersi» che è
invece disciplinato dal secondo(48), altri vanno in esattamente opposto avviso, ritenendo che una cosa sia
l’oggetto della garanzia di cui al comma 1, e un’altra l’oggetto dei limiti previsti dal secondo(49). In questo caso,
la giurisprudenza costituzionale si è mostrata più decisa, ed ha abbracciato con chiarezza la prima delle due
opinioni appena descritte(50). Questa sembra tuttavia da respingere, dimentica com’è dei dati costituzionali
testuali e del fatto che — ove altrimenti si ritenesse — il secco riconoscimento della «libertà» dell’iniziativa non
avrebbe senso. È proprio la distinzione fra atto di impulso di un’attività economica volta alla produzione (51) e
atti di svolgimento di quella stessa attività, che può infatti dar ragione dei diversi accenti del comma 1 e del
comma 2 dell’art. 41 Cost. e della imparagonabilità dei limiti dei secondi rispetto ai limiti del primo.
Ed infatti, mentre lo svolgimento dell’attività economica privata può essere anche oggetto di limiti
positivi, e cioè di veri e propri obblighi di «facere», lo stesso non può accadere per l’atto di iniziativa(52):
proprio in virtù della garanzia apprestata dal comma 1 dell’art. 41 Cost., infatti, nessuno può essere tenuto ad
investire capitali per intraprendere un’attività produttiva contro la propria volontà o a mantenere in vita
un’attività economica se ciò non risponde più al suo vantaggio.
Più meditata e consapevole — anche se non per questo più condivisibile — è stata la giurisprudenza
costituzionale in riferimento alla nozione costituzionale di proprietà. Certo, quella giurisprudenza non esprime
un modello di proprietà che sia originale e identificato da contorni ben definiti(53). Essa, tuttavia, indica
almeno quali sono gli strumenti sulla scorta dei quali la Corte pensa che un modello del genere possa essere
costruito. Sin dalle storiche sentt. nn. 6 del 1966 e 55 e 56 del 1968(54), infatti, il giudice costituzionale ha
ritenuto che la Costituzione garantisse la proprietà in quanto istituto e proteggesse allo stesso tempo il suo
contenuto essenziale. In particolare la sent. n. 55 del 1968, poi, chiariva — come già anticipato — (55)che tale
contenuto essenziale era da ritenersi coincidente con quello ascritto alla proprietà dalla coscienza sociale
prevalente. Quest’ultima, a sua volta, non sarebbe stata costituita da un sistema di credenze socialmente
dominanti, bensì determinata dal diritto positivo: il contenuto essenziale della proprietà sarebbe stato infatti
offerto solo da ciò che «è connaturale al diritto dominicale, quale viene riconosciuto nell’attuale momento
storico» dallo stesso ordinamento giuridico.
In questo modo, la Corte costituzionale operava un ancoraggio del contenuto essenziale della proprietà
al diritto positivo e non ad una pretesa nozione (ideo!)logica di appartenenza privata, rifuggendo così da
qualunque tentazione di impronta giusnaturalistica. Alcune pronunce successive, però, proponevano una
lettura assai più radicale di quei precedenti, e finivano — a ben vedere — per identificare il contenuto essenziale
con ciò che inerisce «naturaliter» a quella situazione soggettiva che chiamiamo diritto di proprietà e che non
sarebbe tale senza quei tratti distintivi(56). Nelle decisioni del 1966 e del 1968, infatti, la Corte aveva prestato
attenzione soprattutto agli aspetti formali delle garanzie della proprietà. Si poteva invero desumere da quella
giurisprudenza che al legislatore era consentito — sì — conformare il diritto di proprietà secondo le proprie
scelte discrezionali, ma gli era precluso trattare in modo diseguale situazioni proprietarie omogenee, e
soprattutto violare il principio della riserva di legge, lasciando all’Amministrazione il potere (discrezionale,
appunto) di stabilire il regime delle singole proprietà, che avrebbe invece dovuto esercitare in prima
persona(57).
72
Secondo alcuni(58), il giudice costituzionale sarebbe passato invece, con la giurisprudenza successiva, da
una concezione funzionale ad una concezione strutturale della proprietà, e cioè da una concezione nella quale
la comprensione della disciplina costituzionale ruota attorno al concetto di funzione sociale, ad un’altra in cui
ciò che conta è la «natura» del diritto di proprietà in sé e per sé. L’osservazione, pur acuta, può essere
condivisa soltanto per ciò che attiene alla sua seconda parte: infatti, per quanto la giurisprudenza della fine
degli anni ‘60 fosse stata poco sensibile al fascino della nozione di proprietà intesa sub specie aeternitatis, fu
nondimeno anche poco attenta al rapporto tra funzione sociale e diritto dominicale, sicché il ruolo della prima
restò anche allora sullo sfondo. In altre parole, quella giurisprudenza non seguì né la via della concezione
funzionale, né quella della concezione strutturale, ma si limitò — tacendo sostanzialmente sull’una e sull’altra —
ad elaborare una serie di garanzie formali e procedimentali del diritto di proprietà nei confronti dell’intervento
dei poteri pubblici (rispetto della riserva di legge, obbligo di disciplinare i beni privati per categorie e non
singulatim, ecc.). Certo, è chiaro che il ruolo svolto dal principio della funzione sociale poteva essere più libero
ed incisivo all’interno della logica di quella giurisprudenza piuttosto che di quella successiva. Ciò non toglie,
però, che neppure la prima seppe fare ciò che davvero andava fatto: sciogliere il nodo del concetto di funzione
sociale e chiarire in che modo questa si rapportasse al diritto di proprietà. E che questo fosse il compito
decisivo, è palese per chi condivida quanto già detto sul collegamento fra normativa costituzionale in materia
economica e valori sociali (che la Costituzione definisce) fondamentali.
È proprio questo vizio d’origine della stessa giurisprudenza del 1966-1968, del resto, che spiega
l’insoddisfazione che si prova di fronte al suo aspetto più gravido di conseguenze teoriche e pratiche:
l’accoglimento della nozione di espropriazione sostanziale. Non è questa la sede per discuterne, e bastino ora
da un lato il rinvio alla voce «Proprietà» nonché a quelle relative all’espropriazione(59), dall’altro la
considerazione che proprio le decisioni sulle espropriazioni sostanziali e sulla misura dell’indennizzo sono
state fra quelle nelle quali la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di incidere più pesantemente sugli
equilibri del sistema economico.
5. Gli strumenti del governo pubblico dell’economia secondo la Costituzione.
La misura delle garanzie e la sostanza dei limiti delle situazioni economiche di vantaggio sono date,
dunque, dal modo in cui esse si raccordano con il progetto costituzionale di trasformazione sociale. È quanto
ci indicano tutti gli elementi esaminati in precedenza, ed è quanto conferma anche la protezione accordata dal
comma 2 dell’art. 41 — oltre che alla «sicurezza» ed alla «libertà» — alla «dignità umana». Il riferimento ad essa,
infatti, non può non valere da richiamo dell’analogo concetto di «dignità sociale» presente nell’art. 3, che
rappresenta un po’ la cerniera fra commi 1 e 2 di quell’articolo(60), epperciò funge da raccordo fra le garanzie
delle libertà individuali tradizionali e le garanzie del (realistico svolgersi del) disegno costituzionale di
trasformazione.
Oltre queste indicazioni sostanziali, però, la Costituzione sembra volerne offrire altre anche in
riferimento alle modalità in cui il potere pubblico può, governando i processi economici, inverare il disegno
dell’art. 3, comma 2, Cost. La disposizione-chiave, in proposito, sembra l’art. 41, comma 3, a tenor del quale
«la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali». Questa disposizione mostra chiaramente che la Costituzione
ritiene necessario un «governo» pubblico dell’economia: il mercato, da solo, non è ritenuto in grado di
assicurare il pieno affermarsi dei valori costituzionali. E la regolamentazione pubblica, a sua volta, può e deve
avere ad oggetto qualunque «attività economica pubblica e privata», senza essere limitata soltanto ad alcuni
settori economici (come potrebbero essere ad esempio quelli indicati dall’art. 43 Cost.).
Gli strumenti attraverso i quali il governo pubblico dell’economia può essere esercitato sono i più vari,
come dimostra l’impiego di un termine così generico ed onnicomprensivo come «controlli». Cionondimeno, la
Costituzione menziona espressamente e vede con favore particolare il ricorso a quello strumento organico di
governo dell’economia che sono i «programmi».
Anche su questo punto è bene qui rinviare ad altra voce [v. infatti → piano economico e pianificazione
(diritto civile)], e limitarsi a qualche semplice notazione sui punti di rilievo più generale, che aiutino la
ricostruzione, che qui si tenta, del rapporto complessivo fra Costituzione ed economia. Anzitutto, è da dire che
l’uso del plurale «programmi» in luogo dei singolari «piano» o «programma» o «programmazione » non ha
alcuno specifico significato normativo(61). È infatti la stessa reciproca stretta interdipendenza dei fenomeni
economici, che reclama una loro visione unitaria e consente che essa sia oggettivata in un non meno unitario
documento anziché in più documenti settoriali(62). I «programmi», poi, sono funzionalizzati al raggiungimento
dei «fini sociali», e poiché quei fini — in quanto «sociali» nel senso fatto proprio dall’art. 3, comma 2, Cost. —
73
convergono tutti nell’obiettivo primario e unificante di costruire una società «in progress», è logico che possano
(e forse debbano) essere perseguiti con l’ausilio di strumenti non disarticolati. Anche ad arrestarsi al piano
puramente letterale, comunque, l’indicazione offerta dall’uso del plurale non sarebbe univoca, perché ove
davvero lo fosse dovrebbe esserlo allora anche quella fornita dall’uso del singolare «legge» per identificare l’atto
destinato a contenere i programmi.
In realtà, la tesi secondo la quale la Costituzione non conferirebbe diritto di cittadinanza ad un piano
economico generale e nazionale, ma solo a piani settoriali e/o territorialmente definiti, pare nascondere il
timore che si verifichi — in caso contrario — uno slittamento verso forme di più o meno intenso dirigismo(63).
Ma si tratta di un timore ingiustificato, perché da un lato i lavori preparatori (…), dall’altra lo stesso testo della
Costituzione, dimostrano che la programmazione cui essa pensa è una programmazione anzitutto democratica
e partecipata nella fase della definizione dei suoi obiettivi, ed in secondo luogo volta soprattutto a promuovere
ed indirizzare l’attività dei privati (non già addirittura escludendo, ma comunque) contenendo il ricorso a poteri
di tipo autoritativo(65). Valga, in proposito, il richiamo agli artt. 45, cpv., 45, comma 2, 47, ma valga soprattutto
il riferimento allo stesso art. 41, che mostra in filigrana il chiaro intento di contenere sin dove è possibile gli
interventi autoritativi sul mercato(66).
La natura democratica della programmazione disegnata dall’art. 41 Cost. e la fondamentalità delle scelte
di programma in materia economica, danno infine solido fondamento alla tesi secondo la quale il riferimento
alla «legge» ha qui ad oggetto anzitutto la legge parlamentare, prima che gli atti normativi del Governo ad essa
«equiparati» (67). Con la conseguenza che — conformemente alla logica generale del sistema — (68)il
Parlamento deve predeterminare almeno i principi della normazione e della azione amministrativa (volta in
concreto a indirizzare e coordinare le attività economiche) del Governo(69).
6. La giurisprudenza costituzionale e il sistema economico.
L’inesistenza di una protezione, in Costituzione, dell’interesse allo sviluppo o all’equilibrio economico
in sé e per sé, che si è mostrata in precedenza, emerge con minore nettezza nella giurisprudenza della Corte
costituzionale, nella quale è avvertibile qualche incertezza e qualche ambiguità. Va notato, infatti, che a fronte
di una numerosa giurisprudenza sull’art. 41 Cost. che fa esattamente rientrare nel concetto di utilità sociale
soprattutto interessi correlati alla crescita della società nel suo complesso piuttosto che all’efficienza
dell’economia qua talis, si collocano alcune decisioni più sensibili alla protezione di interessi puramente
economici(70), le quali fanno dubitare che la Corte abbia saputo avvertire che il sistema economico disegnato
in Costituzione non è autosufficiente ed autocentrato, ma ruota attorno a (ed è definito nei suoi contorni da)
valori ad esso esterni(71). Nonostante queste oscillazioni, comunque, è senz’altro l’indirizzo più corretto, che si
rivela prevalente. Stanno a testimoniarlo non solo, direttamente, le decisioni che assumono quali parametri gli
artt. 41 e 42 Cost., ma anche e soprattutto quelle (già ricordate) (72)sui diritti sociali. Va poi sottolineata
l’assenza, nella giurisprudenza costituzionale, dell’idea — essenziale come visto perché si abbia vera
«Costituzione economica» — del riconoscimento in Costituzione di un saldo principio-guida di politica
economica fondato appunto sulle sole ragioni dell’economia. Lo mostra con chiarezza l’interpretazione che la
Corte ha offerto dell’art. 81, comma 4, Cost., in ordine alla politica della spesa pubblica, «che deve essere
contrassegnata non già dall’automatico pareggio del bilancio, ma dal tendenziale conseguimento dell’equilibrio
tra le entrate e la spesa» (73). Ed è proprio l’incertezza di contenuto di quel «tendenziale equilibrio»,
esattamente notata dalla dottrina(74), che apre le porte ad una vasta pluralità di scelte di politica della spesa (ivi
compresa quella del disavanzo)(75), eliminando perciò in radice qualunque «principio» autonomo di pur
minimale governo dell’economia.
Questi indirizzi giurisprudenziali avrebbero dovuto portare evidentemente ad una svalutazione da parte
della Corte delle esigenze strutturali del sistema economico ed alla loro subordinazione alle altre, diverse
(politiche, sociali, ecc.), positivizzate in Costituzione. Con essi sembra perciò in contraddizione l’altra, non
meno nota e consolidata giurisprudenza che vuole la Corte particolarmente cauta nell’adozione di decisioni
che non siano «kostenlose», almeno nei momenti storici in cui la contingenza economica non è florida. Tutti
sanno, a questo proposito, che la giurisprudenza è stata sempre assai sensibile nei confronti dei periodi di crisi
economica, nel corso dei quali ha mostrato una notevole indulgenza nei riguardi dell’inattuazione legislativa dei
compiti di elevazione dei settori meno fortunati della società dal punto di vista culturale, sociale, ecc. Un’intera
stagione della giurisprudenza costituzionale, addirittura, è stata profondamente segnata dall’emergenza
economica(76), che ha indotto un vistoso appannamento della tutela dei diritti sociali (77) ed in generale una
perdita del peso complessivo del giudice costituzionale nel sistema. E la memoria di quella fase è tanto viva,
che nonostante la nuova realtà dell’economia italiana — in via di principio puntualmente recepita dalla
74
giurisprudenza costituzionale, che vive un momento di grande incisività e coraggio (78) — non mancano ancora
oggi decisioni che scivolano — per giustificare l’assolvimento di scelte legislative di dubbia correttezza — nel
richiamo della «crisi», dell’«emergenza», della «difficoltà» della contingenza economica.
Sembra, dunque, che vi sia una contraddizione. Ma questa, in effetti, sarebbe reale soltanto se la ragione
dell’atteggiamento della Corte appena descritto fosse da rinvenire nell’attenzione per le esigenze dell’economia
in sé considerate; come se il giudice costituzionale — cioè — dicesse: il costo della protezione di certi diritti
costituzionalmente riconosciuti è tale, che garantirla a dispetto di tutto significherebbe distruggere già precari
equilibri economici e compromettere il valore dell’efficienza e della stabilità del sistema economico nel suo
complesso. Probabilmente, però, le cose sono più complicate, ed il ruolo decisivo è stato giuocato da altri due
fattori. Anzitutto, dalla delicatezza della legittimazione della Corte costituzionale: questa, non potendo essere la
legittimazione democratica tradizionale, va delicatamente costruita e costantemente ricostruita(79), e la
disinvoltura, l’audacia del giudice costituzionale in fasi storiche nelle quali la stessa tenuta dei poteri
democraticamente legittimati è messa a dura prova(80), poggerebbero su basi troppo fragili. In secondo luogo,
è presumibile che si rifletta qui, sull’agire della Corte, la relativa doppiezza dell’atteggiamento della
Costituzione stessa nei confronti dell’economia. Come abbiamo già visto, infatti, il buon funzionamento del
modo di produzione capitalistico accolto (nella forma dell’«economia mista») dalla Costituzione, è inteso sia
come condizione di fatto del progresso sociale (epperciò della realizzazione del progetto disegnato dall’art. 3,
comma 2, Cost.), sia come suo potenziale ostacolo, come quello che consente la produzione di diseguaglianze
di fatto che la Costituzione vorrebbe invece cancellare. La cautela della Corte nei momenti di crisi economica,
la sua parallela audacia in occasione di una contingenza favorevole, potrebbero dunque essere interpretate
anche come una spia del fatto che il bilanciamento (pur sempre ineguale) fra le ragioni dello sviluppo
economico e quelle dello sviluppo sociale è in qualche modo variabile, e tende ad oscillare in favore delle
prime, quando il loro sacrificio potrebbe essere troppo grave o addirittura senza ritorno.
7. La disciplina costituzionale dell’economia alla prova del tempo.
A quarant’anni dalla loro entrata in vigore, le norme costituzionali in materia economica mostrano
ancora una discreta tenuta. Si possono formulare due ipotesi opposte, per spiegare le ragioni di questa
perdurante vitalità. Si può, così, ritenere che la normativa costituzionale in materia economica non rechi segni
del tempo troppo vistosi perché, a ben vedere, è stata sempre ai margini del concreto farsi dei fenomeni reali,
che hanno obbedito a logiche loro proprie, ben distanti da quella che mosse in origine la Costituzione(81).
Sarebbe perciò la sua stessa astrattezza e distanza dalla realtà che la renderebbe insensibile all’evolversi di
questa, assicurandone una tenuta che si risolve in effetti in debolezza e carenza di incisività. E si può, tutt’al
contrario, pensare che la tenuta delle norme costituzionali sia figlia della loro intrinseca duttilità, che le pone al
riparo dalle trasformazioni del loro oggetto, che sono comunque in grado di «governare».
In entrambe queste possibili risposte c’è un grumo di verità.
Nella prima, perché l’andamento dei fenomeni economici ha seguito chiaramente linee di sviluppo
fortemente condizionate da condizionamenti oggettivi, sempre più spesso riconducibili — fra l’altro — agli
equilibri degli assetti internazionali. Nella seconda, perché almeno per ciò che attiene alla disciplina del lavoro
(82) l’incidenza della normativa costituzionale si è avvertita con chiarezza, favorita anche da una giurisprudenza
costituzionale ben più sicura e convincente di quella che si è maturata in riferimento alle situazioni economiche
di vantaggio. Ma ciò che conta, soprattutto, è che la disciplina costituzionale dell’economia ha tenuto
soddisfacentemente proprio in virtù del suo collegamento con la Costituzione nel suo complesso;
collegamento imputabile specialmente al raccordo assicurato dall’art. 3, comma 2, Cost. La tenuta della
disciplina dell’economia, in altri termini, è la tenuta di tutta la Costituzione, e le sorti dell’una sono largamente
le sorti dell’altra.
Il problema, a questo punto, è dunque quello della vitalità della Costituzione nel suo complesso e della
sorte che sarà riservata ai tentativi di delegittimarla che da qualche tempo e da più parti vengono compiuti(83).
Tentativi che, se pure si muovono soprattutto sul terreno della disciplina costituzionale delle istituzioni di
Governo, finiscono tuttavia per investire la Costituzione tutta intera, per il nesso-inscindibile che lega la sua
parte «organizzativa» a quella «sostanziale» (84). Su questo punto, però, solo il futuro potrà darci risposte
significative.
Nonostante questa complessiva vitalità, comunque, l’edificio costituzionale della disciplina
dell’economia presenta per non pochi aspetti crepe vistose. Per ricordare solo alcuni fra i punti principali, va
anzitutto sottolineata la mancanza di un chiaro principio costituzionale in materia di concentrazioni e di
oligopoli privati. Proprio questa mancanza rende più complessa l’opera di elaborazione di un’efficace
75
normativa antitrust, tuttora insoddisfacente sia in generale (85) sia come normativa speciale in settori
particolarmente delicati(86). È poi evidente la arretratezza dell’art. 47, comma 1, che abbandona l’attività
creditizia e finanziaria ad una quasi assoluta assenza di principi(87). Lo stesso può dirsi per l’art. 47, comma 2,
che affronta in modo alquanto approssimativo un tema così importante come quello del diritto all’abitazione
(ciò che tuttavia non ha impedito, di recente, alla Corte costituzionale, di elaborare un’incisiva giurisprudenza
in materia)(88). Anche la normativa in materia tributaria meriterebbe, infine, qualche integrazione e
puntualizzazione, soprattutto in considerazione della notevole timidezza della giurisprudenza costituzionale,
che tra l’altro non sembra ancora avere offerto una definizione convincente del concetto-chiave di capacità
contributiva, attorno al quale ruota un po’ tutto l’art. 53 Cost.(89).
L’evoluzione della costituzione economica italiana
In un libro di grande successo (La nuova costituzione economica, Laterza, Roma-Bari, 1997),
Sabino Cassese ha proposto una successione cronologica per descrivere la transizione dalla “vecchia”
alla “nuova” costituzione economica.
La “vecchia” costituzione economica è stata suddivisa nei seguenti periodi.
1) Lo Stato liberista (dal 1861 alla fine del XIX Secolo). Questo periodo, che prende avvio
dall’unificazione del Regno d’Italia, retto dallo Statuto concesso da Carlo Alberto, re di Sardegna, nel
1848, è stato caratterizzato dai seguenti elementi.
unificazione legislativa.
a) Creazione di un mercato nazionale attraverso l’unificazione
legislativa Le istituzioni del
neonato Regno d’Italia adottarono un codice civile (1865) e un codice del commercio
(1865, poi sostituito nel 1882). Questo obiettivo fu perseguito anche attraverso l’estensione
a tutto il territorio nazionale della legislazione piemontese, che aveva visto come grande
ispiratore Cavour, cui si ascrive l’idea di amministrazione che per decenni e in parte ancora
oggi caratterizza l’esperienza italiana, viene estesa all’intero territorio nazionale. Al pari, in
armonia con l’imperante ideologia liberale, la proprietà privata assurge a diritto
fondamentale della persona e a pilastro del sistema economico.
b) Difesa del mercato attraverso il protezionismo doganale.
doganale Può di primo acchito apparire
lontano dai princìpi liberali, ma lo Stato liberista ha provveduto alla protezione del nascente
mercato unico attraverso l’introduzione di tariffe doganali e altre misure equivalenti al fine
di tutelare i prodotti nazionali in competizione con i beni importati.
c) Privatizzazioni.
Privatizzazioni Lo Stato liberista procedette ad una ragguardevole alienazione del demanio,
con conseguente trasferimento della proprietà di terreni e altri beni già pubblici ai privati, in
vista di un alleggerimento dello Stato e di un più efficiente utilizzo di tali beni. Mancò, in
questo periodo, una pesante macchina statale di governo dell’economia, in quanto alle
istituzioni pubbliche furono assegnati i tradizionali compiti di ordine pubblico, di difesa dei
confini, di somministrazione della giustizia, di governo della moneta. L’autosufficienza
dell’economia, ispirata alle tesi smithiane del laissez faire e della mano invisibile, si
sostanziò in un potenziamento delle istituzioni private a cominciare dalle camere di
commercio, che all’epoca operavano ed erano trattate alla stregua di vere e proprie strutture
corporative.
2) La prima industrializzazione (il primo ventennio del XX Secolo). Di questo periodo sono
individuabili i seguenti quattro aspetti fondamentali.
a) La differenziazione
differenziazione legislativa.
legislativa Diversamente dallo Stato liberista, furono introdotte
discipline normative differenziate al fine di tener conto di specifiche realtà territoriali,
reclamanti interventi mirati sul piano legislativo. Si pensi, in particolare, alle leggi speciali
per Napoli, per la Calabria e per la Basilicata, alla luce dei molteplici problemi legati al
corretto e ordinato sfruttamento del territorio, sia in termini di politiche abitative sia in
relazione alle attività agricole.
76
b) La politica dei lavori pubblici
pubblici.
ci Si assiste ad un forte incremento degli interventi volti a
realizzare infrastrutture necessarie per lo sviluppo economico: ferrovie, strade, ponti, dighe,
e via dicendo. Ciò determinò, peraltro, copiosi trasferimenti di denaro pubblico ai privati,
visto che i relativi lavori furono appaltati da imprese edili non incardinate nella pubblica
amministrazione.
c) Furono istituite le prime imprese pubbliche,
pubbliche in relazione a servizi di pubblica utilità:
ferrovie, telefoni, assicurazioni, istituti di credito. Fu il primo tentativo di assegnare
l’erogazione di servizi pubblici a entità imprenditoriali, estranee al paradigma ministeriale
(quindi, strutture operative più simile alle imprese private che alle organizzazioni
dell’apparato centrale a forte connotazione amministrativa).
d) La previdenza sociale.
sociale Si realizzò il graduale passaggio da un sistema mutualistico, basato
sull’azione prevalente di soggetti della società civile con connotazione volontaristica, ad un
sistema previdenziale in cui una parte dello stipendio è devoluta ad appositi enti pubblici
che provvederanno, al momento della pensione, alla erogazione del trattamento
economico.
3) L’economia
economia mista (dal 1929 al 1947). Il 1929 è l’anno del grande crollo delle borse, con
conseguente depressione economica che coinvolse tutti i paesi industrializzati. Il mercato fallì la
propria azione regolatrice dell’economia, dimostrando di non essere in grado di assicurare da solo
l’equilibrio tra domanda e offerta. Le tesi keynesiane inducono le istituzioni statali ad intervenire
massicciamente nei rapporti economici. Nel nostro Paese si assistette a tre passaggi fondamentali.
a) Un nuovo codice civile.
civile Nel 1942 fu adottato un unico codice civile che incluse anche le
disposizioni del vecchio codice del commercio.
b) Il monopolio pubblico.
pubblico L’inedito ruolo interventista dello Stato si realizzò attraverso:
- la configurazione di una riserva originaria dello Stato in settori economici strategici per
lo sviluppo e la crescita (trasporto marittimo e trasporto aereo, telefonia e
radiodiffusione, miniere, acque);
- estensione del sistema delle autorizzazioni, dunque, da una regime di accesso libero al
mercato ad un regime di accesso controllato in settori chiave quali il commercio, le
assicurazioni, il sistema creditizio, l’industria;
- ricorso massiccio al metodo della pianificazione, soprattutto nei settori del credito,
dell’urbanistica, dei beni culturali.
c) Istituzione di enti pubblici.
pubblici In vari settori (seta e cotone, tessile, riso, artigianato, carbone,
zolfo, turismo, ecc.) furono costituiti enti dotati non solo dei tratti tipici delle imprese
private, ma anche di poteri di regolazione del settore. Furono costituite poi società per
azioni con partecipazione statale: per tutte si pensi all’Istituto per la ricostruzione industriale
(I.R.I.) nel 1937, quale società di controllo di tante società impegnate in diversi ambiti
produttivi e commerciali.
4) Lo Stato del benessere (dal 1948 alla metà degli anni Settanta). La Costituzione repubblicana
del 1948 imboccò la strada tracciata dalle tesi keynesiane e rafforzò ulteriormente il ruolo dello Stato
in campo economico. Accanto alle previsioni della cd. costituzione economica, sulle quali si avrà
modo di indugiare più avanti, sono identificabili quattro aspetti centrali in questo periodo.
a) Completamento del sistema delle partecipazioni statali.
statali Fu istituito l’ENI nel 1953, per
favorire la crescita, in regime di monopolio, del sistema degli idrocarburi. Si procedette alla
nazionalizzazione dell’energia elettrica con conseguente istituzione dell’ENEL (1962),
tramite l’espropriazione delle imprese private e delle aziende municipalizzate che sino a
quel momento avevano operato nel settore. Venne istituito un apposito Ministero delle
partecipazioni statali, con il compito di governare l’assetto organizzativo che si strutturò su
tre livelli: ministero; enti di gestione; società per azioni controllate dagli enti di gestione.
77
b) Lo Stato finanziatore.
finanziatore Lo Stato si preoccupò anche di condizionare le transazioni
economiche attraverso l’erogazione di somme di denaro (sussidi, sovvenzioni) o con la
predisposizione di incentivi economici (es. credito agevolato, premi, contributi a fondo
perduto).
c) Dalla pianificazione si passò al metodo meno invasivo ma pur sempre dirigistico della
programmazione.
programmazione In seno al Governo fu, a tal fine, istituito il CIPE, ossia il Comitato
interministeriale di programmazione economica, con il compito di coordinare l’azione dei
ministeri coinvolti, più o meno intensamente, negli ambiti economici.
d) Furono, infine, estese e potenziate le istituzioni del
del benessere.
benessere Espressioni paradigmatiche
del welfare state furono senza dubbio l’istruzione, la sanità (con l’istituzione del sistema
sanitario nazionale nel 1978), la previdenza sociale, il lavoro.
Della “nuova” costituzione economica Sabino Cassese ha identificato i seguenti aspetti
fondamentali.
1) Processo di integrazione europea.
europea L’obiettivo essenziale della graduale formazione di un
mercato unico europeo, davvero competitivo rispetto agli altri mercati, è stato perseguito attraverso tre
strumenti:
a) libertà di circolazione delle merci, dei lavoratori, dei servizi, dei capitali;
b) disciplina della concorrenza,
concorrenza attraverso norme antitrust e contrasto agli abusi di posizione
dominante;
c) limitazioni agli aiuti di Stato alle imprese.
2) Discipline nazionali del mercato e della concorrenza. L’economia di mercato, alimentata
dalla concorrenza tra le unità di decisione economica, è divenuta la forma prescelte anche negli
ordinamenti, quali il nostro, che non ne parlano mai e che, anzi, recano previsioni più vicine
all’economia mista, come l’art. 41, terzo comma, Cost. Queste innovative discipline si sono
concretizzate:
a) in una disciplina generale (legge n. 287 del 1990), per colpire le intese restrittive della libertà
di concorrenza, gli abusi di posizione dominante, le operazioni di concentrazione. A tal fine sono
state istituite due authorities di controllo: l’Autorità garante della concorrenza e del mercato
(Antitrust) e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom);
b) in più discipline speciali
speciali,
ali soprattutto nei seguenti settori: comunicazioni di massa, stampa
quotidiana, pubblicità radiofonica e televisiva, partecipazione al capitale delle banche.
3) Ridefinizione dei servizi pubblici.
pubblici Più avanti sarà affrontato il tema dei servizi pubblici. Qui
basta anticipare che con questa espressione si allude a prestazioni che il mercato non garantirebbe a
tutti, inclusi gli indigenti, perché i costi sarebbero nettamente superiori ai ricavi. Subentra, quindi, lo
Stato con le sue strutture operative. Si assiste alla transizione:
- dal regime tradizionale,
tradizionale basato sulla riserva originaria o esclusiva a favore dello Stato, che
provvede alla gestione diretta o indiretta o in concessione (a privati o a società controllate dallo Stato);
- al regime attuale,
attuale contraddistinto (nei settori, in particolare, dell’energia elettrica, del gas, dei
trasporti di linea, delle telecomunicazioni, delle poste) dalle liberalizzazioni per favorire la
concorrenza; dalla regolazione pubblica (per aprire i mercati, per garantirne il funzionamento, per
assicurare la fruizione dei servizi essenziali); dalla dissociazione tra gestione delle reti ed erogazione
dei servizi.
4) Le privatizzazioni.
privatizzazioni Si assiste ad uno smobilizzo delle partecipazioni pubbliche, con
conseguente diminuzione, su questo versante, dell’indebitamento pubblico e dimensioni più efficienti
delle imprese pubbliche.
78
5) Controllo della finanza pubblica.
pubblica In un’altra parte di questa dispensa verrà dedicato ampio
spazio al ciclo di bilancio che vede come protagonisti non solo il Parlamento ed il Governo, ma
anche le istituzioni europee. Ciò al fine di garantire il contenimento della spesa pubblica nell’interesse
non solo dei singoli Stati membri ma anche dell’intera Unione europea.
6) Disciplina pubblica della finanza privata
privata.
ata Nei tre seguenti settori sensibili gli interessi in gioco
sono tali da richiedere una particolare attenzione del legislatore nel regolare i comportamenti dei
relativi attori economici:
- mercato bancario:
bancario fermo il potere di disciplina devoluto alla Banca d’Italia, si assiste alla
apertura del mercato con un tasso di concorrenza più alto rispetto al passato. Si consolida la
conformazione funzionale della banca come impresa a tutti gli effetti, e ciò pone un problema di
tutela degli utenti dei servizi bancari;
- mercato mobiliare:
mobiliare alla Consob sono assegnati compiti di regolazione degli intermediari
finanziari, nel rispetto e in attuazione dei princìpi di trasparenza e di concorrenza;
- mercato assicurativo:
assicurativo la disciplina delle assicurazioni è devoluta all’Isvap sempre in funzione di
liberalizzazione tariffarie e di concorrenza tra operatori.
È agevole notare i caratteri comuni a questi tre mercati:
- liberalizzazione per la concorrenza;
- accesso al mercato subordinato ad autorizzazione;
- regole cogenti per operazioni e servizi resi;
- severa discipline per fronteggiare situazioni di crisi;
- ruolo regolativo, di controllo e sanzionatorio di autorità amministrative indipendenti.
79
Capitolo V
I SOGGETTI DELLA COSTITUZIONE ECONOMICA
La costituzione economica vive attraverso l’azione dei propri protagonisti. È quindi
indispensabile soffermarsi sui soggetti della costituzione economica seguendo due distinti versanti:
quello dei soggetti pubblici e quello dei soggetti privati.
Sezione I
I SOGGETTI PUBBLICI
Lo Stato
Tra i soggetti pubblici occorre prendere le mosse dallo Stato.
Stato
Lo Stato è una organizzazione giuridica complessa qualificabile come tale per effetto della
compresenza di tutti e tre i seguenti elementi costitutivi:
1) territorio:
territorio una porzione, più o meno estesa, del pianeta Terra circoscritta da confini politici,
ossia delimitata da frontiere decise dall’uomo;
2) popolo:
popolo è l’insieme dei cittadini, ossia degli individui in possesso della cittadinanza, quale
condizione giuridica soggettiva che instaura un peculiare rapporto tra lo Stato e le persone;
3) governo:
governo non è che il complesso delle istituzioni che, esercitando i tre classici poteri, fanno
funzionare lo Stato.
Lo Stato è, dunque, costituito da un popolo, stanziato su di un territorio, che vive secondo le
regole e le decisioni assunte da un apparato di governo.
La fonte dei poteri statali è la sovranità.
sovranità Ogni Stato è sovrano e indipendente in quanto non
deriva i propri poteri da altri Stati o organizzazioni sovranazionali. Uno Stato è tale per forza propria,
quando riunisce i tre elementi costitutivi. Non è quindi necessario alcun riconoscimento formale da
parte degli altri Stati, che insieme formano la comunità internazionale.
Il seguente scritto di L. Ornaghi chiarirà meglio l’evoluzione e la sostanza del concetto di Stato.
L. ORNAGHI, voce Stato, in Dig. IV ed., Disc. pubbl., vol. XV, Utet, Torino, 1999, pp. 25 ss.
…
2. Il lemma Stato: lo svolgimento italiano del concetto attraverso repertori, dizionari, enciclopedie.
Sono le voci con cui i classici repertori giuridici hanno di volta in volta definito e concettualizzato lo
Stato a mostrare quanta e quale sia l’attuale difficoltà di ricomporre in una sintesi coerente gli elementi ancora
fondamentali di una teoria dell’organizzazione e del potere statale.
Nella prima edizione del Digesto troviamo la seguente definizione: «Per antonomasia in diritto pubblico
la parola Stato si applica alle condizioni generali organiche di un popolo, ossia all’organismo sociale, col quale
si trova ordinato [...]» (4).
Alla voce «Stato (come persona giuridica)», del Nuovo Digesto, si incontra un’affermazione altrettanto
indicativa: « Chi vuol ragionare dello Stato — e non solo fornire una descrizione sommaria di un certo Stato,
preso come oggetto di conoscenza astratta e naturalistica — non può legarne la definizione a una sua particolare
e puntuale realizzazione storica; anzi, per intendere e valutare questa puntuale realizzazione, occorre riportarlo
e tuffarlo, per così dire, nel suo processo di formazione e di sviluppo, come serie di fenomeni collegati,
80
illustrati, illuminati da un principio e da un fine superiore, che in essi si svolge» (5). Sarà ancora lo stesso
autore, Giacomo Perticone, al quale verrà affidata una seconda volta la voce «Stato» del Novissimo Digesto, a
sottolineare la necessità di integrare la dottrina giuridica alla luce del «carattere sociologico»: «Il fatto storicopolitico è insieme un atto giuridico da cui deriva lo stato come ordinamento (giuridico), pure restando, da un
altro punto di vista, un fatto storico, economico, sociologico, ecc., che, per le connessioni intercorrenti, non
può essere insignificante per il giurista» (6).
Non stupisce pertanto che persino nella voce «Stato» scritta per un repertorio precipuamente rivolto a
operatori del diritto, com’è il caso della Enciclopedia forense, si ritrovi la medesima accortezza riguardo ai
criteri definitori: «La definizione dello Stato, nei termini che abbiamo enunciato, implica quindi la distinzione
tra Stato e ordinamento giuridico» (7).
Più di recente, del resto, lo stesso concetto viene ribadito da Paolo Biscaretti di Ruffia, secondo il quale
sarebbe non meno erroneo ridurre lo Stato a un mero sistema di norme, «[g]iacché pare innegabile, sul piano
della realtà quotidiana, la materiale concretezza, territoriale ed umana, dello Stato: è, quindi, frutto di
un’eccessiva impostazione teorica limitare la sua reale essenza al mondo delle concezioni astratte, anche se
dotate di effetti nella realtà positiva e concreta» (8).
Con significativa evidenza la successione di tali voci scandisce il tentativo di svincolare il concetto di Stato
da quell’intrinseco carattere di «giuridicità», che è connaturato al ruolo centrale attribuitogli dalla
giuspubblicistica ottocentesca sin dalla nascita e per grandissima parte degli svolgimenti successivi. Non per
caso, quasi al termine di questa traiettoria, più forte diventa allora la necessità di ribadire il carattere
naturalmente e irrimediabilmente giuridico del concetto di Stato. È con una specie di obbligato controcanto
che, sulle pagine della Enciclopedia del diritto, Egidio Tosato avverte: « Il concetto dello stato è dunque un
concetto essenzialmente giuridico, e non vi sono altri concetti dello stato fuorché quello giuridico. Varie sono
le scienze (come la storia, la filosofia, la sociologia, la politica, l’economia, la statistica, ecc.) che si occupano
anche dello stato; ma ciò avviene in quanto nello stato o per effetto dello stato si verificano fenomeni che
formano l’oggetto specifico delle ricerche proprie di ciascuna di esse» (9).
La sensibilità del giurista non stenta a riconoscere in siffatta scansione i segni di quel lungo travaglio
metodologico, che si è accompagnato alla progressiva delimitazione per settori disciplinari (e talvolta a
un’effettiva disarticolazione) non solo del diritto pubblico, ma anche dei «diritti» al primo più contigui o
interdipendenti. Nella sequenza temporale delle voci, entro la quale lo Stato risulta sempre meno definibile
per via della — e persino a partire dalla — sua intrinseca giuridicità, viene così a delinearsi un segmento
straordinario di storia della scienza giuridica, e forse ad assumere consistenza l’unico tentativo possibile perché
il diritto statale non perda contatto con il proprio fatto costitutivo: lo Stato, appunto, quale reale ordinamento
di convivenza politica. Certo, la parabola della figura dello Stato delineata dalla giuspubblicistica (e dalle
differenti giuspubblicistiche) non può compiutamente e correttamente disegnarsi se non ricostruendo
andamenti, sovrapposizioni e scostamenti reciproci, innovazione più o meno ardita e conservazione puntigliosa
degli apparati categoriali e linguistici di ognuna di quelle partizioni disciplinari della scienza giuridica che
maggiormente hanno alimentato il discorso sullo Stato e che da un simile discorso sono state esse stesse
influenzate (sino, assai spesso, a risultarne determinate). Tuttavia, quel che dal rapido progredire della
riflessione giuridica sullo Stato e nel suo crescente esporsi agli apparati linguistici e concettuali delle scienze
sociali realmente fu aperto come problema cruciale (e tuttora lo resta), è il rapporto tra Stato e politica.
Con ogni probabilità, proprio dal fatto che gli aspetti più ambivalenti e meno dogmatizzabili di tale
rapporto non siano mai stati esplorati sino in fondo e in modo del tutto soddisfacente per il giurista, è dipesa la
crescente attenzione — anche nel campo del diritto — per la creazione e per gli svolgimenti storici dello Stato
quale forma genuinamente e modernamente politica di organizzazione del potere. Già Felice Battaglia —
nell’aprire, con la sezione Storia del nome, il lemma «Stato» della Enciclopedia Italiana — osservava come con
«la parola stato si designa modernamente la maggiore organizzazione politica che l’umanità conosca,
riferendosi tanto al complesso territoriale e demografico su cui si esercita una data signoria, quanto al rapporto
di coesistenza e di connessione di leggi e di organi che su quello imperano. Tuttavia tale significato è piuttosto
recente e il suo principio si può porre tra la seconda metà del sec. xiii e la prima del sec. xv, mentre era affatto
ignoto all’antichità e all’alto Medioevo» (10).
In una teoria giuridica dello Stato che possa collocare alcuni suoi fondamenti nel tipo moderno di Stato
e nel reale divenire storico della moderna organizzazione statale del potere, non di rado si è cercato (e ancora
lo si tenta) di risolvere non solo il rapporto tra Stato e politica, ma persino quello tra diritto e Stato. Rivestita
così di una funzione critica all’interno della teoria dello Stato, la storia del «moderno Stato (europeo) » ha
portato ai limiti estremi la storicizzazione dell’esperienza statale: fino al punto massimo oltre cui, nemmeno
troppo paradossalmente, è sembrato indispensabile e quasi obbligatorio cercare lo Stato o in quelle tradizioni
81
storiografiche che maggiormente lo hanno marginalizzato, o soprattutto laddove le istituzioni, i campi d’azione
e le stesse formule di legittimazione statali paiono oggi non del tutto plasmati e irrimediabilmente
contrassegnati dalla (pretesa) esclusività politica dello Stato. Anche per questa ragione, uno dei punti su cui
maggiormente si soffermerà la presente voce è costituito da una considerazione dello «Stato al plurale», cioè
delle forme diverse di presenza dello Stato stesso all’interno di una configurazione poliarchica e reticolare di
quella che — invero sempre meno classicamente, e persino convenientemente — continua a definirsi «società
civile».
La storicizzazione dell’esperienza statale dell’Europa moderna si è imbattuta ormai da tempo in un altro
ostacolo, per nulla agevole da superare. È infatti sempre più dubbio se la moderna organizzazione del potere,
nelle sue articolazioni statali, sia correttamente spiegabile con un modello onnicomprensivo di Stato, o se
invece non siano esistiti due modelli fondamentali (quello anglo-insulare, di contro a quello europeocontinentale), e se il secondo non sia più proficuamente da distinguere negli ulteriori due tipi dello Stato
francese e di quello prussiano. Un simile interrogativo — com’è subito evidente — non solo spiana la via verso
suddivisioni di analisi sempre più particolari a mano a mano che si sposta il punto di osservazione del sistema
«centrale» e del rapporto «centro-periferia», ma facilita anche una sorta di localizzazione e identificazione
nazional-territoriale delle esperienze statali, così accentuando refrattarietà o radicali opposizioni rispetto a ogni
pretesa di nuove costruzioni tipologiche. In realtà, se ci si vuol sottrarre al richiamo delle tipologie, non sembra
esservi altra alternativa se non quella di accettare una frammentazione storica che, mentre ha di fatto
caratterizzato i processi di formazione statale, nondimeno rimane suscettibile di un qualche procedimento
comparativo in cui ricomprendere la specificità dei singoli casi nazionali e — cosa forse di ancor maggior
importanza — di più o meno vaste aree «regionali».
Anche quest’ultima prospettiva, tuttavia, finisce col supporre o presupporre, sia pure soltanto per
esigenze euristiche, se non un determinato modello di Stato almeno l’aspetto o gli aspetti che meglio lo
caratterizzano, i quali a loro volta rispecchiano il concreto profilo critico della forma storica di Stato da cui
vengono dedotti. Di qui la necessità ulteriore, oggi, di analizzare le trasformazioni dello Stato, anziché
indugiare nuovamente sulla sua crisi, o su quelle «contraddizioni» che, considerate una per volta piuttosto che
nel loro complesso, paiono ribadire comunque la tesi antica di un suo autodissolvimento.
In effetto, ancor prima che a livello speculativo, è sul piano pratico che si impongono con ogni evidenza
i nessi mediante cui le trasformazioni dello Stato (delle sue funzioni e della sua struttura, così come delle sue
più tradizionali forme di legittimazione) si intrecciano e interagiscono con due opposti e complementari
insiemi di fenomeni, da cui oggi sono investiti l’ordine statale particolare e il sistema politico degli Stati: l’uno, il
complesso di fenomeni che potremmo definire in termini di «pluralizzazione» dei tradizionali assetti statali, e,
l’altro, quello della «internazionalizzazione» di questi stessi assetti.
È soprattutto la storia del diritto a dare conto di gran parte del primo dei due processi: basti pensare
specificamente ai contributi offerti dal riconsiderare il ruolo che la teoria (giuridica) dello Stato ha svolto
nell’immaginare e semplificare l’effettiva storia (giuridica) dei processi di formazione statale dal cosmo del
Medioevo all’età moderna, vale a dire quella «storia dei giuristi» (nel senso del ceto dei giureconsulti), che fino
a un certo punto potrebbe restituirci la molteplicità degli aspetti della vicenda dello Stato dal basso, per così
dire, muovendo cioè dalla concreta esperienza forense di coloro i quali hanno avuto il compito di decifrare,
applicare e adattare i precetti del potere statale(11).
Più controverso (e per ora senza confini ben definiti) resta invece il campo relativo all’aspetto «esterno»
dei mutamenti che interessano la forma e l’essenza dello Stato. Proprio quel campo, insomma, dove con
turbolenza maggiore, con ritmo più intenso, con conseguenze a prima vista più ampie e profonde, si svolgono i
processi di crescente intersezione e ibridazione tra dinamiche e fatti economici e sociali, tra politica e diritto:
quella rete di processi, cioè, da cui sono sempre più caratterizzati i rapporti internazionali e il moltiplicarsi dei
circuiti funzionali tra gli Stati, e da cui vengono dilatate, o direttamente prodotte, analoghe interferenze e
ibridazioni dentro ciascuna delle comunità statali particolari. A questo proposito la riflessione sul diritto
internazionale e sulle sue istituzioni, per quanto (o forse proprio perché) così consolidata dal punto di vista
giuridico(12), continua a risultare quasi del tutto impermeabile ai risultati raggiunti dal contemporaneo ambito
disciplinare della teoria delle relazioni internazionali o da linee di ricerca interdisciplinare come quelle della
International Political Economy.
Non che la distinzione tra «interno» ed «esterno» possegga un contenuto in sé e per sé compiuto, o che
abbia acquisito di recente una maggiore chiarezza definitoria. Sempre più consapevolmente, tuttavia, ci si
avvede dell’accentuata interdipendenza tra l’uno e l’altro, e forse della necessaria, reciproca fungibilità dei due
punti di vista, in modo non dissimile rispetto a ciò che è capitato ad altre, e ben più inossidabili, partizioni82
contrapposizioni concettuali (quella tra «pubblico» e «privato», per arrestarci all’esempio principale e di
maggior pertinenza).
In sostanza, anziché dismettere immediatamente gli stilemi linguistici della dogmatica giuridica, è
opportuno considerare la possibilità di traslitterarli, là dove sia possibile, nel linguaggio delle scienze sociali.
Senza avanzare, camuffandola con panni nuovi, nessuna antica pretesa di completezza (del resto non
auspicabile, e soprattutto non conveniente al momento), un simile obiettivo comporta implicitamente un
impegno di carattere metalinguistico, nel senso di un «meta-discorso» il cui referente sia costituito dai discorsi
all’interno dei quali è stato effettivamente pensato (o si renda nuovamente pensabile) lo Stato(13). Per
semplificare e chiarire: non è al contenuto semantico della parola Stato — cui si presterà tuttavia la doverosa
attenzione più avanti — che è necessario e urgente ora guardare, bensì alle procedure discorsive di innovazione
e «tesaurizzazione» per il tramite delle quali, a turno, si è pensato ora di abbandonare il concetto di Stato (in
favore per esempio della nozione creduta più elastica e non storicizzabile di «sistema politico», com’è successo
per mano e in settori diffusi della scienza politica), ora di tornarvi nuovamente allo scopo di ricostruire i tratti
distintivi del rapporto tra Stato e società.
Nondimeno, è bene avvertire subito che il tragitto dalla definizione giuridica a quella «sociologica» dello
Stato (e viceversa) presuppone proprio quella duplice considerazione del diritto, sia dal punto di vista giuridico
sia extra-giuridico (sociale, economico e politico), alla quale si sono attenuti gli stessi giuristi intenti a risolvere il
circolo vizioso tra giuridicizzazione e socializzazione dello Stato. È il caso, veramente esemplare per cogliere la
traiettoria di un simile periplo concettuale, della rivisitazione del lemma «Stato» — cui già si è accennato in
apertura della presente voce — da parte di Giacomo Perticone. Con un significativo effetto (chissà quanto
voluto) di spiazzamento dei lettori mediante l’assenza della maiuscola nel termine «stato», la traiettoria veniva
così disegnata: «Dallo stato di fatto della sociologia allo stato di diritto c’è passaggio; ma non si tratta di due
concetti diversi, ma di due punti di vista dai quali si considera lo stesso oggetto» (14).
Non è la sola, peculiare sensibilità sociologica del giurista a poter spiegare completamente una simile
affermazione. Un’impostazione metodologicamente affine viene infatti accolta anche da studiosi di altra
provenienza, ugualmente impegnati non soltanto a evidenziare la manifesta indeducibilità dell’ordine politico
dall’ordinamento giuridico dello Stato, ma altresì a rilevare «la irriducibilità a ordinamento giuridico dei tipi
storici di Stato che hanno preceduto lo Stato rappresentativo» (15).
Insomma, proprio come una «rete» sospesa sui fatti, per ripetere la felice immagine di Carl Gustav
Hempel, la teoria giuridica dello Stato è sembrata allentarsi in modo tale da apparire ormai inutilizzabile.
Ovvero è parsa annodarsi su se stessa — il che ha prodotto conseguenze quasi uguali, se non del tutto identiche
— al punto di risultare addirittura impenetrabile a ogni riscontro empirico. Proprio a partire da questa impasse
della teoria, ha allora ripreso corpo l’indagine storiografica sulla genesi dello Stato. Quando non si tenesse
conto di un tale blocco, né si capirebbe come mai il codice genetico dello Stato venga ritenuto così importante
per descrivere le attuali trasformazioni dell’organizzazione statale, né ci si accorgerebbe del perché, via via che
le persistenze feudali paiono maggiori o più rilevanti delle «novità» nelle istituzioni politiche e nelle formule di
legittimazione del moderno ordinamento del potere(16), il concetto stesso di «Stato» appaia in procinto di
perdere quella sua esclusiva determinazione storica che ne ha ultimamente e sin qui protratto — in sede
euristica, almeno — il significato principale e la sorprendente vitalità.
Non per caso, gli estensori delle voci più recenti dedicate al lemma Stato hanno avvertito l’esigenza,
quasi senza eccezioni, di definire l’oggetto in base ai peculiari caratteri che hanno contraddistinto il suo
emergere in età moderna. Ben pochi studiosi, insomma, sono sembrati disposti a pensare lo Stato quale
«grande modello» in cui ricomprendere (e mediante cui comprendere) le forme di organizzazione del potere
succedutesi a partire dalla «città-stato» greca, se non addirittura dal regno babilonese di Hammurabi nella
Mesopotamia del secondo millennio a. C.(17). È allora significativo che proprio uno studioso di formazione
politologica come Alfio Mastropaolo, in una tra le più rilevanti voci pubblicate nei primissimi anni Ottanta(18),
abbia sentito l’urgenza di sgombrare il campo dalle «incaute, anzi scorrette estensioni per le quali alla fine si
parla, e non di rado, di stato-città — o di città-stato —, di stato patrimoniale o addirittura di stato feudale, con il
risultato di privare il nostro concetto di gran parte di quel suo spessore storico di cui invece deve assolutamente
tener conto ogni indagine rigorosa in tema di organizzazioni politiche» (19). Il campo d’indagine, in tal modo,
viene delimitato attraverso il classico procedimento per genus et differentiam: « [r]ispetto al genus "sistema
politico" è dunque assodato che lo "stato" rappresenta unicamente una delle molte "species" possibili» (20).
Ai fini della nostra analisi, è però da notare che una simile ricognizione del concetto di Stato, per quanto
possa guadagnare in chiarezza, non sfugge al pericolo di perdere terreno proprio [rispetto] al dato storico,
quantomeno sotto il profilo di quella metodologia weberiana che — come si vedrà — continua a rappresentare il
banco di prova per ogni ulteriore declinazione del termine Stato: per Weber infatti, è forse il caso di
83
ricordarlo, un concetto storico «non può essere definito e limitato secondo lo schema, genus proximum,
differentia specifica, ma dev’essere costruito a poco a poco dalle parti storiche che lo compongono, e che
vanno tolte dalla realtà storica» (21).
Un simile rilievo nulla intende togliere, beninteso, alla pregnanza della ricostruzione offerta da
Mastropaolo sul piano storiografico. Evidenzia, semmai, la peculiarità della sua indagine rispetto alla vulgata
del paradigma weberiano. Per quanto lo stesso Mastropaolo si richiami esplicitamente a una rappresentazione
ideal-tipica dello Stato moderno, pure le pagine conclusive del suo lavoro rivelano con chiarezza l’obiettivo di
delineare una teoria in grado di ricomprendere al proprio interno la molteplicità dei tipi o dei modelli dedotti
dall’analisi storica (accentramento, burocratizzazione, e così via).
Torna utile in proposito il confronto con la voce «Stato moderno», stesa pochissimi anni addietro da
Pierangelo Schiera già per la prima edizione del Dizionario di politica della Utet(22). Il concetto di Stato viene
qui individuato non già per differenza specifica rispetto al suo genus, quanto per contrasto con ciò che lo
accompagna quale componente irriducibile rispetto alla moderna «sintesi» statale. È il caso, in particolare, di
quella «società per ceti» di cui lo stesso Schiera firma la corrispondente voce nel medesimo Dizionario. Non
privo di significato è allora il fatto che, tra le qualificazioni o determinazioni associate alle voci sullo Stato del
Dizionario di politica («moderno», e — nelle successive edizioni — «contemporaneo», «del benessere», ecc.),
manchi quella connotazione «per ceti» che si ritrova nel tedesco Ständestaat. Si potrebbe concludere che, in tal
modo, venga restituita alla concretezza storica uno dei tasselli fondamentali che sono serviti a costruire il
concetto di Stato, dal momento che questo, al pari di qualunque altro concetto, si compone di più parti, le
quali — per dirla ancora con Weber — «vanno tolte dalla realtà storica» (23).
Più recentemente, sul punto in questione è tornato Maurizio Fioravanti, con una ricca e documentata
voce della Enciclopedia del diritto(24). Il «paradigma weberiano» dello Stato viene sottoposto a una rilettura a
contrario, per il tramite (in particolare) della prospettiva di uno storico come Otto Brunner. L’analisi di questi
due paradigmi, assunti a emblemi di una continua e persistente oscillazione tra due opposte concezioni dello
Stato moderno (quella razional-istituzionale di stampo weberiano, e quella di Brunner centrata sulla coppia
«unità-sovranità»), non si risolve tuttavia nel riconoscimento di una pura e semplice contrapposizione, bensì
muove alla ricerca di una terza declinazione dello Stato come equilibrio, i cui tratti fondamentali vengono per
la gran parte desunti dalla storiografia costituzionale inglese.
Al di là delle differenze tra il modello di Stato angloinsulare e quello europeo-continentale (per cui si dà
del primo una versione continuista polemicamente opposta all’elemento di rottura tra Medioevo e moderno,
che si ritiene abbia prodotto e definitivamente caratterizzato l’avvento del secondo), Fioravanti mira a sfuggire
al gioco di specchi attraverso cui le due prospettive sono venute reciprocamente convalidandosi (o
invalidandosi). Il suo obiettivo è di comprendere unitariamente l’intera vicenda storica dello Stato, così
svincolandola da una contrapposizione storiografica che opportunamente l’autore giudica ormai del tutto
sterile e inconcludente. In tal senso, si tratta non già di liquidare i tradizionali paradigmi dello Stato, bensì di
integrarli alla luce di un modello di Stato come equilibrio, in grado di delineare l’articolazione pluralista sia dei
meccanismi associativi, sia della loro traduzione in ordinamenti giuridici e in regole di condotta.
È d’obbligo a questo riguardo un richiamo alla voce «Stato» scritta da Norberto Bobbio (25) agli inizi
degli anni Ottanta. Bobbio, soffermandosi sulle cause della contrapposizione tra concezioni moniste e
pluraliste dello Stato, a lato delle seconde ha colto — anche e significativamente nel pluralismo sociale proprio
della dottrina anglosassone del guild socialism — «una variante della teoria dello Stato minimo, confinante con
la teoria della fine dello Stato» (26). Ci si potrebbe chiedere in qual modo la riflessione sui «limiti dello Stato»
sia potuta andare ad appannaggio di un così ampio spettro dottrinale, che va dal liberalismo al pluralismo
socialista. Ma la risposta è probabilmente già contenuta nel binomio, che l’autore ritiene inscindibile, tra Stato
e politica: sicché il comune denominatore scaturisce in questo caso da una concezione della politica definibile
soltanto in termini convenzionali e da una visione sempre circoscritta del ruolo di quest’ultima nella società.
Che sotto questo profilo la parola Stato in sé finisca con l’assumere uno spessore poco più che
nominalistico, lo si intuisce dal tenore dell’argomento a favore della tesi «discontinuista» sull’origine dello
Stato. Osserva infatti Bobbio: «Il problema del nome "Stato" non sarebbe così importante se l’introduzione del
nuovo termine alle soglie dell’età moderna non fosse stato occasione per sostenere che esso non corrispose
soltanto a un’esigenza di chiarezza lessicale ma andò incontro alla necessità di trovare un nome nuovo per una
realtà nuova: la realtà dello Stato appunto moderno da considerarsi come una forma di ordinamento tanto
diverso dagli ordinamenti che lo avevano preceduto da non poter essere più chiamato con gli antichi nomi»
(27).
Mentre Bobbio sembra concentrare la sua attenzione sul confronto tra le tesi discontinuiste e quelle
continuiste, Nicola Matteucci ha accolto esplicitamente e senza riserve la definizione dello Stato come forma
84
storicamente determinata di organizzazione del potere, la quale si impone solo in epoca moderna e con
caratteristiche del tutto peculiari rispetto ad altre «forme di dominio» (28). L’implicita adesione al paradigma
weberiano è però funzionale a una ricostruzione storica che, in Matteucci, punta a oltrepassare la semplice
contrapposizione di fatto tra monismo e pluralismo (quest’ultimo inteso nel senso dell’associazionismo di
stampo liberale, anziché in termini corporativi o cetuali, che come tali appaiono all’autore in netta antitesi con
il moderno pluralismo).
Di particolare rilievo, almeno per quanto riguarda le argomentazioni principali che si stanno qui
cercando di svolgere, è il passaggio conclusivo della voce scritta da Matteucci, la quale — a differenza delle altre
finora considerate — apre l’analisi al sistema politico internazionale. Da quest’ultimo sistema l’autore fa
discendere la diminuzione, se non addirittura l’estinzione, del potere sovrano degli Stati. Di fronte al definitivo
logoramento dell’antico ius publicum europaeum, che a sua volta si reggeva su di un equilibrio tra Stati sovrani,
Matteucci propende verso l’ipotesi di uno Stato «post-moderno», situato nel mezzo di un fitto reticolo di
interdipendenze e irriducibile all’effettuale realtà di centro che si pretenda illimitatamente sovrano.
Ovviamente, perché una simile ipotesi risulti appropriata alle principali trasformazioni in corso, non
basta assumere lo Stato come variabile dipendente rispetto alla dimensione internazionale dei processi politici.
Né — come talvolta si crede — è sufficiente andare «oltre lo Stato», allo scopo di riscoprire l’articolazione
pluralista del processo di governo. In tal caso verrebbe infatti a mancare la benché minima considerazione
circa gli effetti strutturali che lo Stato dispiega e produce, per parte sua, sui medesimi processi di cui lo si
vorrebbe ormai (e, non di rado, in misura prevalente) un oggetto passivo.
Piuttosto, è da notare in qual modo il tragitto dalla definizione giuridica di Stato a quella sociologica e,
poi, politologica — così come lo si è sinteticamente ripercorso attraverso alcuni dizionari, repertori ed
enciclopedie della cultura italiana — ci restituisca infine l’immagine di un sistema assente: un sistema che non è
(ancora) pienamente riconducibile a un vero e proprio corpus teorico, ma che, nondimeno, rimane operante
sul piano della ricostruzione funzionale. In questo senso è allora assai indicativa la forza con cui torna a
riaffiorare il problema del nome Stato, insieme al persistente paradosso, neppure troppo inconsueto nel lessico
e nei discorsi della politica, di un nome antichissimo per una parola «nuova».
3. Un nome antico per una parola nuova (ovvero, breve excursus sulla nascita di un termine bastardo).
Uno dei modi più frequenti di risalire alle origini del concetto di «stato» (prima ancora che a quelle del
suo nome) consiste nel procedere alla ricostruzione, o inversamente alla decostruzione, dei caratteri costitutivi
mediante cui le dottrine giuspubblicistiche sono pervenute alla definizione dello Stato quale forma specifica di
ordinamento politico. Con pari frequenza, in molte indagini continua a sembrare più proficuo anteporre alla
storia del concetto giuridico la storia dei modi d’impiego del termine. Nelle analisi che si sono venute
accumulando intorno alla genesi e all’uso linguistico della parola in questione, non è pertanto difficile scorgere
ora il tentativo di sottrarre al logorio storico Videa di Stato, ora l’intento di comprovare la sua irreversibile crisi.
In simili prospettive di ricerca vengono così a esplicitarsi due procedimenti complementari, che trovano
la loro sintesi nello svolgimento complessivo del termine-concetto di Stato. Eppure, qui più che altrove, non è
affatto irrilevante notare come proprio negli slittamenti semantici tra il concetto e il termine di status, sul quale
si innesta il ceppo originario della parola «stato», sia da trovare il motivo conduttore di quell’incessante
operazione di cesello terminologico e concettuale cui è stata sottoposta, a più riprese e con modalità diverse, la
nozione di Stato.
In effetti, mentre l’area lessicografica che inizialmente pertiene al termine status è quanto mai vasta (e
perciò anche sostanzialmente indeterminata), gli sviluppi che coinvolgono la sua connotazione giuspubblicistica
— così diremmo oggi — permangono sostanzialmente inalterati dall’antichità fino al secolo xiii. Non che,
naturalmente, il termine status sia risultato nell’età classica del tutto privo di connotazioni «politiche»: com’è
noto, infatti, per il suo tramite veniva definita non soltanto la condizione familiare (status familiae) e quella
economico-sociale (status libertatis), bensì anche la situazione civile in senso proprio (status civitatis). Neppure,
tuttavia, si può plausibilmente affermare l’opposto: cioè che l’impiego di status in senso giuspubblicistico, al
quale ha dato luogo il passo ben noto (e variamente interpretato e tradotto) di Ulpiano nelle Institutiones,
1,1,4: «publicum ius est, quod ad statura rei Romanae spectat», abbia indicato qualcosa di più della pura e
semplice «condizione» o, al limite, del «modo d’essere» della res publica. Il punto di partenza, in tale
direzione, è infatti l’endiadi status rei publicae. È però da notare già da ora come, specialmente sotto il profilo
della distinzione tra «pubblico» e «privato», la nozione di status abbia finito col condividere le altalenanti
vicende di un’altra fondamentale categoria derivata dal diritto romano, quella del «contratto». Al pari di
quest’ultima, ma per ragioni diametralmente opposte su cui si dovrà tornare, anche l’idea di status si presta
85
infatti a quella duplice e irriducibile chiave di lettura — in senso ora privatistico, ora pubblicistico — che è poi al
fondo dell’ambivalenza costitutiva (o, se si vuole, del carattere bastardo) presente nel patrimonio genetico di
Stato.
In ogni caso, il termine status verrà a indicare la condizione («stabile» e «stabilizzante», in primo luogo)
(29)dell’una come dell’altra delle due forme di organizzazione politica scaturite dalla disarticolazione di
quell’universalismo da cui traeva alimento l’idea di respublica Christiana: le nascenti autonomie cittadine, da
un lato, e, dall’altro, le monarchie territoriali in via di formazione sin dall’alto Medioevo. Come avvertirà, ai
primi decenni del Trecento, Marsilio da Padova già nel secondo capitolo del Defensor Pads, per poter definire
cosa sia la «tranquillità» di una civitas o di un regnum occorre infatti tener conto che il termine regnum (quale
res publica, «Stato») ha molti significati: «In un senso indica infatti un dato numero di "città" [civitatum] o
"province" che sono contenute entro un certo regime; e in questo senso lo Stato [regnum] non differisce dalla
città per quanto riguarda le specie di costituzione [policie], ma piuttosto per la loro quantità. In un altro senso,
uno Stato [regnum] può consistere tanto in una sola città, come accadeva appunto al tempo in cui sorsero le
comunità civili, poiché allora vi era di solito un re per ogni città. Il terzo e più familiare significato di questo
termine è una combinazione del primo e del secondo. E nel suo quarto senso, significa qualcosa di comune ad
ogni specie di regime temperato, sia in una sola città sia in molte città». A partire da qui, la nozione di «stato» —
invece di servire di rinforzo all’immagine della respublica (o della civitas, nonché del regnum) — inizierà
lentamente e quasi impercettibilmente a prenderne il posto. E tuttavia, se si ripercorrono separatamente gli
sviluppi del termine status in rapporto alle sue diramazioni in volgare, non si può fare a meno di notare come i
piani di connotazione che investono il termine «stato» siano costretti a variare sensibilmente a seconda dell’area
linguistica di riferimento. Una possibile chiave di lettura può essere fornita in proposito dai dispositivi
argomentativi che di volta in volta vengono impiegati, in particolare per quanto riguarda il rapporto inverso che
intercorre tra inventio e tesaurizzazione. È comunque certo che l’acquisizione del moderno concetto di Stato
non procede per «compartimenti stagni» (30). Così, in determinate circostanze, quel che tarda a comparire in
modo evidente e distinto è l’uso del latino status, senza altre qualificazioni o specificazioni al di fuori di quelle
concernenti lo «stato», ovvero la condizione, di qualcuno o di qualcosa. Nulla di più, insomma, di quanto non
verrà tesaurizzato da Egidio Forcellini nel suo Lexicon totius latinitatis.
In effetti, ancora intorno al 1570 circa, nel suo trattato sulle origini della monarchia francese intitolato
Francogallia, il calvinista François Hotman ascrive senza indugio all’idioma popolare l’espressione «Affari di
Stato». All’inarca nel medesimo torno di tempo, e nell’identico contesto storico, un atteggiamento di analoga
diffidenza nei riguardi del neologismo «Stato» si può incontrare anche in Bodin, il quale — com’è ben noto —
preferisce adoperare il classico termine di République, o respublica. Sono bensì numerosi i luoghi della sua
opera maggiore nei quali ricorre il corrispondente volgare, soprattutto usato al plurale, di status (estats): esso
tuttavia conserva un’irriducibile polivalenza semantica, a seconda del ruolo funzionale occupato dal vocabolo
nei Six livres de la République, fin dalla loro pubblicazione nel 1576. Naturalmente, non è solo con riguardo
alla «condizione» che Bodin impiega il termine estat, bensì anche con riferimento alla tripartizione aristotelica
e polibiana delle forme di governo. Eppure, nonostante tutto, si tratta di un uso linguistico ancora incerto, che
oscilla tra la determinazione di uno stato di fatto, ovvero di una posizione cetuale elevata a «ordine», quando
non ancora di una forma di ordinamento politico(31).
Non può dunque sfuggire che, sempre per lo stretto profilo linguistico al quale per ora ci si sta
attenendo, il medesimo problema relativo alla polivalenza del termine «stato» lo avesse già posto (non per la
prima volta, e tuttavia in maniera divenuta esemplare) l’uso di tale vocabolo da parte di Machiavelli.
Sebbene sia ormai insostenibile la tesi secondo cui il celeberrimo passo d’apertura del Principe inauguri
l’uso in senso moderno del termine Stato («Tutti gli stati, tutti e’ dominii che hanno avuto e hanno imperio
sopra gli uomini, sono stati e sono o republiche o principati»), nondimeno rimane vero che il linguaggio
machiavelliano ha costituito un momento determinante per gli sviluppi concettuali relativi all’idea di Stato.
Questo «momento machiavelliano», per dirla con le parole dello storico del pensiero politico John Pocock,
può essere interpretato in diversi modi, i quali alimentano altrettante ipotesi intorno a quel duplice e
contestuale processo che molti continuano a vedere come personalizzazione dello «stato» (fino alla costruzione
della sua personalità giuridica, almeno a partire dalla celebre recensione scritta nel 1837 da Wilhelm Albrecht
ai Grundsätze des heutigen deutschen Staatsrechts di Romeo Maurenbrecher) e come simultanea, necessaria
spersonalizzazione di coloro, principe e aiutanti, da cui fattualmente viene esercitato l’«imperio».
L’ipotesi principale, sviluppata originariamente da Hans De Vries nel suo Essai sur la terminologie
constitutionnelle chez Machiavel — Il «Principe», profilata anche da Federico Chabod, infine sostenuta con
vigore e condotta alle sue estreme conseguenze da Gianfranco Miglio, è che nella terminologia di Machiavelli
lo «stato» equivalga al «gruppo ristretto e concreto di uomini i quali si dedicano all’esercizio del potere: gli
86
aiutanti fidati che esercitano l’"imperio" con il principe, e sono autorizzati a prendere decisioni capitali; mentre
il titolo che li legittima come partecipi dello "stato" è il possesso dell’autorità"» (32). In quest’idea di «stato»
come «équipe dominante» starebbe allora, secondo Miglio, il carattere fortemente «realistico» delle originarie
accezioni del concetto. È pertanto del tutto significativo che nell’interpretazione migliana dello svolgimento
complessivo dello Stato (e in ordine alla tesi secondo cui l’esperienza statale moderna rappresenta un
gigantesco tentativo di ridurre a «contratto» l’area dell’obbligazione politica), il «realismo» appaia non solo
presente carsicamente, ma anche destinato ad affievolirsi progressivamente e rapidamente, almeno fino al
chiudersi del ciclo storico del moderno Stato. La connotazione realistica dell’originaria idea di «stato» comincia
infatti già a soccombere, quando a quest’ultima si sovrappone, e si impone, la fictio dello Stato come
«complesso di istituzioni».
Lo «stato» dev’essere quindi concepito in primo luogo quale «stato del principe», conformemente del
resto con l’idea di status alla quale si riferivano i giuristi del Trecento per definire l’estat du royaume in solido
con lo status regis. Anche in Machiavelli, di conseguenza, persiste l’accezione patrimoniale del vocabolo
«stato», che in tal senso resta a indicare appunto la «condizione del principe», e, per estensione, del suo
territorio, inteso soggettivamente come il «suo stato».
Difatti, in quale modo il dominio territoriale (equivalente allo status di chi lo detiene) abbia potuto infine
risolversi nello «stato» del territorio in senso oggettivo — ovvero, per dirla con la formula tuttora valida di
Francesco Ercole, come si sia passati dallo «stato-soggetto» allo «stato-oggetto» (33) — è questione tutt’altro che
scontata, quando ci si attenga a un circostanziato esame del linguaggio machiavelliano. Probabilmente un simile
passaggio concettuale, presente in modo embrionale, non poteva che rimanere incompiuto in Machiavelli, il
quale aveva sì intuito o magari chiaramente intravisto la possibilità di personificazione dello Stato, ma non
poteva certo prevedere e delineare per intero quel poderoso processo di istituzionalizzazione che, soprattutto
legittimandosi mediante la ratio della «impersonalità del comando», avrebbe reso l’assetto complessivo dello
Stato il più possibile astratto rispetto agli individui e ai gruppi che lo costituiscono (o così, perlomeno, quando
si intenda trovare il più inossidabile elemento di unitarietà nella vicenda del moderno Stato, si continua
tutt’oggi e in quasi assoluta prevalenza a ritenere).
In effetti, è soltanto nel Cinquecento che incomincia a prefigurarsi con tutta evidenza lo straordinario
dispositivo concettuale destinato a godere di una larghissima fortuna nei secoli successivi, anche (e forse
soprattutto) come modello storiografico in grado di raffigurare lo Stato non solo quale persona (ficta), soggetto
astratto e perciò svincolato dagli individui che in concreto lo impersonano, bensì e in specifico quale struttura
di base a cui riportare, senza mutazioni essenziali e nemmeno variazioni così numerose o significative da
divenire sospette, tanto lo Stato di diritto quanto il cosiddetto Stato sociale.
Senza dubbio, in tale vicenda, un considerevole ruolo iniziale (e subito, in senso proprio, ideologico) è
stato svolto dai trattatisti della «ragion di Stato», il cui obiettivo era per l’appunto quello di capire e spiegare in
quale modo l’interesse personale e immediato del sovrano e del suo entourage potesse infine elevarsi a
«interesse di Stato». Nella nutrita schiera dei ragionatori di Stato, sarà Fabio Albergati a distinguersi per la sua
aspra polemica nei riguardi della dottrina bodiniana e in «difesa d’Aristotile». Quel che secondo Albergati era
da «riprovare» dell’opera di Bodin riguardava proprio l’assenza di una definizione dell’«oggetto» antecedente
alla puissance souveraine (summa potestas) della République: la moltitudine degli «istati» delle famiglie, dei
borghi e delle città di cui si compone infine lo «stato», che per Bodin varrebbe solo come nozione
«accidentale», riferibile tutt’al più a un modo d’essere empiricamente determinato e quindi mutevole della
respublica(34).
Ma un simile rilievo, vista anche la statura del pensatore al quale viene rivolto, induce a chiedersi non
tanto perché sia invalso da un certo momento in poi l’uso del neologismo Stato (così come ha ritenuto di
poterlo definire a tutti gli effetti Alessandro Passerin d’Entrèves)(35), bensì all’opposto che cosa ne ha impedito
per così lungo tempo l’impiego, anche laddove giungeva a piena e completa maturazione l’idea di sovranità,
come nel caso appunto della dottrina bodiniana.
È convincimento diffuso, già lo si è detto, che la ricostruzione del tentativo di calcare sul termine «stato»
il significato di realtà oggettiva (la quale, conta ricordarlo, deriva il proprio modo d’essere dall’estat du prince,
ma pure è a questo antecedente in quanto multitudo), debba procedere da un duplice e complementare
procedimento di personalizzazione della nuova «realtà» e di astrazione rispetto al principe medesimo. In tale
direzione, la chiave di volta parrebbe costituita da quella «finzione» che Ernst Kantorowicz dimostrerà operante
già nella riflessione tardo-medievale intorno ai «due corpi del re», e che come tale verrà addirittura ripresa nel
secolo xvi dai giuristi elisabettiani per dimostrare la dignitas imperitura del sovrano, in contrappunto con le
transeunti vicende di chi materialmente l’avrebbe impersonata. E tuttavia, è proprio Kantorowicz ad avvertire
che «mentre la giurisprudenza continentale poteva facilmente giungere al concetto di "Stato" in astratto o
87
identificare il principe con lo Stato, non arrivò mai a concepire il principe come corporation sole — un ibrido
dalla genealogia certo complessa — dalla quale il corpo politico in quanto rappresentato dal Parlamento non
poteva mai andare disgiunto» (36).
Vi è già qui un primo motivo di riflessione per quanto riguarda il contesto anglosassone, che per un
significativo lasso di tempo si presta infatti ad accogliere di preferenza, piuttosto del neologismo «Stato»,
commonwealth: dunque, proprio quel lessema (calco — essendo wealth la forma astratta di weal — del latino
bonum publicum), che nel secolo xvi giunge a indicare ordinariamente il «corpo politico», dopo essere stato
impiegato sino ad allora per denotare, nel contempo e indistintamente, tanto il «corpo politico» quanto il
«benessere».
Tra i numerosi esempi che si possono addurre, quello di John Locke resta — nel secolo successivo —
forse il più rilevante, giacché vi si riscontra una sorta di punto d’approdo nella vicenda del termine
commonwealth. È l’avvertenza che l’autore dei Two Treatises of Government formula nel secondo Libro, §
133: «Tutte le volte che dico "società politica" [commonwealth] bisogna ritenere ch’io intenda non una
democrazia o una qualsiasi forma di governo, ma una comunità indipendente, che i latini indicavano con il
vocabolo civitas, a cui il vocabolo che meglio corrisponde nella nostra lingua è commonwealth, che esprime
tale società di uomini molto più propriamente che non facciano i termini inglesi di community o city».
Sono due, allora, le questioni che qui vengono sollevate in forma di linguaggio stipulativo. La prima è la
connotazione «repubblicana» del termine commonwealth (conforme del resto alla traduzione letterale di
respublica, e pure affatto peculiare se risolta ad appannaggio del repubblicanesimo in senso stretto): proprio
ciò induce Locke a premettere come in specie non vi sia riferimento ad alcun tipo di regime o «forma di
governo». Con la seconda, invece, viene rimarcato lo scarto tra l’idea di civitas come modello di una comunità
«indipendente», ora denominata commonwealth, e le vere e proprie comunità cittadine intese quali corpora
civitati subordinata, dello stesso genere dei collegi o delle comunità ecclesiastiche.
D’altra parte, durante tutto il Seicento, non per caso gli esponenti del moderno giusnaturalismo
ricorreranno di preferenza al concetto di respublica per designare l’ordinamento della civitas, senza che
avvertano mai l’urgenza di impiegare, al posto di quest’ultima nozione, il termine «stato». Né serve a molto
ricordare che Grotius, Pufendorf o ancora Wolff scrivessero in latino: una circostanza, questa, che anzi
sembrerebbe dimostrare quanto vicina al suo significato originario fosse per allora la nozione di «stato», e di
conseguenza quanto poco familiare risultasse la vera e propria invenzione del neologismo Stato(37).
Sembrerebbe quindi che sia, per l’appunto, la difficoltà di denominare una forma di organizzazione
politica — qual è quella che viene consolidandosi a discapito del vocabolario di cui dispongono coloro i quali la
osservano — a condizionare l’impiego del termine Stato. Se si guarda meglio, però, una simile posizione di
stallo in cui s’imbatte l’état du jeu linguistico risulta addebitabile con facilità alla nozione circolare del termine
Stato. Il quale altro non è se non la sostantivazione di un modo d’essere riferito allo status di una pluralità di
soggetti, e poi per passaggi successivi a quello di un solo agente sovrano, la cui condizione in tanto viene
percepita come tale in quanto la si vuole in ogni caso indeclinabile.
Così, il sistema di dominio assolutista si inscrive fin dentro il lessico politico, che, con modalità e tempi
diversi a seconda dei differenti contesti territoriali, vede declinare gli «stati» (intesi ovviamente in senso cetuale,
quali Stände, estates), nello Stato «sovrano». Allo stesso modo, anche se per converso, quella cetuale rimane
per un tempo più o meno lungo la componente semantica cospicua e immediatamente visibile del termine
«stato», che proprio per questo motivo tarderà a comparire in luogo del concetto moderno di sovranità.
Il problema è allora vedere per quali ragioni e sotto quali condizioni, al culmine di quel processo per cui
lo Stato diviene esso stesso persona giuridica in grado di inglobare la figura concreta del sovrano, risulti
possibile una qualche ulteriore e decisiva declinazione dell’idea di Stato, se non per lo Stato medesimo. Detto
altrimenti, e più drasticamente: fino a qual punto è possibile intravedere una via d’uscita alla tautologia dello
Stato (sovrano), senza incorrere in una enunciazione pleonastica qual è in effetti quella di «Stato per ceti», o
Ständestaat, che è servita soprattutto per la mise en relief del secondo termine, divenuto così il vero centro
d’interesse dell’enunciato in questione.
È certamente un passaggio indispensabile, quest’ultimo, per uscire dalla circolarità del concetto di
konstitutionellen Staatsverfassung, di «costituzione costituzionale», e quindi per oltrepassare lo Stato
costituzionale (di diritto) in prospettiva della concreta «costituzione statale» radicata nelle articolazioni del
potere a livello territoriale. Ma è del resto ben noto come lo stesso Otto Brunner, che forse più di qualunque
altro storico ha contribuito ad avvalorare questa prospettiva, abbia avvertito il rischio di trascurare il «momento
dell’unità politica» una volta abbandonato del tutto il concetto, anzi il «superconcetto» (Oberbegriff), di
Stato(38): come a dire che è ancora per il tramite delle coordinate concettuali indicate da quest’ultimo che si
rendono decifrabili le trasformazioni della moderna organizzazione del potere, anche laddove esse siano il
88
risultato di processi situabili al di fuori dello Stato, ossia nella (dis-)articolazione in senso pluralista della società
e nella mutevole e instabile struttura delle relazioni internazionali.
Precisamente in questo senso occorre cercare di stabilire se e fin dove sia ancora possibile tematizzare la
nozione di Stato, rispettivamente — ma anche congiuntamente — in termini di «pluralismo» per il versante
interno, e di «internazionalizzazione» (più d’uno direbbe ormai «globalizzazione»), per quel versante esterno
finora considerato del tutto distinguibile e spesso opposto al primo.
…
6. Il ruolo economico dello Stato e l’economia costituzionale.
Anziché porre unilateralmente l’enfasi sul «ritrarsi» dello Stato dalla società e dall’economia, così da
legare le sue sorti all’andamento congiunturale dell’apparato produttivo, sembra di gran lunga più plausibile
ritenere che vi sia stato un processo di ridefinizione delle sue funzioni, il quale ha visibilmente inciso sui mezzi,
la forma, e soprattutto gli obiettivi dell’intervento statale(45). Così, mentre gli strumenti di attuazione delle
politiche pubbliche sono per la gran parte passati da una gestione statale diretta a una indiretta per via del
ricorso ad agenti quasi-pubblici o anche del tutto privati, per converso va aumentando il peso dell’attività
regolativa dello Stato in alcuni settori nevralgici del mercato, per lo meno quando si consideri quest’ultimo
come un meccanismo soggetto sia ad attriti di tipo istituzionale, sia a variazioni nel processo produttivo. Se
questi due aspetti non vengono assunti come dati dall’analisi economica, allora diviene cruciale interrogarsi su
quale sia e possa essere il ruolo economico dello Stato.
In effetti, anche se ci si attenesse solo ed esclusivamente a un’esposizione di tipo descrittivo (senza cioè
domandarsi in prima battuta se lo Stato debba avere un ruolo economico, minimo o massimo che sia), risulta
nondimeno agevole cogliere il carattere cogente di un simile problema, già a partire dall’analisi dei «costi di
transazione» connessi agli scambi di mercato. È forse il caso di ricordare che, sulla scorta dell’ormai classica
trattazione di Oliver E. Williamson, vengono definiti di transazione quei costi legati all’assenza di mutua fiducia
(distrust) delle parti contraenti, le quali sono perciò indotte a premunirsi dai rischi di inadempienza unilaterale
o reciproca accordandosi su ogni possibile evenienza sfavorevole: può così darsi la possibilità, per nulla
remota, che i costi connessi con una specificazione quanto più possibile esaustiva degli accordi siano talmente
alti da sospingere i contraenti a confidare in pratiche contrattuali atipiche o non convenzionali(46).
In tal modo il sistema normativo, che funge da supporto alle relazioni contrattuali, anziché essere preso
come dato, viene elevato a variabile interveniente nell’analisi dei costi di transazione. Di conseguenza, la scelta
di un determinato quadro di garanzie legali implica anche un diverso tipo di condotta transattiva: si pensi per
esempio al caso dell’economia sommersa, in cui i benefici derivanti dall’eludere il sistema contributivo
vengono generalmente stimati maggiori dei costi connessi a un vincolo contrattuale garantito per legge.
In simili circostanze appare evidente che il cosiddetto governo dell’economia non possiede, né potrebbe
mai possedere, una configurazione unitaria, dal momento che i livelli di governo variano a seconda dei
differenti (livelli di) costi di transazione che le parti sociali sono disposte a sostenere, e che vengono
diversamente stimati anche in ragione della velocità del processo di innovazione economica.
Da questo punto di vista l’analisi tradizionale dello sviluppo economico muove dalla constatazione
evidente, e di per sé incontrovertibile, che il cambiamento tecnologico impedisce di predeterminare in anticipo
le variazioni del processo produttivo, sicché non potrebbe darsi altra possibilità se non quella di agevolare
l’iniziativa imprenditoriale. Tuttavia, una simile impostazione del problema prescinde totalmente dalla
riflessione intorno ai «sistemi nazionali di innovazione», che non solo sono ammissibili in linea teorica (per
quanto non ortodossa questa possa apparire), ma costituiscono in pratica un fattore di incidenza determinante
per cogliere l’effettivo impatto esercitato dal processo di internazionalizzazione sui singoli paesi.
Se è vero che i sistemi di innovazione non dipendono solo dal grado di entrepreneurship di una
determinata area geografica, e nemmeno in modo preponderante da eventuali incentivi statali, bensì e
propriamente dalle specifiche circostanze «ambientali» presenti in un dato territorio, allora è inevitabile
commisurare la competitività delle economie nazionali alla loro capacità di orientare in un modo o nell’altro i
percorsi innovativi. Si pensi in proposito, per esemplificare ulteriormente, al caso degli standard tecnologici,
che sono il risultato di scelte tecniche spesso sostenute e assecondate da nazioni divenute egemoni in
determinati settori produttivi, proprio in virtù di una promozione mirata del patrimonio di conoscenze
maturato al loro interno e quindi esportato ad altri paesi (in particolare a quelli in via di sviluppo).
Non si tratta con questo di riproporre una visione mercantilista dei rapporti tra gli Stati. Ciò comporta
semmai la necessità di cogliere il differente grado di incidenza che l’azione di governance dell’economia da
89
parte degli Stati ha sul processo di internazionalizzazione, sia in termini di canalizzazione dell’innovazione, sia
in rapporto alla formazione di «mercati sicuri», ossia caratterizzati da ridotti costi di transazione in presenza di
un’elevata fiducia reciproca tra i contraenti (o viceversa).
Una volta accertato che gli Stati svolgono comunque un ruolo economico più o meno vincolante,
possiamo allora interrogarci in termini normativi su quel che dovrebbe essere l’azione statale in economia a
seconda del diverso tipo di scelte compiute sul terreno di quella «politica costituzionale» alla quale si è
accennato in precedenza. Evidentemente una definizione normativa dell’attività economica dello Stato non è
del tutto svincolata da presupposti analitico-descrittivi, che in un certo modo la rendono operativa. E in questo
senso possono entrare in gioco proposizioni prescrittive che non sono situate al di fuori del mercato (per
esempio il trade off tra efficienza ed equità), ma che piuttosto sono consequenziali al «fallimento» di
quest’ultimo nel fornire una soluzione ottimale ad alcuni cruciali problemi come quelli sollevati (segnatamente)
dai beni pubblici, dalle esternalità e dai monopoli naturali.
È da notare come numerosi aspetti di questo dibattito siano tuttora al centro degli sviluppi di quel
composito indirizzo di studi che va sotto il nome di New Political Economy, la quale può qualificarsi a un
tempo in senso internazionale e costituzionale. Per quest’ultimo caso, ancor più che di una «costituzione
economica» in senso stretto (sia pure in un’accezione nuova rispetto alla tradizionale disciplina dell’economia
anteriore all’emergere di organizzazioni sovranazionali come l’Unione Europea)(47), si potrebbe parlare di una
economia costituzionale in grado di svolgere una specifica, e di volta in volta rivedibile, funzione di cerniera tra
le varie cerchie di appartenenza (d’interessi e di territorio), così come vengono ridisegnandosi a seguito dei
processi opposti e complementari di internazionalizzazione e regionalizzazione. Non si discute, in sostanza, di
quella parte delle norme fondamentali che disciplinano l’economia, bensì di quegli aspetti economici che
assumono una piena rilevanza costituzionale in quanto interferiscono con la «concreta forma di un
ordinamento politico».
…
8. Il sistema degli Stati.
Si è già osservato come non sia necessario ricorrere alla distinzione tra descrittivo e normativo per
riconoscere che risulterebbe insoddisfacente per più di una ragione la sola descrizione dello Stato improntata
al cosiddetto «realismo», tanto in senso sociologico (nei termini a noi già noti del pluralismo, in una direzione
opposta al formalismo giuridico), quanto in un senso strategico (con riguardo in particolare ai rapporti di forza
tra gli Stati). Per quanto il realismo dei pluralisti differisca radicalmente da quello degli internazionalisti proprio
in ordine all’assunzione dello Stato quale unità d’analisi (che è tanto irrilevante per i primi quanto
determinante per i secondi), nondimeno ambedue le impostazioni finiscono col risultare complementari, nella
misura in cui relegano la dimensione giuridica a un ruolo marginale o strumentalmente funzionale rispetto ai
rapporti di forza «reali» (o presunti tali), presenti nelle singole società nazionali o nel sistema politico
internazionale.
In effetti, e non per caso, ci troviamo nella singolare circostanza di poter osservare e meglio intendere la
natura e le funzioni dell’ordinamento statale, a partire dallo stesso punto di vista dal quale gli studiosi del diritto
internazionale sono da tempo abituati a descrivere e valutare il proprio oggetto: ossia come un complesso
normativo che aderisce a una situazione di tendenziale «anarchia» (51), ma che non per questo risulta del tutto
svincolato da un principio d’ordine.
Nel preciso momento in cui si riconosce la natura pluralistico-conflittuale delle relazioni di base che
fanno da sfondo all’ordinamento statale, e che vengono impropriamente proiettate all’esterno di esso nei
rapporti tra gli Stati, ci si avvede di come la sintesi che ne dovrebbe scaturire non abbia necessariamente le
caratteristiche di un gioco a somma zero, come invece si è creduto a partire dal mercantilismo per arrivare agli
odierni «realisti». D’altra parte, né l’orientamento liberale, né quello marxista (gli altri due maggiori indirizzi
che, insieme all’ultimo appena richiamato, risultano predominanti tra gli specialisti di relazioni internazionali),
hanno fornito argomenti decisivi a sostegno dei rispettivi assunti teorici. Di certo non convince la trattazione
dello Stato quale mero riflesso dei rapporti antagonistici di mercato, o quale luogo di intersecazioni di interessi
d’impresa cui soggiacciono più o meno passivamente gli apparati politico-amministrativi dei paesi che li
accolgono.
Una volta accertata l’effettiva riduzione di autonomia decisionale degli Stati per effetto dell’integrazione
dei mercati e dell’interdipendenza finanziaria (la quale, va aggiunto, di per sé può sempre rovesciarsi in una
teoria della dipendenza o del sottosviluppo situabile già in prossimità dell’emergere di quella «economia90
mondo europea», che uno studioso d’orientamento marxista come Immanuel Wallerstein ha ripercorso a
partire dal xvi secolo), bisogna notare che, paradossalmente, «[n]ello stesso momento in cui il sistema degli stati
assorbe il mondo intero, lo stato singolo può perdere parte del suo significato» (52).
È questo un rilievo che appare non meno plausibile anche quando si pensi, per converso, che
l’interdipendenza dei mercati sembra condurre, più che alla polarizzazione tra nazioni con differenti traiettorie
di sviluppo (nel senso cioè di quella teoria della dipendenza o del sottosviluppo di cui si è appena detto), a una
convergenza di tutte le società nazionali verso la segmentazione dei rispettivi apparati produttivi, così da
assoggettare tutti gli Stati indistintamente al medesimo tipo di sollecitazioni «sistemiche ».
In sostanza, all’ovvia constatazione circa il declino dello Stato quale entità sovrana, bisogna affiancare la
registrazione, per certi versi sorprendente, del duplice fatto che il «sistema degli Stati» si rafforza e
contestualmente agevola al proprio interno la proliferazione di nuovi soggetti statali, e che, al proliferare di
questi soggetti, il fondamentale rapporto che ha storicamente legato «Stato» e «democrazia» non solo — nello
stesso tempo e contraddittoriamente — si stringe in taluni punti e si allenta in altri, ma anche muta per funzioni
e in qualità (53).
Così, a misura che assistiamo alla progressiva diffusione di un unico modello di «forma-Stato», non
tardiamo ad accorgerci come quest’ultima si sia trasformata in una sorta di prerequisito indispensabile per
l’accesso alle organizzazioni internazionali da parte di paesi pure lontanissimi dall’esperienza del «moderno
Stato europeo». E non è pertanto un caso se le stesse nazioni europee, che per prime (sia pure con modalità
molto diverse l’una dall’altra) sono state le artefici principali di questa esperienza, vedano rapidamente scemare
nel volgere di questo secolo le peculiarità che in origine marcarono i rispettivi processi di formazione statale.
Tutto questo non significa, ovviamente, che siano venuti meno i tratti distintivi e talora unici ai quali è
legata la storia dello sviluppo istituzionale dei singoli paesi(54). La diffidenza dell’attuale storiografia nei
confronti della modellistica comparata sta a ricordarci, semmai, il contrario. È da notare tuttavia come non si
sia forse riflettuto a sufficienza sui motivi per cui gli Stati, anziché diversificare le loro politiche in ragione delle
specifiche e sempre più frammentate realtà territoriali, abbiano assunto stili politico-decisionali
complessivamente simili gli uni agli altri, sia pure nel segno (negativo) di un generale indebolimento dell’azione
statale, da interpretarsi (in positivo) come possibile flessibilità e conformità (più che subordinazione) alle «leggi
del mercato». Se così è, allora non serve granché interrogarsi sulla odierna e sempre più esplicita attitudine
dello Stato a delimitare le sue pretese di controllo e gestione della società e dell’economia, giacché in questi
termini nulla vieta di pensare — anche solo per ipotesi — che il pendolo possa tornare ad oscillare nella
direzione opposta di un «ritorno allo Stato», il quale ritorno risulterebbe altrettanto se non più fuorviante della
prospettiva inversa.
Con ogni probabilità, stiamo assistendo a una cruciale fase di trasformazione della forma-Stato lungo
due diverse direttrici che interessano allo stesso tempo i processi e le strutture statali, e che però quasi mai
procedono nell’identico senso. Ne è un esempio l’emergere di processi federativi e di pratiche di negoziazione
che scavalcano o aggirano la struttura istituzionale più o meno centralizzata degli Stati, soprattutto in presenza
di un alto grado di disomogeneità territoriale. Non che sia sufficiente affidarsi in proposito alla spiegazione
dello Stato quale struttura già per definizione «stabilizzante», come se così e semplicemente si potesse
anteporre alla dinamicità dell’area del «contratto-scambio» l’apparente immutabilità e staticità dell’«obbligo
politico». In tal modo si finirebbe infatti con l’identificare nuovamente lo Stato con la politica, o per meglio
dire con una definizione assai riduttiva di quest’ultima.
È vero anzi che un simile approccio strutturale alla moderna organizzazione del potere rischierebbe
fatalmente di racchiudere l’immagine dello Stato in una sorta di compartimento stagno del tutto impermeabile
al concreto, mutevole e spesso imprevedibile «flusso storico» dal quale sono emersi originariamente i diversi
processi di formazione statale(55), le cui traiettorie di sviluppo, lo ripetiamo ancora, appaiono al momento
attuale di gran lunga più ravvicinate tra loro di quanto non lo fossero soltanto mezzo secolo addietro. E questa
convergenza non può ritenersi accidentale. Con ogni probabilità, si tratta dell’esito ultimo e più evidente di una
dinamica storica, al culmine della quale anche quei paesi maggiormente caratterizzati da una diffusa
consistenza del potere a livello territoriale sono alle prese con i medesimi problemi che attanagliano gli Stati
con una tradizione consolidata di centralismo amministrativo.
sull concetto tradizionale di Stato
Considerazioni su
Questa ricca lettura dimostra la difficoltà di accedere ad una nozione appagante di Stato. È,
quindi, preferibile accontentarsi di individuare alcuni fattori sintomatici dell’esistenza di uno Stato,
piuttosto che tentare di inseguire un concetto inafferrabile ed evanescente.
91
Si è detto che tre sono gli elementi costitutivi dello Stato. Ed è ciò che si legge spesso nei
manuali, non solo di diritto costituzionale.
La verità è che, oggi, questa triade non ha lo stesso significato di un tempo.
Si pensi innanzitutto al territorio
territorio. I confini sono divenuti liquidi. La globalizzazione ha reso le
relazioni sociali ed economiche decisamente più rapide e facili rispetto al passato. Le transazioni
commerciali sempre più si svolgono in rete, e non con la circolazione fisica di persone e cose.
Rispetto al fattore economico, dunque, i confini hanno smarrito gran parte del loro significato
originario di barriere erette a presidio dei sistemi produttivi nazionali. La delocalizzazione delle
imprese completa il quadro. Sul piano politico, poi, trattati internazionali relativamente recenti hanno
rimosso le frontiere tra gli Stati, garantendo una piena e libera circolazione: si pensi all’accordo di
Schengen.
Quanto al popolo,
popolo la cittadinanza, specie in campo economico, ha perso la risalente funzione
discriminante tra cittadini e non quanto alle opportunità di produrre beni o di svolgere attività
commerciali o finanziarie. Con lo sviluppo del processo di integrazione europea, poi, la cittadinanza
ha assunto contorni più estesi, e le distanze tra i cittadini dei paesi membri dell’Unione europea si
sono ridotte a ben poco. Oggi la cittadinanza rileva sul versante del diritto di voto limitatamente alle
elezioni politiche. Il crescente ed imponente afflusso di immigrati ha, poi, reso non più rinviabile un
ripensamento circa le modalità di acquisto della cittadinanza, viste soprattutto le concrete modalità di
integrazione delle seconde generazioni che non possono vantare alcuna pretesa basata sullo ius soli.
Infine, il governo e, con esso, la sovranità.
sovranità Ancora una volta la globalizzazione ha
progressivamente eroso la sovranità, come capacità delle istituzioni nazionali di autodeterminarsi. Gli
Stati hanno ceduto via via ingenti fette di sovranità ad organismi sovranazionali: si pensi ancora una
volta all’Unione europea. Sovente i processi decisionali in atto nei singoli Stati sono sensibilmente
condizionati da elementi esogeni: le agenzie di rating, gli organismi commerciali transnazionali, la
banca mondiale. Tutte entità che hanno poco o nulla in comune con l’idea tradizionale di Stato e che
difettano di legittimazione e di rappresentatività democratica.
Pertanto, questi elementi innovativi, sommariamente descritti, concorrono a dimostrare che in
questa epoca la nozione di Stato non è più quella di qualche decennio fa, e che occorre ripensare
alcuni concetti ritenuti erroneamente consolidati.
I titolari dei tre poteri dello Stato sono il Parlamento, il Governo e l’ordine giudiziario.
Il Parlamento
Di regola, il potere legislativo spetta al Parlamento
Parlamento,
ento che a sua volta si articola in due “rami”: la
Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica.
Repubblica
Questa scelta è la conseguenza dell’accoglimento del principio del bicameralismo perfetto:
perfetto una
assemblea legislativa suddivisa in due organi collegiali (bicameralismo), i quali, nonostante alcune
differenze marginali quanto all’elettorato attivo e passivo e al numero dei componenti, esercitano le
medesime funzioni (bicameralismo perfetto).
La funzione legislativa del Parlamento si esprime attraverso la legge ordinaria,
ordinaria che nel sistema
delle fonti occupa il gradino immediatamente più basso rispetto a quello della Costituzione. La legge
ordinaria è l’epilogo di un procedimento (→ insieme di atti e operazioni coordinate e indirizzate vero
l’adozione i un determinato atto, secondo una scansione rigidamente regolata dal diritto), i cui tratti
essenziali sono i seguenti:
92
- fase dell’iniziativa: la Costituzione contempla un numero chiuso di soggetti legittimati a
presentare proposte di legge (ogni parlamentare, il Governo, il popolo tramite un progetto sottoscritto
da almeno 50.000 elettori, ogni consiglio regionale, il C.n.e.l.);
- fase costitutiva: in questa fase intervengono le commissioni
commissioni parlamentari permanenti e
competenti per materia,
materia composte esclusivamente da parlamentari in modo tale da rispecchiare
l’equilibrio tra le forze politiche presenti in ciascuna Camera. Più precisamente:
a) se la commissione discute e vota la proposta di legge e, successivamente, anche la Camera
(o il Senato) fa lo stesso, allora si parla di commissione in sede referente (→ procedimento
ordinario);
b) se la commissione discute e vota definitivamente la proposta di legge, senza che intervenga
la Camera (o il Senato), allora si parla di commissione in sede deliberante o legislativa (→
procedimento decentrato);
c) se la commissione discute la proposta di legge e poi la Camera (o il Senato) si limita a
votarlo, quindi non lo discute, allora si parla di commissione in sede redigente (→
procedimento misto).
Per il voto è sufficiente la maggioranza semplice (cinquanta per cento più uno dei presenti).
Una volta che il testo è licenziato da una Camera, esso passa all’altra. Alla fine i due rami del
Parlamento dovranno approvare lo stesso identico testo.
- fase integrativa dell’efficacia: la proposta di legge votata o dalla commissione o dalla Camera (o
dal Senato) è perfetta, ma non ancora efficace. Per esserlo sono necessarie:
a) la promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica, il quale può anche
rinviare la legge alle Camere se le ritiene affette da incostituzionalità. Se però le Camere
riapprovano il testo tale e quale, allora il Presidente della Repubblica deve procedere con la
promulgazione (salvo che non si esponga, in tal modo, al rischio di essere in futuro
incriminato per attentato alla Costituzione o alto tradimento);
b) la pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Dal quel
momento decorrono, di regola, quindici giorni (→ vacatio legis) al termine dei quali
finalmente la legge produce i suoi effetti (→ entrata in vigore).
Il Parlamento esercita anche il potere legislativo di revisione costituzionale,
costituzionale in forza del quale o
modifica la Costituzione o adotta leggi costituzionali, ossia fonti del diritto equiparate alla
Costituzione. La nostra è una Costituzione rigida in quanto prevede, a tal fine, una procedura
aggravata (→ art. 138 Cost.). Gli elementi di aggravamento di tale procedura, rispetto al
procedimento legislativo ordinario, sono i seguenti:
1) doppia deliberazione:
deliberazione il testo deve essere votato due volte in ciascun ramo del Parlamento a
distanza non inferiore a tre mesi;
2) maggioranza:
maggioranza in entrambi i rami del Parlamento per la seconda votazione è necessaria la
maggioranza assoluta (cinquanta per cento più uno dei membri);
3) referendum: se alla Camera e al Senato non viene raggiunta la maggioranza dei due terzi
nella seconda votazione, allora un quinto dei membri di ciascuna Camera, cinque consigli
regionali o 500.000 elettori possono, entro tre mesi dalla pubblicazione notiziale del testo,
chiedere un referendum con il quale si chiede agli elettori di votare a favore o contro la
riforma votata dal Parlamento. Non è previsto un quorum costitutivo, per cui non è
necessario che alla consultazione referendaria partecipi la maggioranza degli aventi diritto.
Le leggi ordinarie (e le altre fonti primarie statali del diritto) possono essere sottoposte a
referendum abrogativo,
abrogativo così che saranno gli elettori a decidere se mantenere in vita una data
disciplina legislativa oppure abrogarla (→ art. 75 Cost.).
93
Il Governo
Il potere esecutivo è assegnato dalla Costituzione al Governo.
Governo Il Governo (organo complesso) è
composto da un Presidente del Consiglio dei ministri (organo monocratico) e da un certo numero di
ministri (anch’essi organi monocratici), che insieme formano il Consiglio dei ministri (organo
collegiale).
I ministri con portafoglio sono preposti ad una apposita struttura burocratica complessa (il
ministero),
ministero mentre i ministri senza
senza portafoglio sono destinatari di una delega da parte del Presidente
del Consiglio in relazione a determinate tematiche.
Nella nostra forma di governo parlamentare il Governo deve godere della fiducia di entrambe
le Camere. Più precisamente:
- il Presidente della Repubblica, una volta effettuate le consultazioni, nomina il Presidente del
Consiglio che, a seguito delle più recenti riforme del sistema elettorale, è il leader della
coalizione che ha vinto le elezioni;
- il Presidente della Repubblica nomina, poi, i singoli ministri,
ministri su proposta del Presidente del
Consiglio;
- il Presidente del Consiglio e i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica. Da questo momento, il nuovo Governo può occuparsi degli affari correnti
(ossia quelle attività che non impegnano l’indirizzo politico e il rapporto fiduciario con le
Camere), nonché dei casi straordinari di necessità e di urgenza;
- entro dieci giorni dal giuramento, il Presidente del Consiglio si presenta alle Camere per
illustrare il programma
programma di governo;
- ciascuna camera è, quindi, chiamata a votare la mozione di fiducia,
fiducia a maggioranza semplice
e a voto palese per appello nominale. Da questo momento il Governo acquista la pienezza
delle proprie attribuzioni.
Il rapporto di fiducia viene meno e, dunque, il Governo è costretto a dimettersi:
a) quando una Camera vota la mozione di sfiducia,
sfiducia a maggioranza semplice e a voto palese
per appello nominale;
b) quando il Governo ha posto la questione di fiducia su di un determinato atto, e una delle
due Camere ha votato contro;
c) quando il Presidente del Consiglio si dimette.
dimette
Il Governo non svolge solo attività qualificabili come espressione del potere esecutivo, ma, nei
casi tassativamente previsti dalla Costituzione, può anche adottare atti legislativi aventi forza di legge.
Le fonti primarie del diritto poste in essere dal Governo sono il decreto legislativo e il decreto legge.
1) Decreto legislativo (→ art. 76 Cost.): il Governo emana un decreto legislativo sulla base di
una previa legge delega approvata dal Parlamento, il quale delega al Governo l’esercizio
della funzione legislativa. La legge delega deve contenere: i princìpi e i criteri direttivi,
l’oggetto da regolare, il termine entro il quale adottare uno o più decreti legislativi.
2) Decreto legge (→ art. 77 Cost.): di questo fonte primaria del diritto occorre ricordare
quanto segue:
- il Governo puà emanare un decreto legge in casi straordinari di necessità e di urgenza;
urgenza
- il decreto legge, una volta emanato dal Presidente della Repubblica, è pubblicato nella
Gazzetta ufficiale ed entra in vigore immediatamente;
- entro sessanta giorni dalla pubblicazione deve essere convertito in legge dal Parlamento.
Sicché, il Presidente del Consiglio presenta alle Camere un disegno di legge di conversione
del decreto legge, che deve essere approvato in modo tale da rispettare il suddetto termine;
- se manca la conversione in legge (perché le Camere hanno lasciato trascorrere il suddetto
termine senza decidere, o perché una di esse ha votato contro la conversione), allora il
decreto legge perde efficacia sin dall’
dall’inizio.
inizio In altri termini, in difetto di conversione il
94
decreto legge è come se non fosse mai entrato in vigore: i suoi effetti vengono meno
retroattivamente;
- il Parlamento può con legge regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
Quanto ai possibili abusi cui si presta il decreto legge, si ricorda quanto segue:
- il Governo non può adottare un decreto legge nei casi in cui la Costituzione espressamente
attribuisce alla legge ordinaria o ad un’altra fonte primaria una determinata materia o un
certo compito (così, ad es., il Governo non può usare il decreto legge per delegare
l’esercizio della funzione legislativa, o per convertire in legge un altro decreto legge, o per
approvare il bilancio, o per autorizzare la ratifica dei trattati internazionali, o per concedere
l’amnistia o l’indulto, o per dichiarare lo stato di guerra, o per disciplinare l’organizzazione
di Camera e Senato, ecc.);
- se il Parlamento non converte in legge il decreto legge, il Governo non può, se non
ricorrono nuovi casi straordinari di necessità e d’urgenza, adottare nuovamente la stessa
disciplina con un altro decreto legge, e continuare così ogni volta che il Parlamento non
avrà convertito in legge. La reiterazione dei decreti legge è stata dalla Corte costituzionale
dichiarata illegittima perché vanifica la perentorietà del termine di sessanta giorni per la
conversione (→ sentenza n. 360 del 1996);
- in caso di palese difetto dei presupposti (i casi straordinari di necessità e d’urgenza), la
Corte costituzionale può dichiarare l’incostituzionalità del decreto legge anche se è
intervenuta la conversione in legge (→ sentenza n. 171 del 2007);
- se in sede di conversione il Parlamento introduce nel decreto legge emendamenti del tutto
estranei all’
all’oggetto originario del decreto stesso, la Corte costituzionale è legittimata a
dichiarare l’incostituzionalità di tali disposizioni “eccentriche” (→ sentenza n. 22 del 2012).
Il Governo non produce diritto oggettivo soltanto attraverso i decreti legislativi e i decreti legge,
ma anche tramite i regolamenti,
regolamenti che sono fonti secondarie del diritto subordinate alla legge e agli atti
aventi forza di legge. Su di essi si rinvia alla precedente analisi della riserva di legge.
La pubblica amministraz
amministrazione
ione
Il Governo esercita le funzioni ascrivibili al potere esecutivo anche tramite la pubblica
amministrazione. Più precisamente, le pubbliche amministrazioni sono organizzazioni giuridiche,
amministrazione
istituite dal diritto, per provvedere alla cura concreta di interessi generali.
Come si vedrà più avanti, le pubbliche amministrazioni esercitano poteri amministrativi.
amministrativi Dal
punto di vista organizzativo occorre osservare che:
- si tratta di organizzazioni create dal diritto (e non da negozi giuridici, come ne caso delle
società, che sono istituite tramite un contratto);
- esistono solo le pubbliche amministrazioni costituite dalla legge;
- i rapporti al loro interno sono retti dal modello della sovraordinazione/subordinazione (in
rari casi, da un modello gerarchico): dunque, l’organo sovraordinato svolge funzioni di
direzione e di coordinamento nei confronti degli organi subordinati;
- il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni è stato privatizzato e, dunque,
equiparato all’impiego privato. Di pubblico impiego oggi si può parlare solo in relazione ad
alcune specifiche amministrazioni (es. forze armate, forze di polizia, università ecc.).
Quanto alle amministrazioni preposte alla erogazione di servizi pubblici (acqua, elettricità,
telefono, gas, trasporti, servizi postali ecc.), si registra la seguente evoluzione:
a) un tempo tali servizi erano erogato dalle amministrazioni autonomie,
autonomie che, in realtà, erano
ramificazioni dirette dei ministeri (es. amministrazione poste e telegrafi). Ciò significa che il
loro bilancio era incluso in quello del ministero di riferimento, i vertici erano scelti dal
95
ministero, la struttura operativa ricalcava quella ministeriale, che però era stata pensata per
l’esercizio di funzioni pubbliche, non per l’erogazione di servizi;
b) per rimediare alle inefficienze di tali enti, si è passati alla forma di ente pubblico
economico,
economico che ha acquisito una sostanziale autonomia dal ministero di riferimento, pur
dipendendo dal punto di vista finanziario da esso (es. Ente Poste italiane);
c) posto che anche l’ente pubblico economico non poteva considerarsi la formula
organizzativa più congeniale per l’assolvimento di tali compiti, si è passati finalmente alla
società per azioni (es. Poste italiane S.p.A.).
L’ordine giudiziario
La funzione giurisdizionale è attribuita alle istituzioni che, nel loro complesso, formano l’ordine
ordine
giudiziario.
giudiziario Più precisamente:
a) giustizia civile:
civile giudice di pace e tribunale (in primo grado), corte d’appello;
b) giustizia penale:
penale giudice di pace, tribunale, corte d’assise (in primo grado), corte d’appello e
corte d’assise d’appello;
c) giustizia amministrativa:
amministrativa tribunali amministrativi regionali (in primo grado), Consiglio di
Stato (appello);
d) giustizia tributaria:
tributaria commissioni tributarie provinciali, regionali, centrale;
e) giustizia contabile:
contabile Corte dei conti.
A ciò vanno aggiunte altre giurisdizionali speciali o sezioni specializzate della giustizia civile (es.
tribunali delle acque pubbliche, tribunali dei minorenni, giurisdizione militare), e, soprattutto, va
aggiunta la Corte di cassazione.
cassazione Essa svolge una funzioni di uniformità nell’interpretazione e
nell’applicazione del diritto (→ nomofilachia). Come tale essa opera quale giudice di legittimità,
legittimità
avverso le sentenze pronunciate dai giudici di merito (ossia quelli prima indicati). Normalmente, il
processo si conclude con una pronuncia della Cassazione e, dunque, si afferma che in questo modo
la sentenza passa in giudicato.
giudicato
La Costituzione enuncia una serie di princìpi fondamentali in materia giudiziaria (artt. 101 e
seguenti), tra i quali:
- la giustizia è amministrata in nome del popolo;
popolo
- i giudici sono soggetti soltanto alla legge;
legge
- la funzione giurisdizionale è esercitata dagli organi giudiziari ordinari;
ordinari
- non si possono istituire giudici speciali o straordinari:
straordinari infatti, nessuno può essere distolto dal
giudice naturale precostituito per legge;
legge
- la magistratura costituisce un ordine autonomo
autonomo e indipendente dagli altri organi. A tal fine
opera il Consiglio superiore della magistratura quanto ai magistrati ordinari;
- i magistrati sono assunti tramite concorso pubblico;
pubblico
- i magistrati sono inamovibili e possono essere trasferiti solo con il loro consenso o a seguito
di un procedimento che assicuri tutte le garanzie di difesa;
- i magistrati si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni;
funzioni
- l’ufficio del pubblico ministero è assistito dalle medesime garanzie di autonomia e
indipendenza previste per i magistrati ordinari.
A sua volta, l’attività
attività processuale è retta, in particolare, dai seguenti princìpi costituzionali:
- ogni persona ha diritto di agire in giudizio;
giudizio
- ogni individuo ha diritto alla difesa in giudizio;
- in materia penale, vige la presunzione
presunzione di non colpevolezza,
colpevolezza che viene meno solo con la
sentenza definitiva di condanna;
- ogni persona ha diritto ad un giusto processo,
processo che si svolga in un lasso di tempo
ragionevole,
ragionevole in contraddittorio tra le parti, dinanzi ad un giudice terzo e imparziale
imparziale.
le
96
Gli organi di garanzia
Gli organi di garanzia si proiettano al di fuori dell’orizzonte illuminato dai tre classi poteri. Ad
essi, infatti, spetta il compito di garantire la tenuta dello Stato costituzionale di diritto, attraverso lo
svolgimento di attività preordinate a garantire il rispetto dei princìpi e de valori costituzionali.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune e resta in carica sette
anni.
Non è titolare di alcuno dei tre poteri dello Stato e, nondimeno, interagisce con ognuno di essi
attraverso poteri di impulso e di controllo:
a) quanto al potere legislativo,
legislativo il Presidente, prima di promulgare le leggi, può – come si è
visto- rinviarle alle Camere per un riesame in punto di costituzionalità. Il Presidente invia
messaggi motivati alle Camere. Il Presidente può sciogliere una o entrambe le Camere;
b) quanto al potere esecutivo,
esecutivo il Presidente nomina i membri del Governo, emana gli atti
normativi dello stesso, autorizza la presentazione in Parlamento dei disegni di legge di
iniziativa governativa, ratifica i trattati internazionali;
c) quanto al potere giudiziario,
giudiziario il Presidente della Repubblica è anche Presidente del Consiglio
superiore della magistratura.
Più in generale, il Presidente della Repubblica è capo dello Stato e rappresenta l’unità
nazionale. In questa veste svolge attività di persuasione, di stimolo, di dialogo con le istituzioni, al fine
di favorirne il corretto funzionamento e di orientarne i rapporti nel rispetto del principio di leale
collaborazione. Il Presidente è super partes in quanto estraneo alla lotta politica: egli interviene nella
dialettica politica per sedare gli animi, per alleggerire le tensioni, per invocare il supremo bene dello
Stato, per rafforzare la coesione sociale. Egli può essere criticato, ma non può essere chiamato a
rispondere politicamente delle proprie azioni. La responsabilità politica del Presidente si trasferisce
sul Governo per effetto della controfirma apposta dai membri dal Presidente del Consiglio e/o dal
ministro competente/proponente. Sul piano giudiziario, nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente
risponde dei soli reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento, per i quali può essere messo
in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune (→ impeachment) e giudicato dalla Corte
costituzionale.
La Corte costituzionale è composta da quindici giudici (un terzo eletti dal Parlamento in seduta
comune, un terzo eletti dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative, un terzo nominati dal
Presidente della Repubblica), i quali durano in carica nove anni.
In posizione di autonomia e indipendenza dagli altri organi dello Stato, la Corte:
a) giudica della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e
delle Regioni;
b) dirime i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e i conflitti di attribuzione tra Stato e
Regioni e tra Regioni;
c) giudica dell’ammissibilità
ammissibilità del referendum abrogativo;
d) giudica, in composizione allargata, il Presidente della Repubblica per i reati presidenziali.
presidenziali
Quanto, in particolare, al giudizio di legittimità costituzionale:
costituzionale
- non è previsto un accesso diretto alla Corte costituzionale, in quanto le questioni di legittimità
costituzionale possono essere sollevata dinanzi alla Corte:
• o nel corso di un giudizio davanti ad un giudice (→ giudizio di legittimità
costituzionale in via incidentale: eccezione d’incostituzionalità)
• o dallo Stato contro una legge regionale o da una o più Regioni contro una legge
statale o di altre Regioni (→ giudizio di legittimità costituzionale in via principale:
azione d’incostituzionalità);
- possono essere impugnate solo le fonti primarie del diritto per asserita violazione di norme
costituzionali;
97
-
la decisione di merito può essere:
• di rigetto: la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale e,
dunque, la norma legislativa impugnata sopravvive (pur essendo nuovamente
censurabile in futuro);
• di accoglimento: la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma legislativa,
che così viene meno anche retroattivamente.
Quanto alle autorità amministrative indipendenti,
indipendenti su di esse si sofferma la voce enciclopedica
redatta da M. Poto, che si potrà leggere di qui a poco.
In via preliminare, occorre osservare che quando si parla di autorità amministrative
indipendenti (o, nel linguaggio comune, le authorities), si fa riferimento al fenomeno della
neutralizzazione della politica.
politica
In effetti, questi organismi sono vere e proprie autorità amministrative, ossia organizzazioni
preposte allo svolgimento di attività di cura concreta degli interessi generali. Idealmente, sarebbero
riconducibili al potere esecutivo.
Nel modello classico, informato al principio di legalità e alla tradizione ottocentesca, le
istituzioni del potere esecutivo rispondono sempre, dal punto di vista politico, all’assemblea
legislativa. Così, il Governo (che è il vertice dell’apparato preposto al potere esecutivo) risponde
politicamente del proprio operato di fronte alle Camere. La ragione è semplice. Il Governo
rappresenta la sola maggioranza, mentre l’assemblea legislativa include anche i membri
dell’opposizione. In un assetto democratico, l’operato del potere esecutivo non può sottrarsi al
controllo popolare, e dunque la sua azione è sottoposta al confronto con l’organo politicamente
rappresentativo del popolo, ossia il Parlamento.
Nel caso delle autorità amministrative indipendenti, invece, si hanno bensì autorità
amministrative, ma sottratte al controllo e alla ingerenza del potere politico. In effetti, le authorities
sono composte da soggetti in posizione indipendente e autonoma rispetto al potere politico incarnato
tanto dal Parlamento quanto dal Governo. In questo modo, la politica viene neutralizzata (ossia, resa
neutrale) rispetto alle importanti e delicate attribuzioni assegnate a tali autorità.
Perché sono istituite le autorità amministrative indipendenti ?
La risposta è semplice. Esistono settori della società e, soprattutto, dell’economia in cui sono in
gioco beni costituzionalmente garantiti: basti pensare alla libertà di parola. Le autorità amministrative
indipendenti hanno il compito di garantire un adeguato equilibrio tra l’effettivo godimento di tali beni
e lo svolgimento di attività che potrebbero, in qualche misura, danneggiarli. In alcuni settore sensibili,
questo problema è particolarmente avvertito. Si pensi, ad esempio, al settore della stampa e delle
telecomunicazioni. Gli interessi economici in gioco potrebbero alterare o pregiudicare l’effettivo
esercizio del diritto di espressione e di interazione con gli altri. Se le relative attività amministrative
venissero affidate direttamente ad organismi dipendenti dal Governo si correrebbe il rischio di
favorire iniziative strumentali della maggioranza, tali da pregiudicare il libero scambio di opinioni e la
corretta e completa diffusione di informazioni, ossia ingredienti irrinunciabili di un sistema
democratico. Così, nelle moderne democrazie si è pensato di attribuire questi poteri amministrativi
ad organismi non più soggetti al controllo della maggioranza, ma posti in posizione di autonomia e
indipendenza dal potere politico.
In questo senso, le authorities possono a buon titolo essere annoverate tra gli organi di garanzia,
essendo estranei ai tre classici poteri. Anzi, per alcune funzioni esse assomigliano parecchio alle
istituzioni giudiziarie (si pensi alla composizione di controversie ad esse devolute in via esclusiva). Le
stesse autorità amministrative, oltre ad adottare atti amministrativi, svolgono anche attività normativa
(regolamenti), consultiva, sanzionatoria.
M. POTO, voce Autorità amministrative indipendenti, in Dig. IV ed., Disc. pubbl., Agg., vol. III, Utet,
Torino, 2008, pp. 54 ss.
98
1. I modelli.
L’istituzione delle autorità amministrative indipendenti si riconduce alla necessità di approntare un
modello di amministrazione alternativo a quello tradizionale esercitato dai pubblici poteri, al fine di offrire una
tutela nei cosiddetti settori sensibili dell’ordinamento, mediante un’attività di vigilanza e controllo, ancorata a
parametri tecnici. Il calco da cui le autorità indipendenti prendono forma viene tradizionalmente ricondotto
all’influenza di due modelli: da un lato, il modello costitutivo tedesco, la cui genesi risale al discorso tenuto da
Carl Schmitt alla Camera di commercio di Berlino, nel 1930, sulla necessità di riconoscere ad organismi
tecnici, tra i quali la Banca centrale, lo status di organi di governo neutri rispetto al potere esecutivo; dall’altro,
il modello delle agencies angloamericane, cui, a far data dalla fine dell’Ottocento, furono attribuite funzioni di
regolazione pubblica dell’economia.
La metamorfosi del concetto di sovranità che, da espressione del potere statale esercitato su un
territorio, si fraziona nella nascita ed evoluzione di regimi regolatori che agiscono al di là dei confini geografici
e nell’ambito del mercato, è indubbiamente connessa con la nascita ed evoluzione del diritto comunitario e dal
suo irradiarsi, secondo i meccanismi del diritto amministrativo globale.
Attraverso l’opera mediatrice del diritto comunitario, modelli di agenzie istituite per la tutela di settori
sensibili iniziarono a circolare e la necessità di offrire una risposta alla frammentazione di poteri si fece sentire
anche nel nostro sistema.
La progressiva privatizzazione dell’attività pubblica costituì una ulteriore forza propulsiva nella ricerca di
modelli di amministrazione alternativi a quello tradizionale, con una sempre maggiore tendenza dell’azione
pubblica ad offrire risposte tecniche alle esigenze della collettività. Di qui, la istituzione, attraverso lo strumento
legislativo, delle principali autorità amministrative indipendenti, a cui, in mancanza di una previsione
costituzionale che le riconosca e le disciplini, si ritiene applicabile il corpus di principi che regolano l’attività
della pubblica amministrazione (ed, in particolare, gli artt. 97 e 98 in primis, ma anche 24, 28, 103 e 113).
Tutte le autorità che operano nel nostro sistema sono quindi caratterizzate dalla soggezione ai principi
che regolano l’azione amministrativa, con la conseguente applicazione alle medesime anche delle norme sul
procedimento amministrativo (l. 7-8-1990, n. 241, come modificata dalla l. 11-2-2005, n. 15, recante
«Modifiche ed integrazioni alla l. 7-8-1990, concernenti norme generali sull’azione amministrativa»). Alle
autorità indipendenti sono inoltre applicabili le disposizioni del diritto civile in quanto compatibili, secondo la
previsione dell’art. 1, co. 1 bis, legge n. 241/1990, quando pongono in essere atti autoritativi. La previsione si
salda con la considerazione della loro natura bifronte, ponendosi ambiguamente sulla linea di confine tra il
diritto pubblico ed il diritto privato. Oltre all’esercizio di funzioni autoritative, le autorità indipendenti pongono
in essere un’attività che spesso è qualificabile come sostanzialmente privatistica. Soffermandosi sulle funzioni
da esse esercitate, la dottrina ha, al riguardo, rilevato che, esaminato nel suo complesso, il diritto prodotto dalle
autorità indipendenti è per molti versi diritto privato: «imperativo, ma a volte anche suppletivo, condizionale e
non finalistico, negoziato e non imposto. Non può quindi applicarsi ad esso la logica tradizionale del conflitto
autorità-libertà attraverso cui si inquadrava il rapporto tra amministrazione e cittadino». La collocazione delle
autorità in limine tra diritto pubblico e diritto privato produce importanti conseguenze a livello applicativo: a
quale giudice rivolgersi nel caso in cui si voglia instaurare una controversia; quali norme applicare nel caso di
non corretto adempimento delle funzioni di regolazione e quindi di responsabilità delle stesse.
In sintesi, pare utile ricondurre a tre grandi aree tematiche i maggiori punti di attrito che, intorno al
modello delle authorities, sono venuti a crearsi nel corso degli anni: 1) anzitutto, la necessità di una definizione
dei loro caratteri distintivi e di individuare le funzioni da esse esercitabili; 2) di poi, la difficoltà
nell’individuazione del giudice competente a conoscerne le controversie; 3) infine, la delimitazione dei confini
della loro responsabilità, in uno con la prospettazione delle eventuali azioni a tutela dei soggetti danneggiati
dalla loro attività.
2. I caratteri.
L’esercizio dell’attività amministrativa, nel rispetto dei principi, costituzionali e legislativi, che la
regolano, si combina con l’elemento unificante dell’indipendenza, in ordine al quale la dottrina ha individuato
distinte categorie di autorità, che tendono a caratterizzarla con differenti coloriture.
Le autorità amministrative indipendenti sono state distinte in autorità con poteri di garanzia di interessi
afferenti all’ordinamento in generale e di immediata attuazione dei precetti costituzionali, in quanto titolari di
competenze esclusive; autorità il cui scopo precipuo è quello di regolamentare il settore economico, essendo la
99
loro attività coordinata con l’operato del Governo e infine autorità dotate di competenze tecnico
amministrative.
Alla prima categoria appartengono la Consob, la Banca d’Italia, nell’ambito di alcune delle funzioni ad
esse attribuite, e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il Governo, nei confronti di tali autorità, è
sprovvisto di poteri di indirizzo, anche se non sempre è totalmente estraneo dalla nomina dei componenti di
vertice.
La seconda categoria comprende l’Isvap, e le Autorità sui servizi di pubblica utilità, elettricità, gas e
telecomunicazioni, nei cui confronti il Governo esercita funzioni di indirizzo di politica generale e di settore,
oltre a rivestire un ruolo effettivo nella nomina degli organi di vertice.
Nell’ambito della terza categoria si annoverano l’Autorità per l’informatica della pubblica
amministrazione (A.i.p.a., oggi Centro per l’informatica della pubblica amministrazione) e l’Agenzia per la
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (A.p.a.t.), con funzioni di coordinamento e di controllo tecnico
in certi settori di intervento. Su di esse il Governo esercita funzioni di indirizzo e vigilanza.
3. Il controllo giurisdizionale. Le previsioni testuali.
Tra i nodi problematici che attengono all’istituzione delle authorities emerge, quale carattere peculiare
del nostro sistema, il profilo attinente alla giurisdizione, riscontrandosi una evidente difficoltà di sottoporre a
controllo l’operato delle autorità, stante la loro doppia natura.
Tale tensione tra i due poli si riflette non solo nella valutazione sull’opportunità di un controllo
giurisdizionale pieno del loro operato, ma anche nella determinazione dell’organo giurisdizionale competente
a conoscere delle relative controversie.
Il panorama dottrinale e giurisprudenziale entro cui si snodano tali tematiche non è di agevole fruizione,
in parte per la mancanza di una disciplina organica, in parte per il carattere per sua natura magmatico e
frammentario, oltre che soggetto a rapida obsolescenza, della casistica in materia di violazione degli obblighi di
vigilanza e controllo al cui rispetto le autorità sono tenute.
Dall’analisi dei profili strutturali dei principali organi di vigilanza, è possibile rinvenire, pur nella
eterogeneità di fondo delle fattispecie, alcuni punti di contatto — tra i quali spicca il carattere dell’indipendenza
— ma anche alcune divergenze in ordine alla qualificazione giuridica ed ai compiti ad esse affidati.
Sul piano della tutela giurisdizionale, la dottrina e la giurisprudenza pressoché costanti affermano la
necessità di un controllo da parte dell’Autorità giudiziaria sugli atti posti in essere dalle Autorità indipendenti.
Le conseguenze cui si giungerebbe nel caso di totale esclusione di un sindacato giurisdizionale
condurrebbero, infatti, alla violazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost., che rimettono all’autorità giudiziaria
l’ultima parola sugli atti destinati ad incidere negativamente sulle posizioni giuridiche soggettive.
In secondo luogo, ove si configurassero poteri giurisdizionali in capo alle autorità indipendenti, si
ricadrebbe nell’aporia di dover affidare funzioni di tipo giurisdizionale a soggetti posti al di fuori del potere
giudiziario, operazione che presenterebbe indubbi profili di incostituzionalità.
Quanto al problema relativo al riparto di giurisdizione, occorre preliminarmente ricordare che, prima
dell’entrata in vigore del d.lg. 31-3-1998, n. 80, poi successivamente modificato dalla legge 21-7-2000, n. 205,
non esistevano criteri univoci in ordine alla individuazione del giudice, amministrativo o ordinario, competente
a sindacare gli atti della autorità indipendenti.
In molti casi, infatti, il legislatore optò per la soluzione che demandava alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo le controversie relative all’attività delle Autorità.
Si pensi alla legge 10-10-1990, n. 287, che, all’art. 33, devolve al giudice amministrativo la giurisdizione
sugli atti del Garante della concorrenza, salvo poi attribuire al giudice ordinario il contenzioso in tema di
risarcimento del danno per le nullità degli accordi anticoncorrenziali nonché in tema di poteri di urgenza.
Circa le sanzioni irrogate dall’Autorità, l’art. 31 della legge dispone che per le sanzioni amministrative
pecuniarie conseguenti alla violazione della disciplina antitrust «si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689».
Analogamente, la legge 14-11-1995, n. 481, che ha istituito le Autorità di regolazione dei servizi di
pubblica utilità (per l’energia elettrica ed il gas, e per le telecomunicazioni) ha fissato la giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo per quanto riguarda l’autorità dell’energia elettrica e del gas.
Così la legge sull’autorità delle telecomunicazioni (l. 31-7-1997, n. 249), all’art. 1, 26° co., fissa la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
In controtendenza rispetto alla scelta di devolvere la maggior parte del contenzioso relativo all’attività
delle autorità indipendenti al giudice amministrativo si pone la legge 31-12-1996, n. 675, di recente sostituita
100
dal t.u. approvato con d.lg. 30-6-2003, n. 196, (art. 29, 6° co.), che, per quanto riguarda il Garante dei dati
personali, ha fissato la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie che derivano
dall’applicazione della legge.
...
5. La responsabilità.
Il tema della responsabilità delle autorità di vigilanza si snoda sulla falsariga dell’evoluzione della
responsabilità della pubblica amministrazione.
Paradigmatica in tale senso è l’evoluzione della giurisprudenza con riferimento alla responsabilità della
Consob. La prima sentenza che ha riconosciuto la responsabilità della Consob, dopo la pronuncia sulla
risarcibilità degli interessi legittimi, è la n. 3132/2001 della Corte di Cassazione, nei confronti di un gruppo di
investitori, per omesso controllo sulla completezza e veridicità delle informazioni fornite dai promotori di
un’operazione di collocamento di titoli atipici relativi ad un’operazione immobiliare. La Suprema Corte aveva
infatti ritenuto colposamente negligente il comportamento della Consob per il mancato esercizio dei suoi
poteri di vigilanza. In particolare, secondo il giudice di legittimità, la discrezionalità amministrativa attribuita
all’organo di vigilanza non poteva concretarsi in una assoluta omissione di controllo, in quanto ad esso era
connesso il diritto soggettivo dei risparmiatori all’integrità del patrimonio. In particolare, si legge in
motivazione: «La Consob, fermo restando il potere (...) di innovare le proprie metodologie informative
dell’offerta (...) aveva poi il ben più penetrante e diffuso potere di controllo della completezza — veridicità delle
notizie (...) lungo tutto l’arco procedimentale, (...), un potere espressico della scelta legislativa di assegnare alla
Consob la massima funzione di garante dell’agire della società e tradotto in plurime potestà di intervento (...),
significativamente richiamate per la fase di controllo dell’operazione di sollecitazione al pubblico risparmio
(...), tra le quali, e per quel che rileva, la potestà di disporre esibizioni ed integrazioni documentali, ispezioni ed
inchieste, al fine di accertare l’esattezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati». L’affidamento
incolpevole dei privati infatti si fondava sulla attività pubblica di vigilanza, posta in essere con grave negligenza.
La Suprema Corte ravvisò i presupposti per la configurabilità di una responsabilità civile dell’autorità
medesima, ammettendo in modo implicito che tale amministrazione è chiamata a risarcire i danni derivanti dal
negligente esercizio dell’attività di vigilanza, atteso che «costituisce comportamento dovuto l’osservanza delle
norme che disciplinano la funzione di vigilanza della Consob, sicché l’omissione dello stesso configura illecito
aquiliano, che comporta la risarcibilità dei danni riconducibili a lesioni di situazioni protette dei privati».
La dottrina ha sollevato sul punto una serie di dubbi, con riferimento al rischio che la paventata
esasperazione del principio di responsabilità scarichi sul controllore i costi derivanti dalle inefficienze del
mercato finanziario. Di tali problemi, si è fatto carico il legislatore, dapprima abbozzando il quadro sulla
responsabilità nella legge di tutela del Risparmio, di poi definendone più puntualmente i confini con il d.lg. 810-2007, n. 179: «Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di
garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell’ articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28-12-2005,
n. 262».
Il proliferare delle pronunce giurisprudenziali in materia di responsabilità, insieme all’ennesima crisi che
minacciava di far crollare l’intero sistema, hanno spinto verso la Legge di tutela del Risparmio.
Se nella definizione dei poteri delle autorità un tempestivo adeguamento del nostro sistema al quadro
delle garanzie comunitarie non era più rinviabile, esso appariva pertanto imprescindibile in tema di
responsabilità.
L’intervento, pur salvifico, della giurisprudenza non riusciva a contenere un problema che rischiava di
estendersi a macchia d’olio, e di condurre al collasso l’intero sistema.
Imbrigliare l’attività delle Autorità nelle maglie dell’ art. 2043 c.c. non era operazione facile, e in ogni
caso troppo aleatoria.
L’eco della dottrina ha forse risuonato minacciosa nelle orecchie del legislatore: «Nei rapporti tra
autorità indipendenti e potere giudiziario si è aperto di recente, in seguito ad una svolta giurisprudenziale, un
nuovo fronte: la responsabilità civile delle prime per danni cagionati a terzi in relazione all’esercizio difettoso
dell’attività di vigilanza. (...) La svolta può avere un effetto positivo, sul piano del modello, poiché consente di
chiamare le autorità indipendenti a rendere conto del loro operato e dunque contribuisce ad attenuare il deficit
di legittimazione democratica di cui esse soffrono. L’arma della responsabilità civile deve essere però
maneggiata dai giudici con cautela. Oltre un certo limite, infatti, vi è il rischio che le autorità indipendenti
101
manifestino eccessiva prudenza giustificata dal timore della responsabilità, ma contraria a un esercizio vigoroso
dei poteri».
Di qui, l’obbligo di istituzione di un fondo nel caso di perdite derivanti da omessa vigilanza, a modello di
altri Stati membri, primo fra tutti del sistema tedesco, in cui è disposta la corresponsione di un indennizzo nel
caso di perdite da omessa vigilanza, alla cui diffusione ha contribuito l’opera amplificatrice della giurisprudenza
comunitaria.
Si legge nell’art. 27 legge n. 262/2005 che: «Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’istituzione, in materia di servizi di
investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli
investitori e dei risparmiatori, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica».
A tale previsione, segue l’elencazione dei principi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire; tra
questi, figura, alla lett. c), dell’art. 27, 1° co., la «salvaguardia dell’esercizio del diritto di azione dinanzi agli
organi della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto
all’indennizzo (...)».
La bontà dell’iniziativa finalizzata all’istituzione del menzionato fondo tradì la propria inconsistenza, non
risultando da un lato ben chiara la fonte di provenienza del medesimo, — e l’inciso «senza nuovi e maggiori
oneri per la finanza pubblica» contenuto nell’ art. 27 legge n. 262/2005 non forniva alcuna precisa indicazione
al riguardo — e, dall’altro, generando una certa qual preoccupazione la contrazione di tutela che si avrebbe,
qualora la via preferenziale divenisse unicamente quella della corresponsione di un indennizzo in luogo della
condanna al risarcimento del danno.
Tali perplessità erano emerse anche alla vigilia dell’approvazione della legge di tutela del risparmio in
Francia: «Si le budget de l’Autorité provient des ressources du marché lui-même, la responsabilité de l’autorité
prend de ce fait une forme mutualisée (...). Cela relativise le lien entre responsabilité pécuniarie et souci de
bien faire».
A chiosa di tale constatazione, la dottrina arrischiava l’analisi per cui «il incomberait au marché, et donc
à la collectivité de ses acteurs, de supporter le poids de le réparation de la faute commise par l’autorité de
régulation dans l’exercice de sa mission. Mais, n’y a-t-il pas dans cette proposition le risque d’une
déresponsabilisation de l’autorité de régulation?». Il fatto che tale domanda non avesse ricevuto ancora
risposta, in quanto non era ancora definitiva l’approvazione del decreto di applicazione della nuova legge,
induceva la dottrina ad essere ottimisti circa una possibile risposta positiva riguardo ad un ripensamento del
legislatore: «Mais, il faut être optimiste!».
Il legislatore delegato, nell’autunno del 2007, ha rischiarato la via, sia pur con un intervento che, a non
volerlo qualificare del tutto «rimediale», certamente non dà al quadro complessivo quell’impressione di
sistematicità di cui certamente abbisogna.
Il Capo II del d.lg. n. 179/2007, nel prevedere l’istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e
gli investitori, dispone all’art. 8 la destinazione di tale fondo «all’indennizzo, nei limiti delle disponibilità del
fondo medesimo, dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o
con dolo arbitrale non più impugnabile, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del d.lg. 242-1998, n. 58. 2. La gestione del Fondo è attribuita alla Consob. 3. Possono accedere al Fondo gli investitori
come definiti dall’articolo 1 del presente decreto. Il Fondo è surrogato nei diritti del soggetto danneggiato,
limitatamente all’ammontare dell’indennizzo erogato, e può rivalersi nei confronti della banca o
dell’intermediario responsabile. 4. La Consob è legittimata ad agire in giudizio, in rappresentanza del Fondo,
per la tutela dei diritti e l’esercizio dell’azione di rivalsa di cui al comma precedente (...); 5. Il Fondo è
finanziato esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
irrogate per violazione delle norme di cui al comma 1». Infine, il 6° co. dello stesso art. 8 attribuisce alla
Consob il potere regolamentare di definire i criteri di determinazione dell’indennizzo, fissandone anche la
misura massima; di disciplinare le modalità e le condizioni di accesso al Fondo. Tali regolamenti, precisa l’art.
9 devono essere emanati «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. 2.
Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
La disciplina della responsabilità extracontrattuale della Consob costituisce tuttavia solo un esempio,
sebbene forse il più avanzato, di regolamentazione delle controversie risarcitorie per attività delle autorità
indipendenti che potrebbe avere un’espansione ultrasettoriale. La necessità di sindacare l’attività illecita delle
autorità indipendenti alla luce dei parametri che informano la responsabilità civile della pubblica
amministrazione appare una soluzione pienamente rispondente alla sistematica complessiva di tali organi.
La previsione — generalizzata per le diverse tipologie di autorità — di ulteriori meccanismi garantistici,
accessori ed eventuali rispetto agli ordinari rimedi risarcitori, quale è quello dell’indennizzo, è una soluzione
102
che potrebbe essere adottata al fine di offrire il più ampio spettro di tutela per i soggetti destinatari dell’attività
delle autorità indipendenti.
Le autonomie territoriali e funzionali
Lo Stato ha ceduto parte della propria sovranità anche alle autonomie territoriali.
territoriali
Le Regioni,
Regioni innanzitutto, sono enti pubblici territoriali dotati di autonomia politica. Nel
dettaglio, le Regioni sono:
- enti,
enti ossia organizzazioni giuridiche;
- pubblici,
pubblici ossia organizzazioni create dal diritto per la realizzazione di interessi generali;
- territoriali,
territoriali in quanto esplicano le loro funzioni all’interno di un certo ambito geografico
delimitato da confini;
- dotati di autonomia politica:
politica questa può essere definita come la capacità della Regione di
soddisfare gli interessi della comunità di cui essa è ente esponenziale secondo un proprio
indirizzo politico, in ipotesi anche diverso da quello dello Stato e delle altre Regioni.
Occorre soffermarsi sulla nozione di autonomia politica, scomponendola:
- capacità,
capacità intesa come insieme di poteri e funzioni;
- interessi della comunità:
comunità la Regione, in quanto ente pubblico territoriale, si occupa dei
bisogni e delle richieste provenienti dalla collettività stanziata in un determinato ambito
geografico;
- ente esponenziale:
esponenziale è tale la Regione in quanto ente politicamente rappresentativo della
comunità. In effetti, gli organi di vertice della Regione (il Consiglio, Regionale, il Presidente
della Regione, la Giunta regionale) sono scelti tramite meccanismi di selezione democratica
da parte dell’elettorato regionale: il Consiglio e il Presidente sono eletti a suffragio
universale e diretto, i membri della Giunta (→ assessori) sono nominati dal Presidente;
- indirizzo politico:
politico è l’insieme degli obiettivi e degli orientamenti di carattere politico che la
maggioranza, che ha vinto le elezioni, intende perseguire e assecondare per rendere
coerente l’azione complessiva di governo in ambito regionale. Così, se a livello statale c’è
una maggioranza di centrodestra, con un indirizzo politico coerente con questo
posizionamento politico, nulla impedisca ad una coalizione di centrosinistra di governare
una data Regione, con un proprio indirizzo politico. Al contrario, gli uffici periferici dello
Stato (ad es., le prefetture, le sovrintendenze, le agenzie delle entrate ecc.) non sono enti
autonomi, ma articolazioni dipendenti dallo Stato centrale: sicché, in questi casi non di
autonomia si parla bensì di decentramento.
decentramento
Anche i Comuni,
Comuni le Città metropolitane e le Province sono enti pubblici territoriali dotati di
autonomia politica. Diversamente dalle Regioni, però, non hanno la funzione legislativa, e non è poco
visto che questa è la funzione di prima attuazione del dettato costituzionale, che si realizza attraverso
la produzione di norme giuridiche dotate di un certo valore.
Si noti che le Province autonome di Trento e di Bolzano sono in tutto e per tutto equiparate alle Regioni e,
dunque, nel loro territorio si hanno anche leggi provinciali.
Le autonomie territoriali sono state istituite per diversificare l’azione dei pubblici poteri in tutto
il territorio, nella consapevolezza che le peculiarità degli specifici contesti locali esigono interventi e
misure legislative e amministrative mirate e congeniali. Per i rapporti nei quali vi è uniformità a livello
nazionale, il principio di eguaglianza impone una omogeneità di trattamento (es. ordine pubblico,
difesa dei confini, affari internazionali, giustizia, diritto privato e diritto penale, rapporti con le
confessioni religiose ecc.). In relazione ai rapporti che più di altri risentono delle caratteristiche
singolari e peculiari dei diversi territori, il principio di eguaglianza viene attenuato, lasciando spazio a
discipline differenziate: così, ad esempio, il turismo non è lo stesso in tutte le Regioni e, dunque, sono
103
preferibili regolamentazioni diversificate. E così altri settori economici: agricoltura, commercio,
industria, artigianato, pesca, caccia.
In ogni caso:
- l’Italia rimane una Repubblica «una e indivisibile» (→ principio unitario vs. principio
autonomista);
- Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato costituiscono, nel loro insieme, la
Repubblica (→ Principio di pari dignità istituzionale: art. 114 Cost.).
Sono amministrazioni autonome, ma non territoriali, le autonomie funzionali:
funzionali si pensi alle
università degli studi, agli istituti scolastici, alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura. Si tratta di enti che operano in regime di autonomia, tanto dallo Stato quanto dagli enti
territoriali, ma il territorio non è il loro elemento identificativo. Anche quando, come nel caso delle
camere di commercio (che operano in ambito provinciale), esplicano attività in alcuni ambiti
territoriali, nondimeno ciò che rileva è l’attribuzione agli stessi di funzioni amministrative di cura
concreta di interessi generali.
dell’’Unione europea
Le istituzioni dell
Un breve cenno meritano le istituzioni dell’Union
Unione
Unione europea,
europea visto l’impatto prodotto dalle
decisioni assunte in quell’ambito anche sul versante economico.
1) Consiglio europeo.
europeo È composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo
presidente e dal presidente della Commissione. Il Consiglio è l’organo di indirizzo politico dell’U.e.
2) Consiglio.
Consiglio È composto da un rappresentante per ogni Stato a livello di ministro. Ha
composizione variabile, in quanto essa dipende dai temi posti all’ordine del giorno. Di particolare
importanza è il Consiglio
Consiglio Ecofin,
Ecofin costituito dai ministri economici e finanziari. In seno a quest’ultimo
opera l’Eurogruppo
Eurogruppo,
Eurogruppo che riunisce a titolo informale i ministri degli Stati che hanno adottato l’euro. Il
Consiglio esercita, insieme al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio.
Inoltre, definisce e coordina le politiche dell’Unione; garantisce il coordinamento e la sorveglianza
delle politiche economiche; assume le decisioni relative alla politica estera e alla difesa comune.
3) Parlamento europeo
europeo.
peo È composto da 751 membri, eletti nei singoli Stati con differenze dal
punto di vista numerico a seconda della popolazione degli stessi (non meno di 6 e non più di 96
membri per ogni Stato). Non esiste ancora un sistema elettorale comune a tutti gli Stati. La legislatura
dura cinque anni. Il Parlamento esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa. Si
occupa di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e funzioni consultive. Elegge il Presidente
della Commissione.
4) Commissione
Commissione. È composta da un membro per Stato, incluso il Presidente e l’alto
rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Dura in carica cinque anni. Ha l’iniziativa
degli atti legislativi. Presente il progetto annuale di bilancio e ne cura l’esecuzione. Vigila
sull’applicazione del diritto dell’U.e. potendo avviare la procedura di infrazione contro gli Stati
ritenuti inadempienti.
5) Corte di giustizia.
giustizia I giudici sono nominati dai governi per sei anni. Giudica delle controversie
fra Stati membri; fra l’Unione e uno Stato membro; fra le istituzioni dell’U.e.; fra persone (giuridiche
e fisiche) e l’U.e., sia pure in limitati casi: ricorsi per inadempimento e ricorsi di annullamento. Alla
Corte si affianca il Tribunale,
Tribunale competenze per le azioni intraprese da persone fisiche o giuridiche.
6) Banca centrale europea.
europea È dotata di personalità giuridica propria e versa in una condizione
di indipendenza. Il Presidente è nominato per otto anni da Consiglio europeo. La Bce ha un ruolo
decisivo in materia di politica monetaria. Esercita anche poteri normativi.
7) Corte dei conti.
conti Composta da un rappresentante di ogni Stato membro, controlla appunto i
conti dell’U.e. attraverso l’analisi delle entrate e delle spese.
Occorre, infine, ricordare anche il Comitato
Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni.
regioni
104
Ad integrazione della parte sul sistema normativo, si ricorda in questa sede che le fonti del
diritto dell’
dell’Unione europea sono di due tipologie: originarie e derivate.
derivate
I trattati sono le fonti originarie del diritto dell’U.e., in quanto stipulati dagli Stati membri «per
una durata illimitata» al fine di definire l’intelaiatura fondamentale delle istituzioni e di enunciare i
princìpi basilari. I due trattati sono: il Trattato sull’
sull’Unione europea (Tue), che consta di 55 articoli, e
il Trattato sul funzionamento dell’
dell’Unione europea (Tfue), costituito da ben 358 articoli.
Le fonti derivate del diritto dell’U.e. sono:
- il regolamento:
regolamento atto di portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi, direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri;
- la direttiva:
direttiva atto che vincola gli Stati membri in relazione ai risultati da raggiungere, mentre
spetta agli stessi Stati l’individuazione dei mezzi ritenuti più opportuni;
- la decisione:
decisione atto obbligatorio in tutti i suoi elementi, ma indirizzato a specifici destinatari.
Da ricordare, poi, anche le raccomandazioni e i pareri,
pareri che non sono giuridicamente vincolanti
in quando non fanno sorgere diritti ed obblighi.
In caso di contrasto tra una fonte italiana primaria e un regolamento, prevale quest’ultimo in
applicazione del criterio di competenza: dunque, il giudice applica il regolamento e non applica la
legge italiana con esso in contrasto. Lo stesso vale per le cd. direttive self-executing, che, nonostante il
nome, sono equiparabili ai regolamenti.
Quanto alle direttive, il Parlamento italiano approva ogni anno la legge comunitaria,
comunitaria al fine di
darne attuazione nel rispetto dei termini da esse stabiliti.
Sezione II
I SOGGETTI PRIVATI
persone
Persone fisiche e pers
one giuridiche
Le persone fisiche sono gli individui, laddove le persone giuridiche sono le strutture
organizzative, più o meno complesse e più o meno stabili, costituite dalle persone fisiche per lo
svolgimento di attività che richiedono la compartecipazione di più soggetti.
Quanto alle persone fisiche, ci si soffermerà più avanti sulle condizioni soggettive (capacità
giuridica e capacità di agire) e sugli strumenti giuridici a loro disposizione per lo svolgimento delle
rispettive attività (diritti soggettivi, interessi legittimi, poteri, facoltà, obblighi, oneri).
Per ciò che rileva di più in questa sede, si ricorda che:
- ai sensi dell’art. 2082 del codice civile «è imprenditore chi esercita professionalmente una
attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi»;
- ai sensi dell’art. 2083 del codice civile «sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo,
gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia».
Quanto alle persone giuridiche, l’ordinamento riconosce alcune distinzioni rilevanti anche sul
versante economico.
In generale, per aversi una “persona giuridica” è necessario che essa abbia un proprio
patrimonio,
patrimonio inteso come insieme di rapporti giuridici attivi e passivi:
- che sia distinto da quello di qualsiasi persona fisica;
- che sia assoggettato a vicende autonome collegate alla realizzazione di un determinato
scopo.
105
Sicché, si ha autonomia patrimoniale perfetta quando dei debiti della persona giuridica
risponde soltanto essa con il suo patrimonio. Si ha, invece, autonomia patrimoniale imperfetta
quando, pur essendovi una separazione patrimoniale tra la persona giuridica e i suoi membri, i
creditori a certe condizioni possono aggredire anche il patrimonio dei membri stessi. Nel contempo,
il patrimonio resta immune dalle pretese vantate dai creditori nei confronti dei singoli partecipanti. In
sintesi:
a) autonomia patrimoniale perfetta = insensibilità del patrimonio del singolo partecipante ai
debiti dell’ente e insensibilità del patrimonio dell’ente ai debiti personali del partecipanti;
b) autonomia patrimoniale imperfetta = responsabilità dei partecipanti (o, almeno, di alcuni fra
essi) per i debiti dell’ente + esistenza di qualche schermo che protegga il patrimonio
dell’ente nei confronti dei creditori personali dei singoli partecipanti + destinazione
preferenziale del patrimonio dell’ente ai creditori dell’ente stesso.
Le persone giuridiche private si distinguono in:
1) istituzioni:
istituzioni esse sono vincolate ad uno scopo che è predeterminato dall’atto costitutivo ed è,
di regola, immodificabile. Possono perseguire tanto interessi generali, quanto interessi di
una particolare categoria di persone;
2) corporazioni:
corporazioni esso sono gruppi di persone che gestiscono sovranamente la propria
organizzazione e dispongono liberamente del patrimonio comune. Anche in questo caso
possono essere perseguiti interessi personali oppure di specifici gruppi di persone.
Tra le istituzioni hanno una importanza notevole le fondazioni,
fondazioni ossia enti istituiti da uno o più
fondatori che conferiscono il patrimonio iniziale e determinano, nell’atto costitutivo, lo scopo
dell’ente stesso e le norme sulla gestione. I comitati,
comitati invece, sono gruppi di persone che raccolgono
presso terzi fondi da destinare ad uno scopo annunciato.
Tra le corporazioni:
- se esse non hanno uno scopo di lucro o mutualistico, allora si hanno associazioni.
associazioni Dal
riconoscimento dipende l’autonomia patrimoniale perfetta;
- se, invece, è perseguito uno scopo di lucro, allora siamo in presenza di società;
società
- dal canto loro i consorzi sono corporazioni nelle quali più soggetti perseguono un interesse
economico in comune, attraverso un’opera o un servizio o il coordinamento delle attività
economiche poste in essere dagli stessi partecipanti.
Posto che con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per
l’esercizio in comune di un’attività produttiva, le società si distinguono in:
a) Società di persone.
persone Sono caratterizzate da una maggiore rilevanza delle persone dei singoli
soci e da una correlativa minore unificazione del gruppo. In esse, almeno una parte dei soci risponde
personalmente dei debiti sociali:
- società semplice:
semplice è quella che ha l’autonomia patrimoniale meno forte. Non essendo previste
idonee garanzie per i creditori sociali, il codice civile non consente che attività commerciali possano
essere svolte in forma di società semplice. Ciascun socio risponde personalmente, in solido con gli
altri, delle obbligazioni sociali sorte durante la partecipazione alla società o anteriormente. La società
semplice non è soggetta a registrazione;
- società in nome collettivo:
collettivo è prevista la registrazione. È rafforzata l’autonomia patrimoniale da
momento che il creditore particolare del singolo socio non può chiedere la liquidazione della quota
del suo debitore finché la società dura. Se, però, il socio è un imprenditore commerciale, e versa in
stato di insolvenza, allora il suo creditore particolare potrà farne dichiarare il fallimento: in tal caso, la
quota dovrà venire liquidata in favore della massa dei creditori. In sintesi, nella società in nome
collettive sussiste una responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci per i debiti sociali;
- società
società in accomandita semplice:
semplice è prevista la registrazione. È caratterizzata dalla presenza di
due tipologie di soci: gli accomandatari, che rispondono in solido e illimitatamente per i debiti sociali,
106
e gli accomandanti, i quali rischiano solo la quota conferita. L’amministrazione della società spetta
soltanto ai primi.
b) Società di capitali.
capitali In esse l’elemento del capitale ha una prevalenza concettuale e normativa
rispetto all’elemento soggettivo rappresentato dai soci, con una più spiccata separazione tra i
patrimoni della società e dei soci:
- società per azioni:
azioni dei debiti sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. I soci
rischiano soltanto il loro conferimento. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da
azioni. L’azionista non ha poteri di amministrazione;
- società a responsabilità limitata:
limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il
suo patrimonio. Le quote dei soci non sono rappresentate da azioni. Pertanto, possono circolare solo
nel rispetto delle norme sulla cessione dei crediti. L’art. 2463 bis, introdotto di recente, ha previsto la
società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.): come per la S.r.l., anche con la S.r.l.s. è possibile
iniziare anche da soli (la “S.r.l.s. unipersonale”) e la responsabilità per eventuali debiti della società è
limitata al capitale investito. I soci o l’unico socio non rischiano direttamente con i propri beni
personali;
- società in accomandita per azioni:
azioni vi sono le stesse due tipologie di soci descritte in relazione
alla accomandita semplice. Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni.
c) Società cooperative e di mutua assicurazione:
assicurazione sono caratterizzate dallo scopo mutualistico,
ossia fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai soci a condizioni più vantaggiose
rispetto a quelle del mercato. Possono essere e responsabilità limitata oppure illimitata.
Quando si pensa ai privati e al loro ruolo in ambito economico, non si possono trascurare i
gruppi di pressione,
pressione meglio noti come lobbies.
Ad essi è dedicata la seguente trattazione.
Q. CAMERLENGO, Lobbies e processi di decisione politica, in F. Rigano (a cura di), La Costituzione
in officina. Il primo intervento urgente, Pavia University Press, Pavia, 2013, pp. 37 ss.
1. Un rinnovato interesse per un antico tema
«Chi sa qualcosa farebbe bene a denunciare questi comportamenti gravissimi», ha commentato il
presidente del Senato Pietro Grasso promettendo di adoperarsi per «fornire agli inquirenti nel più breve
tempo tutte le informazioni che riterranno utili alle indagini».
Una nota trasmissione televisiva, dedita ad inchieste di pubblico interesse, ha denunciato, attraverso
un’intervista ad un anonimo assistente parlamentare, una prassi diffusa presso deputati e senatori: alcune
multinazionali verserebbero periodicamente somme di denaro al fine di condizionare le espressioni di voto dei
parlamentari. Secondo questo racconto, vi sarebbe addirittura un tariffario, peraltro sensibile al diverso livello
di prestigio dei parlamentari destinatari di tali esborsi di denaro.
Il clamore suscitato da questa narrazione ha prodotto un significativo impatto mediatico, in un frangente
in cui gli strali dell’antipolitica rappresentano un motivo ricorrente, scandito con inedita regolarità.
È però vero che il tema dei gruppi di pressione, certamente non nuovo in quanto attecchito da tempo
nel terreno istituzionale, aveva qualche settimana prima polarizzato l’attenzione dei saggi nominati dal Capo
dello Stato.
Più precisamente, nella relazione finale del Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali istituito il 30
marzo 2013 dal Presidente della Repubblica, licenziata il 12 aprile dello stesso anno, il paragrafo 17 è dedicato
alle lobbies: «i gruppi di interesse particolare svolgono una legittima ma non sempre trasparente attività di
pressione sulle decisioni politiche. Spesso si tratta di un’opera utile per portare a conoscenza dei decisori
politici realtà frequentemente ignorate. Ma, come ha suggerito l’OCSE, è un’opera che ha bisogno di
trasparenza per non diventare un mezzo per alterare la concorrenza o per condizionare indebitamente le
decisioni. Il Gruppo di lavoro propone una disciplina che riprenda i modelli del Parlamento Europeo e quello
degli Stati Uniti, fondata su tre caratteri fondamentali: a) si istituisce presso la Camera, il Senato e presso le
Assemblee regionali l’albo dei portatori di in-teressi; b) costoro hanno diritto a essere ascoltati nella istruttoria
legislativa relativa a provvedimenti che incidono su interessi da loro rappresentati; c) il decisore deve rendere
107
esplicite nella relazione al provvedimento le ragioni della propria scelta e deve evitare ogni possibile situazione
di potenziale o attuale conflitto di interessi».
Nel corso dell’audizione del 22 maggio 2013 dinanzi alle Commissioni riunite affari costituzionali, il
Ministro per le riforme costituzionali Quagliariello ha segnalato «la necessità di una regolamentazione
dell’attività di lobbying, in grado di evitare ingiuste demonizzazioni ma anche di scongiurare che l’attività dei
gruppi di pressione possa indebitamente inquinare la vita democratica e alterare la concorrenza».
Nella riunione del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2013, il Presidente Letta ha presentato le linee
sulle quali si articolerà un prossimo disegno di legge in tema di attività delle lobbies e di rappresentanza degli
interessi economici.
2. Gruppi di pressione, democrazia, partecipazione
La partecipazione ai processi decisionali instaurati in Parlamento (ma lo stesso ragionamento potrebbe
essere generalizzato includendovi tutte le assemblee elettive degli enti politici) può considerarsi una modalità
privilegiata di contemperamento tra la democrazia rappresentativa e la democrazia diretta.
La democrazia rappresentativa esclude gli elettori dai circuiti decisionali, essendo rimessa agli eletti la
manifestazione di volontà sottesa alle conseguenti determinazioni. La democrazia diretta, dal canto suo, rende
gli elettori protagonisti immediati delle decisioni, in quanto soggetti attivi (seppur non individualmente) delle
necessarie espressioni volitive.
Attraverso la partecipazione, nulla muta quanto agli organi investiti del potere decisionale. Nondimeno, i
rappresentati sono dall’ordinamento abilitati a esporre le loro istanze e le loro sollecitazioni ai rappresentanti.
In questo modo, l’organo decisionale è reso edotto delle complessità proprio dei rapporti sui quali la
determinazione in fieri è destinata ad incidere.
Ora, quanto al procedimento legislativo il momento dedicato all’ingresso di tali elementi di conoscenza
e di giudizio è l’istruttoria (Galeotti 1957, p. 109; Predieri 1974, p. 2526; Cocozza 1988, pp. 9 ss.; Recchia e
Dickmann 2002). Questa è la fase in cui il legislatore acquisisce gli elementi di fatto e di diritto sui quali
fondare la propria decisione normativa. La «garanzia di una buona “istruttoria”» (Elia 1961, p. 70) è requisito
indefettibile affinché l’epilogo del procedimento sia espressione di un corretto esercizio della funzione
legislativa. Una esauriente istruttoria rende il Parlamento un organo cosciente e consapevole, in grado di
incidere con efficacia e cognizione di causa nei rapporti sociali (Manzella 2003, p. 321).
Anche alla luce della raccomandazione dell’Ocse del 9 marzo 1995 sul miglio-ramento della qualità
della produzione normativa, le circolari dei Presidenti di Camera e Senato del 10 gennaio 1997 hanno stabilito
i caratteri dell’istruttoria legislativa, quale attività preordinata a verificare la necessità dell’intervento legislativo,
la sua coerenza innanzitutto con il dettato costituzionale, la fattibilità e l’economicità della disciplina e
l’inequivocità sostanziale delle disposizioni da approvare. Le circolari individuano i soggetti destinatari delle
richieste di informazione: Governo e pubblica amministrazione, enti territoriali, associazioni di categoria,
organizzazioni sindacali, gruppi sociali ed esperti nei diversi settori interessati dall’intervento legislativo. L’art.
79, quarto comma, del Regolamento della Camera ha imposto alle commissioni parlamentari di considerare la
necessità dell’intervento legislativo, il rispetto degli altri ambiti di competenza, il rapporto costi-benefici, la
corretta stesura del testo (Dickmann 2000, pp. 217 ss.; Gianniti e Lupo 2008, p. 193).
È dubbio, però, che i gruppi di pressione agiscano alla luce del sole intervenendo nella fase istruttoria
secondo le modalità formalizzate dalle ricordate circolari e previsioni regolamentari.
Intanto, con l’espressione “gruppi di pressione” (lobbies) s’intende «tutta una se-rie di gruppi sociali di
diverso genere e portatori di interessi disparati […] che influi-scono (o cercano comunque di influire) in vari
modi sulle scelte dei pubblici poteri cui sono in maggior misura interessati» (De Marco 1998, p. 429. V. anche
Pasquino 1988; Trupia 1989; Petrillo 2012, pp. 179 ss.). Che le lobbies preferiscano agire senza scoprire le
carte è un dato di fatto difficilmente contestabile. Senza dubbio i percorsi tracciati dai regolamenti parlamentari
costituiscono una preziosa risorsa per esternare le rispettive istanze. Nondimeno, l’esperienza insegna come sia
più congeniale un’opera di costante condizionamento svolta nell’ombra, con contatti informali al di fuori delle
ritualità istituzionali. È preferibile per gli stessi soggetti influenzati non esporsi troppo, mantenendo così un
basso profilo che potrebbe rivelarsi utile in occasione della successiva competizione elettorale.
Ad ogni modo, le principali caratteristiche del lobbismo italiano sono state così individuate: innanzitutto,
è una tipologia di rappresentanza priva di disciplina positiva; in secondo luogo, è una forma di pressione che
risente alquanto della cultura politica nazionale; inoltre, è un modello di relazione istituzionale più orientato
all’esercizio dell’influenza come relazione sociale che alla comunicazione come processo; infine, è un sistema
108
basato sui rapporti diretti e immediati tra lobbista e decisore piuttosto che su forme indirette di pressione
(Antonucci 2012, p. 110).
3. Due fattori che favoriscono l’attività di lobbying: la trasformazione della legge; il finanziamento ai
partiti
Innanzitutto, l’azione dei gruppi di pressione ha assunto nel tempo contorni sempre più nitidi alla luce
dell’evoluzione del concetto stesso di legge.
Con l’illuminismo la legge assurge a «expression de la volonté générale», come sancito dall’art. 6 della
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 (Carrè de Malberg 1931). Secondo Rousseau, la
legge rispecchia la volontà palesata dalla comunità indivisa, non frammentata in fazioni o partiti. Essa, dunque,
sottintende la capacità del legislatore di trascendere dai propri interessi egoistici per assecondare i bisogni della
collettività: «la volontà generale diviene così non un dato numerico, ma una qualità del contenuto della legge,
una qualità che presuppone legislatori capaci di quella astrazione da se stessi» (Zagrebelsky 1994, p. 155). È
questa la massima esaltazione dello spirito democratico che ha pervaso il costituzionalismo rivoluzionario
francese.
Nel tempo, grazie anche all’avvento dirompente delle istanze pluralistiche, questa concezione svanisce
per lasciare il posto ad una diversa immagine della legge. Questa, «che esprime un processo politico generale,
nel senso che in esso partecipa la generalità dei soggetti politici, non è altro che il modo in cui si coordina il
maggior numero di interessi particolari» (Zagrebelsky 1994, p. 155). Nella società si materializzano molteplici
conflitti, alimentati dalla interazione tra interessi contrapposti. Attraverso i partiti siffatti interessi entrano nel
circuito decisionale culminante nella legge. I partiti operano per realizzare interessi particolari. È proprio di un
sistema democratico la rappresentazione degli interessi di parte, così come è compatibile con un tale regime il
loro soddisfacimento per il tramite delle entità politiche che hanno vinto la competizione elettorale. In uno
Stato costituzionale di diritto, per evitare l’arbitrio nell’esercizio della potestà legislativa, il giudizio di legittimità
mira a presidiare la vocazione propria della legge quale strumento privilegiato di primo inveramento della carta
fondamentale.
In questo quadro scosso da profondi mutamenti, la “generalità”, tratto essenziale della legge, sopravvive
solo in relazione al procedimento (dal momento che in Parlamento sono rappresentate le diverse “fazioni”
della comunità), e non al contenuto delle leggi, il quale esprime interessi particolari non necessariamente
conformi ad un ipotetico interesse generale. E la stessa legge si arricchisce di inedite modalità espressive, sol
che si pensi all’impatto che su di essa ha avuto l’affermazione degli istituti propri dello stato sociale: leggi
provvedimento, leggi incentivo, leggi programma, e via discorrendo.
Questa trasformazione della legge ha dissodato il terreno più fecondo per l’attecchimento di radicate
pratiche di lobbying. Quanto più la legge diviene sensibile alle sollecitazioni provenienti dal tessuto sociale,
tanto maggiore sarà la capacità dei gruppi di pressione di influenzare i processi decisionali. Se la legge diviene
lo strumento per realizzare interessi di parte, nel senso dapprima chiarito, e se le lobbies sono per definizione
portatrici di esigenze altrettanto di parte, allora vi sono tutte le condizioni perché la legge e l’attività di lobbying
si muovano in perfetta sintonia come due ruote del medesimo ingranaggio.
Il tema delle lobbies, poi, s’intreccia con quello, senza dubbio munito di maggiore visibilità, del
finanziamento pubblico ai partiti.
In entrambi i casi le formazioni politiche sono destinatarie di utilità misurabili in termini economici. La
loro sopravvivenza, quali soggetti attraverso i quali i cittadini concorrono con metodo democratico alla
determinazione della politica nazionale, dipende dall’acquisizione delle necessarie risorse strumentali.
Nella misura in cui si contrae l’erogazione di finanziamenti ad opera dello Stato, siano essi diretti o
mediante il rimborso delle spese elettorali, aumenta la “sensibilità” dei partiti alle forme di pressione poste in
essere dalle lobbies. Alla ricerca di nuovi canali di finanziamento, i partiti cercheranno sponsor disposti a
supportarne le attività.
La Presidenza del Consiglio dei ministri ha annunciato l’imminente presentazione in Parlamento di un
disegno di legge che dovrebbe condurre ad una progressiva eliminazione del finanziamento pubblico. Ciò
verosimilmente spingerà le lobbies ad incrementare le iniziative di condizionamento dei processi decisionali,
avendo come interlocutori tanto soggettivi collettivi (i partiti) quanto singoli individui (i parlamentari) divenuti
ancor più recettivi e disponibili. È evidente, quindi, la necessità di approntare una adeguata regolamentazione
affinché l’attività di lobbying non degeneri in una mercantilistica modalità di approvvigionamento di risorse per
restare sulla scena istituzionale.
109
Non va trascurato, poi, che entrambe le fenomenologie qui considerate condivi-dono la medesima
necessità di assicurare livelli elevati di trasparenza (Biondi 2012, pp. 189 ss.). L’accessibilità, da parte di tutti gli
interessati, ai dati relativi alle somme percepite ed alla loro utilizzazione è un ulteriore elemento che
contribuisce a rinsaldare il non facile rapporto tra rappresentati e rappresentanti, messo da tempo a dura prova
da eclatanti fenomeni di malcostume e corruzione.
Del resto, in Gran Bretagna ed in Canada sono state da tempo adottate discipline atte a rendere
conoscibili gli interessi dei parlamentari e, nel contempo, quelli dei gruppi di pressione anche attraverso
specifiche regole in tema di finanziamento privato ai partiti politici (Petrillo 2011, p. 183).
4. La necessità urgente di una regolamentazione delle lobbies
La presenza dei gruppi di pressione nei circuiti decisionali è un dato conclamato. Esso è altresì un dato
fisiologico, non essendo incompatibile con un’accezione matura di democrazia l’azione dispiegata da soggetti
collettivi che aspirano ad influenzare le determinazioni assunte dalle istituzioni, a cominciare dalle leggi. È
questo uno dei tanti riflessi del pluralismo, quale elemento essenziale di qualsiasi ordinamento democratico:
invero, «una democrazia pluralista non solo ammette in linea di principio i conflitti che fondano e alimentano
una società aperta, ma dispone di una varietà di istituzioni e circuiti decisionali utili a canalizzarli, a
contemperarli reciprocamente, a trasformarne la natura o ad assorbirli nel tempo, senza scaricarne l’impatto su
un solo punto del sistema» (Pinelli 2006, p. 309).
Del resto, la radicata e rodata esperienza dei pressure groups nel Congresso degli Stati Uniti, tanto per
fare un importante esempio, conferma la compatibilità del lobbying con una matura democrazia (Galloway
1955; Blaisdell 1957; Oleszek 1989).
Le lobbies sono, dunque, una «componente indefettibile del sistema politico, espressione di un
dinamismo sociale ed economico da valorizzare» (Petrillo 2011, p. 186). Al fine di evitare pratiche
degenerative è, però, altrettanto indispensabile regolare il fenomeno con regole chiare, certe, trasparenti.
L’esperienza nordamericana lo dimostra: l’azione dispiegata dai gruppi di pressione è stata razionalizzata da
importanti atti normativi quali il Federal Regulation of Lobbying Act del 1946, e il Lobbying Disclosure Act del
1995.
In un frangente storico caratterizzato dalla crisi delle ideologie, i partiti e movimenti politici tendono
sempre più ad intercettare gli interessi particolari e a tradurli in decisioni congeniali all’appagamento degli
stessi, secondo dinamiche non troppo distanti dalle regole di funzionamento del mercato. È chiaro che in
questo contesto l’azione delle lobbies trova il terreno ideale per espandersi.
Le determinazioni politiche, a cominciare dalla legge, sono sempre più il frutto di interazioni e confronti con le
diverse componenti sociali, secondo una forma di contrattazione che si affranca dal tradizionale archetipo della
decisione come atto unilaterale imposto dai pubblici poteri. Questa “negoziazione legislativa” (De Marco 1984)
immette nei processi democratici elementi di tensione, che solo un’attenta e rigorosa disciplina può contenere
e orientare.
È, quindi, indispensabile che i rappresentati siano resi edotti delle reali ragioni sottese alle scelte
politiche invalse innanzitutto in Parlamento. E non perché, in difetto, la legge sarebbe viziata
d’incostituzionalità. Piuttosto, ciò è necessario perché la democrazia funzioni, seguendo il percorso tracciato
dai princìpi costituzionali. Detto in termini più immediati: che vi sia pure una certa impronta sulle leggi
confezionate in Parlamento o nei consigli regionali, purché tale impronta sia chiara, accessibile, nota
all’opinione pubblica. Solo in questo modo gli elettori saranno messi nelle condizioni di esprimere un voto
consapevole in occasione delle future tornate elettorali, visto che il potere politico sostanziale è assai più
complesso di quello – formale – che è definito dalla Costituzione stessa e dalle leggi che ne sono attuazione.
5. Due modelli ai quali ispirarsi
Per l’edificazione di un’adeguata e solida struttura normativa entro la quale collocare l’attività di lobbying
alcuni spunti preziosi possono essere ricavati dalla lettura di due atti istituzionali concepiti al di fuori del
territorio nazionale.
5.1. La normativa dell’Unione europea
110
Con l’accordo del 23 giugno 2011, tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, è stato istituito
il «registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati
nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione» (Sassi 2012).
Come si evince dalla lettura del preambolo, questo accordo è stato stipulato nella considerazione che «i
responsabili politici europei non agiscono in maniera avulsa dalla società civile, bensì mantengono un dialogo
aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile».
L’istituzione e il funzionamento del registro rispettano i principi generali del diritto dell’Unione
europea, compresi i principi di proporzionalità e di non discriminazione, nel rispetto del diritto dei
parlamentari europei di esercitare il loro mandato senza restrizioni. Le parti, quindi, sono tenute a garantire a
tutti gli operatori parità di trattamento.
Il registro include alcuni orientamenti sull’ambito di applicazione del registro, le attività ammissibili alla
registrazione e le esenzioni; sulle categorie cui è aperta la registrazione; sulle informazioni richieste a coloro
che intendono registrarsi, compresi gli obblighi di informazione finanziaria. Il registro include altresì un codice
di condotta, nonché un meccanismo di reclamo.
Ebbene, rientrano nell’ambito di applicazione del registro tutte le attività «svolte allo scopo di
influenzare, direttamente o indirettamente, l’elaborazione o l’attuazione delle politiche e i processi decisionali
delle istituzioni dell’Unione, a prescindere dai canali o mezzi di comunicazione impiegati, quali
l’esternalizzazione, i media, i contratti con intermediari specializzati, i centri di studi, le “piattaforme”, i forum,
le campagne e le iniziative adottate a livello locale». Queste attività comprendono, tra l’altro, i contatti con
membri, funzionari o altro personale delle istituzioni dell’Unione, la preparazione, la divulgazione e la
trasmissione di lettere, materiale informativo o documenti di dibattito e di sintesi, e l’organizzazione di eventi,
riunioni, attività promozionali e iniziative sociali o conferenze, cui siano stati invitati membri, funzionari o altro
personale delle istituzioni dell’Unione. Sono parimenti inclusi i contributi volontari e la partecipazione a
consultazioni formali su futuri atti legislativi o altri atti giuridici dell’Unione ovvero ad altre consultazioni
aperte.
L’attività di lobbying in senso proprio è descritta anche alla luce di ciò che, se-condo il presente accordo,
non è incluso nell’ambito di applicazione del registro, e cioè: le attività legate alla prestazione di consulenza
legale o altre attività professionali; le attività delle parti sociali in quanto attori del dialogo sociale (sindacati,
associazioni di datori di lavoro, ecc.); le attività rispondenti a richieste dirette e individuali di un’istituzione
dell’Unione o di un deputato al Parlamento europeo, come le richieste specifiche o periodiche di informazioni
fattuali, dati o consulenze e gli inviti individuali a presenziare ad audizioni pubbliche o a partecipare a comitati
consultivi o forum analoghi.
Il registro, poi, non concerne le confessioni religiose, i partiti politici, gli enti territoriali.
Mediante la registrazione, le organizzazioni interessate: consentono a che le informazioni fornite ai fini
della registrazione siano rese pubbliche; s’impegnano ad agire in conformità del codice di condotta;
garantiscono la correttezza delle informazioni fornite; consentono a che ogni reclamo nei loro confronti sia
trattato in base alle disposizioni del codice di condotta; consentono ad essere assoggettate ai provvedimenti
applicabili in caso di violazione del suddetto codice; prendono atto che le parti potrebbero dover divulgare la
corrispondenza e altri documenti relativi alle attività dei soggetti registrati.
Alcuni spunti interessanti possono essere dedotti dal più volte evocato codice di condotta, quale parte
dell’accordo in oggetto.
I soggetti registrati si identificano sempre con il proprio nome e facendo riferimento all’organismo o agli
organismi per cui lavorano o che rappresentano; dichiarano gli interessi, gli obiettivi e le finalità promosse e, se
del caso, specificano i clienti o i membri che essi rappresentano; evitano di ottenere o cercare di ottenere
informazioni o decisioni in maniera disonesta, esercitando pressioni indebite o comportandosi in modo
inadeguato; non rivendicano alcuna relazione ufficiale con l’Unione o con una delle sue istituzioni nei loro
rapporti con terzi, e non distorcono gli effetti della registrazione in maniera da ingannare i terzi o i funzionari o
altro personale dell’Unione; garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni fornite ai fini
della registrazione e successivamente nell’esercizio delle loro attività rientranti nell’ambito di applicazione del
registro sono complete, aggiornate e non fuorvianti; si astengono dal vendere a terzi copia dei documenti
ricevuti da un’istituzione dell’Unione; non inducono i membri delle istituzioni dell’Unione a contravvenire alle
disposizioni e alle norme di comportamento a essi applicabili.
5.2. Il contributo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)
111
Una solida impalcatura per la trasparenza delle attività di lobbismo è fondamentale per salvaguardare
l’interesse pubblico e per promuovere un’effettiva parità di condi-zioni tra imprese. Per questa ragione
l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha pubblicato, nel 2012, il decalogo
recante i Principles for Transparence and Integrity in Lobbying per supportare l’opera di regolamentazione
posta in essere dalle istituzioni nazionali. Tali princìpi sono parte integrante della strategia dell’OCSE «for a
stronger, fairer and cleaner economy».
I pilastri di una forte regolamentazione in questo ambito, come suggerito dall’esperienza, sono i
seguenti:
- definizioni «clear and unambiguous» delle attività di lobbying;
- obblighi di comunicazione volti a fornire informazioni pertinenti su aspetti chiave del lobbying in
ordine agli obiettivi perseguiti, ai beneficiari, alle fonti di finanziamento;
- standard di comportamento per evitare l’uso improprio di informazioni riservate, conflitti di interessi,
nonché per prevenire «revolving door practices»;
- collocazione delle diverse procedure entro una cornice coerente di strategie e meccanismi, inclusi il
monitoraggio e l’adozione di misure coercitive;
- promozione, da parte delle istituzioni, di una cultura di integrità e trasparenza nella pratica quotidiana
di lobbismo.
I princìpi enunciati dall’OCSE sono, dunque, i seguenti.
I. Costruzione di un quadro efficace ed equo per l’accesso alle pratiche di lob-bying.
1. Parità di accesso nel “mercato” delle lobbies. Le pubbliche istituzioni devono garantire il libero flusso
delle informazioni e la loro fruibilità. Consentendo a tutti i soggetti interessati un «fair and equitable access» per
partecipare allo sviluppo delle politiche pubbliche, gli Stati debbono nondimeno proteggere l’integrità delle
decisioni e tutelare l’interesse generale. Allo scopo di infondere nei cittadini la fiducia nel processo decisionale
pubblico, le istituzioni devono promuovere la rappresentanza equa di interessi economici e sociali.
2. Norme e linee guida sulle pratiche di lobbying adeguate agli specifici contesti socio-politici e
amministrativi. In questo modo gli Stati sono chiamati a scegliere le soluzioni più adeguate, prendendo in
considerazione in particolare i principi costituzionali e le pratiche democratiche consolidate, quali le audizioni
pubbliche o altri meccanismi istituzionalizzati di consultazione. Gli Stati non dovrebbero replicare direttamente
le regole e le linee guida da un livello di governo ad un altro, avendo quindi cura di valutare le potenzialità e i
limiti delle diverse opzioni politiche e di regolamentazione. Nei contesti in cui domanda e offerta di lobbying
sono limitate, dovrebbero essere contemplate opzioni alternative alla regolamentazione obbligatoria per
migliorare la trasparenza, la responsabilità e l’integrità nella vita pubblica. Ove si acceda ad una disciplina
cogente, le istituzioni di governo dovrebbero ponderare l’onere amministrativo di conformità alle regole per
garantire che esso non diventi un ostacolo per un accesso giusto ed equo.
3. Norme e linee guida sulle pratiche di lobbying coerenti con il generale sistema normativo di
riferimento. La regolamentazione deve essere parte integrante del quadro normativo preordinato ad una «good
public governante». Per supportare una cultura di trasparenza e integrità delle attività di lobbismo è necessario
il coinvolgimento degli stakeholder attraverso la consultazione pubblica e la partecipazione, il diritto di
petizione, la libertà di informazione, norme in materia di partiti politici e finanziamento delle campagne
elettorali, codici di condotta per i funzionari pubblici e lobbisti, meccanismi per la distribuzione efficace delle
rispettive responsabilità in caso di illecita influenza.
4. I paesi dovrebbero definire chiaramente i termini ‘lobbying’ e ‘lobbista’. Le definizioni devono essere
«robust, comprehensive and sufficiently explicit», al fine di scongiurare errori di interpretazione e per evitare
scappatoie. Nel definire l’ambito di attività di lobbying, è necessario bilanciare la diversità dei soggetti, le loro
capacità e risorse, attraverso l’adozione di misure per migliorare la trasparenza. Regole e linee guida
dovrebbero indirizzarsi in particolare a coloro che ricevono compensi per lo svolgimento di attività di lobbying.
Ad ogni modo, la definizione delle attività di lobbying dovrebbe essere considerata in modo più ampio e
globalmente per garantire par condicio tra i gruppi di pressione. Lo sforzo definitorio deve tenere conto del
fatto che vi sono modalità di interazione con i pubblici poteri che non possono considerarsi strumenti di
pressione trattandosi di rapporti formalizzati quali commissioni legislative, audizioni pubbliche e altri meccanismi istituzionali di consultazione.
II. Miglioramento degli standard di trasparenza
5. Gli Stati devono assicurare un adeguato livello di trasparenza, per garantire che i funzionari pubblici, i
cittadini e le imprese possano ottenere informazioni sufficienti sulle attività di lobbying. Ciò non esclude la
possibilità di deroghe legittime dettate, in particolare, dalla necessità di preservare le informazioni riservate di
interesse pubblico o per proteggere le informazioni di mercato sensibili in caso di necessità. Le informazioni di
112
base riguardano i lobbisti, gli obiettivi dell’attività di lobbying, i beneficiari. La comunicazione sulle attività di
lobbying e sui gruppi di pressione deve essere assicurata tramite un registro accessibile al pubblico, aggiornato
in modo tempestivo, al fine di fornire informazioni accurate tali da consentire un’analisi efficace da parte dei
funzionari pubblici, dei cittadini e delle imprese.
6. Gli Stati debbono consentire alle parti interessate – comprese le formazioni sociali, le imprese, i
media e il pubblico in generale – di esaminare le attività di lobbying. Il pubblico ha il diritto di sapere come le
istituzioni pubbliche hanno assunto le decisioni, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate di
informazione e di comunicazione, come Internet, per rendere le informazioni accessibili al pubblico in un
modo economicamente efficace. Una «vibrant civic society» che include gli osservatori, «watchdogs», gruppi di
cittadini rappresentativi e dei media indipendenti è fondamentale per garantire un adeguato controllo delle
attività di lobbying. Per identificare coloro che hanno influenzato i processi decisionali è indispensabile fornire
una «legislative footprint» che indichi i lobbisti consultati. Garantire l’accesso tempestivo a tali informazioni
consente l’inserimento di diversi punti di vista della società e delle imprese per lo sviluppo equilibrato e per
l’attuazione delle decisioni pubbliche.
III. Promozione di una cultura di integrità.
7. Gli Stati sono sollecitati a promuovere una «culture of integrity» nelle organizzazioni pubbliche
attraverso l’enunciazione di princìpi, regole, norme e procedure atte a fornire ai funzionari pubblici indicazioni
chiare su come essi sono autorizzati ad impegnarsi con i lobbisti. I funzionari pubblici devono interagire con i
gruppi di pressione in linea con le regole, gli standard e le linee guida in modo tale da garantire un pieno
controllo pubblico. In particolare, essi devono assicurare l’imparzialità nel perseguimento del pubblico
interesse, condividendo le informazioni autorizzate, non abusando delle «confidential informations», ed
evitando altresì conflitti di interesse. I decisori dovrebbero dare l’esempio «by their personal conduct» nel
rapporto con i lobbisti. A questi fini, gli Stati dovrebbero fissare alcune prescrizioni a carico dei pubblici
funzionari per evitare conflitti di interesse quando si cerca una nuova posizione e per inibire l’uso improprio di
informazioni riservate. Potrebbe essere necessario imporre un «cooling-off period» per evitare che gli ex
funzionari pubblici trovino una nuova collocazione professionale presso i gruppi di pressione con i quali hanno
interagito.
8. I lobbisti devono rispettare standard di professionalità e trasparenza, condividendo essi stessi la
responsabilità di promuovere una cultura della trasparenza e dell’integrità. Se è vero che i governi ed i
legislatori hanno la responsabilità primaria per la definizione di norme di comportamento chiare per i
funzionari pubblici, nondimeno i lobbisti e i loro clienti, come il committente, debbono esimersi dall’esercitare
un’influenza illecita, rispettando gli standard professionali nei loro rapporti con i pubblici funzionari, con altri
gruppi di pressione e con il pubblico. Per mantenere la fiducia nel processo decisionale pubblico, occorre
promuovere i princìpi di buon governo. In particolare, i lobbisti devono intrattenere le loro relazioni con i
funzionari pubblici «with integrity and honesty», fornendo informazioni affidabili e precise, nonché evitando
conflitti di interesse.
IV. Configurazione di meccanismi per l’effettiva attuazione, il rispetto ed il con-trollo.
9. Gli Stati devono coinvolgere gli attori chiave nell’attuazione di una gamma coerente di strategie e
pratiche per ottenere la conformità. La conformità è una sfida particolare quando i paesi affrontano problemi
emergenti come la trasparenza delle attività di lobbismo. Per garantire la conformità, e per prevenire e rilevare
le violazioni, gli Stati devono progettare e applicare una gamma coerente di strategie e meccanismi, incluso il
monitoraggio e l’applicazione di risorse adeguate. Tutto ciò contribuisce a creare una comprensione comune
degli standard attesi. Le strategie ed i meccanismi dovrebbero rafforzarsi reciprocamente giacché questo
coordinamento potrebbe contribuire a raggiungere gli obiettivi generali di migliorare la trasparenza e l’integrità
nelle attività di lobbying. Le strategie di implementazione dovrebbero bilanciare attentamente i rischi con
incentivi per i funzionari pubblici e lobbisti allo scopo di creare una cultura del rispetto. Sanzioni visibili e
proporzionate dovrebbero combinare approcci innovativi, come la divulgazione pubblica delle violazioni
accertate, con sanzioni tradizionali, come ad esempio l’interdizione e il giudizio penale a seconda dei casi.
10. I paesi dovrebbero rivedere il funzionamento delle loro regole e delle linee guida su base periodica e
di effettuare le regolazioni necessarie in base all’esperienza. Ciò con la partecipazione di rappresentanti di
gruppi di pressione e della società civile. L’affinamento progressivo delle regole dovrebbe essere perseguito
aggiornando le strategie di attuazione ed i relativi meccanismi operativi. L’integrazione di questi processi
aiuterà a soddisfare le mutevoli aspettative del pubblico per la trasparenza e l’integrità nelle attività di lobbying.
6. Una proposta
113
Alla luce di quanto osservato in precedenza, si suggerisce innanzitutto di includere nel testo
costituzionale una previsione di principio sui gruppi di pressione.
La collocazione ideale appare l’art. 67, sul divieto di mandato imperativo, a cui si potrebbe aggiungere
un secondo comma così sobriamente formulato: «Con legge ordinaria sono stabilite le norme sull’attività dei
gruppi di pressione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, non discriminazione, correttezza ed integrità».
La legge ordinaria di attuazione dell’art 67, secondo comma, dovrebbe quindi disciplinare nel dettaglio
l’attività di lobbying, prevedendo, in particolare: la definizione di lobbista e di lobbying; la creazione di un
registro dei gruppi di pressione accreditati; la definizione di adeguate regole di condotta; la previsione di
obblighi stringenti di trasparenza; la predisposizione di un appropriato e proporzionato sistema sanzionatorio.
Gli stessi regolamenti parlamentari, resi omogenei sul punto, dovrebbero essere integrati da previsioni
relative ai gruppi di pressione, e gli stessi presidenti dovrebbero adottare, tramite circolare, misure volte a
disciplinare l’accesso alle sedi istituzionali da parte dei rappresentanti delle lobbies.
Anche a livello regionale gli statuti e le leggi regionali dovrebbero dettare una apposita disciplina in
materia.
114
Capitolo VI
GLI OGGETTI DELLA COSTITUZIONE
COSTITUZIONE ECONOMICA
I soggetti della costituzione economica, nello svolgimento delle rispettive attività, utilizzano
oggetti materiali e immateriali che nel linguaggio giuridico sono definiti beni.
beni
In questa sede sarà illustrata la distinzione tra:
- beni privati;
- beni pubblici;
- beni comuni.
In generale, i beni materiali sono le cose e le energie suscettibili di appropriazione: si distingue
così tra beni immobili (che sono materialmente incorporati al suolo) e beni mobili (tutti gli altri beni);
tra beni fungibili (che possono indifferentemente sostituirsi gli uni agli altri in quanto eguali quantità
di cose dello stesso genere sono del tutto equivalenti ai fini della loro utilizzazione) e beni infungibili
(ossia, le cose prodotte in esemplari unici, nonché tutte le cose usate); tra beni consumabili (ossia
insuscettibili di un uso continuativo o ripetuto) e beni inconsumabili (tutti gli altri, anche se soggetti a
deterioramento). Sono, poi, pertinenze le cose destinate in modo durevole ad ornamento o a servizio
di un’altra cosa senza esserne parte costitutiva (così il garage). Sono universalità di mobili le pluralità
di cose appartenenti alla medesima persona ed aventi una destinazione unitaria (es. una collezione di
francobolli). Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, indipendentemente
dall’intervento dell’uomo, mentre sono civili i frutti che si ricavano da un bene come corrispettivo del
godimento assegnato ad altri.
Sono beni immateriali le creazioni intellettuali come le opere dell’ingegno.
Sezione I
I BENI PRIVATI
Quando si parla di beni privati si allude al diritto di proprietà.
proprietà
La proprietà è il diritto soggettivo per antonomasia. Anzi, si può persino affermare che, nella
millenaria evoluzione delle istituzioni giuridiche, sia venuta prima la proprietà del concetto stesso di
diritto soggettivo. Quest’ultimo, infatti, è stato artificiosamente costruito dai giuristi proprio partendo
dalla proprietà.
La proprietà, in quanto diritto soggettivo, è un fascio di poteri, pretese, facoltà che
l’ordinamento riconosce ad un soggetto (persona fisica o giuridica) in relazione ad un determinato
bene, mobile o immobile, affinché ne possa goderne pienamente. L’art. 832 del codice civile, infatti,
attribuisce al proprietario il «diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro
i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico».
La proprietà è un diritto assoluto,
assoluto in quanto opponibile a tutti (→ erga omnes), diversamente
dai diritti di credito che, in quanto relativi, valgono solo nei confronti di determinati soggetti, i
debitori.
La proprietà è un diritto reale,
reale in quanto è il diritto di trarre da un bene le sue utilità
economiche legalmente garantite o alcune di esse.
La proprietà si distingue dagli altri diritti reali che, avendo un contenuto più limitato, vengono
detti diritti reali minori:
- i diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, servitù prediale, enfiteusi);
- i diritti reali di garanzia (pegno, ipoteca).
La proprietà si distingue anche da altri istituti che, spesso, nel linguaggio comune sono utilizzati
come sinonimi: possesso e detenzione.
detenzione Nel diritto, proprietà, possesso e detenzione sono istituti
115
diversi. La proprietà è un diritto soggettivo, mentre possesso e detenzione sono poteri di fatto su una
cosa. Inoltre, il possesso è un potere di fatto che riflette un diritto reale (ad es., il proprietario che ha
nella propria disponibilità un bene, o l’usufruttuario), mentre la detenzione è un potere di fatto che
riflette un diritto di credito (ad es. chi ha preso in affitto un negozio di proprietà di un altro soggetto),
con la conseguenza non marginale che solo chi ha il possesso può usucapire un bene, ossia divenirne
proprietario dopo un uso ininterrotto per un lasso temporale stabilito, a seconda del bene, dal codice
civile.
La proprietà si acquista nei modi e secondo le forme previste e disciplinate dal codice civile.
Codice che garantisce e tutela la proprietà con diverse modalità.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia, oltre che alla lettura diretta de codice civile, ad un buon
manuale di istituzioni di diritto privato.
Ebbene, la Costituzione si occupa di proprietà all’art.
art. 42,
42 di cui si riporta il testo:
1. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad
enti o a privati.
2. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i
modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti.
3. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.
4. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria
e i diritti dello Stato sulle eredità.
Il commento di F. Macario, successivamente riportato, illustra la dimensione costituzionale del
diritto di proprietà.
Prima, però, si osservi quanto segue.
1) La Costituzione riconosce la proprietà pubblica accanto a quella privata. Ciò è rilevante
anche sul piano delle attività economiche di produzione di beni o di servizi, visto che nei sistemi di
socialismo reale i fattori di produzione sono di proprietà rigorosamente pubblica. Ed in effetti il
nostro art. 42 individua non solo nei privati, ma anche nello Stato il possibile e legittimo proprietario
dei beni economici.
2) La dimensione sociale del nostro sistema costituzionale affiora anche in questa disposizione.
La proprietà può essere senz’altro privata, ma il legislatore può regolarla anche per assicurarne la
«funzione sociale». Cos’è la funzione sociale della proprietà ? Come si vedrà in seguito, anche
l’iniziativa economica privata può essere limitata o vincolata per ragioni di «utilità sociale».
3) La proiezione sociale della proprietà privata affiora anche dall’obbligo posto in capo al
legislatore ordinario di intervenire per rendere la proprietà stessa accessibile a tutti. Altrimenti, non
avrebbe senso il principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma.
4) L’espropriazione della proprietà privata è un fenomeno noto e risalente alla notte dei tempi.
Solo che, una volta, non vi erano garanzie per i proprietari che vedevano coattivamente sottrarre dal
proprio patrimonio un bene anche di rilevante valore. La Costituzione ribadisce la vigenza di tale
potere amministrativo, pur assegnano alla legge il compito di prevederlo e disciplinarlo (→ principio
di legalità). Si ribadisce che – anche se appare superfluo – che tale potere può essere esercitato, al
pari di tutti i poteri amministrativi, solo per soddisfare interessi generali. Il problema è, dunque,
l’indennizzo: una cifra simbolica, per un compassionevole ristoro della perdita subita, o una somma il
più possibile vicina al valore di mercato del bene espropriato ?
116
F. MACARIO, Commento all’art. 42, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario
alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 864 ss.
1. Precedenti, origine e linee evolutive
1.1 Le origini della disposizione e il dibattito alla Costituente
Rappresentazione emblematica, non soltanto nell’ottica del diritto civile, dello stesso concetto di diritto
soggettivo, la proprietà privata ha sempre occupato un ruolo centrale nel nostro ordinamento (così come in
altri). Si pensi anche soltanto alle norme in tema di proprietà presenti nel c.c. del 1865, che disciplinava
dettagliatamente l’istituto, sul quale tutto il codice era del resto impostato, al punto che il II libro era dedicato
al regime «dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni» e il III si occupava «dei modi di acquistare e
trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose». Le Carte costituzionali, per parte loro, completavano il
quadro garantistico, sancendo il carattere sacro e inviolabile della proprietà privata.
Costituisce pertanto la conferma dell’importanza del tema il controverso dibattito svoltosi in sede di
Assemblea Costituente. L’analisi storica e politica conferma la radicale contrapposizione, emersa in seno alle
diverse forze politiche, relativamente alla funzione economica e sociale della proprietà. Una corrente di
pensiero, di ispirazione cattolica, era favorevole ad assegnare alla proprietà privata, quale espressione del
«diritto soggettivo della persona umana», un ruolo fondamentale nel contesto del sistema economico e della
tutela dei diritti soggettivi. Altra e contrapposta tendenza, di ispirazione marxista, si muoveva nella prospettiva
di sancire il riconoscimento costituzionale soltanto alla proprietà pubblica, appartenente allo Stato, oppure ad
organismi collettivi o cooperative queste ultime diffuse nelle Regioni governate da forze politiche di sinistra.
Le discordanti visioni politiche ed economiche finivano per attribuire alla proprietà funzioni diverse. I
sostenitori del sistema capitalistico e del libero mercato identificavano nella proprietà tutto lo spazio che
l’ordinamento concede «alla signoria dell’individuo» nella sfera economica, sia sotto il profilo statico
dell’utilizzazione del bene, sia sotto il profilo dinamico della libertà di agire economicamente, di acquisire i
beni, di alienarli, di vincolarsi verso i terzi mediante i rapporti obbligatori. La contrapposta corrente di
pensiero affermava, invece, la prevalenza delle «forze del lavoro» ed esaltava i valori sociali sui quali avrebbe
dovuto fondarsi la Repubblica, riconoscendo la funzione insostituibile della proprietà personale, ancorata
all’istituzione di una «Repubblica di agricoltori indipendenti».
Il dibattito, che vide confrontarsi le diverse ideologie, si sviluppò su tre piani distinti. Il primo era
relativo all’esame dell’intero progetto della Costituzione repubblicana (elaborata dalla Commissione dei 75). Il
secondo, invece, concerneva l’impostazione teorica e politica relativa alla funzione della proprietà consacrata
nella Carta costituzionale (ed elaborata essenzialmente da Togliatti) e, in particolare, l’esame del Titolo III
della Parte I della Costituzione (relativa all’esame dei problemi dell’economia con specifico riferimento
all’analisi dei modelli economici e sociali diffusi in quel periodo storico). Infine, il terzo piano cui si accennava
atteneva alla formulazione della disposizione in esame.
La disciplina elaborata in sede costituente rappresentava il risultato del lavoro della I e della III
Sottocommissione, entrambe impegnate sulla disciplina della proprietà, benché in una diversa prospettiva: la I,
volta a individuare il nesso fra la proprietà e i diritti fondamentali della persona; la III, incaricata di definire la
regola con riferimento ai rapporti economici e sociali. Così, proprio nell’intento di sancire il diritto di proprietà
come garanzia costituzionale riconducibile ai diritti fondamentali, Dossetti proponeva di distinguere
nettamente il regime della proprietà personale, frutto del lavoro e del risparmio, volto a garantire la libertà e
l’affermazione della persona e della sua famiglia, dal regime della proprietà dei beni strumentali, finalizzata ad
assicurare il coordinamento della vita economica, tutela del diritto alla vita, al lavoro e al benessere per tutti.
Non tardò ad emergere così la difficoltà tecnica di armonizzare i tre obiettivi: riconoscere la natura
costituzionale al diritto di proprietà, connettere il diritto di proprietà costituzionalmente tutelata al lavoro e al
risparmio, elaborare un modello di proprietà alternativo a quello civilistico, finalizzato alla realizzazione di un
progetto di gestione economica delle risorse pubbliche e private.
La difficoltà di contemperare le diverse esigenze costituiva anche un indice della rilevanza, ed anzi del
valore centrale che i costituenti attribuivano alla proprietà, da taluno ancora intesa alla stregua dei diritti
fondamentali ovvero quale strumento essenziale per garantire la libertà e l’indipendenza della persona. Un
punto di convergenza poteva rinvenirsi nell’idea di una garanzia individuale di una sfera di azione autonoma
identificabile con la proprietà e con i limiti che tale tutela costituzionale avrebbe dovuto avere. L’idea era,
tuttavia, ancora generica, sicché non si riuscì a raggiungere un accordo chiaro e puntuale, dal momento che
non si riteneva possibile porre limiti all’esercizio del diritto, senza aver prima risolto l’annoso problema relativo
117
alla necessità o anche soltanto opportunità che la Carta fondamentale distinguesse tra forme di proprietà
riconosciute e proprietà non garantite a livello costituzionale.
Il processo di formulazione della disposizione proseguì così in sede di Assemblea, con la presentazione
di emendamenti, risentendo della preliminare esigenza di definire l’assetto del governo dell’economia al fine di
determinare il contesto in cui il problema della proprietà privata avrebbe dovuto collocarsi. Né mancavano, da
parte di costituenti di matrice comunista, emendamenti ove si proponeva un modello economico di tipo
sovietico caratterizzato dall’intervento dello «Stato per coordinare ed orientare l’attività produttiva dei singoli e
di tutta la Nazione, secondo un piano che assicuri il massimo di utilità sociale»: una proposta inaccettabile per
la maggioranza dell’Assemblea, la quale manifestava forte diffidenza verso i pretesi vantaggi di tale modello
(che non sembrava offrire soluzioni concretamente costruttive). Rigettati tutti gli emendamenti proposti, l’art.
38 del progetto divenne così l’art. 42 senza subire modifiche.
Il rapido excursus storico-politico vale a porre in luce l’esigenza, avvertita in sede di Assemblea
Costituente, di disciplinare la proprietà in relazione a precisi obiettivi di natura economico-sociale. Il risultato
dell’appassionato dibattito è in una nozione di proprietà, riconosciuta e garantita dalla Costituzione, che non
soltanto si riallaccia alla tradizione civilistica, ma sembra veicolare quel «sentimento del diritto soggettivo», in
cui sono richiamate le idee forza del liberalismo europeo, come «diritto di partecipazione alla organizzazione e
sviluppo della vita economica». In questo ruolo partecipativo, il proprietario è tutelato, sicché, «la ratio della
tutela costituzionale non è tanto la sua personalità quanto la funzionalità del sistema socio-economico».
La tutela proprietaria si atteggia così a presupposto essenziale di un ordinamento che accetta l’economia
di mercato. Il contenuto del diritto può essere inciso solo nel conflitto con altri valori costituzionali ritenuti
prevalenti e il legislatore in tale giudizio è soggetto al controllo sulle modalità con cui tale bilanciamento è
avvenuto. Quello che, con formula più suggestiva che descrittiva, è stato definito «terribile diritto», non è «pura
forma né puro concetto ma un nodo di sentimenti, certezze speculative, interessi grezzi», di cui il legislatore
non può non farsi carico alla luce, in primo luogo, dell’intero disegno costituzionale.
1.2 La disciplina costituzionale della proprietà nel sistema del diritto civile
Le difficoltà che la riflessione giuridica sul diritto di proprietà è inesorabilmente destinata a incontrare
sul piano della teoria generale, muovendo innanzitutto dai dati normativi offerti dal sistema del c.c., non
sembrano diminuire ove si adotti la prospettiva costituzionale della disciplina della proprietà privata. Del resto,
appare già sufficientemente complesso il tentativo di riordino legislativo, tentando di stabilire quante volte e in
che modo una copiosissima legislazione speciale, nelle materie più varie, abbia dato attuazione alle regole di
fondo (o se si preferisce, ai principi) della Carta fondamentale.
È dunque soltanto apparente la maggiore facilità di ricostruzione della coerenza del sistema (in materia
di diritto di proprietà, ma in particolare della proprietà privata) che offrirebbe il dato costituzionale, rispetto al
passato, che imponeva un’elaborazione (di tipo dogmatico) fondata sull’architettura del c.c. e sulle teorie con
cui la dottrina aveva preparato l’edificazione dell’impianto normativo espresso dalla codificazione.
Premesso che il diritto di proprietà costituisce per i giuristi innanzitutto una figura astratta del pensiero,
della quale la cultura giuridica si serve per poter organizzare discorsi di tipo sistematico e generale, è evidente
che mai come in tema di proprietà la ricostruzione giuridica dell’istituto non possa che procedere in
concomitanza con un’analisi di tipo storico del concetto stesso.
Il discorso vale evidentemente tanto per il sistema del diritto di proprietà delineato dal c.c. - che, non a
caso, si ritiene comunemente tramontato o comunque soppiantato dalla legislazione di settore - quanto per
l’assetto normativo della proprietà privata nella chiave costituzionale. Qualsiasi tipo di impostazione sistematica
dello studio del diritto di proprietà non può dunque che ricondursi alla storia e, più in particolare, alla cultura
e ai valori vigenti in un determinato periodo.
Ancor più che in altri settori disciplinari è perciò ardua una ricostruzione sistematica dell’intero istituto,
in cui si riesca a comporre in modo armonico le regole costituzionali, quelle del c.c. e la multiforme
legislazione speciale che, nei più vari ambiti, ha enormemente arricchito il quadro della disciplina della
proprietà privata. Infatti, al prevalente momento politico, individuabile nel dettato costituzionale (cui s’è fatto
appena cenno), fa riscontro il momento essenzialmente tecnico, anch’esso peraltro inscindibile dalle
connotazioni ideologiche, del dettato codicistico. A tale quadro si aggiunge l’occasionalità della legislazione
speciale (non sempre in linea con il disposto costituzionale e perciò puntualmente sottoposta al vaglio della
Corte, come si avrà modo di vedere nel prosieguo), che contribuisce al carattere asistematico della disciplina.
Le diverse impostazioni metodologiche si rivelano pertanto decisive in qualsiasi studio in materia, fermo
118
restando che la disciplina costituzionale non può eludere il suo ruolo di riferimento fondamentale per il
controllo di logicità e ragionevolezza di ogni operazioni ermeneutica.
...
1.4 Segue: ideologia e sistematica della proprietà «funzionalizzata»
Il tentativo di comprendere il senso del riferimento costituzionale alla funzione sociale non può
trascurare il retroterra, sia pur sommariamente delineato, di natura ideologica e sistematica. Certamente non è
difficile rinvenire gli echi della tradizione cattolica, che riporta la funzione sociale all’«ordine naturale
dell’economia», la quale sancisce «non soltanto il diritto di appropriazione privata, ma il diritto di tutti all’uso
comune dei beni».
Questo tipo di interpretazione della nozione di funzione sociale determina, inevitabilmente,
conseguenze pratiche ovvero, secondo un’autorevole opinione, «la funzione sociale appare operante, in
maniera prevalente se non esclusiva là dove attorno ai beni economici in proprietà si instauri un rapporto che
sollecita l’altrui collaborazione nell’utilizzazione della cosa», nel senso «di un particolare modo di essere
dell’individuo in confronto degli altri» e della necessità di valutare secondo tale criterio «gli atti del dominus
compiuti nell’ambito dei rapporti connessi all’utilizzazione del bene o dei beni che sono oggetto del diritto di
proprietà».
Sempre fra ideologia ed esigenze della sistematica, si rinviene la ratio della funzione sociale anche
nell’esigenza di garantire la libertà e l’affermazione della persona. Riconosciuta, pertanto, l’importanza e la
rilevanza della funzione sociale come principio ordinatore della disciplina della proprietà, si ritiene che alla
stregua di tale criterio si possa e si debba operare ove sorga un «problema di controllo dell’esercizio di poteri
proprietari in forme tali da poter determinare situazioni di conflitto con l’interesse della collettività».
Che l’art. 42 Cost. non sia formulato secondo i canoni delle enunciazioni civilistiche, in quanto in tale
prospettiva la norma risulterebbe assai poco significativa, è un dato pressoché indiscutibile. Si è detto allora
correttamente che «il problema non è quello della formulazione degli enunciati costituzionali, ma quello degli
orizzonti dell’apparato ermeneutico che l’interprete è disposto a porre all’opera». Neanche è mancato chi ha
fatto osservare come, a bene vedere, nel testo costituzionale, la parola proprietà sia mutevole, quanto al suo
significato, almeno se ci si pone nella prospettiva civilistica pura.
Considerando come la stessa Corte costituzionale, in realtà, abbia esteso la garanzia prevista per la
proprietà privata ad altre situazioni di appartenenza (non coincidenti con il diritto di proprietà), una corretta
concezione è incline a ritenere che il termine proprietà privata sia nella Costituzione, non soltanto di significato
più ampio rispetto a quello che può avere nel codice civile, ma anche riferibile a problemi e tematiche
assolutamente estranee a quelle considerate dai conditores del codice».
Con riferimento al dettato costituzionale, possono distinguersi senza particolari difficoltà i due profili
relativi, rispettivamente, alla interpretazione costituzionalmente adeguata del concetto di proprietà privata e alla
garanzia costituzionale della stessa. Chi ha attentamente ricostruito gli itinerari della dottrina, alla ricerca di
un’interpretazione costituzionalmente adeguata del sistema stesso del diritto di proprietà, ha fatto notare, come
la funzione sociale abbia svolto un duplice ruolo. Essa ha costituito il centro focale delle varie forme e
discipline dei beni ricadenti nella proprietà privata e, d’altro lato, ha contribuito a ridurre (o forse a
neutralizzare) la barriera costituita dalla eccezionalità dei limiti alla proprietà privata, che aveva impedito di
tenere conto nelle ricostruzioni del diritto di proprietà in chiave di teoria generale - in sostanza, nella
prospettazione dogmatica dell’istituto - delle diverse discipline di conformazione della proprietà espresse dalle
leggi speciali sempre più numerose, mentre sul piano ermeneutico, le norme costituenti un limite alla proprietà
dogmaticamente intesa avrebbero incontrato le preclusioni e comunque le strettoie che la disciplina generale
dell’interpretazione della legge riserva appunto alle norme di natura eccezionale.
Si deve a pionieristici studi (esemplari quelli di Rodotà, seguiti, in diverso modo evidentemente dalle
riflessioni di Rescigno e di Sacco) il dischiudersi di nuove prospettive, che avrebbero consentito l’applicazione
anche analogica delle disposizioni che, in apparente contraddizione logico-sistematica all’enunciazione generale
della massima libertà di godere e disporre del proprietario (di cui all’art. 832 c.c.), stabilivano una serie di
«limiti», da considerarsi, nelle più moderne prospettazioni, elementi strutturali e fisiologici di un determinato
modo di essere del tipo di proprietà privata disciplinata dal legislatore, in termini di disciplina o regime
giuridico del bene.
Fondamentale risultava così l’impostazione delle riflessioni di Pugliatti, il quale attribuiva al concetto di
funzione sociale della proprietà privata il compito di sintetizzare, costituendone il comune denominatore, le
119
discipline degli altrettanti tipi di proprietà privata, diversi al punto da suggerire e legittimare l’uso del concetto
al plurale. La funzione operava così dall’esterno, quale direttiva indirizzata al legislatore per la conformazione
della proprietà nelle diverse normative di settore. Altri ha tentato di concretizzare l’idea della funzione sociale
espressa dalla Costituzione alla luce dei principi (ovvero dei valori) del welfare, prendendo in considerazione il
costo sociale relativo alla utilizzazione e distribuzione delle risorse. Appare, del resto, abbastanza evidente che
l’affermazione del requisito della funzione sociale non implichi un’opzione ideologica precisa nel senso del
produttivismo e del benessere economico quali punti di riferimento di una determinata filosofia politicosociale.
1.5 Segue: funzione sociale e limiti ai diritti del proprietario
Nella difficoltà di offrire una concretizzazione alla formula funzione sociale mediante il riferimento ai
costi e ai benefici dello stato sociale (ovvero, s’è detto, del welfare), l’espressione costituzionale veniva così
collegata ai compiti che la Carta fondamentale assegna alla Repubblica, con particolare riferimento al
raggiungimento dell’eguaglianza cosiddetta «sostanziale» (di cui all’art. 3, 2° co., Cost.). Se poi si identifica la
funzione sociale con riferimento, non tanto all’istituto proprietario, ma al «sistema di limiti», la
funzionalizzazione non atterrebbe più alle facoltà dominicali, ma appunto alle sue limitazioni, che
costituirebbero, in ultima analisi, la negazione delle facoltà dominicali intese nel senso più tradizionale.
Tale lettura è stata tuttavia ritenuta da taluno troppo «estremistica», al punto da collocarsi fuori dello
spirito compromissorio che aveva dato vita al testo costituzionale, in quanto «rifiuta di scorgere i valori che si
fondano sulle condotte economiche individuali con i quali gli altri valori vanno contemperati». Alla luce del
panorama attuale, e discorrendo in termini socio-economici, anche la scelta di attribuire senz’altro prevalenza
ai valori costituzionalmente rilevanti, che rappresentano interessi di ordine collettivo rispetto a quelli più
direttamente imputabili all’individuo e, quindi, alla concezione soggettivistica della proprietà privata, non
soltanto pone un problema di rapporto con lo spirito della Costituzione (oltre che con il suo dettato, in
particolare dell’art. 42), ma rischia di apparire anche incongrua rispetto alla cosiddetta economia sociale di
mercato, che fa capo a modelli, i quali «prevedono tutti un sistema economico concorrenziale e non può darsi
concorrenza se non si riserva e si garantisce istituzionalmente che la gestione economica dei beni sia affidata
per una porzione piuttosto larga a scelte individuali di tipo proprietario».
Taluno, in dottrina, ha segnalato addirittura il rischio di incorrere in un vero e proprio errore logico,
celato nella confusione fra la funzione sociale del limite e la funzione sociale invece della proprietà tout court.
Pertanto, è assolutamente ragionevole che il costituente, nella consapevolezza della necessaria indeterminabilità
del valore affidato all’espressione funzione sociale, abbia deciso di demandare al legislatore ordinario la
realizzazione di tutto ciò che poteva essere compreso, a seconda delle condizioni socio-economiche e delle
scelte di politica del diritto, in detto valore, istituendo, in un certo senso, una sorta di filtro giuridico fra
l’enunciazione costituzionale e la sua concreta attuazione (diversamente da quanto accade per altri valori
costituzionali dotati di forza normativa tale da essere direttamente operanti nei rapporti e che possono
costituire, quindi, oggetto immediato dell’attività dell’interprete).
In tal senso, se da un lato non dovrebbero trovare cittadinanza nel nostro ordinamento normative di
settore che non realizzino, nello specifico e in modo concreto, la funzione sociale prevista dal costituente,
dall’altro si deve convenire con chi ha affermato che l’assegnazione al legislatore ordinario del compito di
promuovere la funzione sociale vincola l’interprete a dedurre significato e operatività della «funzionalizzazione»
da un’interpretazione sistematica estesa all’intera normativa in materia di proprietà, che dovrà pertanto risultare
coerente.
La funzione sociale della proprietà privata finisce dunque per identificarsi nella stessa disciplina del
singolo tipo di bene, che evidentemente non può che contraddire alla logica - si direbbe meglio, la mistica della proprietà privata apparentemente desumibile dalla lettura delle disposizioni generali del c.c. in questa
materia. Il criterio fondamentale adottato dalla Costituzione, in altri termini, si rifletterebbe sullla disciplina dei
beni anziché su quella del diritto di proprietà, frammentato quest’ultimo, ormai inesorabilmente, nella
vastissima legislazione di settore, che incide direttamente sull’uso e sulla circolazione dei beni di proprietà
privata.
Sul versante poi dei limiti della garanzia costituzionale del diritto di proprietà, un ostacolo può essere
costituito dalla concezione, piuttosto diffusa, secondo la quale gli interventi conformativi attuati dal legislatore
ordinario, proprio in quanto mirati sulla disciplina dei singoli beni e diretti a realizzare la funzione sociale
prevista nella Carta fondamentale, sarebbero sempre legittimi. A parte lo svuotamento di significato della
formula costituzionale che verrebbe a determinarsi ove si ritenesse che qualsiasi intervento del legislatore
120
ordinario realizzi di per sé la funzione sociale, è comunque necessario rammentare la distinzione fra interesse
pubblico e interesse «sociale». È evidente, infatti, che la disciplina della proprietà privata contenuta nella
legislazione di settore risponde sempre a un interesse particolare (di un gruppo o di una categoria) di soggetti
che non identificano o esprimono, nel loro insieme, un interesse generale. Da un altro punto di vista, deve
segnalarsi l’atteggiamento di cautela della Corte costituzionale, che soltanto eccezionalmente avrebbe avuto
modo di valutare il carattere «funzionale-sociale» delle scelte operate dal legislatore ordinario.
2. Commento
2.1 La funzione sociale della proprietà privata in tema di:
(a) locazioni
L’art. 42, 2° co., Cost. ha costituito il fondamento del regime vincolistico delle locazioni di immobili
adibiti all’esercizio di attività commerciale o artigianale (ai sensi della l. 1115/1971) e nello stesso senso ha
ragionato, successivamente, la Corte con riferimento al regime di blocco dei canoni delle locazione degli
immobili urbani adibiti ad uso abitativo (ai sensi della l. 1444/1963 e delle successive disposizioni di proroga).
Dopo l’introduzione della l. 392/1978 sull’equo canone, la Corte è intervenuta più volte, sempre ritenendo
legittime le disposizioni censurate: ad esempio, quelle che consentono al proprietario/locatore di riottenere la
disponibilità dell’immobile, purché sia proprietario da almeno due anni e dimostri la necessità propria di
adibire l’immobile ad uso abitativo o commerciale; così come la norma che non prevede il diritto del locatore
di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo di recedere anticipatamente dal contratto in regime
transitorio, nel caso di mancata occupazione continuativa dell’immobile da parte del conduttore (art. 73, l.
392/1978). Nel 1988 la disciplina dell’equo canone (l. 392/1978) viene considerata dalla Corte nel suo
complesso legittima, in quanto la compressione del diritto di proprietà del locatore sarebbe stata giustificata
«dall’esigenza ancora attuale, di assicurare ai conduttori una adeguata stabilità sul godimento di un bene
primario», sicché la normativa è intesa dalla Corte come «graduale passaggio dalla legislazione vincolistica alla
nuova legge sulle locazioni urbane, che realizza un’equilibrata tutela dei contrapposti interessi dei conduttori e
dei locatori». Sono, invece, le ulteriori proroghe che suscitano gli strali della Corte, che ritiene irrazionale la
protrazione della normativa (eccezionale e temporanea) per lo sconfinamento rispetto al fondamentale criterio
della funzione sociale.
(b) rapporti agrari
Più di una volta è stata sottoposta al vaglio della Corte la disciplina dei rapporti agrari (con riferimento,
in primo luogo, alla l. 11/1971, recante la nuova disciplina dell’affitto di fondi rustici), ritenuta
costituzionalmente illegittima nelle disposizioni che non prevedevano forme di rivalutazione periodica del
canone, così come nella parte in cui venivano fissati i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale, ai
fini della determinazione del canone, in quanto la compressione del diritto dominicale ne avrebbe comportato
quasi l’annullamento, riducendo il reddito in misura irrisoria. La normativa impugnata violava, specie in
ragione dell’insufficienza dei coefficienti di rivalutazione [a volte onerosi per la proprietà della terra, a volte
determinandone il reddito in misura irrisoria], gli artt. 42, 2° co., e 44, 1° co., Cost., «perché incide fortemente,
sino ad annullarlo, su un diritto riconosciuto e garantito, talvolta addirittura da una specifica tutela». Legittime,
invece, sono state ritenute dalla Corte quelle forme di limitazione del diritto del proprietario/concedente, il
quale, non partecipando alle spese di coltivazione del fondo, vedeva compressi i suoi diritti alla ripartizione del
prodotto.
(c) distanze nelle costruzioni
La funzione sociale della proprietà ha inoltre consentito di ritenere comprese nella disposizione dell’art.
42, 2° co., le norme sulle distanze nelle costruzioni, giustificabili appunto alla luce del criterio generale indicato
dalla Costituzione.
(d) cave e vincoli urbanistici e/o paesistici
121
Diversa la logica seguita dalla Consulta in relazione ai giacimenti di cava, così come ai vincoli urbanistici
e paesistici. Per i primi, la tutela dell’interesse pubblico giustifica, costituendone secondo la Corte il
fondamento, il regime autorizzatorio; per i secondi, il discorso è certamente più articolato, ma la
giurisprudenza costituzionale si rivela costante e omogenea.
Vi è, evidentemente, un legame piuttosto stretto con la giurisprudenza in tema di espropriazione [...], ma
in prima battuta si può rilevare che la Corte ha sempre, sin dall’inizio, ritenuto connaturali al diritto di
proprietà la disciplina dello jus aedificandi e, quindi, i vincoli derivanti dalla normativa, di varia natura, in
materia urbanistica ed edilizia. Sono rimaste storiche - a mo’ di pietre miliari, per così dire - le decisioni
55/1968 e 56/1968 [...], ove è stata sancita la legittimità dei limiti aventi per scopo una disciplina dell’edilizia
urbana relativa alla immodificabilità di quelle aree che i piani destinano al trasferimento, in vista di
trasformazioni programmate per diverse utilizzazioni del suolo, in considerazione della particolare natura e
funzione dei piani.
Fra le cosiddette «limitazioni» all’esercizio della proprietà ovvero tra le disposizioni di natura
conformativa del diritto un ruolo di primo piano è svolto dalle regole in materia di concessione edilizia che,
senza scorporare il diritto dominicale dallo jus aedificandi, impone al proprietario di corrispondere un
contributo a favore del Comune concedente, ritenuto in linea di principio ragionevole e in sintonia con
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale (oltre che politica). Il limite, perché
non si sconfini nella illegittimità delle disposizioni in materia di concessione, è dato da quella sorta di bussola
generale nelle mani della giurisprudenza costituzionale, costituita dal criterio della ragionevolezza.
Sempre l’interesse pubblico ha poi consentito di ritenere legittima la disposizione dell’art. 11, ult. co., l.
729/1961 (di proroga del termine per le occupazioni temporanee), per l’esigenza sopravvenuta di apportare
modifiche ai progetti di costruzione di opere pubbliche già approvati.
La tutela del paesaggio, secondo l’art. 9 Cost., è stata poi posta in relazione ai vincoli relativi ai diritti
sulle terre incluse nei parchi o riserve, con la conseguenza che, nella normativa in materia di terre di uso civico
incluse in parchi e riserve, non incidendo sull’assetto proprietario, ma disciplinando il godimento
«funzionalizzato» rispetto ad interessi generali, detti vincoli non sono stati ritenuti assoggettabili alle procedure
di sdemanializzazione.
(e) servitù prediali
Di recente, infine, la Corte è intervenuta, utilizzando (anche) il disposto della norma costituzionale in
esame, con una sentenza di tipo additivo in materia di servitù di passaggio coattivo a favore di un fondo non
intercluso in considerazione delle esigenze dei portatori di handicap di accedere ad edifici destinati ad
abitazione. La Corte ha ritenuto che l’impossibilità di accedere alla pubblica via, attraverso un passaggio
coattivo sul fondo altrui si traduce nella lesione del diritto del portatore di handicap ad una normale vita di
relazione (un diritto che trova peraltro espressione e tutela in una molteplicità di precetti costituzionali).
Quanto alla espropriazione,
indennizzo dovuto al
espropriazione il nocciolo della questione è la misura dell’indennizzo
soggetto che si vede sottrarre coattivamente (in tutto o in parte) un bene immobile di sua proprietà.
Con la sentenza . 348 del 2007, la Corte costituzionale ha stabilito che l’indennizzo cui lo Stato
è tenuto in caso di espropriazione non può ritenersi legittimo se non consiste in una somma che si
ponga in rapporto ragionevole con il valore del bene. In precedenza, la norma dichiarata
incostituzionale prevedeva una indennità oscillante, nella pratica, tra il 50 e il 30 per cento del valore
di mercato del bene ed ulteriormente ridotta dall’imposizione fiscale.
Sezione II
I BENI PUBBLICI
Appartengono necessariamente allo Stato e sono inalienabili (dunque, non possono essere
acquistati dai privati neppure per usucapione) i beni del demanio pubblico:
pubblico tali sono il lido del mare,
la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in
materia; le opere destinate alla difesa nazionale.
122
Fanno parte del demanio pubblico e sono sottoposti al medesimo regime, solo se appartengono
allo Stato o ad enti pubblici territoriali: le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli
acquedotti; gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in
materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni
che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico; i cimiteri, i mercati
comunali. Ciò significa che tali beni possono anche essere di proprietà privata.
Altri bene fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti pubblici territoriali.
Più precisamente: le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello
Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le
cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in
qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Presidenza della
Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Fanno parte del
patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro
appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a
un pubblico servizio.
Infine, i beni che, pur appartenendo allo Stato e agli enti pubblici territoriali, sono destinati a
dare un reddito costituiscono il patrimonio disponibile.
disponibile Come tali, essi possono essere alienati
essendo assoggettati alle regole del diritto privato.
Sezione III
I BENI COMUNI
La dicotomia tradizionale beni privati/beni pubblici è stata messa in discussione, di recente,
dalle teorie dei beni comuni.
comuni Si tratterebbe di beni che non appartengono né a soggetti privati, né allo
Stato inteso come persona giuridica pubblica. Anzi, per i beni comuni non si pone un problema di
titolarità del diritto di proprietà vantato dagli stessi, quanto un problema di godimento di fatto dei
medesimi da parte della comunità, in vista del pieno esercizio dei diritti fondamentali.
La sintesi del dibattito e l’interazione tra diritti ed economia sono illustrate nel seguente saggio.
L. RAMPA, Q. CAMERLENGO, I beni comuni tra diritto ed economia: davvero un tertium genus ?, in
Politica del diritto, 2014, pp. 253 ss.
1.
Dalla «tragedia dei comuni» all’attuale dibattito: una breve introduzione
Negli anni Settanta un importante saggio di Paolo Grossi gettò un’inedita luce su di un tema, quale
quello dei beni comuni, sul quale era da tempo calato il silenzio. Nel libro si dimostra come le variegate forme
di possesso comune o collettivo delle risorse naturali fossero state da noi in gran parte abbandonate nel corso
dell’Ottocento a causa di una legislazione incline a generalizzare la proprietà privata. Nel corso della seconda
metà del Novecento si registra un seppur timido riavvicinamento al tema dei beni comuni, intesi come
meccanismi di gestione economico-sociale idonei ad abbinare economia ed ambiente, ragioni della produzione
e istanze di tutela dell’ecosistema.
Nel precedente decennio, però, già Hardin aveva evocato la suggestiva immagine della «tragedia dei
comuni» per descrivere il progressivo depauperamento delle risorse naturali imputabile ad un eccesso di
consumo individuale di beni universalmente accessibili. Trent’anni dopo, fu contrapposta una «tragedia degli
anticomuni», volta in questo caso a dimostrare il sottoconsumo ascrivibile all’azione di una pluralità di poteri di
ingerenza su questi beni.
Il tema dei beni comuni si muove nell’alveo tracciato dal costante confronto tra proprietà privata e
proprietà pubblica. Per un verso, se si pensa alla scuola di Chicago, si esaltano i vantaggi in termini di efficienza
dell’assegnazione di diritti ai privati, a scapito della tendenza dei pubblici poteri ad accumulare beni attraverso,
in particolare, lo strumento delle espropriazioni. Altrove, invece, si enfatizzano i fallimenti del mercato cui
porre rimedio con interventi regolativi e limitativi dell’esercizio di tali diritti, se non con vere e proprie forme
di proprietà pubblica, come nel caso dei monopoli naturali.
123
Tale dibattito ha tratto argomenti dai risultati delle ricerche del Premio Nobel Elinor Ostrom che, oltre
a chiarire concettualmente il significato economico dei comuni (inescludibilità dell’accesso ma rivalità nel
consumo), da lei ridefiniti common pool resources, ha anche messo in evidenza come la loro gestione
efficiente potesse avvenire sotto varie combinazioni di assegnazioni dei diritti di proprietà, e non
necessariamente solo mediante proprietà pubblica, né tantomeno mediante esclusivi diritti privati. Pertanto
non pare esservi alcuna ragione tecnica o economica per confondere beni comuni a libero accesso con
proprietà collettive che ne facciano uso comune ed esclusivo.
Il suo contributo da economista, come più in generale quello dell’institutional economics e dell’analisi
economica del diritto, possono gettare qualche luce sul dibattito chiarendo i limiti non solo di definizioni
troppo estese e generiche del genus beni comuni, ma anche di affrettate conclusioni circa i regimi proprietari
socialmente più appropriati degli stessi e circa i diritti fondamentali che sono chiamati a soddisfare.
In questa diatriba si inserisce l’analisi economica del diritto che, da un lato, dimostra la portata relativa e
contingente dei rimedi ai fallimenti del mercato (sicché, sostenere la natura necessariamente pubblica o
comune di determinati beni può avere senso solo in un determinato contesto sociale e giuridico), e, dall’altro,
revoca in dubbio la capacità delle pubbliche istituzioni di porre rimedio sempre e comunque ai predetti
fallimenti (si pensi alla leva fiscale, a possibili usi strumentali dei beni pubblici in nome di interessi particolari,
o anche ai fenomeni di rent seeking): «in questa più articolata impostazione, dunque, l’analisi economica del
diritto invita a comparare i benefici e i costi della proprietà pubblica e di quella privata: nella prima, la
negoziazione avviene nell’ambito del processo democratico interno alle istituzioni; nella seconda, la
negoziazione ha ad oggetto lo scambio di risorse sul mercato».
2. L’attenzione verso i beni comuni negli anni delle privatizzazioni
Il tema dei beni comuni è esploso contestualmente allo sviluppo crescente dei processi di
privatizzazione e di liberalizzazione che hanno investito principalmente (anche se non solo) le public utilities
gestite da imprese pubbliche nazionali o municipali e aventi, in molti casi, la natura di monopolio naturale.
Non a caso, nel nostro paese i referendum promossi in nome di essi riguardavano l’abrogazione della norma
che prevedeva l’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a soggetti scelti a
seguito di gara ad evidenza pubblica, consentendo la gestione in house solo ove ricorrano situazioni del tutto
eccezionali; nonché di quella che stabiliva la determinazione della tariffa per l’erogazione dell’acqua, nella
parte in cui prevede che tale importo includa anche la remunerazione del capitale investito dal gestore.
Le norme in oggetto, in effetti, avrebbero potuto determinare un esteso trasferimento della proprietà e
della gestione di beni, già oggetto di proprietà pubblica, in capo ad attori economici privati. Il caso
paradigmatico dell’acqua riassume in sé queste problematiche. Questo bene, infatti, viene distribuito mediante
reti che hanno la caratteristica di monopolio naturale e che ne hanno determinato l’assimilazione alle altre
public utilities sia nella letteratura economica che nei programmi governativi di liberalizzazione.
La possibile privatizzazione, allontanata dall’esito della consultazione referendaria sfociata
nell’abrogazione delle relative disposizioni legislative, ha investito infatti un bene ascrivibile, in quanto risorsa
naturale riproducibile e in natura accessibile a tutti, nel novero dei commons e, per di più, spesso affidato alla
gestione pubblica in quanto bene di consumo destinato al soddisfacimento dei bisogni essenziali delle persone.
Lucarelli, uno dei sostenitori più convinti della teoria dei beni comuni, immagina come alternativa
«politiche pubbliche locali in grado di interpretare, a tutela dei soggetti più deboli e indifesi, la trasformazione
dello Stato sociale, in un quadro di depauperamento e deterioramento delle risorse comuni, nel quale il
pubblico non gestisce più i beni di sua proprietà e i beni comuni sono sistematicamente messi sul mercato, a
vantaggio di pochi». In sostanza il rifiuto della politiche di liberalizzazione e privatizzazione viene motivato sia
in termini di finalizzazione alla tutela dei soggetti più deboli congiuntamente a quella della tutela, à la Ostrom,
del bene inteso come risorsa deteriorabile.
Il Manifesto di Mattei descrive chiaramente il nesso che, a suo giudizio, avvince il tema dei beni comuni
al processo di privatizzazione.
Secondo questa teoria, le privatizzazioni comportano una lesione, pro quota, del diritto vantato dai
singoli individui sui beni comuni oggetto del trasferimento di proprietà dal pubblico al privato. Analogo è il
processo inverso, quando lo Stato espropria un bene privato per devolverne la proprietà ad un ente pubblico.
Vi è, tuttavia, una grande differenza. Solo nel secondo caso la Costituzione, all’art. 42, terzo comma, configura
una serie di limiti e condizioni. Dunque, la proprietà privata è presidiata dalla riserva di legge, dalla previsione
di un indennizzo, dalla vocazione finalistica dell’espropriazione quale misura preordinata al soddisfacimento di
interessi generali. Nulla di tutto ciò, invece, assiste i beni comuni di fronte a decisioni di privatizzazione.
124
Nell’impianto teorico edificato da Mattei, lo Stato (al pari degli altri enti pubblici) non vanta alcun diritto
di proprietà sui beni comuni. In effetti, egli sostiene che «in un processo di privatizzazione il governo non
vende quanto è suo, ma quanto appartiene pro quota a ciascun componente della comunità». Qui appare
chiara l’assunzione di una sorta di titolarità collettiva, non limitata una particolare collettività ma estesa a tutta la
comunità dei cittadini, e anteriore alla proprietà statale giuridicamente stabilita. Ed aggiunge che «ogni processo
di privatizzazione deciso dall’autorità politica attraverso il governo pro tempore espropria ciascun cittadino (…)
della sua quota parte del bene comune espropriato, proprio come avviene nel caso dell’espropriazione di un
bene privato». Soccorre al riguardo la metafora del maggiordomo. Il governo, nelle privatizzazioni, si comporta
come quel maggiordomo che vende l’argenteria del suo datore di lavoro per colmare debiti personali. Anziché
servire lealmente il proprio dominus, il maggiordomo persegue interessi propri, correlati a pregressi
comportamenti erronei o azzardati, che lo hanno esposto al rischio di un impoverimento personale. Lo stesso
vale per un governo, che nella gestione dei beni comuni dovrebbe essere servitore del popolo sovrano: il
governo è chiamato a “servire bene” il popolo, alla stregua di un accorto amministratore fiduciario «e certo non
proprietario, libero di abusarne alienandoli e privatizzandoli indiscriminatamente». Invero – prosegue Mattei –
i beni comuni, una volta alienati, «non esistono più, e non sono riproducibili o facilmente recuperabili né per
la generazione presente che dovesse rendersi conto di aver scelto (a maggioranza) un maggiordomo scellerato,
né per quella futura, cui non si può neppure rimproverare la scelta del maggiordomo».
La tradizione liberale classica garantisce, dunque, solo la proprietà privata in caso di espropriazione, ma
non i beni comuni in caso di privatizzazione. Secondo questo approccio, il processo di privatizzazione dei beni
comuni non è che il modo attraverso il quale i governi, incapaci di gestire in maniera appropriata e accorta le
risorse acquisite principalmente tramite la leva fiscale, tentano di estinguere il copioso debito accumulato negli
anni.
In estrema sintesi, la tesi sostenuta nel Manifesto di Mattei è la seguente: la categoria dei beni comuni è
chiamata a svolgere una inedita funzione costituzionale, quale quella di «tutela del pubblico tanto nei confronti
tanto dello Stato quanto del potere privato».
La categoria dei beni comuni assurge dunque a concetto che rispecchia l’ideale di una appartenenza
collettiva dei beni indispensabili alla vita associata e, a ben vedere, alternativa sia alla proprietà privata che a
quella pubblica in senso classico.
Sicché, al di fuori di tale nozione non ci sarebbe spazio per dare ingresso e tutela alle istanze sociali e
collettive intrinsecamente legate ai beni di cui la collettività ha bisogno per poter concepire la stessa vita
associata.
L’esame del dibattito recente mette in evidenza come, tuttavia, le accezioni del termine beni comuni
possano essere molteplici rispetto allo scopo di redigerne un elenco significativo sia sotto il profilo
giuspubblicistico che sotto quello della politica economica e del diritto, il che richiede un’analisi più accurata al
fine di fondare una teoria utilizzabile sotto entrambi i profili.
3.
I beni comuni e il diritto positivo
Il diritto positivo non contempla tali beni. Nella giurisprudenza costituzionale, poi, sono ricavabili solo
alcuni cenni, evidentemente non sufficienti.
La categoria dei beni comuni non è affatto una novità. Di essa vi è già traccia nel diritto romano, a
cominciare dalle res communes omnium tratteggiate da Marciano nel terzo secolo d.C. Al riguardo, la mente
corre immediatamente alle res nullius, che però, a differenza dei beni comuni, sono suscettibili di
appropriazione individuale.
La dottrina internazionalista tende a considerare il mare libero o internazionale non come una res
nullius (in quanto bene non occupabile), bensì alla stregua di una res communis omnium, dal momento che
nessun soggetto può vantare uno ius excludendi alios. In relazione a tale risorsa comune vige il principio della
libertà dei mari in forza del quale tutti gli Stati hanno un eguale diritto a trarre da esso tutte le utilità che questo
può offrire. Nel contempo, però, gli Stati non possono utilizzare il mare internazionale sino al punto di
eliminare le chances di utilizzo da parte degli altri.
In epoca meno risalente si sono comunque affermate esperienze di condivisione di beni in qualche
misura associabili a quelli qui considerati. Al di fuori dei confini nazionali si pensi alle marche tedesche e ai
commons inglesi su cui il diritto consuetudinario riconosceva diritti di uso benché essi ricadessero
formalmente nella titolarità dal Sovrano. Nei contesti di common law la tutela giuridica delle res communes
derivanti dal diritto consuetudinario è stata ricondotta alla cosiddetta Public trust doctrine. Negli Stati Uniti
essa ha ispirato le sentenze di diverse Corti federali contro le pretese di privatizzazione di importanti risorse
125
pubbliche. In molti altri paesi, leggi e sentenze ne hanno adottato lo spirito a fondamento di norme di difesa
ambientale, estendendone l’applicazione se non, addirittura, riconducendola al diritto naturale, come nel caso
di sentenze delle corti supreme indiana e filippina. E già in questi casi il divario rispetto ai beni pubblici tende
ad affermarsi con sufficiente chiarezza. Così, in Inghilterra per common land non s’intende designare un bene
immobile di proprietà statale o pubblica, essendo in realtà di proprietà di privati o enti denominati partition
units.
Quanto all’Italia, si pensi alle partecipanze emiliane. Trattasi di un’antica forma di proprietà collettiva di
terreni interessati a bonifiche. Senza trascurare il maso chiuso quale istituto, diffuso nell’area alpina
germanofona ed in Trentino-Alto Adige, diretto a garantire l’indivisibilità della proprietà agricola. Vicino alla
morfologia del bene comune è pure l’uso civico, quale diritto di godimento su beni immobili, esercitabile in
varie forme e spettante ai membri di una collettività, su terreni di proprietà comunale o anche di terzi, non
derivante da un negozio giuridico in quanto radicato nella prassi collettiva.
Sul piano legislativo, si è pervenuti nel nostro Paese ad un tentativo di codificazione attraverso
l’istituzione di una apposita commissione. Più precisamente, la Commissione Rodotà, istituita con d.m. 21
giugno 2007 per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici, presentò nel febbraio
2008 una proposta di articolato, poi caduta nel nulla a causa della prematura interruzione della legislatura.
In questo testo, la categoria dei beni comuni include «le cose che esprimono utilità funzionali
all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona». In sostanza si potrebbe dire che il
rapporto tra beni comuni e diritti fondamentali ha la stessa natura di quello tra mezzi e fini. A questa
definizione generale si accompagnò una ricognizione dei beni comuni, sia pure non esaustiva: invero, secondo
tale proposta «sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l’aria; i
parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le
nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni
archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate».
4.
Beni comuni, beni pubblici, beni collettivi nel dibattito giuspubblicistico
Si registra una diffusa inclinazione a considerare i beni comuni un tertium genus rispetto ai beni privati e
a quelli pubblici. E se il divario rispetto ai beni privati è persino autoevidente, in quanto allude ad una netta
distinzione tra ciò che è proprio di un individuo (dimensione individualistica) e ciò che è proprio di una
comunità (dimensione comunitaristica), la comparazione con i beni pubblici si rivela alquanto problematica.
Un tempo la distinzione in oggetto poteva non avere senso. È stato osservato che «fin tanto che lo Stato
ha gestito i beni di sua proprietà, limitando il ricorso all’istituto della concessione per i beni demaniali
(gestione) e impedendo facili processi di sdemanializzazione (circolazione) non risultava di immediata necessità
distinguere i beni comuni dai beni pubblici». Oggi non è così.
Già a livello di prima approssimazione, si intuisce che i beni pubblici e quelli comuni condividono la
medesima aspirazione a soddisfare interessi che si proiettano oltre la mera sfera individuale per abbracciare
l’intera comunità di riferimento. Detto in breve, i beni comuni e quelli pubblici, diversamente dai beni privati,
afferiscono alla sfera del sociale, piuttosto che al campo dominato dai bisogni individuali. È stato
autorevolmente scritto che i beni pubblici sono funzionalmente diretti «alla immediata soddisfazione di bisogni
considerati d’importanza sociale».
Il contributo classificatorio di Massimo Severo Giannini rappresenta un irrinunciabile punto di partenza.
I beni pubblici possono essere distinti in beni pubblici in senso soggettivo, ove si sottolinei
l’appartenenza ad un pubblico potere, e beni pubblici in senso oggettivo, se rileva la loro differenza di regime
rispetto ai beni privati. Quasi scontato, a questo punto, appare il riferimento al demanio e ai beni patrimoniali
indisponibili e disponibili, di cui al codice civile.
Quanto, in particolare, ai beni pubblici in senso soggettivo, Giannini opera una ulteriore distinzione tra
beni a fruizione collettiva (il bene, pur appartenendo allo Stato è goduto da altri) e beni a fruizione
imprenditoriale (quando sono le imprese a goderne, e non la collettività).
I beni collettivi coincidono con i cd. demani o domini collettivi e, dunque, rientrano nella categoria
generale dei beni di uso civico. Essi sono utilizzati dai soli appartenenti ad una data comunità.
Infine, i beni comuni «costituiscono una forma moderna di proprietà collettiva, poiché di essi la
collettività ha l’effettivo godimento, mentre l’appartenenza al potere pubblico è in funzione di costituzione,
conservazione, disposizione delle utilità collettive, delle utilità collaterali e della gestione del bene». Beni
comuni sono, così, l’etere, l’acqua e l’aria, vale a dire «beni talmente importanti che, almeno sinora, non si è
mai posto un problema di appartenenza».
126
Giannini a questo punto individua le sostanziali differenze tra queste tre tipologie di beni non ascrivibili
alla proprietà privata. I beni pubblici consentono la fruizione del bene stesso a chiunque secondo il bisogno. I
beni collettivi sono destinati ad una platea circoscritta di consociati. Infine, per i beni comuni si prescinde dal
problema della titolarità, essendo decisivo l’ordine di fruizione del bene. Rispetto a questo problema, lo Stato
svolge un ruolo di ordine.
Napolitano osserva come la ricostruzione teorica di Giannini abbia individuato in nuce il nucleo del
ragionamento economico sui fallimenti del mercato: «il suo discorso sui beni che rendono servizi indivisibili
per natura o per scelta del legislatore o che, ancora, per la loro abbondanza naturale, consentono utilizzazioni
libere a chiunque, presenta un’interessante consonanza con la teoria dei “beni pubblici puri” perché non
escludibili e non rivali nel consumo». Sino a quel momento la scienza giuridica aveva omesso di considerare le
ragioni economiche sottese al regime pubblicistico di determinati beni. Anzi, il più delle volte i cultori del
diritto avevano abbracciato l’idea di «un’area di beni naturalmente e immancabilmente riservata alla mano
pubblica». L’influenza esercitata dagli studi economici ha, così, contribuito a fornire inedite basi alla
qualificazione dei beni pubblici in termini il più possibile oggettivi.
Nel Manifesto di Mattei si propugna l’elaborazione di una categoria giuridica dei beni comuni distinta
rispetto alla tradizionale dicotomia proprietà pubblica/proprietà privata. Detti beni sono destinati ad operare
«come strumenti politici e costituzionali di soddisfazione diretta dei bisogni e dei diritti fondamentali della
collettività». Prima degli interessi individuali vengono gli interessi di tutti, «concepiti come un ecosistema di
relazioni di reciproca dipendenza». Dunque, i beni comuni stanno in un rapporto di mezzi rispetto ai fini di
tali diritti, intesi però più come diritti di un’intera collettività che dei singoli.
È chiaro il divario rispetto allo spirito che anima la proposta della Commissione Rodotà. Invero, nella
relazione di accompagnamento si legge che i beni comuni «esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti
fondamentali nonché al libero sviluppo della persona, e sono informati al principio della salvaguardia
intergenerazionale delle utilità». Sicché, la natura dei beni comuni come mezzo viene vista in rapporto a diritti
fondamentali della persona, certamente sociale ma non indistintamente compresa in una collettività generale,
oltre che in funzione della garanzia di tali diritti alle persone future.
Ora, è stato perspicuamente osservato che «prendere in considerazione i beni pubblici dal punto di vista
delle loro utilizzazioni comporta l’apertura di un orizzonte difficilmente riconducibile a un ordine sistematico.
Non soltanto perché i singoli tipi di beni sono assai diversi, ma anche perché sono compositi gli interessi
incarnati nelle regole che presiedono alle loro utilizzazioni e soprattutto perché la dimensione dell’uso implica
un confronto con la realtà che non risulta mai convenientemente traducibile in astratte categorie». Dunque, se
è vero che la tassonomia concepita da Giannini in qualche misura risente di condizionamenti provenienti dagli
studi condotti in ambito extragiuridico, e se è altrettanto indiscutibile che la teoria dei beni comuni,
enfatizzando la dimensione fattuale rispetto a quella formale, tende ad affrancarsi dall’area di influenza delle
categorie giuridiche, a questo punto appare logico indugiare sull’analisi economica dei beni qui considerati.
5. Beni pubblici e beni comuni nel dibattito economico
Com’è noto la distinzione tra beni pubblici, comuni e privati è fondata in economia sulle caratteristiche
intrinseche o oggettive dei beni stessi e non sui titoli di proprietà. Essa è molto semplice e chiara in quanto si
basa sulle proprietà di escludibilità/inescludibilità e di rivalità/non rivalità dei beni. Secondo questa distinzione
un bene pubblico inescludibile e non rivale, un bene comune è invece inescludibile e rivale, mentre un bene
privato è escludibile e rivale.
Per chiarire le implicazioni di queste distinzioni, consideriamo anzitutto il caso in cui queste proprietà
non derivino da norme dell’ordinamento giuridico.
L’inescludibilità può essere dovuta a ragioni di ordine tecnico (ad esempio la fruizione del bene o
servizio della difesa, come quello dell’aria atmosferica, non può essere impedito a nessuno) o di ordine
economico (escludere qualcuno dal loro uso sarebbe troppo costoso in rapporto ai benefici che se ne
traggono) Se un bene possiede questa caratteristica non può dunque essere oggetto di diritti di proprietà e di
uso esclusivi, e pertanto di alienazione attraverso scambi sul mercato o contratti.
Un bene è poi rivale se, quando è goduto da qualcuno, è sottratto al consumo altrui. Tuttavia una
definizione più generale comporta che l’aggiunta di un nuovo fruitore, provoca una diminuzione marginale del
godimento altrui, ad esempio in termini di congestione. Per molti beni, come l’aria e il mare, ma anche le
strade pubbliche non congestionate e le reti informatiche, tale perdita marginale risulta trascurabile se non
nulla, sicché essi sarebbero da considerare non rivali, quindi pubblici piuttosto che comuni. Nel caso, invece,
127
di congestione temporanea la perdita marginale non è trascurabile e la nitidezza della distinzione in termini di
rivalità viene meno.
Ciò può valere anche in altri casi come quello della conoscenza. Se, infatti, la conoscenza in generale
può definirsi non rivale, una nuova e specifica conoscenza può essere divulgata e conosciuta senza rivalità, ma
il suo utilizzo a scopi produttivi o industriali può dar luogo a diritti esclusivi. Per queste ragioni (cogestione o
esclusione a scopi specifici) gli economisti hanno adottato un’ulteriore distinzione tra beni pubblici puri e non
puri.
Quanto all’assegnazione dei diritti di proprietà sui vari tipi di beni, essa viene valutata in funzione
dell’efficienza, secondo il principio che essi devono essere attribuiti ai soggetti che sono in grado di
maggiormente contribuire al benessere sociale. Ad esempio laddove si tratti di beni privati, trasferibili
mediante scambi volontari, contratti o negozi, si ritiene che l’ordinamento giuridico debba favorire
l’assegnazione a chi li valuta di più. Questo principio ha conseguenze piuttosto indeterminate nel caso che il
diritto di proprietà è concepito come fascio di diritti separabili (ad esempio accesso, uso, trasferimento,
gestione) piuttosto che come titolo unitario. Ma è essenziale, ai fini delle valutazione di efficienza sociale, che la
loro assegnazione sia ben definita.
La dottrina e la giurisprudenza (almeno in Italia) non si sono quasi mai valsi dei criteri economici,
preferendo distinzioni basate sui titoli di proprietà, ma li hanno riscoperti a proposito dei beni comuni grazie
anche ai contributi del premio Nobel Elinor Ostrom. Gli esempi classici (anche se spesso molto discussi) di
commons o di common pool resources, come foreste, spiagge, parchi, bacini idrici e fluviali, sono in sé
inescludibili per motivi tecnici o per il costo eccessivo dell’esclusione, ma rivali. Limitandoci, al momento, a
considerare solo le caratteristiche economiche o pre-giuridiche di tali beni, li definiremo natural commons. La
proprietà di inescludibilità risulta rilevante poiché essa comporta libero accesso, particolari tutele del bene,
particolari diritti e, in ogni caso, la fuoriuscita dalla sfera dei beni privati in senso stretto.
Meno chiaro è, nel dibattito in corso, il fondamento delle ragioni sottostanti alle particolari tutele e ai
particolari diritti.
Per un economista non vi sarebbero dubbi che un bene pubblico puro, quando si tratti di un bene
prodotto anziché di una res communis omnium, costituisca il fallimento del mercato più arduo da superare e
che, per questo motivo, si raccomandi la sua fornitura da parte di istituzioni pubbliche e (nella maggior parte
dei casi) un titolo di proprietà pubblica in capo ad esse. E da questa stessa ragione discende la sua
inalienabilità, la sua indisponibilità e la sua natura di bene senza mercato o di res extra commercium.
La ragione fondamentale sta nella circostanza che la non rivalità comporta un’esternalità positiva anche a
favore di chi non coopera nel fornirlo (il free rider o l’opportunista), determinando così un forte incentivo a
non contribuirvi, sicché non vi sarebbe alcuna possibilità di garantirne la produzione e il consumo a livello
socialmente efficiente sulla base della mera razionalità auto-interessata. Non a caso un modo molto frequente
in letteratura (e nelle aule universitarie) di spiegarlo è costituito dal celebre Dilemma del prigioniero.
Che dire ora di un bene comune? Il modo più semplice di chiarirne la differenza rispetto a un bene
pubblico puro sta nel cogliere la conseguenza della rivalità. Essa infatti riduce (se non elimina) l’esternalità
positiva a favore del free rider, diminuendone l’incentivo a non contribuire. Non che questo risolva del tutto il
problema dell’opportunismo, né la difficoltà della sua fornitura a livello socialmente efficiente; ma, certamente,
si può dire che in questo caso la rende meno ardua.
Il contributo di Elinor Ostrom consiste nel mostrare, sia con argomenti teorici che attraverso una estesa
analisi empirica, che, in questo caso, sono possibili molte soluzioni istituzionali, e combinazioni di diritti, che
consentono di utilizzare ad un livello socialmente efficiente il bene. Ciò contro il punto di vista dominante
secondo cui solamente i diritti di proprietà privata ne assicurerebbero un utilizzo più efficiente; e contro l’idea
prevalente che i residui casi di proprietà comune ancora oggi esistenti sarebbero destinati a scomparire, al pari
dei diritti comunitari inglesi anteriori alle enclosures, a causa della Tragedia dei comuni resa celebre da
Hardin.
Una common pool resource ha di norma la caratteristica di riproducibilità delle unità di risorsa che se
ne possono trarre per il consumo, ma sotto condizioni che ne evitino il sovra-utilizzo e il deterioramento
(come nel caso della fauna ittica o forestale) e quindi la conservazione per il futuro. Essa può essere di
proprietà pubblica, nazionale o locale, di gruppi o anche di collettività informali. Al riguardo Ostrom
documenta sia casi di successo che di insuccesso per ciascun tipo di regime proprietario, concludendo che non
vi è sempre una automatica associazione tra common pool resources e particolari tipi di esso.
Un aspetto fondamentale delle sue ricerche consiste nella specificazione della assegnazione del fascio di
diritti che caratterizza ogni singolo caso (accesso, ritiro di unità di risorsa, gestione, esclusione, alienazione), e
porta alla conclusione che le soluzioni, sia de facto che socialmente più efficienti, possono essere supportate da
128
combinazioni assai più complesse di quelle previste dalla semplice distinzione tra proprietà pubblica, privata o
collettiva (di gruppi) intese come diritti unitari. In particolare Ostrom ritiene che non vi siano ragioni teoriche
né empiriche a favore della superiorità della proprietà privata. Il suo messaggio sembra invece essere che agli
ordinamenti giuridici spetti il compito di disegnare regole di uso e di gestione della risorsa basate su
combinazioni ben definite di diritti capaci di garantirne nel tempo il libero accesso e la fruizione, evitandone il
degrado o l’esaurimento.
Tali combinazioni, tuttavia, potrebbero rivelarsi inefficienti laddove l’eccessivo frazionamento dei diritti
provochi conflitti di interesse o interferenze nell’esercizio degli stessi, generando per questa via un sotto-utilizzo
delle risorse rispetto al livello socialmente ottimo, ovvero una tragedia degli anti-commons per certi versi
opposta a quella dei commons.
Consideriamo ora il caso in cui le proprietà di escludibilià/non escludibilità e rivalità/non rivalità siano
definite dall’ordinamento giuridico. Ad esempio l’ordinamento può stabilire che un bene pubblico, ad
esempio una nuova conoscenza, perda almeno transitoriamente tali proprietà, ammettendo temporanei diritti
privati di uso a scopo economico al fine di favorirne lo sviluppo futuro. Poiché tali diritti creano un monopolio
temporaneo, con conseguente perdite nette di surplus, ma incentivano anche innovazioni e opere di ingegno
che generano un beneficio sociale, la loro efficienza dipende dal confronto tra questo beneficio supposto
permanente e la temporanea perdita da monopolio. Nel valutarne l’efficienza sociale è anche necessario
considerare particolari costi sociali che la rivalità tra innovatori può determinare, quali il sovra o sottoinvestimento in ricerca e sviluppo, nonché la dissipazione determinata da possibili fenomeni di rent seeking.
Se l’ordinamento giuridico li valuta socialmente efficienti e li istituisce, la conoscenza, o meglio quel
particolare tipo di conoscenza (ad esempio informatica o biotecnologica), da bene pubblico diventa un
common spesso definito, in questi casi, creative o knowledge common.
A sua volta l’inescludibilità dei beni, e la loro conseguente inalienabilità, viene talora prevista dagli
ordinamenti giuridici perché ritenuta socialmente meritevole di essere presa in considerazione, pur in assenza
di ragioni tecniche o di eccessivo costo economico dell’esclusione. Nell’economia pubblica molti di questi casi
sono stati ricondotti alla categoria dei beni di merito per i quali (si riteneva) lo Stato dovesse provvedere alla
fornitura onde evitarne la sotto-produzione o il sotto-consumo determinati dell’insufficiente disponibilità dei
privati a pagarli ai prezzi di mercato. Tipici esempi sono costituiti dall’istruzione, dalla sanità pubblica o dalla
previdenza cui, non a caso, sono associati non solo diritti ma anche obblighi di fruizione e di contribuzione. Il
giuspubblicista può riconoscervi facilmente l’oggetto dei diritti sociali.
Si noti che in questi casi non si tratta solo di beni o servizi singoli, ma spesso di una complessa attività
volta a fornire molteplici beni e servizi, sicché questi ultimi andrebbero distinti dall’attività stessa. Inoltre il
servizio pubblico universale garantito dall’ordinamento non implica necessariamente la fornitura di specifici
beni in natura, ad esempio tutti o particolari tipi di farmaco, bensì la garanzia della loro accessibilità attraverso
varie combinazioni di misure distributive, fiscali e tariffarie.
Giuristi e cultori dell’analisi economica del diritto hanno talora giustificato questi casi con ragioni distinte
dai classici casi di fallimento del mercato, riconducendoli invece a ragioni di ordine morale o di ordine
paternalistico. Tra le prime, ad esempio, Calabresi e Melamed, in un loro celebre saggio, indicano ragioni
connesse all’integrità della persona umana che renderebbero inalienabili le parti del corpo. Tuttavia la
discussione successiva ha messo in evidenza come, in ultima analisi, queste ragioni avessero a che fare esse
stesse con le cause dei fallimenti del mercato come le esternalità positive (nel caso dell’istruzione obbligatoria o
della sanità pubblica) o le asimmetrie informative (come nel caso della previdenza), o varie combinazioni di
esse.
Questa conclusione non risolve tuttavia in termini di soli fallimenti tutte quelle ragioni che hanno a che
fare con la natura di cittadino dei titolari dei diritti come, ad esempio, quelle distributive connesse alla loro
sopravvivenza, dignità ed eguaglianza. Un ordinamento giuridico, a partire dalla sua Costituzione, può
dopotutto essere pensato esso stesso come un bene pubblico di ordine superiore da cui nessun cittadino può
essere escluso. Da quali diritti e beni egli non possa essere escluso varia da ordinamento a ordinamento, ma in
ognuno di essi si può dire che esiste un insieme di diritti fondamentali che sono riconosciuti alla sua natura.
Inevitabilmente i caratteri giuridici di escludibilità/non escludibilità e di alienabilità/non alienabilità discendono
non solamente dalla natura intrinseca dei beni ma anche da questi diritti fondamentali, specialmente se
costituzionalizzati. Ciò non impedisce, naturalmente, che possano determinarsi contraddizioni tra criteri
economici e criteri giuridici di non esclusione, ma, laddove queste non si verifichino sembra, potersi creare un
proficuo confronto tra approccio economico e giuridico.
Riassumendo, l’analisi economica del diritto, non si pone il problema dei fini che lascia agli ordinamenti
giuridici definire mediante l’assegnazione dei diritti e della loro alienabilità o inalienabilità. Alla sfera dei fini
129
appartengono i diritti fondamentali di cui tutti sono titolari in quanto persone e su cui l’analisi economica del
diritto si è esercitata ma finora con molta indeterminatezza di conclusioni. Non pronunciandosi sui fini,
l’analisi economica del diritto riconosce pertanto che possano esistere ragioni non solo tecniche, o di eccessivo
costo dell’esclusione, a fondamento dell’inescludibilità e, in particolare, ragioni aventi a che fare con lo status
di cittadino in uno stato democratico.
Essa si pone invece il problema dei mezzi e della loro efficienza. Sotto questo profilo riconosce che
siano socialmente efficienti non solo varie forme di limitazione dei diritti di proprietà privati, ma anche varie
forme di proprietà collettiva, oltre che pubblica (inevitabile nel caso dei beni pubblici puri), anche se non
mancano punti di vista estremi che lo negano.
Quanto ai beni comuni sembra indubbio che vi siano argomenti economici largamente condivisi circa
l’esistenza del tertium genus e sulla fondatezza della loro sottrazione dalla sfera dei beni privati. Ciò tuttavia
non toglie che il dibattito recente abbia talora portato a conclusioni ideologiche e a cataloghi di beni comuni
basati su criteri di distinzione poco chiari, sia sotto il profilo delle caratteristiche economiche dei beni che del
fondamento dei diritti. Ma, una volta riconosciuto che poteri di fruizione e diritti fondamentali delle persone
cui essi sono assegnati sono interconnessi, sembra possibile ricostruire un quadro analitico più chiaro utile sia
agli economisti che ai giuristi.
6.
Beni comuni e diritti fondamentali
Le sollecitazioni provenienti dall’analisi economica inducono a polarizzare l’attenzione sul tema centrale
dei beni qui considerati: i beni comuni quali strumenti per consentire l’effettivo esercizio dei diritti
fondamentali.
L’approccio economico tentato in questa sede concorda con l’intima connessione funzionale tra alcuni
beni e l’effettivo esercizio dei diritti fondamentali. Non è detto, però, che tali beni siano soltanto i beni comuni,
a meno di una indebita estensione di questo concetto. Più precisamente, non è scontato che l’effettivo esercizio
dei suddetti diritti sia garantito dal tertium genus rappresentato dai soli beni comuni.
Il dubbio, peraltro, sorge anche leggendo una recente e importante pronuncia delle Sezioni unite della
Corte di cassazione. Secondo la Suprema Corte, dalla Costituzione si ricava il principio della tutela della
personalità umana e del suo corretto svolgimento, nell’ambito dello Stato sociale, non solo in relazione ai beni
pubblici, «ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte
del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione, risultino, sulla base di una compiuta interpretazione
dell’intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività
e che – per tale loro destinazione alla realizzazione dello Stato sociale – devono ritenersi “comuni”
prescindendo dal titolo di proprietà, risultando così recessivo l’aspetto demaniale a fronte di quello della
funzionalità del bene rispetto ad interessi della collettività». La Suprema Corte, dunque, allude a beni che, pur
essendo qualificabili come beni comuni, sono preordinati alla realizzazione degli interessi generali.
Esattamente come i beni pubblici in senso economico. Riguardo ai beni cd. comuni, il giudice di legittimità
osserva che questa qualificazione come bene comune «comporta per l’ente titolare anche la sussistenza di oneri
di governance finalizzati a rendere effettive le varie forme di godimento e di uso pubblico del bene». Detto in
altri termini: nel genus dei beni pubblici, come individuati dal diritto positivo, vi è una species di beni (i beni
comuni) che richiedono formule organizzative e meccanismi operativi per molti versi inediti rispetto ai modelli
tradizionali, in vista di una piena ed effettiva fruizione da parte della comunità degli utenti.
Procedendo con ordine, il nesso che avvince sul piano funzionale i beni in parola ai diritti fondamentali
(sul piano del loro concreto godimento), è ben espresso da Stefano Rodotà.
L’idea di persona «costituzionalizzata» irrompe in un ambito in cui la «ragionevole follia dei beni
comuni» aveva sollecitato l’abbandono del tradizionale dualismo pubblico/privato e l’emancipazione della
logica proprietaria a favore di inediti assetti. La consacrazione della proiezione costituzionale della persona
comporta «l’integrale recupero di quei diritti fondamentali che, a loro volta, individuano i beni funzionalmente
legati a quei diritti e alla loro soddisfazione, senza che sia necessario passare attraverso il modello proprietario
privatistico. Dunque, in primo luogo, i beni comuni».
La nozione di bene comune utilizzata nel dibattito intercetta questo mutamento e lo traduce in una
nuova concezione che illumina la concretezza dei bisogni, collegando i diritti fondamentali ai beni
indispensabili per la loro soddisfazione mediante l’accesso (la non esclusione). Sicché «diritti fondamentali,
accesso, beni comuni disegnano una trama che ridefinisce il rapporto tra il mondo delle persone e il mondo
dei beni». L’accesso, da modalità meramente strumentale «si è progressivamente reso autonomo, individuando
una modalità dell’agire da riconoscere come un diritto necessario per definire la posizione della persona nel
130
contesto in cui vive. L’accesso, inteso come diritto fondamentale della persona, si configura come tramite
necessario tra diritti e beni, sottratto all’ipoteca proprietaria». Coniugando questa innovativa concezione
dell’accesso e l’idea di una costituzionalizzazione della persona, Rodotà perviene ad identificare i beni comuni
come «quelli essenziali per la sopravvivenza (l’acqua, il cibo) e per garantire eguaglianza e libero sviluppo della
personalità (la conoscenza)». In questa visione, dunque, diventano comuni i beni il cui accesso è garantito
secondo i fini, finendo per includere beni che sono tali per ragioni oggettive (i beni pubblici in senso
economico) o per ragioni funzionali rispetto ai fini stessi. Trattasi, in sostanza, di beni funzionali al
soddisfacimento di diritti fondamentali. Così, in questa visione, è proprio il riconoscimento di un diritto
fondamentale a produrre un common. Si è, dunque, di fronte non già ad una «semplice associazione tra diritti
fondamentali e beni comuni, bensì alla produzione di beni comuni attraverso i diritti fondamentali». Sicché,
«l’intreccio tra beni comuni e diritti fondamentali produce un concreto arricchimento della sfera dei poteri
personali, che a loro volta realizzano precondizioni necessarie per l’effettiva partecipazione al processo
democratico».
In sintesi, secondo Rodotà i beni comuni sono a titolarità diffusa, ossia appartengono a tutti e a nessuno
e dunque nessuno può vantare pretese esclusive, trattandosi di beni accessibili a tutti; devono essere gestiti
partendo dal principio di solidarietà; incorporando la dimensione dell’avvenire, devono essere gestiti anche
nell’interesse delle generazioni future.
Nel costituzionalismo liberale, ciò che rileva è il riconoscimento, in misura eguale per tutti (eguaglianza
formale), della astratta titolarità dei diritti fondamentali. Nello stato liberale di diritto le pubbliche istituzioni
s’impegnano a garantire tale condizione, senza ingerirsi nelle relazioni sociali ed economiche: difesa dei confini
nazionali, ordine pubblico, giustizia, moneta.
Con l’avvento del pensiero di matrice socialdemocratica si persegue l’obiettivo, a fonte delle gravi
disparità di fatto che attraversano la società, di promuovere l’effettivo esercizio dei diritti fondamentali, non
essendo più sufficiente, in una società che aspira ad essere più giusta ed equa, la mera titolarità degli stessi. Lo
stato sociale sollecita l’intervento positivo delle pubbliche istituzioni nei rapporti sociali ed economici. Il
principio di eguaglianza sostanziale, di cui all’art. 3, secondo comma, Cost., è unanimemente interpretato
come strumento per garantire l’effettivo godimento dei diritti fondamentali.
I mezzi per attuare tale progetto di riforma della società sono i diritti sociali, quali pretese giuridiche
soggettive a che lo Stato intervenga per assicurare ai consociati beni e prestazioni rispetto ai quali si è registrato
il fallimento del mercato.
Se, dunque, può considerarsi pacifico che la nostra legge fondamentale esige la creazione delle
condizioni per rendere effettivo l’esercizio dei diritti fondamentali, non altrettanto può dirsi circa
l’individuazione dei diritti qualificabili come fondamentali.
Se si considera la Costituzione come l’atto volto a presidiare i diritti soggettivi nei confronti dei pubblici
poteri, secondo l’intuizione liberale, allora sono fondamentali proprio le posizioni giuridiche soggettive protette
non solo nei rapporti tra privati, ma anche – e ancor prima – nelle relazioni con l’autorità. In questo modo, si
accede anche ad un’altra concezione, quale quella dei diritti inviolabili, che ulteriormente rafforza il potenziale
garantista di tali situazioni soggettive. Senonché, l’avvento dello Stato sociale e con esso di nuove posizioni
giuridiche individuali ad esso congeniali (i diritti sociali), ha indotto non pochi a rivedere l’attributo stesso della
inviolabilità, al fine di estenderlo oltre il suo originario ambito di applicazione.
Se il tema che qui rileva riguarda i beni comuni, e la loro presunta qualificazione come tertium genus,
allora i Principia Iuris di Ferrajoli potrebbero fornire utili elementi di riflessione, atteso che in questo edificio
teorico si coglie una evidente correlazione tra diritti fondamentali e beni (e non soltanto quelli comuni).
I diritti fondamentali sono diritti soggettivi di cui tutti sono titolari in quanto persone naturali o in quanto
cittadini o ancora, se si tratta di diritti potestativi, in quanto capaci di agire o cittadini capaci di agire.
L’universalità è il tratto caratteristico dei diritti in parola, in condizioni di eguaglianza formale: eguaglianza che
può essere assoluta (se si fa riferimento alle persone naturali) o relativa (se si fa riferimento ai cittadini e/o ai
capaci di agire). Il carattere universale dei diritti fondamentali comporta il carattere inalienabile e indisponibile
degli interessi ad essi sottesi. Nell’esperienza storica del costituzionalismo, tali interessi coincidono «con le
libertà e con gli altri bisogni fondamentali dalla cui garanzia dipendono la vita, la sopravvivenza, l’uguaglianza e
la dignità degli esseri umani».
Si noti che per l’A. l’eventuale rango costituzionale dei diritti fondamentali è irrilevante ai fini di una
simile qualificazione, essendo la previsione nella legge fondamentale solo una tecnica di protezione. Come a
dire: i diritti fondamentali sono tali anche se non previsti dalla Costituzione. Se lo sono, la loro garanzia diviene
più forte. Invero, con la costituzionalizzazione, i relativi interessi e bisogni diventano limiti e vincoli alle libertà
altrui e ai poteri pubblici.
131
Diversamente dai diritti fondamentali, i diritti patrimoniali, avendo per oggetto beni o prestazioni
concretamente determinati, sono singolari e disponibili. Diversamente dai primi, i diritti patrimoniali
determinano una diseguaglianza giuridica. I diritti fondamentali non sono mai diritti patrimoniali. Questi ultimi
non sono mai fondamentali. I diritti fondamentali sono inclusivi, i diritti patrimoniali sono esclusivi. I diritti
patrimoniali, in quanto disponibili, sono alienabili, negoziabili, transigibili. Diversamente, i diritti fondamentali
sono sottratti alle logiche di mercato (in particolare, non sono espropriabili). Ancora, i diritti fondamentali
riposano su norme giuridiche, laddove i diritti patrimoniali si basano su atti giuridici (ad es. contratti). Infine, i
diritti fondamentali dànno vita a rapporti pubblicistici (dimensione verticale), mentre quelli patrimoniali
generano rapporti privatistici (dimensione orizzontale).
Quanto, poi, ai beni, sono fondamentali i beni oggetto dei diritti fondamentali, mentre sono patrimoniali
i beni oggetto dei diritti patrimoniali.
Atteso che, secondo Ferrajoli, i diritti fondamentali primari sono “libertà da”; “libertà di”; diritti sociali,
allora: le “libertà da” hanno ad oggetto i beni personalissimi; i diritti sociali hanno ad oggetto i beni sociali; le
“libertà di” hanno ad oggetto i beni comuni, questi ultimi in quanto oggetto di «libertà-facoltà consistenti nel
diritto di tutti di accedere al loro uso e godimento».
I beni personalissimi e i beni comuni sono oggetto di diritti individuali negativi consistenti in aspettative
negative cui corrispondono i divieti erga omnes di lesione. I beni sociali sono oggetto di diritti positivi, vale a
dire di aspettative positive cui corrispondono obblighi erga omnes di prestazione. Pertanto, i beni sociali in
tanto sono oggetto di diritti sociali in quanto non appartengono e non sono accessibili naturalmente a quanti ne
fanno uso. Essi diventano beni fondamentali grazie alle norme che contemplano i diritti sociali come diritti
fondamentali primari. Si noti qui come i beni sociali costituiscano una categoria molto prossima a quella dei
beni meritori, non a caso elaborata dall’economia e dalla finanza pubblica in epoche in cui gli ordinamenti
giuridici avevano già recepito il loro riconoscimento.
Dal canto loro, i beni personalissimi e i beni comuni sono beni naturali, la cui garanzia risiede nella loro
indisponibilità. Quest’ultima è però diversa nei due casi: nel caso dei primi, il corpo umano è tutt’uno con la
persona; invece, i beni comuni sono patrimonio comune dell’umanità, ossia oggetto di una «situazione
collettiva composta dai diritti di uso e di godimento ascritti a tutti gli esseri umani in quanto componenti del
genere umano». Come a dire: i beni personalissimi appartengono ai loro titolari e a nessun altro; i beni comuni
appartengono a tutti, nessuno escluso.
Inoltre, secondo Ferrajoli i beni personalissimi e quelli comuni consistono in cose, ossia in entità
materiali per loro natura accessibili e utilizzabili. Per questo motivo, la loro protezione, in quanto necessaria
alla tutela dei diritti fondamentali di cui sono oggetto, può aver luogo soltanto attraverso il divieto della loro
disposizione.
Ad ogni modo, l’A. nota che «la qualificazione di un bene come fondamentale è un fatto storico e
culturale, prima che giuridico, e non ha nulla di ontologico». Così, lo sviluppo delle tecnologie ha determinato
l’alterazione dell’ecosistema rendendo fondamentali per la sopravvivenza del genere umano beni che in
precedenza erano considerate mere cose: l’acqua, l’aria, gli equilibri ambientali, ossia beni che oggi richiedono
di essere garantiti a tutti come beni comuni tramite limiti alle attività private e vincoli alla sfera pubblica.
Quanto, in particolare, ai beni comuni, essi conseguono alla natura di diritti universali – quali diritti
umani – dei diritti di accesso e di uso di cui sono oggetto. Si tratta, invero, «di una sorta di proprietà comune
spettante a tutti e a ciascuno, ben diversa dai diritti patrimoniali ed esclusivi di proprietà privata o pubblica,
anche se non sempre accompagnata da un’analoga consapevolezza dei loro titolari».
7. Qualche opportuna restrizione al genus
Mentre il dibattito sui beni comuni ha fatto emergere un’ampia (anche se non generale) condivisione su
di essi come tertium genus, non altrettanto estesa sembra essere la condivisione circa i beni che
apparterrebbero al genus stesso. La già evidenziata tendenza ad identificare sotto questa specie cataloghi troppo
ampi, se non generici, rischia di depotenziare il concetto, rendendolo inutilizzabile dal punto di vista giuridico
e delle politiche volte al soddisfacimento dei diritti e dei bisogni.
Se, da un lato, si conviene che si tratti di beni caratterizzati dalla proprietà oggettiva di inescludibilità,
accompagnata dalla caratteristica funzionale del soddisfacimento dei diritti fondamentali, dall’altro sembra
opportuno circoscriverne l’estensione in termini di queste caratteristiche non soggettive.
Se si guarda all’aspetto oggettivo, taluni beni citati come comuni quali aria o mare, se non ambiente o
eco-sistema, soprattutto se considerati come res unitarie e generiche, sembrano più simili ai beni pubblici puri
(in quanto in sé non rivali) ed è discutibile assimilarli ai comuni per il solo fatto di soddisfare diritti
132
fondamentali e bisogni primari. Dotata di caratteristiche di non escludibilità e non rivalità sembra essere la
conoscenza in generale. La rete internet, fino a quando non è satura e quindi non emergono situazioni di
rivalità, è essa stessa un bene pubblico puro. Naturalmente un ordinamento giuridico potrebbe anche
permettersi di assimilarli, ma allora perché non includere anche strade pubbliche, fari o infrastrutture per la
difesa e la giustizia? Il livello di garanzia dell’accesso, in questi casi, non viene alterato dall’appartenenza all’una
o all’altra categoria.
Se si guarda invece alla caratteristica funzionale sembra opportuno distinguere i beni comuni da quei
beni e servizi cui corrispondono pretese di prestazioni in nome di diritti sociali. Mentre i primi sono oggetto di
diritti consistenti in aspettative negative cui corrispondono i divieti erga omnes di lesione, i secondi sono
oggetto di diritti positivi, vale a dire di aspettative positive cui corrispondono obblighi erga omnes di
prestazione. La prestazione, poi, può consistere in combinazioni di beni e servizi forniti in natura (si pensi alla
sanità pubblica o all’istruzione obbligatoria), ma anche in trasferimenti o sussidi che ne garantiscono l’accesso.
Se alcuni di questi sono forniti in kind, come i beni meritori degli economisti (e, volendo, i beni sociali à la
Ferrajoli), lo sono perché la loro fornitura diretta risulta più efficiente del ricorso ad altri strumenti
redistributivi come i sussidi per il loro acquisto sul mercato. Inoltre essi non sono nemmeno inescludibili in
senso tecnico. In questo caso, l’assimilazione ai beni comuni rischia di confondere il servizio in sé con i beni di
cui esso è costituito, come i libri e le medicine, la cui acquisizione è lasciata alla libera scelta, seppure sotto il
controllo pubblico e a prezzi sussidiati. D’altro canto non si vede come la loro riconduzione alla specie dei
beni comuni possa renderne più efficiente l’accesso e la garanzia del relativo diritto.
La più importante restrizione del genus sembra essere quella che lo riconduce, come ha ben chiarito
Ostrom, a risorse comuni soggette, per la loro potenziale rivalità, al rischio di sovra-utilizzo e depauperamento
rispetto al godimento delle future generazioni. Vi rientrano ovviamente molte risorse naturali (il lido del mare,
la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi, le foreste), ma anche beni comuni non naturali, culturali e
artistici o cultural commons (ad esempio musei, archivi, biblioteche, siti archeologici.), che con esse
condividono quelle caratteristiche, e che l’ordinamento italiano classifica come beni demaniali o come
patrimonio indisponibile dello Stato. Se la conoscenza in generale è bene pubblico, conoscenze specifiche
possono essere classificate come intellectual commons laddove presentino caratteristiche di rivalità che ne
possano limitare lo sfruttamento a livello socialmente ottimale.
Al riguardo soccorre una precisazione. In effetti, lo slittamento dai beni corporali naturali (lidi, foreste) a
beni non naturali (musei ecc.) è potenzialmente pericoloso, dal punto di vista teorico e poi pratico. Ciò
significa che un museo privato è un bene comune? Oppure che un’opera d’arte di un pittore sconosciuto, poi
divenuto celebre, diviene bene comune ? Senza trascurare i problemi associati alla distinzione tra i beni
corporali e il corrispondente servizio (si pensi al personale del museo). Ebbene, è possibile superare questa
obiezione riconoscendo che le opere d’arte rientrano nel tertium genus se già appartenenti a un ente pubblico.
In effetti l’art. 822 c.c. li inserisce nel demanio, ma poi l’art. 839 ammette che «cose di proprietà privata,
immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, sono sottoposte alle
disposizioni delle leggi speciali». Su queste non c’è diritto di proprietà in capo allo Stato ma la solo
sottoposizione a vincoli di tutela e valorizzazione.
In secondo luogo sembra opportuno evitare l’ambiguità derivante dalla confusione tra il diritto di
accesso al bene e il regime proprietario e di gestione. Sotto questo profilo, se è condivisibile che si debba
abbandonare la tradizionale distinzione “soggettiva” tra beni pubblici e privati, non appare fondata la
conclusione che il tertium genus debba essere definito tale associandolo (solamente) ad un sorta di regime
proprietario o di gestione alternativo, né pubblico né privato ma collettivo. Anche qui Ostrom docet quando
mostra come vi siano molteplici soluzioni efficienti basate su varie combinazioni di diritti di proprietà intesi
come fascio piuttosto che come diritto unitario. Naturalmente evitando di creare tragedie di anti-commons
attraverso assegnazioni di diritti eccessivamente frazionate e potenzialmente conflittuali.
Riferendoci ora al caso emblematico dell’acqua intesa come res indistinta, il suo inserimento nel genus è
problematico (al pari dell’aria) e privo di conseguenze operative, potendo essa essere intesa come risorsa
naturale, come infrastruttura per la sua raccolta e distribuzione, come bene finale di consumo, o anche come
un insieme di tutte queste cose. Non vi è dubbio, tuttavia, che l’inserimento dell’acqua intesa come risorsa
naturale nel senso di laghi, fiumi e bacini idrici sia coerente con le caratteristiche economiche e funzionali dello
stesso. La natura di common della risorsa, intesa in tal senso, non è dunque in discussione, mentre le
infrastrutture per la raccolta e la distribuzione sono monopoli naturali. Separarli concettualmente e
operativamente è opportuno, a condizione tuttavia di evitare l’anti-common, tanto più che al pubblico compete
anche il controllo ambientale e di qualità. In tal senso si è pronunciata la Corte costituzionale nella sentenza n.
259 del 1996 quando, soffermando l’attenzione «sull’acqua (bene primario della vita dell’uomo), configurata
133
quale “risorsa” da salvaguardare, sui rischi da inquinamento, sugli sprechi e sulla tutela dell’ambiente, in un
quadro complessivo caratterizzato dalla natura di diritto fondamentale a mantenere integro il patrimonio
ambientale» ha affermato «che la “pubblicità delle acque” ha riguardo al regime dell’uso di un bene divenuto
limitato, come risorsa comune, mentre il regime (pubblico o privato) della proprietà del suolo in cui esso è
contenuto diviene indifferente in questa sede di controllo di costituzionalità».
Anche con riferimento all’acqua destinata al consumo finale, res ancora diversa, bisogna distinguere il
servizio di fornitura del bene dalle reti di distribuzione. In particolare va evitato con attenzione il
fraintendimento che porta a confondere la proprietà di tali reti con il diritto di gestione del servizio che rende
fruibile il bene. Mentre per evitare l’anti-common pare opportuno ritenere le reti sotto la proprietà pubblica,
non si vede l’utilità di particolari obblighi o divieti circa la natura societaria (privata, pubblica, cooperativa o
mista) delle imprese chiamate a competere per le concessioni. Sotto questo profilo, posto che esse sappiano
garantire tariffe più basse congiuntamente alla migliore conservazione e sviluppo della rete stessa, appaiono
immotivate sia la norma abrogata, che ammetteva solo società private o miste, sia l’assunzione implicitamente
adottata dai promotori del referendum circa la superiorità della natura pubblica del gestore.
Per le stesse ragioni dell’acqua, una res indistinta come la conoscenza può consentire di individuare casi
specifici di conoscenze, come taluni intellectual commons, che meritano diritti di proprietà non privata. Quello
del genoma umano è particolarmente interessante, in quanto una sequenza potrebbe congiuntamente
possedere caratteristiche di inescludibilità al fine della ricerca e rivalità qualora brevettabile per scopi di
produzione farmaceutica, poiché in tal caso potrebbe essere mantenuta segreta per essere sfruttata a scopi
commerciali. Al riguardo la Dichiarazione Universale sul Genoma Umano ed i Diritti dell’uomo, all’art. 4,
stabilisce che «il genoma umano al suo stato naturale non può dar luogo a profitto», e preclude soltanto le
condotte di sfruttamento economico di parti del genoma allo stato naturale, vale a dire parti prelevate da un
organismo vivente e opportunamente isolate, ma non impedisce che le stesse condotte vengano realizzate su
copie artificialmente prodotte del genoma o di parti di esso.
L’inalienabilità dei diritti sul genoma umano, in quanto parte del corpo, potrebbe essere giustificata nei
termini dei beni personalissimi à la Ferrajoli, o anche dell’inalienabilty à la Calabresi-Melamed. Tuttavia essa
ha anche a che fare, più in generale, con gli intellectual commons.
Due Premi Nobel, Stiglitz (per l’economia) e Sulston (per la medicina), hanno sostenuto, come molti
accademici, i danni sociali della brevettabilità delle sequenze genetiche. Inoltre è stata sottolineata l’analogia del
caso del genoma con quello di innovazioni nel campo del software, il cui contenuto di “conoscenza” può
essere raccolto in banche dati o memorie elettroniche riservate oppure pubbliche. Elinor Ostrom, che si è
molto spesa per sostenere il riconoscimento dei microbiological commons, applicherebbe anche in questo
caso la sua proposta di combinazioni efficienti di diritti volti comunque a garantire l’accesso a tutti.
Riconosciuta la non brevettabilità delle sequenze naturali, diritti meno esclusivi in capo a comunità scientifiche
istituzionalmente ben definite, se non di copyleft, potrebbero ridurre o eliminare le conseguenze
monopolistiche delle esclusive stesse e garantire l’accesso alle sequenze artificiali ai fini di una più estesa e
rapida diffusione della conoscenza.
8.
Alcune opportune precisazioni su beni comuni, proprietà privata, proprietà collettiva
La teoria dei beni comuni, da Mattei a Rodotà, accede ad una accezione di proprietà collettiva che mira
a definire una netta linea di demarcazione rispetto alla proprietà pubblica. L’intento è chiaro: solo dimostrando
che i beni comuni non sono oggetto di proprietà pubblica è possibile sottrarli al potere dispositivo dello Stato,
esercitato in occasione delle privatizzazioni.
Il concetto di proprietà allude alla “appartenenza” di un determinato bene. La prospettiva giuridica
insegna che se un bene appartiene ad un soggetto, questi è proprietario del bene. Così ragionando, la proprietà
collettiva immaginata dai teorici dei beni comuni più volte citati rischia di imbattersi in una obiezione non
trascurabile. Un soggetto giuridico è tale in quanto titolare di diritti soggettivi ed obblighi corrispondenti. Il
diritto positivo italiano contempla due tipologie di soggetti giuridici: le persone fisiche e le persone giuridiche.
La capacità giuridica e la capacità di agire sono previste e regolate in funzione della loro attribuzione a tali
tipologie di persone. Dal canto suo, la “collettività” è un insieme indistinto di persone fisiche e giuridiche
accomunate dal fatto di dimorare, in un dato momento, all’interno di un certo territorio (più o meno esteso) e
ivi di svolgere i rispettivi affari. La “collettività”, dunque, ha un assetto variabile, perché essa può includere
anche persone fisiche e giuridiche che siano stanziate ed operanti in quel territorio soltanto per un lasso di
tempo limitato. La collettività quale insieme indistinto e variabile di persone fisiche e giuridiche è essa stessa
una persona giuridica ?
134
La distinzione tra Stato-apparato e Stato-comunità potrebbe rivelarsi pertinente ai fini qui considerati. Lo
Stato-apparato, «in quanto titolare di situazioni attive e passive nei confronti dei cittadini e degli altri soggetti,
pubblici e privati, è persona giuridica». Al contrario, lo Stato-comunità, quale insieme dei governati, difetta «dei
necessari presupposti di organizzazione unitaria implicati nel termine Stato».
Se, dunque, la “collettività”, così intesa, non può considerarsi una persona giuridica (e, dunque, un
soggetto giuridico), allora essa può intendersi come un tertium genus rispetto alle persone fisiche e alle persone
giuridiche ? Ebbene, l’approccio economico può contribuire a dissipare i dubbi che si addensano su questo
crinale.
L’approccio ai property rights rappresenta una estensione, in linea con le tesi dell’analisi economica del
diritto (e di Ostrom), in merito alla distinzione piuttosto ristretta tra disponibilità e facoltà di godimento del
nostro codice civile. Come sopra evidenziato, secondo tale approccio un ordinamento giuridico riconosce sulle
cose un ampio fascio di diritti, tra loro separabili, distinti in diritti di disposizione (ovvero di trasferimento e di
alienazione), diritti di godimento (ovvero di accesso, di uso, di ritiro) e diritti di gestione. Essi sono sottoposti a
limiti volti ad assicurare la massima efficienza collettiva (la funzione sociale). Tali limiti, spesso previsti
esplicitamente a livello costituzionale, costituiscono il titolo per gli interventi regolatori dello Stato.
La caratteristica di inescludibilità dei beni comuni implica che sia collettivo il diritto di godimento,
almeno nel senso di accesso, uso e ritiro, e in ogni caso nei limiti previsti dalle regolamentazioni. Queste
regolamentazioni, finalizzate alla loro tutela e valorizzazione, sono rese necessarie dalla natura dei commons,
che li espone (a causa della rivalità) al rischio di depauperamento.
Diversa è la questione dei diritti di disposizione. Questi in linea di principio possono essere in capo a
soggetti di natura diversa, ovvero pubblica, collettiva e privata, ma pur sempre a condizione che siano garantiti
l’accesso e la fruizione collettiva e sia evitato il depauperamento. In altri termini, il diritto di disposizione è più
o meno efficiente a seconda che l’alienabilità comporti più o meno rischi di esclusione dal godimento e di
depauperamento.
Anche il diritto di gestione può, a sua volta, essere separato dal godimento e dalla disposizione.
L’efficienza sociale di tale separazione e della sua assegnazione dipende tuttavia da quanto essa rende più facile
e meno costosi l’accesso e il godimento, come più sopra si è visto a proposito della distribuzione dell’acqua.
Tornando ora al diritto di disposizione, l’inalienabilità e l’inappropriabilità, implicite nelle res
communes omnium (che tuttavia sono piuttosto classificabili come beni pubblici puri in quanto non rivali),
appaiono applicabili anche a molti commons naturali, quali laghi, fiumi, torrenti, foreste, spiagge, lidi, che le
distinzioni meramente formali del nostro codice civile collocano alternativamente tra il demanio e il
patrimonio statale indisponibile. Mentre nel caso della fauna ittica o forestale l’appropriazione, qualora
ammessa, sembrerebbe quanto meno da assoggettare ai limiti delle regolamentazioni volte alla loro
conservazione.
L’estensione dell’inalienabilità ai cultural commons sembra giustificata invece al caso in cui questi siano
già di pubblica proprietà.
Ora, se dalla proprietà pubblica è escluso il diritto di disposizione si potrebbe sostenere che la proprietà
non sia “pienamente” in capo Stato o agli enti pubblici territoriali (come è invece nel caso di beni del
patrimonio disponibile o di beni mobili o immobili destinati a pubblici servizi).
Tuttavia ciò non sembra sufficiente a immaginare che la proprietà sia in capo ad una collettività
indistinta. Intanto perché i titoli di proprietà, per essere efficienti, devono essere ben specificati
dall’ordinamento quanto al detentore cui sono assegnati. In secondo luogo perché le collettività possono essere
molteplici e possono avere un assetto oltremodo variabile. Si pensi ai nostri usi civici oppure al caso di
collettività circoscritte di un ben definito territorio, in cui, secondo Ostrom, diritti di godimento più ristretti
sarebbero spesso più efficienti, purché le collettività in questione siano ben definite e tali diritti siano ben
regolati a fini di conservazione del bene comune.
9. Conclusioni
Il pilastro della moderna teoria dei beni comuni è rappresentato dalla configurazione degli stessi come
un tertium genus che spezza il binomio proprietà pubblica (beni pubblici) e proprietà privata (beni privati).
Questo approccio teorico si affranca dal classico criterio discretivo basato sul titolo di proprietà, per accedere
ad una considerazione dei beni orientata verso la dimensione fattuale dell’uso degli stessi. Enucleando questa
terza categoria di beni, i fautori di tale teoria mirano a porre le condizioni per l’edificazione di una inedita
costruzione giuridica entro la quale collocare i beni comuni: un innovativo regime i cui elementi costitutivi
135
dovrebbero frapporre ostacoli alle iniziative id privatizzazione che, negli ultimi anni, hanno interessato beni
destinati alla fruizione collettiva.
La teoria dei beni comuni non è un insieme monolitico e compatto di ipotesi, enunciati e proposizioni.
Comparando i diversi contributi, si notano significative differenze quanto alla stessa identificazione puntuale
dei beni comuni. Nei vari cataloghi, anche solo esemplificativi, si rinvengono infatti beni pubblici in senso
economico, talora ascrivibili alle res communes omnium, veri e propri commons e, spesso, beni che
l’economia classifica invece come meritori. Ebbene una simile divergenza e varietà non fa che riflettere
l’assenza di un nucleo forte di fattori teorici attorno ai quali aggregare un modello esplicativo condiviso ed
obiettivo in cui calare lo studio e la disamina dei beni in questione.
Una affermazione è, tuttavia, ricorrente: i beni definiti come “beni comuni” sono preordinati all’effettivo
esercizio dei diritti fondamentali e, dunque, al pieno soddisfacimento degli interessi ad essi sottesi. Il rinvio ai
diritti fondamentali in quanto universali e non singolari, e perciò inescludibili, determina infatti un
indissolubile nesso con un interesse inevitabilmente generale e collettivo e non solo individuale.
Gli studi economici suggeriscono, però, che questa vocazione funzionale va ponderata alla luce della
circostanza che i beni comuni hanno proprietà di inescludibilità e rivalità, diversamente dai beni pubblici in
senso economico. Inoltre, i beni funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali sociali sono più correttamente
qualificabili come beni meritori, anziché comuni, come peraltro emerge dalla ricostruzione concepita da
Ferrajoli.
Ancora, i beni pubblici in senso economico (inescludibili e non rivali) possono essere di proprietà
pubblica (si pensi ad alcuni beni del demanio e del patrimonio indisponibile) oppure non formano oggetto di
proprietà, come nel caso dell’aria, dell’acqua indistinta, del mare, della conoscenza in generale. Diversamente,
i beni comuni (inescludibili, ma rivali) possono essere tanto di proprietà pubblica quanto di proprietà collettiva.
Per questo motivo, non appare condivisibile l’assunto secondo cui il tertium genus debba essere costituito da
beni esclusivamente di proprietà collettiva, diversa e contrapposta da quella privata e da quella pubblica.
È anche vero che, in alcuni casi sono identificabili specificazioni dei beni indistinti che, quindi, possono
essere qualificati come beni comuni: nel caso dell’acqua indistinta, si pensi ai bacini idrici, così come nel caso
della conoscenza si pensi agli intellectual commons.
Ebbene, ogni tentativo di rigida classificazione dei beni comuni rischia di non riflettere le reali
caratteristiche degli stessi, in termini di accesso e di fruizione secondo lo schema escludibilità/inescludibilità e
rivalità/non rivalità, che l’analisi economica mette ben in evidenza. Pertanto, come dimostrato dal confronto tra
elementi giuridici ed elementi economici, appare più efficiente e corretto procedere ad una valutazione caso
per caso del bene che, presentando certi connotati, esigono l’allestimento di uno specifico regime giuridico
autenticamente orientato alla valorizzazione della loro dimensione funzionale connessa all’esercizio dei diritti
fondamentali. Così, ad esempio, la Corte costituzionale potrebbe sindacare la legittimità di atti legislativi
destinati ad incidere pesantemente sull’assetto giuridico di un dato bene, quanto alla sua gestione o al suo
accesso.
Perché questa valutazione caso per caso, condotta alla stregua di condivisi elementi essenziali, possa
favorire una serena ed obiettiva ponderazione delle iniziative volte ad incidere sul regime giuridico dei cd. beni
comuni, suscitando le reazioni polemiche dei sostenitori di questa teoria, appare necessario trovare un
fondamento costituzionale attraverso la lettura combinata dei pertinenti enunciati della carta fondamentale.
Anzitutto la particolare attenzione per i beni qui considerati si riconnette alla necessità, in qualche modo
sottintesa al catalogo dei diritti contemplati dal dettato costituzionale, di salvaguardare le legittime aspettative
delle generazioni future.
Un antico ammonimento indiano invita tutti a considerare la terra non come un bene che abbiamo
ricevuto in eredità da chi ci ha preceduti, ma come un bene che abbiamo ricevuto in prestito dai nostri figli e
discendenti.
I processi costituenti si sono ispirati all’idea di salvaguardare le generazioni del domani. Oltre ai
rivoluzionari francesi, ben consapevoli di non poter vincolare le generazioni future alle scelte del presente, a
proposito dell’ammissione di nuovi Stati nell’Unione, Sherman, delegato del Connecticut, sostenne come si
stesse «provvedendo alla nostra posterità, ai nostri figli e ai nostri nipoti, che avranno uguali probabilità di
essere cittadini di nuovi stati o di quelli vecchi».
Tra le Costituzioni moderne, sulla medesima scia si colloca quella tedesca nella quale, a seguito della
modifica avvenuta nel 1994 che ha portato all’inserimento del nuovo art. 20a nel Titolo II. Anche se la
locuzione «sviluppo sostenibile» non è direttamente presente comunque le sue basi concettuali sono
fortemente affermate e tutelate. Infatti, secondo l’art. 20°, «è compito dello Stato, anche in vista delle
136
responsabilità per le future generazioni, proteggere le basi naturali della vita, nel quadro dell’ordinamento
costituzionale e, in base alla legge e al diritto, tramite il potere esecutivo e la giurisdizione».
Inoltre, all’art. 74 della Costituzione polacca è affermato il dovere delle autorità pubbliche di
«proteggere l’ambiente» congiuntamente a quello «di garantire la sicurezza ecologica delle presenti e delle
future generazioni».
Per quanto manchi nella Costituzione italiana un esplicito riferimento alle generazioni future,
nondimeno l’essenza dei beni che formano oggetto di una specifica protezione, in quanto patrimonio comune,
è tale da imporre di proiettare il nostro sguardo, quanto ai potenziali fruitori degli stessi, ben oltre l’orizzonte
attuale. Del resto, la giurisprudenza costituzionale va proprio in questa direzione, con specifico riferimento
all’ambiente, la cui regolamentazione deve essere rivolta ad approntare «una tutela piena ed adeguata, capace
di assicurare la conservazione dell’ambiente per la presente e per le future generazioni». E non mancano
pronunce di analogo tenore giustappunto in relazione all’acqua. Invero, per la Corte «la dichiarazione di
pubblicità delle acque si risolve in un limite della proprietà dovuto alla intrinseca e mutata rilevanza della
risorsa idrica, rispondente alla sua natura, come scelta non irragionevole operata dal legislatore e quale modo
di attuazione e salvaguardia di uno dei valori fondamentali dell’uomo (e delle generazioni future) all’integrità
del patrimonio ambientale, nel quale devono essere inseriti gli usi delle risorse idriche».
Visto in questa prospettiva il secondo comma dell’art. 9 della nostra Costituzione potrebbe fornire una
base solida alla considerazione e alla tutela non solo dei beni comuni naturali ma anche dei beni culturali come
commons non naturali.
Quanto al tema della proprietà, la disposizione di riferimento è quella di cui all’art. 42 Cost., a mente
del quale «la proprietà è pubblica o privata». La secca, quasi perentoria, alternativa (secondo lo schema dell’aut
aut), parrebbe, di primo acchito, escludere qualsiasi altra forma di proprietà. Tradotta in termini congeniali alla
presente ricerca, la disposizione in parola potrebbe essere letta nel senso di riconoscere solo beni pubblici o
privati: tertium non datur. Più precisamente, quindi, non si potrebbe riconoscere un fondamento
costituzionale alla proprietà collettiva che, come si è visto, potrebbe essere una delle forme giuridiche di
titolarità dei beni comuni.
In verità, è possibile accedere ad una diversa interpretazione.
Innanzitutto, non è da escludere che alla base di tale previsione vi sia la volontà di riconoscere ai due
regimi proprietari la medesima dignità dal punto di vista costituzionale. In effetti, l’opera di codificazione svolta
dall’Assemblea costituente ha risentito dell’ascendente esercitato, sul punto, dalla tradizione illuministica e
liberale, che ha sempre enfatizzato la concezione della proprietà privata come diritto fondamentale che si
risolve in un potere assoluto ed esclusivo su di un determinato bene. La garanzia costituzionale della proprietà
privata, anche alla luce del precedente rappresentato dall’art. 29 dello Statuto albertino, doveva considerarsi un
dato acquisito definitivamente nell’ordinamento giuridico: una sorta di conquista irreversibile nel momento in
cui si aderisce comunque alla tradizione liberale. Dal canto suo, il riconoscimento costituzionale della
proprietà pubblica riflette una precisa scelta politica, sottesa anche ad altre previsioni disseminate nel testo
costituzionale. In uno Stato sociale di diritto, fondato innanzitutto sul principio di eguaglianza sostanziale e
alimentato dalla vitalità dei diritti sociali, la presenza di beni intestati ai poteri pubblici è una delle condizioni
indefettibili affinché lo Stato possa assolvere alla funzione interventista ad esso assegnata proprio dalla legge
fondamentale della Repubblica. Da ciò l’irrinunciabile compresenza dei due regimi di proprietà: la loro
costituzionalizzazione non è che una forma di garanzia forte a presidio delle due categorie di beni giuridici, a
fronte di possibili interventi del legislatore di tenore e portata non conciliabili con questa scelta.
In secondo luogo, l’art. 42 rispecchia una chiara impostazione metodologica basata sulla classica nozione
di proprietà e sul tradizionale modo di intenderla dal punto di vista giuridico. E non solo: come ha osservato
un maestro del diritto, il regime del diritto di proprietà rispecchia la struttura delle relazioni economiche e
sociali caratteristiche di una data epoca. Negli anni di avvio della Costituzione repubblicana la struttura delle
predette relazioni non si conciliava con l’idea di beni comuni affiorata in epoca più recente.
Se, tuttavia, il fine perseguito dai beni comuni è l’effettivo esercizio dei diritti fondamentali, l’orizzonte
costituzionale degli stessi è destinato ad essere più ampio rispetto all’angusta prospettiva dischiusa dall’art. 42
Cost. Quest’ultima previsione identifica due tipologie di proprietà, ne consacra la dignità costituzionale e si
preoccupa, con riferimento ai beni privati, di presidiarli a fronte del rischio di una loro espropriazione per
ragioni di pubblica utilità. Per i beni comuni il profilo della titolarità soggettiva resta sullo sfondo, assumendo
rilievo tanto il potere di fatto esercitato sui medesimi (possesso e detenzione), quanto la loro gestione.
Alla luce delle precedenti considerazioni, si evince che l’art. 42 Cost. non si frappone al riconoscimento
giuridico della categoria dei beni comuni.
137
A questo punto, è possibile sfruttare, sul piano ermeneutico, alcune combinazioni tra princìpi e norme
costituzionali.
Intanto, l’art. 43 Cost. contempla la possibilità, a fini di utilità generale, di riservare originariamente o di
trasferire imprese o categorie di imprese che erogano servizi pubblici essenziali o che gestiscono fonti di
energia o che operano in regime di monopolio, anche a «comunità di lavoratori o di utenti». In tale modo si
allude ad una gestione partecipata, in seno alla comunità, di servizi che potrebbero inerire in molti casi a beni
comuni.
Più in generale, vista la matrice solidaristica e cooperativa dei beni comuni, un appiglio costituzionale si
potrebbe rinvenire nell’art. 2, là dove ai consociati è imposto l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale, nonché nell’art. 3, secondo comma, dal momento che il fine di
giustizia sociale in esso espresso può trovare nei beni in parola uno strumento irrinunciabile al fine di garantire
il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione dei lavoratori alla vita comunitaria. Senza
dimenticare, poi, le tante previsioni, a cominciare dall’art. 42 là dove parla di funzione sociale della proprietà,
che illuminano la vocazione sociale della Costituzione, da intendersi come sensibilità verso le dinamiche
comunitarie relative alla distribuzione delle risorse ed all’esercizio dei diritti fondamentali.
Se, poi, si pensa alle specifiche tipologie di beni atti a soddisfare diritti fondamentali, siano essi comuni
in senso economico oppure meritori, allora altri agganci costituzionali potrebbero rinvenirsi, ad esempio, nella
lettura combinata degli artt. 9 e 32 sulla quale ha trovato fondamento l’ambiente quale bene provvisto di
dignità e, dunque, di tutela costituzionale, a cui si potrebbero ricondurre i vari commons naturali . Per
converso lo stesso art. 32, che definisce la salute come oggetto di un diritto fondamentale dell’individuo, oltre
che «interesse della collettività», costituisce anche il fondamento di un tipico bene meritorio quale la sanità
pubblica, così come l’art. 34 sul diritto allo studio o l’art. 38 in tema di previdenza e assistenza.
La combinazione delle norme dettate in materia di libertà fondamentali potrebbe, a sua volta, fornire
una ulteriore base costituzionale a beni strettamente correlati al diritto alla vita e ai diritti alla esplicazione dei
momenti cruciali nei quali si esprime l’autonomia del singolo, sia pure come membro di una comunità. Si
pensi all’impatto dell’art. 21 e anche dell’art. 33 sulla libertà di ricerca e di insegnamento sulla conoscenza, sia
come bene pubblico in senso economico, sia in relazione a sue specificazioni nel senso dapprima chiarito, cui
appaiono riconducibili i diversi casi di cultural e di intellectual commons.
138
Capitolo VII
GLI STRUMENTI DELLA COSTITUZIONE ECONOMICA
I soggetti, pubblici e privati, della costituzione economica, si avvalgono di una serie di strumenti
che l’ordinamento giuridico mette a loro disposizione per lo svolgimento delle rispettive attività.
In questo capitolo, analogamente ai precedenti, si analizzeranno gli strumenti della costituzione
economica partendo dal versante pubblico per poi passare ai soggetti privati.
Sezione I
I POTERI DEI SOGGETTI PUBBLICI
Le pubbliche istituzioni, nello svolgimento delle loro attività istituzionali, di regola si avvalgono
di poteri.
poteri Si tratta di situazioni giuridiche soggettive che esprimono una certa autorità, nel senso che
attraverso il loro esercizio le pubbliche istituzioni sono legittimate a prescrivere comportamenti
cogenti ai consociati. Attraverso il potere si esprime appieno la posizione di autorità che tali istituzioni
rivestono nelle relazioni con gli individui. Nel nostro Stato costituzionale di diritto – è bene ribadirlo
– i poteri non sono assoluti e illimitati, incontrando in realtà vincoli e limitazioni che discendono dalla
Costituzione e che trovano, poi, attuazione in ambito legislativo.
Lo Stato esprime la propria autorità attraverso i tre classici poteri: legislativo, esecutivo,
giudiziario. Di essi qualcosa è stato detto in precedenza. Ora si tratta di completare il quadro
attraverso la disamina dei profili che più da vicino interessano i rapporti tra il diritto e l’economia.
La funzione legislativa
La funzione legislativa è l’attività di prima e diretta attuazione della Costituzione. Spesso
quest’ultima si limita ad enunciare princìpi generali lasciando alla legge il compito di attuarli ponendo
norme di svolgimento e di dettaglio. Altre volte la Costituzione fissa essa stessa regole
immediatamente applicabili: in questo caso la legge svolge una funzione integrativa o di
specificazione.
È bene precisare che la funzione legislativa si esprime non solo attraverso la legge ordinaria del
Parlamento, ma anche attraverso altre fonti primarie la cui produzione è devoluta ad altri organi o
istituzioni: si pensi agli atti aventi forza di legge del Governo (i decreti legislativi e i decreti legge)
legge e alle
leggi regionali (e delle Province autonome di Trento e di Bolzano).
1. La legge ordinaria del Parlamento. – Prendendo le mosse dalla legge ordinaria,
ordinaria è bene
innanzitutto osservare che essa è l’epilogo di un procedimento disciplinato dalla Costituzione e dai
regolamenti di ciascuna Camera. Vigendo il principio del bicameralismo perfetto, ogni legge deve
essere il frutto delle convergenti, seppur distinte, manifestazioni di volontà dei due rami del
Parlamento. Per la descrizione del procedimento si rinvia a quanto sintetizzato in un precedente
capitolo.
In questa sede, invece, vale la pena indugiare sulle trasformazioni che hanno alterato l’originaria
fisionomia della legge.
In principio, la legge poteva a buon titolo considerarsi come lo strumento privilegiato e
coerente di manifestazione della volontà popolare sul piano dell’attività normativa, sia pure attraverso
la mediazione decisiva dell’organo democratico della rappresentanza politica. La legge era considerata
espressione della volontà generale, in quanto preordinata a realizzare e garantire interessi della
comunità nazionale, e si risolveva nella produzione di norme generali e astratte, in nome del principio
di eguaglianza formale.
139
Tutto ciò era in linea con le basi dello Stato liberale di diritto:
- norme generali e astratte destinate a rendere effettiva l’eguaglianza di tutti davanti alla legge;
- pieno rispetto della separazione dei poteri, atteso che la legge era destinata ad operare quale
fonte del diritto;
- configurazione di un procedimento svolto dinanzi all’assemblea rappresentativa del popolo.
Nel momento in cui muta la cornice di riferimento, cambia anche la fisionomia della legge.
Con l’avvento dello Stato sociale, compito delle istituzioni pubbliche non è solo quello di
garantire i diritti soggettivi, ma è anche quello di intervenire direttamente nei rapporti economici e
sociali per correggere i fallimenti del mercato e l’iniqua distribuzione della ricchezza nazionale.
Questa trasformazione del ruolo complessivo dello Stato ha prodotto ripercussioni anche sul
versante legislativo attraverso una ridefinizione dei caratteri della legge.
Più precisamente, questa rivisitazione dello strumento legislativo è stata favorita da un
ripensamento globale del principio della separazione dei poteri. Nella sua versione classica, di
ispirazione liberale, data la sua rigidità questo principio non avrebbe potuto assistere adeguatamente
l’inedito ruolo delle pubbliche istituzioni. Lo Stato sociale ha, così, imposto una attenuazione della
rigidità della divisione dei poteri. Ciò a favore, innanzitutto, di un potenziamento dei luoghi di
confronto e di collaborazione. L’alleggerimento della rigidità di tale principio ha poi condotto alla
introduzione di deroghe giustificate dalla necessità di configurare meccanismi idonei a fronteggiare i
molteplici problemi dei quali si era preso carico lo Stato sociale.
Dunque, nella versione classica di matrice liberale, la legge era considerata fonte primaria del
diritto, produttive di norme generali e astratte, espressione diretta ed esclusiva della funzione
legislativa, come tale pienamente rispettosa del principio della separazione dei poteri.
Con l’avvento dello Stato sociale, resta ferma questa configurazione, ma lo spettro delle
potenzialità espressive della legge si arricchisce progressivamente attraverso la creazione di inedite
tipologie di legge. Si passa, così, da una concezione monolitica della legge ad una dimensione
poliedrica della stessa.
Ecco le novità su questo versante, che più interessano la costituzione economica.
1) Leggi provvedimento.
provvedimento Queste leggi scardinano la netta separazione tra potere legislativo e
potere amministrativo. Infatti, nello Stato liberale di diritto il potere legislativo conduce alla
produzione di norme giuridiche generali e astratte, mentre il potere esecutivo si esprime attraverso
atti amministrativi, vale a dire in provvedimenti destinati a definire una situazione specifica mediante
l’applicazione della legge ad un caso concreto.
Così, ad esempio, la legge stabilisce che per costruire una casa su di un terreno il proprietario deve chiedere
una licenza (funzione legislativa). Il Sig. Tizio, proprietario di un terreno sito nel comune di Villanova in via Verdi
11, per costruire su di esso una casa, chiede al sindaco di tale comune la licenza (funzione amministrativa).
Ebbene, attraverso la legge provvedimento, il legislatore anziché produrre norme giuridiche
generali e astratte, produce norme sì giuridiche, ma relative a situazioni specifiche, concretamente
identificate.
Così, ad esempio, una legge dispone la revoca di tutti i provvedimenti amministrativi concessi a talune
imprese per lo svolgimento di determinate attività. Oppure, una legge stanzia una data somma di denaro come
sovvenzione ad un determinato ente privato di assistenza.
Con la legge provvedimento, dunque, il legislatore compie un atto che, stando al principio della
separazione dei poteri, spetterebbe all’autorità amministrativa, cioè al potere esecutivo. Si parla,
infatti, anche di leggi in luogo di provvedimento amministrativo, proprio a sottolineare questa
sostituzione.
Le ragioni sottese a questo tipo di intervento sono molteplici. Il potere legislativo intende
assumersi direttamente la responsabilità di decisioni destinate ad incidere direttamente in realtà
140
soggettive specificamente individuate. Oppure, si predilige la legge per ridurre il rischio di azioni legali
contro certe decisioni. Infatti, un atto amministrativo può – come vedremo – essere impugnato
davanti al T.a.r., in primo grado, e al Consiglio di Stato, in appello: non solo doppio giudizio, ma
anche varietà dei vizi denunciabili (violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere). Al contrario,
una legge (che si sostituisce all’atto amministrativo) può essere impugnata solo davanti alla Corte
costituzionale in presenza di rigorosi presupposti (nel corso di un giudizio davanti ad un giudice,
sempre che la questione di legittimità costituzionale sia rilevante e non manifestamente infondata).
Detto in breve, sostituendosi all’amministrazione (potere esecutivo), il legislatore mette una decisione
concreta al riparo di iniziative giudiziarie potenzialmente capaci di vanificare la decisione stessa.
In campo economico è ricorrente l’uso delle leggi provvedimento. Quando lo Stato
nazionalizzò alcuni servizi pubblici negli anni Sessanta (si pensi, ad esempio, all’energia elettrica),
l’espropriazione delle vecchie aziende private e la creazione di un’unica impresa pubblica furono
realizzate non con atto amministrativo, ma con la legge. In effetti, per espropriare un bene (funzione
amministrativa, cioè potere esecutivo), è più facile e sicuro ricorrere alla legge (funzione legislativa),
per le ragioni sopra ricordate.
Le leggi provvedimento costituiscono oramai una componente stabile e accettata del nostro
panorama giuridico. Nondimeno, la Corte costituzionale ha definito un assetto giurisprudenziale
congeniale ad un appropriato equilibrio tra la funzione legislativa e la funzione amministrativa.
a) La natura provvedimentale di una legge o di un atto avente forza di legge è riconosciuta
quando essa «incide su un numero determinato e molto limitato di destinatari ed ha contenuto
particolare e concreto». Non così, invece, allorché l’atto legislativo si riferisca «ad un numero
indeterminato di destinatari» e non concerna «un oggetto rientrante tra quelli propri dei
provvedimenti amministrativi».
b) Anche il legislatore regionale è legittimato ad adottare simili atti. Non si può, infatti, asserire
che «il divieto di leggi a contenuto particolare e concreto tocchi soltanto le Regioni in conseguenza di
un presunto principio generale dell’ordinamento giuridico, poiché un principio del genere,
concernendo i caratteri strutturali della legge diretti a qualificarne l’essenza o l’identità tipologica
come atto normativo, dovrebbe essere desunto da una inequivoca norma avente un rango superiore
alla stessa legge, che in verità non è dato rinvenire nel nostro ordinamento positivo».
c) La legittimità delle leggi provvedimento riposa sulla mancata previsione, in Costituzione, di
una riserva di amministrazione tale da imporre un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare
e concreto. La legge può «attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente
affidati all’autorità amministrativa». Quindi, è «possibile che, in casi particolari, il legislatore provveda
direttamente alla valutazione ed alla determinazione di scelte concrete che, altrimenti, in attuazione
dei criteri dettati dal legislatore stesso, resterebbero affidate alla discrezionalità dell’amministrazione
nell’apprezzamento del pubblico interesse».
d) La legittimità di siffatte leggi, «valutata in relazione al loro specifico contenuto», è verificata
attraverso uno scrutinio stretto di costituzionalità, condotto alla stregua del principio di ragionevolezza
nelle sue molteplici declinazioni di non arbitrarietà, di proporzionalità, di adeguatezza, di congruità.
In particolare, il giudice costituzionale è chiamato ad appurare, in maniera stringente, se siano
identificabili interessi in grado di giustificare l’intervento del legislatore, desumibili anche in via
interpretativa, e se sia stata realizzata una scelta proporzionata ed adeguata all’obiettivo da
raggiungere. Ciò in considerazione del pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo
particolare o derogatorio.
e) Posto che sul legislatore non grava alcun obbligo di motivazione, nondimeno debbono
risultare i criteri che ispirano le scelte realizzate con la legge provvedimento, nonché le relative
modalità di attuazione. Al riguardo, «è sufficiente che detti criteri, gli interessi oggetto di tutela e la
ratio della norma siano desumibili dalla norma stessa, anche in via interpretativa, in base agli ordinari
strumenti ermeneutici». Resta fermo che il sindacato della Corte sulla denunciata irragionevolezza
della scelta compiuta dal legislatore «non può spingersi fino a considerare la consistenza degli
elementi di fatto posti a base della scelta medesima». Nondimeno, la Corte esige che dette leggi sia
141
precedute ad una adeguata istruttoria, la cui carenza è sintomo di cattivo esercizio del potere
legislativo in funzione provvedimentale.
2) Leggi incentivo.
incentivo Nello Stato sociale, la legge non si limita a fissare norme giuridiche a
contenuto prescrittivo (→ imposizione obbligatoria di comportamenti o di omissioni) o a contenuto
punitivo (→ configurazione di illeciti e previsione contestuale di sanzioni). Talora, la legge svolge una
funzione promozionale, nel senso di contemplare previsioni che spingono le persone interessate ad
assumere determinate iniziative. Questa spinta è fatta attraverso la previsione di misure finanziarie,
sgravi fiscali, alleggerimenti burocratici, volti tutti a incentivare il compimento di azioni che altrimenti
nessuno avrebbe interesse a porre in essere.
Si pensi alle leggi che consentono di detrarre, nella dichiarazione dei redditi, una parte delle spese
sostenute per la ristrutturazione di un immobile. Oppure ad una legge che prevede l’erogazione di una somma di
denaro per la rottamazione dell’autovettura in vista dell’acquisto di un nuovo veicolo. O, ancora, alla previsione
legislativa di incentivi per l’adozione di fonti rinnovabili di energia, come l’eolico o il fotovoltaico.
Queste leggi sono coerenti con l’inedita vocazione dello Stato quale soggetto promotore di
attività rilevanti sul piano economico al fine di stimolare la ripresa del sistema produttivo e la sua
crescita.
Il fattore di criticità di queste leggi è la loro possibile abrogazione, magari con efficacia
retroattiva. In questi casi è forte la lesione del legittimo affidamento che i consociati ripongono in
misure che li hanno indotti a prendere iniziative che altrimenti non avrebbero assunto. Ancora una
volta è la Corte costituzionale a porre vincoli e condizioni per l’abrogazione delle leggi di incentivo, in
nome soprattutto del principio di ragionevolezza.
Così, ad esempio, se una legge incentivo prevede l’erogazione periodica di finanziamenti, la sua
abrogazione, per non alterare un rapporto giuridico pendente in quanto destinato a proiettarsi nel tempo, deve
essere, secondo la Corte costituzionale, corredata da una adeguata disciplina transitoria, in modo tale da rendere
meno brusco il venir meno di quell’incentivo.
3) Leggi di interpretazione autentica.
autentica Interpretare la legge significa ricavare dalla disposizione la
norma da applicare al caso concreto. Per disposizione s’intende la frase che il legislatore ha redatto
per esprimere la propria volontà normativa. Per norme s’intende lo schema di qualificazione entro
cui ricondurre un determinato fatto secondo il modello causale già descritto. Normalmente, da una
disposizione si ricava una e una sola norma. Se, invece, a causa di inesattezze o ambiguità lessicali o
perché vi sono stati importanti mutamenti sociali o economici dal momento dell’entrata in vigore
della legge, dalla disposizione si possono in astratto ricavare più norme (confliggenti tra di loro), allora
emerge un problema interpretativo. Nel rispetto del principio della separazione dei poteri spetta al
giudice sciogliere il nodo interpretativo, applicando le ordinarie e vincolanti regole
dell’interpretazione (criterio letterale, intenzione del legislatore, criterio sistematico, interpretazione
costituzionalmente orientata). In effetti, l’interpretazione è il passo che precede l’applicazione della
legge al caso concreto, che spetta al giudice per dirimere una data controversia.
A volta, però, è lo stesso legislatore a svolgere questo compito, attraverso appunto le leggi di
interpretazione autentica.
Queste leggi si identificano in presenza di espressioni del tipo: «... l’art. 18, comma 1, lett. a), della legge 23
marzo 1990, n. 123, deve essere interpretato nel senso che i beneficiari del trattamento pensionistico previsto
dall’art. 17 della stessa legge sono soltanto i dirigenti...». Normalmente queste leggi recano testualmente la loro
qualifica di “leggi di interpretazione autentica”.
Perché il legislatore si sostituisce all’autorità giudiziaria nell’interpretare una data legge ?
Nel nostro ordinamento, posto che «i giudici sono soggetti soltanto alla legge» (→ art. 101,
secondo comma, Cost.), l’interpretazione dei giudici, persino quella della Corte di cassazione (→
142
giurisprudenza), non è giuridicamente vincolante. Dunque, quand’anche la Corte di cassazione,
organo di chiusura dell’apparato giudiziario e titolare del già citato potere di nomofilachia, sceglie una
determinata interpretazione, gli altri giudici possono anche discostarsene., con l’unico rischio (ma non
la certezza) di vedersi annullare la decisione nei successivi gradi di giudizio.
La legge di interpretazione autentica, invece, è giuridicamente vincolante, in quanto detta
interpretazione è stabilita da una fonte del diritto: dunque, i giudici sono soggetti alla legge di
interpretazione autentica. È definita “autentica” proprio perché proviene dal legislatore, che
interpreta propri atti precedenti.
Normalmente, una legge di interpretazione autentica interviene quando vi è un forte dissidio tra
i giudici sulla interpretazione di una data norma legislativa. Ciò che crea incertezza del diritto, in
quanto in un tribunale una data disposizione si interpreta in un certo modo, mentre in un altro
tribunale la si interpreta in modo diverso. Si suole affermare che, in quel caso, non si è formato alcun
“diritto vivente”, ossia un indirizzo giurisprudenziale consolidato. Per risolvere questo problema, il
legislatore mette fine ai dubbi interpretativi imponendo con legge una certa interpretazione, con
esclusione delle altre.
A volte, però, il legislatore interviene anche quando c’è un diritto vivente, ma in questo modo
vuole costringere i giudici a cambiare idea, accedendo alla interpretazione preferita dallo stesso
legislatore. In questo caso, è forte la tensione tra funzione legislativa e funzione giudiziaria, e il
principio della separazione dei poteri ne risente parecchio.
Ad accentuare questa tensione intervengono leggi che si mascherano dietro la qualifica di
interpretazione autentica, avendo in realtà una diversa portata sostanziale. Non c’è nessun dubbio
interpretativo da sciogliere. Il legislatore interviene solo per imporre anche per il passato una nuova
norma giuridica.
In effetti, le leggi di interpretazione autentica sono per definizione retroattive.
retroattive Visto che il loro
compito è interpretare una precedente legge, il legislatore fornisce una risposta che non può non
applicarsi sin dal momento in cui quella legge è entrata in vigore.
Ebbene, per limitare l’abuso dell’interpretazione autentica, la Corte costituzionale ha stabilito
che:
a) non è decisiva l’autoqualificazione della legge come “legge di interpretazione autentica”;
b) ciò che conta è la portata retroattiva della stessa, che è ammissibile solo nel rispetto dei limiti
e delle condizioni, tutte in qualche misura riconducibili al principio di ragionevolezza, che la Corte
stessa ha individuato nel tempo.
4) Leggi legate alla manovra di bilancio.
bilancio Lo strumentario legislativo si è arricchito di inedite
figure nel corso degli ultimi decenni, proprio in relazione alla manovra di bilancio.
Ogni anno il Parlamento approva con legge il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo:
- il bilancio preventivo indica le spese e le entrate previste per l’anno successivo;
- il rendiconto consuntivo indica le spese e le entrate effettivamente poste in essere nel corso
dell’anno precedente.
Questi atti sono predisposti dal Governo per poi essere approvati, in ossequio al principio no
taxation without representation, dal Parlamento con legge.
Senonché ben presto la legge di bilancio si è rivelata uno strumento finanziario troppo rigido.
In effetti:
Tutte le spese devono essere previste dalla legge (più correttamente, da una fonte primaria del
diritto). Anche le entrate, con particolare riferimento alle imposte (→ art. 23 Cost.), devono essere
previste dalla legge (da una fonte primaria).
Quando il Governo redige il bilancio, esso è vincolato al rispetto delle leggi, di spesa e di
entrata, vigenti in quel momento.
Nel contempo il Governo deve poter realizzare gli obiettivi con i quali la maggioranza si è
presentata alle elezioni, per poter contare su una possibile nuova vittoria.
143
Per la realizzazione di quegli obiettivi, il Governo deve spendere o deve agire sul versante delle
entrate (ad esempio, diminuendo le tasse).
Dunque, nel predisporre il bilancio (spese e entrate), il Governo può verificare se le leggi di
spesa e di entrata in vigore in quel momento sono davvero sufficienti e adeguate. E se non lo sono ?
- il Governo non può modificare quelle leggi mentre redige il bilancio perché non ne ha i
poteri;
- al tempo stesso, anche il Parlamento non può modificarle in sede di approvazione del
bilancio, dal momento che la legge di approvazione del bilancio è una legge meramente formale in
quanto il Parlamento non può modificare il bilancio redatto dal Governo, né apportare direttamente
modifiche alla legislazione vigente.
E, allora, che fare ?
Ebbene, per garantire al Governo la possibilità di realizzare i propri obiettivi programmatici
potendo contare su spese ed entrate adeguate, in modo organico e globale, il Parlamento ha
introdotto, nel 1978, la legge finanziaria.
finanziaria Alla legge finanziaria è stato affidato il compito di modificare
le leggi di spesa e di entrata in vigore in quel momento in modo coerente con gli obiettivi
programmatici del Governo. In questo modo i singoli ministri furono messi nelle condizioni di
stabilire l’entità finanziaria degli interventi nei rispettivi settori contando su un quadro normativo
modificato. Modificato non a casaccio, ma in maniera mirata e coordinata, alla luce della
quantificazione delle risorse necessarie a realizzare i suddetti obiettivi.
Pertanto, la manovra di bilancio si articolava, sommariamente, nelle seguenti fasi:
1) documento di programmazione economicoeconomico-finanziaria
finanziaria:
ia il Governo adottava e presentava alle
Camere un documento recante gli obiettivi macroeconomici da realizzare nel triennio successivo, in
armonia con l’indirizzo politico di maggioranza;
2) legge finanziaria:
finanziaria il Parlamento, su iniziativa del Governo, approva una sola legge che include
tutte le modifiche alle leggi vigenti, sia sul versante delle spese sia su quello delle entrate, in modo tale
da poter predisporre un bilancio coerente con i suddetti obiettivi;
3) legge di bilancio:
bilancio finalmente il Parlamento procede con l’approvazione del bilancio.
Senonché, la legge finanziaria ha ben presto smarrito la propria vocazione originaria, per
divenire uno strumento col quale il debito pubblico è aumentato a dismisura. In effetti, la
procedura di approvazione della legge finanziaria veniva percepita come l’occasione più propizia per
introdurre nel testo presentato dal Governo le previsioni più disparate al fine di accontentare gruppi
di pressione o assecondare i desideri espressi dagli elettori dei singoli parlamentari. Il disegno di legge
finanziaria entrava in Parlamento con un peso, e ne usciva con un peso decuplicato: più interventi
dello Stato, più spese e, quindi, più tasse e più indebitamento pubblico.
A porre un freno a questa crescita smisurata e incontenibile del debito pubblico ha provveduto
la maturazione del processo di integrazione europea. Un debito pubblico elevato indebolisce un
sistema economico. L’indebolimento dell’economia di uno Stato si riflette inevitabilmente sui sistemi
economici degli altri Stati membri dell’Unione europea. Sicché, le istituzioni comunitarie hanno
intrapreso una serie di iniziative volte a raccomandare, prima, e a imporre, dopo, comportamenti
virtuosi degli Stati, in termini di interventi strutturali di riduzione e di contenimento della spesa
pubblica. Per semplificare al massimo, l’Unione europea ha obbligato gli Stati a tenere in ordine i
conti al fine di non subire conseguenze negative, così accrescendo progressivamente i poteri di
ingerenza e di controllo degli organismi comunitari.
In particolare, in virtù del Trattato di Maastricht, i conti non tornano se:
1) il disavanzo supera la soglia del 3 % del prodotto interno lordo;
2) il debito pubblico supera la soglia del 60 % del prodotto interno lordo.
Da ultimo è intervenuto il cd. Fiscal compact,
compact vale a dire il Trattato sulla stabilità, sul
coordinamento e sulla governance dell’Unione europea, sottoscritto da 25 paesi (trai quali l’Italia) il 2
marzo 2012. Tra i molteplici vincoli così introdotti occorre ricordare, in particolare:
- l’inserimento del pareggio di bilancio (cioè un sostanziale equilibrio tra entrate e uscite) di
ciascuno Stato in «disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale»;
144
- il vincolo dello 0,5 di deficit “strutturale” – quindi non legato a emergenze – rispetto al
prodotto interno lordo;
- l’obbligo di mantenere al massimo al 3 per cento il rapporto tra deficit e prodotto interno
lordo, già previsto da Maastricht;
- per i paesi con un rapporto tra debito e prodotto interno lordo superiore al 60 % previsto da
Maastricht, l’obbligo di ridurre il rapporto di almeno un ventesimo all’anno, per raggiungere quel
rapporto considerato “sano” del 60 %.
Il nostro Paese si è uniformato al fiscal compact innanzitutto modificando l’art. 81 Cost., nei
seguenti termini:
«1. Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio,
tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
2. Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del
ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta
dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
3. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
4. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo.
5. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e
per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
6. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad
assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del
complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti
con legge costituzionale».
Il senso di questa previsione è chiaro: le istituzioni debbono adoperarsi per garantire il pareggio
di bilancio,
bilancio considerando il ricorso all’indebitamento quale extrema ratio da riservare solo in
occasione di eccezionali situazioni di crisi economica.
La portata di questa disciplina è altrettanto evidente. Per pervenire al pareggio di bilancio, lo
Stato può anche considerare di fare tagli notevoli alla spesa sociale.
Per garantire, poi, il rispetto dei vincoli comunitari di contenimento della spesa pubblica e di
stabilità, la legge n. 196 del 2009, come modificata nel 2011, ha definito un ciclo annuale di bilancio.
bilancio
Il Parlamento italiano ha eliminato la legge finanziaria e l’ha sostituita con la legge di stabilità.
stabilità
«La legge di stabilità riporta i livelli massimi del saldo netto da finanziare (cioè la differenza
tra le entrate e le spese) e del ricorso al mercato finanziario. Essa dispone in particolare
l’eventuale aumento o riduzione dell’imposizione fiscale, i fondi destinati al rinnovo dei contratti
pubblici, le misure correttive alle varie leggi di cui è necessario (se del caso) ridurre l’onere:
insomma, contiene le disposizioni volte a far sì che il bilancio dell’anno successivo corrisponda
agli obiettivi programmatici. La legge di stabilità non è stata concepita come diversa solo nel nome
dalla vecchia legge finanziaria: nelle intenzioni dovrebbe risultare un testo relativamente scarno,
con un contenuto limitato alla fissazione di poste, saldi, aliquote, mentre per gli “interventi di
carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell’economia” ci si
dovrebbe affidare a specifici disegni di legge collegati alla manovra finanziaria (indicati sin da
aprile nel documento di economia e finanza), con lo scopo cioè di introdurre nell’ordinamento
quelle innovazioni che si ritiene servano a perseguire gli obiettivi prefissati. I disegni di legge
collegati vanno presentati entro il gennaio successivo, quando il ciclo di bilancio dell’anno solare
comincia a muovere i suoi primi passi in ambito europeo. A oggi si è tuttavia rimasti alle buone
intenzioni: la legge di stabilità approvata alla fine del 2013 conteneva ben 749 articoli-commi (…).
Le procedure di bilancio ora descritte, in base alla legge di attuazione del nuovo art. 81 Cost.,
restano in vigore fino al 2016 quando legge di stabilità e legge di bilancio confluiranno in un unico
testo (v. l. 24 dicembre 2012, n. 243)» (A. BARBERA, C. FUSARO, Corso di diritto pubblico, VIII
ed., Il Mulino, Bologna, 2014, 279).
145
Il ciclo di bilancio tra Parlamento, Governo e istituzioni europee può essere descritto dal
seguente calendario, non prima però di aver sintetizzato la tipologia e il contenuto degli atti che
costituiscono la manovra di bilancio.
a) Documento di economia e finanza (D.e.f.): analizza l’andamento dell’economia e dei conti
pubblici, con le relative previsioni tendenziali, e contiene il programma di stabilità
stabilità e il programma
nazionale di riforma.
riforma Questi ultimi, a loro volta, indicano gli obiettivi programmatici per il triennio,
con particolare riferimento alla riduzione del debito pubblico, alla ripartizione degli obiettivi per
livelli di governo e alle ipotesi di riforma strutturale.
b) Rendiconto generale dello Stato:
Stato non è che il bilancio consuntivo relativo all’anno
precedente.
c) Legge di assestamento:
assestamento è la legge con la quale eventualmente si riportano i conti in linea con
gli obiettivi per l’anno in corso.
d) Nota di aggiornamento del D.e.f.:
D.e.f. aggiorna le previsioni macroeconomiche e indica i nuovi
obiettivi da raggiungere anche su indicazione dell’Unione europea.
e) Legge di bilancio:
bilancio è la legge con la quale ogni anno le Camere approvano il bilancio
preventivo dello Stato, redatto dal Governo.
f) Legge di stabilità:
stabilità è l’erede della vecchia legge finanziaria, e serve a realizzare gli obiettivi
stabiliti nel D.e.f. Nella legge di stabilità deve essere specificato: il saldo netto da finanziare, ovvero il
disavanzo pubblico tra spese e entrate finali; il saldo del ricorso al mercato, ossia il deficit complessivo
da coprire mediante prestiti; l’importo dei fondi speciali di bilancio; l’importo massimo per il rinnovo
dei contratti del pubblico impiego; gli stanziamenti per il rifinanziamento di spese in conto capitale
previste da leggi in vigore; le previsioni di spesa a lungo termine, connesse alle risorse finanziarie
disponibili in ogni anno.
g) Documento programmatico di bilancio:
bilancio è l’atto con il quale il Governo illustra alle istituzioni
europee i disegni di legge di bilancio e di stabilità.
h) Leggi collegate alla manovra:
manovra recano le vere e proprie riforme strutturali volte a realizzare gli
obiettivi programmati.
31 gennaio e 31
marzo
10 aprile
30 aprile
30 giugno
31 luglio
20 settembre
15 ottobre
30 novembre
31 dicembre
31 gennaio dell’
dell’anno
succ.
La Commissione europea presenta l’analisi
analisi annuale sulla crescita e formula
proposte strategiche. In seguito, il Consiglio U.e. fissa le linee guida recanti i
principali obiettivi di politica economica.
Il Governo presenta alle Camere di D.e.f.
Il Governo presenta alle istituzioni comunitarie il programma di stabilità e il
programma nazionale di riforma.
riforma
Il Governo presenta in Parlamento il disegno di legge di approvazione del
rendiconto generale e, contemporaneamente, il disegno di legge di
di
assestamento.
assestamento
La Commissione e il Consiglio U.e. valutano il programma di stabilità e il
programma nazionale di riforma, formulando eventuali pareri.
Il Governo presenta alle Camere la nota di aggiornamento del D.e.f.
Il Governo presenta in Parlamento il disegno di legge di approvazione del
bilancio di previsione e il disegno di legge di stabilità.
stabilità
La Commissione europea adotta un parere sul documento programmatico di
bilancio.
bilancio
Termine ultimo per l’approvazione del bilancio annuale. Altrimenti, scatta
l’esercizio
esercizio provvisorio per un periodo non superiore a quattro mesi.
Il Governo presenta alle Camere i disegni di legge collegati alla manovra di
finanza pubblica.
146
2. Gli atti aventi forza di legge del Governo. – Dei decreti legislativi e dei decreti legge del
Governo si è già detto abbastanza in precedenza.
Qui basta notare come questi atti normativi siano sempre più considerato gli strumenti
privilegiati di intervento in campo economico o, comunque, in settori sociali che risentono più da
vicino delle vicissitudini del sistema produttivo.
Si ricorre al decreto legislativo, preceduto dalla legge delega, quando s’intende realizzare vaste
riforme di discipline organiche che richiedono particolari competenze tecniche che il Governo,
meglio del Parlamento, è in grado di assicurare con il suo apparato amministrativo. In più, spesso con
la legge delega si demanda al Governo l’adozione di misure normative impopolari, che come tali
metterebbero a disagio la maggioranza parlamentare: si pensi al mercato del lavoro, al sistema
previdenziale, al diritto tributario.
Si ricorre al decreto legge quando non si confida più sulla capacità del Parlamento di
intervenire in maniera efficace in campo economico, specie in presenza di una situazione di grave
crisi. In questo modo, il presupposto dei casi straordinari di necessità e di urgenza viene interpretato
spesso con disinvoltura, e l’atteggiamento del Parlamento in sede di conversione diviene
accondiscendente, quasi di ratifica delle scelte operate dall’esecutivo.
Ad ogni modo, oggi il Parlamento fa sempre meno leggi, e correlativamente è esplosa l’attività
normativa del Governo, ritenuto l’organo meglio attrezzato, non solo per le competenze tecniche ma
anche per la facilità nel pervenire alle decisioni, per fronteggiare i cicli sfavorevoli dell’economia. Ciò
comporta, però, una traslazione della responsabilità politica dal potere legislativo al potere esecutivo,
con significativi contraccolpi sul modello di democrazia rappresentativa accolto dalla nostra
Costituzione: l’efficienza decisionale e la necessità di rispettare il confronto democratico spesso
entrano in tensione.
3. La legge regionale. – Il principio autonomistico giustifica l’adozione di discipline legislative
differenziate, che tengano conto delle peculiarità dei rispettivi contesti territoriali. Nel contempo il
principio unitario impone l’adozione di discipline legislative uniformi allorquando vi siano interessi
da tutelare che travalicano i confini regionali per coinvolgere l’intera comunità nazionale.
Per contemperare questi due princìpi, l’assemblea costituente ha deciso di assegnare la
funzione legislativa anche alle Regioni, eliminando così il monopolio statale.
Si è posto, però, un problema di distribuzione della funzione legislativa: quando interviene la
legge statale ? Quando interviene, invece, la legge regionale ?
L’Assemblea costituente avrebbe potuto optare per il criterio del livello degli interessi. Se sono
coinvolti interessi nazionali, spetta al legislatore statale intervenire. Se, invece, sono prevalenti gli
interessi locali, tocca ai legislatori regionali. Tuttavia, questo criterio è troppo opinabile e inafferrabile,
risultando estremamente difficile identificare con certezza il livello degli interessi incisi da una data
disciplina legislativa. Senza contare, poi, i tanti casi in cui sussiste un tale intreccio di interessi
(nazionali e locali) da rendere impossibile l’identificazione degli interessi prevalenti.
Così, è stato scelto il criterio delle materie.
materie La Costituzione italiana, al pari delle carte
costituzionali degli ordinamenti federali, ha optato per un criterio oggettivo, accessibile, chiaro. Per
materia, infatti, s’intende l’insieme di fatti e rapporti giuridici accomunati da condivisi elementi
essenziali, alla luce degli obiettivi e delle finalità da raggiungere attraverso l’azione dei pubblici poteri
e le iniziative poste in essere dai privati.
Il limite di tale criterio è, nondimeno, evidente. Per un verso, la Costituzione non reca la
definizione puntuale di ogni singola materia (e, comunque, sarebbe stato difficile pervenire a questo
risultato). Pertanto, non sempre risulta agevole collocare un determinato rapporto o comportamento
o situazione in una materia piuttosto che in un’altra.
Un esempio. Il servizio di telefonia in sede fissa, erogato dai cd. phone center, ossia locali aperti al
pubblico, all’interno dei quali è possibile comunicare via telefono o internet a tariffe vantaggiose, è “commercio” o
“comunicazione” ? Il dubbio nasce dalle specifiche caratteristiche di questa attività economica. Sono utilizzate
147
apparecchiature elettroniche di comunicazione, ma al tempo stesso i phone center sono inclusi nella rete
commerciale di un dato Comune (hanno l’aspetto esteriore del “negozio” a tutti gli effetti).
Questo criterio, poi, palesa una ulteriore criticità. I rapporti sociali ed economici sono in
continua evoluzione. Dunque, che fare se si affermano, a livello legislativo, nuove materie non
considerate nel testo costituzionale ? Senza trascurare i rapporti giuridici che andrebbero collocati
contemporaneamente in ambiti materiali diversi.
Una esemplificazione del primo problema, sempre che ci si collochi idealmente agi anni dell’entrata in
vigore della Costituzione, è senza dubbio internet, o anche la tutela dell’ambiente, che è una conquista
relativamente recente nel panorama giuridico. Quanto al secondo problema, si pensi all’agriturismo: agricoltura o
turismo ? O agli alloggi popolari: edilizia o servizi sociali ?
Nonostante queste criticità, il criterio materiale è stato accolto senza esitazione e continua a
definire l’assetto dei rapporti tra legge statale e legge regionale.
L’Assemblea costituente ha assegnato all’art.
art. 117 il compito di definire la distribuzione della
funzione legislativa tra Stato e Regioni.
In origine (dunque, prima della riforma costituzionale del 2001), l’assetto era definito nei
seguenti termini:
a) erano specificamente individuate materie rimesse alla potestà legislativa concorrente.
concorrente In
questi ambiti materiali lo Stato avrebbe dovuto fissare i princìpi fondamentali (→ legislazione di
cornice), mentre i legislatore regionali avrebbero dovuto dettare le norme di svolgimento di tali
princìpi. Dunque, una cornice comune a tutte le Regioni, recante i princìpi di base, e poi discipline
differenziate a seconda delle scelte politiche e delle esigenze espresse in quegli ambiti materiali;
b) in tutte le materie non indicate nell’art. 117 ci sarebbe stato spazio solo per le leggi statali;
c) in queste ultime materie, però, il legislatore statale avrebbe potuto delegare alle Regioni il
compito di integrare la disciplina confezionata a livello statale (potestà
potestà legislativa integrativa o
attuativa).
attuativa
Come si nota, lo spazio di espressione dell’autonomia legislativa regionale, come ritagliato in
origine dall’art. 117, era alquanto striminzito, quasi il riflesso della missione paternalistica assegnata
allo Stato nei confronti delle neonate Regioni: o interviene solo lo Stato (perché sono dominanti gli
interessi nazionali) o intervengo le Regioni, ma nel rispetto dei princìpi dettati a livello nazionale, al
fine di ridurre o contenere le differenziazioni legislative in ambito locale.
Per le Regioni a statuto speciale la situazione non era poi tanto dissimile. È vero: ad esse fu
riconosciuta una potestà legislativa sulla carta più forte, la cd. potestà legislativa regionale piena o
esclusiva.
esclusiva Tuttavia, i limiti previsti dai rispettivi statuti speciali erano tali da consentire ingerenze forti
da parte del legislatore statale (si pensi solo al limite delle “norme fondamentali di riforma
economico-sociale” e all’uso che di esse ne è stato fatto nella prassi legislativa).
Questa è la situazione in cui versa l’autonomia regionale nel momento in cui, come anticipato,
il Parlamento varò una importante riforma costituzionale nel 2001 (→ legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3), modificando anche e innanzitutto l’art. 117. La riforma, su questo versante, fu ispirata
dal’esperienza degli ordinamenti federali, dove la regola è la legge statale e l’eccezione è la legge
federale: cioè, la Costituzione individua le materie in cui c’è spazio per le leggi federali, mentre tutto il
resto spetta alle legislazioni statali (→ clausola residuale). Come vedremo di qui a poco, l’ascendente
esercitato dallo Stato federale ha prodotto solo in parte i suoi effetti palingenetici.
Ebbene, per effetto della revisione costituzionale del 2001, l’attuale art. 117 contempla tre
distinti livelli di legislazione.
1) Potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Stato Nelle materie elencate nel secondo comma c’è spazio
solo per leggi statali.
Ecco le materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione
europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; b)
148
immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello
Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello
Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad
esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme
generali sull’istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei
beni culturali.
2) Potestà legislativa concorrente.
concorrente Nelle materie elencate nel terzo comma al legislatore statale
spetta la enunciazione dei princìpi fondamentali, mentre ai legislatori regionali tocca intervenire con
norme di svolgimento.
Ecco le materie: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione
per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali,
aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
3) Potestà legislativa residuale delle Regioni.
Regioni Ai sensi del quarto comma, «spetta alle Regioni la
potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato».
Senza soluzione di continuità rispetto al passato, la riforma ha confermato al potestà legislativa
concorrente, sia pure arricchendo il corrispondente elenco di materie.
Diversamente dall’originaria opzione dell’Assemblea costituente, è stata capovolta la clausola
residuale a favore dei legislatori regionali.
Quanto alle Regioni a statuto speciale, la loro condizione è rimasta sostanzialmente immutata. Tuttavia,
l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ha stabilito che «sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le
disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già
attribuite». Ciò significa che se per effetto della modifica dell’art. 117 alle Regioni a statuto ordinario è stata
attribuita la potestà legislativa esclusiva in una data materia, per la quale invece gli statuti speciali non prevedono
una analoga attribuzione, allora tale innovativa previsione va estesa anche alle Regioni speciali. Ciò per evitare che
in determinate materie le Regioni ordinarie abbiano più poteri delle Regioni speciali grazie alla modifica dell’art.
117.
È agevole notare, dalla lettura complessiva dell’art. 117, come l’economia
economia sia stata assegnata alle
cure dei legislatori regionali. Non sono inclusi nei due elenchi definiti dal’art. 117 e, dunque, spettano
ai legislatori regionali ambiti materiali inclusi nella macromateria “economia”: industria, commercio,
agricoltura, artigianato, turismo, pesca, caccia.
La riforma costituzionale aveva fatto sperare quanti invocavano da anni un potenziamento
dell’autonomia legislativa regionale. Peraltro, due anni prima il Parlamento aveva varato una revisione
costituzionale che aveva rafforzato l’autonomia statutaria delle Regioni ordinarie. Inoltre, con la stessa
riforma del 2001 è stato equiparato il trattamento delle leggi statali e di quelle regionali davanti alla
Corte costituzionale, quanto meno per le modalità di accesso.
149
Secondo gli auspici, la legge regionale sarebbe divenuta la regola, e la legge statale sarebbe
diventata l’eccezione.
Ma è andata davvero così ?
La rinascita della legge regionale, e con essa dell’autonomia di tali enti territoriali, è stata
ostacolata da una serie di fattori critici.
a) Materie.
Materie Come in passato, si è riproposto il problema della esatta delimitazione degli specifici
ambiti materiali. In mancanza di definizioni nel testo costituzionale, le materie sono definite dal
legislatore statale. Ove le Regioni non condividano tali qualificazioni, allora spetterà alla Corte
costituzionale identificare i contorni e i contenuti delle singole materie. Tutto ciò rende il legislatore
statale più forte e, nel contempo, assegna alla Corte costituzionale – ad un giudice, quindi, sia pure
particolare – un compito che dovrebbe essere assolto dalla politica. Le materie in ambito giuridico
sono contenitori artificiosamente creati dall’uomo.
b) Potestà concorrente.
concorrente Come in passato, la Corte ammette che i princìpi fondamentali non
debbano necessariamente essere fissati da apposite leggi cornice, ma possano anche essere identificati
in via interpretativa attraverso un metodo induttivo (→ da particolare al generale), attingendo dalle
varie norme legislative prodotte dallo Stato nel corso degli anni. È questo un ulteriore elemento di
forza del legislatore statale, che può fare affidamento su processi interpretativi dall’esito non scontato,
la cui protagonista è ancora una volta (non la politica bensì) la Corte costituzionale.
c) Compiti trasversali.
trasversali Il secondo comma dell’art. 117, dedicato alla potestà esclusiva del
legislatore statale, individua, accanto a vere e proprie materie, anche quelli che la Corte costituzionale
ha definito compiti trasversali dello Stato. In effetti, e gli esempi che verranno addotti di qui a poco
chiariranno bene il concetto, non sempre le espressioni usate in quel comma denotano insiemi
organici di rapporti giuridici accomunati da condivisi tratti essenziali. Al contrario, si tratta di attività
preordinate al conseguimento di determinati obiettivi associati alla tutela di interessi nazionali. Si
pensi in particolare ai seguenti, importanti esempi.
- Tutela dell’
dell’ambiente:
ambiente più che atteggiarsi a materia in senso stretto, la tutela dell’ambiente si
traduce in un compito assegnato al legislatore statale in vista della cura dell’interesse generale alla
preservazione dell’ecosistema.
- Tutela della concorrenza:
concorrenza anche in questo caso l’art. 117 non affida al legislatore statale una
materia in senso proprio, ma un obiettivo da raggiungere e, cioè, intervenire al fine di garantire la
libera competizione tra attori economici nei diversi ambiti produttivi e commerciali.
- Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
sociali: in questo caso, compito
dello Stato è quello di fissare norme, applicabili in tutte le Regioni, affinché i fondamentali diritti di
libertà e i diritti sociali ricevano un grado di protezione minima e comune in tutti gli ambiti territoriali.
Perché questi compiti sono definiti “trasversali” ? La risposta è semplice. Per loro natura, questi
compiti tendono a propagarsi in tutti gli ambiti materiali di azione del legislatore regionale. Dunque,
le norme giuridiche prodotte nell’assolvimento di tali compiti sono destinate a trovare applicazione
diffusa in tutte le Regioni, così da imporsi alle scelte dei legislatori regionali, persino nelle materie in
cui questi vantano la potestà residuale.
Si pensi ad esempio alla caccia. Questa è una materia residuale e, dunque, in astratto dovrebbe esserci
spazio solo per leggi regionali. Ma non è così, dal momento che per preservare specie in via di estinzione il
legislatore statale può intervenire anche con norme di dettaglio in nome della “tutela dell’ambiente”. Lo stesso vale
per la pesca.
Si tenga presente, inoltre, che questa attitudine trasversale compete anche ad altre “materie”
(queste sì) incluse nell’elenco di cui al secondo comma dell’art. 117. Si pensi all’ordinamento
ordinamento civile:
civile
questo è l’insieme delle norme che disciplinano il diritto privato. Così, le Regioni ben possono
regolare il commercio o l’artigianato o il turismo, ma le attività contrattuali che si svolgono in questi
150
settori sono regolate in via esclusiva dal legislatore statale. Un altro esempio significativo è
rappresentato dall’ordinamento
ordinamento penale.
penale Nei diversi ambiti in cui interviene, anche a titolo esclusivo, il
legislatore regionale, vi possono essere comportamenti penalmente rilevanti (così nella caccia, ad
esempio). Tali condotte possono essere qualificate come reati e punite solo da leggi dello Stato.
Ora, è chiaro che se il legislatore statale, tramite i compiti trasversali, può ingerirsi in tutte le
materie devolute alle Regioni, allora ne consegue un indebolimento dell’autonomia legislativa
regionale.
In relazione ai compiti trasversali, un approfondimento merita senza dubbio la già citata “tutela
tutela
della concorrenza”,
concorrenza vista l’intima connessione di tale compito con la costituzione economica.
La Corte costituzionale ha chiarito la portata di questo compito trasversale. Secondo il
consolidato indirizzo giurisprudenziale, la nozione di concorrenza, come mutuata dall’ordinamento
comunitario, include innanzitutto gli interventi regolatori che, a titolo principale, incidono sulla
concorrenza: si pensi alle misure legislative di tutela in senso stretto, volte a contrastare gli atti e i
comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati.
Misure che, peraltro, disciplinano le modalità di controllo e i meccanismi sanzionatori. Detta nozione
abbraccia, poi, le misure legislative volte a promuovere l’apertura dei mercati eliminando barriere
all’entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della
competizione tra imprese, e rimuovendo i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche.
Nella sua proiezione dinamica, quindi, la tutela della concorrenza asseconda finalità di ampliamento
dell’area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta,
di beni e di servizi. La Corte, al riguardo, ha ripetutamente precisato che la promozione della
concorrenza «costituisce una delle leve della politica economica statale e, pertanto, non può essere
intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio
perduto, ma anche in quell’accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure
pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad
instaurare assetti concorrenziali».
Ecco i punti salienti.
- La Corte costituzionale ha costantemente sottolineato – stante il carattere «final
finalistico
finalistico»
istico della
stessa – la «trasversalità
trasversalità»
trasversalità che caratterizza tale materia, con conseguente possibilità per quest’ultima di
influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni,
ed, in particolare, il possibile intreccio ed interferenza con la materia «commercio». Infatti, la materia
«tutela della concorrenza» non ha solo un ambito oggettivamente individuabile che attiene alle misure
legislative di tutela in senso proprio, quali ad esempio quelle che hanno ad oggetto gli atti e i
comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati e ne
disciplinano le modalità di controllo, ma, dato il suo carattere «finalistico», anche una portata più
generale e trasversale, non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al
momento dell’esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro
rispettiva competenza.
- La Corte ha anche puntualizzato che «nell’ambito dell’esercizio della competenza statale in
materia di tutela della concorrenza, l’illegittima invasione della sfera di competenza legislativa
costituzionalmente garantita alle Regioni, frutto di un’eventuale
eventuale dilatazione oltre misura
dell’interpretazione delle materie trasversali, può essere evitata non tramite la distinzione tra norme di
principio e norme di dettaglio, ma esclusivamente con la rigorosa verifica della effettiva funzionalità
delle norme statali alla tutela della concorrenza Quest’ultima infatti, per sua natura, non può tollerare,
anche per aspetti non essenziali, differenziazioni territoriali, che finirebbero per limitare, o addirittura
neutralizzare, gli effetti delle norme di garanzia».
- La concorrenza ha un contenuto complesso in quanto ricomprende non solo l’insieme delle
misure antitrust,
antitrust ma anche azioni di liberalizzazione,
liberalizzazione che mirano ad assicurare e a promuovere la
concorrenza “nel
nel mercato”
per il mercato”,
secondo gli sviluppi ormai consolidati
mercato e “per
mercato
nell’ordinamento europeo e internazionale. Pertanto, la liberalizzazione, intesa come
151
razionalizzazione della regolazione, costituisce uno degli strumenti di promozione della concorrenza
capace di produrre effetti virtuosi per il circuito economico. Una politica di “ri-regolazione” tende ad
aumentare il livello di concorrenzialità dei mercati e permette ad un maggior numero di operatori
economici di competere, valorizzando le proprie risorse e competenze. D’altra parte, l’efficienza e la
competitività del sistema economico risentono della qualità della regolazione
regolazione,
golazione la quale condiziona
l’agire degli operatori sul mercato: una regolazione delle attività economiche ingiustificatamente
intrusiva – cioè non necessaria e sproporzionata rispetto alla tutela di beni costituzionalmente protetti
– genera inutili ostacoli
ostacoli alle dinamiche economiche,
economiche a detrimento degli interessi degli operatori
economici, dei consumatori e degli stessi lavoratori e, dunque, in definitiva reca danno alla stessa
utilità sociale. L’eliminazione degli inutili oneri regolamentari, mantenendo però quelli necessari alla
tutela di superiori beni costituzionali, è funzionale alla tutela della concorrenza e rientra a questo
titolo nelle competenze del legislatore statale».
- L’abrogazione delle disposizioni che prevedono l’obbligatorietà
obbligatorietà di tariffe
tariffe fisse tende a
«stimolare una maggiore concorrenzialità nell’ambito delle attività libero-professionali e intellettuali,
offrendo all’utente una più ampia possibilità di scelta tra le diverse offerte, maggiormente differenziate
tra loro» e ciò in nome della tutela della concorrenza.
- Anche l’uso di un determinato marchio,
marchio cui conseguono determinati effetti giuridici, può
alterare la libera competizione all’interno di un mercato. La Corte costituzionale ha più volte
sottolineato il rilievo centrale che, nella disciplina del mercato comune delle merci, ha il divieto di
restrizioni quantitative degli scambi e di misure di effetto equivalente, concernente sia le importazioni,
sia le esportazioni». La legge regionale istitutiva di un marchio di origine locale, «mirando a
promuovere i prodotti realizzati in ambito regionale, garantendone siffatta origine, produce,
quantomeno “indirettamente” o “in potenza”, gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci
che, anche al legislatore regionale, è inibito di perseguire per vincolo dell’ordinamento comunitario».
- Sono vietati gli aiuti concessi dagli Stati,
Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma,
che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza e
che incidano sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia, sul presupposto che non tutti gli aiuti hanno un
impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri, per gli aiuti di importo poco
elevato, generalmente accordati alle piccole e medie imprese e che sono per lo più gestiti da enti
locali o regionali, nella disciplina attuativa del trattato, è stata introdotta una regola, detta de minimis,
che fissa una cifra assoluta al di sotto della quale, in ossequio a un’esigenza di semplificazione
amministrativa a vantaggio tanto degli Stati membri quanto dell’apparato organizzativo della
Commissione e delle stesse imprese, l’aiuto non è più soggetto all’obbligo della comunicazione.
- In materia di aggiudicazione di lavori od opere pubblici,
pubblici in relazione alle norme che
riguardano l’ammissibilità delle offerte e, perciò, attengono alla fase della procedura di evidenza
pubblica che precede la stipulazione del contratto, la Corte ha più volte precisato che «l’ambito
materiale prevalente è quello della tutela della concorrenza» e che «nello specifico settore degli
appalti pubblici vengono in rilievo norme che si qualificano per la finalità perseguita di assicurare la
concorrenza “per” il mercato». Il codice dei contratti pubblici stabilisce che in tema di «qualificazione
e selezione dei concorrenti» le Regioni «non possono prevedere una disciplina diversa» da quella
statale. In particolare, lo stesso codice prevede, innanzitutto, che «nella predisposizione delle gare di
appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di
lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore
economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il
quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche
dei lavori, dei servizi o delle forniture», e, in secondo luogo, che «nella valutazione dell’anomalia la
stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente
indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle
forniture».
- Nell’accezione «dinamica» della «tutela della concorrenza», – scaturente dalla consolidata
giurisprudenza costituzionale e inclusiva delle misure dirette a promuovere l’apertura di mercati o ad
152
instaurare assetti concorrenziali, mediante la riduzione o l’eliminazione dei vincoli al libero esplicarsi
della capacità imprenditoriale e alle modalità di esercizio delle attività economiche –, è consentito al
legislatore statale intervenire anche nella disciplina degli orari degli esercizi commerciali che, per ciò
che riguarda la configurazione «statica», rientra nella materia commercio attribuita alla competenza
legislativa residuale delle Regioni.
- È incostituzionale la norma che, imponendo una limitazione temporale alla cessione di attività
commerciali, restringe la possibilità di accesso di nuovi operatori, con conseguente violazione del
limite della tutela della concorrenza. Anche in un contesto nel quale il numero complessivo delle
autorizzazioni all’esercizio del commercio è condizionato dalla disponibilità di «spazi appositamente
definiti», una limitazione temporale alla cessione dell’attività si traduce inevitabilmente in una barriera
all’entrata di nuovi operatori.
- È precluso al legislatore regionale disciplinare il rinnovo delle concessioni in violazione dei
principi di temporaneità e di apertura alla concorrenza
concorrenza,
renza impedendo «l’accesso di altri potenziali
operatori economici al mercato, ponendo barriere all’ingresso tali da alterare la concorrenza tra
imprenditori».
- Secondo la normativa europea una deroga al principio della libera circolazione dei servizi può
ritenersi necessaria, e dunque ammissibile, solo quando sia giustificata «da ragioni di ordine pubblico,
di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente».
d) Attrazione in sussidiarietà.
sussidiarietà A partire dalla sentenza n. 303 del 2003,
2003 la Corte costituzionale
ha inaugurato il modello della «attrazione
attrazione in sussidiarietà»,
sussidiarietà che ha mitigato la rigidità insita nel riparto
materiale definito dall’art. 117 Cost. Ove lo Stato, in vista del soddisfacimento di interessi unitari,
decida di allocare, presso le proprie istituzioni, funzioni amministrative che, ratione materiae,
dovrebbero spettare alle Regioni, allora tale conferimento, in nome del principio di legalità, trascinerà
con se anche la potestà legislativa.
Ai sensi dell’art.
art. 118 Cost.,
Cost. le funzioni
funzioni amministrative sono assegnate in base al principio del
comune come amministrazione generale e in base ai princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e
differenziazione. In particolare, applicare il principio di sussidiarietà significa individuare l’ente che
meglio di altri è in grado di esercitare una certa funzione amministrativa.
Tutte le funzioni amministrative devono essere disciplinate dalla legge, in nome del principio di
legalità.
legalità
In forza del principio di legalità, spetta alla legge distribuire tra Stato, Regioni, Province e
Comuni le funzioni amministrative. Tocca, in particolare:
- alla legge statale,
statale se si tratta di funzione amministrativa che insiste in una materia di potestà
esclusiva statale (art. 117, secondo comma, Cost.);
- alla legge regionale
regionale,
nale se si tratta di funzione amministrativa che insiste in una materia di potestà
legislativa regionale, sia essa concorrente o residuale (art. 117, commi terzo e quarto, Cost.).
Supponiamo ora che la realizzazione di una certa opera pubblica sia destinata ad interessare più
Regioni (es. un’autostrada o un ponte o una linea ferroviaria) e che richiede l’esercizio di una
funzione amministrativa (es. per il rilascio di una autorizzazione al privato che dovrà fare quella
infrastruttura). Pertanto:
- siamo in una materia regionale (governo del territorio; grandi reti di trasporto);
- spetterebbe alla legge regionale, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., decidere a chi
assegnare quella funzione amministrativa.
Senonché,
Senonché si tratta di un’opera che coinvolge più Regioni e, dunque, tocca gli interessi di più
comunità regionali. Essendoci interessi sovraregionali, il principio di sussidiarietà impone di
individuare l’ente più adatto ad esercitare quella funzione amministrativa. Date le caratteristiche
dell’opera da realizzare, è lo Stato l’ente migliore in forza del principio di sussidiarietà.
Abbiamo così una sola funzione amministrativa, attribuita allo Stato.
Stato Ma chi la regola, in nome
del principio di legalità ? Ovviamente lo stesso Stato con legge, visto che sarà poi una autorità statale a
rilasciare l’autorizzazione (si tratta di opera che tocca più Regioni e sarebbe irragionevole imporre
153
all’amministrazione statale di osservare più e magari diverse leggi regionali, quante sono le Regioni
coinvolte).
Ricapitolando:
- siamo in una materia regionale;
- lo Stato si appropria della funzione amministrativa in quanto si tratta di gestire interessi che
vanno oltre i confini di una sola Regione (e il principio di sussidiarietà ci dice che è lo Stato l’ente più
adatto, data la dimensione degli interessi da tutelare);
- lo Stato si prende pure la funzione legislativa per disciplinare quella funzione amministrativa.
Pertanto, alla fine il risultato sarà il seguente: in una materia regionale (ai sensi dell’art. 117) la
disciplina legislativa viene fatta dallo Stato in applicazione dell’art. 118. Siamo in presenza dunque
della cd. attrazione in sussidiarietà (o anche chiamata in sussidiarietà): lo Stato assegna a se stesso una
funzione amministrativa e, con essa, si prende anche la corrispondente funzione legislativa, in deroga
a quanto stabilito dall’art. 117.
La Corte ammette l’attrazione di sussidiarietà purché:
1) si tratti di intervento strettamente necessario per soddisfare interessi nazionali (principio
principio di
proporzionalità
proporzionalità e ragionevolezza);
ragionevolezza
2) vi sia una intesa con le Regioni interessate (principio
principio di leale collaborazione).
collaborazione Se la Regione
non acconsente, allora lo Stato potrà rivolgersi alla Corte costituzionale per far valere il
comportamento sleale della Regione.
e) Coordinamento della finanza pubblica.
pubblica Con questo titolo di legittimazione di natura
concorrente, il legislatore statale ha inciso parecchio sull’autonomia regionale, in relazione a profili
strettamente connessi alla costituzione economica.
La Corte costituzionale ha riconosciuto la natura di princìpi fondamentali nella materia, di
competenza legislativa concorrente, del coordinamento della finanza pubblica alle norme statali che si
limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio
contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo
esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi.
Secondo la Corte, il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente
«imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali,
condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si
traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti».
Questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali
quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle
risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa».
Lo Stato, quindi, può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme
puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni «a
condizione di permettere l’estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di
uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia regionale». In caso contrario, la norma statale non può
essere ritenuta di principio, a prescindere dall’autoqualificazione operata dal legislatore.
La competenza statale in questo campo non si esaurisce con l’esercizio del potere legislativo,
ma implica anche l’esercizio di poteri amministrativi, di regolazione tecnica e «di rilevazione di dati e
di controllo».
Nell’esercizio di questa potestà legislativa lo Stato ha introdotto una serie copiosa di misure
volte a limitare e ridurre la spesa pubblica, a fronte di provvedimenti finanziari assunti a livello
Regione che hanno contribuito non poco ad aumentare il disavanzo pubblico. Dal 1999 l’Italia ha
adottato il proprio Patto di stabilità interno individuano gli obiettivi programmatici per gli enti
territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno secondo modalità differenti, alternando
principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi
saldi. La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed
approvazione della manovra di finanza pubblica. In questo frangente istituzionale si analizzano le
154
previsioni sull’andamento della finanza pubblica e si decide l’entità delle misure correttive da porre in
atto per l’anno successivo e la tipologia delle stesse.
Così, la spesa per il personale,
personale per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di
stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un
importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al
suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale. In particolare, il
blocco delle sostituzioni di personale andato in pensione con nuovo personale (→ turn over) è stato
disposto con i seguenti divieti: a carico degli enti nei quali l’incidenza delle spese per il personale è
pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti, il divieto di procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; a carico dei restanti enti, la possibilità di
procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle
cessazioni dell’anno precedente.
Similmente, le norme statali in materia di stabilizzazione dei lavoratori precari sono state
riconosciute come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in quanto le stesse
perseguono la finalità del contenimento della spesa nello specifico settore del personale.
Ancora, è stato fissato il divieto di procedere «alle procedure contrattuali
contrattuali e negoziali relative al
triennio 2010-2012» dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e che non vi è «possibilità di
recupero». Misura, questa, ribadita anche negli anni successivi, con ulteriori blocchi della
contrattazione collettiva in questo ambito.
In ambito sanitario, poi, è stato posto l’obbligo
obbligo di rientro dal disavanzo. Al riguardo, la Corte ha
reiteratamente affermato che «l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela
della salute ed in particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla
luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di
esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del
settore sanitario». Pertanto, il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla
spesa corrente per assicurare l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione
con il perseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari».
Questi profili sono la premessa per indugiare sul tema dell’autonomia
autonomia finanziaria delle Regioni,
vista la sua stretta attinenza con altri aspetti della costituzione economica.
La previsione di riferimento è l’art. 119, come modificato anche di recente:
«1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria
di entrata e di spesa.
2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i
principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
3. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i
territori con minore capacità fiscale per abitante.
4. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle
Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche
loro attribuite.
5. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della
persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato
destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni.
6. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
7. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E’ esclusa
ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».
L’art. 119, come riformulato rispetto alla sua versione originaria, mira a implementare nel
nostro ordinamento il modello del federalismo fiscale.
fiscale È quel sistema in cui gli enti territoriali
155
provvedono a finanziare le loro attività attraverso tributi propri, ossia imposte disciplinate da loro leggi
il cui gettito è destinato a rimanere entro i confini territoriali. Così, lo Stato federale ha tributi federali
che riguardano funzioni federali. Gli Stati membri hanno propri tributi per proprie attività.
L’ordinamento italiano non pretende di arrivare a questo assetto, ma intende comunque
superare l’originaria scelta dell’Assemblea costituente di considerare e trattare l’autonomia finanziaria
regionale come autonomia derivata dallo Stato, con tutte le conseguenze facilmente intuibili.
Ebbene, un quadro completo dello stato di attuazione del modello italiano è tracciato da L.
Antonini nel seguente saggio.
L. ANTONINI, L’autonomia finanziaria delle Regioni tra riforme tentate, crisi economica e
prospettive, in RivistaAIC, 2014.
…
2. La legge n. 42 del 2009: luci e ombre della prima sistematica attuazione dell’art.119 Cost.
2.1. Il versante dei poteri fiscali regionali
Il contesto italiano è molto particolare: da tempo la Corte costituzionale aveva richiamato la necessità di
dare attuazione alla nuova autonomia finanziaria definita dalla riforma costituzionale del 2001. Già la sentenza
n. 370/03 affermava: “appare evidente che l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione sia urgente al fine di
concretizzare davvero quanto previsto nel nuovo Titolo V della Costituzione”. Eppure quella pagina è rimasta
bianca per molti anni e solo con la legge delega n. 42 del 2009 sembrò aprirsi una nuova stagione del nostro
assetto della finanza decentrata: ispirata da una linea di continuità con l’impostazione del governo precedente,
venne salutata con favore dalla migliore dottrina.
Coniugando in modo adeguato “il principio di autonomia con quello di unità della finanza pubblica”
poteva, infatti, permettere un’imponente operazione di razionalizzazione di un sistema che, per molti aspetti e
per diversi motivi, risultava inadeguato. La relazione presentata dal Governo alle Camere il 30 giugno del 2009,
redatta sulla base delle analisi della Copaff (Commissione tecnica per l’attuazione del federalismo fiscale),
titolava, consapevolmente, il suo primo paragrafo con la metafora dell’”albero storto” e proseguiva con la
puntuale denuncia delle numerose anomalie (sedimentazione del criterio di finanziamento a spesa storica,
bilanci non armonizzati e non trasparenti, compartecipazioni poco responsabilizzanti, ecc.) riscontrate
nell’analisi di un sistema all’interno del quale pure non mancavano esperienze virtuose. Tutto il processo del
federalismo fiscale era stato impostato nel tentativo di riconcepire il sistema, superando almeno i principali
nodi critici che si erano sedimentati negli anni.
Se in attuazione della legge delega n. 42 del 2009 sono stati definitivamente varati, ad oggi, nove decreti
legislativi, è evidente che qualcosa nel processo non ha funzionato. Occorre quindi cercare di evidenziare quali
sono i fattori sia contingenti che strutturali che hanno reso difficile il tentativo di cambiamento, che cosa è
opportuno salvaguardare di quello che è stato fatto e che cosa è necessario ancora fare (o rifare). A questo
riguardo è necessario interrogarsi anche su quale livello normativo è necessario intervenire per non correre il
rischio di buttare, assieme all’acqua sporca, anche il bambino. Sembra, infatti, prendere sempre più
consistenza la convinzione che la crisi epocale che stiamo attraversando abbia definitivamente superato le
ragioni che sottostavano alle istanze del decentramento.
Questa opinione non appare convincente: non si può rimpiangere il “centralismo italiano”, all’interno del
quale è esploso il debito pubblico e la corruzione che ha condotto poi a Tangentopoli, come un paradiso
perduto. Inoltre, i modelli sanitari di alcune Regioni (ad esempio Emilia Romagna e Veneto) costituiscono ad
esempio delle eccellenze mondiali che difficilmente sarebbero venuti in essere all’interno di una gestione
centralizzata (il problema semmai è quello di uniformare verso questi modelli quelli degenerati di altre
Regioni): oggi la sanità italiana, in base alle classifiche Ocse, è al secondo posto per il livello di qualità (la nostra
aspettativa di vita è più alta della Germania) e all’undicesimo per il livello di costi (inferiori del 50% a quelli
degli USA). C’è poi una questione di democrazia: centralismo e federalismo non hanno la stessa cifra
democratica.
Un primo fattore contingente che occorre considerare deriva dal fatto che la riforma del federalismo
fiscale è caduta in una congiuntura storica straordinaria, quella di una crisi economica epocale, non certo
favorevole a un processo di dimensioni strutturali. Questa congiuntura ha condotto, da un lato, a
comportamenti del centro non sempre giustificabili e poco concilianti e, dall’altro, a rivendicazioni contingenti
156
degli enti territoriali colpiti dalle manovre di finanza pubblica. La stagione dei primi pesanti tagli statali ai
trasferimenti, operati senza andare troppo per il sottile, è infatti iniziata proprio nel mezzo della fase della
redazione dei primi decreti legislativi. L’imponente taglio lineare del decreto legge n. 78 del 2010 avvenne, ad
esempio, per circostanza fortuita proprio dopo la determinazione da parte della Copaff - attraverso un lungo e
accurato lavoro - dei trasferimenti statali che andavano fiscalizzati a favore delle Regioni. Si trattava di una cifra
intorno ai quattro miliardi, inquadrabile come i cd. trasferimenti ex Bassanini, ovvero i trasferimenti diretti a
finanziare le nuove funzioni amministrative che erano state, con quella riforma decentrate. In base a quella
cifra si sarebbe dovuta ridurre l’Irpef nazionale e aumentare corrispondentemente l’aliquota base
dell’addizione Irpef regionale. Ma quando nel 2010 è esplosa la crisi, quei quattro miliardi, anziché fiscalizzati
a favore delle Regioni (come prevedeva la l. n. 42 del 2009), vennero semplicemente e brutalmente tagliati,
aprendo anche sul fronte regionale una fase di ostilità alla direzione assunta dalla riforma.
È quindi più nel modo con cui è stata affrontata la crisi, che nelle sue intrinseche ragioni, che si è
interferito con il processo di attuazione della riforma del federalismo fiscale.
Una crisi economico-finanziaria dovrebbe infatti esaltare, e non indebolire, le ragioni del federalismo
fiscale, che è una riforma che intende rafforzare la responsabilità delle autonomie territoriali nella gestione dei
propri bilanci a partire da una ripartizione delle risorse pubbliche tra livelli di governo e tra enti decentrati
ispirata a criteri di equità.
Un secondo fattore che non ha giocato a favore della riforma è stata una certa retorica del federalismo,
che probabilmente non ha favorito la comprensione dei processi che si stavano attuando: in questa retorica era
implicita la prospettiva di una sorta di federalismo competitivo (decisamente incompatibile con una situazione
come quella italiana caratterizzata da un forte divario tra Nord e Sud), che avrebbe assegnato maggiori risorse
al Nord a prescindere dallo sforzo fiscale. A questa retorica si aggiungeva una generalizzata cultura degli
amministratori locali più favorevole, dopo molti decenni di finanza derivata, ad acquisire maggiore potere di
spesa piuttosto che maggiore potere impositivo: basti considerare che già la legge delega risentiva, per alcuni
aspetti, di questa cultura ed effettuava, in quanto legge statale, scelte impositive che si sarebbero potute lasciare
alla autonoma decisione delle Regioni, come ad esempio quella sull’imposta di soggiorno.
Come si è visto, peraltro, a questa retorica del federalismo si è in realtà accompagnata una pratica del
centralismo19, che di fronte alle esigenze di risanamento dei conti pubblici, che la crisi ha via via imposto, ha
trovato il Governo centrale non esitante, fin dall’inizio del processo di attuazione del federalismo, a ricorrere a
forme di intervento non solo decisamente dirigistiche, come i tagli lineari, ma anche decisamente penalizzanti
per le realtà più virtuose (che paradossalmente erano invece quelle che avrebbero dovuto beneficiare
maggiormente del federalismo fiscale).
Salvo poi acconsentire a manovre come quella attuata con il decreto legge 201 del 2011 per cui le
addizionali regionali Irpef che, in base al d. lgs. n. 68 del 2011, sarebbero potute aumentare solo nel 2013 e
per autonoma decisione delle Regioni, vennero aumentate dallo Stato già dal 2011 dello 0,33% in modo
generalizzato dal Governo per compensare le Regioni dei nuovi tagli subiti.
Accanto a fattori contingenti hanno giocato anche fattori strutturali nel rendere difficile l’attuazione
dell’art.119 Cost. L’esito dell’affrettata riforma del Titolo V è stato, infatti, un sistema largamente incompiuto,
dove si alimenta facilmente un localismo conflittuale in cui il diritto di veto rischia di bloccare qualunque
decisione. È senz’altro significativo che né la xv né la xvi legislatura siano riuscite a portare al traguardo
dell’approvazione, nonostante l’impegno profuso, la cosiddetta «Carta delle autonomie»: dieci anni di continui
veti incrociati tra Regioni ed Enti locali non hanno ancora permesso un’adeguata definizione di «chi fa che
cosa» (condizione invece indispensabile per procedere a una definizione dell’assetto finanziario): il nodo
irrisolto a livello costituzionale tra regionalismo o municipalismo rende quasi impossibile l’impresa.
Il risultato è un sistema dove a prevalere sono frammentazione e incertezza del diritto. Le disfunzioni
del sistema attuale sono evidenti: oggi a distanza di più di dieci anni dalla Riforma del Titolo V emerge
un’eccessiva frammentazione del riparto delle competenze, che dovrebbe essere superata a favore di un
decentramento legislativo più equilibrato e più funzionale allo sviluppo economico e sociale. Su una qualsiasi
procedura si incrociano troppe competenze costituzionali e, in generale, questa frammentazione, con la
difficoltà a mettere d’accordo i soggetti coinvolti, produce costi enormi: oggi in Italia il costo per un km di rete
ferroviaria ha raggiunto 50 ml di euro, contro i 13 della Francia e i 15 della Spagna. La differenza dei costi non
è giustificabile solo con la conformazione orografica del territorio italiano.
Si pensi inoltre ai costi per l’energia che in Italia risultano superiori del 30% rispetto a quelli di altri Paesi
europei (a causa del fatto che per più di dieci anni abbiamo avuto un sistema amministrativo che ha bloccato
gli investimenti nell’energia). Si pensi ancora alla questione del trasporto pubblico locale, che rappresenta
157
l’emblema di come nel nostro sistema si sia innescato un sistematico scaricamento di responsabilità fra i vari
livelli di governo coinvolti.
La materia «grandi reti di trasporto» è stata collocata tra le competenze concorrenti tra Stato e Regioni
(neanche il Canada ha fatto una scelta di decentramento tanto forte), ma il finanziamento del trasporto
pubblico locale continua ad avvenire tramite un trasferimento statale alle Regioni in base alla spesa storica, che
poi lo girano, sempre seguendo lo stesso criterio, in parte alle Province e in parte ai Comuni. A loro volta
questi enti lo girano alle aziende di trasporto. In sintesi: le Regioni hanno negoziato per due anni con lo Stato
l’entità del trasferimento, con enormi polemiche tra i vari soggetti coinvolti; la possibilità di pervenire a una
razionalizzazione della spesa appare lontana e se in un Comune gli autobus si fermano per mancanza di
gasolio, il cittadino non sa a quale porta deve bussare per lamentarsi.
Eppure lo scopo del federalismo dovrebbe essere proprio quello di permettere di raggiungere più
facilmente la porta cui bussare se le cose vanno male e al limite, se si rimane inascoltati, quello di cambiare
residenza (il voting by feet).
Quali dunque i rimedi? Oltre a un riordino del riparto delle competenze legislative e amministrative,
emerge evidentemente soprattutto la necessità di una revisione del bicameralismo e l’istituzione di una Camera
delle autonomie, non solo per introdurre, cum grano salis, una sede di coordinamento a livello politico e
legislativo, ma anche per realizzare la condizione di responsabilizzazione delle realtà territoriali in un sistema
che non può che inspirarsi, dato il profondo divario Nord Sud, al federalismo solidale e quindi continuare a
fondarsi in gran parte su compartecipazioni ai tributi erariali.
I modelli di federalismo, infatti, si possono semplificare in competitivi e solidali. Il primo (ad esempio:
quello degli USA) si basa su forti poteri fiscali autonomi degli enti federati; il secondo si sviluppa invece
principalmente su compartecipazioni ai tributi dello Stato centrale (è ad esempio il modello tedesco). Il rischio
del secondo modello è di creare un meccanismo finanziario di tipo parassitario, che non responsabilizza gli
enti sub statali, cui pure è decentrata la quota principale di spending power. È esattamente quello che è
avvenuto in Spagna e in certa misura anche in Italia, soprattutto riguardo a certe realtà territoriali. In Germania,
che appunto è un modello anch’esso fondato prevalentemente su compartecipazioni a tributi erariali, tutto
questo non è successo grazie a un sistema che prevede non solo regole costituzionali molto dettagliate (quindi
non travolgibili o negoziabili in modo estemporaneo) sul sistema fiscale dei Länder ma anche e soprattutto un
vero e proprio senato federale - il Bundesrat, composto da delegati degli esecutivi regionali - funzionale a
rendere i Länder corresponsabili (mettono quindi “la faccia” sulle imposte statali cui compartecipano) su tutte
le decisioni finanziarie: tributi, perequazione, debito.
In Italia non è pensabile un sistema di federalismo competitivo all’americana, con forti poteri fiscali
delle Regioni. Immaginiamo cosa potrebbe succedere se alla regione Lombardia si accordasse il potere, come
può avvenire in Texas o in Oklahoma, di introdurre una propria imposta sul reddito.
Rispetto a quella delle regioni meridionali, la capacità fiscale della Lombardia è enormemente più
elevata, per cui essa si troverebbe con una possibilità di finanziamento molto più alta della propria spesa
pubblica o, al contrario, con la possibilità di praticare una imposizione sui redditi molto più bassa e
competitiva. In un sistema di questo tipo la perequazione, ovvero la solidarietà tra territori, non sarebbe più
realisticamente praticabile(perché la Lombardia dovrebbe trasferire la maggior parte della propria imposta sul
reddito a finanziamento delle regioni del Sud o viceversa perché non potrebbe ridurre la propria imposizione
sul reddito senza porsi il problema della solidarietà verso gli altri territori?).
Questo è stato poco compreso da chi sostiene che il federalismo fiscale avrebbe dovuto consegnare
poteri fiscali molto più ampi non solo alle Regioni; realisticamente e costituzionalmente l’unica soluzione
praticabile per l’Italia è quindi un federalismo solidale, fondato principalmente su compartecipazioni a grandi
tributi statali, su limitati tributi propri (la cui ampiezza, rispetto alla situazione attuale, andrebbe senz’altro
incrementata, ma senza eccessi) e perequazione. Questo sistema però deve però essere portato a compimento
– altrimenti non può funzionare correttamente - con un adeguato meccanismo di responsabilizzazione politica.
Da questo punto di vista il modello di senato federale introdotto nel progetto di riforma costituzionale
recentemente approvato è poco idoneo, perché più simile al senato federale americano (valido in un sistema
competitivo, ma non in uno solidale) che a quello tedesco.
2.2. La legge n. 42 del 2009 sul versante della spesa regionale e locale: l’innovazione dei costi e
fabbisogni standard
Tra i nove decreti legislativi che hanno attuato la legge n. 42 del 2009, un rilievo particolare rivestono
quelli relativi ai costi (d. lgs. n. 68/2011) e ai fabbisogni standard (d. lgs. n. 216/2010): sono, infatti, intervenuti
158
in un sistema dove ancora nel 2008 ben circa cento miliardi di euro venivano assegnati a Regioni ed Enti locali
sostanzialmente in base al criterio della spesa storica. Si è trattato di un intervento strutturale diretto a
modificare nel lungo periodo il sistema istituzionale, con un impatto su grandi temi di natura costituzionale: i
comportamenti, la responsabilità, la trasparenza, la democraticità, il controllo elettorale. Lo scopo è stato
quello di avviare una dinamica che potesse permettere il passaggio dalla spesa storica (che finanzia
indistintamente servizi e inefficienze) a quello del fabbisogno standard (che finanzia solo i servizi). L’evoluzione
verso costi e fabbisogni standard ha anche implicazioni costituzionali che meritano di essere considerate. Costi
e fabbisogni standard infatti si raccordano alla perequazione e quindi al principio di solidarietà, consentendo
un grado di attuazione
del principio di eguaglianza di alta intensità. Spesso nel dibattito scientifico non è mancato chi ha criticato
questa soluzione, ritenuta eccessivamente farraginosa, affermando che il criterio preferibile sarebbe stato quello
di perequare in base alle capacità fiscali. Chi sostiene questa tesi (…) non considera, però, non solo il vincolo
che deriva dall’art.119 Cost., ma nemmeno quello che deriva dal principio di eguaglianza in relazione ai diritti
sociali e civili. La perequazione in base alle capacità fiscali penalizza infatti indebitamente i territori che
dispongono di minori risorse, mentre quella ai fabbisogni standard attiva processi di efficienza ma non
pregiudica, anzi valorizza, il principio di eguaglianza. È utile, peraltro, ricordare che l’Ocse valuta il sistema dei
fabbisogni standard come il modello di perequazione più evoluto, senz’altro preferibile non solo a quello
distorsivo della spesa storica ma anche a quello della capacità fiscale.
È opportuno precisare che riguardo alla spesa sanitaria regionale il criterio di standardizzazione è stato
di natura diversa rispetto a quello, molto più sofisticato ed efficiente utilizzato per i fabbisogni standard, ed è di
tipo top down: tale scelta si è giustificata da un lato per un certo superamento del criterio della spesa storica
che avvenuto negli ultimi anni e dall’altro per alcune carenze dei sistemi contabili regionali. Il metodo si basa
sulla identificazione di cinque Regioni in sostanziale equilibrio economico tra le quali la Conferenza StatoRegioni ne individua tre, che fanno da benchmark per le altre. Solo il 5 dicembre 2013 all’interno della
Conferenza delle Regioni è stata effettuata la scelta a favore di Umbria, Emilia Romagna e Veneto, che poi è
stata ratificata nel corso della Conferenza Stato-Regioni e servirà, in parte, per il riparto del Patto della Salute
2013 e a regime per quello del 2014. È un risultato comunque importante (anche nonostante il ritardo) perché
permette perlomeno di raggiungere un obiettivo minimale: rendere maggiormente trasparenti gli sprechi che
oggi si annidano in alcuni sistemi regionali, ottenere il superamento degli attuali limiti del Patto per la Salute
dove spesso, disponendo di una base informativa idonea, si sono seguiti criteri empirici di negoziazione di
natura prettamente politica o di convenienza contingente (…).
È opportuno precisare che costi e fabbisogni standard rappresentano un processo di razionalizzazione
della spesa pubblica decisivo per superare la perdurante logica, ormai diventata inaccettabile, dei tagli lineari a
Regioni e Enti locali.
Occorre, infatti, un cambio radicale, come peraltro richiesto dalla recente, dirompente (e poco
considerata) sentenza n. 193/2012 della Consulta, per la quale i tagli di diversi miliardi che le ultime manovre
stabilivano come strutturali e sostanzialmente definitivi, perderanno efficacia a partire dal 2015.
La sentenza ha dichiarato l’incostituzionalità per violazione dell’articolo 119 della Costituzione
della manovra di agosto 2011, nella parte in cui estendeva i tagli anche agli anni successivi al 2014. La Corte
costituzionale non si è limitata alle Regioni speciali, ma ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità anche
delle restanti parti della manovra che “dispongono ulteriori misure restrittive in riferimento alle Regioni
ordinarie, alle Province ed ai Comuni senza indicare un termine finale di operatività delle misure stesse”. In
sintesi: tutta la manovra dei tagli agli enti territoriali è stata riscritta dalla Corte costituzionale nella parte in cui
prevede che gli stessi si applichino a decorrere dall’anno 2012 e 2013 anziché “sino all’anno 2014”.
In questo modo la Corte costituzionale ha attivato il timer di una bomba a orologeria nei conti pubblici
italiani, stabilendo un criterio senz’altro condivisibile, ovvero che il legislatore può ristrutturare in termini
definitivi la spesa solo con vere e proprie riforme e non con tagli estemporanei, che al contrario possono
essere solo a tempo determinato.
La via di uscita obbligata da questa situazione è allora proprio quella offerta dai costi e standard, che
rendono possibile quantificare i lep (livelli essenziali delle prestazioni), la cui definizione diviene ora un altro
passaggio fondamentale per rispondere alla giusta sentenza della Consulta. In altre parole, il legislatore
nazionale dovrà definire quanti asili nido o residenze per anziani occorrono per un determinato numero di
abitanti (si tratta appunto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali) e il relativo fabbisogno standard
permetterà di quantificare le risorse necessarie a garantire in termini efficienti quel servizio. Laddove
imprescindibili esigenze di finanza pubblica imponessero un ridimensionamento della spesa locale, il
159
legislatore nazionale dovrà intervenire sulla rimodulazione dei livelli essenziali, assumendosi la responsabilità
della scelta.
In conclusione, se si è decentrato circa il 60% della spesa pubblica31 (è un dato di fatto) e si vuole
rimanere all’interno di un modello di federalismo cooperativo e solidale occorre strutturare su solide basi la
funzione di coordinamento statale del sistema e questo non può che avvenire considerando i costi e fabbisogni
standard. Questi potranno determinare un’importante razionalizzazione del nostro federalismo di spesa;
sarebbe molto grave se il processo, ora che è giunto al traguardo, non venisse portato a regime e sostenuto nei
prossimi anni. La richiesta di proseguire in tale direzione proviene, come si è visto, ormai anche dalla Corte
costituzionale che impone, per ristrutturare nel lungo periodo la spesa, di sostituire i tagli lineari o altri simili,
grossolani, criteri.
Sempre su questo piano diventa imprescindibile dare piena attuazione alla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni, sia a livello regionale (alcuni punti previsti dalla legge delega e dai decreti legislativi
sono rimasti inattuati e solo recentemente il processo è stato avviato ma è ancora lontano dalla conclusione: si
veda infra) sia a livello locale, dove i lep mancano completamente. I due ambiti sono collegati, perché costi e
fabbisogni standard permettono la corretta quantificazione dal punto di vista finanziario dei livelli essenziali
delle prestazioni. È questa una funzione di coordinamento che lo Stato centrale deve assumere pienamente e
responsabilmente. In futuro, cioè, lo Stato deve poter responsabilmente evidenziare che il sistema non può
più, ad esempio, sostenere i costi di un asilo ogni (per ipotesi) mille abitanti, e che per questo motivo si deve
ridurre il finanziamento agli Enti locali, indicando il livello sostenibile. È cosa diversa da - come invece si è
fatto - operare un taglio lineare sostanzialmente al “buio”, con il risultato poi che parecchi Comuni devono
chiudere gli asili nido perché, di fatto, magari pur essendo stati efficienti, non ricevono più risorse sufficienti.
La mancata definizione dei Lea e dei Lep, quindi, simboleggia come nel nostro sistema sia prevalsa una
retorica del federalismo e una pratica del centralismo, cosa ben diversa dall’esercizio di un effettivo ruolo di
coordinamento dello Stato. Recentemente la Corte costituzionale ha evidenziato la gravità della lacuna nella
sentenza n. 273 del 2013 che salvato il fondo statale per il trasporto pubblico locale, adducendo come motivo
per non seguire la sua consolidata giurisprudenza (che preclude che fondi statali possano essere istituiti nelle
materie residuali regionali) proprio l’inattuazione della riforma del federalismo fiscale. “In particolare”,
sottolinea la sentenza “non è stato ancora emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui l’art.
13, comma 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011 demanda la ricognizione dei livelli essenziali delle
prestazioni nelle materie dell’assistenza, dell’istruzione e del trasporto pubblico locale, nonché dei livelli
adeguati del servizio, anche nella materia da ultimo richiamata, previsti all’articolo 8, comma 1, lettera c), della
citata legge n. 42 del 2009.
L’intero processo di individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia che le Regioni a
statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi, nonché degli obiettivi di servizio, sulla base
della determinazione dei costi e fabbisogni standard, è poi rimesso, dal successivo comma 6 dello stesso art. 13
del d.lgs. n. 68 del 2011, alla Società per gli studi di settore – SOSE s.p.a., in collaborazione con l’ISTAT e
avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso
il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle Regioni, secondo la metodologia e il
procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216
(Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane
e Province). I richiamati procedimenti, allo stato attuale ben lungi dal concludersi, costituiscono pertanto
condizione necessaria ai fini della compiuta attuazione del sistema di finanziamento delle funzioni degli enti
territoriali previsto dall’art. 119 Cost. Ciò determina la perdurante inattuazione di quanto previsto in materia
dalla legge n. 42 del 2009, che non può non riflettersi sull’attuazione dell’art. 119 Cost., la quale, quantomeno
sotto questo profilo, può dirsi ancora incompiuta”. La sentenza conclude quindi affermando: “Le suindicate
finalità e il contesto nel quale è stato realizzato l’intervento del legislatore statale diretto a garantire un
contributo al finanziamento del trasporto pubblico locale, per garantire quelle esigenze di omogeneità nella
fruizione del servizio che rispondono ad inderogabili esigenze unitarie, valgono pertanto a differenziare la
fattispecie in esame dalle ipotesi, soltanto apparentemente omologhe, in cui il legislatore statale, in materia di
competenza regionale, prevede finanziamenti vincolati, ovvero rimette alle Regioni una determinata materia
pretendendo poi di fissare anche la relativa disciplina”.
Il richiamo della Corte costituzionale - considerando anche le gravi disfunzioni (in precedenza
sottolineate) che determina il corto circuito di un sistema dove, da un lato, la materia trasporto pubblico locale
è diventata materia residuale regionale e quella sulle grandi reti di trasposto è divenuta concorrente, e,
dall’altro, il finanziamento avviene ancora con un fondo statale a destinazione vincolata - evidenzia
160
ulteriormente quale ruolo decisivo rappresenti la attuazione della legge n. 42 del 2009 e dello stesso disposto
costituzionale dell’art.117 Cost. sulla determinazione dei Lea e dei Lep.
Peraltro, un altro ambito fondamentale che è rimasto sostanzialmente inattuato è quello relativo alla
perequazione, che, come stabilisce la legge 42 del 2009, dovrebbe essere stabilmente basata sui costi/fabbisogni
standard per le funzioni essenziali che si ricollegano a lea e lep (circa l’80% delle spese complessive) e sulla
capacità fiscale per le altre.
…
f) Unità economica.
economica L’art. 120, primo comma, Cost., stabilisce che le Regioni non possono
«istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè
limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale».
Questa previsione mira a favorire la creazione di un mercato nazionale non parcellizzato, né
irrazionalmente frazionato. I legislatori regionali sono abilitati a dettare discipline congeniali alle
peculiarità dei rispettivi ambiti territoriali, con particolare riferimento alle realtà economiche locali.
Tuttavia, ciò non può alterare la tendenziale unità dell’assetto economico italiano, che verrebbe
gravemente compromessa da misure protezionistiche come quelle espressamente identificate. Si è
visto, in particolare, nella parte dedicata alla tutela della concorrenza, come sia precluso ai legislatori
regionali istituire marchi regionali al fine di valorizzare i prodotti locali a danno di quelli realizzati al
di fuori dei confini regionali.
La nozione di «unità
unità economica»
economica è, poi, testualmente utilizzata nel successivo comma dello
stesso art. 120, dedicato al potere statale di sostituzione:
sostituzione «il Governo può sostituirsi a organi delle
Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di
norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o
dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali». Il comma successivo dispone
che «la legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto
del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione».
Esercitando il potere sostitutivo, lo Stato rimedia all’inerzia degli enti territoriali. Tra le
condizioni che giustificano il ricorso a tale intervento surrogatorio è annoverata proprio la tutela
dell’unità economica.
Il requisito dell’unità economica (Wirtschaftseinheit) è stato introdotto ispirandosi alla
konukurrierende Gesetzgebung di cui all’art. 72, secondo comma, della Costituzione tedesca. In
quell’ordinamento, la tutela dell’unità economica giustifica l’intervento del legislatore dello Stato
federale (Bund) in luogo di quello dei legislatori dei singoli Stati (Länder).
La Corte costituzionale non ha ancora chiarito la portata di tale requisito. In via generale, la
Corte ha riconosciuto che la citata disposizione costituzionale «è posta a presidio di fondamentali
esigenze di eguaglianza, sicurezza, legalità che il mancato o l’illegittimo esercizio delle competenze
attribuite, nei precedenti artt. 117 e 118, agli enti sub-statali, potrebbe lasciare insoddisfatte o
pregiudicare gravemente». Sicché, «la previsione del potere sostitutivo fa dunque sistema con le
norme costituzionali di allocazione delle competenze, assicurando comunque, nelle ipotesi
patologiche, un intervento di organi centrali a tutela di interessi unitari». In relazione ai presupposti di
esercizio del potere sostitutivo la Corte costituzionale ha osservato che, proprio con specifico
riferimento alla tutela dell’unità giuridica e dell’unità economica, «si tratta all’evidenza del richiamo ad
interessi “naturalmente” facenti capo allo Stato, come ultimo responsabile del mantenimento della
unità e indivisibilità della Repubblica garantita dall’articolo 5 della Costituzione».
L’unità economica è stata, quindi, percepita come corollario del principio unitario enunciato,
nella sua globalità, nell’art. 5 Cost.
Nella giurisprudenza costituzionale, perciò, le evocazioni della tutela dell’unità economica si
hanno nelle pronunce in cui il giudice delle leggi si è occupato delle misure volte a garantire la
stabilità dei conti pubblici. In particolare, la Corte ha precisato che i princìpi fondamentali enunciati
161
dal legislatore statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» sono «funzionali anche ad
assicurare il rispetto del parametro dell’unità economica della Repubblica».
4. La potestà regolamentare e la delegificazione. – Come si è visto, i regolamenti (governativi,
regionali, provinciali, comunali) sono fonti secondarie del diritto, ossia subordinate alla legge e agli atti
aventi forza di legge in virtù del criterio gerarchico, che in questo ambio assume la qualificazione di
principio di legalità.
Il regolamento è uno strumento snello, rapido, efficiente, di produzione normativa. I tempi di
gestazione del regolamento sono decisamente ridotti rispetto al procedimento legislativo. Il ministro
competente lo predispone. Il Consiglio dei ministri lo discute e lo approva. Il Presidente della
Repubblica lo emana. Dopo la pubblicazione esso entra in vigore. Pochi giorni, qualche settimana,
per confezionare un atto normativo.
In campo economico, il regolamento è uno strumento particolarmente utilizzato, specie ove si
tratti di disciplinare i poteri dell’amministrazione.
Il ricorso al regolamento è stato favorito anche dalla diffusione del modello della
delegificazione.
delegificazione Si ha delegificazione quando un regolamento sostituisce una previa legge (o,
comunque, una fonte primaria del diritto) per disciplinare in futuro una determinata materia. Il
regolamento viene preferito alla legge appunto perché più snello e rapido: più facile è la sua
approvazione, altrettanto più agevole è la sua modifica o sostituzione con un altro regolamento.
La delegificazione risponde, quindi, alla sempre più incessante domanda di normazione rapida,
mirata, efficiente, che spesso in campo economico caratterizza i rapporti tra le istituzioni pubbliche e i
privati.
Non solo. Con la delegificazione il protagonista della disciplina di una determinata materia non
è più il Parlamento, ma il Governo. L’attività normativa, quindi, esce dal circuito rappresentativo della
contrapposizione maggioranza/opposizione, per accedere ad un ambito in cui è solo la maggioranza a
decidere. E non è una differenza trascurabile.
Dal punto di vista tecnico, la delegificazione deve rispettare una serie di condizioni rigorose. In
effetti:
- non tutte le materie si prestano alla delegificazione;
- quando un regolamento (fonte secondaria) si sostituisce alla legge (fonte primaria),
quest’ultima viene abrogata, ma, in forza de criterio gerarchico, non può essere il regolamento ad
abrogarla.
Pertanto, il tradizionale modello di delegificazione è così strutturato:
a) non c’è spazio per la delegificazione nelle materie coperte da riserva assoluta di legge (es. in
materia penale): i beni in gioco sono dotati di tale rilevanza costituzionale (es. la libertà personale) da
sconsigliare che la relativa regolamentazione sia affidata a fonti secondarie nelle mani della
maggioranza;
b) per avviare la delegificazione c’è pur sempre bisogno di una legge (o, comunque, di una
fonte primaria) a cui spetta:
- autorizzare l’esercizio della potestà regolamentare da parte del Governo;
- emanare norme generali, in modo tale da orientare nel contenuto le future scelte
regolamentari;
- disporre l’abrogazione della previgente legge con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di delegificazione: in questo modo non si vìola il criterio gerarchico e non si crea alcun
vuoto normativo, garantendo la continuità tra la vecchia legge e il nuovo regolamento.
Diversa dalla delegificazione è la cd. deregulation. Con essa addirittura si ritrae il diritto per
lasciare il posto a diverse forme di regolamentazione, quale può essere, ad esempio, quella pattizia o
negoziale tra gli attori economici. In breve, con la deregulation scompare il diritto e appare una
disciplina non giuridica di determinati rapporti.
È superfluo notare come la deregulation sia una misura evocata a gran voce da tutti coloro che
accedono, idealmente, a istanze neoliberiste: più deregulation, meno Stato, più libertà. La
162
deregulation, in effetti, è una delle strade percorse dalle riforme di liberalizzazione,
liberalizzazione che si ha quando
vengono meno gli oneri burocratici a carico degli operatori economici (meno requisiti, meno
autorizzazioni).
amministrativa
La funzione ammini
strativa
Le autorità amministrative di regola svolgono le loro attività attraverso l’esercizio dei poteri
amministrativi. Il potere amministrativo è la capacità giuridica speciale con la quale una pubblica
amministrazione provvede alla cura concreta di interessi generali. L’esercizio del potere
amministrativo culmina in un atto amministrativo che può avere l’effetto di accrescere o diminuire il
patrimonio giuridico del destinatario.
Questa tematica è particolarmente importante nell’ambito qui considerato dal momento che in
molti casi l’attività economica è condizionata dal potere amministrativo, sotto forme di autorizzazioni,
licenze, permessi, concessioni, sussidi, sovvenzioni, controlli, sanzioni, e via discorrendo.
Il potere amministrativo presenta essenzialmente tre caratteristiche:
a) unilateralità:
unilateralità l’atto amministrativo si perfeziona con la volontà manifestata unilateralmente
dall’organo competente;
b) imperatività:
imperatività l’atto amministrativo s’impone anche contro la volontà del destinatario,
modificandone cogentemente la sfera giuridica;
c) tipicità:
tipicità in nome del principio di legalità, le autorità amministrative possono esercitare solo i
poteri ad esse attribuiti dalla legge, intesa come fonte primaria;
d) funzionalizzazione:
funzionalizzazione ogni potere amministrativo è funzionale al soddisfacimento di uno e un
solo interesse generale.
Come si avrà modo di illustrare successivamente, di fronte al potere amministrativo il singolo
versa in una condizione di soggezione, essendo titolare di un interesse legittimo, e non di un pieno
diritto soggettivo.
Oltre al principio di legalità, il potere amministrativo è soggetto ai seguenti princìpi
fondamentali:
1) principio del buon andamento:
andamento l’amministrazione deve essere organizzata in modo tale da
garantire efficienza, efficacia ed economicità nell’azione amministrativa; dove:
• per efficienza s’intende il rapporto tra gli obiettivi programmati e le risorse utilizzate;
• per efficacia s’intende il rapporto tra gli obiettivi programmati e i risultati
effettivamente conseguiti;
• per economicità s’intende il miglior utilizzo possibile delle risorse disponibili;
2) principio di imparzialità:
imparzialità nello svolgimento della propria attività istituzionale ogni pubblica
amministrazione deve rispettare e garantire l’eguaglianza formale di tutti, senza favoritismi o
privilegi;
3) principio di ragionevolezza e proporzionalità:
proporzionalità un atto amministrativo deve essere l’esito di
una corretta ponderazione tra interesse pubblico e interesse privato. Una misura negativa
per il destinatario è giustificata solo se strettamente necessaria, solo se congrua rispetto al
fine da raggiungere, solo se c’è proporzione tra fini e mezzi;
4) principio dell’
dell’equilibrio del bilancio e della sostenibilità del debito pubblico:
pubblico è un principio
che si ricollega a quanto stabilito dall’art. 81 Cost., come modificato nel 2012;
amministrazione: gli organi di governo stabiliscono
5) principio della distinzione tra politica e amministrazione
gli obiettivi da raggiungere e controllano l’azione delle pubbliche amministrazioni attività
politica), mentre gli organi amministrativi individuano i mezzi più opportuni per realizzare
quegli obiettivi (attività di gestione);
163
6) principio di responsabilità dei pubblici funzionari:
funzionari i funzionari e i dipendenti dello Stato e
degli enti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti;
7) principio del concorso:
concorso alle pubbliche amministrazioni si accede tramite concorso, ossia
attraverso una selezione pubblica destinata ad individuare i più meritevoli.
Con l’esercizio del potere amministrativo, la pubblica amministrazione pone in essere una serie
di atti ed operazioni qualificabili, nel loro complesso, come attività.
attività
A seconda del rapporto tra legge e attività amministrativa e del rapporto tra pubblica
amministrazione e giudici in caso di controversia, si possono distinguere tre tipologie di attività
amministrativa.
a) Attività amministrativa vincolata.
vincolata In alcuni casi l’amministrazione è tenuta ad accertare la
sussistenza delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla legge ai fini della adozione di un determinato
atto amministrativo. Una volta accertata la presenza di tali presupposti, l’amministrazione deve
adottare quell’atto. In questo senso si parla di attività amministrativa vincolata.
Si pensi, ad esempio, alla iscrizione nelle liste elettorali, quale condizione indispensabile per esercitare il
diritto di voto. La legge richiede che il cittadino sia residente in un dato comune al fine di essere iscritto nelle
predette liste. In tal caso, l’amministrazione deve semplicemente appurare questa condizione e, in caso di esito
positivo, deve procedere alla suddetta iscrizione. Altro esempio. L’assegnazione di un alloggio popolare è un atto
di amministrazione vincolata. Una volta che l’autorità competente avrà verificato, nel caso del singolo richiedente,
l’esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge (reddito, composizione del nucleo familiare, eventuali disabilità, ecc.),
allora l’amministrazione dovrà procedere all’assegnazione dell’alloggio.
Di fronte alla legge, dunque, l’amministrazione gode di insignificanti margini di manovra. Essa
può considerarsi mera esecutrice del comando legislativo. La verifica delle condizioni fissate dalla
legge non richiede un particolare sforzo.
Di fronte all’autorità giudiziaria, poi, l’amministrazione versa in una condizione di debolezza. In
effetti, ove il richiedente si rivolga al T.a.r. perché l’amministrazione gli ha negato l’atto richiesto, il
giudice adìto non dovrà fare altro che verificare se, nel caso di specie, sussistano i requisiti stabiliti
dalla legge. In caso di esito positivo di tale verifica, il T.a.r. darà ragione al privato e torto
all’amministrazione (→ accoglimento del ricorso giurisdizionale).
b) Attività amministrativa discrezionale.
discrezionale In altri casi, la legge si limita a definire l’obiettivo da
raggiungere, lasciando all’amministrazione il compito di individuare i mezzi più opportuni per
realizzare quell’obiettivo.
Si pensi ad una autorizzazione commerciale. La legge attribuisce alle competenti autorità il compito di
consentire lo svolgimento di attività di natura commerciale se queste garantiscono o concorrono allo sviluppo del
sistema economico. Questo è il fine stabilito dalla legge. Spetterà poi all’amministrazione decidere se, quando e a
quali condizioni rilasciare ai richiedenti la prescritta autorizzazione. Altra esemplificazione. Per aprire uno
stabilimento balneare occorre chiedere ed ottenere una concessione. In effetti, il lido è un bene del demanio
pubblico, che può essere sfruttato economicamente dai privati solo a seguito del conseguimento della concessione,
che è un atto amministrativo. La legge si limita a stabilire l’obiettivo: valorizzazione e corretta utilizzazione di tale
bene. Spetta, quindi, all’autorità competente decidere se, a chi, quando e a quali condizioni rilasciare tale
concessione, in relazione proprio a quell’obiettivo. Similmente, le miniere (beni pubblici) possono essere sfruttate
economicamente solo grazie ad un permesso (atto amministrativo). Posto che ogni miniera può essere sfruttata da
una sola impresa e posto che la legge si limita ad affermare che il permesso deve essere concesso a chi sarà in
grado di ottenere il miglior risultato possibili in termini economici, allora l’amministrazione deciderà se e quale
degli aspiranti avrà diritto di sfruttare quella risorsa naturale.
In questi casi si suole affermare che l’amministrazione gode di discrezionalità nel decidere se
adottare oppure no l’atto amministrativo richiesto da un privato e, in caso affermativo, a quali
condizioni e termini procedere.
A questo punto occorre fare una precisazione di estrema importanza. Discrezionalità e libertà
non sono la stessa cosa. Nel caso della discrezionalità, l’obiettivo da raggiungere è determinato da un
soggetto diverso da quello che assumerà una data decisione attraverso la manifestazione della propria
164
volontà: nel caso qui esaminato, è il legislatore a determinare, in forza del principio di legalità, i fini da
raggiungere. Nel caso della libertà, invece, è lo stesso soggetto che agisce a determinare da sé i fini
delle proprie azioni. In questo senso, la pubblica amministrazione non è mai libera, diversamente dai
privati, che quando svolgono un’attività negoziale o, comunque, giuridicamente rilevante, definiscono
autonomamente gli obiettivi da raggiungere. Il fine da raggiungere è l’interesse pubblico sotteso ad
ogni specifico potere amministrativo. Vale la pena ribadire che ogni potere amministrativo è
finalizzato alla realizzazione di un determinato interesse generale, inteso come stato di aspirazione o
di tensione ideale della comunità (e non si singoli individui o di specifici gruppi di persone) verso un
bene ritenuto necessario per soddisfare un determinato bisogno.
Pertanto, di fronte alla legge, l’amministrazione che si avvale di discrezionalità gode di ampi
margini di manovra, essendo la propria azione vincolata solo finalisticamente dalla legge.
Di fronte al giudice, poi, la posizione dell’amministrazione tende a rafforzarsi rispetto all’attività
vincolata. Il giudice, infatti, deve limitarsi a verificare se l’autorità amministrativa abbia correttamente
rispettato il fine predeterminato dalla legge. Nel contempo, il giudice non può sostituirsi
all’amministrazione nel valutare l’adeguatezza o l’opportunità o l’efficacia dei mezzi prescelti, in
quanto una simile valutazione entra nel merito dell’azione amministrativa. Nel rispetto del principio
della separazione dei poteri, il giudice può solo verificare la legittimità degli atti amministrativi, e non
il merito, cioè l’opportunità della scelta posta in essere dall’amministrazione.
Pertanto, se l’amministrazione competente nega il rilascio di una autorizzazione commerciale, in quanto ha
giudicato il richiedente non idoneo a svolgere una utile attività economica, in caso di controversia il giudice
amministrativo dovrà limitarsi a verificare la legittimità dell’atto: se l’amministrazione che ha respinto la domanda
del privato è quella competente; se è stata rispettata la legge che disciplina quel potere; se c’è una motivazione; se
l’amministrazione ha correttamente comparato gli interessi, pubblici e privati, in gioco, e via discorrendo. Il giudice
non può dire: «se fossi stato io al posto dell’amministrazione avrei concesso all’imprenditore Tizio l’autorizzazione
commerciale in quanto mi pare idoneo». Questo tipo di valutazione compete in via esclusiva al potere esecutivo,
cioè all’amministrazione pubblica, in virtù del principio della separazione dei poteri.
c) Discrezionalità tecnica.
tecnica A volte, l’attività amministrativa vincolata presenta un aspetto
particolare. L’amministrazione deve sì limitarsi a verificare i requisiti stabiliti dalla legge per
l’emanazione di un determinato atto, ma questa verifica richiede una specifica preparazione tecnica
da parte di chi procede a questo accertamento.
In un concorso pubblico, la decisione finale dipende dall’accertamento dei requisiti stabiliti dalla legge per
quello specifico profilo professionale: professore universitario, magistrato, dirigente della pubblica
amministrazione, funzionario di Polizia ecc. L’amministrazione in questi casi si affida ad una commissione
composta da esperti: infatti, solo con una adeguata preparazione e competenza maturata nel tempo è possibile
verificare se sussistono i requisiti stabiliti dalla legge. Lo stesso discorso vale per gli esami di abilitazione
all’esercizio delle professioni: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, e via dicendo. L’esame per la patente
di guida è un altro importante esempio di discrezionalità tecnica.
In questi casi, i giudici hanno elaborato la nozione di discrezionalità tecnica proprio per definire
un’attività vincolata che però richiedere particolari conoscenze tecniche ai fini della decisione. Questa
nozione è stata concepita al fine di rafforzare la posizione della pubblica amministrazione in caso di
giudizio davanti al giudice amministrativo. In effetti, se la decisione dipende da particolari conoscenze
tecniche, il giudice, in ossequio al principio della separazione dei poteri, non potrà sostituirsi
all’amministrazione nel valutare la specifica posizione del privato, come invece accede – lo si è visto –
nel caso della attività amministrativa vincolata.
Così, se un aspirante avvocato viene bocciato all’esame di abilitazione e questi ricorre al T.a.r. per ottenere
l’annullamento del provvedimento negativo, il giudice non potrà verificare se il ricorrente fosse davvero preparato
oppure no. Questa valutazione è riservata all’amministrazione, che a tal fine si è avvalsa dell’opera di esperti (la
commissione dell’esame da avvocato è composta da avvocati, magistrati e docenti universitari in materie
giuridiche). Semmai, il giudice potrà verificare il corretto svolgimento della prova: legittima costituzione della
commissione esaminatrice, rispetto dei tempi, pertinenza dei temi di esame, ecc. Se un aspirante guidatore è stato
165
bocciato all’esame per il conseguimento della patente (che è un atto amministrativo), il giudice non potrà sedersi al
fianco del candidato per verificare di persona se è capace oppure no di guidare.
È bene, però, osservare che le più recenti riforme legislative sul giudizio amministrativo hanno,
tra l’altro, rafforzato i poteri dei giudici, così che il concetto di discrezionalità tecnica ha smarrito gran
parte della propria originaria configurazione garantistica a vantaggio dell’amministrazione. Basti
pensare all’ampliamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo che, a determinate condizioni,
può anche avvalersi dell’opera di periti, ossia di consulenti esperti nei vari settori.
Il potere amministrativo è di regola esercitato tramite un procedimento.
procedimento In quanto successione
regolare e ordinata di atti e operazioni tra loro coordinati, il procedimento è un istituto di garanzia per
il corretto e legittimo esercizio del potere amministrativo. Ciò risulterà ancora più chiaro quando ci si
occuperà della nozione di interesse legittimo.
Il procedimento amministrativo si articola nelle seguenti fasi:
a) fase dell
dell’
ll’istruttoria:
istruttoria il procedimento è avviato su iniziativa di un privato o di un’altra
amministrazione (iniziativa di parte) oppure su iniziativa della stessa amministrazione
decidente (iniziativa d’ufficio). Dell’avvio del procedimento occorre darne comunicazione
agli interessati, con l’indicazione del responsabile del procedimento stesso (ossia il
funzionario che seguirà la pratica, come si suol dire);
b) fase istruttoria:
istruttoria il responsabile del procedimento provvede alla acquisizione degli elementi
di fatto e di diritto necessari per prendere una decisione. A tal fine dispone di molteplici
strumenti previsti dall’ordinamento (→ poteri istruttori);
c) fase costitutiva:
costitutiva una volta acquisiti tutti gli elementi di conoscenza, l’autorità competente (un
organo monocratico, quale può essere un dirigente, o un organo collegiale, quale può
essere una commissione) prende la decisione. Al termine di questa fase, si avrà un atto
amministrativo perfetto, ma non ancora efficace;
d) fase integrativa dell’
dell’efficacia:
efficacia l’atto amministrativo perfetto diviene anche efficace (cioè in
grado di produrre validamente i propri effetti tipici) mediante operazioni che determinano
la conoscenza ufficiale dell’atto ai suoi interessati: notificazione, comunicazione,
pubblicazione.
La disciplina de procedimento amministrativo riposa sui seguenti princìpi:
1) di regola, obbligo di motivazione degli atti amministrativi;
2) minor aggravio possibile per i destinatari dell’atto, in termini di tempi e di sacrifici subiti;
3) trasparenza amministrativa, legata al principio di imparzialità e, dunque, sinonimo di
pubblicità, salvi i casi in cui le amministrazioni sono tenute al segreto;
4) diritto di accesso agli atti, quale modalità di realizzazione dell’interesse legittimo;
5) partecipazione degli interessati all’istruttoria, anche attraverso la presentazione di documenti
e di memorie;
6) contraddittorio tra i soggetti portatori dei diversi interessi coinvolti;
7) obbligo di conclusione del procedimento entro un determinato e perentorio termine.
termine
A proposito di termine, se l’amministrazione non provvede entro il termine stabilito dalle
relative discipline normative, e dunque non decide se accogliere o rigettare la domanda del privato
volta al conseguimento di un determinato atto amministrativo, allora si ha il silenzio della pubblica
amministrazione.
Contrariamente al detto comune secondo cui «chi tace acconsente», nel diritto amministrativo
opera il principio secondo cui «qui tacet utique non fatetur, sede tamen verum est non negare». Detto
in parole povere, l’amministrazione che tace è un’amministrazione inadempiente: non acconsente, né
respinge, ma semplicemente è inerte.
Pertanto, in questo ambito la regola è quella del silenziosilenzio-inadempimento.
inadempimento
166
Di fronte al silenzio-inadempimento il privato potrà rivolgersi al giudice amministrativo e questi,
una volta accertata l’inerzia della competente amministrazione, pronuncerà una sentenza con la quale
intimerà alla stessa di decidere entro un certo termine.
Si noti. Quando un privato si rivolge al T.a.r. contro il silenzio dell’amministrazione, non
chiede al giudice di intimare all’amministrazione di accogliere la sua domanda. Il privato ricorrente
chiede al giudice di riconoscere che c’è stato un inadempimento e che, dunque, la pubblica
amministrazione è costretta a decidere, in un senso o nell’altro.
Se, poi, l’amministrazione ignora la decisione del giudice e non decide entro il termine
perentorio stabilito nella sentenza, allora il giudice, nuovamente adìto dal privato, procederà a
nominare un commissario ad acta che si sostituirà all’amministrazione inadempiente nella assunzione
della decisione finale.
Ancora una volta, si faccia attenzione. Il giudice che riconosce questo ulteriore inadempimento
non determina l’accoglimento della domanda presentata a suo tempo dal privato ricorrente. Egli si
limita a nominare un soggetto estraneo all’amministrazione per decidere. Il commissario, che si
sostituisce all’amministrazione, potrà quindi anche respingere la domanda del privato e, dunque,
negare il provvedimento richiesto.
Si tenga presente che l’inadempimento dell’amministrazione può avere anche conseguenze
penali. Il codice penale prevede infatti il reato di omissione in atti d’ufficio, che però può dar luogo a
condanna del singolo funzionario responsabile solo se il pubblico ministero dimostra il dolo, e cioè
l’intenzione del funzionario stesso di non decidere entro il termine previsto.
Se il silenzio-inadempimento è la regola, vi sono però due eccezioni.
Queste eccezioni sussistono nei soli casi tassativamente previsti dalla legge.
a) SilenzioSilenzio-rigetto.
rigetto Se l’amministrazione non decide entro il termine stabilito, allora la
domanda del privato s’intende respinta. È il caso, importante, del ricorso gerarchico, sul
quale ci si soffermerà più avanti quando ci occuperemo dei rimedi contro gli atti illegittimi
della pubblica amministrazione.
b) SilenzioSilenzio-assenso.
assenso Decorso il termine stabilito dalla legge o dal regolamento, senza che
l’amministrazione abbia provveduto a decidere, allora la domanda del privato s’intende
accolta.
Si noti che il silenzio-assenso rientra tra gli istituti di semplificazione amministrativa.
amministrativa Invero, se
la legge dispone che, in caso di silenzio dell’amministrazione, il privato può svolgere quella attività (ad
esempio, un’attività economica) subordinata ad un atto amministrativo, allora si semplifica il rapporto
con i privati. Questi, infatti, non sono tenuti ad attivare il macchinoso e dispendioso meccanismo
giudiziario creato avverso il silenzio-inadempimento.
Un altro istituto di semplificazione è la denuncia di inizio attività.
attività Nei casi previsti, il privato può
immediatamente iniziare una data attività altrimenti subordinata ad un atto amministrativo, e
l’amministrazione ha a disposizione un lasso di tempo relativamente breve per eventualmente vietare
al singolo la continuazione di quell’attività. Decorso quel termine, il privato potrà considerarsi “al
sicuro”. Pochi anni fa, questo istituto è stato sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività
(s.c.i.a.), ma nella sostanza nulla è cambiato. Resta ferma la possibilità per l’amministrazione di
bloccare l’attività in oggetto, una volta decorso il predetto termine, solo esercitando i propri poteri di
autotutela (v. dopo). In questo caso, però, l’amministrazione dovrà fare i conti con il legittimo
affidamento vantato dal privato circa la prosecuzione dell’attività tacitamente assentita.
Gli atti amministrativi sono l’esito dell’esercizio di un potere amministrativo. Normalmente
hanno forma scritta, ma vi possono essere anche atti privi di tale attributo. A parte il caso del silenzioassenso, dapprima esaminato, si pensi agli atti posti in essere attraverso comportamenti concludenti o
per il tramite di oggetti. Nel primo caso, si pensi ad esempio al vigile urbano quando regola il traffico.
Nel secondo caso, e sempre in tema di circolazione stradale, si pensi ai colori del semaforo: il rosso
impone l’arresto dei veicoli, e tale imposizione non è che espressione di un potere amministrativo
della categoria degli ordini.
167
Nell’ambito degli atti amministrativi assumono un particolare rilievo, soprattutto nell’ambito
della costituzione economica, i provvedimenti amministrativi:
amministrativi in essi l’elemento qualificante è dato
proprio dalla manifestazione di volontà posta in essere dall’autorità competente.
I provvedimenti amministrativi hanno forma scritta e recano l’intestazione, il preambolo, la motivazione, il
dispositivo, la data, il luogo e la firma del funzionario.
I provvedimenti amministrativi possono avere portata negativa o positiva quanto all’incidenza
che essi hanno nel patrimonio giuridico del destinatario. Più precisamente:
- i provvedimenti sfavorevoli (o restrittivi) determinano un impoverimento del patrimonio
giuridico del destinatario. Si pensi, ad esempio, ad un provvedimento di espropriazione di
un terreno: a seguito di tale decisione, il destinatario si vedrà privare di un bene immobile
che era di sua proprietà (altri esempi sono gli ordini, le occupazioni, le requisizioni, le
sanzioni amministrative);
- i provvedimenti favorevoli (o ampliativi),
ampliativi) invece, arricchiscono il destinatario, conferendo
loro beni o facoltà in precedenza non sussistenti.
Tra i provvedimenti favorevoli che più interessano la costituzione economica, vale al pena
ricordare:
- le concessioni:
concessioni in questo modo il privato acquista un diritto che in precedenza non aveva (è
già stato fatto in precedenza l’esempio della concessione per uno stabilimento balneare);
- le autorizzazioni:
autorizzazioni il provvedimento amministrativo rimuove un ostacolo al legittimo
esercizio di un diritto di cui il destinatario è già titolare. Si pensi, ad esempio, ad una licenza
di commercio. Il privato è già titolare del diritto di iniziativa economica (→ art. 41 Cost.), la
il legislatore ha ritenuto necessario subordinare l’esercizio concreto di tale diritto ad uno
specifico atto amministrativo, per tutelare l’interesse generale allo sviluppo adeguato del
sistema economico. O, ancora, per costruire una casa occorre ottenere una autorizzazione:
per garantire l’interesse generale al corretto e razionale sfruttamento dell’assetto urbanistico
il legislatore ha deciso di subordinare il concreto esercizio di edificare ad un apposito
provvedimento amministrativo, benché in astratto il proprietario di un terreno, in quanto
tale, sia già titolare dello ius edificandi.
- le sovvenzioni:
sovvenzioni con questi provvedimenti l’amministrazione concede incentivi o aiuti
economici sotto forma di contributi alle imprese.
Si parla di patologia dell’atto amministrativo quando questo è affetto da vizi che ne
compromettono l’attitudine ad esplicare la funzione tipica.
Nel linguaggio tecnico, per patologia s’intende l’invalidità
invalidità dell’atto amministrativo, come
deviazione dallo schema generale prefigurato dal diritto oggettivo.
In questo ambito si distingue tra:
a) inesistenza (o nullità),
nullità) nel senso che l’atto amministrativo è privo degli elementi costitutivi
essenziali necessari perché possa essere riconosciuto come tale dal punto di vista giuridico.
Si pensi, ad esempio, ad una licenza di commercio emanata dal giudice di pace di Pavia. L’atto materialmente
esiste, ma è radicalmente inesistente in quanto adottato da un organo – il giudice di pace – del tutto estraneo dalla
pubblica amministrazione. Oppure si pensi ad una autorizzazione costruire un villa sul pianeta Giove o sul pianeta
Kubrakstwedzali: nel primo caso l’oggetto è (attualmente) impossibile, nel secondo l’oggetto è (attualmente)
inesistente.
b) illegittimità (o annullabilità),
annullabilità) che ricorre quando un atto amministrativo, pur “esistente”
giuridicamente nel senso prima chiarito, non rispetta i requisiti, formali e sostanziali, di
validità e, quindi, può essere annullato.
Il diritto oggettivo individua tre vizi di illegittimità dell’atto amministrativo.
168
1) Violazione di legge:
legge si ha quando l’autorità amministrativa ha violato una norma giuridica (si
parla di “legge”, anche se in realtà questo vizio ricorre anche quando è violato un
regolamento). È in vigore una legge generale sul procedimento legislativo. Quando una sua
disposizione è violata si ha illegittimità dell’atto.
Ad esempio, se non è stato comunicato l’avvio del procedimento, o se non è stato designato il responsabile
del procedimento, o se l’atto è carente di motivazione, o se non è stato acquisito un parere prescritto dalla legge.
2) Incompetenza:
Incompetenza si ha quando l’atto è stato emanato dall’autorità incompetente. In effetti, il
diritto oggettivo attribuisce ogni singolo e specifico potere ad una determinata autorità
amministrativa, e solo a quella. Si hanno, quindi, imperative norme sulla competenza, che a
sua volta può essere per materia, per valore o per territorio.
Così, ad esempio, se un atto di competenza della Giunta comunale viene adottato dal Sindaco, o se un
provvedimento di competenza del Prefetto di Milano viene posto in essere dal Prefetto di Pavia.
3) Eccesso di potere: è questo il vizio tipico dell’attività amministrativa discrezionale. Non
esiste una definizione puntuale di eccesso di potere. Piuttosto, i giudici hanno nel corso
degli anni identificato una serie di figure sintomatiche di eccesso di potere. Così come tosse,
raffreddore, febbre alta, dolori articolari sono sintomi dell’influenza, in questo modo
identificata dal medico, analogamente grazie a questi sintomi il giudice riconosce un eccesso
di potere e, quindi, annulla l’atto impugnato. Senza ambizione di completezza, ecco alcune
figure sintomatiche:
- sviamento di potere: l’amministrazione ha agito per tutelare un interesse diverso da quello
sotteso allo specifico potere amministrativo;
- irragionevolezza: l’amministrazione ha preso una decisione priva di conseguenzialità logica
rispetto alle premesse, oppure ha assunto un atto che prevede una misura negativa
sproporzionata rispetto al fine da raggiungere, o non c’è congruenza tra obiettivo e mezzi
prescelti, o si tratta di una decisione arbitraria;
- ingiustizia manifesta: l’atto è aberrante, assurdo, privo di razionalità intrinseca;
- contraddittorietà tra atti: in situazioni sostanzialmente equivalenti l’amministrazione ha
deciso in maniera opposta;
- motivazione incongrua o carente: l’amministrazione ha sì rispettato l’obbligo di
motivazione, ma allega argomentazioni deboli, contraddittorie, ambigue;
- istruttoria inadeguata: il responsabile del procedimento non ha svolto una adeguata
istruttoria, tenuto conto della complessità della realtà destinata ad essere incisa dal
provvedimento finale;
- travisamento dei fatti: compiuta l’istruttoria, l’autorità procedente accede ad una
interpretazione erronea della realtà;
- violazione della prassi amministrativa, cioè di ciò che normalmente fa l’amministrazione in
determinati casi.
Di fronte ad un atto amministrativo affetto da invalidità, l’ordinamento giuridico contempla una
serie di rimedi.
rimedi
1) Autotutela amministrativa.
amministrativa È la stessa amministrazione pubblica ad attivarsi per porre
rimedio alla invalidità di un determinato atto. Essa, però, può attivarsi solo se allega uno
specifico interesse pubblico all’intervento sull’atto viziato. L’autotutela può, invero, risolversi
tanto nella eliminazione dell’atto viziato, quanto nella correzione dell’atto stesso. Nel primo
caso si ha, ad esempio, l’annullamento
annullamento d’
d’ufficio,
ufficio quando l’amministrazione elimina un atto
invalido per ragioni di legittimità. Oppure si ha revoca dell’atto, quando questo viene meno
per ragioni di opportunità. Nel secondo caso si ha, ad esempio, una ratifica quando
l’autorità competente conferma la decisione assunta dall’autorità incompetente.
169
2) Ricorsi amministrativi.
amministrativi In questi casi il privato, che ritiene di essere stato danneggiato da un
atto amministrativo asseritamente illegittimo, anziché agire in giudizio (v. dopo) si rivolge
all’amministrazione pubblica. Più precisamente, si hanno tre tipi di ricorsi amministrativi:
• ricorso gerarchico,
gerarchico quando il privato impugna l’atto davanti all’autorità amministrativa
gerarchicamente sovraordinata a quella che lo ha emanato. È necessario, quindi, che
vi sia un rapporto gerarchico o di sovraordinazione/subordinazione. Questo rimedio
è di carattere generale e può essere fatto valere solo per motivi di legittimità. In caso
di esito negativo o si silenzio-rigetto, il privato può rivolgersi al giudice competente o
esperire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (v. dopo);
• ricorso in opposizione:
opposizione nei soli casi tassativamente previsti dalla legge, il privato può
impugnare l’atto davanti alla stessa autorità che lo ha emanato;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Repubblica: esso vale solo contro gli atti
definitivi, è un rimedio di carattere generale, prevede un ruolo formalmente
consultivo ma sostanzialmente decisivo del ministero competente, ed è una misura
alternativa all’azione giudiziaria, nel senso che se si opta per questo rimedio non ci si
può poi rivolgere al giudice.
3) Ricorsi giurisdizionali.
giurisdizionali Nel nostro ordinamento avverso gli atti della pubblica
amministrazione opera il modello del doppio binario, nel senso che esistono due giudici
diversi davanti ai quali promuovere una azione: il giudice ordinario e il giudice
amministrativo (già descritti in precedenza). L’atto va impugnato davanti al giudice ordinario
se il privato è convinto di aver subito una lesione di un proprio diritto soggettivo. Invece,
l’atto va impugnato davanti al giudice amministrativo se il privato è convinto di aver subito
una lesione di un proprio interesse legittimo (su questa distinzione, v. dopo). Nel dubbio,
decide la Corte di cassazione a sezioni unite chi ha giurisdizione. In alcune materie in cui è
problematico distinguere tra diritti soggettivi e interessi legittimi (si pensi, ad esempio, ai
servizi pubblici), l’ordinamento contempla la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo,
amministrativo nel senso che la controversia deve sempre essere risolta dal T.a.r. in primo
grado e dal Consiglio di Stato in appello.
A questo punto della trattazione è bene sottolineare che la pubblica amministrazione non opera
soltanto attraverso l’esercizio di poteri. Può accadere, infatti, che nell’assolvimento dei propri compiti
istituzionali la pubblica amministrazione ricorra agli istituti e agli strumenti del diritto privato. In
questi casi si è soliti parlare di attività consensuale della pubblica amministrazione.
Ricorrendo determinate condizioni la pubblica amministrazione, anziché adottare un atto
imperativo e unilaterale, può concludere un accordo con il privato interessato. Una volta concluso
tale accordo, il regime applicabile sarà di regola quello definito dalle regole di diritto privato. Così, ad
esempio, anziché adottare un provvedimento amministrativo di espropriazione, l’autorità competente
può concludere un accordo con il soggetto interessato, il quale potrà beneficiare di un trattamento più
favorevole in termini di ristoro economico per la perdita subìta.
Più in generale, le pubbliche amministrazioni ricorrono agli strumenti del diritto privato
quando devono acquisire beni o servizi da privati: si pensi, ad esempio, alle pulizie degli uffici o alla
ristrutturazione degli immobili, o alla fornitura di strumenti quali computer, materiale di cancelleria, e
così via.
In questi frangenti la pubblica amministrazione si avvicina parecchio al privato, quanto a
modalità giuridiche di acquisizione di beni o prestazioni: così, se si tratta di ristrutturare l’immobile in
cui ha sede una determinata amministrazione, questa stipula un contratto d’appalto con un’impresa
privata, che provvederà, dietro compenso, ad effettuare i lavori richiesti.
Tuttavia, e qui emerge con nettezza la specificità dell’attività negoziale di diritto privato della
pubblica amministrazione, mentre un privato è libero di scegliere la controparte contrattuale, per gli
enti pubblici non è così. In effetti, le amministrazioni pubbliche operano per il soddisfacimento di
interessi generali e, in quanto tali, sono soggette al rispetto della legge. Si è detto prima che le
170
amministrazioni non godono mai di libertà, ma semmai di autonomia e discrezionalità. Inoltre, le
amministrazioni pubbliche sostengono i costi derivanti dalla conclusione di contratti di diritto privato
attingendo a risorse pubbliche, costituite principalmente dalle entrate tributarie (i cd. “soldi del
contribuente”). Tutto ciò impone una particolare cautela nella individuazione della controparte
contrattuale, per evitare scelte inefficienti, diseconomiche e, soprattutto, parziali.
Non è superfluo rammentare i numerosi vantaggi che una impresa privata acquisisce, in termini
economici, quando “vince un appalto” con la pubblica amministrazione. In altri termini, per una
impresa privata è estremamente proficuo stipulare un contratto d’appalto con lo Stato o con altri enti
pubblici: per la mole di lavoro, per il guadagno, per le possibilità di ritoccare in corso d’opera il
prezzo del lavoro svolto o del servizio erogato. M al’amministrazione pubblica, come si è visto, deve
essere imparziale, e deve quindi evitare favoritismi a favore di alcuni soggetti imprenditoriali a danno
di altri.
A ciò si aggiunga che il diritto dell’Unione europea si è dimostrato molto sensibile al tema dal
momento che uno dei suoi pilastri è la libera concorrenza.
concorrenza I legislatori nazionali devono, quindi,
disciplinare l’attività di diritto privato delle pubbliche amministrazioni in modo tale da favorire la
competizione tra tutte le imprese, anche di altri paesi dell’Unione europea, che avrebbero interesse e
chances di vincere un appalto con una pubblica amministrazione.
Per realizzare questo obiettivo, la normativa comunitaria e quella italiano hanno eretto a regola
la cd. evidenza pubblica.
pubblica Nella individuazione del contraente le pubbliche amministrazioni devono
attivare una procedura concorsuale finalizzata alla scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa:
una gara pubblica o una licitazione privata. Ciò che conta è che si svolga una sorta di asta grazie alla
quale le imprese concorrenti hanno la possibilità di fare la loro offerta, in segreto, in vista della
pubblica selezione del vincitore. Soltanto per i contratti che, dal punto di vista economico, non
superano una certa soglia in euro, l’amministrazione può, con trattativa privata, scegliere l’altro
contraente senza indire una competizione pubblica.
Una volta individuato il contraente, la pubblica amministrazione stipula il contratto e ad esso si
applicheranno le norme del diritto privato.
Questa succinta ricostruzione dell’attività di diritto privato della pubblica amministrazione è la
premessa per passare all’argomento successivo, di grandissima rilevanza nell’ambito della costituzione
economica: i servizi pubblici.
I servizi pubblici
Si parla correntemente di fallimenti del mercato in due casi:
- quando la libertà di mercato conduce alla creazione di monopoli o, comunque, di cartelli
discorsivi della concorrenza, con conseguente aumento dei prezzi e minore attenzione verso la qualità
dei prodotti;
- quando le imprese, che coltivano per definizione l’ambizione a massimizzare il profitto
(dunque, a rendere più ampio possibile il divario tra ricavi e costi) non hanno interesse a produrre
determinati beni o a erogare determinati servizi, trattandosi di prodotti o prestazioni immessi nel
sistema economico a prezzi ampiamente inferiori a quelli derivanti dall’incontro tra domanda e
offerta.
In questi casi il mercato fallisce in quanto non riesce a garantire la condizione di equilibrio
ottimale tra domanda e offerta. E fallisce in quanto si tratta di beni e servizi ritenuti meritevoli di
acquisizione generalizzata da parte dei consumatori e degli utenti.
L’accesso universale a tali beni e servizi esige che il prezzo del bene o la tariffa del servizio siano
così bassi da consentirne l’acquisizione anche agli individui che versano in condizioni di svantaggio
economico.
Perché è così importante garantire l’accesso a tali beni e servizi da parte dei ceti più deboli della
società ?
Dal punto di vista giuridico la risposta è molto semplice: è la Costituzione ad imporlo.
171
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2). Tutti sono eguali
davanti alla legge (art. 3, primo comma). Le istituzioni sono tenute a rimuovere gli ostacoli economici
e sociali che impediscono il pieno sviluppo della personalità e l’effettiva partecipazione alla vita
comunitaria (art. 3, secondo comma).
Non basta l’astratto riconoscimento dei diritti fondamentali a tutti: è necessario creare le
condizioni per renderne effettivo l’esercizio. Perché ciò accada è indispensabile acquisire determinati
beni o servizi. Così, per rendere effettivo l’esercizio della libertà di circolazione è necessario garantire
i trasporti. Per rendere effettivo l’esercizio della libertà di domicilio è necessario garantire l’accesso di
tutti ad una abitazione. Per rendere effettivo l’esercizio del diritto allo studio o il diritto alla salute è
indispensabile ricorrere a percorsi formativi o a percorsi terapeutici gestiti da insegnanti o da medici.
E gli esempi potrebbero essere ancora tanti.
Tuttavia, l’imprenditore privato, vigendo le ferree regole di mercato, non avrebbe alcun
interesse a erogare un servizio di trasporto a tariffe decisamente inferiori a quelle che sarebbero
secondo le dinamiche competitive del mercato, specie se si tratta di collegare piccoli centri montani o
comunque assai distanti dai principali centri urbani. Così, il mercato immobiliare garantisce la
possibilità di affittare un appartamento, ma il canone di locazione di mercato non è accessibile a chi
vive in condizioni di indigenza. Quale imprenditore sensato deciderebbe di erogare il servizio
scolastico sapendo che ai ceti più indigenti la Costituzione impone di fornirlo gratuitamente ? E lo
stesso vale per il servizio sanitario.
Pertanto, in uno Stato sociale di diritto come il nostro, basato sui princìpi costituzionali
dapprima evocati, le istituzioni sono giuridicamente obbligate a prendersi carico dei problemi di
allocazione e distribuzione di beni e servizi associati ai fallimenti del mercato. Posto che tali prodotti e
prestazioni sono correlati all’effettivo esercizio dei diritti fondamentali (il che li rende meritevoli di
acquisizione universale), allora a ciò provvedono le pubbliche istituzioni tramite i servizi pubblici.
pubblici
Le amministrazioni si occupano, dunque, di funzioni e di servizi pubblici. In relazione alle
prime, ciò che rileva è la manifestazione di volontà culminante in un atto connesso alla tutela di un
interesse generale. In relazione ai secondi, ciò che rileva è lo svolgimento di attività tese alla fornitura
di prodotti o di prestazioni.
Il rilascio di una autorizzazione, di una concessione, di un certificato o lo svolgimento di un’attività di
controllo magari culminante in una sanzione sono tutte espressioni di una funzione pubblica. I trasporti, le
telecomunicazioni, il gas, l’acqua, l’energia elettrica, sono esemplificazioni di servizi pubblici.
Ora, secondo la concezione soggettiva «costituiscono servizio pubblico le attività rivolte a
produrre utilità per la comunità, quando il loro stesso svolgimento e le relative modalità sono
determinati dalle decisioni regolative delle istituzioni pubbliche e non dalla spontanea azione e dalle
spontanee convenienze del mercato» (G. FALCON, Lezioni di diritto amministrativo. I) L’attività, II
ed., Cedam, Padova, 2009, 191). Questa definizione pone l’accento sul soggetto pubblico che
provvede.
Secondo, invece, la concezione oggettiva,
oggettiva è servizio pubblico ogni attività volta a soddisfare
esigenze essenziali della comunità, indipendentemente dal soggetto protagonista di tale attività.
Atteso che queste due concezioni possono considerarsi, volendo, due facce della stessa
medaglia, ciò che interesse di più in questa sede è la descrizione delle modalità di gestione dei servizi
pubblici.
Le correnti modalità di gestione si collocano tra due estremi:
- la gestione diretta da parte della stessa pubblica amministrazione (cd. gestione in house);
- la gestione privata,
privata ossia direttamente da parte di imprese private.
Tra questi due estremi, si hanno diverse modalità di gestione:
- per i servizi elementari si confida sull’ordinaria organizzazione amministrativa e si parla di
gestione in economia;
economia
- per i servizi più complessi si adottano diverse formule organizzative:
172
* per i servizi che richiedono una organizzazione imprenditoriale dominante in
passato si ricorreva alla azienda speciale
speciale,
ciale ossia una struttura dedicata, incardinata presso
una determinata pubblica amministrazione. Oggi si predilige la gestione attraverso una
totale;
società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria o totale
* oggi, però, si predilige la gestione mediante affidamento del servizio ad un
soggetto esterno alla pubblica amministrazione, che viene scelto tramite gara pubblica. Lo
strumento a tal fine adoperato è quello della concessione di pubblico servizio.
servizio In epoca
più recente, alla concessione è subentrato l’affidamento
affidamento,
affidamento al fine di ridimensionare la
connotazione pubblicistica propria della concessione a vantaggio della sua configurazione
contrattuale (dal diritto pubblico al diritto privato);
* in ambito locale esiste anche l’istituzione
istituzione,
istituzione quale organismo strumentale dell’ente
locale per l’erogazione di servizi sociali, ossia privi di carattere imprenditoriale;
* altri servizi, particolarmente complessi in quanto s’intrecciano atti e prestazioni, si
ricorre a formule organizzative diversificate: si pensi ai servizi di istruzione (le scuole, le
università), o ai servizi sanitari (le aziende ospedaliere, le aziende sanitarie locali).
Ricapitolando. La gestione dei servizi pubblici può aver luogo:
a) a mezzo di terzi tramite concessione (oggi affidamento). Il concessionario di pubblico servizio
svolge l’attività economica sulla base di un contratto stipulato con l’amministrazione e trae la propria
remunerazione dalle tariffe pagate dagli utenti. Se i ricavi non sono sufficienti, allora ha luogo una
compensazione attraverso finanziamenti erogati dall’amministrazione concedente. La scelta del
concessionario deve avvenire tramite gara, informata a princìpi di trasparenza e imparzialità;
b) tramite l’in house providing. La gestione del servizio è devoluta ad una organizzazione
appartenente all’ente che ne è responsabile. Visto che tale modello entra in tensione con il principio
della concorrenza, la vigente normativa esige che sussistano le condizioni che permettano di
considerare la struttura esterna come facente parte dell’organizzazione dell’ente pubblico, in una
posizione non dissimile da quella degli ordinari organi e uffici in cui si articola quell’ente (si pensi, ad
esempio, ad una società per azioni a totale partecipazione comunale).
Secondo la relativa direttiva comunitaria ricorre questo modello gestionale quando risultano soddisfatte
tutte le seguenti condizioni: a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona
giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80 % delle
attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati
dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore controllante o da altre persone giuridiche controllate
dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata
non vi è alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati
che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei
trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
c) tramite società miste.
miste Se l’impresa è esercitata da una società commerciale a capitale pubblico
e privato, è mista la società in cui è socio l’ente pubblico che ha la responsabilità del servizio (→
partenariato pubblico-privato).
Ora, per un adeguato e ricco approfondimento del tema dei servizi pubblici si rinvia al
commento redatto da A. Lucarelli, in merito all’art. 43 Cost., non prima di aver ricordato che
secondo questa disposizione «a fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o
trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di
lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici
essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente
interesse generale».
A. LUCARELLI, Commento all’art. 43, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario
alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 883 ss.
173
…
2. Commento
2.1 I principali orientamenti della dottrina
In dottrina, il primo nodo che emerse dall’interpretazione ed attuazione dell’art. 43 Cost., si pose in
merito alla contrapposizione tra concezione oggettiva e concezione soggettiva del servizio pubblico.
Tale dualismo, apparentemente di portata solo teorica, in realtà, riguardava il modello di Costituzione
economica ed in particolare la natura e la funzione della categoria dei servizi pubblici. Una parte della dottrina
sosteneva l’esistenza di una categoria di servizi pubblici tanto ampia da comprendere accanto alle attività
economiche assunte e gestite da soggetti pubblici, anche altre attività (economiche) private rientranti nei
programmi di settore.
Altro orientamento dottrinario costruiva una tesi restrittiva della categoria di servizio pubblico,
sostenendo la natura pubblica soltanto per i servizi assunti direttamente dalla pubblica amministrazione,
evidenziando come la gestione dei servizi pubblici essenziali, non solo potesse restare nelle «mani» private, ma
addirittura potesse essere da loro meglio gestita. Si osservava come i privati potessero essere assoggettati, in
merito al servizio prestato, ad una disciplina non diversa da quella prevista per l’attività economica pubblica di
cui all’art. 41 Cost.
Il dibattito dottrinario si concentrava, dunque, in prevalenza sul ruolo dello Stato nelle attività
economico-produttive e sul rapporto intercorrente tra impresa pubblica e impresa privata. Irrilevante rimaneva
la posizione relativa ai diritti degli utenti.
Per Pototschnig, con una visione lungimirante, la riserva in favore dello Stato ed il monopolio pubblico
di servizi essenziali sarebbero stati costituzionalmente legittimi, per fini di utilità generale, soltanto nei casi in
cui si fosse dimostrata infruttuosa l’esperienza di una gestione sostenuta dalla libera iniziativa degli operatori
privati. In coerenza con le scelte di fondo della Costituzione economica, andava ricercato un punto di
equilibrio tra ruolo «attivo» dello Stato e riconoscimento e garanzia delle attività economiche dei privati. In
questo senso, l’azione dello Stato avrebbe assunto una portata sussidiaria rispetto alla iniziativa dei privati. La
valenza originaria della disposizione, in una logica di politica economica dirigista, consisteva nel porre limiti
all’intervento autoritativo dello Stato nell’economia, ma contestualmente a legittimare poteri di intervento.
Interpretazioni differenti tendevano a valorizzare il ruolo dello Stato, sottolineando gli aspetti garantisti
ed interventisti della disposizione. La nozione di utilità generale avrebbe determinato garanzie per il privato e
per il pubblico. Secondo tale orientamento, l’utilità generale, che legittimava, nella sua idea originaria,
interventi eccezionali ed il ricorso a strumenti autoritativi, quali la sostituzione della «mano pubblica» ai privati
imprenditori, non coincideva unicamente con l’interesse economico della collettività, teso ad evitare la
costituzione di monopoli privati, ma si allargava anche alla protezione di interessi diversi. In sostanza, l’utilità
generale si identificava con la protezione diretta dei principi generali enunciati nell’art. 3, 2° co., Cost., nella
presa d’atto che il pubblico potere dovesse rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale all’eguaglianza
e comunque assicurare che certi bisogni della popolazione fossero soddisfatti. La titolarità pubblica dei servizi,
in settori protetti, nasceva dal dovere-potere di fornire a tutti i cittadini le prestazioni ritenute necessarie per
soddisfare, ad eguali condizioni, bisogni a corrispettivi moderati. In ogni caso, affinché la presenza dei servizi
pubblici si potesse estendere legittimamente in un nuovo settore, era necessaria una legge a giustificarla.
Nell’ambito del rapporto pubblico-privato, parte della dottrina conferiva, dal punto di vista politico-economico,
all’art. 43 Cost. una forza riformatrice, in linea con lo schema europeo occidentale del dopoguerra ed in
omogeneità con le altri componenti del sistema.
Come vedremo nei paragrafi successivi, in particolare nel paragrafo relativo alla «europeizzazione» dei
servizi pubblici, si verifica dall’inizio degli anni novanta un totale ripensamento delle costruzioni teoriche.
L’applicabilità dell’art. 43 Cost., in particolare per quanto attiene all’adozione di riserve pubbliche nella
titolarità e gestione dei servizi pubblici, viene misurata in relazione al rispetto della regola comunitaria della
concorrenza. Le teorie soggettive ed oggettive dei servizi pubblici perdono di attualità, così come non è più
rilevante se il servizio sia prestato da un soggetto pubblico o privato. Le teorie aventi ad oggetto la
trasformazione dei servizi pubblici si snodano nell’ambito di rapporti di natura orizzontale che coinvolgono i
poteri pubblici, nella qualità di soggetti regolatori, il mercato, luogo dove si svolge in regime di concorrenza
l’attività dei privati, e gli utenti, quali soggetti operanti in condizione di potere di mercato o contrattuale
orientati naturalmente al perseguimento dello scopo di lucro. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale, i
174
nuovi assetti istituzionali e socio-economici non consentono più all’interprete di ragionare con vecchie
categorie, l’approccio dogmatico-formalista va appunto ad essere sostituito da una dimensione nuova che si
sofferma in particolare sulla riduzione dei prezzi e sull’aumento della qualità.
2.2 Le applicazioni della norma costituzionale
In premessa, va detto che già in epoca pre-costituzionale, sussisteva il monopolio pubblico delle
comunicazioni, regolato dal codice postale del 1936. Successivamente, i servizi postali e di comunicazione
venivano sottoposti, dal d.p.r. 156/1973, a riserva originaria ai sensi dell’art. 43 Cost. Il codice del 1973
ribadiva che i servizi postali, telegrafici e di telecomunicazioni dovessero essere riservati allo Stato ed essere
esercitati soltanto dall’amministrazione o mediante concessione.
Nell’ambito delle dinamiche socio-economiche sviluppatesi nel nostro Paese, va detto che l’art. 43 Cost.,
seppur in settori strategici dell’economia, è stato poco utilizzato. I casi più noti di applicazione della norma
sono la introduzione della riserva per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi nella pianura
padana a favore dell’Eni, disposta con la l. 136/1953 e la nazionalizzazione della energia elettrica, disposta con
la l. 1643/1962, con la quale si nazionalizzava tutto il settore, dalla produzione alla distribuzione della energia
elettrica, espropriando le imprese relative e trasferendole all’Enel, un ente appositamente costituito.
Con l’istituzione dell’Eni si intendeva promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nel campo
degli idrocarburi e dei vapori naturali. L’ente nasce come ente autonomo di gestione, titolare di una serie di
società caposettore, dalle quali dipendono le società operative. Esso veniva successivamente sottoposto con l.
1589/1956 al potere di vigilanza e direzione delle partecipazioni statali. Successivamente, attraverso una serie di
interventi normativi, si istituiva una riserva in suo favore, da esercitare attraverso società controllate a capitale
integralmente pubblico, della ricerca e coltivazione di idrocarburi in determinate zone del territorio nazionale,
comprese le piattaforme marine e dello stoccaggio sotterraneo nei relativi giacimenti. La distribuzione del gas
naturale continuava ad essere assoggettata alla disciplina generale dei servizi pubblici locali, in quanto la riserva
non determinava una espropriazione di imprese private, rimanendo limitata alla fonte di energia.
Con la nazionalizzazione dell’energia elettrica si procedeva alla espropriazione delle imprese operanti
nel settore, ad eccezione delle aziende municipalizzate e delle imprese autoproduttrici. All’Enel, ente pubblico
economico, al quale veniva attribuita una capacità generale di diritto privato, sottoposto tuttavia ad una
direzione ed un controllo diretto del governo, veniva riconosciuta la riserva dell’attività di produzione,
importazione, esportazione, trasporto e distribuzione24. Come affermato esplicitamente nell’art. 1, 3° co., l.
1643/1962 «ai fini di utilità generale l’ente nazionale provvederà alla utilizzazione coordinata e al
potenziamento degli impianti allo scopo di assicurare con minimi costi di gestione una disponibilità di energia
elettrica adeguata per quantità e prezzo alle esigenze d’un equilibrato sviluppo economico del paese».
Altro settore al quale veniva applicato l’art. 43 Cost. era quello radiotelevisivo. In merito al monopolio
pubblico del settore radiotelevisivo determinato, sulla base degli artt. 21, 33, 41 e 43 Cost., dagli artt. 1 e 168,
n. 5, Codice PT approvato con r.d. del 27 febbraio 1936 (come modificati dal d.p.r. n. 156 del 29 marzo 1973
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni») si sosteneva che data la limitazione di fatto dei canali disponibili, la televisione si
caratterizzasse come attività predestinata quanto meno all’oligopolio. Dalla limitatezza dei canali, e quindi dal
pericolo del formarsi di oligopoli privati, si desumeva il riconoscimento della esistenza di ragioni di utilità
generale idonee a giustificare l’avocazione in esclusiva, ai sensi dell’art. 43 Cost., di tali servizi allo Stato. In
sostanza, in un siffatto scenario economico, caratterizzato dalla scarsezza delle risorse e dei mezzi tecnologici,
lo Stato avrebbe garantito più favorevoli condizioni di obiettività, imparzialità, completezza e continuità in tutto
il territorio nazionale. Questo orientamento, come si vedrà nella parte relativa alla giurisprudenza,
successivamente muterà, ritenendosi legittima la riserva allo Stato del servizio radiotelevisivo soltanto in
specifici casi.
2.3 La legislazione nazionale di riferimento
Con la Costituzione del 1947, ed in particolare sulla base dell’art. 43 Cost., veniva istituito nel 1953
l’Eni, l’Ente nazionale idrocarburi, per la gestione, in regime di esclusiva, della ricerca e della coltivazione dei
giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi. Con la l. 1589/1956 si istituiva il Ministero per le partecipazioni
statali. Il numero degli enti di gestione si ampliava con l’istituzione dell’Enel e della Efim nel 1962. La
nazionalizzazione dell’energia elettrica costituiva l’unico esempio di attuazione della riserva originaria ex art. 43
Cost. In dottrina, si è parlato più che di nazionalizzazione, di pubblicizzazione, con il trasferimento delle
175
imprese elettriche dai privati ad un ente pubblico appositamente costituito, in favore del quale veniva disposta
la riserva originaria, precludendo alle società espropriate l’esercizio dell’impresa elettrica.
Successivamente, l’art. 43 Cost., in merito alla nozione di servizi pubblici, trovava un equivalente
nell’espressione comunitaria «imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico-generale», di
cui all’art. 86 TCE, che sottoponeva anche tali imprese alla regola della concorrenza, nei limiti in cui
l’applicazione di tali norme non fosse ostativa all’adempimento della specifica missione loro affidata. La
disposizione comunitaria trovava recepimento nell’art. 8 della l. 287/1990, in base al quale la regola della
concorrenza si estendeva anche alle imprese pubbliche titolari della gestione di servizi di interesse economicogenerale. Tale regola trovava dunque un fondamento giuridico diretto nell’ordinamento italiano, con il limite
delle eccezioni previste in ambito comunitario. Sulla compatibilità dell’art. 43 Cost. con l’evoluzione normativa
statale e comunitaria ed interna in tema di concorrenza, si esprimeva, seppur non in via diretta, l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato con segnalazione del 28 ottobre 1998: «Misure di revisione e
sostituzione di concessioni amministrative». L’Authority sottolineava, in particolare, come l’istituto della
concessione avesse favorito la riserva di impresa a pubblici poteri, fondata sull’art. 43 Cost. Tale istituto, dal
quale sarebbero derivate due rilevanti distorsioni della concorrenza, quali la restrizione discrezionale
dell’accesso al mercato come regola e la posizione privilegiata delle imprese concessionarie, secondo
l’Authority, dovrebbe gradualmente scomparire a seguito degli interventi comunitari e nazionali di
liberalizzazione dei mercati. Successivamente, per favorire lo sviluppo della concorrenza all’interno di un
mercato regolato, il legislatore, oltre all’istituzione dell’antitrust, ha previsto apposite autorità di settore,
contemplate dall’art. 1, l. 474/1994. Su questa base, la l. 481/1995 ha dettato norme generali sui servizi
pubblici e sui poteri attributi alle autorità, disciplinando immediatamente l’Autorità per l’energia elettrica e il
gas. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni veniva istituita successivamente con la l. 249/1997. Tuttavia,
come osservato in dottrina, oggetto della regolazione non era soltanto la introduzione della regola della
concorrenza e dei principi di un mercato libero, ma anche la definizione di regole di comportamento destinate
alle imprese erogatrici per il conseguimento dell’interesse della collettività. In estrema sintesi l’obiettivo era
quello di migliorare il rapporto tra servizi pubblici e diritti degli utenti.
Nel triennio 1997-2000, tutte le discipline di settore venivano radicalmente riformate, l’istituto societario
si poneva quale unico modello di gestione, anche nei servizi pubblici locali, ed il regime della riserva di cui
all’art. 43 Cost., risultava ormai superato, oltre che inapplicabile. In merito agli interventi settoriali più
significativi avutisi con l’avvio del processo di liberalizzazione, tesi ad eliminare situazioni di monopolio e di
riserve si segnalano: il d.lg. 261/1999 relativo ai servizi postali; il d.lg. 79/1999 relativo al mercato elettrico che
liberalizza il settore, ad eccezione delle attività di trasmissione, volte all’utilizzazione e all’esercizio degli
impianti di produzione e di trasmissione per i quali sussistono condizioni di monopolio naturale, assoggettate a
riserva ed affidate in concessione; il d.p.r. 146/1999 relativo al sistema ferroviario; il d.lg. 164/2000 relativo alla
liberalizzazione nel settore del gas.
In conclusione, settori economici storicamente protetti sono ormai liberalizzati ed importanti pacchetti
azionari sono posti sul mercato. L’art. 43 Cost. perde di effettività, ad eccezione dei c.d. monopoli naturali.
Tuttavia i venti delle privatizzazioni e della liberalizzazione del mercato, al passaggio del nuovo secolo,
sembrano perdere di intensità. Alcuni segmenti di mercato restano in regime di concessione, l’apertura del
mercato dal punto di vista formale non porta ad una concorrenza effettiva. In questo scenario incerto e
confuso, il presidente dell’autorità garante della concorrenza e del mercato, nella sua relazione annuale (2004),
ha chiaramente affermato che le nostre utilities, facendo in particolare riferimento all’Eni ed all’Enel, sono
nella sostanza monopoli privati, che hanno posto in essere comportamenti censurati come abusi di posizione
dominante. L’Antitrust ha dovuto ammettere prezzi troppo alti in bolletta, concorrenza inesistente, collusioni,
conflitti di interesse, evidenziando come una posizione nazionale dominante non garantisce alcuna capacità di
concorrere a livello internazionale.
Secondo parte della dottrina e anche secondo l’Antitrust, la soluzione sarebbe quella di accelerare sulla
strada delle liberalizzazioni, secondo altri sarebbe opportuno mettere un freno. Tuttavia, va detto che la stessa
Antitrust ha sostenuto la necessità che le reti dei servizi, su cui viaggiano la corrente, il gas, i telefoni, i treni,
fossero mantenute in mano pubblica.
Infine occorre ricordare che con l’art. 4 della l. 350/2003 (finanziaria 2004), si conferma l’istituto della
golden share, adeguandolo semplicemente alla giurisprudenza comunitaria, bloccando di fatto la dismissione
delle imprese pubbliche. In questa fase di ripensamento dell’applicazione della regola della concorrenza alle
public utilities, nella quale si tende a riaffermare i privilegi dei poteri pubblici nell’economia, si leggono alcuni
interventi legislativi che stanno determinando una erosione dei poteri delle autorità di regolazione,
176
minacciandone la loro indipendenza. Si fa riferimento alla l. 66/2001, al d.l. 193/2002, convertito con l.
238/2002, al d.lg. 259/2003.
2.4 Principali orientamenti della giurisprudenza costituzionale
La giurisprudenza costituzionale degli anni sessanta si caratterizzava nel legittimare la nazionalizzazione
dell’energia elettrica e più in generale le riserve ed i monopoli in favore dello Stato.
La Corte legittimava il monopolio pubblico nel settore radiotelevisivo, sostenendo che data la limitatezza
di fatto dei canali disponibili, si trattasse di un’attività predestinata in regime di libero mercato a divenire
ostaggio di oligopoli privati e dichiarava la legittimità costituzionale della nazionalizzazione dell’energia elettrica,
ai sensi dell’art. 43 Cost. Nella sentenza, tuttavia, la Corte evidenziava che la legge di riserva non potesse
predisporre mezzi inidonei o contrastanti con lo scopo che il servizio doveva perseguire. In tal senso, si
limitava la discrezionalità del legislatore, riconducendo la sua azione nell’ambito dei principi e degli scopi fissati
dall’art. 43 Cost.; sostenendo la necessità che la legge relativa al trasferimento o alla riserva di determinate
imprese alla mano pubblica definisse il modello organizzativo necessario per rendere la nuova gestione
rispondente ai fini di utilità generale.
Nel 1974, sempre in merito al settore radiotelevisivo, la Corte costituzionale, in due pronunzie, mutava
il precedente orientamento, ponendo le basi per i successivi processi di liberalizzazione. In particolare, nella
prima delle due sentenze si affermava che il monopolio statale nel settore radiotelevisivo potesse ritenersi
legittimo soltanto se il suo esercizio fosse disciplinato in modo da garantire, da un lato la obiettività e la
completezza della informazione, dall’altro il diritto di accesso nella misura massima consentita dai mezzi
tecnici. Con la seconda sentenza si liberalizzavano le trasmissioni televisive via cavo a carattere locale.
Infine, la Corte costituzionale liberalizzava definitivamente l’attività radiotelevisiva privata limitatamente
all’ambito locale, nella considerazione che l’aumento della disponibilità di frequenze ed i costi meno elevati,
avrebbero evitato il rischio della formazione di oligopoli privati.
Il processo di liberalizzazione nei settori protetti procedeva negli anni ottanta, attraverso la
giurisprudenza della Corte, con significative pronunzie. Nel 1988 si disponeva l’illegittimità della esenzione
dell’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni da responsabilità per danni verso l’utente, per
contrasto con gli artt. 3 e 43 Cost., riducendo così le prerogative ed i «privilegi» dell’impresa pubblica. Tale
esenzione, in precedenza giustificata da una concezione puramente amministrativa del servizio postale,
risultava in contrasto con l’evoluta interpretazione dell’art. 43 Cost. che, secondo la Corte, istituendo uno
stretto collegamento tra la nozione di servizio pubblico essenziale e nozione di impresa, imponeva la
conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al diritto
privato.
Sulla medesima linea, si dichiarava incostituzionale, perché in contrasto con l’art. 3 Cost., l’art. 6 del
d.p.r. 156/1973, nella parte in cui disponeva che il concessionario del servizio telefonico non fosse tenuto al
risarcimento dei danni per l’interruzione dovuta a sua colpa. È un’altra sentenza che tende ad interpretare i
rapporti tra P.A. e privati in senso orizzontale, riducendo la portata dei poteri speciali della P.A., inducendo ad
un ripensamento del classico modello di Etat Administratif.
In relazione all’art. 41 Cost., ma con una diretta ed immediata relazione con l’art. 43 Cost., si colloca la
sentenza del 1991, nella quale si affermava che la regola della concorrenza fosse riconducibile ai principi
costituzionali.
I privilegi del servizio pubblico, in particolare per quanto attiene alle relazioni con gli utenti, si riducono
ulteriormente con l’intervento della Corte del 1994, che disponeva l’illegittimità, per violazione dell’art. 3
Cost., dell’art. 6 del d.p.r. 156/1973, nella parte in cui si escludeva, mediante il richiamo dell’art. 25 del d.m.
del 1930, la responsabilità del concessionario del servizio telefonico in caso di omessa o erronea indicazione
dell’utente nell’elenco degli abbonati. La Corte, confermando il precedente orientamento, affermava che il
concessionario di un servizio pubblico potesse essere assoggettato a disciplina speciale soltanto nel caso in cui
non si alterasse l’equilibrato componimento degli interessi nel rapporto di utenza.
Nel 1997 la Consulta confermava l’illegittimità dell’art. 6 del d.p.r. 156/1973, per violazione dell’art. 3,
1° co. Cost., nella parte in cui disponeva che l’amministrazione non fosse tenuta al risarcimento dei danni in
caso di colpevole ritardo nella rinnovazione di assegno postale, smarrito, distrutto o sottratto.
Infine, alla regola della concorrenza, con sentenza della Corte del 2004, veniva attribuito rango
costituzionale; allo Stato, in tema di regime delle competenze, era assegnata la funzione legislativa esclusiva in
materia di servizi pubblici locali, ritenendola «trasversale» in merito agli aspetti della concorrenza. Significativo
è che i servizi pubblici locali, classificati di rilevanza economica, trovino fondamento nella norma che tutela la
177
concorrenza ed in senso più ampio nel mercato concorrenziale, piuttosto che nell’art. 43 Cost., che
fisiologicamente è la norma che si occupa dei servizi pubblici.
Si tratta di un processo di liberalizzazione che oramai, al di là del diritto comunitario, ha una sua base
normativa nella l. 481/1995, che detta norme generali sulla disciplina dei servizi pubblici e sui poteri attribuiti
all’autorità. La legge mira a promuovere nei servizi pubblici essenziali la concorrenza e la efficienza, a garantire
adeguati livelli di qualità dei sevizi in condizioni di economicità, redditività, ad assicurare la loro diffusione e
fruizione in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.
In conclusione, la giurisprudenza della Corte sembra recepire i mutamenti che in Europa, per effetto
delle privatizzazioni e delle liberalizzazioni, indotte dal diritto comunitario, dall’inizio degli anni novanta,
hanno completamente modificato la disciplina dei servizi pubblici40. Il modello sembrerebbe, adesso, ruotare
intorno alle autorità di regolazione, pubblici poteri indipendenti dal governo, espressione di una attività di
regolamentazione e controllo, tale da assicurare, anche nell’ambito dei servizi pubblici essenziali,
l’introduzione ed il funzionamento della concorrenza, insieme al soddisfacimento dell’interesse degli utenti.
…
3.2 Il quadro sovranazionale. L’europeizzazione dei servizi pubblici: disciplina, limiti ed eccezioni
3.2.1 La prima fase: regola della concorrenza, servizi pubblici e disapplicazione dell’art. 43 Cost.
Il diritto comunitario, durante la fase della costruzione europea, ha praticamente ignorato la categoria
dei servizi pubblici. Soltanto l’art. 77 TCE, con la politica comune dei trasporti e l’art. 86 TCE, con la nozione
«servizi di interesse economico-generale», facevano riferimento, seppur sommariamente, ad essi. Lo scopo
originario del Trattato, come è noto, non era la regolamentazione dei servizi pubblici, nell’ambito di una
economia di mercato libera, fondata sulla regola della concorrenza, ma quello di eliminare progressivamente le
barriere nazionali alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei capitali e dei servizi. La stessa
Comunità acquisiva i principi dell’economia concorrenziale in un secondo momento, attraverso un percorso
lungo e accidentato. In una prima fase, l’azione comunitaria si caratterizzava per neutralità in ordine alla
proprietà delle imprese economiche, al riconoscimento di diritti esclusivi in favore delle imprese pubbliche,
all’ammissione di politiche dirigiste e protezioniste refrattarie al ricorso della regola della concorrenza.
Soltanto in un secondo momento, tra i principali obiettivi comunitari, si individuava la regola della
concorrenza. L’obiettivo diveniva la costruzione di una definizione ampia di impresa, al fine di sottoporre ogni
attività economica alle regole del diritto comunitario della concorrenza.
3.2.2 La seconda fase: l’Atto Unico europeo, le problematiche connesse all’armonizzazione del quadro
giuridico e le deroghe alla regola della concorrenza
La contrapposizione tra il mercato libero e il modello stato-centrico di gestione e funzionamento dei
servizi pubblici si accentuava con l’adozione dell’Atto unico europeo, che si proponeva, tra l’altro, di realizzare
un mercato unico attraverso l’armonizzazione del quadro giuridico in tutti i campi in cui la diversità delle
regole giuridiche ponesse ostacoli. I differenti modelli economico-istituzionali e le divergenti interpretazioni
della nozione di servizio pubblico indussero, dagli anni novanta, il diritto comunitario a riconoscere che le
funzioni dei servizi pubblici potessero giustificare l’applicazione di regole particolari, in deroga alla regola della
concorrenza, garantendo un livello specifico di servizio. Occorreva uscire da dogmatismi concettuali e da
imbalsamate nozioni giuridiche, al fine di rapportare, di volta in volta, in relazione a specifiche fattispecie, lo
studio sui servizi pubblici più in una ottica di tutela dei diritti (diritti dell’impresa, diritti degli utenti), che in
un’ottica organizzativo-funzionale.
Il processo evolutivo, pragmatico e garantista, si concretizzava attraverso la giurisprudenza della Corte di
Giustizia, sulla base di una innovativa, seppur formale, interpretazione dell’art. 86, 2° co., TCE, secondo la
quale, a certe condizioni, la regola della concorrenza non sarebbe risultata applicabile.
3.2.3 La terza fase: il Trattato di Amsterdam, la peculiarità dei «servizi di interesse economico-generale»
e la parziale rivalutazione dell’art. 43 Cost.
Come è noto, il Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 a seguito del Consiglio di Europa del
16 e 17 giugno 1997 ed entrato in vigore il 1 maggio 1999, ha introdotto l’art. 16 TCE (ex art. 7 TUE) che
178
riconosce l’importanza dei servizi di interesse economico-generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione
europea e stabilisce che la Comunità e gli Stati membri devono provvedere affinché tali servizi funzionino in
base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i relativi compiti. L’entrata in vigore del Trattato
di Amsterdam ha segnato un cambiamento politico ed economico in favore del settore pubblico; con l’art. 16
TCE è possibile infatti parlare di riequilibrio del modello economico europeo, quanto meno dal punto di vista
formale.
In particolare, l’art. 16 TCE prevede che «fatti salvi gli artt. 73, 86, 87, in considerazione della
importanza dei servizi di interesse economico-generale nell’ambito dei valori comuni della Unione, nonché del
loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati membri, secondo le
rispettive competenze e nell’ambito del campo di applicazione del presente Trattato, provvedono affinché tali
servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti». L’aver
inserito l’art. 16 TCE nella prima parte del Trattato, relativo ai principi, dimostra l’importanza che i redattori
hanno voluto attribuire a tale disposizione. L’articolo enfatizza la specifica e delicata missione affidata ai servizi
di interesse economico-generale, di cui agli artt. 86 e 87 TCE, espressione dei valori comuni dell’Unione e
strumenti decisivi per la promozione della coesione sociale e territoriale. In sostanza, la regola della
concorrenza, nell’ambito dei servizi di interesse economico-generale, non ha valore assoluto, ma è limitata dal
raggiungimento dei fini sociali e dal rispetto dei valori fondanti l’Unione, quali lo sviluppo armonioso,
equilibrato e sostenibile delle attività economiche, la solidarietà, l’elevato livello dell’occupazione e la
protezione dell’ambiente, della salute e dei consumatori.
L’art. 16 TCE consentirebbe una rilettura dell’art. 43 Cost., tesa ad un’interpretazione del ruolo dello
Stato che non solo possa determinare la sostanza e le caratteristiche di qualità e quantità della
regolamentazione o del sostegno economico al servizio stesso, ma possa altresì procurare, in presenza di certe
condizioni, il servizio con i suoi mezzi.
Si configurerebbe uno Stato non soltanto regolatore, ma altresì idoneo a gestire l’attività produttiva,
laddove il settore privato non sia in grado di assolvere a funzioni dall’alto impatto sociale. L’obiettivo e la
garanzia di raggiungere un livello specifico di servizio consentirebbe allo Stato, impegnato nell’erogazione di
servizi pubblici, di derogare alla regola della concorrenza, attribuendo poteri speciali o esclusivi ad una
determinata impresa.
Tuttavia, va anche ricordato che la formula utilizzata dalla Corte di Giustizia nella sentenza Sacchi per
affermare la legittimità del monopolio, non si ritrova più nella giurisprudenza della Corte negli anni novanta,
nella quale si consolida la tesi che l’espropriazione di una impresa costituisca comunque una eccezione alla
regola della concorrenza. Al di fuori dell’eccezione, si configura un esercizio abusivo della posizione
dominante e dunque una violazione delle norme sulla concorrenza.
L’obiettivo sociale dell’art. 16 TCE rimane quello di soddisfare efficientemente, e ad eguali condizioni,
diritti sociali dei cittadini e non quello di ripristinare regole di monopolio pubblico o di riserva di attività
economiche in favore dello Stato. Alla dimensione dell’utente destinatario del servizio tende a sostituirsi quella
del cittadino titolare di diritti fondamentali (diritti universali di cittadinanza).
Tuttavia, come evidenziato in dottrina, non si può escludere che l’art. 16 TCE possa in futuro influire
sulla giurisprudenza della Corte per quel che concerne l’applicazione di regole comunitarie in materia di aiuti
di Stato alle imprese pubbliche che esercitano una missione di interesse economico-generale. In particolare,
l’eccezione prevista dall’art. 86, 2° co., TCE, potrebbe divenire oggetto di un’interpretazione più ampia,
inducendo le imprese pubbliche a far valere le loro specificità in confronto alle imprese private.
Infine, si può ritenere che l’art. 16 TCE possa contribuire a realizzare nell’ambito dell’Unione un
sistema di valori politici, culturali e sociali condivisi dagli Stati membri, al fine di limitarne la dimensione
economica e mercantile. Il rallentamento dei processi di liberalizzazione delle public utilities a livello
comunitario risultano evidenti, tra l’altro, anche dal tenore della normativa comunitaria, che sembrerebbe
risentire dei nuovi scenari introdotti dall’art. 16 TCE. In particolare, si fa riferimento ai lunghi termini fissati
per l’apertura dei mercati ferroviari, postali e dell’energia dalla dir. 12-14/2001/CE, dir. 39/2002/CE e dir. 5455/2003/CE.
3.3 Il diritto comunitario ed i servizi di interesse economico-generale
I servizi di interesse economico-generale, esclusi quelli non orientati fisiologicamente al mercato, quali
l’educazione e la salute, consentono, a certe condizioni, allo Stato di godere di regole particolari e, quindi, di
«sfuggire» alla regola della concorrenza. Si tratta di settori che, secondo quanto ha affermato la Commissione,
possono essere individuati in autonomia dagli Stati membri.
179
In ogni caso, la rilevanza degli interessi economici generali va intesa quale limite all’applicazione delle
regole del mercato comune e della concorrenza. La comunicazione della Commissione europea sui servizi di
interesse generale del 20 settembre 2000 ha escluso dall’area occupata dai servizi di interesse generale le attività
che non hanno contenuto economico e quelle identificate come servizi sociali, in ordine alle quali spetta agli
Stati membri stabilire il tipo di politica ed organizzazione da seguire, nonché la determinazione delle attività
non profit. Invece, sono stati qualificati servizi di interesse economico-generale la navigabilità della più
importante via d’acqua del Paese (Porto di Mertert), un monopolio sulla pubblicità della televisione (Sacchi), la
gestione delle linee aeree non redditizie dal punto di vista commerciale (Ahmed Saeed), la gestione di una rete
telefonica pubblica (RTT), la gestione del servizio postale (Corbeau), la distribuzione di elettricità (Comune di
Almelo).
Va ricordato inoltre che la Commissione aveva già preso posizione sulla funzione e la regolamentazione
dei servizi pubblici nel diritto comunitario con la sua comunicazione 433/1996 sui servizi di interesse generale
in Europa. Il documento si riferisce soltanto ai servizi di interesse economico-generale, poiché la nozione di
servizio pubblico è pressoché sconosciuta al diritto comunitario. Tali servizi dovrebbero operare, secondo la
Commissione, come strumenti per garantire la parità di trattamento dei cittadini comunitari e promuovere la
solidarietà. Per la prima volta, con la suddetta comunicazione, si pone in ambito comunitario in modo
sistematico il problema dell’assunzione della responsabilità dell’individuazione e definizione dell’interesse
generale europeo.
Il punto focale attiene alla produzione di beni e servizi, prescindendo dalla natura giuridica del soggetto
che la pone in essere e dalle sue finalità. Tutte le attività economiche, in linea di principio, sono sottoposte al
regime della concorrenza e pertanto non possono fruire di aiuti pubblici. Il paradigma per qualificare come
economica una determinata attività è la sua capacità di incidere sul mercato. Tale regola, interpretata in senso
rigido, non può che innescare un processo di privatizzazione delle imprese monopolistiche pubbliche.
Tuttavia, alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia, che sta contribuendo alla
creazione di un c.d. diritto sociale europeo, dell’art. 86, 2° co., TCE e dell’art. 16 TCE, occorre elaborare
nuove configurazioni dei diritti d’impresa relativi ad attività che gestiscono servizi, ai quali ineriscono esigenze
di conseguimento e soddisfazione di interessi pubblici. La comunicazione della Commissione del 20 settembre
2000 sottolinea come il servizio di interesse economico-generale non riguardi una normale attività di impresa,
ma attenga a funzioni essenziali finalizzate alla coesione sociale. In sostanza, i servizi di interesse economicogenerale, anche se di proprietà e gestione privata, non possono prescindere dall’organizzazione pubblica, che
definisce i servizi di interesse economico-generale. Essa opera secondo i principi della proporzionalità e
sussidiarietà, sulla base dei quali può derogare alla regola della concorrenza. I pubblici poteri possono
intervenire con mezzi appropriati rispetto all’obiettivo e soltanto quando il servizio svolto dal privato si dimostri
inidoneo al perseguimento dell’interesse generale.
Sempre al fine di rivalutare la funzione sociale del servizio pubblico, in una dimensione derogatoria dei
principi del libero mercato, si è espressa la comunicazione della Commissione del 2001, che al punto 14), ha
testualmente affermato che «[...] i servizi di interesse economico-generale si differenziano dai servizi ordinari
per il fatto che le autorità pubbliche ritengono che debbano essere garantiti anche quando il mercato non sia
sufficientemente incentivato a provvedervi da solo». Il nuovo orientamento comunitario tende dunque a
realizzare un equilibrio tra regola della concorrenza e interesse generale da una parte e regimi speciali
caratterizzanti i servizi pubblici dall’altra.
La Commissione ricorre al principio di proporzionalità affermando che «[...] le restrizioni sulla
concorrenza sono giustificate soltanto per quanto riguarda i servizi che, per loro natura e per le condizioni
nelle quali sarebbero offerti in un mercato in regime di concorrenza, comprometterebbero l’equilibrio
economico della prestazione di servizi di interesse economico generale o avrebbero in altro modo un impatto
su tale prestazione».
La proporzionalità, quale principio generale del diritto comunitario, offre al singolo Stato membro la
possibilità di valutare la legittimità di una misura, nazionale o comunitaria, in base al rapporto fra mezzi
impiegati e risultato ottenuto. Tale principio, applicato ai servizi di interesse economico-generale, è finalizzato a
valutare se una misura restrittiva della regola della concorrenza, ad esempio la normativa che riserva la gestione
della rete elettrica ad un solo soggetto, sia necessaria a garantire il servizio pubblico, ponendo le condizioni
affinché tutti i cittadini possano ricevere energia elettrica in qualsiasi parte del paese a prezzi ragionevoli ed in
modo continuo. Occorre ripensare quelle tesi nelle quali si affermava che il mantenimento della struttura
concorrenziale, con i pubblici poteri posti in posizione di indipendenza e neutralità, fosse in grado di
assicurare di per sé il perseguimento del pubblico interesse.
180
…
La possibilità per gli Stati membri di invocare l’eccezione prevista dal 2° co. dell’art. 86 TCE sta
determinando un’influenza diretta sull’applicazione delle regole di aiuto dello Stato alle imprese pubbliche che
svolgono una missione di interesse economico-generale82. Il ricorso a tale eccezione potrà variare da Stato a
Stato e comunque dovrà porsi in armonia con il quadro costituzionale. Inoltre, nelle suindicate comunicazioni
della Commissione, è fatto salvo agli Stati il potere di individuare missioni di interesse generale (ai sensi
dell’art. 86, 2° co., TCE) ulteriori rispetto agli obblighi del servizio universale. Come evidenziato in dottrina,
oltre ai servizi oggetto delle direttive di liberalizzazione, che devono essere garantiti ai cittadini europei a prezzi
abbordabili e ad eguali condizioni, secondo quanto richiesto dall’obbligo del servizio universale, non si esclude
la possibilità di individuare ulteriori obblighi, che possono avere nella maggior parte dei casi contenuto
minimo.
…
3.5 La nozione di coesione sociale, la regola della concorrenza ed il ruolo dello Stato
La regola della concorrenza, in linea di principio, si applica ai settori strategici dell’economia
«liberalizzati» e dalla rilevante funzione pubblica, quali le telecomunicazioni, i trasporti aerei e ferroviari,
l’elettricità, il gas, l’acqua, cioè a quegli ambiti economici per anni gestiti ed esercitati in regime di monopolio.
Tale regola, dopo l’art. 16 TCE e l’art. 36 della Carta europea dei diritti fondamentali, impone un
ripensamento in relazione al rapporto tra erogazione dei servizi pubblici ed eguale soddisfacimento dei diritti
sociali, con una conseguente riflessione sull’effettività dell’art. 43 Cost.
La nozione di «coesione sociale» in ambito europeo, da ultimo esplicitamente prevista dall’art. 36 della
Carta europea dei diritti fondamentali, potrebbe costituire un «freno» all’onda liberista ed una rivalutazione dei
principi di carattere sociale contenuti nell’art. 43 Cost. La dimensione sociale può concretizzarsi in vari modi,
ad esempio, attraverso l’erogazione di aiuti di Stato finalizzati sia ad imprese pubbliche che private, purché
giustificati dal perseguimento di finalità sociali e dall’obiettivo della coesione economico-sociale, che si
concretizza, tra l’altro, in un livello alto di occupazione. La regola della concorrenza verrebbe quindi derogata
da istituti che si caratterizzano per la temporaneità ed eccezionalità. L’intervento dello Stato nelle attività
economiche relative a servizi di interesse economico-generale si trasforma da regola ad eccezione.
Tuttavia, al fine di legittimare interventi dello Stato in deroga alla regola della concorrenza, occorre
intendere la coesione economico-sociale quale obiettivo e non quale strumento; obiettivo che difficilmente può
raggiungersi senza l’intervento dello Stato. In un sistema fondato sul capitalismo concorrenziale, senza l’azione
dello Stato, non si avrebbe avuto lo sviluppo di settori strategici dell’economia. Settori privati dell’economia,
quali ad esempio quello automobilistico, non avrebbero avuto la stessa fortuna se a monte non vi fosse stato, in
alcuni settori (siderurgico, rete dei trasporti) un modello di capitalismo monopolistico e non concorrenziale.
Sistemi di monopolio e riserve in favore dello Stato costituiscono in certi momenti storici ed in alcuni segmenti
di mercato l’indispensabile presupposto per lo sviluppo economico del Paese.
Si potrebbe addirittura sostenere che la coesione sociale vada interpretata dal legislatore europeo e dai
singoli Stati membri come un pre-requisito alle politiche pubbliche e non come un mero obiettivo da
raggiungere per mezzo delle politiche stesse. In questo senso, la coesione economico-sociale andrebbe letta in
termini di omogeneità ed osservanza del principio di eguaglianza (in questo senso v. art. 11 del d.lg. 286/99 che
ha dato fondamento normativo alla Carta dei servizi), divenendo un vero e proprio principio costituzionale, dal
valore prescrittivo e non meramente programmatico. Il paradigma della coesione economico-sociale non può
essere costituito unicamente dal binomio libertà-solidarietà, ma va implementato con i valori contenuti nel
principio di eguaglianza sostanziale. Secondo tale interpretazione, i principi contenuti nell’art. 16 TCE, ed
espressamente richiamati dall’art. 36 della Carta europea, bilancerebbero la dimensione sociale comunitaria,
intesa nella sua più ampia accezione di eguale soddisfacimento dei diritti sociali, con la regola della
concorrenza e del mercato.
In quest’ottica, si è espresso il Parlamento europeo che nella risoluzione 97/35799, sui servizi di
interesse generale in Europa, ha chiesto alla Commissione di tenere debitamente conto, nella formulazione
delle sue future proposte e nell’attuazione del mercato interno con diretto o indiretto riferimento ai servizi di
interesse economico-generale, degli obiettivi dell’art. 130 TCE sulla coesione economica. La coesione
assurgerebbe a principio dell’Unione e dei singoli Stati membri, finalizzata all’uguaglianza di trattamento ed alla
perequazione tariffaria. Se la coesione sociale assumesse tale valenza, dal punto di vista giuridico e socio181
economico, i servizi che operano in tali ambiti potrebbero derogare alla regola della concorrenza, nel caso in
cui non siano in grado, all’interno del mercato, di raggiungere e mantenere soddisfacenti obiettivi sociali.
…
4. La disposizione tra crisi e riforma
4.1 Il servizio pubblico «europeizzato» e la Costituzione italiana
In relazione all’evoluto quadro europeo che ha determinato il nuovo assetto normativo ed economico
dei servizi pubblici, occorre verificare la legittimità, oltre che l’attuale vigenza, dell’art. 43 Cost. Come è noto, il
diritto comunitario primario e secondario (trattati, regolamenti, direttive, decisioni della Commissione,
sentenze della Corte di Giustizia) va applicato su tutto il territorio e prevale su quello nazionale sino alle
disposizioni costituzionali comprese, fatti salvi i principi della democrazia ed il contenuto essenziale dei diritti
inviolabili della persona.
I monopoli pubblici di servizi e di produzione sono ricondotti dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia all’art. 86, 1° co. e 3° co., TCE e le eccezioni permesse, con riguardo a tutti i settori soggetti a
monopolio o in cui vigano diritti speciali od esclusivi, sono quelle previste dall’art. 86, 2° co., TCE. Il principio
generale è l’applicazione della regola della concorrenza anche nell’ambito dei servizi di interesse economicogenerale, al fine di realizzare un mercato libero e aperto. Il diritto comunitario è indifferente al fatto che le
imprese siano in mano pubblica o privata; la disciplina che l’ordinamento comunitario detta per il soggetto
economico attiene all’attività, a prescindere dalla proprietà.
Quando vi sono i presupposti, di cui all’art. 86, 2° co., TCE, per derogare alla regola della concorrenza e
consentire aiuti economici ad imprese che svolgono attività di interesse economico-generale, o l’attribuzione di
poteri speciali, le disposizioni comunitarie richiedono che ciò avvenga in condizioni di trasparenza contabile, al
fine di consentire l’individuazione degli interventi di aiuto pubblico. In dottrina, si è sostenuto che il servizio
pubblico economico europeo non presenterebbe un insanabile contrasto con il complessivo impianto della
Costituzione economica italiana. La applicazione della regola della concorrenza in settori liberalizzati, quali i
servizi di interesse economico-generale, ai sensi dell’art. 86, 2° co., TCE e dell’art. 16 TCE, andrebbe attuata
secondo procedure e programmazioni di politica economica, conformi ai principi fondativi della Carta
costituzionale, ovvero orientate alla tutela del pubblico interesse, non inteso unicamente come raggiungimento
dell’efficienza organizzativa e della razionalizzazione di settori economici.
In quest’ottica, il pubblico potere tende a ridurre le funzioni di gestione, concentrandosi su quelle di
regolazione della concorrenza, delle tariffe e degli standards dei servizi, in un’attività di social regulation. Gli
scopi e gli obiettivi delle privatizzazioni, che sono in particolare la massimizzazione dei profitti e la riduzione
del debito pubblico, non possono prevalere sui diritti fondamentali della persona. L’obiettivo della
privatizzazione dei servizi di interesse economico-generale non può essere unicamente quello di restituire
efficienza e competitività alle imprese ex pubbliche, reinserendole in un mercato pienamente concorrenziale, e
ridurre il debito pubblico, diffondendo l’azionariato ed allargando il mercato borsistico. Mentre gli obiettivi
della produttività e dell’efficienza sono validi per i processi di privatizzazione degli enti pubblici, la cui
trasformazione in persona giuridica può essere anche considerata uno strumento di semplificazione
amministrativa, non sono sempre validi, o quanto meno esclusivi, per gli enti che svolgono funzioni o servizi di
rilevante interesse pubblico.
Le deroghe alla regola della concorrenza e del libero mercato, attraverso aiuti di Stato, o con
l’attribuzione di poteri speciali (golden shares) o di esclusività (monopoli legali), non sono dunque giustificate
dalla cura degli interessi economici dell’impresa, ma dal perseguimento degli obiettivi nazionali di politica
economica ed industriale. Le deroghe al libero mercato, consentite dalla disciplina comunitaria, non possono
esaurirsi in un’attività di ingerenza e controllo sulla vita e gestione delle imprese. La regola della concorrenza,
all’interno dello spazio giuridico europeo, non può avere l’effetto di ridurre i diritti sociali a meri diritti legali o
ritenere le disposizioni costituzionali mere norme programmatiche. Utilità e fini sociali contribuirebbero a
configurare una visione solidaristica dell’attività economica, assicurando tutela al nucleo essenziale dei diritti
della prima parte della Costituzione. In sostanza, si tratta di far coesistere i valori del mercato con quelli del
Welfare e dell’eguaglianza, sulla base dei principi fondativi del patto costituzionale, pensando a nuove regole e
a nuovi equilibri che non conducano alla riduzione dello Stato sociale. In futuro sarà opportuno con
rilevazioni periodiche verificare se i ricavi delle liberalizzazioni e la riduzione del debito pubblico comportino
182
anche la crescita delle entrate fiscali, lo sviluppo del mercato azionario, l’aumento della occupazione, migliori
condizioni di vita, alimentari, abitative, sanitarie, più istruzione, sistema pensionistico sicuro.
4.2 L’ineffettività dell’art. 43 Cost. e la salvaguardia della dimensione sociale costituzionale
Il modello di economia sociale di mercato, e segnatamente quanto emerge dall’art. 86, 2° co., TCE,
dall’art. 16 TCE, dalle comunicazioni della Commissione e dalla recente giurisprudenza della Corte di
Giustizia non sembrerebbe porsi in contrasto con principi fondativi della Carta costituzionale. L’Unione
europea lascia agli Stati nazionali la definizione di pubblico servizio e la possibilità, nel rispetto del principio di
proporzionalità, di attivare misure in deroga alla regola della concorrenza, anche in relazione al proprio quadro
costituzionale. In quest’ottica, non sembra potersi accogliere la tesi che ritiene che il diritto comunitario, ma in
particolare l’applicazione della regola della concorrenza, abbiano abrogato la Costituzione economica
nazionale.
Gli strumenti di cui all’art. 43 Cost. non risulterebbero, dunque, in contrasto con il diritto comunitario,
rappresentando un’eventuale deroga alla regola generale. In una economia «liberalizzata», è evidente che l’art.
43 Cost. si svuoti di significato, perdendo di effettività. Tuttavia, le attività economiche di interesse generale e
dall’alto impatto sociale rimarrebbero suscettibili di interventi da parte dei poteri pubblici, specialmente nei
casi in cui la spontaneità del mercato non possa soddisfarle. I processi di collettivizzazione, non espressamente
vietati dal diritto comunitario, assumerebbero il carattere dell’eccezionalità, mutando il contenuto originario
dell’art. 43 Cost. Infatti, come evidenziato in dottrina, la collettivizzazione prevista dall’art. 43 Cost., non aveva
carattere eccezionale, ma era l’applicazione di un principio generale del controllo e della pianificazione
economica. In questo senso, nella consapevolezza che è il diritto europeo, in ultima istanza, a stabilire quando
è possibile derogare alla regola della concorrenza, l’art. 43 Cost. va ripensato, in via interpretativa, assumendo
l’intervento dello Stato il carattere dell’eccezionalità.
4.3 Art. 43 Cost.: dimensione sociale ed eccezionalità degli interventi statali
Nei casi in cui il pubblico servizio non sia in grado di raggiungere spontaneamente, ed all’interno del
libero mercato, gli obiettivi che la Costituzione pone alla base di detta attività, nel caso in cui non si
raggiungano i fini del pubblico servizio, anche all’interno di un mercato regolamentato, ci si troverà di fronte ad
un fallimento del mercato che potrebbe legittimare l’assunzione del servizio da parte dell’amministrazione
pubblica in regime di monopolio, per concedere la gestione ai privati, in regime di concessione, o prestare
direttamente i corrispondenti servizi.
Il diritto comunitario ammette la sottrazione di attività al regime di mercato quando ciò sia necessario
per la realizzazione degli scopi che gli Stati assegnano alle attività medesime. La garanzia dei diritti di
cittadinanza, al di là dei profili soggettivi, assurge ad elemento costitutivo del pubblico servizio. Il regime della
riserva non è un presupposto necessario, ma una conseguenza dal carattere dell’eccezionalità, alla quale
ricorrere allorquando fallisce l’attività di regolamentazione del mercato.
Vi sono casi in cui l’attività di regolazione può risultare inefficace, in presenza di forti rigidità tecniche o
di economie di scala, oppure nel caso in cui la pubblica utilità richieda l’erogazione del servizio a tutti i
cittadini, anche in assenza di economicità per l’impresa. In questi casi, lo Stato non può limitarsi allo status di
regolatore, ma dovrebbe promuovere direttamente ed incentivare attività economiche.
4.4 Regime della riserva e servizio universale
La riserva in favore di un’impresa, giustificata dal perseguimento di interessi sociali e dall’obiettivo della
coesione sociale, impedirebbe ad altri soggetti di accedere a settori economici, violando la regola della
concorrenza. In linea di principio, l’utilità sociale e la coesione sociale non sembrano giustificare, come
evidenziato in dottrina, riserve di attività economiche e quindi la creazione di monopoli legali. La riserva non è
presupposto necessario affinché nell’ambito dei servizi di interesse economico-generale si possano raggiungere
finalità di utilità generale, quali la qualità, l’eguaglianza e tariffe contenute.
La legge di riserva, per essere conforme al diritto comunitario, dovrebbe dimostrare che i servizi di
interesse economico-generale per assolvere i loro compiti, ovvero al servizio universale, devono creare le
condizioni di una riserva di attività. A queste condizioni, una legge adottata ex artt. 43 e 117, 2° co., lett. e
Cost., potrebbe risultare compatibile con la normativa comunitaria.
183
L’impresa pubblica, che gode di diritti speciali ed esclusivi, dovrà soddisfare due esigenze, una relativa al
mercato, l’altra all’interesse generale ed al raggiungimento della coesione sociale. Tuttavia, il soddisfacimento
del servizio universale non esclude mercati concorrenziali. Può avvenire, infatti, come nel settore delle
telecomunicazioni, che la concorrenza ed il servizio universale siano obiettivi complementari, venendosi a
realizzare una competizione.
4.5 Incompatibilità tra servizio universale e regola della concorrenza. La riserva e gli aiuti finanziari: da
eccezione a regola
Diverso è il caso in cui si ricorre all’art. 16 TCE ed all’art. 86, 2° co., TCE, laddove la concorrenza ed il
servizio universale non siano obiettivi complementari. Il servizio di interesse economico-generale non riesce ad
avere i requisiti di servizio universale, ovvero ad avere tariffe ridotte ed a servire tutti i cittadini ad eguali
condizioni, indipendentemente dalla localizzazione geografica dell’utente124. Vi sono settori nei quali non
esiste un potenziale di innovazione tecnologica e di competitività tale da poter sviluppare con proprie forze il
servizio universale. In tali ambiti si verifica il c.d. market failure, ovvero quando il mercato concorrenziale non
offre affatto oppure offre in quantità e qualità insufficiente un bene pubblico puro. In questo caso, il
soddisfacimento dell’interesse pubblico, che grava sul principio della fiscalità generale, e quindi sui principi
dell’eguaglianza e della progressività, prevale sull’interesse del pubblico, laddove questo ultimo può essere
fonte di discriminazioni, diseguaglianze e di parcellizzazione sociale.
In questi casi ciò che rileva è la qualità del servizio e la sua utilità sociale, a prescindere dalla natura
giuridica dell’impresa e dalla titolarità della proprietà. La natura della attività può essere condizione sufficiente
per derogare alla regola della concorrenza, con l’istituzione di riserve o con aiuti da parte dello Stato. Il
finanziamento costituisce un meccanismo di deroga alla regola della concorrenza ed ha quale finalità il
raggiungimento della coesione sociale nell’ambito dei servizi di interesse economico generale; esso sarà
consentito nei limiti della necessità dell’equilibrio finanziario del servizio di interesse generale e nei limiti di
quanto indispensabile ad assicurare il servizio universale. Ogni Stato, nel rispetto del principio di sussidiarietà e
di proporzionalità, ed in relazione allo spirito di fondo del proprio modello economico, può decidere di
finanziare un servizio economico di interesse generale, purché si rispettino le condizioni ed i requisiti
comunitari e ci siano effettivamente quelle esigenze tali da giustificare deroghe alla regola della concorrenza.
Una forma di new governance europea, diversa dalle forme di governo statali, difficilmente può assolvere a
compiti redistributivi tipici dei sistemi politici nazionali ed assicurare prestazioni di livello uniforme all’interno
del territorio europeo.
In conclusione, dallo status di acquiescenza ed ineffettività temporale e contingente dell’art. 43 Cost., è
possibile configurare all’interno del nostro sistema un equilibrio tra la regola della concorrenza ed i principi
dell’economia sociale di mercato, un compromesso tra il dirigismo statale e l’ordine competitivo, un equilibrio
volto a preservare le garanzie costituzionali di ambiti quali la sicurezza sociale e la giustizia sociale, necessari
per la costruzione di un Welfare State, ispirato ai principi della democrazia economica sostanziale. Lo Stato
gestore, e non soltanto regolatore, pur con i limiti posti dal diritto comunitario e dalle nuove esigenze di
mercato, può, in via eccezionale, continuare a trovare il proprio legittimo fondamento giuridico nell’art. 43
Cost., e in senso più ampio, nei principi d’eguaglianza e solidarietà sociale.
Una trattazione specifica merita il tema dei servizi a rete.
rete
Si ha monopolio legale quando lo Stato sottrae ai privati lo svolgimento di una determinata
attività economica riservandola ad un unico operatore. Spesso, il monopolio legale subentra ad un
preesistente monopolio di fatto il quale, a sua volta, in molti casi è riconducibile alle peculiari
caratteristiche dell’attività economica, che ne rendono opportuna o conveniente la concentrazione in
capo ad un solo soggetto. In questi casi si parla di monopolio naturale.
naturale L’ipotesi più ricorrente è
quella di attività produttive che richiedono l’accesso a o la disponibilità di infrastrutture (tubi, binari,
cavi, ecc.) che non sono moltiplicabili per ragioni di carattere fisico o perché la loro moltiplicazione
avrebbe costi insostenibili. Ebbene, è proprio questo il caso dei servizi a rete.
rete
Si pensi all’acqua potabile. Una volta introdotto un regime di liberalizzazione volto a favorire la
competizione tra due o più operatori, se ognuno di questi avesse un proprio impianto gli edifici sarebbero invasi da
tubi. Immaginiamo la situazione di un grande condominio in cui i diversi proprietari degli appartamenti stipulano
contratti di erogazione del servizio idrico con più operatori. E la situazione diventerebbe insostenibile se una
184
proliferazione di infrastrutture interne al condominio riguardasse anche gli altri servizi a rete: gas, elettricità,
telefono e internet. È, dunque, più economico avere un solo impianto fruibile da più operatori.
Senonché, in un regime di monopolio, per quanto giustificato dalle diseconomie legate alla
gestione delle infrastrutture, l’unico operatore ha carta bianca nel definire il prezzo o la tariffa del
servizio reso.
Per la risoluzione di questo problema la strada più vecchia imboccata nel nostro Paese è stata
quella di sostituire all’impresa privata un’impresa pubblica, la quale, in quanto soggetta al controllo
politico, era dissuasa dall’assumere i comportamenti tipici dell’operatore monopolista che sfrutta la
propria posizione di rendita.
Più di recente si è passati ad un diverso approccio, assegnando ai pubblici poteri compiti di
regolazione finalizzati a prevenire comportamenti “egoistici” del monopolista. In effetti si parla di
regolazione economica proprio in relazione al sistema di regolazione dell’offerta in mercati non
concorrenziali.
Su impulso dell’Unione europea, l’ordinamento italiano ha avviato negli anni Novanta un vasto
processo di liberalizzazioni nei settore dei servizi a rete: energia elettrica, gas naturale,
telecomunicazioni, trasporto ferroviario: per “liberalizzazione” s’intende il passaggio da mercato
chiuso al mercato aperto alla concorrenza.
Tuttavia, la liberalizzazione introduce le condizioni legali per questa transizione, ma non risolve
i problemi – prima descritti – legati al monopolio naturale. Resta, infatti, da sciogliere il nodo della
gestione della infrastruttura, rispetto alla quale rimangono i problemi di economico sfruttamento degli
impianti a rete.
Ebbene, affinché la liberalizzazione funzioni e, nel contempo, affinché vi sia una adeguata
gestione dell’infrastruttura, è necessario che quest’ultima sia sottratta al monopolista per essere resa
accessibile alla generalità delle imprese che, in regime di concorrenza, intendono erogare un dato
servizio pubblico. Deve esserci, insomma, una dissociazione tra il soggetto che gestisce la rete e gli
operatori economici che competono nel mercato attraverso l’erogazione di un dato servizio.
Si consideri l’esempio del trasporto ferroviario. Un tempo vi era un monopolio naturale. Un solo soggetto
(un’impresa pubblica, ossia le Ferrovie dello Stato) che gestiva la rete (stazioni e rotaie) e che erogava il servizio.
Oggi il settore è stato liberalizzato. In esso vi operano più imprese. Quanto alla Lombardia si pensi a Trenitalia,
Trenord, Nuovo Trasporto Viaggiatori, Treni Regionali Ticino Lombardia. Nondimeno, sulla rete insiste ancora
oggi una posizione di monopolio con protagonista l’impresa Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Così in altri settori
come quelli dell’energia e del gas, nei quali la società proprietaria della rete di trasmissione elettrica (Terna) è
controllata dall’ENEL, e la proprietaria della rete di distribuzione del gas (Snam) è una controllata dell’ENI.
Analogamente nel settore della telefonia fissa.
Per evitare che l’ente di gestione dell’infrastruttura favorisca un operatore economico
appartenente alla medesima entità imprenditoriale (una società dello stesso gruppo), allora sono state
adottate misure per rendere indipendente l’ente di gestione della rete.
Così la società Terna è stata scorporata da Enel e accorpata al GRTN (Gestore della Rete di Trasmissione
Nazionale), dando luogo alla nascita del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), proprietario e gestore della Rete
elettrica, nonché responsabile della sua manutenzione e di tutte le politiche di sviluppo della medesima.
Il gestore dell’infrastruttura è un monopolista. Secondo il diritto europeo, è abuso di posizione
dominante la condotta dell’impresa che, gestendo una infrastruttura non duplicabile, ne rifiuta
l’accesso, senza ragioni oggettive, alle imprese che ne abbiano necessità per lo svolgimento delle
rispettive attività economiche. Si tratta di una infrastruttura essenziale,
essenziale vale a dire un bene necessario
per accedere al mercato in condizioni competitive con gli altri operatori. Ciò rende indispensabile
uno specifico regime dell’infrastruttura specie sul versante della sua capacità, ossia della possibilità
concreta di sfruttamento da parte di tutti gli operatori. Dunque, l’accesso alla infrastruttura si realizza
mediante un regime pubblicistico del servizio: le utilità fornite dall’infrastruttura sono oggetto di un
servizio pubblico la cui gestione è affidata tramite concessione.
concessione Indipendentemente dalla proprietà
185
della infrastruttura, tale bene è gestito in forza di un atto amministrativo che presuppone la riserva
pubblica del servizio erogato.
Il regime dell’infrastruttura ruota, così, intorno a due entità: l’autorità
autorità di regolazione,
regolazione che è una
autorità amministrativa indipendente, e il gestore.
gestore
In definitiva. Il gestore deve essere un amministratore imparziale della rete. Al gestore è
precluso lo svolgimento delle attività economiche che si avvalgono dell’infrastruttura. La capacità della
rete deve essere distribuita tra gli operatori sulla base di regole previamente determinate, in modo tale
da evitare discriminazioni. L’uso della infrastruttura è subordinato al pagamento di una tariffa. Il
gestore è responsabile dell’adeguamento della rete alle esigenze degli operatori.
La funzione giurisdizionale
Sulla struttura dell’ordinamento giudiziario ci si è già soffermati.
Quanto ai rapporti tra dinamiche processuali e attività economiche il caso delle acciaierie Ilva di
Taranto è un esempio eclatante dei molteplici modi attraverso i quali la funzione giurisdizionale
finisce con condizionare le attività produttive.
Le diverse forme di responsabilità dell’imprenditore, sulle quali si tornerà più avanti, sono
affidate ad altrettanto differenti autorità giudiziarie. Qualche esempio:
- l’imprenditore che non onore gli obblighi contrattuali scaturenti da un mutuo concesso da una
banca sarà sottoposto a provvedimenti giudiziari che incideranno coattivamente sul suo patrimonio,
così alterando la sua capacità di competere nel mercato sino a sancirne, nei casi estremi, la fuoriuscita
(decreti ingiuntivi, precetti, giudizi civili seguiti se necessario da atti di esecuzione forzata come il
pignoramento);
- l’imprenditore che si vede negare una autorizzazione amministrativa si rivolgerà al competente
T.a.r. per ottenere giustizia. In caso di esito negativo della vertenza giudiziaria, gli verrà preclusa la
possibilità di svolgere quella data attività economica;
- l’imprenditore che, con dolo o colpa, inquina l’ambiente senza aver adottato le misure
preventive prescritte dalla legge o che immette nel mercato prodotti alimentari alterati o che
corrompe un amministratore locale per vincere un appalto pubblico, è un imprenditore che verrà
sottoposto a processo penale e che, in attesa della sentenza definitiva, potrà subire misure cautelari (il
sequestro, ad esempio) tali da ostacolare lo svolgimento dell’attività economica;
- sul piano fiscale, poi, l’imprenditore potrà essere coinvolto in vertenze giudiziarie che si
celebrano dinanzi alle commissioni tributarie.
In tutti questi frangenti processuali l’autorità giudiziaria dispone di poteri idonei a influenzare
l’andamento dei mercati, inibendo determinate attività o sanzionando alcuni operatori. I princìpi
costituzionali dettati in questa materia sono, dunque, finalizzati ad evitare un cattivo uso della
funzione giurisdizionale, ma non sono certo diretti a proteggere le attività economiche di fronte alle
iniziative giudiziarie. Lo sviluppo economico non può mai essere evocato per inibire l’esercizio del
potere giudiziario. È uno degli elementi che il giudice dovrà prendere in considerazione, senza però
derogare alla legge per motivi attinenti all’efficiente svolgimento di attività produttive e commerciali.
La stessa Corte costituzionale svolge un ruolo importante in campo economico, come si è visto
in altre parti di questa dispensa e che come si avrà modo di notare anche in prosieguo di trattazione.
Nel giudicare la legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge la Corte
è chiamata a pronunciarsi al cospetto di disposizioni costituzionali che riguardano proprio il fattore
economico. Si pensi ai tanti casi in cui è evocato l’art. 41 sulla libertà di iniziativa economia privata,
senza dimenticare i giudizi nei quali i parametri del sindacato della Corte sono attinti dalle
disposizioni che riguardano i rapporti di lavoro.
Quando si occupa dei rapporti tra legge statale e legge regionale, non è affatto raro che la Corte
pronunci sentenze economicamente rilevanti: in tema di tutela della concorrenza, di coordinamento
della finanza pubblica, di livelli essenziali delle prestazioni legate ai diritti civili e sociali, di attività
negoziali e “ordinamento civile”, di tutela del lavoro, di professioni, di materie economiche devolute
186
alla competenza residuale dei legislatori regionali. In questi frangenti, una decisione della Corte può
spostare gli equilibri tra livelli di formazione, con ripercussioni anche nel mercato, perché non è
indifferente che a dettare le norme da applicare sia lo Stato anziché la singola Regione.
Un esempio è particolarmente significativo, pur nella consapevolezza che se ne potrebbero allegare decine
altrettanto suggestivi. In precedenza si è fatto riferimento ai cd. phone center, ossia i centri di telefonia in sede fissa
che consentono di comunicare, via telefono o tramite la rete, a tariffe decisamente vantaggiose. Nel 2006 la
Regione Lombardia adottò una legge finalizzata a contrastare un fenomeno ritenuto preoccupante per l’ordine
pubblico, legato a comportamenti asseritamente pericolosi posti in essere da cittadini extracomunitari in questi
luoghi. Questa legge introdusse due importanti elementi di novità: in primo luogo stabilì una serie di requisiti
strutturali e logistici molto stringenti non solo per aprire nuovi phone center ma anche per continuare denuncia di
inizio attività, una apposita autorizzazione comunale, imponendola anche agli operatori già presenti nel settore.
Questa legge fu impugnata in quanto: irragionevolmente lesiva della libertà di iniziativa economica privata;
difforme dai princìpi fondamentali dettati dal legislatore statale nella materia concorrente dell’ordinamento delle
comunicazioni. Dopo un primo tentativo andato male (nel senso che la Corte dichiarò inammissibile la questione),
con la sentenza n. 350 del 2008 la Corte dichiarò l’incostituzionalità dell’intera legge regionale. La previsione di
una nuova e ulteriore autorizzazione amministrativa aveva violato il principio fondamentale di semplificazione
(c’era già la denuncia di inizio attività). È rimasto assorbito il profilo legato ala presunta violazione dell’art. 41 Cost.
Ebbene, in questo modo la Corte ha impedito l’ulteriore smantellamento del settore dei phone center. Infatti, sino
a quel momento nella sola provincia di Brescia quasi il 70 % dei centri attivi era stato costretto a chiudere perché
impossibilitati ad adeguarsi ai nuovi requisiti stabiliti dal legislatore regionale.
Sezione II
I POTERI DEI SOGGETTI PRIVATI
Le posizioni giuridiche soggettive
Ogni individuo svolge le proprie attività giuridiche innanzitutto esercitando diritti soggettivi. Il
diritto soggettivo è un insieme di poteri, facoltà, pretese, immunità oggetto di tutela da parte
dell’ordinamento. Ad ogni diritto soggettivo è sotteso un interesse giuridicamente rilevante.
L’interesse, a sua volta, è lo stato di aspirazione o di tensione ideale verso un bene ritenuto necessario
per il soddisfacimento di un determinato bisogno. Dunque, attraverso l’assegnazione di un diritto
soggettivo l’individuo si vede riconosciuta una piena protezione da parte dell’ordinamento quanto al
soddisfacimento dell’interesse coltivato verso un determinato bene.
In altri termini, tramite il diritto soggettivo l’ordinamento tutela il rapporto tra il suo titolare e
un determinato bene, così che ogni ingerenza illecita, ossia contraria al diritto oggettivo, da parte di
altri potrà essere sanzionata e rimossa da un giudice.
Ad ogni diritto soggettivo corrisponde un obbligo,
obbligo che può gravare tanto su tutti i consociati
(diritti assoluti) quanto su alcuni soggetti (diritti relativi). L’obbligo è lo stato di soggezione in cui versa
un individuo che si relazione direttamente con il titolare di un diritto soggettivo. È un obbligo di fare
qualcosa (→ obbligo di facere) o anche solo di astenersi dal fare qualcosa (→ obbligo di non facere).
A fronte di un obbligo sussiste quindi una pretesa vantata da altri.
Più intenso del diritto soggettivo è il diritto potestativo,
potestativo ossia il potere di determinare, attraverso
un proprio atto di volontà, una modificazione della sfera giuridica di un altro individuo che versa in
una condizione di soggezione (cioè, non può che subire quella modificazione).
Ove un soggetto non ha il potere di modificare la condizione giuridica in cui versa un altro
soggetto, allora quest’ultimo risulterà protetto da una immunità,
immunità cui corrisponde quindi una
mancanza di potere.
Se, invece, ad un soggetto è riconosciuta la facoltà di compiere un determinato atto o di
assumere un certo comportamento, allora la posizione passiva corrispondente non è l’obbligo, in
quanto si ha mancanza di pretesa.
A volte l’acquisto di un diritto dipende dal verificarsi di alcune circostanze di fatto. Quando
alcune di queste si realizzano, e altre non ancora, allora si dice che il soggetto interessato vanta una
187
aspettativa.
aspettativa Aspettativa che è “di fatto” se non è protetta dall’ordinamento giuridico, mentre è “di
diritto” se il diritto oggettivo contempla una norma che la riconosce e la garantisce. Così, ad esempio,
se la legge vieta atti che possano impedire in modo sleale il perfezionamento di un diritto, allora il
titolare dell’aspettativa è legittimato a compiere atti conservativi per preservare il bene che potrebbe
divenire suo.
Diverso, poi, dal’obbligo è l’onere
onere.
onere In questo caso un individuo non è tenuto ad assumere un
determinato comportamento, ma se non lo fa non riuscirà ad ottenere il risultato prefissato.
Una prima distinzione all’interno dei diritti soggettivi è quella che intercorre tra…
- Diritto assoluto,
assoluto tale perché conferisce ad un individuo pretese che questi può far valere nei
confronti di una pluralità indeterminata di destinatari (→ erga omnes).
Oltre al già descritto diritto di proprietà, si pensi ad un brevetto di invenzione, che consente ad un soggetto
di pretendere che chiunque si astenga dal fabbricare e mettere in commercio l’oggetto brevettato. Si pensi, poi,
anche ai diritti al nome, alla reputazione, all’onore, all’integrità psicofisica, e via dicendo.
- Diritto relativo,
relativo tale perché attribuisce al suo titolare una pretesa opponibile solo a una o più
persone determinate.
Così, se un soggetto presta una somma di denaro ad un altro individuo vanterà solo nei confronti di
quest’ultimo la pretesa a farsi restituire quella somma di denaro. Si pensi, poi, al patto di non concorrenza, che
impegna solo lo stipulante nei confronti del soggetto che vanta un interesse a che altri si astenga dallo svolgere
attività in competizione con la sua.
Altra importante distinzione è quella che intercorre tra …
- Diritti della personalità,
personalità che sono intrasmissibili (cioè inalienabili, irrinunciabili) in quanto
attengono direttamente alla persona del loro titolare: la vita e l’integrità psicofisica, la riservatezza, la
libertà di movimento, e le altre libertà fondamentali previste dalla Costituzione.
- Diritti patrimoniali,
patrimoniali i quali, avendo per oggetto una utilità economica, sono di regola
trasmissibili. Così, i diritti patrimoniali assoluti includono la proprietà e gli altri diritti reali già
menzionati, laddove i diritti patrimoniali relativi sono detti diritti di credito e i rapporti instaurati
attraverso il loro esercizio sono definiti rapporti obbligatori (o più semplicemente obbligazioni).
obbligazioni
Sul piano costituzionale, è importante la distinzione tra diritti fondamentali e altri diritti. Solo i
primi godono di una particolare, specifica e forte protezione da parte della Costituzione, in questa
essa reca vincoli e condizioni opponibili allo stesso legislatore. Pertanto, il regime giuridico dei diritti
fondamentali può essere definito dal legislatore ordinario nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla
Costituzione. Il regime giuridico degli altri diritti, invece, è rimesso alla discrezionalità del legislatore
ordinario, che così gode di ampi margini di manovra.
Così, sono fondamentali il diritto alla vita, all’integrità psicofisica, alla libertà personale, alla parola, al credo
religioso, alla comunicazione, e via dicendo. Non è fondamentale il diritto di credito.
Riguardo ai diritti fondamentali si è posto un dilemma di difficile composizione: sono tali sono
quelli espressamente contemplati dalla Costituzione o se ne possono aggiungere altri (i cd. nuovi
diritti)
diritti grazie alla previsione dell’art. 2 Cost. secondo cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti
dell’uomo ?
Nel solco tracciato dal pensiero positivista, sarebbe corretto affermare che i diritti fondamentali
sono soltanto quelli espressamente contemplati dagli enunciati costituzionali. La ragione è semplice:
secondo questo approccio teorico, la Costituzione crea, in quanto atto normativo, i diritti
fondamentali. Stando così le cose, le lacune, quanto al catalogo dei diritti fondamentali, sarebbero in
radice escluse.
188
Accedendo, invece, alla prospettiva illuminata dal giusnaturalismo, parrebbe più coerente
abbracciare l’idea della Costituzione quale atto che si limita a riconoscere e a garantire i diritti
fondamentali: questi, dunque, preesistono al processo costituente, essendo patrimonio irretrattabile di
tutti gli individui in quanto appartenenti al genere umano. La Costituzione sarebbe, così, pervasa da
un numero non previamente quantificabile di lacune, la cui consistenza dipende da ciò che la
comunità ascrive, secondo ragione o in base a valori etici o religiosi, ai diritti fondamentali.
Non pochi studiosi hanno subito il fascino di questa interpretazione orientata dalla teoria del
diritto naturale, pervenendo a riconoscere nell’art. 2 Cost. la base normativa di un catalogo aperto di
diritti fondamentali, quasi che gli artt. 13 e seguenti si limitassero a fornire un elenco importante ma
non tassativo di diritti. Si è prevenuti alla medesima conclusione, pur non aderendo alla dottrina
giusnaturalistica, anche affermando che la categoria dei diritti è sensibile e, dunque, aperta ai valori e
agli interessi inediti che stanno emergendo grazie alle forze politiche e culturali prevalenti.
Questa posizione è stata contestata da quanti, pur senza cedere alle lusinghe del formalismo,
fanno notare come, imboccando questo itinerario interpretativo, si rischi di favorire l’affermazione di
concezioni ideali che rappresentino solo una parte della comunità, là dove uno dei princìpi cardine
della nostra Costituzione è proprio il pluralismo. Senza dimenticare, poi, che l’ampliamento
progressivo di nuovi diritti fondamentali, i quali entrano nell’ordinamento attraversando la porta
spalancata dall’art. 2, determina paradossalmente una graduale limitazione di tutti i diritti, vista la
necessità di un loro bilanciamento.
Dal canto suo, il giudice delle leggi, abbandonato il vecchio indirizzo di chiusura, ha identificato
nuovi diritti il più delle volte attraverso una interpretazione estensiva delle positive previsioni
costituzionali: il diritto alla vita alla luce degli artt. 13 e 32, o la libertà di coscienza ancorandola agli
artt. 19 e 21. In questa giurisprudenza, l’art. 2 è rimasto sullo sfondo, nel senso che non è stato dalla
Corte ignorato, ma è sovente stato incluso nel complesso edificio argomentativo dalla stessa costruito
per pervenire al riconoscimento di un nuovo diritto.
Gli sviluppi più recenti del costituzionalismo, sempre più orientato ad un dialogo multilivello
tra differenti sistemi, testimoniano l’intensità dell’impatto prodotto dai cataloghi di diritti altrove
definiti, a cominciare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo: si pensi, ad
esempio, al diritto all’onore, al decoro, alla rispettabilità, alla riservatezza, intimità e reputazione. Si è,
quindi, in presenza di un inedito universalismo dei diritti non più fondato sui pilastri del
giusnaturalismo, ma ancorato alle fondamenta del costituzionalismo cooperativo che si proietta ben
oltre i confini nazionali.
La Corte, dunque, assecondando il prevalente indirizzo dottrinale ha optato per il meccanismo
dell’interpretazione estensiva, azionato alla luce dell’art. 2. Sicché, appare ragionevole affermare che i
nuovi diritti, così identificati, sono già presenti in nuce nelle disposizioni costituzionali. Pertanto, non
di riconoscimento di inedite situazioni giuridiche soggettive dotate di rilevanza costituzionale si tratta,
quanto di arricchimento o ampliamento dell’oggetto definito dalle previsioni della legge
fondamentale.
La capacità giuridica,
giuridica che si acquista al momento della nascita, è l’attitudine delle persone di
divenire soggetto di diritti e di obblighi.
Peraltro, anche il concepito può ricevere per donazione o per successione ereditaria a condizione che
successivamente nasca e nasca vivo. Durante la gestazione il concepito vanta solo una aspettativa, presidiata da una
amministrazione dei beni nel suo interesse.
Dal canto suo, la capacità di agire è l’attitudine dei soggetti a disporre dei rispettivi diritti e di
assumere impegni mediante manifestazioni di volontà o comportamenti concludenti: è, dunque, la
capacità di porre in essere validamente atti giuridici. Essa si acquista al raggiungimento della maggiore
età.
189
I minori versano in condizioni di incapacità di agire. Per i minori emancipati vi è una debole capacità di
agire (tali sono i minori che, avendo compiuto i sedici anni, possono per gravi motivi essere autorizzati a contrarre
matrimonio). Gli interdetti e gli abilitati, seppur maggiorenni, sono parimenti privi della capacità di agire in quanto
incapaci di intendere e di volere. L’incapacità legale è assoluta per i minori e gli interdetti, e relativa per i minori
emancipati e gli inabilitati. L’incapacità naturale è l’effettiva incapacità di intendere e di volere.
L’autonomia
autonomia privata si sostanzia nel potere del singolo di regolare, in modo coerente con i
propri interessi, i tanti rapporti giuridici che lo riguardano, sia da punto di vista sociale che in ambito
economico, scegliendo da sé le finalità della propria azione.
L’autonomia privata si esprime attraverso i negozi giuridici,
giuridici vale a dire atti recanti dichiarazioni
di volontà alle quali l’ordinamento fa seguire effetti corrispondenti all’intento manifestato dal
dichiarante. Può anche esprimersi attraverso atti non negoziali,
negoziali che, non essendo diretti a creare,
modificare o estinguere un determinato rapporto giuridico, perseguono soltanto un risultato di fatto:
tali sono gli atti materiali (ad es. il rinvenimento di una cosa smarrita) e le comunicazioni, volte a
informare o a intimare.
Il negozio giuridico unilaterale si esprime attraverso la manifestazione di volontà o il
comportamento concludete posti in essere da una sola parte (es. il testamento), dove per “parte”
s’intende una persona fisica o giuridica o anche un gruppo di persone che agisce in maniera compatta
e unitaria.
Il negozio giuridico bilaterale
bilaterale o plurilaterale si sostanzia, invece, in manifestazioni di volontà o
in comportamenti concludenti posti in essere da due o più parti.
Contrariamente a quanto spesso si pensa, la donazione è un negozio giuridico bilaterale, in quanto si
perfeziona solo con l’incontro delle volontà manifestate dal donante e dal donatario. La ragione è semplice: non è
da escludere che una donazione possa determinare effetti pregiudizievoli in capo al donatario. Si pensi alla
donazione di un’azienda (→ insieme di beni utilizzati dall’imprenditore), che può essere gravata da debiti ingenti,
che toccherà poi al donatario estinguere.
Tra i negozi giuridici di questo secondo tipo spicca il contratto,
contratto ossia il negozio con il quale due
o più parti costituiscono, regolano o estinguono rapporti giuridici patrimoniali. Secondo il codice
civile elementi costitutivi del contratto sono l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto, la forma quando
è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
Il nostro ordinamento risposa sul principio della autonomia contrattuale,
contrattuale nel senso che le
persone possono concludere non solo i contratti espressamente previsti dal diritto positivo (i contratti
tipici),
tipici ma anche i cd. contratti atipici o innominati,
innominati ossia privi di puntuale disciplina legislativa ma
invalsi nella pratica negoziale. L’art. 1322 del codice civile, infatti, stabilisce che «le parti possono
anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché
siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico». Si pensi, ad
esempio, al leasing, al factoring, al catering, al sale and lease back.
Quanto alle strutture contrattuali si possono fare ulteriori distinzioni.
- Il contratto è a titolo oneroso quando al sacrificio patrimoniale di ciascuna parte fa riscontro
un vantaggio corrispondente (es. la compravendita). Altrimenti, il contratto è a titolo gratuito (es. la
donazione).
- Nei contratti unilaterali solo una parte esegue o si obbliga ad eseguire una data prestazione a
favore dell’altra (es. la donazione), laddove nei contratti a prestazione corrispettiva (o sinallagmatici)
sinallagmatici
alla prestazione di una parte fa riscontro la prestazione dell’altra.
- Nel contratto preliminare le parti si impegnano a stipulare in futuro un determinato contratto.
Se una delle parti rifiuta di concludere il contratto definitivo,
definitivo allora l’altra può adire il giudice che
pronuncerà una sentenza produttiva degli stessi effetti del contratto non stipulato.
- La distinzione tra contratti commutativi
commutativi e contratti aleatori sta nel fatto che solo nei secondi vi
è l’assunzione di un rischio, nel senso che l’esistenza, le dimensioni e il valore di una almeno delle
prestazioni dipendono da eventi incerti (es. assicurazione).
190
- Nei contratti a esecuzione
esecuzione continuata o periodica le prestazioni sono poste in essere
ripetutamente nel corso del tempo al fine di appagare un bisogno del creditore che, analogamente, si
protrae nel tempo (es. somministrazione, locazione, deposito, conto corrente, ecc.).
- Infine, sono consensuali i contratti che si perfezionano in qualsiasi forma. Sono formali quelli
che richiedono una specifica forma. Sono reali quelli che richiedono la consegna della cosa oltre alla
manifestazione della volontà negoziale. Nei contratti con effetti reali,
reali invece, la proprietà di un bene si
trasmette e si acquista per effetto del consenso delle parti.
I contratti sono usualmente raggruppati nei seguenti insiemi:
- contratti di alienazione a titolo oneroso (vendita, riporto, permuta, contratto estimatorio,
somministrazione);
- contratti di alienazione a titolo gratuito (donazione);
- contratti di utilizzazione di cose (locazione, affitto, comodato);
- contratti di prestazione d’
d’opera (appalto, trasporto, deposito, sequestro convenzionale);
- contratti di cooperazione nell’
nell’attività giuridica altrui (mandato, commissione, spedizione,
agenzia, mediazione);
- contratti di credito e garanzia (mutuo, fideiussione, anticresi, conto corrente);
- contratti bancari (depositi, cassette di sicurezza, apertura di credito, anticipazione bancaria,
sconto bancario, conto corrente);
- contratti aleatori (rendita vitalizia, assicurazioni, gioco e scommessa);
- contratti diretti a dirimere controversie (transazione, cessione dei beni ai creditori).
Sono vizi
annullamento del contratto, l’errore, il dolo e
vizi della volontà,
volontà e come tali determinano l’annullamento
la violenza. Anche l’incapacità di agire è causa di annullamento del contratto. Quando, invece, il vizio
è più radicale, si ha nullità del contratto (ad es., se non è rispettata la forma scritta imposta dalla legge
sotto pena di nullità).
Accanto a queste figure patologiche del contratto, che ne determinano l’invalidità, altre cause
possono far venir meno gli effetti obbligatori da esso discendenti:
a) rescissione,
rescissione perché si tratta di contratto concluso in stato di pericolo o in stato di bisogno;
b) risoluzione,
risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta, per eccessiva onerosità
sopravvenuta;
c) recesso,
recesso cioè il diritto di sciogliersi dal vincolo contrattuale mediante una dichiarazione
unilaterale indirizzata alla controparte.
Un cenno merita, infine, il tema della responsabilità nell’ambito del diritto privato, da
intendersi come insieme delle conseguenze negative che affliggono un soggetto quando vìola una
norma di diritto privato.
Non sempre l’ordinamento giuridico vieta attività che cagionano danni agli altri. L’imprenditore
di successo, che sbaraglia i concorrenti, produce a questi un pregiudizio, ma non per questo va
incontro a responsabilità.
Altre volte, invece, l’ordinamento vieta attività dannose: queste si concretizzano, dunque, in atti
illeciti,
illeciti fonte di responsabilità per i loro autori.
Sulla responsabilità contrattuale si è fatto un rapido cenno a proposito tanto delle cause di
invalidità, quanto degli accadimenti che determinano l’estinzione del rapporto contrattuale (così, ad
esempio, è contrattualmente responsabile chi non adempie la prestazione prevista dal contratto, con
conseguente possibilità di risoluzione del contratto stesso). A ciò si aggiunga la responsabilità
precontrattuale,
precontrattuale derivante dalla inosservanza delle regole di correttezza e di lealtà che debbono
connotare i comportamenti dei soggetti impegnati nelle trattative che potrebbero sfociare nella
conclusione di un contratto.
La responsabilità civile (o extracontrattuale o aquiliana)
aquiliana riposa sulla regola generale di cui all’art.
2043 del codice civile: «qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto,
obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno».
Affinché vi sia un illecito civile, dunque, è necessario che ricorrano i seguenti elementi:
- l’elemento materiale, ossia il fatto: una azione o una omissione;
191
- l’elemento psicologico, vale a dire il dolo (l’intenzione di cagionare il danno) o la colpa
(negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline), con
l’avvertenza che in determinati casi (si pensi, ad esempio, alla responsabilità del medico o del
magistrato) è necessaria la colpa grave, e non una lieve incuria;
- il rapporto di causalità, nel senso che occorre provare il nesso tra causa ed effetto;
- l’ingiustizia del danno, quindi la sua contrarietà al diritto oggettivo.
Si hanno, quindi, diverse figure di illecito: gli illeciti contro la persona, gli illeciti contro l’onore
e la reputazione, la lesione di diritti reali, i danni all’ambiente. Per ciò che interessa di più la
costituzione economica si segnalano la concorrenza sleale e gli illeciti contro l’l’impresa.
impresa Commettono
concorrenza sleale:
- l’imprenditore che pone in essere atti idonei a generare confusione della propria attività e dei
propri prodotti con l’attività e i prodotti di altri imprenditori;
- l’imprenditore che diffonda notizie ed apprezzamenti idonei a determinare il discredito dei
concorrenti;
- l’imprenditore che si appropria dei pregi dei prodotti o dell’impresa del concorrente.
Nel caso dell’impresa
impresa la responsabilità assume connotazioni peculiari, in quanto l’attività
oggetto di obbligazione è posta in essere dal debitore che si avvale di una propria organizzazione di
mezzi e di persone e che intrattiene rapporti con altri soggetti per l’acquisizione di materie prime, di
forniture, di servizi. Così, l’inadempimento può derivare non solo da motivi interni all’impresa, ma
anche da problemi associati ai rapporti che l’imprenditore intrattiene all’esterno. L’elemento della
colpa assume quindi tonalità in parte diverse da quelle generali. Pertanto, ad esempio, l’esistenza di
misure tecniche e organizzative idonee ad evitare un danno non necessariamente conduce al
riconoscimento della colpa in capo all’imprenditore per i danni eventualmente cagionati per effetto
della omessa adozione di quelle misure. In effetti, può trattarsi di misure eccessivamente onerose dal
punto di vista economico. Ancora, la responsabilità potrebbe essere imputata a ritardi o negligenze
altrui, come nel caso di fornitori che tardano o non adempiono quanto pattuito, o magari ai ritardi
con i quali spesso le amministrazioni pubbliche onorano gli impegni derivanti da un contratto
d’appalto. Secondo la giurisprudenza, la responsabilità dell’imprenditore è esclusa solo quando
l’inadempimento è ascrivibile a cause esterne alla sua sfera di controllo e di pianificazione.
È responsabile, ma solo per dolo o colpa, il genitore (al pari dei tutori, dei precettori e dei
maestri) per i danni cagionati dai figli minori non emancipati che abitino con essi (negli altri casi, si
tratta di danni provocati dai minori sottoposti a tutela e dagli allievi).
In alcuni casi, poi, non è necessario provare almeno la colpa, in quanto sussiste la cd.
responsabilità oggettiva:
oggettiva il proprietario di un veicolo, il caso della “rovina di un edificio”, il danno
causato da cose o animali, la responsabilità per il fatto dei dipendenti, l’esercizio di attività pericolose.
In questi casi, il soggetto attivo può esimersi da responsabilità soltanto provando il caso fortuito o la
forza maggiore: dunque, avvenimenti che fuoriescono dal controllo del diligente padre di famiglia.
I rimedi giuridici contro gli atti illeciti sono: il risarcimento del danno per equivalente, la
reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno non patrimoniale, l’azione inibitoria.
Ci si può esimere da responsabilità solo adducendo una delle cause di giustificazione previste
dall’ordinamento: legittimità difesa, stato di necessità, consenso dell’avente diritto, esercizio di un
diritto.
Diritto soggettivo e interesse legittimo
Ogni consociato è portatore di una serie di interessi. Per interesse s’intende lo stato di
aspirazione o di tensione ideale verso un bene considerato necessario per il soddisfacimento di un
determinato bisogno.
bisogno
Non tutti gli interessi sono tutelati dall’ordinamento giuridico. Alcuni interessi trovano riscontro
in norme sociali o etiche o religiose. Altri, invece, sono considerati e quindi protretti da specifiche
192
norme giuridiche. I primi sono definiti meri interessi di fatto,
fatto i secondi sono gli interessi
giuridicamente rilevanti.
rilevanti
Spetta al legislatore selezionare gli interessi giuridicamente rilevanti alla luce delle prevalenti
concezioni sociali, politiche, economiche, culturali. Al mutare dei rapporti sociali si può assistere ad
un ampliamento o a una restrizione degli interessi giuridicamente rilevanti.
A loro volta, gli interessi giuridicamente rilevanti assumono una particolare forma, che è quella
del diritto soggettivo. Questa posizione giuridica soggettiva è stata già descritta. Qui basta ribadire che
il diritto soggettivo garantisce al suo titolare una particolare e intensa protezione quanto alla
realizzazione dell’interesse sotteso a tale diritto. Una volta dimostrata la lesione del diritto soggettivo,
il suo titolare potrà rivolgersi al giudice competente per ottenere giustizia, ossia per ripristinare la
pienezza del diritto soggettivo anche solo sotto forma di risarcimento del danno così patito.
Nei rapporti con la pubblica amministrazione, quando essa esercita un potere la posizione del
destinatario del relativo atto non è titolare di un diritto soggettivo. Di fronte al potere amministrativo,
il privato è portatore di un interesse giuridicamente rilevante, che tuttavia non assume la forma
dell’interesse legittimo.
Consideriamo il seguente esempio. Tizio è proprietario di un terreno, vanta cioè su questo
bene immobile un diritto soggettivo. Egli vorrebbe costruire una casa su questo terreno, ma la legge
subordina questa costruzione ad un atto amministrativo, la cd. concessione o licenza edilizia. Ciò può
apparire anomalo dal momento che il diritto soggettivo di proprietà avente per oggetto un
determinato bene si sostanzia in una somma di pretese, facoltà, poteri che consentono al suo titolare
il pieno godimento del bene con esclusione degli altri. Tra le facoltà di godimento incluse nel diritto
soggettivo di proprietà su un terreno vi è senza dubbio il diritto di costruire al di sopra di esso, in
quanto da questa attività il proprietario può trarre una utilità ammessa dall’ordinamento. Ma non può
farlo direttamente, in quanto il suo diritto di costruire (→ ius edificandi) è subordinato ad un atto
amministrativo. Pertanto, ove il proprietario di un terreno costruisse su di esso una casa senza aver
ottenuto il prescritto atto amministrativo, egli incorrerebbe in una sanzione, avendo commesso un
abuso edilizio: la case potrebbe essere demolita anche contro la volontà del proprietario. Dal canto
suo la competente autorità amministrativa potrebbe negare la licenza di costruire ove il progetto
presentato dall’interessato si rivelasse incompatibile con il piano regolatore del Comune. Questo
piano è un atto amministrativo generale che suddivide il territorio comunale in aree individuando
quelle in cui è consentito costruire e subordinando le costruzioni a specifici requisiti strutturali e
condizioni urbanistiche. Il Comune predispone il piano regolatore per garantire il corretto, ordinato e
razionale sfruttamento del territorio, dal momento che occorre bilanciare molteplici interessi: il diritto
di costruire, lo svolgimento di attività commerciali, lo sfruttamento agricolo del territorio, la tutela
dell’ambiente, la viabilità. Per questo motivo, la legge ha attribuito al Comune il potere
amministrativo di permettere o meno al privato l’esercizio del diritto di costruire. Questo potere è
finalizzato alla tutela dell’interesse generale alla razionale utilizzazione del territorio. Il legislatore ha
ritenuto di dover dare peso a tale interesse, vietando attività dei privati incompatibili con esso.
Quindi, quando il privato chiede al Comune il permesso di costruire, si fa portatore di un interesse
individuale alla realizzazione di un edificio. Questo interesse individuale deve essere sottoposto a
confronto con il superiore e prevalente interesse generale: se l’interesse individuale risulta
compatibile con l’interesse generale (perché il progetto è rispettoso del piano regolatore) allora
l’amministrazione comunale concederà al privato il permesso di costruire; se l’interesse individuale
risulta contrastante con l’interesse generale (perché il progetto vìola il piano regolatore) allora
l’amministrazione comunale negherà al privato il permesso di costruire.
Da questo esempio si deduce che:
- in certi casi (ma non sempre) il legislatore decide, alla luce delle prevalenti concezioni
sociali, politiche, economiche, culturali, che determinate attività individuali debbano essere
valutate attraverso un confronto con interessi dell’intera comunità: gli interessi generali,
appunto;
193
se il legislatore identifica tali interessi generali, conferisce loro prevalenza rispetto agli
interessi privati;
- in forza di tale prevalenza, un interesse privato che dovesse risultare incompatibile con
l’interesse generale potrà essere legittimamente sacrificato;
- questo sacrificio dell’interesse privato si risolve nel diniego dell’atto amministrativo che la
legge prevede come condizione per il legittimo svolgimento di una determinata attività;
- se invece l’interesse privato risulta compatibile con l’interesse generale, allora l’atto
amministrativo verrà emanato dall’amministrazione competente.
Se, invece, la legge non individua alcun interesse generale da preservare, allora l’interesse
privato non potrà mai essere sacrificato in suo nome. Più semplicemente, non vi sarà alcun atto
amministrativo cui subordinare una determinata attività. In questi casi, il privato risulterà titolare di un
diritto soggettivo opponibile alla pubblica amministrazione, in quanto non suscettibile di essere
sacrificato.
Ebbene, quando la legge individua un interesse generale, lo protegge affidandone la cura ad una
amministrazione, che così diviene titolare di un determinato potere il cui esercizio è condizione
necessaria per svolgere legittimamente un’attività privata, allora il singolo è titolare di un interesse
legittimo.
legittimo
L’interesse legittimo è la posizione giuridica soggettiva in cui versa un individuo quando
intrattiene un rapporto con una amministrazione titolare di un potere amministrativo.
Diversamente dal diritto soggettivo, l’interesse legittimo può essere sacrificato se incompatibile
con l’interesse generale. Tornando al precedente esempio, il proprietario di un terreno che chiede al
Comune il permesso di costruire è, rispetto a tale attività, titolare di un interesse legittimo. Se il
permesso viene accordato, ciò significa che, confrontando il progetto e il piano regolatore, il Comune
ha riconosciuto la compatibilità dell’interesse legittimo a costruire con l’interesse generale al razionale
sfruttamento del territorio.
La differenza di tutela accordata dall’ordinamento al diritto soggettivo e, rispettivamente,
all’interesse legittimo, si coglie anche in relazione alle dinamiche processuali conseguenti ad una
eventuale controversia sottoposta ad un giudice.
a) Diritto soggettivo → Se Tizio, proprietario di una autovettura, subisce un incidente stradale
a causa del comportamento colposo di Caio, allora Tizio potrà rivolgersi al giudice per
ottenere il risarcimento dei danni così patiti. In particolare, potrà richiedere una somma di
denaro per riparare l’autovettura danneggiata. Il giudice, dal canto suo, dovrà
semplicemente limitarsi a verificare che il bene mobile di proprietà di Tizio sia stato
danneggiato per colpa di Caio. In questo modo il diritto soggettivo ottiene una protezione
piena.
b) Interesse legittimo → Se Sempronio, proprietario di un terreno, vede negarsi il permesso di
costruire dal Comune di Valledorata, allora Sempronio, davanti al giudice amministrativo,
dovrà dimostrare che il suo interesse legittimo era compatibile con l’interesse generale.
Dunque, non baste lamentare la lesione di una posizione giuridica soggettiva, ma occorre
fornire questa ulteriore prova, che nel caso del diritto soggettivo non è richiesta.
Per cogliere bene questa differenza, si rifletta sul seguente esempio. Chi è proprietario di
un’autovettura, può goderne in modo pieno. Tra le diverse facoltà associate alla titolarità del diritto
soggettivo su questo bene mobile vi è anche quella di guidarla. Senonché, a tutti è noto che per
guidare legittimamente un autovettura è necessario ottenere la patente di guida, che altro non è che
un provvedimento amministrativo di discrezionalità tecnica della categoria “abilitazioni”. La
previsione di questo atto, e la conseguente attribuzione del relativo potere ad una determinata
autorità, riflette l’individuazione, da parte del legislatore, di un interesse generale da proteggere:
l’interesse della collettività alla corretta, ordinata, prudente circolazione stradale. Quindi, se all’esame
l’aspirante patentato si dimostra inidoneo alla guida, la patente verrà negata: il suo interesse legittimo
verrà sacrificato in nome del superiore interesse generale. Se il legislatore non avesse individuato e,
quindi, protetto l’interesse generale alla sicura circolazione stradale, non ci sarebbe stato bisogno della
-
194
patente e, quindi, di alcun esame. Chiunque, anche minorenne, una volta acquisita la proprietà
dell’autovettura avrebbe potuto legittimamente e liberamente guidarla senza incorrere in divieti e
sanzioni, a prescindere dalla propria capacità di guidare. Non è una situazione tranquillizzante
questa...
Ricapitolando. Gli interessi di cui sono portatori i consociati sono tre:
- meri interessi di fatto, tali perché non protetti dall’ordinamento giuridico;
- interessi giuridicamente rilevanti tradotti in diritti soggettivi, come tali protetti al massimo
dall’ordinamento giuridico;
- interessi giuridicamente rilevanti tradotti in interessi legittimi, come tali protetti
dall’ordinamento solo se compatibili con l’interesse generale presidiato dal potere
amministrativo attribuito dalla legge ad una determinata autorità.
A questo punto è lecito chiedersi se e in quale misure l’interesse legittimo sia davvero tutelato
dall’ordinamento giuridico.
La risposta è affermativa, pur nella consapevolezza del divario di tutela rispetto al diritto
soggettivo. Infatti, il titolare dell’interesse legittimo può avvalersi delle seguenti due facoltà:
a) facoltà di partecipazione,
partecipazione nel senso che il titolare dell’interesse legittimo può partecipare al
procedimento amministrativo (allegando documenti e memorie, accedendo agli atti)
affinché il potere amministrativo sia esercitato in maniera legittima;
b) una volta esercitato il potere, il titolare dell’interesse legittimo potrà esercitare facoltà di
reazione contro l’atto negativo, al fine di far valere, nelle sedi già descritte, gli asseriti vizi. In
effetti, l’interesse legittimo può essere sacrificato in nome dell’interesse generale, solo se il
potere amministrativo viene esercitato in modo legittimo, cioè se l’atto è privo di vizi di
nullità o di annullabilità.
A corredo di questa trattazione appare necessaria le seguente precisazione. Si è detto che il
diritto soggettivo non può essere sacrificato in nome dell’interesse generale. Tuttavia, molti sanno che
un terreno di proprietà privata può essere, in tutto o in parte, espropriato dalla pubblica
amministrazione, con l’unica consolazione dell’indennizzo. Come si spiega questa lesione del diritto
soggettivo di proprietà determinata dall’esercizio di un potere amministrativo ?
È stata fornita al riguardo una spiegazione basata sul concetto di diritto affievolito.
affievolito Il
proprietario di un terreno è sì titolare di un diritto soggettivo, ma quando l’amministrazione
competente dichiara la pubblica utilità di una determinata opera e decide, ai fini della sua
realizzazione, che un terreno debba essere espropriato, ossia sottratto dal patrimonio giuridico di una
persona, allora il diritto di questi affievolisce e diventa un interesse legittimo. Egli, quindi, diverrà
titolare di un diritto soggettivo all’indennizzo.
La libertà di iniziativa economica privata
Lo studio delle posizioni giuridiche soggettive condotto nelle pagine precedenti è la premessa
indispensabile per una corretta comprensione di uno dei temi centrali della costituzione economica.
La libertà
art. 41 Cost.,
libertà di iniziativa economica privata è prevista e tutelata dall’art.
Cost. di cui si riporta il
testo:
1. L’iniziativa economica privata è libera.
2. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Prima di procedere alla lettura del commento di R. Niro, occorre focalizzare l’attenzione, in
particolare, sui seguenti profili.
195
In via preliminare, è utile ricordare che l’art. 41 si rivolge innanzitutto al legislatore ordinario,
prima ancora che ai potenziali operatori economici o alle pubbliche amministrazioni o ai giudici. Al
legislatore ordinario spetta riconoscere e garantire la libertà di iniziativa economica privata, nella
consapevolezza che le limitazioni che esso può introdurre sono soltanto quelle connesse ai limiti quivi
indicati.
1) Qual è la storia di questa previsione ? Si tenga presente che difficilmente un liberista avrebbe
concepito una simile disposizione. Invero:
- è stato fissato il limite della «utilità sociale»;
- è riconosciuta anche una attività economica pubblica;
- il legislatore può persino orientare e armonizzare pubblico e privato in campo economico per
il conseguimento di fini sociali.
La dimensione “sociale” è posta quale contrappeso del riconoscimento della libertà di iniziativa
economica privata.
Quanto di compromissorio tra le diverse anime dell’Assemblea costituente c’è all’interno di
questa disposizione ?
2) Quali sono i problemi interpretativi che questa previsione pone ?
- iniziativa o anche attività economica ?
- solo l’impresa o anche altre forme di attività economica pur in senso lato ?
- e l’autonomia contrattuale ?
Ma, ancor prima, perché sono importanti questi interrogativi ? Sono solo esercizi interpretativi
o hanno un senso sostanziale ?
3) L’art. 41 prevede oppure no una riserva di legge ? Questo interrogativo è importante, in
quanto dalla risposta ad esso data dipende lo spazio di manovra concesso dalla Costituzione al
legislatore e al potere esecutivo.
E se sì, quale legge ? Solo quella statale o anche quella regionale ?
4) I limiti. Alcuni di essi sono di facile decifrazione e comprensione. L’iniziativa economica non
può violare la libertà altrui, al pari di qualsiasi altra libertà (“la mia libertà incontra un limite nella tua
libertà”). Analogamente, al pari di tutte le altre libertà, anche quella in questione non può minare la
sicurezza, intesa innanzitutto (ma non solo) come incolumità fisica delle persone. Il discorso diventa
meno chiaro, invece, per gli altri due limiti: la dignità umana (cos’è ?) e, soprattutto, l’utilità sociale.
Quanto a quest’ultima, la Costituzione italiana vuole che chi faccia impresa si occupi anche del
benessere collettivo ?
5) Quale modello economico è prefigurato dall’art. 41 ? Economia di mercato, economia
mista, economia socialista ? Quanto è importante, a questo proposito, leggere l’art. 41 unitamente alle
altre pertinenti disposizioni della Costituzione ? Quanto la partecipazione italiana ad organizzazioni
sovranazionali può condizionare la lettura del’art. 41 da questo punto di vista (si pensi all’Unione
europea) ?
R. NIRO, Commento all’art. 41, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla
Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 846 ss.
1. Precedenti, origine e linee evolutive
1.1 Le origini
Tutte le indagini sulle «origini» della libertà di iniziativa economica assumono come atto di «nascita» di
tale libertà quello del riconoscimento della stessa come diritto «autonomo» dal diritto di proprietà, di cui in
196
precedenza si ritiene fosse quasi un «segmento interno», per giunta di scarso rilievo, avviluppata com’era nelle
sue spire, nell’ambito di un sistema «dominicale» per eccellenza, contraddistinto, sul piano economico, dal
modo di produzione agricolo ed artigianale, finalizzato all’autoconsumo, e sul piano politico dalla complessa
architettura feudale. È così che l’«emersione storica di un autonomo concetto di attività economica» si rinviene
in coincidenza dello sviluppo dei traffici mercantili e dell’affermarsi dell’economia di scambio, la quale trova
nelle strutture dell’età comunale (nelle c.d. «città libere»), che segnano la dissoluzione dell’ordinamento
feudale, un assetto anticipatore di quello dello Stato moderno. È in quest’ultimo, infatti, che la libertà
economica conosce la sua piena consacrazione, come dimostrato dalla proclamazione, nella Francia
rivoluzionaria, del principio della «libertà del commercio e dell’industria» (l. 2-17 marzo 1791)- parallelo alla
configurazione della proprietà quale «diritto sacro ed inviolabile» (art. 4 della Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino) - principio simbolicamente rivelatore dell’abolizione del precedente sistema politicoeconomico nel quale il commercio e l’industria non costituivano esercizio di libertà, ma attività il cui
svolgimento era possibile solo con il consenso del sovrano, mediante «privilegi» concessi singolarmente. Una
forma di riconoscimento di siffatto principio, sia pure implicito, si era, d’altro canto, già avuta in Inghilterra, in
corrispondenza dell’elaborazione della teoria dei «diritti naturali» (e dell’importante contributo ad essa dato da
Locke) e della identificazione, fra di essi, in particolare della «libertà personale» e della «proprietà privata» dalla
cui combinazione si desumeva il riconoscimento della predetta libertà di industria e di commercio.
1.2 I «precedenti» dell’art. 41 Cost.
Nonostante i richiamati sviluppi, sono tuttavia rare le costituzioni ottocentesche che contengono
un’espressa e peculiare tutela dell’iniziativa ed attività economica, distinta ed autonoma rispetto a quella
prevista per la proprietà, prevalendo il modello tradizionale dell’indistinzione o del riconoscimento implicito
della libertà economica nella proclamazione del diritto di proprietà. Nel segno della predetta tradizione si
colloca anche lo Statuto albertino, il quale pone fra i «diritti e doveri dei cittadini», accanto alle classiche libertà
civili (la libertà individuale, la libertà di domicilio, la libertà di stampa), il riconoscimento e la tutela di «tutte le
proprietà», nel limite del rispetto dell’«interesse pubblico legalmente accertato» (art. 29). È, infatti, secondo
questa «chiave di interpretazione» che Santi Romano rintracciava, fra le «libertà dei sudditi» statutariamente
consacrate, non solo la c.d. «libertà di attività» - comprensiva della «libertà professionale» consistente nella
facoltà di «chi possiede quei requisiti di capacità richiesti dalle norme generali» di «scegliere l’attività lucrativa
che più gli conviene, sia nel campo delle professioni in senso stretto, sia in quello delle arti, delle industrie e
del commercio» -, ma anche la c.d. «libertà patrimoniale», la quale «integra la libertà di attività», costituendo il
patrimonio «un mezzo di esercizio, un effetto ed un campo dell’attività personale»: tale libertà patrimoniale che pure costituisce «fondamento di molte facoltà che il diritto pubblico abbandona al diritto privato perché le
regoli nei loro momenti e nelle loro conseguenze specifiche» - è contraddistinta da caratteri pubblicistici, che si
rinvengono, in particolare, con riferimento alla espressa proclamazione dell’inviolabilità dei c.d. diritti quesiti
ed all’inviolabilità delle proprietà, intesi quasi quali «svolgimenti» (impliciti) della prima libertà, pur non
espressamente evocata dal testo dello Statuto. È utile ricordare come del riconoscimento (costituzionale)
dell’autonomia (e della libertà) dell’iniziativa economica privata dallo Stato si ritiene che fosse espressione quel
c. comm. del Regno d’Italia adottato nel 1882 e proteso ad affermare l’autoregolazione del processo
economico anche attraverso la stessa separazione del c. comm. dal c.c., in linea con la concezione liberistica
dello Stato e con le teorie della scuola economica classica inglese.
Per un espresso riconoscimento del ruolo centrale assegnato dall’ordinamento alla iniziativa economica
privata in Italia occorre, però, attendere la c.d. Carta del Lavoro, elaborata nella vigenza dell’ordinamento
corporativo fascista (21.4.1927) e contraddistinta, tuttavia, dall’accoglimento di un modello, per certi versi,
contrapposto perché di tipo funzionalista. La predetta Carta, infatti, pur affermando la residualità
dell’intervento dello Stato nella produzione economica («l’intervento dello Stato nella produzione economica
ha luogo soltanto quando manchi o sia insufficiente la iniziativa privata o quando siano in gioco interessi
politici dello Stato»), espressamente qualificava l’iniziativa economica privata come «lo strumento più efficace e
più utile nell’interesse della Nazione» finalizzato al perseguimento degli obiettivi di «benessere dei singoli e
sviluppo della potenza nazionale», specificando che l’organizzazione privata della produzione è una «funzione
di interesse nazionale» e che «l’organizzazione dell’impresa è responsabile dell’indirizzo della produzione di
fronte allo Stato». La «produzione economica» - al perfezionamento della quale si riteneva concorressero non
solo coloro che svolgevano un’attività organizzata di impresa, ma anche coloro che esercitavano una libera
professione o un’arte - era oggetto, in linea di principio, dell’iniziativa economica dei privati, consentendosi allo
Stato di intervenire, nelle forme del «controllo, incoraggiamento e della gestione diretta» non solo, in un’ottica
197
sussidiaria, nei casi di assenza o insufficiente esercizio dell’iniziativa privata, ma anche nel caso più significativo
del ricorrere della necessità di realizzare gli «interessi politici dello Stato».
1.3 L’art. 41 Cost. nel dibattito in Assemblea Costituente: i «dilemmi» di una formula
La questione del rapporto fra iniziativa economica privata e pubblica, già delineata e risolta nei termini
succintamente richiamati dalla Carta del Lavoro, è stata anche una delle questioni poste al centro del dibattito
svoltosi in Assemblea Costituente in relazione all’approvazione delle disposizioni della nuova Costituzione
repubblicana relative all’attività economica. È noto, infatti, che il testo dell’attuale art. 41 non è che la risultante
finale di un dibattito acceso testimoniato dalla redazione, in sede di III Sottocommissione, di due distinti
articoli (artt. 37 e 39) espressivi di due diverse visioni dell’attività economica, cui erano sottese differenti
opinioni circa la qualificazione dell’iniziativa economica privata e la definizione degli ambiti dell’intervento
dello Stato: l’una (espressa dall’art. 37) volta a configurare la medesima attività economica come interamente
finalizzata all’esclusivo perseguimento del benessere collettivo e dunque funzionalizzabile a fini sociali
(Mortati), fini definibili dallo Stato mediante «piani» dal contenuto vincolante per i privati; l’altra (contenuta
nell’art. 39), viceversa, volta a riconoscere l’iniziativa economica privata come libera e ad impedire però che
essa potesse recar danno all’utile pubblico. L’inconciliabilità delle tesi sottintese dalle richiamate disposizioni fu
la ragione della soppressione della previsione delle necessarie finalità da perseguire mediante l’attività
economica, privata e pubblica, di cui all’art. 37 (che, nel testo originario, avrebbe dovuto precedere ogni altra
affermazione sull’iniziativa economica) e del sostanziale recepimento del testo dell’art. 39, al quale finiva con
l’essere aggiunto quel 2° co. dell’originario testo dell’art. 37 del progetto, nella sua versione però «depurata» in
quanto volta ad evitare che, in sede di programmazione economica nonché di determinazione legislativa di
forme di indirizzo e coordinamento dell’attività economica pubblica e privata a fini sociali, l’iniziativa
economica privata potesse essere negata mediante l’adozione di «piani» vincolanti per i privati. È evidente che
in tale modo si operava una scelta in favore del riconoscimento dell’iniziativa economica privata in termini di
libertà (1° co. dell’attuale art. 41): e tuttavia, da un lato, la si corredava di una serie di limiti, penetranti ed
importanti, corrispondenti al non contrasto con la sicurezza, la libertà, la dignità umana, ma soprattutto con
l’utilità sociale (2° co.), formula fortemente criticata per la sua «pericolosa genericità» da Einaudi; dall’altro, la si
«assoggettava» alla possibilità che il legislatore statale intervenisse a determinare programmi, a prevedere
controlli per indirizzare e coordinare la medesima iniziativa a fini sociali, così da indurre addirittura taluno in
dottrina a qualificare la norma che ne era risultata come «indeterminata nel suo nucleo politico centrale» e
«anfibologica», suscettibile, cioè, di essere sviluppata in due opposte direzioni. È infatti il peculiare «statuto»
dell’attività economica delineato dall’art. 41 Cost. - e, più ancora, la considerazione delle diverse «anime» che
all’elaborazione del medesimo avevano contribuito - ad aver provocato, in specie all’indomani dell’entrata in
vigore della Carta costituzionale, tante e così diverse e contrastanti interpretazioni, al punto da fare della
disposizione in esame una delle disposizioni costituzionali di più controversa interpretazione, ma anche ad un
tempo la «chiave di volta» dell’intera Costituzione economica italiana, intesa - quest’ultima - nel suo significato
«neutro» di insieme delle disposizioni costituzionali inerenti ai rapporti economici.
Da un lato, infatti, l’esplicita - ed innegabile - proclamazione della libertà di iniziativa economica e la
inevitabile connessione di quest’ultima non solo con la consacrazione costituzionale della proprietà privata (art.
42) - peraltro demandata, quanto al riconoscimento ed alla garanzia, al legislatore ordinario -, ma soprattutto
con le altre libertà individuali, in quanto ritenuta espressione della personalità umana in un ordinamento
costituzionale che pone al proprio centro lo sviluppo della persona umana (i diritti di quest’ultima), non poteva
non indurre a ritenere accolta nel sistema quella «certa dose di liberismo economico» auspicata da Einaudi
come garanzia della stessa «libertà di pensare». Dall’altro, il mancato espresso riconoscimento dell’inviolabilità
di siffatta libertà, nonché l’apprestamento di vincoli assai più rigidi e penetranti di quelli previsti per le libertà
civili all’esercizio della medesima, hanno fornito il fondamento giustificativo di quelle ricostruzioni che hanno
assegnato alla predetta libertà uno status di libertà «dimidiata», di un rango diverso ed inferiore rispetto alle
libertà civili, non configurabile, diversamente da queste ultime, come diritto fondamentale e conseguentemente
priva dei caratteri ritenuti propri (solo) di siffatti diritti, ove non addirittura, pur in contrasto con le risultanze
dei lavori preparatori (e con la configurazione stessa di un diritto di libertà), di situazione soggettiva
funzionalizzabile al mero perseguimento di quei fini di utilità sociale individuati dall’attività pubblica di
programmazione dell’attività economica letta come «pianificazione» vincolante ed autoritativa, in linea peraltro
con quelle altre previsioni della Costituzione economica italiana di cui all’art. 43 in tema di collettivizzazioni
nonché di cui all’art. 42 in tema di «funzione sociale» della proprietà privata.
198
Ora, ove si escludano le interpretazioni della disposizione in esame adottate - all’indomani dell’entrata in
vigore della Costituzione repubblicana - sulla suggestione di quelle posizioni presenti in Assemblea Costituente
anche se rimaste sconfitte nel dibattito sull’approvazione delle norme relative ai rapporti economici,
vistosamente incompatibili con il dettato costituzionale, appare ragionevole la molteplicità delle opzioni
interpretative suscitate dal peculiare «statuto» dell’iniziativa economica privata delineato non solo dalla
medesima disposizione in esame o dalle altre disposizioni costituzionali relative ai rapporti economici, ma
anche - e forse soprattutto - dalla inevitabile connessione di queste ultime con i principi fondamentali, di
eguaglianza oltre che di libertà, accolti dalla Costituzione repubblicana come cardini dell’intero ordinamento
democratico. Alla stessa accusa rivolta nei confronti della normativa contenuta nell’art. 41 in esame di essere,
non solo di difficile interpretazione, ma «disarmonica» o addirittura «contraddittoria» e «di compromesso» per
il fatto di contenere ad un tempo l’affermazione di valori di libertà individuale ed il riconoscimento di esigenze
di controllo e programmazione delle attività dei singoli da parte dei pubblici poteri nel nome di valori sociali e
di interessi generali, è stata opposta (dalla dottrina ma più ancora dalla giurisprudenza costituzionale) la
possibilità, anzi la necessità di una lettura unitaria della stessa norma, proprio alla stregua di quei principi
fondamentali caratterizzanti il «nuovo» ordinamento costituzionale e volti ad esaltare la centralità della persona
umana, in specie dei diritti assegnati a quest’ultima (in primo luogo dei diritti di libertà), in un’ottica di (eguale)
garanzia dei singoli e delle formazioni sociali da essi create, nei confronti dei poteri pubblici e privati. In questa
medesima prospettiva si è ritenuto di rintracciare nell’art. in esame il fondamento di un sistema ad «economia
mista» (formula, questa, aspramente criticata), corrispondente non già ad un modello economico preciso, ma
semplicemente ad un sistema risultante dal contemporaneo riconoscimento della libera iniziativa privata - che
non deve, tuttavia, svolgersi in contrasto con l’utilità sociale né in modo da recar danno alla sicurezza, alla
libertà ed alla dignità umana, su cui è fondato il sistema costituzionale - e da forme (eventuali) di intervento
pubblico volte ad indirizzare e coordinare «a fini sociali» l’attività economica pubblica e privata.
1.4 L’art. 41 Cost. secondo il diritto comunitario
Le richiamate ambiguità sottese alla formula dell’art. in esame, quindi, sono state, almeno in parte,
presto fugate dagli indirizzi della prevalente giurisprudenza costituzionale, affermatisi sin dai primi interventi
della Corte costituzionale sul punto (nonché di una parte della dottrina), nel segno del riconoscimento e della
garanzia della iniziativa economica privata come diritto di libertà e dell’esclusione della funzionalizzazione del
diritto, oltre che dal fallimento di quell’unica esperienza di legge di programmazione, la l. 685/1967 contenente
il «primo piano quinquennale», unanimemente classificata, in ragione dell’assenza in essa di qualunque
contenuto normativo, «libro dei sogni». E tuttavia è solo con l’accelerazione del processo di integrazione
europea avutasi all’inizio degli anni novanta - oltre che con il consolidamento del «primato» del diritto
comunitario - che talune opzioni interpretative sono state definitivamente estromesse dal sistema, ritenendosi
così avviato quello che è stato qualificato come il «processo di emancipazione dallo schema dirigistico
prefigurato dalla Costituzione». La scelta in favore del «principio di un’economia di mercato aperta e in libera
concorrenza» (art. 4.2 TCE), il divieto di aiuti pubblici alle imprese, unitamente con la proclamazione della
libertà di circolazione dei capitali, delle merci, dei servizi e delle persone, immediatamente vincolanti per le
politiche economiche degli Stati membri, hanno inevitabilmente inciso sulla portata dell’art. 41 imprimendo a
quest’ultimo caratteri in parte nuovi, di cui il legislatore ordinario si è, in alcuni casi, fatto carico di assicurare
gli «svolgimenti». È così che, da un lato, - in linea con l’affermazione comunitaria della centralità della tutela
della concorrenza, «raccolta» e «sviluppata» dal legislatore ordinario, in particolare, con la l. 287/1990 - si sono
dispiegate le virtualità concorrenziali «nascoste» nelle pieghe del 1° co. dell’art. in esame (non da tutti condivise
in dottrina), ravvisandosi la libertà di concorrenza come naturale espressione dello svolgimento della libertà di
iniziativa economica (oggi confermata dall’espressa consacrazione costituzionale della «tutela della
concorrenza» nell’art. 117, 2° co., come sostituito dalla l. cost. 3/2001), e si è desunto dalla medesima
previsione l’implicito riconoscimento (e l’implicita, connessa tutela) del mercato (concorrenziale) inteso come
sistema oggettivo capace di esprimere il massimo realizzabile di efficienza economica e di crescita del tenore di
vita collettivo; dall’altro, si sono fortemente ridimensionate quelle indicazioni di cui al 2° e 3° co. (fino al punto
di indurre a ritenere le medesime previsioni «quiescenti» al pari di quelle di cui all’art. 43) volte a legittimare gli
interventi pubblici nell’economia, anche alla luce di quel principio di «sussidiarietà orizzontale» consacrato
dall’ordinamento comunitario, appunto, e volto a sanzionare definitivamente la recessività dell’intervento
pubblico in economia, la sua progressiva riduzione ove non la sua emarginazione a fronte del riconoscimento
della competenza generale e prioritaria del privato in materia economica.
199
2. Commento
2.1 La nozione di «iniziativa economica»: l’«oggetto» tutelato dalla norma
L’elevata problematicità (richiamata supra) della interpretazione della disposizione in commento è
subito dimostrata da quello che è stato, per molto tempo, un primo, centrale snodo interpretativo: quello della
identificazione dell’oggetto tutelato dalla norma. Si sono, infatti, contrapposte, in dottrina, ipotesi molto
diverse, con conseguenze ricostruttive talora inconciliabili. In primo luogo, si è ritenuto di distinguere
l’«iniziativa economica» dal suo «svolgimento», ravvisando la prima nel solo atto propulsivo dell’attività
(corrispondente alla decisione se intraprendere o meno un’attività economica e comprensivo della eventuale
destinazione dei capitali al processo produttivo) di cui si è postulata l’assoluta libertà, il secondo, viceversa nella
disciplina dello svolgimento della medesima attività ed in particolare nella disciplina dell’impresa, ritenuta al
contrario assoggettata ai penetranti limiti di cui al 2° (ed al 3°) co. della medesima norma e, per certi versi, del
tutto estranea al medesimo raggio d’azione della libertà.
Di tale ipotesi, che delineava una «frattura» interna della norma identificando, quindi, due distinti oggetti
della stessa, è stata - fin da epoca risalente - esclusa la fondatezza, in particolare dalla giurisprudenza
costituzionale che ha, in ripetute occasioni, affermato che la «garanzia posta nel 1° co. di quest’articolo [...]
riguarda non soltanto la fase iniziale di scelta dell’attività, ma anche i successivi momenti del suo svolgimento»,
riconoscendo così l’unitarietà dell’oggetto tutelato dalla norma e la conseguente necessaria applicazione anche
all’atto di iniziativa dei limiti posti dal 2° (e dal 3°) co. della stessa.
Tale soluzione non ha tuttavia sciolto definitivamente il nodo dell’oggetto tutelato dalla norma in esame.
Altre ipotesi ricostruttive sono state, infatti, elaborate sul punto ed hanno portato alla prefigurazione di ulteriori
scenari confliggenti.
Da un lato, vi è chi ha ritenuto di dover ricondurre all’art. in esame la sola attività di impresa, in ragione
della parentela lessicale tra le parole «iniziativa» ed «intrapresa» economica connesse all’aggettivazione
«economica» nonché alla definizione di imprenditore di cui al c.c. come colui che esercita professionalmente
un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi (art. 2082 c.c.),
facendo leva anche sull’idea che solo l’esercizio di una simile attività (corrispondente all’esercizio di un «fascio
di libertà» fra cui la libertà di disporre dei beni, la libertà di investire i capitali, la libertà di destinarli alla
produzione o allo scambio di beni o servizi o all’acquisizione di ricchezza, la libertà contrattuale, il potere di
organizzare il processo produttivo) potesse giustificare l’eventualità, contemplata dal 2° co. della disposizione in
esame, di uno svolgimento contrastante, in particolare, con la «dignità umana» e quindi la necessaria
apposizione di limiti (con conseguente giustificazione della esclusione della configurazione della libertà
economica come diritto della persona ed affievolimento della stessa).
Dall’altro, si è delineata la tesi di chi viceversa ha rintracciato nell’art. 41 la copertura costituzionale di
ogni atto con cui il soggetto sceglie il fine economico che intende perseguire e, in via immediata, l’attività con
cui organizza i mezzi per raggiungerlo, in linea con l’idea della configurazione della libertà economica come di
un diritto di libertà propria della persona, giungendo a comprendervi non solo l’esercizio di una libera
professione, ma anche la prestazione di lavoro subordinato o addirittura la scelta di formare organizzazioni
sindacali di categoria o di aderire ad organizzazioni sindacali già esistenti.
Ora, al di là della complessità logica di una riconduzione di attività quali l’adesione o anche la
formazione di organizzazioni sindacali di categoria o anche dello stesso lavoro subordinato al concetto di
«iniziativa economica», occorre ricordare che tale tesi è stata, nei suoi estremi sviluppi, disattesa dalla
prevalente dottrina e dalla stessa giurisprudenza costituzionale, la quale, tuttavia, sulla scia delle indicazioni dei
lavori preparatori della Costituzione, ha egualmente escluso la riconducibilità alla sola attività di impresa
dell’«iniziativa economica privata», essendo l’impresa soltanto una delle forme di esercizio dell’attività
economica, rintracciando nella disposizione in commento il fondamento costituzionale (e la disciplina) anche
di altre attività economiche sebbene non organizzate ad impresa, quali quelle occasionali o anche il lavoro
autonomo, fino in alcuni casi a comprendervi (non senza vivaci critiche) l’esercizio di attività economiche
consistenti nelle professioni intellettuali
Quanto, infine, alla possibilità di rintracciare nelle maglie della disposizione in commento un autonomo
fondamento della libertà contrattuale, essa si è ritenuto potesse ravvisarsi solo ove fosse stata accolta la nozione
ampia di iniziativa economica privata di cui si è detto sopra, corrispondente ad ogni attività da cui possa
derivare un vantaggio economico a chi la svolge: una volta accantonata, come si è visto, tale ipotesi, la libertà
contrattuale finisce con il risultare costituzionalmente fondata solo in quanto si riveli strumentale alla
realizzazione di una situazione soggettiva espressamente protetta dalla Costituzione e corrispondente, ad
200
esempio, alla libertà di iniziativa economica o al diritto di proprietà, cosicché ogni limite posto alla libertà
contrattuale si rivela legittimo - come affermato dalla Corte costituzionale - solo in quanto «preordinato al
raggiungimento degli scopi previsti e consentiti dalla Costituzione» in relazione alla situazione sostanziale e
quindi anche in relazione all’iniziativa economica.
2.2 I limiti del 2° co. e la questione della riserva di legge
Al di là della questione della complessità (ove non dell’impossibilità) di una elencazione di tutte le
attività specificamente riconducibili all’iniziativa economica di cui all’art. in esame, le indicazioni richiamate in
relazione all’oggetto tutelato dalla norma confermano il dato dell’unitarietà della disposizione in esame,
almeno alla stregua degli indirizzi ormai più che consolidati della giurisprudenza costituzionale. Questo
comporta la conseguenza - segnalata sin da epoca assai risalente da una parte della dottrina - per la quale il 2°
co. dell’art. in esame fa corpo con la proclamazione di libertà del 1° co. cosicché deve ritenersi che «il diritto di
cui al 1° e al 2° co. dell’art. 41 non è riconosciuto dalla Costituzione in modo assoluto, ma solo entro i limiti
fissati dal 2° co. dell’articolo stesso», limiti esterni al diritto, i quali incidono quindi sulla configurazione della
situazione soggettiva di libertà. Quanto a tali limiti - che corrispondono al riconoscimento di altrettanti principi
costituzionali, quali la libertà, la sicurezza, la dignità umana, nonché l’utilità sociale - si è posto il problema
della loro operatività e si sono, anche in tal caso, fronteggiate due distinte tesi: l’una, confortata fin da epoca
risalente dal conforme indirizzo della giurisprudenza costituzionale, secondo la quale essi sarebbero oggetto di
una riserva di legge implicita, desumibile dagli stessi «principi generali informatori dell’ordinamento
democratico secondo i quali ogni specie di limite imposto ai diritti dei cittadini abbisogna del consenso
dell’organo che trae da costoro la propria diretta investitura»; l’altra che, viceversa, ne sostiene l’immediata
precettività, ritenendo che, «indipendentemente da leggi che diano maggiore precisione o concretizzazione alle
formule adottate dalla Costituzione lì dove essa stabilisce limiti, divieti o binari per lo svolgimento delle
iniziative, i singoli siano tenuti a rispettare i limiti fissati dall’art. 41, 2° co., Cost., i giudici a decidere sul loro
rispetto e le autorità esecutive, nei limiti della propria competenza, ad imporne l’esecuzione anche attraverso
l’emissione di atti regolamentari». Quest’ultima tesi - che dietro l’idea dell’esistenza di una riserva di legge
implicita in materia di limiti all’iniziativa economica privata ravvisa la inammissibile sopravvivenza, sotto
mentite spoglie, della configurazione delle disposizioni costituzionali come meramente programmatiche (che
aveva avuto «qualche successo» appena entrata in vigore la Costituzione repubblicana, ma che era stata, poi,
presto superata in buona misura grazie al contributo della giurisprudenza costituzionale) - è stata ripresa e
«sviluppata», in dottrina, con particolare riferimento agli interessi e diritti costituzionali contemplati nella
seconda parte del 2° co. dell’art. in esame. Si è cioè evocata l’idea dell’immediata precettività della previsione
dei limiti all’iniziativa economica privata corrispondenti alla tutela della libertà, della dignità umana e della
sicurezza, interessi e diritti già espressamente contemplati in altre disposizioni costituzionali e quindi già
immediatamente efficaci nei confronti dell’operatore economico sotto forma di doveri di rispetto delle
situazioni giuridiche soggettive costituzionalmente tutelate (i diritti di libertà del dipendente e del terzo, la
sicurezza del dipendente e del terzo, la dignità del dipendente e del terzo), ma suggestivamente richiamati
attraverso la «formula omnicomprensiva» del 2° co. dell’art. in commento a fini di ulteriore garanzia
dell’immediato rispetto dei medesimi da parte di chiunque eserciti la libertà economica. Detta preoccupazione
- di assicurare il rispetto di quei diritti ed interessi già costituzionalmente tutelati - si è ritenuto, d’altro canto,
che si giustificasse anche in considerazione delle peculiari caratteristiche della libertà economica, la quale si
realizza prevalentemente attraverso atti giuridici aventi contenuto patrimoniale, implica la trasmissibilità,
rinunciabilità e disponibilità dei singoli diritti che al titolare spettano sui vari beni costituenti l’azienda, ecc.,
caratteristiche che rendono ragione di una maggiore compressione della medesima nell’ipotesi di contrasto con
i suddetti diritti ed interessi, e che costituiscono fondamento giustificativo, ad un tempo, della configurazione
della predetta libertà come «diritto non essenziale della persona» ovvero della più estrema esclusione sostenuta da altra dottrina, ma contraddetta dalla giurisprudenza costituzionale - della medesima libertà dal
novero dei diritti fondamentali, ritenuti dotati di un rango superiore e di caratteristiche quindi peculiari (fra cui,
ad esempio, l’irrivedibilità), con conseguenze perciò assai più radicali sulla qualificazione della libertà in
commento. Proprio le predette caratteristiche peculiari della libertà in commento, d’altro canto,
giustificherebbero la necessità dell’intervento del legislatore ordinario, a prescindere dall’esistenza o meno di
una riserva di legge implicita, tutte le volte in cui tale libertà possa essere pregiudicata dalla imposizione di un
obbligo o di un divieto di carattere personale o patrimoniale (ai sensi dell’art. 23 Cost.) o anche allorquando come in molte delle ipotesi cui si riferivano le decisioni della Corte costituzionale nelle quali è stata affermata
l’esistenza di una riserva di legge implicita - detto intervento si riveli doveroso al fine di soddisfare il principio
201
di legalità dell’azione amministrativa (ai sensi dell’art. 97 Cost.), delineandosi l’attribuzione di compiti o di
poteri alla P.A.. In favore, tuttavia, del riconoscimento dell’esistenza di una riserva di legge implicita nel 2° co.
dell’art. in esame, vanno, come si è detto, le indicazioni della Corte costituzionale, la quale, sin da epoca assai
risalente, ha ritenuto di rintracciare, nelle pieghe delle disposizioni costituzionali in materia economica (artt.
41, 42, 43 e 44), «una chiara ispirazione unitaria, della quale la regola della riserva di legge, pur senza che si
possa negare una certa sua varia modulazione, rappresenta sicuramente una costante»: costante che
sembrerebbe confermata dallo stesso testo dell’art. 41 in esame, il quale, prevedendo espressamente, al 3° co.,
il necessario intervento del legislatore ordinario per la determinazione dei programmi e controlli opportuni
«perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali» (per la
definizione cioè di quelli che sono stati configurati come i limiti «positivi» dell’attività economica privata), si è
ritenuto che non possa non esigere egualmente ancorché implicitamente, anche per i limiti negativi di cui al 2°
co., il medesimo intervento del legislatore ordinario. E ciò tanto più ove si tenga conto che, fra i predetti limiti
«negativi» di cui al 2° co., ve ne è uno, quello del non contrasto con «l’utilità sociale», la cui vaghezza ed
indeterminatezza ne rende quanto meno complessa l’immediata operatività, implicando l’opportunità, ove non
la necessità, dell’intermediazione del legislatore.
2.3 Il limite dell’utilità sociale: il contributo della giurisprudenza costituzionale
Quanto a quest’ultimo limite, è noto che fu oggetto del più acceso e contrastato dibattito, sin dal suo
primo appalesarsi, in ragione della ritenuta difficile qualificazione della formula impiegata, tanto ampia (e
generica) da essere considerata, in sede di Assemblea Costituente, da Einaudi, addirittura inconoscibile, in
quanto espressiva di una norma indeterminata ed indeterminabile. Di una simile formula - che ha inciso ed
incide non poco sulla stessa qualificazione della natura dell’iniziativa economica privata (diritto di libertà non
fondamentale, situazione soggettiva funzionalizzabile, ecc.) - sono state proposte le più varie interpretazioni, e si
sono delineati i più diversi contenuti, ravvisandosi in essa ora l’esigenza di raggiungere i massimi livelli di
occupazione, attraverso una lettura proposta da Mortati che congiungeva in maniera sistematica l’art. 41 all’art.
4 Cost., ora il «recupero» della nozione utilitaristica di Bentham secondo cui essa corrisponderebbe alla
«maggior quantità di benessere per il maggior numero possibile di uomini», ora ancora il «benessere
economico collettivo» inteso quale «progresso materiale di tutti in condizioni di eguaglianza». In
considerazione della oggettiva difficoltà di identificare una precisa definizione di «utilità sociale» e della
«irriducibile poliedricità» della medesima, riferibile a due distinti campi applicativi costituiti ora dai rapporti
interni dell’unità produttiva, ora dalla sua attività rivolta all’esterno, e quindi riferibile ora ai bisogni dei
lavoratori dipendenti, ora a quelli dell’intera società ovvero di quei soggetti che nella singola fattispecie si
presentino investiti dell’interesse sociale, si è proposta la qualificazione dell’utilità sociale quale «principiovalvola» che consente «l’adattamento dell’ordinamento al mutare dei fatti sociali», ma anche quale «concetto di
valore» intriso di «giustizia sociale», che partecipa dei caratteri dei valori costituzionali che connotano
l’ordinamento, e che quindi è teso alla realizzazione di quel progetto di trasformazione della società italiana
voluto dal 2° co. dell’art. 3 Cost.. In tal modo, se da un lato si è esclusa ogni forma di «pietrificazione» della
nozione di utilità sociale attraverso un unico intervento del legislatore, dall’altro si è riconosciuto il rilevante
ruolo dello stesso nella individuazione delle singole (e svariate) fattispecie normative nelle quali si rintracci
l’utilità sociale, ma soprattutto si è evidenziato il fondamentale compito dell’organo di giustizia costituzionale,
chiamato a verificare, in virtù della propria posizione istituzionale di garante della Costituzione, in primo luogo
i fini effettivamente perseguiti dalla legge (nel nome della necessità di evitare il contrasto con l’utilità sociale) e
l’idoneità dei mezzi predisposti a perseguirli. Detto controllo (di cui si è sottolineata la estrema delicatezza in
ragione del carattere complesso del parametro sia in relazione alla sua formazione, vale a dire al «ricorso a
criteri non espressamente codificati o, come pure si dice impropriamente, extragiuridici», sia in relazione alla
sua struttura, vale a dire alla «mutabilità e mobilità degli specifici valori che vi si incarnano»), è stato, sin da
tempi assai risalenti, svolto dalla Corte costituzionale, la quale, a partire dalla sentenza 14/1964, ha provveduto
a delineare i confini del proprio intervento, riconoscendosi competente a sindacare la palese contraddizione
dei fini di utilità sociale perseguiti dal legislatore con i presupposti di fatto accertabili, la non assoluta inidoneità
dei mezzi predisposti dal legislatore rispetto allo scopo ed infine il perseguimento di finalità palesemente
diversa da quella di utilità sociale formalmente indicata. Le caratteristiche di un simile sindacato - sebbene non
sempre identicamente svolto, ma talora connotato in termini più «formali» in quanto volto a verificare solo la
riconducibilità dei fini perseguiti dalla legge allo spettro delle possibilità consentite dalle clausole costituzionali,
altre volte invece più penetrante ed incisivo sulle scelte operate dal legislatore - rendono arduo desumere dalle
pronunce della Corte una nozione di «utilità sociale» puntualmente definita, non solo in ragione del risvolto
202
«negativo» del controllo (sono censurate le scelte del legislatore che non corrispondono ad una «utilità
sociale»), ma anche per la varietà dei fini di volta in volta ritenuti idonei a configurare la predetta utilità sociale.
E tuttavia, se una precisa definizione di utilità sociale si rivela inaccessibile, è comunque possibile rintracciare,
al fondo delle decisioni in tema una «logica comune» corrispondente al principio «secondo cui sono di utilità
sociale quei beni che non solo sono ritenuti tali dal legislatore ma che godono anche e soprattutto di diretta
protezione e garanzia in Costituzione», che coincidano cioè con altri interessi o diritti costituzionalmente
tutelati, quali, ad esempio, la salute, l’ambiente, il diritto al lavoro, ecc., interessi e diritti la cui tutela imponga,
nel bilanciamento con l’iniziativa economica privata, una limitazione di quest’ultima, proprio alla stregua del 2°
co. dell’art. 41 in commento. A tal proposito si è osservato che esisterebbe una sorta di «nucleo minimo» del
concetto di utilità sociale corrispondente al complesso di «valori che la Costituzione protegge con norme
specifiche in materia di libertà personale, sindacale, di espressione e di informazione, di insegnamento; di
diritto alla salute, al salario «sufficiente», all’assistenza e previdenza; di tutela del paesaggio [...]», non tutti
riconducibili ai limiti di cui alla seconda parte del 2° co. dell’art. 41 e cioè ai limiti della libertà, sicurezza e
dignità, ma riferibili anche ad altre situazioni soggettive espressamente protette dalla Carta costituzionale, come
ad esempio quelle relative ai diritti sociali, in particolare ove considerati in relazione ai loro presupposti storici
di strumenti di attuazione della libertà eguale. In questa direzione vanno quelle decisioni nelle quali la Corte ha
riconosciuto il fondamento costituzionale di utilità sociale di quelle limitazioni poste dal legislatore all’attività
imprenditoriale nel nome della tutela del diritto dei lavoratori al riposo settimanale o del diritto al
mantenimento e all’assistenza sociale o della tutela della donna lavoratrice. Non contraddicono quanto sopra
evidenziato, anzi sembrano confermare la tesi della esistenza di un «nucleo minimo» della nozione di utilità
sociale in parte coincidente con i limiti di cui alla seconda parte del 2° co. della norma in commento, quelle
decisioni della Corte nelle quali si sono individuati, contestualmente, come fondamenti costituzionali delle
limitazioni poste all’iniziativa economica privata dal legislatore, sia i limiti di cui alla seconda parte del 2° co.
dell’art. in commento, sia il limite dell’utilità sociale, quasi a «rafforzare» la scelta operata dal legislatore e a
suggerire una sostanziale contiguità fra gli indicati limiti nel nome della tutela dei diritti e degli interessi
costituzionalmente tutelati e quindi della necessità di un contemperamento degli stessi con la libertà di
iniziativa economica. È così che la Corte ha rintracciato il fondamento del limite posto all’iniziativa economica
avente ad oggetto il gioco d’azzardo nel contrasto con l’utilità sociale oltre che nel danno a libertà, sicurezza e
dignità umana arrecato dal gioco d’azzardo; così pure ha ritenuto di ravvisare una ragione di utilità sociale
nell’abolizione del lavoro notturno dei fornai necessario a garantire la salute - e quindi anche la sicurezza - dei
fornai Il riferimento al limite dell’utilità sociale, congiuntamente ai limiti della libertà, sicurezza e dignità, ha,
d’altra parte, caratterizzato la giurisprudenza costituzionale degli anni novanta, con particolare riferimento alla
tutela del diritto dell’individuo a vivere in un ambiente non degradato: se, infatti, nella sentenza 427/1995, la
Corte, chiamata a pronunciarsi sul condono edilizio, ha rigettato le censure prospettate in relazione alla
presunta lesione di interessi costituzionalmente protetti quali la dignità umana, minacciata dall’abusivismo
edilizio, ritenendo detti interessi, corrispondenti all’utilità sociale, adeguatamente tutelati dai rilevanti limiti
posti al condono (sul tema è «tornata» nella recente sentenza 196/2004, nella quale ha sottolineato il necessario
contemperamento fra gli interessi coinvolti, realizzato nel nome dell’utilità sociale, dalla disciplina sul condono
quali la tutela del paesaggio, della cultura, della salute, oltre che di quegli altri interessi, pure di fondamentale
rilevanza sul piano della dignità umana, dell’abitazione e del lavoro), nella ord. 186/1996, in tema di rifiuti
speciali di origine industriale, assimilabili agli scarichi tossici e nocivi, ha rintracciato il fondamento giustificativo
degli obblighi di comunicazione inerenti alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti non tanto e non solo nel
limite dell’utilità sociale (più volte successivamente connesso alla tutela dell’ambiente), quanto esplicitamente
nel limite della sicurezza, libertà e dignità umana «da ricollegarsi anche alla tutela dell’ambiente» in cui
l’individuo vive.
In alcuni casi, tuttavia, è più arduo rinvenire le tracce di quella «logica comune» alla maggior parte delle
pronunce della Corte sul tema di cui si è detto prima: è accaduto, infatti, in alcune occasioni, che siano stati
ritenuti di «utilità sociale» interessi attinenti alla sfera squisitamente economica, più difficilmente riconducibili
alle previsioni espresse di cui alla carta costituzionale e corrispondenti a valori economici generali quali
l’incremento della produzione, «l’equilibrio locale di mercato tra domanda e offerta», i «valori aziendali» della
concorrenzialità e competitività delle imprese nonché il «sistema economico produttivo vigente», tutti valori il
cui fondamento è rintracciato nella stessa proclamazione costituzionale della libertà di iniziativa economica
anche se sganciati dalla sfera della libertà di iniziativa ed ancorati piuttosto al mercato inteso quale struttura
oggettiva. Di quest’ultimo - del cui implicito (e consapevole) riconoscimento nelle maglie del medesimo art. 41,
in sede di Assemblea Costituente, si è, in dottrina, dubitato, rintracciandosi la «scoperta» del medesimo solo
sulla scia dell’integrazione comunitaria - si sono rinvenuti i caratteri di quei fini di utilità sociale «ai quali deve
203
essere finalizzata l’attività imprenditoriale», nonostante essi si siano risolti in una compressione ad un tempo di
diritti ed interessi «altri», quali ad es. i diritti dei lavoratori subordinati dell’impresa, ed anche degli stessi diritti
di iniziativa economica degli altri operatori, in una prospettiva di prevalenza della protezione del «sistema
economico vigente». Si è, in altri termini, finito con l’intendere l’utilità sociale come una sorta di «ordine
pubblico economico», ma in un senso che sembrerebbe piuttosto distante da quello fatto proprio dalla dottrina
francese ed accolto, sulla suggestione di quest’ultima, anche in Italia, già sul finire degli anni sessanta: non già,
infatti, come la risultante della «combinazione» del principio di libertà (di iniziativa economica privata) con il
principio di giustizia, rispetto al cui soddisfacimento il miglioramento delle condizioni economiche
complessive o l’efficienza del sistema economico possano rivelarsi strumentali, ma piuttosto come l’insieme
delle ragioni della produttività e dell’efficienza del sistema economico nazionale (le ragioni del «mercato»),
elevate a ragioni giustificatrici del sacrificio delle sfere di libertà del soggetto, ivi compresa la libertà economica
costituzionalmente consacrata. Tale «eterogenesi» dei fini di utilità sociale - contraddetta in altre decisioni della
Corte, nelle quali si è viceversa sottolineato il carattere meramente strumentale dell’efficienza del sistema
economico complessivo rispetto ai principi di libertà ed eguaglianza - si sarebbe determinata in corrispondenza
della affermazione comunitaria, enfatizzata dalla accelerazione del processo di integrazione, del mercato
concorrenziale e della conseguente necessità di leggere le disposizioni del dettato costituzionale in materia
economica in maniera conforme rispetto alle indicazioni comunitarie. Si accendeva così il dibattito attorno alla
possibilità di rintracciare nelle maglie della disposizione in commento il riconoscimento costituzionale della
libertà di concorrenza o ancora del mercato (concorrenziale) e non solo con riferimento alla clausola
dell’utilità sociale, come dimostrato dalla stessa l. 287/1990, la quale reca «norme per la tutela della
concorrenza e del mercato» «in attuazione dell’art. 41 Cost. a tutela e garanzia del diritto di iniziativa
economica».
2.4 Iniziativa economica privata e tutela della concorrenza
Se in dottrina si è da tempo sostenuto - sebbene con autorevoli voci dissenzienti - che fosse possibile
desumere, sulla base delle stesse indicazioni dei costituenti, dall’art. in commento il fondamento costituzionale
della libertà di concorrenza, come libertà per certi versi conseguente alla configurazione della libertà di
iniziativa economica quale libertà valevole erga omnes, e cioè non solo nei confronti dello Stato e dei pubblici
poteri ma anche nei confronti degli altri privati, così da qualificarla quale «eguale possibilità» di tutti i privati «di
attivarsi materialmente e giuridicamente nello stesso settore» e quindi «di confrontarsi vicendevolmente,
sottoponendo al giudizio del mercato la valutazione, e il conseguente successo, delle reciproche iniziative,
necessariamente sempre nuove e diverse, in una competizione senza fine», si è anche rilevato che solo con
l’adesione dell’ordinamento italiano all’ordinamento comunitario, ed in particolare con gli sviluppi di
quest’ultimo, si sono forniti robusti strumenti di tutela della concorrenza, e di resistenza nei confronti di quelle
letture dei limiti posti all’iniziativa economica privata dallo stesso 2° co. dell’art. in esame volte a determinarne
una surrettizia estensione in favore dell’intervento diretto dello Stato nell’economia, fino a giungere alla
consacrazione costituzionale espressa della concorrenza, operata dall’art. 117 come modificato dalla l. cost.
3/2001, quale bene o fine o valore costituzionalmente rilevante da perseguire, assegnato, nell’ambito della
nuova ripartizione di competenze fra diversi livelli territoriali di governo, alla potestà legislativa esclusiva dello
Stato. Tale percorso interpretativo - che si snoda lungo traiettorie non sempre identiche, muovendo dalla
libertà di concorrenza e passando attraverso il mercato concorrenziale comunitario e la concorrenza tout court
di cui al nuovo art. 117 - ha coinciso con una diversa declinazione della concorrenza nella stessa
giurisprudenza costituzionale. E, infatti, se è possibile rinvenire in alcune decisioni più risalenti della Corte la
qualificazione della concorrenza quale libertà che «integra la libertà di iniziativa economica che spetta nella
stessa misura a tutti gli imprenditori» ed è ad un tempo «diretta alla protezione della collettività, in quanto
l’esistenza di una pluralità di imprenditori, in concorrenza tra loro, giova a migliorare la qualità dei prodotti ed
a contenerne i prezzi», o ancora quale «valore basilare della libertà di iniziativa economica [...] funzionale alla
protezione degli interessi dei consumatori», è nelle decisioni più recenti che sembra sfumare il richiamo alla
concorrenza nei termini di libertà ed accentuarsi invece una diversa «dimensione» della medesima nozione
proprio sulla suggestione delle indicazioni comunitarie. Nella sent. 14/2004 la Corte, infatti, non solo afferma
che «dal punto di vista del diritto interno la nozione di concorrenza non può non riflettere quella operante in
ambito comunitario, che comprende interventi regolativi, misure antitrust e misure destinate a promuovere un
mercato aperto e in libera concorrenza», ma precisa anche che la tutela della concorrenza «costituisce una delle
leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di
interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell’accezione dinamica, ben nota
204
al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un
sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali»: con ciò adombrando l’idea di una
valenza oggettiva del mercato concorrenziale, inerente non più tanto o comunque soltanto alle sfere di libertà
dei soggetti (comprensive della libertà di concorrenza, intesa come una sorta di «altra faccia» della libertà di
iniziativa economica dei soggetti) quanto al sistema economico oggettivamente considerato, in linea con quel
principio «ordinatore» della Comunità di un’«economia di mercato aperta e in libera concorrenza» (art. 4, 1°
co., TCE) per la realizzazione del quale sembra pertanto possibile il sacrificio o comunque la compressione
delle medesime sfere di libertà economica consacrate dall’art. in commento.
2.5 I «programmi» e i «controlli»
Nell’orizzonte dell’art. in esame in precedenza delineato, il riconoscimento della iniziativa economica
privata di cui al 1° co. come libertà consente di leggere i limiti ad essa apposti dal 2° co. come limiti «esterni»
all’attività economica privata: il che vuol dire che l’attività economica è garantita anche ove non persegua fini di
utilità sociale o non miri allo sviluppo della libertà, della sicurezza e della dignità umana, essendo sufficiente per soddisfare il precetto costituzionale - che essa non sia svolta in contrasto con tali valori. Nella medesima
prospettiva di riconoscimento e tutela della «libertà economica» si svela - di contro a letture «funzionaliste» che
non poca fortuna hanno avuto in particolare negli anni sessanta e settanta, sulla base di una fraintesa contiguità
con la disciplina delle collettivizzazioni prevista dall’art. 43 - la portata della previsione del 3° co. della
disposizione in commento, nella parte in cui attribuisce alla legge il compito (la facoltà) di determinare i
programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali. Si è, infatti, rilevato che, «se si ritiene che tra le attività economiche private rientrino
quelle che costituiscono lo svolgimento della libertà di iniziativa (art. 41, 1° e 2° co.), la conclusione è evidente:
la previsione di «fini sociali» da perseguire con programmi e controlli non può implicare negazione di quella
libertà». E infatti non può ritenersi che la legge determinativa di programmi e controlli abbia la capacità di far
venir meno il principio della libertà dell’iniziativa economica non solo in ragione della unitarietà dell’art. 41 (e
dei suoi tre commi), ma anche sulla base delle risultanze dei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, che
rivelano che, in sede di dibattito, la scelta dell’introduzione del termine «programmi» - in luogo di «piani» nonché del termine «controlli» implicasse un regime di libertà dell’iniziativa economica privata, pur soggetta a
limiti importanti: in questa chiave, la legge determinativa dei programmi e controlli già si riteneva non potesse
far altro che indicare degli obiettivi, dotati di una valenza puramente orientativa o persuasiva o «indicativa» (ad
esempio mediante misure di incentivazione), e non autoritativa, senza quindi incidere sulla libertà del privato
di determinare le proprie iniziative e di organizzarsi di conseguenza. Il che è stato in più occasioni ribadito
dalla stessa Corte costituzionale, la quale ha precisato che i «programmi» ed i «controlli» non devono essere tali
da sopprimere l’iniziativa privata ma solo da indirizzarla e condizionarla, e che - sebbene non debbano essere
tali da condizionare le scelte imprenditoriali in grado così elevato da indurre sostanzialmente la
funzionalizzazione dell’attività economica di cui si tratta, sacrificando le opzioni di fondo o restringendone in
rigidi confini lo spazio e l’oggetto delle stesse scelte organizzative - essi possono affermarsi in vista del
perseguimento di fini di utilità sociale, come nel caso dell’assunzione obbligatoria di determinate categorie di
soggetti (orfani di guerra, invalidi), particolarmente meritevoli di tutela o nel caso del divieto di licenziamento
delle lavoratrici a causa del matrimonio, a tutela della libertà e dignità delle donne lavoratrici o ancora nel caso
della previsione della chiusura settimanale dei pubblici esercizi e la disciplina dell’orario dei negozi, connesse
alla tutela del diritto del lavoratore al riposo.
La previsione del 3° co. dell’art. in esame presuppone pertanto alcuni elementi: in primo luogo, la
consapevolezza dell’incapacità del mercato di autoregolarsi e di garantire l’«ottimo sociale» e la conseguente
attribuzione alla legge del compito di regolazione dell’attività economica in vista della necessità di correggere i
«fallimenti» del mercato; in secondo luogo, la garanzia della «riserva (relativa) di legge» in base alla quale solo la
legge può intervenire a limitare, sempre dall’esterno, l’attività economica e deve farlo determinando criteri e
direttive idonei a contenere in un ambito ben delineato sia l’attività normativa secondaria che la concreta
esecuzione amministrativa; ancora, la scelta di una «programmazione» indicativa o per incentivo, contrapposta
ad ogni forma di pianificazione totalitaria, di per sé incompatibile con il riconoscimento della libertà
economica. Tale ultimo elemento impone una ulteriore riflessione: la legge determinativa dei programmi e
controlli opportuni, perché l’attività economica possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali, ha ad oggetto
non solo l’attività economica privata, che costituisce esercizio della libertà di iniziativa economica privata
consacrata dall’art. in commento, ma anche l’attività economica pubblica. Quest’ultima indicazione, mentre
svela la possibilità che l’attività economica sia svolta dai pubblici poteri in condizioni di parità e di concorrenza
205
con i privati imprenditori - possibilità che ha aperto le porte allo Stato imprenditore e moltiplicato negli anni le
forme di intervento pubblico nell’economia, portando alla proliferazione degli enti, dagli enti pubblici
economici alle società a partecipazione statale, in un’ottica di governo dell’economia teso, almeno negli intenti,
a realizzare la direzione politica del processo economico ed il contestuale rispetto del mercato e delle sue leggi
(dalla l. 136/1953, istitutiva dell’Eni, alla l. 1589/1956, istitutiva del Ministero delle Partecipazioni Statali, al
d.p.r. 1670/1962 regolante l’organizzazione dell’Enel) -, sollecita la precisazione che detta attività non
costituisce e non può costituire esercizio di una libertà, ma piuttosto una funzione, assegnata dalla legge al
soggetto pubblico e strutturalmente destinata a soddisfare esclusivamente la finalità sociale per la quale tale
attività viene imputata al soggetto pubblico, in una prospettiva di garanzia di non pregiudizio dei privati.
È soprattutto dagli anni novanta, tuttavia, che tale «delimitazione» dell’intervento pubblico nell’economia
si è andato profilando in linea anche con una «ripresa» del principio di sussidiarietà dell’azione statale nel
settore della produzione economica, principio - secondo il quale «l’intervento dello Stato nella produzione
economica ha luogo soltanto quando manchi o sia insufficiente l’iniziativa privata o quando siano in gioco
interessi politici dello Stato» e «può assumere la forma del controllo, dell’incoraggiamento e della gestione
diretta» - già affermato nella dichiarazione IX della Carta del Lavoro, recepito da Pio IX nella enciclica
Quadragesimo anno e ribadito dalla Centesimus annus, ma tornato in auge anch’esso sulla spinta
dell’integrazione comunitaria (ed oggi costituzionalmente consacrato nel diverso ambito della ripartizione
dell’attività amministrativa dall’art. 118).
Rispetto a tale riscoperta risulta viceversa assai datato il dibattito relativo alle leggi di «programmazione».
È infatti noto che le più attente analisi sul punto si sono avute attorno agli anni sessanta, nei quali si riteneva
opportuno impostare la politica di programmazione economica generale, al fine di ottenere il duplice risultato
dell’attribuzione al Parlamento della elaborazione delle scelte strategiche in campo economico attraverso la
legge e della tutela, mediante la legge, delle situazioni giuridiche soggettive. La legge di programmazione, in
altri termini, avrebbe dovuto sottrarre alla «mutevole facoltà del potere esecutivo» la determinazione degli
indirizzi di politica economica ed assicurare continuità all’indirizzo politico legislativo in materia economica,
superando la frammentarietà degli interventi che avevano caratterizzato la politica economica dei primi governi
di centrosinistra, condannati a vita breve. L’obiettivo era quello di applicare il metodo della programmazione
economica generale per individuare i fini di politica economica da perseguire ed i mezzi adeguati per
raggiungerli, delineando le apposite procedure di programmazione. Di contro alle indicazioni costituzionali, è
in questa fase che viene recuperato il riferimento ai «piani» (nel segno della necessità di assicurare «una
legislatura, un Governo, un Piano»), anche se l’unica esperienza - peraltro destinata al fallimento - di
legislazione di piano sarebbe stata quella della l. 685/1967, di approvazione del «Primo piano quinquennale
1966-1970», tesa - almeno secondo le indicazioni contenute nella stessa legge cui era allegato il Piano - a
definire «il quadro della politica economica, finanziaria e sociale del Governo e di tutti gli investimenti
pubblici». Anche tale esperimento - come si è detto fallito prima ancora di essere attuato - ha sollevato un
dibattito dottrinale, dividendosi la dottrina fra chi sosteneva l’opportunità (ove non la necessità) di una simile
legislazione a fini ad un tempo di identificazione precisa degli obiettivi economici da perseguire - e quindi di
vincolo ai governi - e di tutela degli operatori economici stessi e chi, viceversa, segnalava l’inutilità del ricorso
alla legislazione, essendo sufficiente l’atto di direttiva parlamentare per la specificazione dell’indirizzo politico
assunto dal programma.
Il diritto al lavoro
In un’impresa, colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine
della produzione o dello scambio di beni o servizi si avvale di manodopera. L’imprenditore assume
persone fisiche concludendo con ognuno di lavoro contratti individuali di lavoro. Così, l’imprenditore
è il datore di lavoro, mentre il personale è composto da lavoratori subordinati.
Il lavoro assume uno specifico rilievo nella nostra Costituzione:
- « l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro» (art. 1, primo comma);
- «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale
del Paese» (art. 3, secondo comma);
- «la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità
206
e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della
società» (art. 4);
- «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e
l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione,
salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero» (art.
35);
- «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro
e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata
massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a
ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi» (art. 36);
- «la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano
al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione
familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il
limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali
norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione» (art. 37);
- «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento
professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o
integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera» (art. 38);
- «l’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non
la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la
registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I
sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione
dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti
alle categorie alle quali il contratto si riferisce» (art. 39);
- «il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano» (art. 40);
- «ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della
produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende» (art. 46).
A queste disposizioni si aggiungano, tra le altre, le previsioni sul C.n.e.l. (art. 99) e sui rapporti
tra legge statale e legge regionale (art. 117 e, anche, l’art. 120).
Si è già detto che il principio lavorista è annoverato tra i princìpi fondamentali del nostro
ordinamento, in quanto il lavoro è la forma privilegiata di pieno sviluppo della personalità e di
effettiva partecipazione alla vita comunitaria.
Il diritto del lavoro è una branca importante dell’ordinamento giuridico. Essa include norme
contenute nel codice civile e in altre leggi ordinarie di fondamentale importanza, a cominciare da cd.
statuto dei lavoratori,
lavoratori ossia la legge n. 300 del 1970. A tali norme vanno aggiunte, per l’importanza
che verrà sottolineata più avanti, le regole poste dai contratti collettivi di lavoro, i quali sono sì negozi
giuridici di diritto privato, ma producono effetti cogenti assimilabili a quelli dispiegati dalle fonti del
diritto.
Prima di passare in rassegna le previsioni costituzionali dedicate al lavoro, appare necessario
fornire alcuni concetti basilari.
Secondo l’art. 2094 del codice civile, «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga
mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale
alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore».
207
Il rapporto giuridico che lega il lavoratore subordinato al datore di lavoro scaturisce da un
apposito negozio giuridico bilaterale a prestazioni corrispettive, ossia il contratto individuale di lavoro.
lavoro
È bilaterale in quanto per il suo perfezionamento esige la convergenza delle volontà manifestate dalle
due parti. È a prestazioni corrispettive (o sinallagmatico), giacché il lavoratore s’impegna a prestare la
propria opera materiale o intellettuale, mentre il datore di lavoro s’impegna ad erogare lo stipendio,
stipendio
consistente in una somma di denaro (→ salario).
Secondo l’art. 2099 del codice civile, la retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita
a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata, con le modalità e nei termini
in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. In mancanza di accordo tra le parti, la retribuzione è
determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali.
Nel determinare le obbligazioni nascenti dal contratto individuale, le parti sono tenute ad
attenersi ai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di
lavoro e dei lavoratori nel settore merceologico interessato. Ciò vale per lo stipendio. Ciò vale anche
per le mansioni, per le ferie, per il riposo settimanale, per l’orario di lavoro, per i periodi di
astensione per malattia, e così via.
Il lavoratore dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta,
dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale, come recita testualmente
l’art. 2104 del codice civile.
Quanto all’epilogo del rapporto individuale di lavoro, il codice civile stabilisce che ciascuno dei
contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel
termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto
verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il
periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del
rapporto per morte del prestatore di lavoro.
Inoltre, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se
il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora
si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il
contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete
l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. Non costituisce giusta causa di
risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa
dell'azienda.
Dal canto suo, l’art. 18 dello statuto dei lavoratori, come modificato nel 2012, stabilisce che il
giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio,
ovvero intimato in concomitanza col matrimonio o in violazione dei divieti di licenziamento di cui
alle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ovvero
perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito
determinante, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il
numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai
dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il
lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in
cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma. Il regime di cui al presente articolo si applica
anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
Il giudice, con la precedente sentenza, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del
danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine
un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del
licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di
estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento
208
non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è
condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al
lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel
posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui
richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione
previdenziale.
Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo
soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato
ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle
previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e
condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al
pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno
del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito,
nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe
potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la
misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione
globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il
lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in
cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo
comma.
Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo
soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con
effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità
risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto
conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del
comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.
La descritta disciplina si applica al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in
ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il
licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di
imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito
dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo
ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente
considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti.
Fatto questo inquadramento generale, e a dire il vero molto semplificato, il primo passo per la
disamina del tema è il seguente: il “lavoro” è un diritto soggettivo a tutti gli effetti ?
In effetti, come si è visto la stessa Costituzione parla di diritto al lavoro, al primo comma
dell’art. 4. L’ordinamento italiano dunque configura un vero e proprio diritto soggettivo al lavoro ?
Oppure questa configurazione è destinata ad operare non prima dell’instaurazione di un rapporto
individuale di lavoro bensì dopo ? Non è una differenza da poco. Se esistesse un diritto soggettivo al
lavoro anche prima della instaurazione di un simile rapporto, allora in caso di rifiuto opposto
dall’imprenditore al potenziale lavorator dipendente determinerebbe una lesione illegittima ad un
diritto soggettivo, con conseguente azione legale per ottenere il ripristino di tale diritto. Questo, però,
significherebbe sancire l’obbligo per l’imprenditore di assumere tutti coloro che ne fanno richiesta.
209
E, poi, cosa s’intende per “dovere” al lavoro ? Certamente, una volta stipulato il contratto
individuale di lavoro, il dipendente è tenuto a prestare la propria opera. E prima si è davvero in
presenza di un obbligo giuridico a lavorare, ossia a cercare un’occupazione ?
Il seguente commento di Cariola aiuterà a sciogliere questi interrogativi.
A. CARIOLA, Commento all’art. 4, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla
Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 114 ss.
…
2.1 La parabola del diritto al lavoro tra istanze di trasformazione sociale e processi di integrazione
sovranazionale
I profili di trasformazione del diritto al lavoro appaiono su tanti versanti.
La proclamazione costituzionale dell’art. 4 Cost. è stata, insieme all’affermazione dell’eguaglianza
sostanziale, uno dei motori di sviluppo della nostra storia repubblicana. Dopo le prime letture che ne
riducevano l’efficacia quale norma esclusivamente programmatica, e che la intendevano quale riconoscimento
di una libertà negativa, tesa a «che i pubblici poteri si astengano da qualsiasi intervento rivolto ad impedire
l’attività del lavoro dei privati», l’art. 4 Cost. è divenuto il principio propulsore ed il campo di prova
dell’estensione dei diritti di libertà nel campo dei rapporti privati, secondo ciò che con espressione tedesca è
indicato con il termine di Drittwirkung, e dell’affermazione dei valori costituzionali riguardo il lavoro nel
naturale ambito dei rapporti di produzione.
Dovrebbe dirsi che l’art. 4 Cost. e le altre norme costituzionali sul lavoro hanno trovato nello st. lav., il
loro momento di massima affermazione. La nota e spesso ripetuta frase di G. Di Vittorio, secondo cui
occorreva «portare la Costituzione nelle fabbriche» indicava, in fondo, il successo della Costituzione
repubblicana quale strumento di integrazione delle forze sociali, atteso, appunto, che a quella Costituzione si
guardava come ad un modello in cui riconoscersi, anche perché frutto del proprio patrimonio ideologico; ed,
al tempo stesso, rilevava quale tendenza di un’interpretazione estensiva dei principi costituzionali medesimi,
colti nel loro aspetto dinamico. Lo st. lav., in altri termini, interpretava ed integrava il quadro delle norme
costituzionali sul lavoro, rappresentando un vero e proprio pezzo della costituzione materiale del nostro Paese
(e certo ben più delle pressoché coeve proclamazioni degli Statuti regionali del 1971, che pure dedicano al
lavoro numerose previsioni).
È plausibile ritenere che tali sviluppi hanno scontato una lettura classista delle norme sul lavoro39, ma è
pur vero che le proclamazioni costituzionali hanno dimostrato di possedere maggiore efficacia proprio in virtù
ed in forza di tali tendenze.
Per altro verso, la considerazione degli interessi propri delle classi lavoratrici ha indotto nell’Italia degli
anni settanta a teorizzare l’utilizzo degli istituti giuridici (sia pure borghesi) in funzione di tutela delle medesime
classi. Ora, a parte le questioni circa l’accettabilità sul piano metodologico dell’uso alternativo del diritto, va
riconosciuto che lo stesso ha contribuito a guardare con occhio critico al formalismo dommatico e a rinnovare
l’attenzione per gli interessi (e i valori) fatti oggetto di tutela da parte delle norme costituzionali.
In siffatta prospettiva, per così dire, materialmente costituzionale non può non rilevarsi, d’altra parte, il
mutamento della tavola di valori costituzionali che si sta producendo ad opera dell’integrazione comunitaria
europea e dei fenomeni di globalizzazione.
Già in ambito nazionale è profondamente cambiato il lavoro, soprattutto quello operaio fatto oggetto di
considerazione e di tutela da una ormai lunga tradizione sociale e politica. Può forse essere uno slogan ad
effetto notare che il figlio dell’operaio una volta adibito alla catena di montaggio, è oggi un promotore
finanziario che celebra le alterne fortune della borsa. La realtà sociale quotidiana continua a conoscere
fenomeni di marginalizzazione e di diseguale distribuzione delle risorse, che segnano le classi sociali ed i
relativi processi di trasformazione. Eppure, è anche vero che una considerazione unitaria del lavoro non è più
possibile, né sotto il profilo legislativo, né tantomeno sotto quello sociale, attese, appunto, le rilevanti differenze
intervenute tra i vari settori produttivi. Si aggiunga che sembra assai mutato anche il ruolo che si è disposti a
riconoscere all’azione pubblica volta ad investimenti di carattere sociale ed a ridurre le diseguaglianze.
In termini assai sintetici, va poi notato che in ambito comunitario il lavoro e la sua tutela non assumono
quel carattere di fondamentalità che li distingue nell’ambito della Costituzione repubblicana.
210
Il dibattito circa la compatibilità tra i principi della nostra Costituzione e quelli propri del processo
costituente europeo si infiamma periodicamente per poi perdere di interesse dinanzi all’ineluttabilità - del resto
ampiamente voluta e condivisa tra le forze politiche e sociali - dell’integrazione europea. Come è stato ancora
di recente osservato a proposito della crisi delle fonti nazionali e statali, l’erompere delle fonti comunitarie
nell’ordinamento interno e la presenza di un sistema giudiziario europeo finiscono per riflettersi sulla tavola
dei valori materialmente costituzionali che non sono più (solo) quelli della Costituzione del 1947, mentre i
fenomeni di globalizzazione economica danno vita a processi anche di produzione normativa che non sono
per intero dominabili dallo Stato.
Invero, in ambito europeo la preoccupazione per i problemi sociali è stata a lungo tempo secondaria
«rispetto a quella di promuovere un grande mercato unificato, fondato sulla concorrenza». L’azione delle
Comunità nel campo delle politiche sociali si è progressivamente estesa in corrispondenza delle disposizioni
che sono state aggiunte ai Trattati istitutivi, ma proclamazioni analoghe a quella dell’art. 4 Cost. (così come di
altre Costituzioni) continuano ad essere assenti nel TCE e nel TUE.
L’art. 2 del TCE assegna alla Comunità «il compito di promuovere [...] un elevato livello di occupazione
e di protezione sociale», ed il successivo art. 3 prevede che l’azione della Comunità comporta «i) la
promozione del coordinamento tra le politiche degli stati membri in materia di occupazione al fine di
accrescerne l’efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l’occupazione; j) una politica nel settore
sociale comprendente un Fondo sociale europeo; k) il rafforzamento della coesione economica e sociale». Ma
può dirsi che il nucleo duro di tale valore comunitario sta nella libera circolazione dei lavoratori (artt. 48-51,
ora 39-42), e solo con il Trattato di Amsterdam si è introdotto il Titolo VI- bis (ora VIII) sulle politiche
europee per l’occupazione, con la sanzione formale secondo cui gli Stati membri considerano «la promozione
dell’occupazione una questione di interesse comune» (art. 126).
La promozione di un elevato livello di occupazione è indicata, poi, tra gli obiettivi dell’Unione Europea
(art. 2 del Trattato di Maastricht).
Non si possono certo negare il rilievo e l’importanza delle politiche europee per l’occupazione, né si
può trascurare il peso determinante della giurisprudenza europea in tema di libertà di circolazione, sulla parità
di trattamento e sul divieto di discriminazione. Anzi, l’azione della Comunità si è manifestata ampiamente
attraverso l’adozione di direttive che hanno inciso su campi assai significativi e a mezzo del Fondo sociale
europeo e dell’attività che ne è derivata. Epperò, la norma di principio dell’integrazione europea rimane quella
dettata dall’art. 4 (3A) del TCE, che proclama l’adesione al modello di «un’economia di mercato aperta ed in
libera concorrenza». Il riconoscimento del diritto al lavoro (inteso come libertà) può farsi rientrare tra i
«principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dello stato di diritto,
principi che sono comuni agli Stati membri», che per l’art. 6 (A) del Trattato di Maastricht danno fondamento
e fisionomia all’Unione Europea. Ed è certo che la caratterizzazione sociale dello Stato contemporaneo
accomuna i Paesi europei (art. 3 Cost. Italia; art. 20 Grundgesetz tedesco; art. 1 Cost. Spagna, ecc.), e che di
siffatta caratterizzazione la tutela del lavoro rappresenta la parte qualificante. Ma è altrettanto evidente che in
ambito comunitario si tratta di un riconoscimento indiretto, che muove pur sempre dalla premessa circa la
necessità di assicurare condizioni di libera concorrenza alle imprese. Si pensi che la stessa Carta comunitaria
dei diritti sociali fondamentali, approvata dal Consiglio l’8-9 dicembre 1989, ha finito con il prevedere «il
minimo comune denominatore dei diritti già riconosciuti» in ambito nazionale, sempre, peraltro, al fine di
«impedire la concorrenza verso il basso delle condizioni di lavoro, cioè un dumping sociale» estremamente
contrario alle politiche ed ai principi medesimi dell’integrazione europea.
Il fatto è che l’integrazione comunitaria sembra in gran parte svolgersi sul presupposto di taluni valori, e
più in generale di una cultura, segnati dalle idee di concorrenza e competitività, tipici appunto della cultura
imprenditoriale, e relativamente ai quali i diritti c.d. sociali assolvono funzione comprimaria, per così dire, di
correzione, di integrazione o di vero e proprio limite, ma sempre in riferimento ad un "progresso economico e
sociale" prodotto dall’attività di imprese operanti in regime di mercato.
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, in fondo, ha
codificato principi già riconosciuti nell’ordinamento comunitario. Il diritto di lavorare e di esercitare una
professione è garantito dall’art. 15 sempre come libertà, ma è significativo che si sia prestata attenzione alla
parità tra uomini e donne (art. 23), al diritto dei lavoratori all’informazione ed alla consultazione (art. 27), al
diritto di negoziazione e di azioni collettive di autotutela compreso lo sciopero (art. 28), alla tutela in caso di
ingiustificato licenziamento (art. 30), al diritto ad avere condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose (art. 31), al
divieto di lavoro minorile ed alla protezione del lavoro svolto dai giovani (art. 32), ai diritti della donna
lavoratrice (art. 33), alla sicurezza ed all’assistenza sociale (art. 34). Nella Carta non hanno trovato, invece,
posto le politiche europee per l’occupazione, mentre sul valore giuridico delle proclamazioni della Carta
211
medesima riguardo al lavoro sembra pesare la circostanza che le stesse rimandano alla disciplina comunitaria e
nazionale e persino alla prassi (artt. 27, 28, 30 e 34), di modo che il contenuto di principio risulta in gran parte
riepilogativo e riassuntivo.
Da questo punto di vista potrebbe osservarsi che il paradigma di costruzione dei diritti sociali ha assunto
dapprincipio (lo Stato nazionale e) l’ambito statale come livello di riferimento e il tentativo di dare effettività a
tali situazioni e di sancire anche a loro riguardo il carattere di fondamentalità sembrerebbe scontare oggi i limiti
segnati dal superamento dello Stato nazionale, oltre che dalla disponibilità delle risorse. Sempre in questa
prospettiva potrebbe concludersi nel senso che aveva visto correttamente quella dottrina che aveva inteso l’art.
4 come riconoscimento del diritto a lavorare e, quindi, innanzitutto come libertà.
Senonché una conclusione in tali termini sarebbe probabilmente affrettata. Letto alla luce del processo
di integrazione comunitaria e dei suoi sviluppi applicativi, il diritto al lavoro sancito dall’art. 4 Cost. dimostra di
possedere una notevole vitalità, atteso che il diritto comunitario ha dato prova di poter rendere justiciable
almeno profili del diritto in questione e di attribuirgli, allora, un’effettività cui l’orizzonte esclusivamente
statalistico non era pervenuto. Il riferimento è a quei profili del diritto al lavoro che maggiormente intercettano
la tavola dei valori comunitari, si tratti della parità di accesso o del divieto di discriminazioni o sulla sicurezza
negli ambienti di lavoro, e che proprio per questo concretizzano aspetti della proclamazione costituzionale,
offrendole l’efficacia via di tutela avanti il sistema giudiziario europeo e quella della responsabilità civile dello
Stato inadempiente, secondo il filone giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza Francovich.
Da questo punto di vista, anzi, si realizza in parte l’intuizione di Mortati circa la responsabilità dello Stato
per l’inerzia nell’attuazione dell’art. 4 Cost., sebbene siffatta responsabilità non riguardi direttamente ed
immediatamente l’obbligo dello Stato di fornire lavoro ai disoccupati, ma solo taluni profili del rapporto di
lavoro (e per lo più, peraltro, relativi ad un rapporto già costituito).
Nella stessa ottica contemporanea, per dir così, può leggersi il dibattito - iniziato già in Assemblea
Costituente - circa la qualificazione del diritto al lavoro, se questo, cioè, significhi il riconoscimento di un vero e
proprio diritto soggettivo, di un interesse legittimo o di altro ancora. In linea generale, appare difficile applicare
al termine diritto adoperato in Costituzione le classificazioni proprie della legislazione ordinaria. Se, infatti, le
proclamazioni costituzionali dei diritti esprimono valori più che regolamentazioni specifiche, la disciplina dei
singoli rapporti attiene a scelte di bilanciamento del legislatore coerenti con la tavola dei valori indicati al livello
più alto. Non a caso la dottrina ha preferito parlare di figure soggettive per qualificare le posizioni di vantaggio
disposte dalla Costituzione. Ed a proposito del diritto al lavoro si è ricorsi alla prospettazione di «una
situazione soggettiva di obbligo per lo Stato, e quindi per gli organi di esso».
Se, allora, la previsione sul diritto al lavoro nell’art. 4 Cost. esprime un valore fondamentale
dell’ordinamento, che funge da ispirazione e copertura delle specifiche disposizioni degli artt. 35-40 Cost., ma
al tempo stesso non è pienamente scomponibile o riconducibile a queste ultime, può convenirsi nella tesi che
l’art. 4 stabilisca una situazione giuridica complessiva di vantaggio a sua volta composta di varie posizioni
giuridiche, molte delle quali tendono ad essere riconosciute anche in sede giurisdizionale.
2.2 Il lavoro e i lavori
Il riferimento a tali sviluppi, compresi quelli di carattere sovranazionale, rende manifesto che sotto il
termine lavoro si celano diverse nozioni, che - come è stato notato a proposito della Costituzione italiana hanno riguardo ora al lavoro subordinato, ora a questo ed al lavoro autonomo, altre volte a qualsiasi attività
relativa allo scambio di beni e servizi, ed ancora a qualsiasi attività socialmente utile.
Si è già ricordato che non a caso il confronto su cosa debba intendersi per lavoro e chi debba qualificarsi
come lavoratore ha impegnato sin dall’inizio l’elaborazione dottrinale ed, ancor più, l’azione dei soggetti
sociali. Si è pure rilevato che le trasformazioni intervenute nel settore della produzione, ed anche in quello che
un tempo si definiva mondo operaio, rendono per alcuni versi superata la netta contrapposizione tra
interpretazioni classiste e, come dire?, organicistiche dell’art. 4, 1° co. Il lavoro è considerato, infatti, non solo
strumento di affermazione della personalità, ma fonte di legittimazione sociale per la titolarità e l’esercizio di
ogni altra posizione, ad iniziare dalla proprietà privata che dal lavoro trae, appunto, una delle sue possibili
giustificazioni. Da questo punto di vista può convenirsi con quelle tesi che individuano nell’art. 4, 1° co., la
garanzia di una libertà, "che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell’attività lavorativa" e giungono a
ritenere che "lavoro significa qualsiasi attività diretta allo scambio di beni e di servizi", individuando una
sostanziale omogeneità tra l’art. 4 e l’art. 1, che sul lavoro fonda, appunto, la Repubblica.
Detto questo, però, va subito aggiunto che la questione sembra in gran parte nominalistica per la
semplice ragione che - se il sistema economico accolto c.d. misto risulta dall’intera Costituzione - la norma sul
212
diritto al lavoro ha (politicamente e giuridicamente) senso per coloro che si trovano in posizione di soggezione
e di debolezza nei confronti dei detentori del potere economico. Questi ultimi più che all’art. 4, guardano
infatti all’art. 41 Cost. ed alla garanzia lì contenuta del diritto di iniziativa economica.
In un certo senso, allora, art. 4, 1° co., ed art. 41, 1° co., si fronteggiano nel fare riferimento a due
contrapposte categorie di soggetti. Potrebbe sostenersi che l’imprenditore trae forza e legittimazione dal
proprio personale lavoro, e che allora l’art. 4 vale anche per lui, ma l’argomentazione alla fine risulterebbe
vana, atteso che i problemi dell’impresa (ad esempio quelli che sorgono a causa degli affidamenti suscitati da
leggi di incentivazione o di agevolazioni tributarie) trovano nell’art. 41 più che nell’art. 4 Cost. la chiave di
soluzione.
Al contrario, l’art. 4 Cost. ha quali suoi naturali destinatari i soggetti che, privi di altre risorse, traggono il
proprio sostentamento essenzialmente dalla propria attività manuale o intellettuale. Il riferimento, allora, è ai
lavoratori subordinati ed agli altri soggetti bisognosi di tutela ed ai quali, infatti, gli artt. 35 Cost. e ss. apprestano
una serie di istituti a garanzia (retribuzione, ferie, riposo, lavoro femminile, assistenza). In altri termini, la
previsione costituzionale dell’art. 4 (delle successive norme degli artt. 35 e ss.) offre copertura al sistema di
garanzie che la disciplina lavoristica fin dal suo sorgere ha sviluppato, di modo che sarebbe, alla fine,
formalistico ritenere che essa riguardi indistintamente tutti i lavori (e concretamente nessuno).
Tra i due estremi rappresentati dal lavoro subordinato e dall’esercizio di attività di impresa stanno tutte
quelle posizioni (oggi, peraltro, estremamente variegate) di lavoratori autonomi, intellettuali, liberi
professionisti, ecc., e di volta in volta si tratta di stabilire se è più forte l’attrazione verso il polo della tutela
lavoristica o verso quello dell’attività di impresa e delle leggi del mercato, in base ad elementi di fatto ed a
considerazioni sociologiche che non possono sottrarsi al giudizio di ragionevolezza. In questa chiave si spiega
perché ai lavoratori autonomi c.d. piccoli siano spesso apprestate le forme di tutela tipiche in origine dei
lavoratori subordinati64. Nella stessa ottica possono trovare soluzione alcuni dei problemi posti dalla
legislazione sul lavoro autonomo (ad iniziare dall’imposizione fiscale) e da talune discipline a sostegno di figure
imprenditoriali in posizione di debolezza sociale, di cui sostenere la presenza sul mercato.
2.3 La disciplina sui licenziamenti e la tutela reale o risarcitoria
Discende dalla funzione di tutela del lavoro subordinato, per così dire, assolta dall’art. 4, 1° co., Cost.
che dalla previsione costituzionale sia stato fatto discendere il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Così,
con motivazione stringente si è notato che "se, infatti, la Costituzione ha assunto come interesse degno di tutela
quello di ogni cittadino a ottenere un posto di lavoro o ad ottenerne un altro adeguato, la ratio legis vuole che
risulti al tempo stesso protetto altresì l’interesse - in un certo senso, ancora più concreto - di ogni lavoratore a
conservare il posto che occupa". Se ne è arguito che sarebbe stato abrogato l’art. 2118 c.c., nel testo del 1942
che consentiva il recesso ad nutum dell’imprenditore, o quantomeno che sarebbe costituzionalmente
ammissibile solo il licenziamento per giustificato motivo, e comunque che l’art. 4 offrisse un chiaro criterio
interpretativo per integrare la disposizione civilistica ed "offrire in qualche modo una garanzia all’interesse del
lavoratore".
La Corte costituzionale non si è mostrata sorda a siffatte ricostruzioni, ma nell’oramai lontano 1965 ha
preferito adottare una sentenza interpretativa di rigetto, la quale, da un canto, ha affermato che l’art. 4 "non
garantisce il diritto alla conservazione del lavoro"; ma dall’altro ha riconosciuto che "l’art. 2118 c.c. è stato
progressivamente ristretto nella sua sfera di efficacia" sia da provvedimenti legislativi che hanno limitato o
temporaneamente precluso il potere di recesso del datore di lavoro, sia dagli intervenuti accordi sindacali. La
stessa Corte, del resto, fece presente che i principi fondamentali di libertà sindacale, politica e religiosa erano
immediatamente immessi nell’ordinamento giuridico con efficacia erga omnes e che al legislatore ordinario
incombeva di dettare la disciplina del licenziamento con gli opportuni temperamenti.
Invero, la disciplina successivamente introdotta dal legislatore ha mostrato di voler fare tesoro di tali
insegnamenti e la giurisprudenza costituzionale ha seguito siffatta evoluzione, finendo per riconoscere il diritto
dei lavoratori dipendenti a non essere arbitrariamente licenziati.
In un "incalzante crescendo di tutele" la disciplina generale, oggi risultante dalla l. 604/1966 (l. lic. indiv.),
dall’art. 18 st. lav. e dalla l. 108/1990, ha finito per distinguere tra diversi tipi di licenziamento, le rispettive
forme e le tutele predisposte. In particolare, la garanzia di tipo obbligatorio, prevista dall’art. 8 l. lic. indiv.,
comporta l’obbligo del datore di lavoro di riassumere il lavoratore o, in alternativa, di corrispondergli
un’indennità quando il licenziamento risulti privo di giusta causa o di un giustificato motivo. La tutela reale è
stata introdotta dall’art. 18 st. lav. a carico dei datori di lavoro che occupino più di quindici dipendenti in
ciascuna unità produttiva ed in ogni caso quando occupino più di sessanta dipendenti; per i datori di lavoro
213
imprenditori agricoli il limite numerico è stabilito in più di cinque unità dipendenti. La stessa importa, nel caso
di licenziamento ingiustificato, inefficace e nullo, l’obbligo di reintegrare il lavoratore nel posto occupato e di
corrispondergli un’indennità a titolo di risarcimento del danno subito. Il lavoratore può anche rinunciare al
reintegro ed ottenere in alternativa un’ulteriore indennità.
È significativo che a distanza di oltre mezzo secolo dalle prime elaborazioni sulla portata giuridica
dell’art. 4 Cost. - in occasione del giudizio di ammissibilità del referendum volto ad abrogare l’art. 18 st. lav. e
ad estendere l’area della garanzia obbligatoria - la stessa Corte costituzionale ha inteso dare una qualche forma
di copertura alla disciplina richiamata, riconoscendo sì che le due modalità di tutela non necessariamente
debbono sussistere entrambe, ma al tempo stesso affermando che gli artt. 4 e 35 Cost. sono il presupposto
dell’abbandono del criterio del recesso ad nutum dell’art. 2118 c.c. e del "principio della necessaria
giustificazione del recesso e del potere di adire il giudice, riconosciuto al lavoratore, in caso di licenziamento
arbitrario".
2.4 Gli ambiti di operatività del diritto al lavoro ed il divieto di discriminazione
Il diritto al lavoro, proclamato nell’art. 4 Cost., invero manifesta un’amplissima propensione a collegarsi
e ad integrarsi con le altre garanzie previste in Costituzione a tutela della persona e della sua dignità.
In fondo, gli artt. 2, 3, 4, 13, 19, 21 e 32 (per citarne solo alcuni) apprestano una serie di garanzie a
favore del lavoratore ed offrono copertura costituzionale ad istituti e precetti che sono stati magari individuati
dalla legislazione ordinaria, ma che ad un esame un poco più approfondito si rivelano dirette e conseguenti
applicazioni dei principi costituzionali, di modo che gli stessi istituti appaiono a contenuto costituzionalmente
vincolato e comunque necessario e risulterebbe di dubbia legittimità un eventuale ritorno indietro.
La tutela della dignità personale, della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, il diritto a ricevere
informazioni, ad esempio, sono sviluppi coerenti dell’istanza di valore contenuta nell’art. 4 di volta in volta in
collegamento con altri valori costituzionali. Le normative di carattere settoriale che ne contengono la disciplina,
risultano obbligatorie riguardo principi di riferimento e contenuto minimo, anche se non può dirsi che per
questo le medesime normative sono determinate una volta per tutte, poiché, anzi, proprio il settore regolato
richiede un costante adeguamento della legislazione agli sviluppi della tecnica (come alla mutata sensibilità
accolta nell’ordinamento: si pensi al campo delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, assurto a notevole
rilevanza negli anni più recenti, o al più alto livello di protezione della dignità del lavoratore che la repressione
del mobbing intende promuovere).
Il collegamento con l’art. 2 Cost. va riferito anche al riconoscimento ed alla promozione delle
formazioni sociali: il che finisce per dare più che adeguata copertura alla libertà sindacale (art. 39 Cost.) ed alla
proclamazione dell’autonomia contrattuale, sino a configurare una vera e propria riserva di normazione
contrattata (sia pure in un rapporto flessibile con la legge), la quale non a caso è sancita in alcune Carte
costituzionali, comprese quelle di carattere sovranazionale.
A contenuto costituzionalmente vincolato sembrano essere le previsioni - oggi nell’artt. 1 e 8 st. lav. - che
riconoscono al lavoratore di manifestare liberamente il proprio pensiero nei luoghi di lavoro e che fanno
divieto al datore di lavoro di svolgere indagini sulle opinione politiche, religiose o sindacali del lavoratore,
nonché sugli altri fatti non rilevanti ai fini dell’attitudine professionale del lavoratore. Si tratta, infatti, di
contenuti normativi che discendono direttamente dalle previsioni costituzionali degli artt. 2, 19 e 21, e che le
disposizioni di fonte legislativa si limitano a specificare e chiarire, rendendo concreti precetti altrimenti
derivabili ad opera dell’interpretazione costituzionale.
Lo stesso è da dire a proposito del divieto di discriminazioni a causa dell’appartenenza sindacale,
contenuto nell’art. 15 st. lav., e che riceve dagli artt. 4 e 39 giustificazione e copertura.
Del resto, l’art. 4 Cost. sembra essere a fondamento anche del diritto alla carriera che l’art. 13 st. lav. riformulando l’art. 2103 c.c. - ha riconosciuto sotto forma di diritto alle mansioni superiori effettivamente
svolte. Spetta, certo, alla discrezionalità del legislatore indicare forme, modalità e termini di esercizio di siffatta
pretesa ed entro certi limiti distinguere anche tra gli ambiti di applicazione della previsione. Ma appare
altrettanto indubbio che - come ha riconosciuto la giurisprudenza formatasi in tema di demansionamento - se il
diritto al lavoro è espressione dei diritti della personalità, la pretesa a vedersi riconosciute le competenze
acquisite attraverso le esperienze maturate (ed i corrispondenti livelli retributivi) attiene ad un profilo legato,
appunto, in maniera assai intensa alla dignità del lavoratore, atteso che il principio sancito nell’art. 4 Cost. si
riflette anche sullo svolgimento del rapporto di lavoro e non riguarda solo la fase della sua instaurazione.
Allo stesso modo, l’art. 4 Cost., questa volta collegato al principio di eguaglianza del precedente art. 3, è
a fondamento del principio di parità e del divieto di discriminazioni. Tra l’altro, muovendo dall’art. 141 TCE,
214
il processo di integrazione comunitaria ha reso assai intenso il campo di applicazione del principio di parità,
tentando di colpire quelle forme di discriminazioni, anche indirette, che si hanno quando "una disposizione,
un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le
persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un
particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre
persone, a meno che tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità
legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari".
Campo privilegiato di attenzione ai temi della parità e delle discriminazioni sono, poi, in ambito statale
come in quello europeo, le politiche di pari opportunità e le azioni positive volte a promuovere le opportunità
di lavoro e di carriera del sesso sottorappresentato.
Se la l. 903/1977, aveva inteso reprimere ogni discriminazione per ragioni di sesso, sia nel momento
dell’assunzione che durante lo svolgimento del rapporto; assicurare la parità di trattamento a fini previdenziali
e fiscalizzare gli oneri sociali legati alla maternità; l’aspirazione della l. 125/1991, espressamente intitolata alle
azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, è stata quella di promuovere il
raggiungimento di alcuni punti di arrivo da parte di soggetti considerati deboli, perché sottorappresentati in
alcuni ambiti lavorativi, sul fondamento dell’eguaglianza sostanziale sancita dall’art. 3, 2° co. Cost., ed anche a
costo di introdurre forme ed istituti di discriminazione rovesciata a favore, appunto, dei soggetti più deboli. La
stessa Corte costituzionale ha riconosciuto che le azioni positive "sono il più potente strumento a disposizione
del legislatore, che, nel rispetto della libertà e dell’autonomia dei singoli individui, tende a innalzare la soglia di
partenza per le singole categorie di persone socialmente svantaggiate - fondamentalmente quelle riconducibili
ai divieti di discriminazione espressi nel 1° co. dello stesso art. 3 (sesso, razza, lingua, religione, opinioni
politiche, condizioni personali e sociali) - al fine di assicurare alle categorie medesime uno statuto effettivo di
pari opportunità di inserimento sociale, economico e politico". E con particolare riguardo al campo
dell’imprenditoria femminile, fatto oggetto di promozione ad opera della l. 215/1992, ha continuato nel senso
che le medesime azioni "sono dirette a superare il rischio che diversità di carattere naturale o biologico si
trasformino arbitrariamente in discriminazioni di destino sociale. A tal fine è prevista, in relazione a un settore
di attività caratterizzato da una composizione personale che rivela un manifesto squilibrio a danno dei soggetti
di sesso femminile, l’adozione di un trattamento di favore nei confronti di una categoria di persone, le donne,
che, sulla base di una non irragionevole valutazione operata dal legislatore, hanno subìto in passato
discriminazioni di ordine sociale e culturale e, tuttora, sono soggette al pericolo di analoghe discriminazioni".
Sulle politiche di pari opportunità (e sulla loro intensità), anche in occasione ed a seguito della recente
riforma dell’art. 51 Cost., ad opera della l. cost. 1/2003, si è sviluppato un confronto assai serrato, a
testimonianza, peraltro, degli interessi coinvolti e del peso delle medesime culture che alimentano il principio
di eguaglianza. Invero, nel passaggio da una misura generale a sostegno di gruppi e di categorie
all’individuazione di un trattamento privilegiato che avvantaggia un singolo individuo a discapito di altri, pare
intravedersi un salto che comporta disponibilità di risorse e vasta accettazione sociale della discriminazione
introdotta.
In ogni caso, applicato al mondo del lavoro, il tema delle discriminazioni (rovesciate) a tutela di interessi
costituzionalmente protetti conferma che l’area coinvolta dalle proclamazioni contenute nell’art. 4 Cost.
comprende, appunto, (la disciplina de) i rapporti ove sono parti soggetti deboli, si tratti (tipicamente) dei
lavoratori subordinati, di quelli autonomi e dei liberi professionisti, come, ancora, di quegli imprenditori che
bisognano di sostegno iniziale per affacciarsi e affermarsi sul mercato (come è il caso della citata imprenditoria
femminile). La circostanza che nel giudicare della legislazione di settore la Corte costituzionale italiana abbia
fatto pressoché esclusivo riferimento al 2° co. dell’art. 3 Cost., non deve infatti far trascurare che misure di tal
tipo rinvengono nell’art. 4 un fondamento di rilievo, atteso che si tratta, appunto, di assicurare da parte della
Repubblica il diritto al lavoro con i mezzi di volta in volta più appropriati. Ne offrono significativa conferma
l’art. 137 e l’art. 141 TCE (nel testo modificato dal Trattato di Amsterdam), che al 4° co. consente che uno
Stato "mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l’esercizio di un’attività
professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere
professionali"; e, ancora di recente, l’art. 23 della Carta dei diritti di Nizza, che contiene una formulazione
analoga, appunto appena dopo la proclamazione del principio di parità tra uomini e donne in tutti i campi,
"compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione".
Le disposizioni comunitarie richiamate sono state, per alcuni versi, necessitate a seguito dell’intervento
della Corte di Giustizia nel caso Kalanke, allorché si è ritenuto che violasse il principio di parità la disciplina
del Land tedesco di Brema, che attribuiva in maniera automatica la preferenza ai candidati di sesso femminile
per promozioni in settori ove le donne erano sottorappresentate. Nelle successive decisioni sui casi Marschall e
215
Badeck la stessa Corte ha ammesso la legittimità di normative nazionali riconducibili allo schema delle azioni
positive a condizione che si operi un esame obiettivo delle candidature e si considerino le qualità personali di
tutti i candidati.
2.5 Lavoro pubblico e privato
La disciplina del pubblico impiego attiene ai fondamenti dell’organizzazione costituzionale se non altro
sotto due profili, giacché il principio democratico richiede che sia socializzato l’esercizio dei poteri pubblici e,
pertanto, sia reso ampio l’accesso agli impieghi e perché, comunque, non può concepirsi che l’utilizzo di una
siffatta risorsa sia ristretto soltanto ad alcuni. Non a caso, l’art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del
cittadino del 14 luglio 1789 legava il principio di eguaglianza all’ammissione di tutti i cittadini "a tutte le dignità,
posti e impieghi pubblici, secondo la loro capacità e senz’altra distinzione che quella delle loro virtù e del loro
ingegno", tenendo a battesimo un valore che sarà ripetuto in sede internazionale (art. 21 Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo) e statale (art. 51 Cost.).
Il senso costituzionale del pubblico impiego sta, in fondo, nell’esigenza di garantire gli accennati valori di
eguaglianza e di partecipazione, insieme a quelli di imparzialità e di personalizzazione dell’amministrazione.
In questa prospettiva si è marcata, in particolar modo, l’istanza partecipativa all’organizzazione sociale e
politica del Paese che sarebbe sottesa al fenomeno burocratico e che si fonderebbe sui principi stabiliti dagli
artt. 2, 3 e 4 Cost.: "la stessa attività pubblica, nei suoi termini formali, deve essere intesa come una delle tante
scelte che il cittadino ha di fronte a sé, per esercitare il suo potere di partecipare all’organizzazione complessiva
del Paese".
La tesi sembra avere riguardo soprattutto al momento di accesso allo svolgimento di funzioni e di servizi
pubblici, e non alle successive fasi di esercizio del potere amministrativo, riguardo alle quali prevale
l’attenzione alle forme di tutela nei confronti di un potere che (se pure può in astratto definirsi partecipato) in
ogni caso risulta eteronomo per quelli ai quali si rivolge.
Per questo, al fine di individuare il significato dell’inclusione in Costituzione di numerose disposizioni
sul pubblico impiego, si è preferito insistere sui caratteri che allo stesso derivano dalla disciplina costituzionale:
l’ampia ed eguale garanzia di accesso, appunto, fondata sul principio meritocratico; l’attinenza del rapporto di
lavoro ai profili organizzativi dell’amministrazione; l’imparzialità da assicurare nei confronti del potere politico;
la responsabilità dei funzionari verso i cittadini le cui sfere soggettive sono incise dall’azione pubblica; la
personalizzazione dell’amministrazione.
Tutto ciò, ovviamente, non significa che le fonti di disciplina del pubblico impiego debbano essere
necessariamente di carattere pubblico, cioè a dire di fonte legislativa e regolamentare. È noto, anzi, che dalla
fine degli anni sessanta si è assistito ad un progressivo ampliamento delle fonti contrattuali nel settore sino alla
c.d. legge quadro 93/1983 ed al d.lg. 29/1993, che ha segnato, alla fine, la (quasi) integrale privatizzazione del
pubblico impiego e l’attrazione dello stesso settore nel campo delle discipline giuslavoristiche.
A dire il vero, permangono molti elementi di specialità del pubblico impiego rispetto al rapporto di
lavoro di diritto privato: il regime delle incompatibilità, la permanenza della giurisdizione amministrativa sulle
procedure concorsuali; l’accertamento pregiudiziale circa la validità, l’efficacia e l’interpretazione dei contratti,
con la possibile proposizione di un ricorso in Cassazione; la previsione dei comparti della contrattazione
collettiva nazionale da operare mediante appositi accordi tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) ed i sindacati che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5 per
cento. Insomma, anche in regime di c.d. privatizzazione il soggetto pubblico si sceglie il soggetto con il quale
contrattare (sia pure sulla base di indici piuttosto obiettivi) e può persino prevedere che le norme di legge,
regolamento o statuto che introducano discipline particolari per i dipendenti pubblici, possano essere derogate
dai successivi contratti collettivi e non risultino più applicabili. In linea generale, poi, il criterio di distinzione tra
ambiti destinati alla disciplina pubblicistica (legge o regolamento) e ambiti "riservati" alle fonti contrattuali
continua a suscitare problemi non indifferenti.
Dal canto suo, la Corte costituzionale non ha potuto incidere più di tanto sulle scelte del legislatore,
quasi a consacrare lo stato della legislazione esistente. Così, la sentenza 68/1980 aveva sì apprezzato la
liberazione a mezzo della contrattazione collettiva del "rapporto di lavoro nell’impiego pubblico dalla
prevaricante sovrapposizione del rapporto c.d. organico o di ufficio", ma ha subito dopo precisato che "anche
se si intendesse privatizzare i rapporti di lavoro con lo Stato non collegati all’esercizio di potestà pubbliche,
dovrebbero pur sempre essere conservati come rapporti di diritto pubblico quelli dei dipendenti, cui tale
esercizio è o potrebbe essere affidato".
216
L’idea sottesa alla decisione sembrava essere quella che dovessero rimanere sottoposti all’integrale
disciplina ad opera della legge i rapporti di impiego dei dirigenti, ma il d.lg. 80/1998 ha sottoposto alla
contrattazione collettiva anche tali rapporti, di modo che oggi restano sottratti al campo di applicazione di
quest’ultima magistrati, avvocati dello Stato, personale militare e di polizia, personale diplomatico e prefettizio,
nonché i docenti universitari.
La disciplina c.d. di privatizzazione è passata indenne al giudizio di costituzionalità, sia per la parte che
riguarda i dirigenti, sia più generale per l’eventuale contrasto con gli artt. 97 e 39 Cost. Sotto il primo profilo si
è ritenuto che "l’organizzazione, nel suo nucleo essenziale, resta necessariamente affidata alla massima sintesi
politica espressa dalla legge nonché alla potestà amministrativa nell’ambito di regole che la stessa pubblica
amministrazione previamente pone; mentre il rapporto di lavoro dei dipendenti viene attratto nell’orbita della
disciplina civilistica per tutti quei profili che non sono connessi al momento esclusivamente pubblico
dell’azione amministrativa". Per quanto riguarda il secondo profilo si è fatto ricorso ad un’elegante costruzione,
secondo la quale l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi nel settore pubblico deriverebbe non
direttamente dagli stessi contratti, ma dall’obbligo delle pubbliche amministrazioni di osservarne gli impegni.
2.6 Il lavoro come dovere
Sul fatto che il 2° co. dell’art. 4 Cost. non ponga una vera e propria norma giuridica assistita da una
corrispondente sanzione la riflessione è pressoché unanime96. Semmai, si è riconosciuto che la previsione
allude ad un contenuto etico minimo senza il quale nessun ordinamento sociale potrebbe sussistere.
Di ciò erano probabilmente consapevoli gli stessi costituenti, e lo rileva sia il fatto - già ricordato - che si
eliminò il 3° co. del progettato art. 31; sia, ancora, la spiegazione che lo stesso Ruini ebbe ad avanzare, notando
che "il lavoro non si esplica soltanto nelle sue forme materiali, ma anche in quelle spirituali e morali che
contribuiscono allo sviluppo della società. È lavoratore lo studioso ed il missionario; lo è l’imprenditore, in
quanto lavoratore qualificato che organizza la produzione".
Non parrebbe che il costituente fosse sensibile all’idea weberiana del lavoro intellettuale come
vocazione, eppure è accolta la concezione secondo la quale tale attività costituisce contributo al progresso
sociale, ed in questo senso può individuarsi un collegamento della norma in esame con l’art. 33 Cost., riguardo
la libertà di insegnamento e l’autonomia delle università e dei centri di ricerca.
Nella visione accolta dal costituente diritto al lavoro e dovere di svolgerlo sono entrambi coerenti
applicazioni dell’ispirazione personalista. Anzi: se il 1° co. dell’art. 4 Cost. fosse letto soprattutto in senso
individualista come libertà da costrizioni e condizionamenti pubblici, paradossalmente potrebbe essere il 2° co.
ad imporre o meglio a consentire la previsione di un qualche obbligo, valorizzando la dimensione sociale del
lavoro medesimo. In questo senso si è collegato il dovere al lavoro con l’art. 38 Cost., che garantisce il
godimento degli istituti di assistenza solo agli inabili ed escluderebbe, perciò, che i disoccupati volontari
possano aspirare legittimamente alla relativa indennità.
Invero, da un lato può rintracciarsi nell’art. 4 Cost., cpv., un’ispirazione comune a quella delle altre
disposizioni costituzionali che prevedono obblighi a carico dei cittadini, come l’art. 23, il 52, il 53 ed 54 Cost.,
ai quali va certamente aggiunto l’art. 2 Cost. con il suo riferimento espresso al dovere di solidarietà. In questa
prospettiva potrebbe individuarsi un fondamento alla possibilità della legge di imporre prestazioni e altri
obblighi riconducibili all’idea di una collaborazione civica. Dall’altro lato, tuttavia, tali obblighi non possono
estendersi sino a violare la dignità umana o ad essere privi di un qualche collegamento con talune situazioni
qualificanti (ad esempio, quella costituita dalla titolarità del diritto di proprietà, che per definizione obbliga ad
alcune prestazioni a protezione dei terzi).
La realtà è che nello spirito del costituzionalismo "clausole aperte" o interpretazioni estensive hanno
ragione di essere applicate solo a favore dei diritti e non dei doveri, la cui imposizione presuppone un forte
ancoraggio a precise disposizioni costituzionali.
Lo stesso è da dire a proposito della tesi che intende legare il 2° co. dell’art. 4 e l’ultima parte dell’art. 48
Cost. e giustificare in tal modo qualche forma di limitazione al godimento dei diritti politici.
In definitiva, i tentativi ricordati non porterebbero comunque lontano, sia perché il raggiungimento della
piena occupazione è un obiettivo remoto (e forse nemmeno accolto tra i presupposti dell’economia
contemporanea), di modo che i poteri pubblici non potrebbero imporre alcuna costrizione; sia per la
contrarietà di obblighi costituzionali siffatti ai presupposti dello Stato liberale. Ancora la Carta dei diritti di
Nizza, all’art. 5, sancisce che "nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio",
assimilando addirittura il lavoro forzato alla schiavitù.
217
Il 2° co. dell’art. 4 Cost. rafforza così l’idea del lavoro come libertà, giacché contempla e ritiene degne di
considerazione costituzionale tutte le attività attraverso le quali si esprime la dignità umana, smorzando la
caratterizzazione classista che è in qualche modo implicita nel 1° co.
A tal proposito, infatti, è evidente che il riconoscimento e l’affermazione di diritti ha senso laddove
questi ultimi vengano negati o subiscano restrizioni. La proclamazione del diritto al lavoro si inserisce e si
spiega in tale contesto, e ne rappresenta anzi una parte fondamentale. E non a caso è al diritto al lavoro che
hanno guardato le forze sociali per farne uno strumento di azione politica assai intensa. Il che ha comportato
che (solo) il 1° co. dell’art. 4 Cost. abbia espresso una carica di trasformazione assai feconda. Al contrario, il 2°
co. dell’art. 4 Cost. con il suo amplissimo riferimento alle possibilità ed alle inclinazioni finisce per costituire
più un limite per l’azione statale, che non un obbligo per il soggetto privato.
2.7 Il diritto al lavoro tra pubblico e privato, tra statalismo e federalismo
Costantino Mortati fece a suo tempo rilevare che "l’art. 4 occupa una posizione intermedia, posto come
è fra alcune proposizioni più generali che rispetto ad esso compiono una funzione di presupposto, ed altre più
particolari le quali possono considerarsi integrative". L’attenzione, infatti, era rivolta ad indagare il modello
economico accolto dalla Costituzione appena entrata in vigore e gli strumenti giuridici atti a conferire efficacia
ad una proclamazione della quale si temeva l’assenza di effettività. In realtà, la considerazione del diritto al
lavoro riflette e richiama le coordinate essenziali del sistema economico e del medesimo assetto istituzionale,
di modo che trattare del lavoro significa non solo tenere presente le politiche occupazionali e sociali, ma le
medesime scelte fondamentali nel campo dell’economia e dello sviluppo.
La "storia" del diritto al lavoro è così (parte del) la storia economica del nostro Paese e del contesto
internazionale in cui il medesimo è inserito. In tale prospettiva, ad esempio, all’indomani dell’entrata in vigore
della Carta costituzionale risultava coerente con il compromesso raggiunto in materia economica puntare
sull’intervento pubblico per la soluzione dei problemi occupazionali ed individuare quali strumenti di
attuazione del compito di rendere effettivo il diritto posto a carico della Repubblica le politiche di piano ed il
monopolio pubblico nel collocamento, subito istituito infatti con la l. 264/1949.
È nota la progressiva dissoluzione - manifestata tra gli anni settanta e ottanta - della fiducia nelle capacità
di programmazione del nostro sistema politico e, più in generale, nei confronti del medesimo strumento di
pianificazione economica generale. La praticabilità di siffatto strumento, infatti, si è dovuta misurare con vari
fattori: dall’instabilità del quadro politico italiano, alle ripetute crisi internazionali, agli stessi limiti di crescita
dell’azione statale. L’intenso processo di integrazione comunitaria, poi, ha reso evidente che i livelli di
programmazione andrebbero individuati su base più ampia di quella nazionale, atteso che proprio il livello
statale appare condizionato e limitato dalle scelte adottate in un ambito comunitario che tanta parte dedica alla
valorizzazione del mercato.
Il diritto al lavoro ha rappresentato in un certo senso la cartina di tornasole di tali mutamenti (culturali e)
istituzionali. In particolare, l’organizzazione del mercato del lavoro ha dovuto fare i conti con una concezione
che in via generale, a partire dai primi anni novanta, ha ridisegnato i rapporti tra pubblico e privato all’insegna
delle politiche di privatizzazione, invocando semmai la c.d. sussidiarietà orizzontale quale criterio di risistemazione di tali rapporti, e con tendenze autonomistiche sempre più forti (da far parlare nel linguaggio
politico di federalismo, anziché di un più esteso e razionale regionalismo).
Si spiega in tale prospettiva che la Corte di Giustizia delle Comunità europee abbia affermato il
contrasto tra i principi comunitari e la disciplina italiana sul collocamento e sull’interposizione nei rapporti di
lavoro, ritenendo che un tale servizio costituisca una vera e propria attività di impresa, assoggettata alle regole
del mercato. Dal canto suo, la l. 59/1997, ha conferito alle regioni gran parte dei compiti relativi al
collocamento prima affidati allo Stato. Il successivo d.lg. 469/1997 ha provveduto alla riorganizzazione della
materia, introducendo la radicale novità dell’affidamento a soggetti privati dell’attività di intermediazione nelle
assunzioni. Il c.d. Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia, reso noto dal Governo nell’ottobre 2001, la
successiva l. delega 30/2003 ed il d.lg. 276/2003, sono le tappe fondamentali di un processo di profondo
rinnovamento del settore, che sta cambiando anche taluni tradizionali approcci alla materia. Del resto, ad un
ritmo impressionante di interventi normativi, il rapporto di lavoro a tempo determinato, il contratto di lavoro
interinale, le possibilità offerte dal lavoro a tempo parziale, il contratto di somministrazione della manodopera
a tempo determinato ed indeterminato, il contratto di lavoro intermittente, ripartito, occasionale, accessorio, a
progetto, stanno modificando la configurazione di molti istituti del diritto del lavoro, seguendo le
trasformazioni sociali e l’apparire di figure professionali nuove, ma anche tentando di dare impulso e sostegno
all’occupazione.
218
L’altro profilo con il quale il diritto del lavoro deve oggi confrontarsi attiene all’estensione delle
competenze regionali ad opera della l. Cost. 3/2001. Come è noto, alla potestà concorrente (statale e) regionale
sono state attribuite le materie della "tutela e sicurezza del lavoro" e delle "professioni"; le regioni sono, poi,
attributarie delle materie innumerate non specificamente assegnate alla potestà esclusiva dello Stato. A tal
proposito si è quasi da subito avvertito che il diritto del lavoro rientra all’interno della materia "ordinamento
civile" di competenza statale, quasi a voler scongiurare la possibilità di discipline regionali differenziate tali da
mettere in crisi il fondamentale valore dell’eguaglianza e da attentare al sistema delle garanzie. La precisazione
è stata senz’altro opportuna; peraltro, essa sembra essere eccessivamente attenta al rischio che l’indicazione
delle materie statali e regionali sia intesa alla stregua del criterio di una netta separazione. Invero il modello
prefigurato dalla riforma del 2001 può acquisire funzionalità solo a condizione di sviluppare tecniche di
integrazione delle competenze e di collaborazione tra lo Stato e le regioni anche sotto il versante normativo,
come poi riconosciuto da C. Cost. 303/2003 e dalla successiva giurisprudenza che impone la previsione di
intese tra Stato e regioni. In questo contesto, l’attribuzione statale di individuare i livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti sociali non è solo la norma di chiusura, ma la medesima chiave di lettura del
riparto realizzato. La giurisprudenza costituzionale in tema di professioni, (sentt. nn. 353/2003, 319, 355, e
405/2005), sembra confermare la tendenza a contenere in maniera rigorosa gli spazi regionali entro penetranti
scelte di principio della legislazione statale. Si aggiunga che la possibilità delle regioni di estendere le rispettive
possibilità di normazione nel campo lavorativo non può andare disgiunta dalla valorizzazione del livello
regionale di contrattazione in forme molto più consistenti di quelle attuali, di modo che in materia (non solo si
incontrano e si intercettano sussidiarietà verticale ed orizzontale, ma) l’esercizio delle competenze normative
regionali appare il frutto di un’articolazione organizzativa che non può non coinvolgere le parti sociali.
contrattazione
I sindacati e la contratt
azione collettiva
Il sindacato è l’organizzazione che rappresenta i lavoratori subordinati. Il sindacato stipula i
contratti collettivi di lavoro. Il sindacato intrattiene rapporti con gli imprenditori. Il sindacato assiste e
tutela i lavoratori anche in ambito giudiziario. Il sindacato indice uno sciopero.
Il sindacato è nato storicamente con l’idea di coalizzare i lavoratori subordinati in modo tale da
contrapporre al datore di lavoro un gruppo unitario forte, compatto, organico.
La libertà sindacale è prevista dall’art. 39 Cost., secondo cui «l’organizzazione sindacale è
libera».
Uno dei compiti fondamentali del sindacato è la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro.
lavoro
Tali contratti sono negozi giuridici di diritto privato, recanti regole destinate a vincolare il datore di
lavoro e il singolo lavoratore dipendente in occasione della conclusione del contratto individuale di
lavoro e per tutto lo svolgimento del rapporto. Il contratto collettivo, dunque, enuncia regole comuni
relative al rapporto di lavoro: retribuzione, mansioni, orari di lavoro, ferie, malattie ecc.
Ci sono diversi livelli di contrattazione collettiva.
collettiva I lavoratori sono raggruppati per settori
merceologici (es. industria, bancario, commercio, e via discorrendo) e in ognuno di questi c’è un
contratto nazionale. Seguono, poi, contratti locali e contratti aziendali, che specificano ulteriormente
la disciplina negoziale fissata a livello nazionale.
L’importanza del contratto collettivo è evidente. Integrando la disciplina legislativa, tali contratti
permettono di adattare le regolamentazioni alle specificità dei singoli settori.
Dal punto di vista giuridico, però, i contratti collettivi di lavoro scontano un problema che ne
potrebbe minare la capacità di tutelare adeguatamente i lavoratori subordinati.
Si è detto: il contratto collettivo di lavoro è un negozio giuridico di diritto privato. Come tale, ad
esso di applicano le norme del codice civile e delle leggi complementari. Il codice civile stabilisce che
«il contratto ha forza di legge tra le parti». Ciò significa che dal contratto nascono diritti e obblighi
imputabili esclusivamente alle parti contrattuali.
Quanto viene stipulato un contratto collettivo nazionale di lavoro le parti sono: i sindacati dei
lavoratori (es. Cgil, Cisl, Uil) e le organizzazioni delle imprese (es. Confindustria, Confcommercio).
Dunque, stando a quanto sancito dal codice civile, che comunque enuncia un principio di portata
generale, il contratto collettivo dovrebbe obbligare soltanto i sindacati e le organizzazioni delle
imprese che lo hanno stipulato.
219
A loro volta, i sindacati e le organizzazioni delle imprese sono associazioni alle quali sono
iscritti lavoratori e, rispettivamente, datori di lavoro. Assolvendo una funzione rappresentativa rispetto
a questi, si può affermare che i contratti collettivi, pur stipulati da parti collettive, impegnano anche i
rispettivi associati.
Senonché, l’iscrizione ad un sindacato o ad una organizzazione imprenditoriale non è
obbligatoria, essendo rimessa ad una libera scelta dei lavoratori e dei datori di lavoro. Pertanto,
coloro che non sono iscritti alle organizzazioni che hanno concluso un contratto collettivo, non sono
obbligati a rispettarne il contenuto.
Questa circostanza non è trascurabile.
Il contratto collettivo mira ad evitare che, in sede di stipulazione di un contratto individuale di
lavoro, la parte più forte (il datore di lavoro) imponga condizioni sfavorevoli alla parte più debole (il
lavoratore subordinato). Così, ad esempio, il contratto collettivo di un dato settore merceologico
stabilisce il salario minimo per ogni tipo di qualifica, mansione e anzianità. Le parti di un contratto
individuale non dovrebbero mai scendere al di sotto di tale minimo.
Si è detto però che il contratto collettivo vale solo per le parti e per coloro che sono iscritti alle
organizzazioni che lo hanno stipulato. Dunque, un datore di lavoro, chiamato a scegliere il lavoratore
da assumere, preferirà colui che non è iscritto ad un sindacato, così da non essere costretto a
rispettare il contratto collettivo. In questo modo, egli riuscirà ad imporre unilateralmente le
condizioni di lavoro, a cominciare dallo stipendio.
Se le cose stessero davvero così, allora il sindacato ne uscirebbe decisamente depotenziato. I
lavoratori non avrebbero interesse ad iscriversi ai sindacati: solo così riuscirebbero a convincere il
datore di lavoro ad assumere loro al posto di altri, iscritti ai sindacati.
Questa conclusione è inconciliabile con il principio consacrato in apertura dell’art. 39 Cost.
sulla libertà sindacale.
Ebbene, per porre rimedio a questo problema, lo stesso art. 39 ha concepito il seguente
meccanismo:
- i contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati registrati sono validi ed efficaci erga omnes,
ossia nei confronti di tutti i lavoratori appartenenti alle categorie di riferimento;
- per la registrazione, i sindacati devono possedere una struttura interna di carattere
democratico.
Senonché, la realizzazione di tale modello è stata dallo stesso art. 39 demandata ad una
apposita legge che dal 1948 ad oggi non è mai stata approvata dal Parlamento. Quindi, questo
meccanismo non ha mai funzionato e tuttora i sindacati sono associazioni non registrate.
Cosa ha impedito l’approvazione di questa legge ?
Si è detto che l’unica condizione richiesta per conseguire la registrazione (che è un atto
amministrativo vincolato, ossia non discrezionale) è l’ordinamento interno a base democratica. A
parte le intuibili difficoltà nel definire una volta per tutte le condizioni di avveramento di tale
requisito, in Parlamento si è sempre formato uno schieramento trasversale ostile a questo
meccanismo. In effetti, la verifica dello stesso presuppone forme di controllo da parte dei pubblici
poteri che i sindacati hanno sempre giudicato con sospetto. Dunque, non se n’è fatto nulla.
E, allora, il problema dell’efficacia erga omnes dei contratti collettivi è rimasto irrisolto ?
Verso la fine degli anni Cinquanta e all’inizio del decennio successivo il legislatore è intervenuto
in più occasioni traducendo in norme giuridiche i contenuti dei contratti collettivi di lavoro. Siccome
le norme giuridiche sono per definizione valide ed efficaci erga omnes, il problema poteva
considerarsi così risolto. Tuttavia, la Corte costituzionale ha bloccato questo meccanismo in quanto
incompatibile con la libertà sindacale e con l’essenza dei contratti collettivi quali espressioni di
autonomia negoziale privata.
Allora, a partire dagli anni Sessanta ci pensarono i giudici del lavoro (i cd. Pretori d’assalto) a
risolvere il problema. In che modo ? Applicando direttamente la Costituzione.
L’elemento più rilevante della contrattazione collettiva è la remunerazione del dipendente.
L’art. 36 Cost. stabilisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla
220
qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia una
esistenza libera e dignitosa. È questo un fondamentale principio di civiltà giuridica calato nei rapporti
di lavoro, così da sottrarre almeno in parte all’autonomia negoziale delle parti la determinazione dello
stipendio. Proprio perché il datore di lavoro (la parte contrattualmente più forte, con il coltello dalla
parte del manico si potrebbe dire) potrebbe approfittarne a fissare uno stipendio modesto.
Ora, quando un lavoratore non iscritto al sindacato agisce in giudizio contro il datore di lavoro
perché il suo stipendio è inferiore al minimo salariale stabilito dal contratto collettivo, il datore stesso
obietterà alla controparte l’inapplicabilità del contratto collettivo per le ragioni suesposte: il contratto
vincola solo le parti e tale non è il lavoratore non iscritto al sindacato.
Per superare questa obiezione il giudice applica direttamente l’art. 36 Cost. utilizzando il
contratto collettivo come standard di riferimento per stabilire cosa sia, in concreto, una retribuzione
proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente a garantire al
lavoratore stesso e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. Il principio generale viene
riempito di contenuto idoneo ad una sua applicazione diretta n ambito processuale. Il contratto
collettivo, usato come parametro oggettivo di riferimento (non potrebbe infatti il giudice valutare
l’adeguatezza dello stipendio) finisce coll’acquisire, in tal modo, la necessaria efficacia erga omnes.
Questa prassi giurisprudenziale, seguita nel corso degli anni e tuttora operativa, è stata quindi
estesa anche alle altre parti del contratto collettivo.
Di seguito, dunque, sono riportati i commenti di D’Aloia, sui sindacati, e di Colapietro sull’art.
36.
A. D’ALOIA, Commento all’art. 39, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario
alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 796 ss.
…
2.1 La libertà dell’organizzazione sindacale: contenuto, limiti, soggetti e forme della rappresentanza
2.1.1 L’art. 39 nel disegno costituzionale di «liberazione e promozione umana»
La disattivazione della parte «normativa» (quella dedicata al problema dei contratti e della
rappresentanza negoziale) dell’art. 39 ha di fatto conferito al principio della libertà dell’organizzazione
sindacale una qualificazione «olistica» e riassuntiva dell’intero svolgimento dell’esperienza sindacale, facendone
il punto di legittimazione e di confronto dei suoi processi di autoformazione ed autoregolazione.
Libertà e autonomia organizzativa del sindacato costituiscono una delle principali epifanie di quello che
può essere definito il filo conduttore del nostro modello di democrazia costituzionale: l’intreccio tra
personalismo e pluralismo, la tutela dei diritti dell’uomo dentro una cornice collettiva in cui le istanze
individuali si rafforzano e si alimentano diventando parte di un progetto complessivo di «società e Stato».
La libertà sindacale, in tutte le sue molteplici manifestazioni, è innanzitutto una libertà della persona, un
diritto che interagisce in maniera biunivoca con altri diritti fondamentali, traducendo da un lato la ricerca
costituzionale di un effettivo riequilibrio della pesante asimmetria che caratterizza il conflitto tra interessi dei
lavoratori e poteri economici, e funzionando altresì come strumento della partecipazione dei lavoratori alla
definizione sul piano normativo-amministrativo della strategia dell’eguaglianza sostanziale (art. 3, 2° co., Cost.).
A questa stregua, il fenomeno sindacale proietta, più di quanto non riescano a fare altre istanze o posizioni
individuali giuridicamente protette, la dimensione tradizionalmente «oppositiva» del discorso sui diritti sul
versante della qualità del sistema democratico, come sistema intrinsecamente «poliarchico», costruito in altre
parole su una complessa rete di figure e procedure (non limitati al campo delle istituzioni pubbliche) che
muovono verso l’obiettivo del potere «bilanciato», dinamicamente «separato».
2.1.2 Art. 39 e art. 18 Cost. L’organizzazione sindacale «non associativa»
Rispetto alla norma costituzionale «generale» sui fenomeni associativi (art. 18), l’affermazione per cui
«l’organizzazione sindacale è libera» esprime una sorta di doppia e divergente «specialità». Infatti, il
restringimento dell’orizzonte teleologico dell’associazione sindacale in rapporto alla tipicità dell’oggetto e del
221
fine della sua attività, nonché degli interessi che essa per definizione rappresenta, appare in un certo senso
«compensata» dalla più ampia delineazione dei modelli di «aggregazione» sindacale dei lavoratori, che
potrebbero assumere anche forme ulteriori rispetto allo schema codicistico dell’associazione non riconosciuta
(art. 36 ss. c.c.).
Secondo la nota e risalente impostazione di Flammia, invero non particolarmente sostenuta dalla
giurisprudenza, «nel nostro settore l’effettività prevale decisamente sulla forma legale nel senso che
l’ordinamento non precostituisce o predetermina forme legali di organizzazione, ma richiede soltanto che
l’autotutela sia effettiva, ...». Di conseguenza, il pluralismo sindacale potrebbe contenere e giustificare anche
soggetti diversi dalle «ordinarie» associazioni; il riferimento, poi ripreso e sviluppato da dottrina successiva, è a
soggetti come coalizioni di sciopero di lavoratori non aderenti ad un sindacato, delegazioni di datori di lavoro
non organizzati in sindacati di settore (delegazioni che nascono ad hoc per contrattare le condizioni di lavoro
con la controparte e che si estinguono automaticamente ad avvenuta contrattazione), forse anche le
commissioni interne (tipiche forme di rappresentanza in azienda nel clima della contestazione).
2.1.3 Problemi di identificazione della fattispecie sindacale: l’art. 10 Convenzione OIL n. 87. Il
sindacato e i lavoratori «non attivi»
Proprio la libertà delle forme organizzative finisce per spostare soprattutto sugli elementi di tipo
teleologico-finalistico il lavorìo di identificazione della fattispecie sindacale. Quello che conta nel fenomeno
sindacale è «l’esserci per», la combinazione tra dimensione organizzativa e «attività diretta alla autotutela di
interessi connessi a relazioni giuridiche in cui sia dedotta l’attività di lavoro (e non solo di lavoro dipendente)».
Illuminante in questo senso la definizione di sindacato contenuta nell’art. 10 Convenzione OIL n. 87: «ogni
organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro che abbia lo scopo di promuovere e di difendere gli interessi
dei lavoratori o dei datori di lavoro».
La definizione OIL apre tutta una serie di prospettive all’azione sindacale, legate al carattere
indeterminabile e al tempo stesso continuamente ri-determinabile degli interessi dei lavoratori, e alla
interazione tra sfera politica, funzioni pubbliche e ambito economico-sociale; ad ogni modo, non appare del
tutto priva di una capacità di orientamento e precisazione nella soluzione di alcune questioni interpretative
sull’essenza del fenomeno sindacale.
In primo luogo, la formula «interessi dei lavoratori» sembra sufficientemente larga per «coprire» sia il
movimento espansivo del diritto del lavoro, con riferimento alle forme del lavoro (subordinato, parasubordinato, autonomo) e alle nuove figure di lavoratore che si vanno delineando attorno a questo processo
evolutivo, che tutta una serie di vicende e di condizioni personali che si pongono come fasi - precedenti,
interne o successive - del rapporto di lavoro. Correttamente, dunque, rimanendo su quest’ultimo punto, le
organizzazioni sindacali possono comprendere (sebbene in modo non esclusivo) soggetti inoccupati,
disoccupati, pensionati, e svolgere la loro azione anche sulle problematiche connesse a tali status.
2.1.3.1 Segue: l’associazionismo «sindacale» degli imprenditori
Cambiando angolo di visuale, la definizione di sindacato e attività sindacale rilanciata dalla Convenzione
OIL giustifica una lettura del fenomeno sindacale comprensiva dell’associazionismo imprenditoriale. In altri
termini, le aggregazioni rappresentative degli interessi dei datori di lavoro non sono semplicemente libere
associazioni (nel «cono» di legittimazione dell’art. 18 Cost.) ovvero forme di organizzazione dell’attività
economica privata (riconducibili direttamente all’art. 41 Cost.), ma vere e proprie associazioni sindacali, nel
quadro di una immagine tendenzialmente simmetrica e oppositiva del modello sindacale che non pare esclusa
o impedita dall’art. 39.
In effetti, la formulazione dell’art. 39, la tutela costituzionale per il lavoro «in tutte le sue forme ed
applicazioni» (art. 35), l’identificazione del lavoro con (ogni) «attività o funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società» (art. 4, 2° co.), sono argomenti forti nel senso della piena legittimazione del
sindacalismo datoriale. Né oggi si può dubitare del fatto che anche il mercato e i suoi «attori» possano essere
contemporaneamente oggetto e fattore di politiche di eguaglianza sostanziale.
È anche vero però che le due situazioni (quella degli imprenditori e quella dei lavoratori a vario titolo)
non sembrano completamente sovrapponibili. A parte la considerazione «classica» (forse oggi più teorica che
non legata all’effettività delle dinamiche socio-economiche) sul diverso grado di rilevanza delle associazioni
sindacali (dei lavoratori) e delle associazioni imprenditoriali ai fini del funzionamento e della stessa pensabilità
di un sistema di relazioni sindacali, è proprio il legame «genetico» dell’esperienza sindacale con le implicazioni
222
e i contenuti del principio-valore dell’eguaglianza sostanziale37 a suggerire di mantenere comunque una linea
di distinzione tra le organizzazioni dei lavoratori e l’associazionismo imprenditoriale. Almeno nel senso che le
ragioni più profonde di una norma come quella dell’art. 3, 2° co., Cost., non possono non legittimare un
indirizzo preferenziale e di sostegno rafforzato - che è stato quello poi praticato dalla legislazione sindacale, e
soprattutto dallo Statuto dei lavoratori - verso i soggetti esponenziali degli interessi e delle condizioni del lavoro
subordinato, più deboli sul piano economico-sociale.
2.1.3.2 Segue: il divieto di sindacati «misti» e di sindacati «di comodo»
La coesistenza di associazioni dei lavoratori e degli imprenditori all’interno dell’ordinamento sindacale
può avvenire comunque solo in una prospettiva di «alterità» e di contrapposizione degli interessi e dei rispettivi
moduli aggregativi. A questa stregua, la figura del sindacato misto (datori di lavoro e lavoratori dipendenti
insieme) appare estranea alla tipicità dell’esperienza sindacale, potendo tutt’al più trovare uno spazio di
riconoscimento come associazione di fatto (ai sensi dell’art. 18 e non dell’art. 39), priva però dei normali poteri
sindacali, primo fra tutti quello di concludere contratti ai diversi livelli.
L’art. 17 st. lav. vieta inoltre la formazione di sindacati di comodo, cioè di quelle associazioni sindacali di
(soli) lavoratori, costituite o sostenute, «con mezzi finanziari o altrimenti», dai datori di lavoro ovvero dalle loro
associazioni. Si tratta di un meccanismo normativo per certi versi intrinseco alla dinamica sindacale, che si
qualifica in rapporto alla natura antagonistica degli interessi rappresentati, raccordandosi altresì ai principi di
non ingerenza dell’imprenditore e di tutela del lavoratore nei confronti delle discriminazioni legate alla propria
affiliazione o attività sindacale (v. art. 15 st. lav. e art. 2 Convenzione OIL n. 98). Questa norma ha ricevuto
dalla giurisprudenza un’applicazione particolarmente rigorosa, tesa a tutelare anche una libera concorrenza tra
le organizzazioni sindacali.
Il sindacato di comodo è in sostanza un «non sindacato». A questo paradigma, negli ultimi anni, è stato
accostato il caso dei contratti collettivi «al ribasso» o «pirata», stipulati da sigle sindacali scarsamente
rappresentative e dichiaratamente alternative ai soggetti confederali, e applicati soprattutto alle piccole e
piccolissime imprese operanti nel settore del turismo, commercio, panificazione, radio e televisioni private,
conto-terzismo. Secondo le letture più critiche di questo fenomeno, la legittimazione datoriale alla stipulazione
dei contratti in favore di queste associazioni «pirata» funzionerebbe da elemento di torsione e di svuotamento
della autenticità dell’azione sindacale, che finirebbe in sostanza col piegarsi, in cambio del riconoscimento
come controparte negoziale, ad interessi economici del datore di lavoro.
Forse però, la realtà del fenomeno è più complessa, ed è difficile inquadrarla in uno schema valutativo
unico. Il carattere sicuramente «disgregativo» di questa esperienza non può escludere del tutto e sempre una
qualificazione sindacale di questi «nuovi soggetti», almeno quando non siano apertamente violate le garanzie
dei lavoratori (e tra queste, principalmente, il diritto ad una retribuzione sufficiente) e i contenuti della libertà
sindacale. Semmai, di fronte a questi contratti, e alle clausole più dissonanti rispetto al parametro dei contratti
collettivi «confederali», può senz’altro ammettersi, come si è giustamente fatto rilevare, un più intenso e
«stretto» sindacato da parte del giudice.
2.1.4 Contenuti «positivi» della libertà sindacale
La declinazione almeno in prima battuta dei contenuti «positivi» della libertà sindacale non pone
particolari problemi o dubbi interpretativi.
Appare scontato che nei confini della libertà sindacale rientrino pienamente la libertà per i lavoratori di
iscriversi ad un sindacato tra quelli esistenti, come pure di recedere da un sindacato ovvero di non aderire ad
alcuno.
Tali opzioni non sono necessariamente condizionate dalla categoria di appartenenza dei lavoratori,
almeno nel senso che la categoria è pur sempre il riflesso di una scelta organizzativa autonoma dei soggetti
sindacali e non, secondo una concezione superata proprio perché fortemente intrecciata con i commi dell’art.
39 rimasti irreversibilmente inattuati, una sorta di elemento logicamente precedente (in quanto naturalmente
emergente dal tessuto sociale) rispetto alle dinamiche volontarie dell’esperienza sindacale.
Del resto, lo stesso riferimento costituzionale alla strutturazione «categoriale» del fenomeno lavoristicosindacale riguarda solo l’ambito di applicazione del contratto collettivo e non l’intero spettro operativo e
finalistico del sindacato; alla fine, anche a volerlo considerare un segno di preferenza della norma
fondamentale (o meglio dei suoi compilatori) verso la dimensione della categoria, non è affatto una preferenza
223
assoluta, convivendo nella prassi con molteplici articolazioni organizzative (settoriali, territoriali, aziendali, subcategoriali, ...) del gruppo dei lavoratori, «tanto longitudinali quanto trasversali» alla categoria medesima.
2.1.5 Il «problema» della libertà sindacale «negativa»
In verità, il punto che resta controverso riguarda il grado e l’estensione della protezione della libertà
«negativa», cioè della libertà di non aderire ad alcun sindacato. Posto che nessuno può essere costretto ad
iscriversi ad un’associazione sindacale (compulsory unionism), il problema è se ed entro quali limiti possano
ritenersi ammissibili strumenti o clausole contrattuali volti ad incentivare o «forzare» l’aggregazione sindacale
mediante la garanzia di ottenere o mantenere un posto di lavoro, ovvero di poter rivendicare alcuni diritti legati
al rapporto di lavoro.
Sul profilo segnalato, l’atteggiamento dei diversi ordinamenti giuridico-lavoristici conserva evidenti
connotazioni asimmetriche: non a caso, questo è un tema quasi «aggirato» dalla normativa internazionale. Non
sono pochi infatti, i Paesi che adottano schemi legislativi non chiusi all’impiego delle tecniche di «sicurezza
sindacale», con una progressiva intensità nella preferenza verso i lavoratori affiliati e, per converso, negli effetti
di «penalizzazione» per i lavoratori non associati. E, per rimanere all’esperienza europea, anche la Cedu ha
sempre evitato di assumere una posizione netta e drasticamente negativa nei confronti degli accordi di closed
shop, valutando invece caso per caso l’accettabilità o meno del meccanismo preferenziale rispetto alla libertà di
scelta dei lavoratori.
Da noi, l’art. 15 st. lav. esprime chiaramente un indirizzo opposto alla logica del «closed shop-System»
(o monopole syndical d’emploi) almeno nelle sue versioni più «estreme», sancendo la nullità di qualsiasi patto
o atto diretto «a subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una
associazione sindacale ovvero cessi di farne parte». Del resto, su un piano più generale, non sembra molto
coerente con il nostro disegno costituzionale dei diritti, nonostante questo abbia una forte impronta pluralistica
e «collettiva», che interessi soggettivi primari (come sono certamente quelli dei lavoratori o di chi aspira ad
avere un lavoro) siano «condizionati» agli interessi delle strutture organizzative che la Costituzione preordina
alla più efficace realizzazione dei diritti medesimi. Nemmeno appare sostenibile l’argomento fondato
sull’esigenza di «tranquillità aziendale» ad avere dipendenti affiliati ad una o a poche sigle sindacali con le quali
(magari) ci può essere una maggiore facilità di negoziare.
In sintesi, la libertà sindacale - come fatto contemporaneamente individuale e collettivo - presuppone
una dimensione di non obbligatorietà, all’interno della quale non c’è spazio per pratiche o procedure che non
rispettino anche una scelta di estraneità complessiva al movimento sindacale, e non semplicemente di recesso
o di dissenso finalizzati ad una diversa proiezione organizzativa. La legge può ovviamente promuovere e
incentivare la scelta associativa, anche alla luce del favor costituzionale per la tutela «collettiva» dei diritti dei
lavoratori (artt. 3, 2° co., e 39), ma può farlo solo agendo sul versante del ruolo e dei compiti riconosciuti alle
organizzazioni sindacali nei diversi livelli in cui si svolge il sistema delle relazioni industriali, e non operando in
chiave discriminatoria nei confronti dei singoli che manifestano una posizione radicalmente «astensiva» nei
confronti dell’organizzazione e dell’azione sindacale.
2.1.6 L’attuazione «conformativa» dell’art. 39: Convenzione OIL e Statuto dei lavoratori
In un contesto costituzionale «rigido», le norme costituzionali costituiscono il parametro orientativo e il
limite delle politiche legislative; di contro però, sono queste a definire l’immagine reale e la proiezione
dinamica dei contenuti delle prime. In altre parole, i principi della Costituzione sono anche ciò che le leggi
progressivamente attuano, in una continua ed incessante rielaborazione dei significati e delle implicazioni
sostanziali riconducibili al suo tessuto normativo «elastico».
A questa stregua, il principio-valore della libertà sindacale ha trovato i suoi momenti fondamentali di
esplicitazione nelle due convenzioni OIL del 1948 e del 1949 (rispettivamente le nn. 87 e 98, ratificate
entrambe nel nostro Paese con la l. 367/1958), e nello Statuto dei lavoratori (l. 300/1970).
Soprattutto lo Statuto dei lavoratori sembra replicare assai bene lo schema dell’attuazione «innovativa»
(o conformativa) del dettato costituzionale. È stata la stessa Corte costituzionale a qualificare le norme dello
Statuto (nel caso in esame gli artt. 14 e 20) come scelte di politica legislativa che «eccedono il contenuto della
garanzia costituzionale della libertà sindacale per tradursi in un intervento giuridico-istituzionale qualificato da
una funzione di sostegno dell’organizzazione sindacale all’interno delle imprese».
E, in effetti, la logica della l. 300/1970 è quella di rafforzare la presenza sindacale nelle aziende,
attraverso il riconoscimento di diritti e possibilità operative (v. soprattutto gli artt. 14-16 e 19 ss. st. lav.), e sul
224
terreno complessivo dell’evoluzione della democrazia industriale nel nostro Paese, accentuando il rilievo di
alcuni soggetti sindacali, quelli confederali, particolarmente adatti a svolgere una funzione di sintesi e
rappresentanza generale degli interessi del mondo del lavoro, e di raffronto di questi con le grandi questioni
dello Stato sociale e della crisi economica.
2.1.7 Limiti alla libertà sindacale tra Costituzione e legge
La libertà di scegliere la forma organizzativa più adatta alle finalità sindacali perseguite, senza ingerenze
statuali o pubbliche, così come l’attività di proselitismo e di autotutela che insieme alla contrattazione
costituiscono il nucleo essenziale di azione delle strutture sindacali, sono inevitabilmente soggette ad una serie
di condizioni limitative poste a garanzia di interessi diversi (si pensi, per un primo esempio agli artt. 17 e 26 st.
lav.). D’altronde, questo è un destino di ogni diritto o libertà costituzionale: ovviamente, è necessario che i
limiti trovino un fondamento giustificativo nella protezione di beni o interessi comunque di rango
costituzionale (nei riferimenti appena fatti, la genuinità del fenomeno sindacale, o il normale svolgimento
dell’attività aziendale e dunque esigenze connesse alla tutela dell’iniziativa economica privata).
2.1.7.1 Segue: sindacati e democraticità
L’art. 39, 3° co., stabilisce che «è condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano
un ordinamento interno a base democratica». La connessione testuale tra procedura di registrazione e requisito
di democraticità dell’ordinamento interno dei sindacati, una volta esaurita ogni concreta prospettiva di
attuazione della seconda parte della disposizione costituzionale, ha messo in ombra proprio questo secondo
profilo, portando una larga parte della dottrina a ritenere che il carattere democratico dell’organizzazione
costituisse in realtà un semplice onere per la registrazione, non più indispensabile al di fuori dell’attivazione di
quello specifico meccanismo procedurale.
Tra le costruzioni più rigorose di questo self-restraint organizzativo dei sindacati, spicca quella di
Carabelli, che configura la libertà sindacale come «immunità» da ogni regola eteronoma, fosse anche rivolta a
garantire il rispetto del principio democratico e dei diritti inviolabili dell’uomo. Per questo A., invero, il
problema di assicurare un minimo di organizzazione democratica dei sindacati - come formazioni sociali
«speciali» (al pari dei partiti politici) - può essere ribaltato nella considerazione che la possibilità stessa di
costituire sindacati è stata ritenuta dal costituente la massima garanzia idonea a promuovere, indirettamente,
all’interno di queste organizzazioni, l’esistenza di una vita democratica e il rispetto dei diritti inviolabili
dell’uomo.
In altre parole, secondo l’impostazione richiamata, posto che «l’essenza della democrazia sindacale
consiste nella possibilità di aderire o di recedere in ogni momento dal sindacato, e di fondarne un altro»,
l’unico modo per spingere le organizzazioni sindacali ad adottare regole interne ispirate al metodo democratico
(elettività delle cariche, partecipazione associati alle decisioni, temporaneità delle cariche direttive, ...) potrebbe
consistere in una legislazione di tipo promozionale, volta cioè a «compensare» con incentivi finanziari e altre
agevolazioni la scelta del sindacato di sottoporsi a regole democratiche più stringenti.
Certo, la questione della democraticità dell’ordinamento sindacale non va ingigantita, nel senso che, sul
piano dell’esperienza, l’alternativa non è quella - pure ipotizzata teoricamente - tra sindacati assoggettati a rigide
prescrizioni «democratiche» imposte dallo Stato e sindacati liberi invece di articolarsi anche secondo moduli
organizzativi totalmente estranei al principio democratico.
In fondo, sembra piuttosto un controsenso accettare l’idea che una «Repubblica democratica» (art. 1
Cost.) possa tollerare che alcune sue articolazioni settoriali esprimano una connotazione apertamente difforme
dal principio fondativo, soprattutto quando si tratta di soggetti che a vario titolo partecipano alla
determinazione dell’indirizzo politico e ai processi decisionali pubblici. Lo «spirito democratico» rappresenta
una sorta di punto di attrazione delle diverse manifestazioni dell’ordinamento giuridico (v. anche, in questo
senso, l’art. 52, 3° co., sull’ordinamento militare), che ad esso debbono tendere. La specialità di taluni
«ordinamenti» (quello sindacale, tra gli altri) può legittimare una certa autonomia o flessibilità di traduzione del
metodo democratico, nel senso che non può esistere uno schema rigido da seguire automaticamente con il
rischio di controlli troppo pressanti sulle associazioni sindacali, ma non una negazione del principio in nome di
una (malintesa) libertà organizzativa che finirebbe col tradire la sua logica finalistica più profonda, quella di
funzionare da strumento di svolgimento e di realizzazione della persona e dei suoi diritti fondamentali. E
questo a prescindere dal fatto che organizzazioni sindacali palesemente non democratiche non troverebbero
probabilmente molto spazio nell’andamento spontaneo delle relazioni s