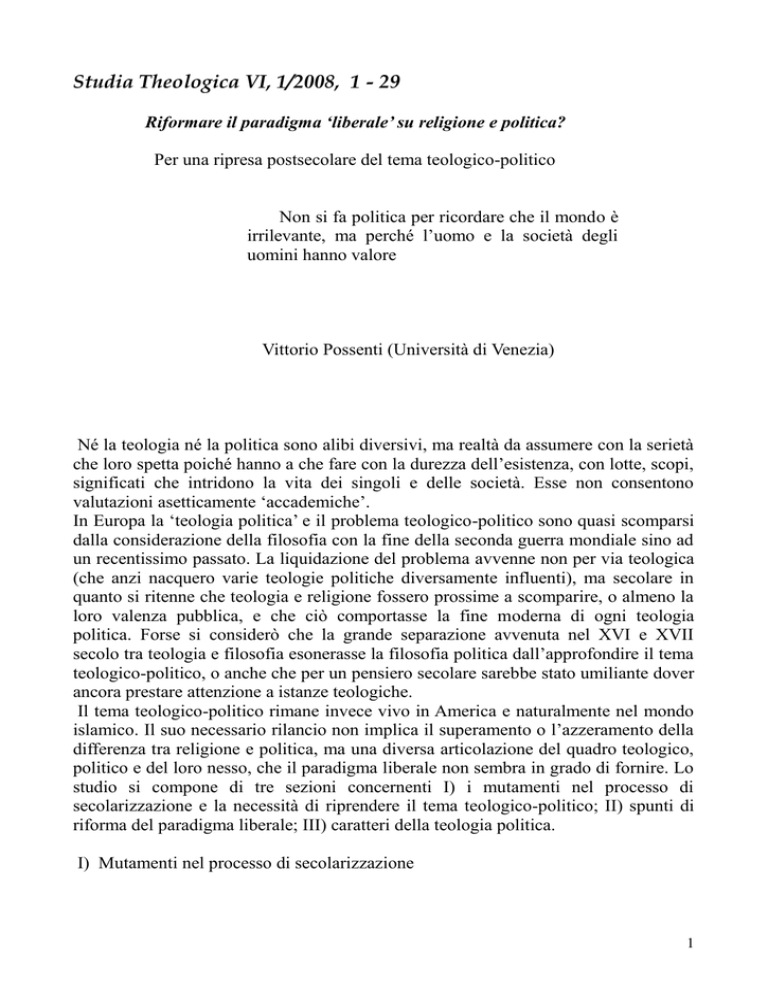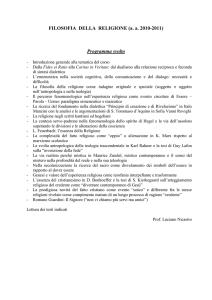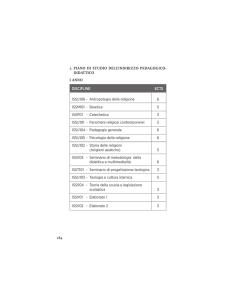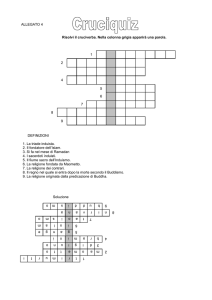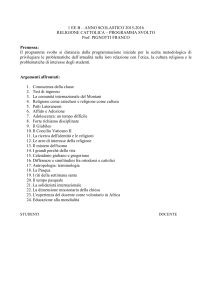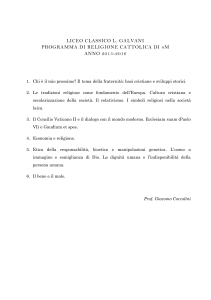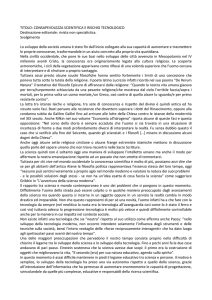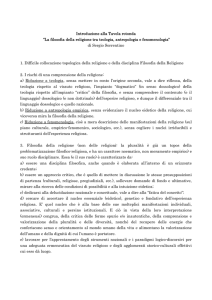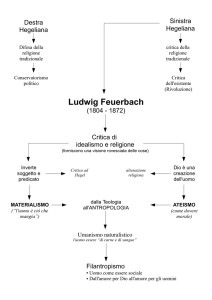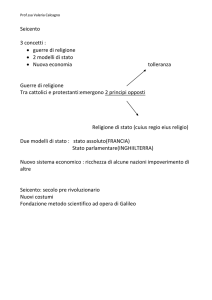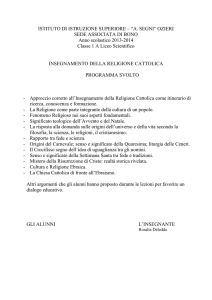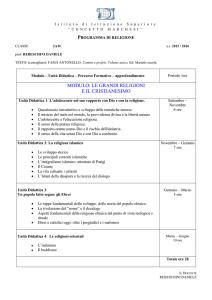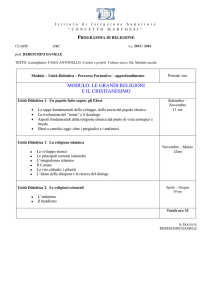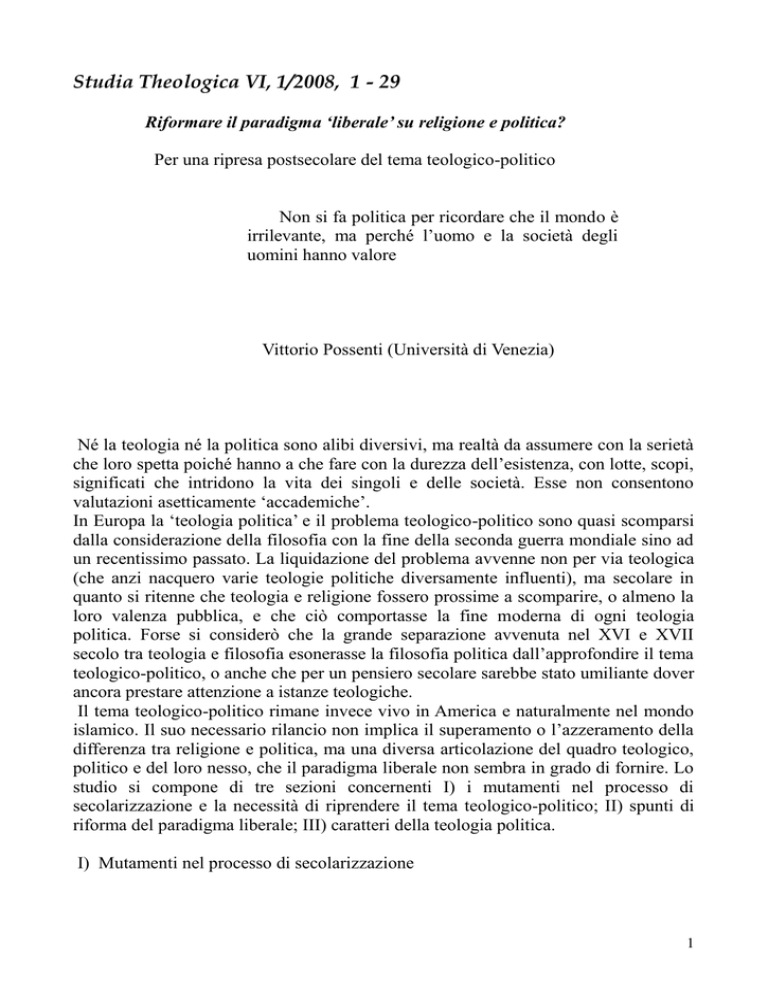
Studia Theologica VI, 1/2008, 1 - 29
Riformare il paradigma ‘liberale’ su religione e politica?
Per una ripresa postsecolare del tema teologico-politico
Non si fa politica per ricordare che il mondo è
irrilevante, ma perché l’uomo e la società degli
uomini hanno valore
Vittorio Possenti (Università di Venezia)
Né la teologia né la politica sono alibi diversivi, ma realtà da assumere con la serietà
che loro spetta poiché hanno a che fare con la durezza dell’esistenza, con lotte, scopi,
significati che intridono la vita dei singoli e delle società. Esse non consentono
valutazioni asetticamente ‘accademiche’.
In Europa la ‘teologia politica’ e il problema teologico-politico sono quasi scomparsi
dalla considerazione della filosofia con la fine della seconda guerra mondiale sino ad
un recentissimo passato. La liquidazione del problema avvenne non per via teologica
(che anzi nacquero varie teologie politiche diversamente influenti), ma secolare in
quanto si ritenne che teologia e religione fossero prossime a scomparire, o almeno la
loro valenza pubblica, e che ciò comportasse la fine moderna di ogni teologia
politica. Forse si considerò che la grande separazione avvenuta nel XVI e XVII
secolo tra teologia e filosofia esonerasse la filosofia politica dall’approfondire il tema
teologico-politico, o anche che per un pensiero secolare sarebbe stato umiliante dover
ancora prestare attenzione a istanze teologiche.
Il tema teologico-politico rimane invece vivo in America e naturalmente nel mondo
islamico. Il suo necessario rilancio non implica il superamento o l’azzeramento della
differenza tra religione e politica, ma una diversa articolazione del quadro teologico,
politico e del loro nesso, che il paradigma liberale non sembra in grado di fornire. Lo
studio si compone di tre sezioni concernenti I) i mutamenti nel processo di
secolarizzazione e la necessità di riprendere il tema teologico-politico; II) spunti di
riforma del paradigma liberale; III) caratteri della teologia politica.
I) Mutamenti nel processo di secolarizzazione
1
1. Nel mondo del XX secolo, in specie la prima parte ma poi anche fino all’incirca
agli anni ‘80, le religioni e le tendenze religiose sono state duramente represse in
molte parti del mondo (paradigmatico il caso dei totalitarismi), oppure confinate al di
fuori della sfera pubblica col fenomeno occidentale della secolarizzazione e del
laicismo. La forza della religione sembrò declinante e schiantata, e l’asse dell’Europa
ricondotto alla Mosca sovietica ed atea o alla Parigi illuministico-liberale e scettica.
Vari fattori mutarono quasi improvvisamente il quadro e la religione riapparve nel
pubblico anche in Occidente, dove pur fatica a riemergere, mentre altrove le tendenze
religiose dispongono del potenziale sufficiente a conferire una diversa forma alle
realtà politiche, a un livello che forse non ha l’eguale dall’epoca del sorgere del
moderno nazionalismo. In modo assai vario, e naturalmente non senza seri rischi, le
tradizioni religiose possono contribuire a rinnovare il linguaggio politico e l’agenda
dei maggiori problemi. Mutamenti di fondo sono dunque intervenuti nel processo di
secolarizzazione, che sembrò sino a un recente passato inarrestabile: diverse
espressioni religiose, al di là dell’Occidente ma anche senza escluderlo, hanno
ricominciato ad acquistare spazio nella sfera pubblica, opponendosi al pluricentenario
movimento che vorrebbe ridurre la religione al privato. Il giudizio secondo cui la
civiltà va verso il secolarismo e l’estinzione della religione, non appare più così certo.
Ciò che sta adesso prendendo forma sotto i nostri occhi è una “deprivatizzazione”
della religione.
Probabilmente si prepara nel XXI secolo un nesso fra religione e politica diverso da
quello da tempo consolidatosi in Occidente, e forse capace di avvertire la nuova
incidenza delle religioni quali grembo delle grandi civiltà. Sembra evidente il bisogno
di una rinnovata considerazione del problema che deve giocare su una tastiera più
ampia di quella, pur preziosa, costituita dagli studi sociologici sulla religione che
sono rinati in tempi recenti. Forse la leva sociologica non è sufficiente per
rappresentare l’intera ampiezza del problema e altri approcci appaiono necessari.
2. Il ‘teorema della secolarizzazione’ si sostanziava in tre segmenti di importanza
crescente. 1) A un primo livello la teoria illuministico-liberale della secolarizzazione
mirava alla crescente separazione fra religione e società, fra Chiesa e Stato, allo
scopo di contenere e infine azzerare l’influsso della prima sulla vita civile, politica,
culturale. Questo progetto ha avuto complessivamente successo in Occidente (meno
altrove). Tuttavia anche in Occidente la situazione sta mutando e la modalità di
separare seccamente religione e società comincia ad entrare in crisi. 2) A un secondo
livello si assumeva che la pratica e la fede religiose sarebbero andate sempre più
declinando sino alla scomparsa. Questa seconda previsione si è dimostrata falsa
anche in parte dell’Occidente. 3) In terzo luogo si confidava che un’estrema
privatizzazione, ossia il confinamento della religione nel privato strettamente
individuale, avrebbe agevolato il processo appena detto e comportato presto o tardi la
sua estinzione a seguito di una completa irrilevanza e marginalità pubbliche. La realtà
storica sta prendendo altra strada, e ciò induce a riesami anche i sostenitori del
teorema della secolarizzazione.
2
Una frase di P. J. Proudhon, vergata in un’epoca rivoluzionaria e d’altro canto
prossima all’ascesa del positivismo antiteologico, dipinse vivacemente l’enjeu del
problema: “Il est surprénant qu’au fond de notre politique nous trouvions toujours la
théologie” (1). Proudhon, che partiva da una posizione rivoluzionaria e antiteista,
offriva la sua valutazione quando il paradigma liberale volto alla privatizzazione della
religione ed alla sua espulsione dalla sfera pubblica aveva compiuto notevoli passi e
si avviava a diventare egemone. In sostanza il liberalismo si ingegnava per non
trovare la teologia al fondo della politica, e probabilmente riteneva non solo che
dietro la politica non ci fosse alcuna teologia ma che in linea di principio non ci
dovesse essere. L’opera di separazione, spesso congiunta ad un’esplicita critica della
religione, iniziò nel ‘700, quando l’illuminismo continentale sferrò un serrato attacco
alla religione e in specie al cristianesimo. Lo slancio di tale critica sembrò trovare un
momento di pausa con la grande lezione di Tocqueville, ma poi riprese in forme
varie, e il Manifesto di Marx divulgò la critica della religione come oppio dei popoli
che dissipavano se stessi in un incerta cura oltremondana dei mali dell’anima.
Nel ‘900 il nesso religione-politica venne elaborato e rielaborato da numerosi autori
secondo una traiettoria che in genere segna un allontanamento del liberalismo
novecentesco dalla critica verso la religione propria dell’illuminismo settecentesco.
Due frasi di Hayek e Rawls dipingono il cambiamento dall’ostilità alla reciproca
neutralità. Secondo il primo “Diversamente dal razionalismo della Rivoluzione
francese, il vero liberalismo non ha da litigare con la religione, ed io posso solo
deplorare il militante ed essenzialmente antiliberale spirito antireligioso, che animò
tanta parte del liberalismo continentale del XIX secolo” (2). Rawls sostiene che
“There is, or need be, no war between religion and democracy. In this respect
political liberalism is sharply different from and rejects Enlightement liberalism,
which historically attacked ortodox Christianity” (3). Vari anni prima J. Maritain
elaborò a lungo non solo il superamento dell’estraneità tra religione e politica, ma
pure la necessità di nutrire la sfera pubblica con un’ispirazione religiosa: il messaggio
evangelico deve essere presente nel pubblico esercitandovi un’influenza cognitiva,
ispirante e motivante. Si tratta di una questione fondamentale che sta assumendo i
caratteri di una disputa culturale; si pensi al dibattito sulla Costituzione europea e alle
radici cristiane dell’Europa. La posizione maritainiana secondo cui il cristianesimo
può rappresentare una forza determinante per la civiltà occidentale del XXI secolo,
viene argomentata attraverso un’elaborazione sull’apporto del messaggio evangelico
alla persona umana, ai suoi diritti, alla liberazione politica, ed una ricostruzione
storica del ruolo giocato dal cristianesimo nella nascita e sviluppo delle istituzioni
politiche tipiche delle moderne società occidentali (Cfr. in specie Umanesimo
integrale, 1936; I diritti dell’uomo e la legge naturale, 1942, Cristianesimo e
democrazia, 1943, L’uomo e lo Stato, 1951).
In anni recenti Habermas ha teorizzato il superamento della reciproca neutralità,
suggerendo una mutua traduzione dei messaggi di liberazione della coscienza laica e
di quella religiosa, nel senso di andare verso un’intesa tra religione e politica
attraverso un processo di doppio apprendimento tra le due parti e un dialogo tra
3
pensiero religioso e pensiero secolare, in cui essi hanno autentica legittimità e
cercano di rispettarsi vicendevolmente (4).
Da qui la domanda cui ci volgiamo: il cammino di ricucitura tra sfera pubblica e
religione - che parte dalla massima distanza del laicismo francese postrivoluzionario
e che si stempera nel liberalismo di Hayek e Rawls sino a giungere al processo di
doppio apprendimento di Habermas -, sino a dove può/deve proseguire? sino al
riconoscimento dell’apporto del discorso biblico alla sfera pubblica? E intorno a quali
paradigmi? In ogni caso lo schema liberale su religione e politica appare bisognoso di
una revisione profonda.
3. Come accennato, la filosofia pubblica degli ultimi 50-60 anni è stata distratta in
merito al tema teologico-politico, e solo recentemente va riscoprendo il tema. Siamo
dinanzi ad un recupero benvenuto ma forse anche frettoloso e con rischi di
superficialità, motivato più da visibili urgenze che da un ripensamento endogeno e di
lunga lena. Uno dei temi principali del dibattito in corso è l’adeguatezza del
paradigma liberale classico, che per essere in pari col problema non può limitarsi ad
operazioni di maquillage. L’idea che si possa procedere solo ritoccando le idee
tradizionali liberali di libertà e di eguaglianza sembra sospetta già a partire
dall’assunto metodologico che ritiene la politica un settore quasi indipendente ed
autonomo. Ma l’impatto sulla sfera civile delle grandi rivoluzioni moderne, tra cui
oggi e domani la Tecnica, non consente singoli aggiustamenti, piuttosto sollecita un
discorso più fondamentale ed intrecciato, più difficile da gestire di quello in cui il
politico è determinato formalmente come sistema chiuso o quasi. Non abbiamo atteso
il recente revival del problema ‘religione-politica’ per sottolinearne il rilievo e la
sorprendente assenza nel pensiero politico di 20 o di 40 anni fa. Da Le società liberali
al bivio (1991) riprendo un brano in cui la diagnosi di marginalità del tema teologicopolitico era esplicita: “Nell’affrontare il suddetto argomento [il nesso tra religione e
politica] si trova che c’è un recupero da operare. In effetti nella seconda parte del XX
secolo la teoria politica ha in genere omesso di trattare i classici temi del rapporto fra
temporale e spirituale, fra politica e religione, abbandonando una tradizione che
annoverò nel secolo scorso grandi autori: Hegel, Rosmini, Stein, Stahl, in parte
Comte” (5).
Negli anni cui alludo la questione del rapporto tra religione e politica diventò
laterale per vari motivi, tra cui probabilmente prioritario fu il progresso della
secolarizzazione che pareva rendere marginali le fedi religiose, e la diffusa
percezione che ‘a più modernità corrisponde meno religione’. In tale slogan si
esprimeva non solo un accertamento ma spesso un auspicio: la religione pareva
destinata in Europa alla scomparsa o ad una crescente marginalità, e questo sembrava
a non pochi un moto da favorire. Nel contempo iniziò nella filosofia politica (italiana)
una messe di attenzioni e studi che largamente ruotavano attorno ad altri temi, tra cui
in specie le teorie contrattualiste della giustizia. L’orientamento ebbe come effetto di
favorire minori attenzioni a campi tradizionali del pensiero e della responsabilità
politica, e di ridurre l’ambito problematico del pensiero politico, sottoponendo la
disciplina ad una cura dimagrante. Ciò ha coinvolto il problema teologico-politico
4
che, sia detto qui brevemente, non è quella parte della Politica dedicata alla religione
e al sacro, ma una prospettiva di base o un tema generativo del politico.
Nell’emarginazione del tema teologico-politico può aver pesato più o meno
fortemente l’idea di origine roussoiana e giacobina secondo cui l’arena pubblica è
quella dell’universale, dove occorre che ogni particolarità sia messa da parte e
purificata affinché si dia luogo alla volontà generale.
Il problema si ripresenta oggi in vesti nuove, in quanto non sembra più vero che a più
modernità corrisponda meno religione. Forse Weber non avrebbe fatto proprio questo
giudizio, nonostante le sue lucide teorizzazioni sul ‘disincantamento’ (Entzauberung)
e la ‘sdivinizzazione’ (Entgöttlichung). Semmai in lui incontriamo l’idea di uno
spazio pubblico ‘neutrale’ in cui il compito di connettivo è assegnato ad un diritto
formalizzato. Una notevole quota di tale posizione è passata in molti successori anche
non weberiani, spesso tinti di un approccio fondato sull’individuo e su una
concezione individualistica dell’esperienza religiosa. La sua privatizzazione e
neutralizzazione fu legata all’idea liberale, spesso alleata con una versione protestante
del cristianesimo. La capacità di forma politica e di rappresentazione pubblica della
Chiesa cattolica oppose al processo una resistenza maggiore di quella operata nei
Paesi protestanti.
Con la ripresa del nesso tra religione e politica sta venendo meno ‘l’epoca delle
neutralizzazioni e spoliticizzazioni’ (C. Schmitt), e forse si procede verso una
ripoliticizzazione della sfera pubblica da parte delle religioni, che certo può
provocare nuove tensioni, ma che d’altra parte può comportare una rinascita di nuove
attenzioni ai temi del bene, della verità, dell’uomo quali elementi fondamentali del
‘politico’. Ora, il ritorno della ‘teologia politica’ deve fare i conti con due fattori: 1)
lo schema separante del secolarismo che intende mantenere e rafforzare la ‘Grande
Divisione’ tra religione e politica, considerata come la base irrinunciabile delle
democrazie liberali, ma smentita dall’esperienza americana, come è rilevato da molti;
2) l’avanzata della Tecnica che spoliticizza e deteologizza. Cercherò più avanti di
mostrare che il rischio principale sembra provenire proprio dalla Tecnica quale mezzo
poderoso per un’infinità di scopi, che oggi porta in sé il tarlo del nichilismo.
Mentre il pensiero politico più consapevole sta iniziando a fare i conti con la nuova
presenza pubblica delle religioni, ad un livello di minore riflessività prevalgono
atteggiamenti di sospetto che individuano in tale nuova presenza quasi solo rischi
(pur reali) di fanatismo e intolleranza. Ciò comporta una concentrazione abnorme sul
punto e su vicende interne alla ‘fortezza Europa’, e la conseguenza che non ci si
preoccupa quasi più dei tanti diseredati ‘esterni’ che muoiono di fame, di stermini,
travolti dai poteri egemoni. La rivendicazione di autonomia e di laicità è giocata con
tale forza all’interno del nostro spazio, in cui si pensa sia in corso una partita decisiva
da vincere ad ogni costo, che il resto del mondo, anche se affamato e oppresso, può
attendere. Ma ci sarà poi tempo e sensibilità etica per questa faccenda?
II) Riforma del paradigma liberale
5
1. Procedere a riformare la teoria liberaldemocratica in modo da superarne i limiti,
dandole un senso che vada oltre la sua indubbia efficacia di strumento di benessere
materiale, è compito necessario in rapporto alla situazione presente in Occidente. Col
termine riforma non alludo ad un semplice ritocco, e neppure ad una trasformazione
totale od un nuovo inizio fondato su criteri totalmente altri. Intendo l’andare verso il
fondamento delle posizioni moderne, ricercandone le virtualità reali, e le ragioni che
giustifichino al meglio il progetto moderno sotto lo sparpagliamento delle prospettive
e ne portino avanti le promesse sinora negate. Significa cogliere l’occasione storica
che il ritorno della religione in Occidente pone per la comprensione secolare della
politica e della modernità. La domanda centrale ora suona: in quale misura tale sfida
può generare una loro (auto)comprensione migliore? I nuclei sono noti: dialogare e
includere l’altro, riconoscendolo ed edificando comunità; operare per la pace
planetaria (non è un caso che questo supremo obiettivo ha alla base autori cristiani,
quasi un ecumenismo della pace politica); riconoscere il valore della vita umana e
della giustizia politica; elaborare una concezione più integra dei diritti umani, che non
sono solo quelli di libertà; tracciare un confine tra naturalismo deterministico e
libertà, per cui l’uomo non è un semplice pezzo della physis, oggettivabile in
laboratorio. Dinanzi al rischio di naturalizzare l’uomo e la mente, dobbiamo separarci
dalle tendenze scientistiche dell’illuminismo senza rifiutarne le premesse
umanistiche. Al punto in cui siamo, sospesi dinanzi a seri problemi, la legittimità e
l’autolegittimazione dell’epoca moderna sono a rischio. Una modernità in difficoltà
su punti essenziali potrà legittimarsi nuovamente, riannodando un’alleanza con il
lievito di rinnovamento storico e sociale che proviene dal Vangelo.
La riforma suggerita dovrebbe generare una comprensione migliore delle
intenzionalità politiche della modernità e un loro ampliamento, non un loro
stravolgimento. Alludere ad una riforma dello schema liberale del nesso tra religione
e politica è un omaggio ad esso. Non sarebbe infatti possibile riformare altri moduli
che pur hanno avuto una grande storia ma che appaiono ormai spenti e carichi di
errori. Si può in merito pensare a paradigmi in cui i soggetti non puntarono alla
ricerca di ampi spazi di libertà individuale, ma si compresero come partecipanti ad un
processo di autoaffermazione collettiva verso un destino comune pilotato
dall’ideologia. Si trattò di schemi chiusi spesso a radice atea e insuscettibili di
riforma.
Aggiungo che il discorso di base qui svolto prescinde dal contesto italiano, compreso
l’annoso problema dei rapporti Stato-Chiesa, spesso declinato secondo uno schema di
limiti e poteri reciproci che finisce per depotenziare il compito e l’ampiezza del tema
teologico-politico.
2. La posizione qui proposta è che il nesso tra religione e politica nella società
postsecolare debba essere di tipo postliberale (6). I due termini abbisognano di un
chiarimento preliminare. Per società postsecolare intendo la chiusura dell’epoca della
neutralizzazione pubblica della religione. Non intendo dunque per postsecolare la fine
della laicità o della secolarizzazione delle istituzioni politiche, e neppure la mera
constatazione che la religione torna nel pubblico, ma la costruzione di una nuova
6
legittimità per quest’ultimo esito. Importanti autori del liberalismo tardo
novecentesco come Rawls ed Habermas hanno avviato un ripensamento in qualche
modo postliberale (ma certo non antiliberale) del nesso religione-politica. Simpatizzo
per il secondo per quanto riguarda l’individuazione della crisi spirituale in corso
(rischi di autodisfattismo della ragione, domande incalzanti sul futuro della natura
umana, difficoltà nella giunzione tra etica pubblica e diritto positivo) (7), forse meno
per quanto concerne le vie d’uscita, eccessivamente fiduciose di trovare un’etica
pubblica procedurale e un diritto positivo di pari taglia che consentano la soluzione
del problema, sulla scorta di una pregiudiziale postmetafisica.
Per motivi varie volte elaborati non ritengo necessario – ai fini del discorso su
religione e politica – far professione di atteggiamento postmetafisico che cerca di
tenersi in mezzo tra scientismo e naturalismo da un lato e ripresa della trascendenza
dall’altro. Su questi aspetti vedi l’Annesso.
3. Sulla riforma del paradigma liberale svolgerò una prima elaborazione su tre
nuclei: A) la questione della libertà; B) quella della laicità; C) la domanda se la
ripresa del tema teologico-politico debba considerare anche il problema di Dio e non
solo la religione.
A) Libertà e scopo politico. Nella prospettiva qui perseguita il termine ‘postliberale’
è sostanziato da tre nuclei: i diritti di libertà non hanno sempre e dovunque il
predominio; il bilanciamento tra diritti e doveri deve essere più rigoroso che
nell’individualismo liberale; infine più radicalmente la libertà non può essere lo
scopo politico unico o supremo. Oltre ad essere vero che la libertà non è tale fine
ultimo, storicamente emerge che il progetto incompiuto della modernità è la giustizia
più della libertà. Per proseguire in senso integro la ‘storia della libertà’ non possiamo
più guardare quasi solo ad essa. Sosterrò invece che la politica postmoderna dovrebbe
risultare centrata sul ‘principio-persona’ invece che sul ‘principio libertà’ e che il
primo è più fondamentale e primario del secondo.
Nel suggerire questo cammino non intendo certo né dissolvere l’alleanza tra religione
e spirito di libertà che portava Tocqueville a sostenere il principio secondo cui “la
libertà vede nella religione la compagna delle sue lotte e dei suoi trionfi; la culla della
sua infanzia, la fonte divina dei suoi diritti”(8), né trascurare l’importanza della
libertà religiosa, così precaria in non poche parti del mondo (9). L’intento è di
valutare l’appropriatezza del far centro sulla libertà come massimo problema politico.
Neppure vorrei limitarmi a suggerire, il che d’altronde sembra inconfutabile, che
l’identificare nella libertà lo scopo politico più alto produce nella sfera pubblica
liberale crescenti difficoltà a generare serietà morale, solidarietà, senso del bene
comune, che non sorgono dal negoziare semplicemente libertà e interessi reciproci.
Una società libera e giusta non può permettersi l’ideologia di una sfera pubblica
neutrale senza arrecare immensi danni alla sua energia morale. Tale sfera non può
fiorire se si fonda solo sul contratto e la ricerca esclusiva dell’interesse individuale,
ma se esistono lealtà, valori, interesse per il bene comune che ricarichino il dialogo e
l’azione. Tutto ciò è vero, e il suo azionamento richiede un rafforzamento delle
7
sorgenti morali e umanistiche, capaci di offrire nuove lealtà e nuove intuizioni per
motivare nella ricerca della ‘buona società’, nonché di offrire un’immagine del bonus
civis. In tal modo i cittadini, evitando di esigere sempre e comunque diritti, sono
inclinati a riflettere su se stessi, sull’apporto da offrire e la comunicazione da
instaurare. L’insufficienza di una cultura politica libertaria nel nutrire responsabilità
etica e attenzione all’altro sembra difficilmente smentibile, ma non è il fulcro
fondamentale dell’argomento qui proposto.
Il quale consiste nell’asserto secondo cui nella vita sociale e politica autonomia e
libertà sono certo valori alti ma non tali da costituirne il fine. In certo modo,
l’iniziatore filosofico della svolta che ravvisa nella libertà lo scopo della politica fu
Spinoza, che scrisse: “finis rei publicae libertas est”. Prima di lui, Tommaso
d’Aquino determinò con maggiore verità lo scopo della res publica, individuandolo
nel bene comune, che naturalmente non si può ricondurre solo alla libertà (10).
Questa rimane imprescindibile quale condizione di possibilità per pervenire al bene
comune in una maniera che non sia prefissata dall’alto e che includa il
riconoscimento dell’altro; non può però sensatamente essere posta come lo scopo
della politica neppure dalla scuola liberale, semmai da quella anarchica. Forse la
formula di Spinoza potrebbe trovare spiegazione nelle condizioni dell’epoca in cui
venne vergata, tuttavia rimane incompiuta e parziale. O la considerazione del bene
comune entra in gioco sin dall’inizio, oppure è assai probabile che venga dimenticata
o positivamente emarginata. Allora la prospettiva della ‘società buona’ rimarrà
astratta e sostituita dalle note teorie della giustizia e della thin theory of good, o dalle
teorie sulla comunità della comunicazione, che procedono in maniera formale e
procedurale in base ad una preliminare sottovalutazione del bene politico.
La domanda generatrice da cui prendere le mosse per una risposta in pari col
problema concerne l’individuazione del bisogno umano primario. La modernità ha
risposto che il bisogno primario è quello di libertà (libertà di scelta, di coscienza, di
religione, libertà dalla paura, dal bisogno, dall’oppressione, ecc.) e conseguentemente
si è costruita più su rivendicazioni di libertà che di giustizia e fraternità. La strada era
percorribile con merito eppure limitata, se è vero che bisogni antropologici altrettanto
fondamentali sono quelli di senso, di identità, di riconoscimento, di giustizia.
L’assunto secondo cui la libertà non è lo scopo politico supremo ossia, in termini più
piani, che la libertà non è abbastanza per una decente vita politica, vale per la libertà
negativa, per quella libertà positiva, e per una combinazione delle due, se vogliamo
riferirci alla nomenclatura concettuale sviluppata da I. Berlin nel 1958. In ogni caso
il problema della libertà politica è ben più complesso della possibilità/concessione di
perseguire i propri scopi e progetti con una minima interferenza altrui. Esso include
almeno la libertà di sollevare questioni e di ricercare insieme i beni sociali che sono
necessariamente comuni, senza ritenere che gli scopi e le utilità comuni siano solo la
somma di quelli individuali. Dal lato del nucleo essenziale dei diritti umani, vi sono
molti diritti fondamentali che non sono diritti di libertà: essere trattato come fine e
non soltanto come mezzo non è un diritto di libertà, ma è la quintessenza della
giustizia, da esercitare verso le donne, i deboli, gli svantaggiati, i vinti; il rispetto cui
8
ha diritto l’embrione umano non è un diritto di libertà; essere lasciate morire (in certi
paesi) perché femmine bambine che non generano reddito non è un’azione che viola
un diritto di libertà. E’ impossibile affrontare la sfida ecologica sulla base
dell’individualismo o su quella della libertà negativa; lo stesso vale per le questioni
della solidarietà con le generazioni future.
L’esemplificazione potrebbe continuare indefinitamente a mostrare lo strabismo che
si commette nel porre nella libertà e nei diritti di libertà lo scopo politico ultimo. Si
tratta di problemi che richiedono che lo scopo dello Stato non sia ridotto alla difesa
della massima libertà individuale di scelta, e che la critica della società civile non sia
condotta sulla base dell’interesse individuale. Anche da tali lati s’intende la
problematicità della soluzione kantiana di consentire una pari libertà per tutti alla sola
condizione di non recare danno all’altro: una clausola forse insufficiente e vaga,
poiché sta diventando sempre più controverso e arduo stabilire chi è l’altro (11).
Da tempo lo Stato liberale classico è stato trasceso nello Stato democratico e sociale
cui le Carte costituzionali indicano finalismi non riconducibili alla sola libertà.
Tuttavia le ali radicali e libertarie hanno rialzato la testa e, semplificando
indebitamente la complessità del problema, rilanciano l’assunto che la libertà del
singolo, in specie adulto, vada tutelata in maniera crescente, spesso attraverso un
richiamo ai criteri di non-discriminazione e di differenza, fatti intervenire secondo
opportunità contingenti. In tal modo si omette la giustizia e si conforma la dottrina
del diritto e dei diritti umani al solo scopo della libertà. Da questa posizione deriva
una visione libertaria e non “dignitaria” dei diritti umani che cerca di imporsi e che
per farlo compromette il significato unitario della Dichiarazione universale dei diritti
umani del 1948. Urgenti correzioni in merito sembrano necessarie. L’enfasi quasi
esclusiva sulla libertà finisce per togliere quella feconda tensione tra libertà e
giustizia, che potrà sboccare in esiti diversi, ma che rimane una garanzia contro la
degenerazione della libertà in arbitrio e della giustizia in imposizione.
B) Laicità. Riprende da tempo vigore la fondamentale polarità tra Dio e Cesare
introdotta dalla celebre pericope evangelica: “«rendete dunque a Cesare quel che è di
Cesare e a Dio quello che è di Dio», in cui nessuna delle rispettive comunità loro
riferibili, Stato e Chiesa, esauriscono la totalità, sebbene il passo non neghi la
signoria ultima di Dio. Essa appartiene a Dio non alla Chiesa. Nessuna idea di
teocrazia o di impero cristiano può essere giustificata dalla pericope gesuana, ma
anche nessun esilio pubblico di Dio.
Tra i vari significati di laicità: laicità come differenza tra religione e politica; come
sinonimo di imparzialità dello Stato; come indifferenza: Stato e legge civile devono
rimanere indifferenti nel senso preciso che non devono introdurre differenze; laicità
come criterio di procedere etsi Deus non daretur; laicità come canone metodologico
di rispetto della realtà e della razionalità, paiono fondamentali il primo e l’ultimo, sul
quale mi soffermo. La laicità, quale metodo razionale e aperto di dialogo che non
delimita a priori, esclude le escludenze. Esclude dunque i criteri che impongono
limiti argomentativi apriorici.
9
Secondo la versione secolaristico-liberale una società laica è quella in cui è possibile
scambiare lealmente argomenti su come debba essere la vita comune, sulla scorta di
basi condivise che esprimono la ’ragione pubblica’. Gli argomenti che promanano da
lealtà di natura religiosa e/o ideologica devono essere lasciati fuori: si suppone che
essi siano una minaccia per la libertà, e più basilarmente che, non essendo suscettibili
di critica, siano mero fideismo cui sarebbe pericoloso concedere di esercitare un
influsso sulla sfera pubblica. Ora, se il criterio di laicità impone di distinguere tra
religione e politica, tra Chiesa e Stato, tra ciò che è religiosamente proibito, ciò che è
moralmente illecito e il reato quale violazione della legge civile, tale criterio non
impone invece di rendere Dio un’ipotesi privata, né di escludere religione e comunità
ecclesiale dal pubblico (12).
In altre parole un comprensivo criterio di laicità non la riconduce a procedere
metodicamente etsi Deus non daretur (‘come se Dio non fosse’). Spesso la formula
dell’etsi incorpora quelle dell’etsi religio non daretur e dell’etsi ecclesia non daretur
e talvolta perfino quella dell’etsi natura humana non daretur (13). Coerentemente
applicata, la regola sfocia in una polarizzata neutralizzazione dello spazio pubblico
rispetto a domande radicali. Inoltre il criterio di uguaglianza civile non è rispettato là
dove ai credenti si impone l’onere aggiuntivo di argomentare etsi Deus non daretur, e
di accettare la concezione secolare dello spazio pubblico come valida di per sé e per
tutti. Qui è in gioco una posizione di principio che, pur consapevole delle difficoltà,
non può accettare come ovvio che argomenti teistici e di religione ecclesiale siano
aprioricamente esclusi dallo spazio argomentativo pubblico, sulla scorta dell’assunto
che Dio un’ipotesi che deve restare nella privatezza del singolo, e con la conseguenza
che se Dio è un’ipotesi, anche le religioni (mono)teistiche lo sono. L’etsi sembra
implicare che i cittadini credenti non possano avere ascolto dagli altri cittadini se non
prescindendo da Dio, mentre l’eguaglianza e il reciproco riconoscimento civici
richiedono la disponibilità all’ascolto e ad imparare gli uni dagli altri.
Il metodo etsi applicato sino in fondo comporta il rischio di difendersi rispetto
all’apporto umanistico più fecondo della rivelazione cristiana, cioè la salvaguardia di
un senso profondo e non utilitario dell’umano, il divino rispetto del debole e
dell’altro, la fecondità della protesta verso un mondo senza spirito, ossessionato dal
potere che prevarica e dalla forza che schiaccia senza remissione. L’adozione dell’etsi
presuppone inoltre che ci si possa appropriare universalmente in modo del tutto
immanente di molti (di tutti?) i contenuti umanistici e liberanti delle tradizioni
religiose, proiettandoli su un piano ‘laico’ e separato. Nulla assicura però il successo
dell’iniziativa, e non poche sono le possibilità che l’operazione raggiunga un punto
morto, e che l’autonomia morale della ragion pratica pericoli e si sparpagli nei mille
rivoli delle molteplici autolegislsazioni degli individui empirici. L’esito sarebbe un
disfattismo morale e normativo che conduce fuori strada. E’ infatti arduo rispondere
alla domanda: dove troverà la coscienza morale autonoma di uomini abitati da
fratture e passioni la spinta a sovvertire i rapporti sociali e morali abitati
dall’ingiustizia e dall’odio? L’impegno a non mettere tra parentesi Dio e la religione
su piano argomentativo si collega a quello di non trascurarli su piano motivazionale,
valutando i nuclei di agape, senso della prossimità, colpa, redenzione, salvezza,
1
0
amicizia, pietas che vivono nella tradizione delle comunità religiose provenienti dalla
Bibbia.
La ripresa della presenza pubblica delle religioni ha posto in crisi il presupposto del
dibattito pubblico neutrale il quale presuppone che la privatizzazione della religione
sia un fatto alle nostre spalle; o comunque la nuova situazione richiede una nuova e
più attenta considerazione della ragione pubblica e di suoi compiti e limiti. Se
prevalesse l’idea dell’etsi Deus non daretur come necessaria e indispensabile
garanzia di laicità, con la conseguenza di espungere tutte le ragioni non neutrali e
religiose dal dibattito pubblico, l’assunto si rivelerebbe privo di riguardo verso i
cittadini con persuasioni religiose, i quali verrebbero a trovarsi in permanente
inferiorità e svantaggio tanto nell’accesso quanto nella partecipazione al dibattito
pubblico. In tal modo si verificherebbe un serio sbilanciamento a favore del ‘partito
laico’, mentre i cittadini religiosi dovrebbero svestirsi della loro individualità e
cultura per diventare cittadini astratti e agenti amorfi della volontà generale.
Diversi autori contemporanei di indirizzo liberale ritengono ormai che la forma
pubblica degli argomenti non sia un requisito pregiudiziale di accesso alla
discussione pubblica ma semmai una sua caratteristica, se i partecipanti al dibattito
desiderano persuadere gli altri delle loro ragioni. In tal senso non si chiede
preliminarmente ai cittadini religiosi di svestirsi delle loro identità per entrare nello
spazio pubblico: semmai saranno le istituzioni ad essere imparziali o ‘cieche’ nelle
loro scelte, non i cittadini.
Rimane tuttavia un problema notevole in ordine alla ragione pubblica: le
argomentazioni di ordine ontologico e antropologico possono far parte della ragione
pubblica? Costituiscono un settore legittimo di tale ragione o vanno escluse a priori?
Se il dibattito pubblico deve fare appello a premesse comuni, affinché sia possibile
persuadere l’altro, tali premesse comuni includeranno il rispetto della persona e
l’intendimento di chi e che cosa è la persona? L’argomento perennemente proposto da
molti teorici liberali è che la ragion pratica è dialettica, ossia che esiste
un’irriducibile pluralità di concezioni anche conflittuali del bene, e che dunque queste
devono rimanere private mentre nella sfera pubblica ci si dovrà regolare secondo il
giusto. Se non intendo male, nulla viene detto sulla ragione speculativa molto
probabilmente perché si ritiene il suo problema già pienamente risolto col suo
irrevocabile congedo (forse si pensa che essendo già la sola ragion pratica dialettica,
figuriamoci quella speculativa). Ma lasciamo pure in sospeso il compito che potrebbe
o dovrebbe spettare alle argomentazioni ontologiche o metafisiche, sperando che la
loro semplice evocazione non crei reazioni emotive. Volgiamoci ad un problema
tipico della ragione pubblica e che si ripresenta puntualmente ad ogni angolo, ossia
sul fatto che non esiste un sostanziale disaccordo su alcuni criteri morali e di giustizia
politica fondanti, quale ad esempio l’uguale rispetto per ciascuno. Questo criterio
centrale della ragione pubblica non genera controversie sulla sua formulazione e
verità ma divergenze in ordine al suo ambito antropologico di applicazione: sin dove
si estende quel qualcuno che dobbiamo rispettare? O anche: chi è l’altro che non
dobbiamo danneggiare ma rispettare? Orbene, questo differend non può essere risolto
eticamente ma antropologicamente e ontologicamente se appunto vi sono motivi per
1
1
rispettare ‘altri’ che finora non sono stati rispettati perché non considerati altri reali.
Sembra dunque che non solo la ragion pratica è dialettica, ma che lo sia forse di più
quella antropologica.
Quale diramazione del problema della libertà e della laicità si pone la questione
della tolleranza e della libertà religiosa. Taluni ritengono che il nucleo fondamentale
della laicità come secolarismo stia nell’uguale diritto di tutti alla libertà religiosa e il
diritto a non essere discriminati in base alle convinzioni religiose. Vi è una parte di
verità in questa assimilazione che però come tutte le semplificazioni si palesa di
limitata utilità. La questione della libertà religiosa e dell’uguaglianza di rispetto e di
opportunità per coloro che seguono differenti fedi religiose o nessuna rimane un
elemento non aggirabile, ma da integrare in un quadro in cui la laicità o il
secolarismo non si riducano solo a questo elemento. In altri termini, salva rimanendo
l’importanza della libertà religiosa, l’orizzonte di partenza dovrebbe essere più
ampio, e quando esso incontra tale tema dovrebbe intenderlo in modo da includere il
diritto di esprimersi anche religiosamente nella sfera pubblica.
L’intento di porre tra parentesi l’argomento teistico e la religione risponde talvolta
all’assillo costituito dal serio problema della tolleranza religiosa. Frequentissimo, un
vero topos di tanta pubblicistica, è il richiamo alle guerre di religione del ‘500 e ‘600
e alla conseguente neutralizzazione della religione, ritenuta la sorgente fondamentale
del conflitto. I media in Europa difendono con accanimento la concezione liberale
della politica e lo spazio pubblico neutrale, sostenendo che questo sia l’unico schema
capace di garantire tolleranza e libertà. Secondo Seligman “Se la politica liberale e
l'ordine sociale secolarizzato sono l'unica premessa possibile della tolleranza, allora
andiamo incontro a tempi difficili, perché il processo di secolarizzazione sembra
regredire e le concezioni liberali dell'individuo e della società vengono attaccate in
molte parti del mondo” (14). Non cade dubbio sul fatto che le guerre di religione
furono un male crudele, e che il loro ricordo sia tuttora vivo, e ciò conduce a ritenere
la privatizzazione della religione una ricetta sempre valida. Eppure non vi è prova che
una maggiore presenza della religione nel pubblico conduca di per sé allo scontro.
Una politica centrata su ideologie chiuse e antropocentriche non possiede migliori
chances di sfuggire alla passionalità e all’intolleranza di una politica pilotata da un
torvo zelo religioso.
La difesa dello schema moderno e il necessario elogio della tolleranza non hanno
bisogno di vestire i panni di un ateismo almeno metodologico. Può anzi succedere
che questo atteggiamento allontani la considerazione di eventi a noi più vicini e forse
più terribili delle guerre di religione. Il loro processo culminò con la pace di
Westphalia (1648) e con la supremazia dello Stato e della politica sulla religione, con
la conseguente sua neutralizzazione pubblica. Una domanda è qui opportuna: quello
che fu un grave problema di allora è ora, 350 anni dopo, un grave problema di oggi?
Sembra che per molti sia così, se si considera la frequenza con cui si richiama la
vicenda delle guerre di religione. Tuttavia non consta che nel XX secolo vi siano state
guerre di religione. Non è piuttosto stato il ‘900 il secolo dei totalitarismi atei? Non è
stata questa la sorgente delle maggiori catastrofi del secolo scorso, forse il più brutale
1
2
e sanguinoso dell’intera storia universale? Non è forse stato presente nei totalitarismi,
in specie il nazista, un sottofondo mitico che si sottrae alla ragione e lascia spazio al
demoniaco?
Supposto che tale diagnosi abbia fondamento, e senza sottovalutare i presenti rischi
fondamentalistici d’intolleranza religiosa, si percepisce che il riferimento al ‘500 e
‘600 per pensare il nesso religione-politica rimanga insoddisfacente, perché trascura
in maniera irresponsabile la tragica lezione del XX secolo, in cui la reciproca
carneficina e la violazione dell’uomo è proceduta da ideologia atee, non da lotte
religiose (e senza dimenticare la scala ben più ampia dei massacri del Novecento).
Con ciò non intendo sostenere che il religioso sia l’unica istanza che ci difende dal
totalitarismo, dal momento che anche la religione più pura può essere guastata dalle
impure mani dell’uomo, e Dio impiegato come un martello. Tuttavia, là dove ragione
e fede si tengono d’occhio l’un l’altra e così Stato e Chiesa nel mutuo rispetto,
concreta è la chance che la polarità tra i due ‘poteri’ apra spazi di dialettica come di
dialogo e di possibile intesa, tolti invece brutalmente dai totalitarismi con la loro
violenta reductio ad unum.
Anche da un altro punto di vista la situazione contemporanea è diversissima da quella
del ‘600. Allora si trattava di lasciare in una sfera privata quei temi religiosi che
facilmente potevano essere esca di nuovi conflitti; oggi si tratta di proteggere l’uomo
dai molti attentati che gli vengono rivolti, di muovere verso una giustizia economica
e politica mondiale meno tragicamente ingiusta, di non incasellare il nesso StatoChiesa come un tema di potere in un gioco in cui se uno vince l’altro perde, ma di
impiegare le potenzialità liberanti e umanizzanti della coscienza religiosa a beneficio
della persona. Questa è la nuova frontiera della giustizia politica, e non vi è alcun
motivo di principio perché tale scopo possa essere in opposizione con quello della
tolleranza e della libertà religiosa.
Una seconda diramazione concerne il nesso tra tecnica e persona. Se non ci
sottraiamo al compito di esaminare in concreto che cosa implichi il metodo dell’etsi
Deus non daretur, ci accorgiamo che comporta una frequente fiducia nella scienza,
anche quando si ritiene che il suo sapere sia provvisorio e fallibile: rinviato in cielo
Dio, per il quale non vi è posto entro il quadro del pensiero calcolante e strumentale,
si trova in terra come sostituto ispirante la tecnica. Questa introduce una sfida intensa
per la politica, dal momento che il pensiero tecnico è senza ‘trascendenza’. L’epoca
della secolarizzazione ha secolarizzato o storicizzato il potere col suo volto un tempo
nascosto e numinoso, ma non è in grado di fare altrettanto con la tecnica, che
piuttosto viene ri-sacralizzata e assolutizzata. In merito la situazione attuale
differisce da quella del ‘700 per l’incommensurabile diversità e profondità
dell’intervento tecnico nelle due epoche. Orbene, il pensiero secolarizzato possiede
un’intrinseca fragilità e quasi un’incapacità nel confronto col problema della tecnica,
che solleva problemi antropologici e morali la cui elaborazione richiede qualcosa di
più del ‘pensiero debole’.
L’affidarsi al pensiero tecnico tende a sopprimere la responsabilità politica che, in
quanto sia intesa nel suo reale e non episodico valore, è chiaramente sovraordinata
1
3
alla responsabilità della scienza e dello scienziato. In caso contrario la responsabilità
politica non farebbe altro che porsi come megafono delle scelte della scienza,
divenute il ‘da pensare’ e il ‘da accettare’. Quando la scienza si pone come unico
pensiero della realtà divine un’ideologia pericolosa anche politicamente, poiché
intende valere come una legalità che è immediatamente legittima. E’ vera perché è
scienza: ecco l’ultima ideologia che non si legittima in rapporto ad altro, ma si
legittima da sé in quanto è scienza.
Oggi l’universo della Tecnica incontra in profondità quello della Persona, e il contatto
non è semplice, poiché la fondazione e l’implementazione del Principio-persona
spetta ad una ragione integra che non rifiuti ontologia e antropologia. Tale principio,
che trova il suo baricentro nell’area del cristianesimo da cui è stato generato, è
chiamato forse ad esercitare in Occidente ed oltre quel compito unificante ed
accomunante che fu svolto dalla religione. Il principio-persona fu una scoperta per il
mondo: stabilisce una direzione della storia universale ancor più che il principio
libertà che gli appartiene ma che non lo esaurisce. Una scoperta ancora largamente
ignota, se molti contesti geoculturali non l’hanno sinora conosciuto (pensiamo
all’Asia e forse in specie all’India dove il sistema delle caste ne è negazione totale).
Le difficoltà sono aumentate con l’avvento delle biotecnologie e la necessità di una
biopolitica (un ambito ben più ampio rispetto a quello convenzionalmente
denominato ‘bioetica’) alla loro altezza. Più che la nozione moderna di ‘persona
giuridica’ con la sua capacità di responsabilità e di obbligazione reciproca, è qui in
ballo la nozione stessa di persona, il cui resoconto ‘secolarizzato’ è in deficit non solo
sotto il profilo dell’irrilevanza del bios (o specularmente della sua totale rilevanza
materialistica: la linea della vita passa però altrove), ma pure attraverso una riduzione
morale ed una portata esclusivamente morale del concetto di persona, che invece è
primariamente una qualità ontologica, una posizione d’essere prima di valere come
qualificazione dell’agire (15). Il personalismo opera per mantenere desta l’idea di
persona e aperto l’ambito di chi occorre considerare tale. In rapporto all’attualità ci si
può riferire al caso serio dell’embrione umano cui la cultura del personalismo
riconosce lo statuto personale, vedendovi un nuovo ambito di realtà da tutelare e
considerandolo un alter a pieno titolo.
C) L’ultima questione concerne la domanda particolarmente delicata se in ordine al
compito pubblico della religione occorra considerare non solo la religione ma anche
il problema di Dio. Orbene, per riprendere alla base l’originaria domanda teologicopolitica è naturalmente un passo indispensabile chiamare in causa religione e politica,
eppure è un passo incompleto se in qualche modo non è convocato anche il problema
di Dio che sta in immediata connessione con quello della religione. Non è qui in
gioco una dichiarazione di teismo o di ateismo ma una accurata valutazione del
legame tra Dio e religione, e del significato di quest’ultima. Secondo il significato
fondamentale deposto nel termine e tradizionalmente elaborato, la religione è il luogo
del rapporto dell’uomo con Dio, non un qualsiasi simbolo di interessi o scopi ultimi.
Religione è re-ligio, qualcosa che lega essenzialmente infinito e finito, trascendenza e
uomo, l’indicazione di un nesso per cui l’uomo appare come un essere volto all’insù.
1
4
In questi caratteri si radicano le potenzialità liberanti della religione: la sua capacità
di riconciliazione; quella di opporsi alla reificazione; l’importanza attribuita alla
razionalità rispetto al valore nei confronti di quella puramente strategica volta al
potere; l’elemento dialogico e del cuore; la capacità di produrre nuova prassi.
Se Dio e religione, pur intimamente legati, non sono la stessa cosa, converrebbe
riprendere a trattare nelle questioni teologo-politiche non solo della religione ma
anche di Dio e delle concezioni che le religioni ne offrono: per questo scopo le
indagini sociologiche prestano servizio in maniera limitata in quanto non possono
andar oltre l’empirico e lo statistico. Sarebbe fuori luogo elaborare in questa sede un
tema tanto immenso, che dovrebbe condurre a compiere una sintesi tra i due ambiti
tradizionalmente chiamati ‘teologia politica o civile’ e ‘teologia naturale’, e che di
fatto spesso rimanevano ambiti distinti, essendo la prima propria dei politici e la
seconda dei filosofi. Il tema era difficile un tempo e lo ancor più oggi. Si potrebbe
definirlo un problema quasi disperato, dal momento che la ragione ad una
dimensione, educata secondo le sole prospettive della scienza, ha congedato come
favola ogni teologia naturale sia degli antichi come dei moderni, generando un
universo chiuso del discorso. Con la crisi della teologia naturale o filosofica siamo
abituati a indirizzare lo sguardo su ciò che consta empiricamente, cioè sulla ripresa
delle religioni e forse delle chiese. Da ciò l’ovvia constatazione che nel tema
teologico-politico di oggi Dio sia posto ai lati e s’innalzi al suo posto la religione e le
relative trattazioni sociologiche di essa. La considerazione è ovvia eppure inadeguata
in ambito islamico, ma pure per vari versi in Occidente.
In effetti basterà limitarsi ad accennare che il nesso religione-politica-spazio
pubblico non compie significativi passi avanti se le religioni sono intese solo come
sorgenti etiche motivanti, o derubricate a luogo in cui si svolge il rito e si fa avanti il
sacro di qualche tipo, lasciando indeciso o negando che esse possano essere lo spazio
fondamentale in cui accade un qualche legame tra uomo e Dio (16). Neppure
possiamo attenderci significativi lumi dall’assunto lucreziano ed humeano secondo
cui la religione nasce dal terrore e proietta superstizione e paura sull’uomo e la sfera
civile (cfr. De rerum natura, e Dialoghi sulla religione naturale).
Una comprensione solo sociologica della religione che proceda su base empirica,
metta tra parentesi la trascendenza e riduca la religione a esperienza fruitivaemozionale accertata da una fenomenologia dell’esperienza religiosa, parte col piede
sbagliato e si porta dietro come una zavorra la partenza. Sacro e rito/liturgia
rappresentano indubbiamente elementi fondamentali e perenni del momento
religioso, eppure non sono determinanti in ultima istanza. Appena si affronti un
lavoro di scavo e non ci si accontenti di luoghi comuni, la sola leva sociologica
appare inidonea a cogliere la specificità del fenomeno religioso, la forza del
teologale, lo spazio della preghiera, l’istanza veritativa.
La soluzione prevalente dà per scontato che la questione della verità sia esterna alle
religioni, che il termine religio vera non significhi nulla, e che la verità del messaggio
sia scarsamente rilevante rispetto all’esperienza del sacro e al rito. La
neutralizzazione pubblica del tema della verità appartiene anche alla soluzione
liberale, forse è il suo colpo di coda ritenere la prassi del rito e lo spazio del sacro
1
5
superiori al tema del vero. Lo spostamento della religione, e in specie del
cristianesimo, dall’ortodossia del vero all’ortoprassi del rito o alla difficilmente
definibile area del sacro rappresenta una sottile estenuazione delle religioni. Risolvere
in senso scettico il tema del nesso tra verità e religione significa che le religioni
vengono a far parte di un ambito ‘dialettico’, cui appartengono anche le concezioni
del bene, in cui l’assunto-guida è che la ragione umana non è in grado di districarsi
per pervenire ad un esito stabile, optando motivatamente per una prospettiva.
In breve, quanto vorrei trasmettere è che il tema teologico-politico rimarrà
impostato in maniera precaria se elude in linea di principio la domanda sulla verità
della religione, una questione cui la modernità filosofica ha dato spesso o una risposta
negativa (Spinoza), o subordinante nel senso che la religione è in seconda posizione
rispetto alla filosofia (Hegel, Gentile).
Prime conclusioni
Una nuova partenza postliberale e postsecolare sul nesso religione-politica accadrà
se saremo in grado di evitare la posizione secondo cui le tradizioni religiose sono
superflue per la buona vita. In realtà le tradizioni religiose – ci riferiamo
specificamente al cristianesimo – offrono alla convivenza civile e politica apporti
fecondi: 1) intuizioni etiche capaci di liberare l’uomo e di renderlo attento all’alterità,
con l’implicita possibilità di tradurre in un linguaggio pubblico paradigmi di vita
buona, di giustizia, di uomo che il soggetto centrato su se stesso non è in grado di
raggiungere; 2) forza motivante all’agire retto ed energia riformatrice; 3) capacità di
mantenere aperto l’orizzonte trascendente e fare dell’uomo un essere che non
appartiene interamente alla polis.
La riforma del paradigma liberale dovrebbe procedere su tutti i piani.
Conformemente all’oggetto, qui si è sviluppato un discorso sul nesso religionepolitica, non per altri ambiti tra cui l’economico dove una globalizzazione del
mercato capitalistico uscita di senno sta provocando enormi danni: non debella né
fame né povertà, ed acuisce le differenze a vantaggio dei ricchi e dei potenti. E
neppure per il quadro del contrattualismo, così presente nella filosofia pubblica
dell’ultimo mezzo secolo, e così giocato su qualche versione dell’autonomia
kantiana, certo importante inizialmente ma poi precaria nel momento in cui viene a
significare totale autolegislazione.
III) Teologia politica
1. Il carattere pubblico della religione è divenuto problematico nella società
moderna, in cui né la religione né la tradizione sono più considerate necessarie per
rendere possibile la società e la socialità: a questo fine è sufficiente, si sostiene, che
gli uomini commercino e consumino. Di conseguenza molti elementi dell’esistenza
sono ricondotti all’ambito privato, mentre la fondamentale destinazione sociale
dell’uomo è divenuta la realtà del lavoro. Entro tale schema “la Chiesa cristiana è
diventata proprio quello che non era mai stata, quello che secondo il Nuovo
1
6
Testamento non avrebbe mai potuto essere: cultus privatus” (17). Lo spostamento
della religio e del cristianesimo verso il culto privato nell’epoca liberale comportò
una coscienza della Chiesa e della teologia come meri custodi dell’interiorità; e una
coscienza della comunità ecclesiale come una comunità che vive a lato della società e
che per fare questo crea istituzioni proprie che ricalcano quelle civili ma che ne
rimangono separate.
E’ un evento quasi paradossale che la soluzione del distanziamento tra religione e
politica si sia sviluppata in Occidente, là dove più intenso è stato l’influsso della
rivelazione biblica e dimensioni grandiose ha assunto il tema teologico-politico tanto
nella riflessione quanto negli eventi storici. Una posizione postsecolare non può non
riprenderlo in considerazione, confrontandosi con lo spirito del cristianesimo e i
fondamenti originari del suo messaggio, che ultimamente poggia su due nuclei o
‘misteri’: l’Incarnazione del Verbo, ossia il Verbum caro, e la Trinità. Ad essi si
collegano la mediazione-presentificazione sacramentale del divino nel mondano, la
comunità ecclesiale di coloro che accolgono e testimoniano il messaggio di salvezza
e i magnalia Dei, l’amore del prossimo e la sua eredità immediata di universalismo
egualitario sostanziato di libertà e convivenza solidale.
Il Vangelo quale magna Charta del Regno appare sul piano della città degli uomini
come desiderio e progetto di una città liberata, della città armoniosa (Péguy),
portatore di un’eredità che va riscoperta e attuata in forme nuove, ma che non ha
alternative. Il fermento evangelico che opera nel sottosuolo della storia del mondo,
non edifica il Regno di Dio in terra, né l’ordinamento politico viene esemplato sul
criterio del Regno. Ma il lievito dell’agape può nutrire la pericolante esistenza
dell’uomo, ed inserire nella politica e nel diritto una più acuta sensibilità in ordine
alla giustizia, alla libertà, al bene, al rispetto dell’altro come sorgenti ineliminabili di
un ordine politico umanistico. Questa è in senso esistenziale e non teorico, - cioè
nell’azione e non soltanto nel discorso, a livello di quelle esperienze profonde in cui
un compito si fa avanti e chiama -, la riserva di senso e di critica che si diparte dalle
altezze del Verbum caro e che come per sovrabbondanza penetra nella storia,
impedendole di implodere o di pendere solo dal lato del negativo e dell’ingiustizia. In
questo senso la ‘teologia politica’ del Verbum caro, che potremmo anche chiamare
‘cristologia politica’, non sacralizza la politica e il potere, e neppure si limita a
restituire – come è giusto – la politica al mondo ed agli ordinamenti secolari, ma la
sprona e la fa avanzare verso il rispetto dell’altro e la giustizia (18). La motivazione
fondamentale dell’agire credente è umanistica: cercare il bene della vita comune,
intervenire solo secondariamente per minimizzare le occasioni del male e il
contenimento della volontà cattiva.
A partire da queste considerazioni si intende che il problema non sta nel concedere
maggiore o minore spazio al processo di secolarizzazione, ma nel mantenere pura la
fede nella sua irriducibilità ad ogni pur fondamentale dimensione intramondana. Né
l’attenzione al pane per gli uomini è qualcosa di dissonante rispetto al mandato della
fede. Tenendosi entro questi limiti, mantenendo aperta e operante la riserva
1
7
escatologica e la dialettica tra grazia e libertà, il cristiano non sopravvaluta il
saeculum, ma è dovunque e dovunque resta libero.
Il cristianesimo non si autocomprende principalmente come una delle religioni
esistenti nella storia, e neanche come una tra le diverse forme di esperienza religiosa
di cui tratta W. James in Le varie forme dell’esperienza religiosa (dove distingue faith
da belief), e neppure come una delle tre grandi religioni del Libro, ma come la
religione del Verbo incarnato. Come religione dell’Evento salvifico l’identità cristiana
è radicalmente storica e parimenti soprastorica, ma in ogni caso sociale, comunitaria
e politica. Attua una specifica politeia, quel tipo di cittadinanza che è definita da san
Paolo nella lettera ai Filippesi: “La nostra patria è invece nei cieli e di là aspettiamo
come Salvatore il Signore Gesù Cristo” (3,20). La politeia celeste attesa
escatologicamente nella dimensione dell’ultimo, non nega ma vivifica in vario modo
la politeia terrestre cui il credente partecipa senza sconti e privilegi, ma pure senza
dimissioni. Egli porta in fragili vasi una speranza eterna ed una redenzione eterna e
non gli è consentito disertare. Non gli è concesso di stare nella polis come se Dio non
fosse e Cristo non fosse venuto. Per questo si pone liberamente in ascolto del
messaggio della ragione e della rivelazione, poiché sa che il Dio cristiano è ‘pratico’ e
agisce nella storia.
2. Da questo nucleo prende nascimento la teologia politica quale disciplina che
studia il rapporto tra Dio e la società, ed in seconda battuta quello tra religione e
società. Nella teologia politica è in questione il concetto di Dio e dei rapporti che
questi intrattiene, in un modo o nell’altro, col mondo e la società degli uomini. Se il
Dio che viene pensato o ipotizzato è un Dio che vale come una sorta di ipotesi
razionale priva di vita, è un conto; un altro è se Dio è il Dio cristiano che interviene
nella storia. Un tale Dio non chiede di portare la politica sotto il dominio della
religione, ma di aprirla al rispetto della giustizia e della persona, e ad intendere le
valenze politiche del messaggio biblico. Da sempre e di fatto ancor oggi una quota
della politica in Occidente si fa avendo in un modo o nell’altro la Bibbia alle spalle, il
che conferma il potere ‘rivoluzionario’ e di lievito della Parola (19).
In senso proprio la teologia politica non ricorre all’annuncio cristiano per giustificare
un determinato sistema politico, ma è la comprensione del nesso Dio-religionepolitica in rapporto al suo significato ed alle decisioni ed azioni conseguenti. Che la
teologia politica sia ritenuta un sapere teologico, o piuttosto sotto il titolo di
‘problema teologico-politico’ qualcosa di precipua pertinenza della filosofia, le due
trattazioni non si pongono in prima battuta come un segmento di scienza e/o di
sociologia delle religioni.
3. Non ci proponiamo il compito immenso di valutare quando e quanto la ‘teologia
politica’ della modernità si è abbeverata, per poco che fosse, a tali sorgenti. In brevi
‘profili’ esamineremo tre autori del Novecento: Schmitt, Peterson, Maritain.
1
8
3.1 Schmitt. Il Novecento teologico-politico si apre con la riflessione di Schmitt
(Teologia politica, 1922), un’elaborazione giustamente celebre ma nel complesso
limitata. Stando alle parole stesse dell’autore, essa “non riguarda nessun dogma
teologico, ma un problema di teoria della scienza e di storia dei concetti: l’identità
strutturale dei concetti teologici e delle argomentazioni e cognizioni giuridiche” (20).
Forse da tale rigorosa delimitazione sorge una certa delusione dinanzi alla portata
ridotta del metodo schmittiano Questo, ruotando quasi interamente sull’analogia tra
concetti teologici e concetti giuridico-politici, e prendendo la strada di una trattazione
sistematica del parallelismo, può aver offerto qua e là spunti scientifici di interesse,
ma non è stato capace di una considerazione teologica della politica ossia di una
teologia politica attiva e chiamante all’azione, alla prassi. Può perfino darsi che abbia
involontariamente contribuito a confermare il teorema di secolarizzazione nel senso
che, avendo la concettualità teologica espresso se stessa nell’analogia e nel travaso in
concetti politici, il suo compito per il mondo e la storia moderni si può considerare
concluso, e il livello teologico congedato. Ciò finirebbe per confermare la
considerazione immanente della politica come un ambito chiuso in sé e non attivabile
da alcun’altra energia.
La teologia politica di Schmitt né procede alla legittimazione sacrale dell’ordine
esistente (come operava la teologia civile antica o ‘romana’), né fa del teologale
cristiano un fermento permanente del politico: è un tertium genus, la cui sistematica
dottrinale e la cui sociologia dei concetti giuridici rimane storico-ermeneutica, una
storia dei concetti e dei loro effetti, in difficoltà nell’andare oltre il proprio carattere
‘teoretico’ e dunque alquanto estranea all’ambito dell’azione, del sapere pratico volto
all’agire, che è il campo della politica. Il metodo schmittiano può essere utile per
intendere a livello di alte astrazioni processi del passato, eppure rimane inadeguato in
rapporto al carattere dell’etica e della politica che sono scienze pratiche, ordinate
intrinsecamente all’azione.
Se la sociologia e l’ermeneutica schmittiane potevano mostrare come metafisica e
teologia fossero l’espressione più chiara della forma spirituale di un’epoca,
difficilmente potevano ricavare da qui una traccia per il concreto agire politico del
cittadino e del cristiano che dovevano rivolgersi altrove, come del resto fece Schmitt,
in maniera profondamente incoerente con le basi ‘teologiche’ del metodo. Egli per un
certo tempo ravvisò nella triade Stato-movimento (guidato da un Capo o Führer)popolo il luogo della concreta azione politica sua e tedesca (21). Nel momento della
scelta lasciò da parte Bonald, Donoso e la dottrina sociale della Chiesa, dove avrebbe
trovato una diversa dottrina del popolo ed una diversa dottrina della polarità ‘noiloro’. Qui furono Hobbes ed Hegel che dominarono, mentre l’antropologia cristiana
qua e là evocata è sostanzialmente abbandonata. Procedendo verso il Begriff des
Politischen quale massima polarità tra amico e nemico, Schmitt va incontro ad un
duplice aporia: non può stabilire una sistematica od un’analogia teologico-politica
che dal livello teologico-cristiano conduca al ‘concetto del politico’ inteso come
scontro sorgivo tra amico e nemico; ed in quanto omette il momento dell’apertura al
dialogo, della comunicazione e dell’amicizia civica non può dare avvio alla ricerca di
1
9
un’analogia tra questi livelli ben presenti nel teologico-cristiano e la politica. In tal
modo egli produce un’obiezione distruttiva verso il suo stesso metodo.
La ‘teologia politica’ schmittiana appare un genere secondario, che non tocca la
radice del problema, poiché non interroga il livello teologico e non lo pone
esistenzialmente in contatto con la vita politica (forse diversamente vanno le cose con
Cattolicesimo romano e forma politica) Secondo M. Nicoletti “Schmitt non è
interessato ad approfondire il nucleo veritativo di concetti della dottrina cattolica
quali il peccato originale, l’incarnazione di Gesù Cristo, e dunque l’idea di
mediazione, la fondazione dell’autorità e del diritto da un punto di vista teologico, né
vuole tradurre questa dottrina sul piano della teoria o della pratica politica” (22). In
quanto metodo ermeneutico delle analogie tra concetti teologici e concetti politici, lo
schema schmittiano non prende le mosse dal terreno teologico ma da quello politicogiuridico, ed è parte di questo.
3.2. Peterson. La teologia politica non è neppure riducibile all’influsso del
monoteismo teologico su un corrispondente monoteismo politico, né è impiegabile
per apologie improprie del tipo ‘un Dio, un re’. Tale influsso esiste, come ha
osservato tra gli altri E. Peterson (Il monoteismo come problema politico, Queriniana,
Brescia 1983), che nella polemica antischmittiana va però oltre. La sua tesi che
“soltanto sul terreno del giudaismo e del paganesimo può esistere qualcosa come una
‘teologia politica’” (p. 72) è manifestamente falsa, e dipende dall’orizzonte limitato
con cui Peterson discute il tema, cioè il nesso tra monarchia divina e monarchia
umana esplorato in un certo periodo storico, e dall’assunto pregiudiziale per cui la
teologia politica sia condannata a legittimare il politico a spese del teologico. In tal
modo anche il profetismo biblico, chiaramente monoteistico ma aperto e non
legittimante, sembra messo tra parentesi.
La trattazione petersoniana sul nesso tra monoteismo e ‘monarchia divina’ da un lato
e monarchia umana e impero dall’altro non si inoltra nella normatività di una
posizione teologica in ordine a scelte, decisioni e azioni politiche: teologia e politica
rimangono separate. Ciò comporta che non sia valorizzato l’evento centrale del
cristianesimo, l’Incarnazione del Verbo, nel senso che l’assoluta novità del Dio
incarnato rende impossibile la scissione fra celeste e mondano. In Il monoteismo
come problema politico dell’Incarnazione si tace, già a partire dalla premessa che si
riferisce solo al monoteismo e alla Trinità: “L’illuminismo europeo, della fede
cristiana in Dio, ha risparmiato soltanto il monoteismo, il quale è tanto problematico
nel suo contenuto teologico quanto nelle sue conseguenze politiche. Per il cristiano
l’agire politico può esistere soltanto alla luce della fede nel Dio trino (corsivo mio).
Questa fede si pone al di là di giudaismo e paganesimo, di ‘monoteismo’ e
‘politeismo’“ (p. 29). Con il riferimento solo alla Trinità e il sorprendente silenzio
sull’Incarnazione, si allontana certo un uso politico improprio o ideologico del
monoteismo, ma si smarriscono l’originalità e la differenza cristiana e in certo modo
il nucleo del tema teologico-politico in terra cristiana, ossia l’esistenza di
un’intenzione divina sul politico, la possibilità di una fecondazione positiva del
2
0
mondano da parte del trascendente. Nell’implicazione reciproca di teologia e di
politica, ciò che domina è l’Incarnazione.
Pubblicata a Lipsia nel 1935, la ricerca di Peterson fu indirettamente e a buon diritto
condizionata dal timore che la teologia del monoteismo, governata da mani molto
grevi, potesse giustificare religiosamente il connubio tra potere politico e religione, e
perfino le posizioni del Führer, allora sostenute dai Deutsche Christen. Nondimeno la
sua tesi sulla liquidazione di ogni teologia politica risulta molto problematica, in
specie nella sua generalizzazione sistematica che comporta l’idea di una teologia pura
che non si confronta con l’esistenza e la realtà della politica. La sua critica non ha
come avversario immediato solo Schmitt, ma l’illuminismo europeo e la sua
riduzione monoteistica e privatizzante della fede cristiana. In merito la controversa
alleanza e commistione tra religione e politica non si chiarisce solo con un esempio di
‘monoteismo politico’ non riuscito, ma appunto scandagliando nuovamente il
messaggio della Rivelazione e oltrepassando anche nel quadro teologico-politico le
strettoie della teologia del protestantesimo liberale, cui Peterson si sottrasse sul piano
teologico-dogmatico. Ed è sul piano del dogma ortodosso della Trinità e
dell’Incarnazione che la Chiesa può opporre resistenza alla riduzione del suo
messaggio a sostegno ideologico di un ordinamento politico.
3.3. Maritain. Un diverso orizzonte si incontra nel pensiero teologico-politico di
Maritain a partire da Religione e cultura (1930) e da Umanesimo integrale (1936).
Tale umanesimo altro non è che umanesimo dell’incarnazione del Verbo. Esso
“riconosce che Dio è il centro dell’uomo, implica il concetto cristiano della grazia e
della libertà”; umanesimo sì, “ma umanesimo teocentrico, radicato là dove l’uomo ha
le sue radici, umanesimo integrale, umanesimo dell’Incarnazione” (23). L’unità del
genere umano, l’uguaglianza naturale di tutti gli uomini, la dignità inalienabile di
ciascuno ed i suoi diritti, la dignità del lavoro e dei poveri, l’inviolabilità delle
coscienze, la sete di giustizia, sono criteri che il messaggio cristiano ha risvegliato
nella coscienza dei popoli, che non possono andare perduti, e che vanno
costantemente rimessi in moto da energie creatrici (24).
Quando rintracciamo l’azione di lievito e fermento che il Vangelo esercita verso
credenti e noncredenti, siamo dinanzi ad un’energia storica in atto, a decisioni
fondamentali, allo spessore dell’esistenza politica con i contrasti che le appartengono,
non dinanzi ad analogie giuridico-politiche. Siamo posti davanti ad una ‘teologia
politica di lotta’ in cui l’assioma che ‘Dio è pratico’ assume tutto il suo rilievo, e con
esso la libertà del cristiano: “Perché il cristiano è libero nel mondo? E’ libero perché è
legato a qualche cosa che non è del mondo. Noi siamo legati al Vangelo ed il Vangelo
annuncia il regno dei cieli. Alla radice di tutti i nostri problemi sta il problema del
Vangelo e del mondo” (25). Viene qui delineata una prospettiva aperta e proseguibile
in maniera omogenea ossia senza negare le principali posizioni antropologiche e
teologiche che le conferiscono sostanza, e nel contempo capace di tenere gli occhi
aperti sui tempi e il mutare delle situazioni storiche. Il ‘teorema di secolarizzazione’
non viene accolto come insuperabile e parimenti l’idea che la modernità sia dotata di
2
1
un immenso potere neutralizzante, e perciò come tale sia irriformabile e da
abbandonare al suo destino non teologico. Il senso dell’elaborazione di Maritain si
può anzi condensare in due elementi: a) riaffermare la politicità trascendente e
animante del Vangelo; b) operare per un accostamento e riconoscimento reciproco tra
i due fronti del moderno, quello laico e quello cristiano, agendo per un
riconoscimento delle conquiste della modernità politica, quali i diritti umani e le
libertà, e mostrando che la loro migliore radice sta nel cristianesimo. Il
riconoscimento del pluralismo religioso, culturale e politico delle società moderne si
accompagna al disegno di una società personalista, comunitaria, pluralista e
liberamente teista, e sul piano politico mondiale alla delineazione di una società
politica planetaria, una sorta di Weltrepublik che sia la risposta alle esigenze di un
bene comune ormai mondiale e a quelle della pace.
Queste fondamentali elaborazioni che si nutrono di succhi cristiani e umanistici, sono
avanzate mediante argomenti pubblici razionali comprensibili in linea di principio da
tutti, a prova che il requisito preliminare per l’accesso al dibattito pubblico non può
imporsi nel senso di escludere a priori ogni teologia politica.
Se nel rapporto tra medioevo ed età moderna Maritain elabora un’ermeneutica più
plurale della tesi ‘secolaristica’ di Blumenberg (La legittimità dell’età moderna,
1966) - la quale si concentra sull’autolegittimazione dell’uomo moderno rispetto
all’assolutismo teologico precedente arrestandosi ad una modernità alquanto chiusa in
se stessa -, il filosofo francese introduce ulteriormente la categoria dell’ultramoderno
(che forse potremmo anche chiamare postmoderno con un significato diverso da
quello oggi corrente) come luogo di una possibile intesa tra illuminismo moderno e
cultura cristiana, in cui il rapporto tra ragione e storia sia aperto e riconosca il valore
del religioso.
La categoria centrale di tale operazione è quella di reintegrazione che si potrebbe
anche chiamare di riconciliazione: reintegrazione al di là delle scissioni della
modernità. A fondamento di tale lettura sta una filosofia della storia moderna e una
lettura della modernità svolta intorno a moduli di carattere filosofico-teologico: il
severo impoverimento del contenuto dell’idea di Dio nella modernità che esige una
ripresa teistica e teologale, la dialettica di libertà e grazia, il nesso tra religione e
cultura, la differenza tra Cesare e Dio, tra spirituale e di temporale, l’emersione del
principio-persona e dei suoi diritti, la sfida dei totalitarismi, il valore della
democrazia, l’importanza del concetto-realtà di popolo, della giustizia politica, del
pluralismo sociale, la critica della sovranità dello Stato, l’imprescindibilità della legge
naturale. In tal senso Umanesimo integrale (e le opere ad esso collegate, tra cui in
specie Per una filosofia della storia) può essere pensato come la più importante
ripresa moderna e ‘aggiornamento’ del problema del De civitate Dei, condotta
attraverso una filosofia cristiana della storia ed una solida alleanza tra ragione
filosofica e messaggio biblico (25).
Commiato
2
2
La teologia politica non è per nulla liquidata, neppure quella ‘tradizionale’ che si
pone al di sopra della ormai incerta e forse logora opposizione tra progressismo e
conservazione, e che tiene l’occhio aperto sui rischi di desertificazione materialistica.
Anzi il problema teologico-politico riemerge dovunque poiché riguarda un elemento
permanente quale è il nesso religione-politica, e non può venire ridotto solo ad uno
schema di relazioni tra Stato e Chiesa. E la frase di Proudhon da cui prendemmo
avvio mostra anche oggi la sua verità: in molti modi nelle nostre società secolarizzate
al di sotto del politico si incontra e riemerge lo strato teologico. Ne sono
probabilmente consapevoli i tentativi neoilluministici di fare perno su una compiuta
autonomia dell’umano. In questo modo viene proseguita una linea che mira a
radicalizzare la secolarizzazione del teologico e a spingere al massimo la separazione
tra politica e religione. La ripresa della teologia politica non può che favorire quella
della stessa filosofia politica, che lentamente si sta ristabilendo da quelle che L.
Strauss ha chiamato le tre ondate della modernità: Machiavelli-Hobbes; RousseauHegel; positivismo, storicismo, Nietzsche-Weber-Heidegger, per cui non è di grande
aiuto richiamarsi ad uno stadio più antico per contrastare quelli più recenti.
Autori dell’ultima ora ritengono che il recente “revival della teologia politica
nell’Occidente moderno è una storia umiliante”. Per allontanarcene dobbiamo
operare “uno sforzo consapevole per separare i principi di fondo della legittimità
politica dalla rivelazione divina” e rimanere consapevoli della minaccia rappresentata
dalla teologia politica (27).
Non abbiamo bisogno né di un uso politico della religione, né di un uso religioso
della politica, né di delegittimare l’eredità della cultura laica moderna con i suoi
criteri quali la distinzione tra diritto e morale, tra reato e colpa, tra politica e
religione, tra foro interno e foro esterno. In realtà si tratta non di rado di criteri più
antichi che certo ogni epoca deve riprendere e modulare. Su diritto e morale
l’Aquinate osserva che non tutto quello che è contro la legge morale e la virtù deve
essere sanzionato dal diritto positivo (cfr. S. Th., I II, q. 96, a. 2). Un resoconto
equilibrato della situazione forse potrebbe sostenere che non sono in discussione i
criteri classici della laicità, ma la loro ermeneutica: quello che il ‘partito laicista e
neoilluminista’ presenta, in anni recenti con maggiore insistenza, come un severo
attacco alla laicità forse non è tale, piuttosto incorpora una versione diversa di laicità
che ne accoglie i criteri di base, ma ne mette in questione la loro interpretazione
liberale e illuministica.
Rimane la realtà di una società plurale, in cui sono plurali le visioni della libertà e
del bene. Il pluralismo potrà variare da un grado accettabile ad uno intollerabile nel
senso che metterebbe a rischio la vita comune. Buona parte dei nostri problemi
derivano dall’individuazione del livello di pluralismo accettabile o compatibile.
Questa ricerca spesso non ha un risultato a priori, ma è il frutto di un bilanciamento
mutevole, in cui la voce della religione oggi chiede con buoni motivi di offrire il suo
apporto.
Ciò potrà accadere in un contesto ormai indirizzato verso una globalizzazione che
coinvolge tutte le culture e che in genere obbedisce ad alcuni fondamentali
orientamenti di base: l’orientamento al controllo tecnico della natura, la generazione
2
3
capitalistica di ricchezza, l’organizzazione procedurale e burocratica del potere, la
tendenza ad accettare l’enorme disparità nella distribuzione della ricchezza, cui
cercano di opporsi molte etiche sociali e talvolta le ali più avanzate del diritto
internazionale. Ed è entro questo contesto che la verticale teologico-politica deve
operare per ridare fiato alla ricerca di criteri condivisi di giustizia politica mondiale.
Note
(1) Les confessions d’un révolutionnaire, pour servir à l’histoire de la Révolution de
Février, Paris 1849, p. 61.
(2) F. A. Hayek, The Constitution of Liberty, Routledge and Kegan Paul, London
1960, p. 407.
(3) The Laws of Peoples, Harvard University Press, Cambridge 1999, p. 176.
(4) Cfr. In particolare J. Habermas, Tra scienza e fede, Laterza, Roma-Bari 2006, e il
dialogo Habermas-Ratzinger su “I fondamenti morali e prepolitici dello Stato
liberale” (2004), trad. it. a c. di M. Nicoletti in Humanitas, n. 2-2004, pp. 232-260.
(5) Le società liberali al bivio. Lineamenti di filosofia della società, Marietti, Genova
1991, p. 249.
(6) Ricorrendo al termine postliberale riprendo il filo di un discorso iniziato vent’anni
fa, seppure con un lessico che ancora non ricorreva al termine postliberale, con opere
quali: Tra secolarizzazione e nuova cristianità (1986), Le società liberali al bivio
(1991), Religione e vita civile (2001), segnato dall’attenzione al tema teologicopolitico.
(7) Tali temi sono emersi, oltre che nei testi habermasiani già citati, nei volumi di
L’inclusione dell’altro, Feltrinelli 1999, Il futuro della natura umana, Einaudi 2002.
Per dirla in breve, io assegno al termine ‘postsecolare’ un significato più intenso di
quello cui ricorre Habermas in Scienza e fede: “L’espressione ‘postsecolare’ si limita
a tributare alle comunità religiose il pubblico riconoscimento per il contributo
funzionale che esse recano alla riproduzione di motivazioni e atteggiamenti
desiderabili” (p. 16). In particolare mi allontano dall’identità habermasiana tra
postsecolare e postmetafisico: “La consapevolezza laica di vivere in una società
postsecolare si esprime sul piano filosofico in forma di un pensiero postmetafisico”
(p. 24).
(8) A. De Tocqueville, La democrazia in America, Milano 1997, p. 55.
2
4
(9) L’impegno per la libertà religiosa deve continuare. In merito un punto positivo fu
segnato dal Concilio Vaticano II con la dichiarazione Dignitatis humanae sulla libertà
religiosa. Con la sua approvazione – certo necessaria – parve che l’ultimo bastione
della ‘resistenza cattolica’ alla modernità venisse meno e che il terreno fosse spianato
per la vittoria dell’interpretazione liberale della libertà e la privatizzazione della
religione. In realtà negli anni ’60 era già cominciato un mutamento nella filosofia
pubblica liberale più avvertita: non più critica della religione ma una sorta di
neutralità e benevola indifferenza nei suoi confronti. A questa fase subentra poi un
tentativo di dialogo e di intesa a scopi civili per non violare l’eguaglianza tra credenti
e noncredenti. E’ notevole che l’idea stessa di libertà religiosa, lungamente impiegata
contro le Chiese, comincia ad essere usata da queste a loro favore per fruire
pienamente della libertà di intervento nell’ambito civile.
(10) B. Spinoza, Tractatus theologico-politicus, cap. 20.
(11) Spesso si dice: “Libero è l’individuo che si autodetermina, che determina la
propria volontà con le leggi che egli dà a se stesso. Autonomia significa
sottomissione ad una legge che ciascuno dà a sé e dunque una legge che riguarda tutti
gli uomini”. Ora, affinché ciascuno, dandola singolarmente a sé, raggiunga una legge
che riguarda tutti gli uomini, occorre che fondamentalmente la trovi in sé e la
riconosca: la trovi in sé per gli aspetti più fondamentali ed universali, e la sviluppi
secondo ragione per gli altri aspetti. Tale è propriamente la legge morale naturale.
Essa ci aiuta ad avviare a soluzione i gravi conflitti di valori e i dilemmi etici che
incontriamo frequentemente, e su cui il relativismo ci lascia senza bussola, se non
quella di far prevalere l’opinione del più forte. Sviluppi in merito sono nel cap. I di
Le ragioni della laicità, Rubbettino 2007.
(12) Consideriamo l’apostasia e l’adulterio. La prima, pur religiosamente proibita,
può non essere moralmente illecita, ed in genere non viola la legge dello Stato laico.
L’adulterio è religiosamente proibito, è moralmente illecito, ma perlopiù non è oggi
sanzionato dalla legge civile.
(13) Su natura umana e persona la ragione monodimensionale, educata quasi solo
dalle scienze, si trova in seria difficoltà ad includerne un resoconto attendibile. Il
fulcro risiede nell’idea di natura umana che la suddetta ragione valuta negativamente,
spesso sospettandovi un sostituto secolarizzato di Dio, per cui l’etsi Deus non daretur
si appaierebbe con l’ etsi natura humana non daretur. Del resto le due strade non
sono poi lontane se, come osservò Sartre, non potrebbe esservi natura umana senza
un Dio che la pensasse.
(14) A. B. Seligman, a cura di M. Bortolini e M. Rosati, La scommessa della
modernità, Meltemi, Roma, 2002, p. 207.
2
5
(15) La corrente scientista deve evitare lo scoglio della contraddizione, poiché essa
sembra includere due posizioni inconciliabili che volta a volta vengono fatte valere
per i bisogni della causa. Da un lato ci si affida alle neuroscienze e alla ricerca
materialistica sulla mente e l’anima, che fa di queste ultime un epifenomeno del
cervello, di modo che tutto è riportato a bios. Poi quel bios che spiega
naturalisticamente mente-cervello, viene allontanato a livello di embrione e di
genoma individuale umano, che pur avrebbe non pochi titoli per valere come ‘segno’
o ‘simbolo’ universale dell’umano.
(16) La funzione cognitiva e motivante della religione è stata recentemente citata da
Habermas: “Le tradizioni religiose provvedono ancora oggi all’articolazione della
coscienza di ciò che manca. Mantengono desta una sensibilità per ciò che è venuto
meno. Difendono dall’oblio le dimensioni della nostra convivenza sociale e
personale, nelle quali anche i progressi della razionalizzazione culturale e sociale
hanno prodotto distruzioni immani. Perché non dovrebbero pur sempre contenere
racchiusi in sé potenziali semantici che, una volta trasformati nel linguaggio della
motivazione, e dopo aver dato alla luce il loro contenuto profano di verità, possono
esercitare una loro forza d’ispirazione?”, J. Habermas, Tra scienza e fede, cit., p. XI.
(17) J. Moltmann, Prospettive della teologia, Queriniana, Brescia 1973, p. 253.
(18) Le civiltà di forma cristiana sono un momento di realizzazione dell’essenziale
struttura ‘incarnatoria’ del cristianesimo, Evento che dovunque si ripercuote. Per tali
motivi il cristianesimo non è “diabolico” ma “simbolico”. Non è diabolico (da
diaballo = separo, disgiungo, disunisco), perché tiene insieme umano e divino, pure
nella loro infinita differenza qualitativa; dunque è simbolico (da sunballo = prendo
insieme, unisco). Centrale è l’idea che da nessuna parte si trova una potenza
riconciliante come nella religione del Verbo incarnato. E’ in ragione di una
sovrabbondanza inerente che il cristianesimo, fede storica basata su eventi fondatori,
si occupa delle civiltà. In esso si segnala un primato dello storico sul cosmico, che le
culture antiche e quelle moderne di taglio “essenzialistico” non riescono a
comprendere. Non è il cristianesimo ad aver bisogno delle civiltà, ma il contrario.
Noi viviamo ancora all’alba del cristianesimo, alle prime luci del suo influsso
sull’uomo e sulla storia: è da questo slancio divino-umano che prenderanno nascita le
più grandi rivoluzioni future per la vita umana, poiché qui, nel cristianesimo, Dio e
uomo si sono dati la mano, stringendo un’alleanza eterna. Non è un compito di
legittimazione che così viene esercitato ma un’azione umanistica.
(19) Vi è in questo fine un elemento che può richiamare la teologia politica
dell’Esodo, l’uscita dall’Egitto, la marcia nel deserto, il Sinai e l’alleanza, l’ingresso
nella terra promessa, eppure una teologia politica dell’esodo non raggiunge forse la
forza fecondante di quella del Logos incarnato. Sull’Esodo e la relativa teologia
politica, cfr. M. Walzer, Esodo e rivoluzione, Feltrinelli 1986.
2
6
(20) Teologia politica II, a cura di A. Caracciolo, Giuffrè, Milano, 1992, p. 17.
Analoga affermazione a p. 83, nota 1, in cui Schmitt procede a delimitare
chiaramente il suo metodo. Non rimediabile appare tuttavia l’uso facile del termine
‘teologia politica’ per un ambito e un metodo cui solo con notevole sforzo si attaglia.
(21) C. Schmitt, Principi politici del nazionalsocialismo, Sansoni, Firenze 1935.
(22) “Il problema della ‘teologia politica’ nel Novecento. Filosofia politica e critica
teologica”, in AA. VV., Teologia politica, a c. di L. Sartori e M. Nicoletti, EDB,
Bologna 1991, p. 29.
(23) Umanesimo integrale, Borla, Torino 1963, p. 81 e p. 119.
(24) Cfr J. Maritain, Cristianesimo e democrazia (1943), in specie il cap.
“L’ispirazione evangelica e la coscienza profana”, Vita e Pensiero, Milano 1977.
(25) J. Maritain, “La libertà del cristiano” (1938), in Scritti e manifesti politici 19331939, a cura di Giorgio Campanini, Brescia 1978, p. 157.
(26) Richiamando la differenza tra teologia e filosofia della storia, Ch. Journet
riteneva quella di Maritain “la più potente filosofia cristiana della storia che sia mai
stata scritta”, “D’une philosophie chrétienne de l’histoire et de la culture”, In AA.
VV., Jacques Maritain. Son oeuvre philosophique, DDB, Paris 1949, p. 33.
(27) M. Lilla, “La teologia politica minaccia l’Occidente”, Corriere della Sera, 17
dicembre 2007. L’autore legge in maniera incrociata la teologia politica islamica e
quella cristiana, sembrando ignorare che la seconda non chiede di identificare legge
divina e legge civile.
Annesso - La ragione monodimensionale e il senso
Il secolarismo assume che l’espressione pubblica di convinzioni intense sia di per sé
offensiva nei confronti di soggetti di altre convinzioni. E ritiene che ogni convinzione
debba essere considerata come basata su ragioni idiomatiche e al di fuori di
argomenti pubblici. In sostanza non vi sarebbe niente di fondamentale su cui
discutere nella sfera pubblica: si ritiene infatti che le domande sull’uomo, il cosmo e
Dio non abbiano soluzione e non sia forse neppure possibile un dialogo preliminare
in merito. Anzi si chiede ai soggetti in carne ed ossa, che partecipano alla vita civile,
di svestirsi delle loro prospettive più meditate e di entrare nella sfera pubblica silenti
2
7
o ammessi ad argomentare solo sulla base di quella che è la posizione secolareliberale, la quale assolutizza un solo tipo di razionalità pubblica, oggi spesso quella
derivata dalla scienza, col rischio di una cattura totalitaria della ragione pubblica da
parte dello scientismo. In tal caso gli argomenti ammessi sarebbero una qualche
versione di utilitarismo morale.
Dinanzi al rischio di una ragione monodimensionale il dialogo etico nella società
postsecolare è benvenuto ma insufficiente, poiché occorre mettere piede nel dominio
del senso. Qui oggi risiede un caso serio, che non può essere risolto invocando il solo
livello dei valori morali. L’esclusione programmatica della ‘filosofia prima’
dall’ambito del discorso secolare su etica, politica, diritto, non rappresenta un
guadagno di razionalità o di laicità, ma perdita che finisce per favorire la
superstizione scientista, il pensiero al ribasso e il disfattismo della ragione.
L’opera di Weber non è stata senza conseguenze in merito. Essa, pur attenta
all’elemento religioso, pose le premesse per un suo abbandono, in quanto per lui
l’evoluzione del genere umano verso la razionalità della scienza positiva è
considerata in omaggio a Comte un progresso, sebbene vi si cominci ad avvertire il
processo di disincantamento (Entzauberung) e di sdivinizzazione (Entgöttlichung).
L’equivoco prospettico di Weber, col quale egli abbandonava la purezza della sua
metodologia, consisteva nella previsione-convinzione che la storia stesse procedendo
verso un razionalismo sempre più ristretto che relegava religione e metafisica
nell’irrazionale e nel passato remoto. Col primato attribuito alla razionalità rispetto
allo scopo su quella rispetto al valore non si può più render conto di molti eventi, fra
cui lo scaturire dell’azione dalla causalità del soggetto e l’influsso della religione
sulla prassi. Coloro che sono venuti dopo non hanno più sostanzialmente sottoposto
ad esame la previsione weberiana e l’inerente nichilismo che la abita, ma hanno
proceduto ritenendo che l’incremento del razionalismo richiedesse di marginalizzare
gli ambiti (religione, metafisica) cui Weber assegnava ancora rilievo, seppure critico.
Nel ribadire tale marginalità essi presero come ascesa verso un maggior livello di
razionalità quello che invece era una discesa, un declino, un grave restringimento.
Ancor meno si è avuta la lucidità intellettuale di riconoscere che il declino di ragione
e razionalità proveniva per non piccola parte da un declino e un regresso religioso
(Ho svolto questi aspetti in Religione e vita civile, cit.).
Uno dei maggiori problemi del disfattismo della ragione consiste in un rapporto
escludente tra metafisica e scienza. In merito a tale rapporto le soluzioni battute sono:
1) la metafisica è non-senso, discorso privo di significato; 2) la metafisica è pseudoscienza, discorso forse non contraddittorio, ma che non ha nulla in comune con la
scienza; 3) la metafisica è pre-scienza, nel senso che dissoda il terreno fornendo
metafisiche influenti capaci di orientare la ricerca della scienza; 4) la metafisica è
sopra scienza, ossia qualcosa di nebuloso che va molto oltre l’ambito del
controllabile. Pochi optato a favore della metafisica come sapere. Sulla propensione
antimetafisica o ametafisica della ‘ragione scientista’ si è di recente innestato il
resoconto dell’evoluzionismo. L’alleanza tra scientismo ed evoluzionismo
neodarwiniano, inteso come la risposta ultima ed esaustiva, rappresenta attualmente
un rischio notevole per la cultura di sfondo delle ‘società liberali’.
2
8
2
9