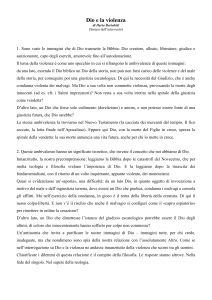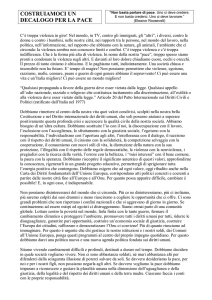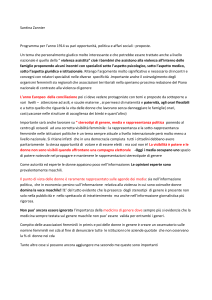La vita è uno schifo
di Léo Malet
Fazi Editore Tascabili
L’opera è il capostipite del noir francese, con una sua originalità troppo spesso non adeguatamente
riconosciuta, rispetto al giallo e al poliziesco. L’autore è il Maigret francese, che talora lo supera
nell’acutezza e nella complessità psicologica, anche se molto meno noto al grande pubblico. La vita
è uno schifo è stata scritta alla fine degli Anni Quaranta del Novecento e poi riunita nella Trilogie
Noire andata in stampa alla fine del 1969 dall’editore Eric Losfeld. La sovra copertina era del
pittore Magritte e oggi quella pubblicazione appare come un evento letterario per varie ragioni, a
cominciare dalla casa editrice La Terrain Vague (terra di nessuno) che pubblicava e riscopriva
autori maledetti come Boris Vian. Una testimonianza dell’autore evidenzia quando Léo Malet
tenesse a questo romanzo e mette in evidenza alcuni messaggi: il protagonista, Jean Fraiger, è tanto
sanguinario quanto tenero, un personaggio che finisce in scacco; smascherato dall’analisi dello
psicanalista del quale lo scrittore confessa aver provato il fascino. La dimensione onirica, delirante
serpeggia nell’opera, attingendo alla cultura surrealista che ha contaminato l’opera di Malet e che
l’autore ha frequentato da vicino, come testimoniano delle lettere critiche di René Magritte su
questo testo. La storia è semplice e se vogliamo banale: un gruppo di anarco-comunisti sostiene con
furti e rapine il proprio credo: l’illegalità come strumento per ristabilire la giustizia, la propria
giustizia e quella del gruppo di appartenenza. Per ammissione dello stesso Léo l’ideologia si
rovescia presto in azioni di criminalità comune, con una banalizzazione del male. L’assunzione che
la vita sia uno schifo e la frase, pronunciata dal protagonista, torna come un refrain nel corso delle
pagine, rende naturale compiere il male come se non si potesse fare diversamente. L’ascendenza
della filosofia di De Sade si sente ma mentre il Marchese tranquillizzava le proprie amiche dicendo
che “il lupo non mangia la carne del lupo”, qui il gruppo sfuma come valore di solidarietà, di
amicizia, di complicità ma si disegna solo come insieme di ingranaggi funzionali alla macchina e ad
un piacere immediato, come una bevuta insieme, che può disgregarsi da un momento all’altro. Una
spirale di violenza non aliena da qualche goffaggine. Alla violenza spietata che stimola altra
violenza – le stesse cronache di quei giorni parlano di un crescendo perché probabilmente il fatto
che tanti crimini restino impuniti dà coraggio a criminali in potenza – c’è la vita intima del
protagonista. Un uomo debole e perfino tenero in certi momenti, di un’ingenuità senza
romanticismo ma più vicina al delirio: l’amore per una donna bellissima e sfuggente, rimembranza
dell’amour fou surrealista, che è autodistruttivo. Un epilogo tragico quanto malinconico che si
conclude con le parole del protagonista <<mi sarebbe tanto piaciuto vivere>>. Perché forse
quell’orgia di erotismo e di violenza è un frastuono che lascia poi nel silenzio della solitudine. In
certi momenti ricorda l’esistenzialismo di Albert Camus nell’Etranger dove però l’estraneità ha
lasciato il posto alla rabbia e ad un’aggressività senza confronti e senza lucidità. E’ uno spietato
ritratto del Novecento per alcuni aspetti tristemente premonitore di Atti casuali di violenza
insensata, per dirla con il titolo di un’opera di Womack. Nello stesso tempo però c’è anche la
misura e la ricercatezza di un francese che usa molto l’Argot e che evidenzia anche con la lingua la
distanza del protagonista dalla donna amata, il suo senso di marginalizzazione e di inferiorità,
compiendo così sottilmente un’analisi, senza pedanteria, sociale e psicologica, che poi in modo
spicciolo e immediato lo psicanalista porta alla luce alla fine del romanzo.