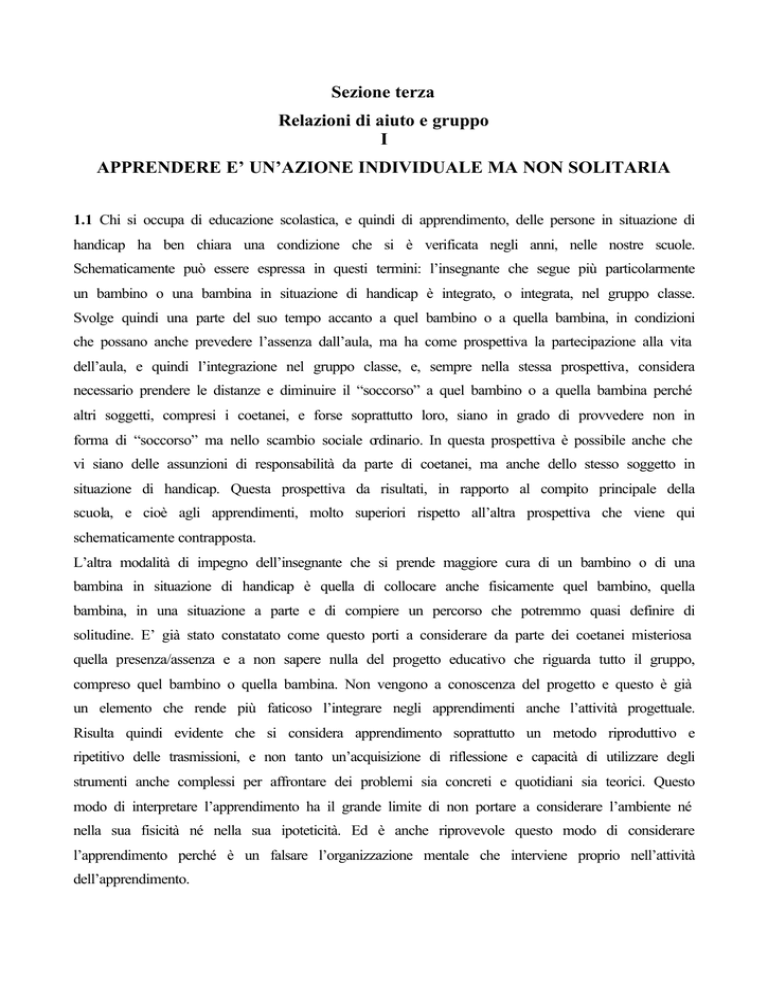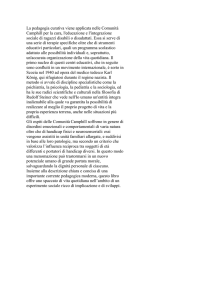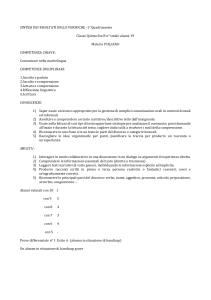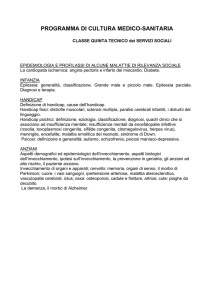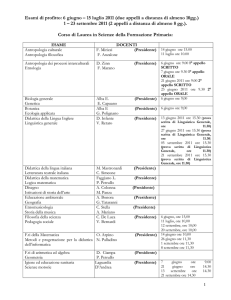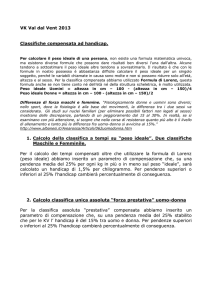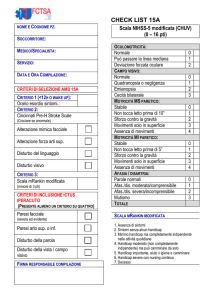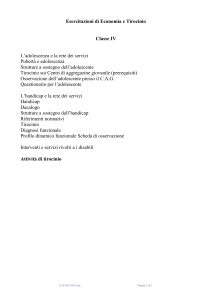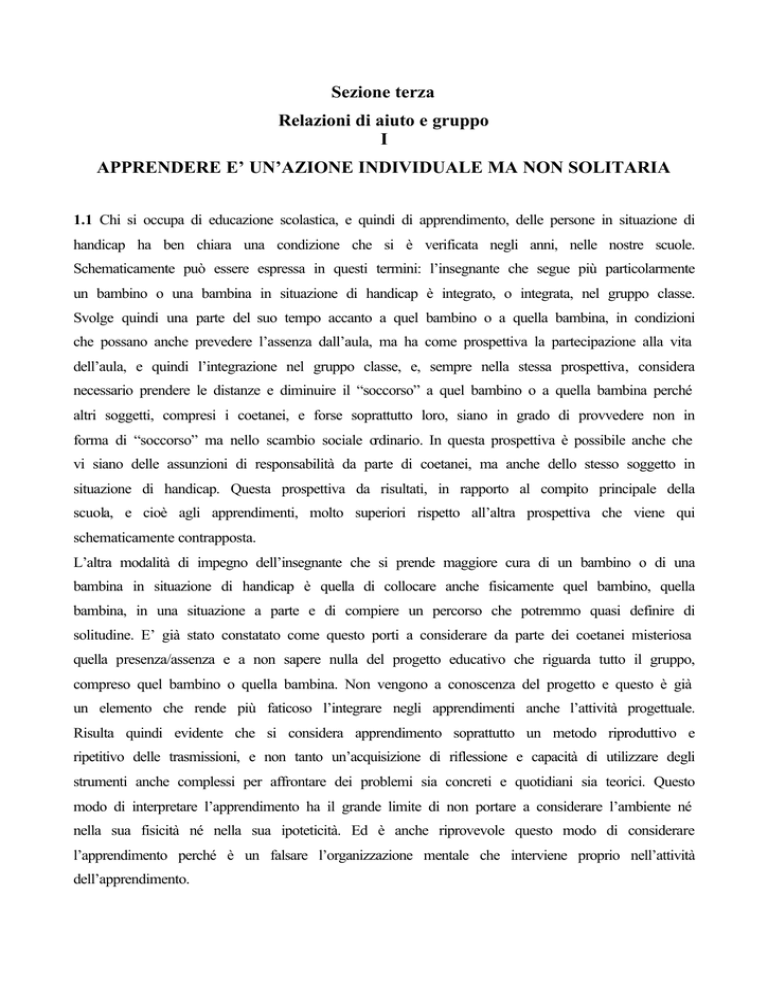
Sezione terza
Relazioni di aiuto e gruppo
I
APPRENDERE E’ UN’AZIONE INDIVIDUALE MA NON SOLITARIA
1.1 Chi si occupa di educazione scolastica, e quindi di apprendimento, delle persone in situazione di
handicap ha ben chiara una condizione che si è verificata negli anni, nelle nostre scuole.
Schematicamente può essere espressa in questi termini: l’insegnante che segue più particolarmente
un bambino o una bambina in situazione di handicap è integrato, o integrata, nel gruppo classe.
Svolge quindi una parte del suo tempo accanto a quel bambino o a quella bambina, in condizioni
che possano anche prevedere l’assenza dall’aula, ma ha come prospettiva la partecipazione alla vita
dell’aula, e quindi l’integrazione nel gruppo classe, e, sempre nella stessa prospettiva, considera
necessario prendere le distanze e diminuire il “soccorso” a quel bambino o a quella bambina perché
altri soggetti, compresi i coetanei, e forse soprattutto loro, siano in grado di provvedere non in
forma di “soccorso” ma nello scambio sociale ordinario. In questa prospettiva è possibile anche che
vi siano delle assunzioni di responsabilità da parte di coetanei, ma anche dello stesso soggetto in
situazione di handicap. Questa prospettiva da risultati, in rapporto al compito principale della
scuola, e cioè agli apprendimenti, molto superiori rispetto all’altra prospettiva che viene qui
schematicamente contrapposta.
L’altra modalità di impegno dell’insegnante che si prende maggiore cura di un bambino o di una
bambina in situazione di handicap è quella di collocare anche fisicamente quel bambino, quella
bambina, in una situazione a parte e di compiere un percorso che potremmo quasi definire di
solitudine. E’ già stato constatato come questo porti a considerare da parte dei coetanei misteriosa
quella presenza/assenza e a non sapere nulla del progetto educativo che riguarda tutto il gruppo,
compreso quel bambino o quella bambina. Non vengono a conoscenza del progetto e questo è già
un elemento che rende più faticoso l’integrare negli apprendimenti anche l’attività progettuale.
Risulta quindi evidente che si considera apprendimento soprattutto un metodo riproduttivo e
ripetitivo delle trasmissioni, e non tanto un’acquisizione di riflessione e capacità di utilizzare degli
strumenti anche complessi per affrontare dei problemi sia concreti e quotidiani sia teorici. Questo
modo di interpretare l’apprendimento ha il grande limite di non portare a considerare l’ambiente né
nella sua fisicità né nella sua ipoteticità. Ed è anche riprovevole questo modo di considerare
l’apprendimento perché è un falsare l’organizzazione mentale che interviene proprio nell’attività
dell’apprendimento.
Una delle situazioni che chi parla e scrive queste note si è trovato a vivere con più interesse è stato
proprio
il
partecipare
all’organizzazione
di
una
condizione
indispensabile
per
realizzare
l’apprendimento da parte di un bambino che sembra va non riuscire ad imparare. Più volte mi sono
trovato a riflettere sull’apparentemente misterioso fatto che riguardava un bambino di undici anni
incapace di sommare 8+8 e invece capace di utilizzare delle operazioni a più cifre per dividere, fare
i conti e fornire anche il resto. Otto erano i chilometri che percorreva quotidianamente dalla sua
abitazione alla scuola, all’andata e al ritorno. E la richiesta, ripetuta più volte, di considerare otto
chilometri all’andata e otto chilometri al ritorno come una somma che permetteva di calcolare
quanta strada facevano le sue gambe lo metteva in seria difficoltà, mentre l’ipotetica somma di
100.000 lire da organizzare per acquistare cibo e cucinarlo poi per un pranzo con amici gli
permetteva di fare delle operazioni complesse. Era lampante, in quel caso, che la sua
organizzazione mentale funzionava meglio quando poteva collocarsi su uno scenario abitato da una
certa tipologia, diciamo così, di persone e in un certo ambiente.
Basterebbe questo esempio per farci capire come la sua mente non poteva agire, ossia pensare,
elaborare, in solitudine, ma doveva evocare uno spazio, altre persone, a cui anche riferire i risultati
del suo operare. E’ questa una delle condizioni che viene meno considerata quando si pensa a un
bambino, una bambina, in situazione di handicap, e lo/la si porta a svolgere un percorso tutto
individuale. Bisogna considerare con attenzione quei percorsi individuali che sono fatti per arrivare
in condizioni ottimali a rapportarsi agli altri, questo e altro; ottengono dei rischi, l’isolamento è il
più evidente, ma possono avere una progettazione alle spalle che, tenendo conto di questi rischi,
procede verso una integrazione. E rientra allora nella prima prospettiva che è stata indicata. Ed è
quindi evidente che tra le due prospettive vi possono essere delle contaminazioni, a volte molto
utili, a volte pericolose. E’ nella natura delle cose.
L’interesse maggiore è quello di riflettere proprio sulle modalità di apprendimento, ed è una delle
condizioni che si sono trovati ad affrontare quegli educatori che, volgendosi a delle popolazioni
considerate a priori come in difficoltà rispetto all’apprendimento hanno avuto l’intuizione di aiutare
ad evocare gli scenari in cui il loro pensiero, l’organizzazione dell’apprendimento, poteva essere più
favorito. Si pensi a Freinet o a Paulo Freire, i cui esempi sono, c’è da sperare, noti, e, se non sono
noti, ci sono però i modi, i libri, le biblioteche, per poterli riprendere o conoscere. L’importanza
maggiore è questa condizione in cui il termine evocazione ha un valore fondamentale per la
strategia dell’apprendimento, però ha anche dei rischi. Ognuno è sensibile a qualche rischio e quindi
non considero quello che io individuo come il rischio maggiore ma quello a cui sono più sensibile
perché più volte l’ho incontrato: è il rischio dell’intimismo. E’ paradossale pensare che, utilizzando
l’evocazione
come
parola
importante
per
una
attività
di
apprendimento
che
va
verso
l’apprendimento sociale, si potrebbe dire utilizzando un termine che ha una radice wygotzkjana, ci
si trovi poi, invece, a realizzare una condizione molto legata alla propria visione intima, e quindi
incapace di aprirsi agli altri. Certamente questo è un rischio dovuto al fatto che si privilegia
l’autoreferenzialità, e quindi si considera con troppa attenzione un lavoro di apprendimento che stia
unicamente sulla piattaforma – usiamo questo termine metaforicamente – e quindi sullo spazio che
quell’individuo ha. E’ proprio un’immagine metaforica, ma la costruzione di un apprendimento che
appoggi sempre e unicamente su uno spazio intimo, può essere pericolosa. Riporta le immagini
delle costruzioni fatte dai bambini con i cubi. La costruzione che mette un cubo sopra l’altro arriva
al punto in cui l’ondeggiamento fa crollare, quel bambino si diverte proprio per quello. Ma se il suo
scopo è quello di elevare è evidente che deve progettare una base più ampia. Questo riporta anche a
quell’esperimento fatto con la scimmia che poteva servirsi di diverse cassette di legno da frutta per
raggiungere delle banane appese al soffitto, e la sua costruzione poteva essere organizzata o
disorganizzata. Nel caso fosse organizzata, la fatica dell’organizzazione veniva compensata dalla
possibilità di servirsi più volte delle banane che apparivano al soffitto, mentre, in una costruzione
disorganizzata, la meno fatica doveva poi essere pagata cara poiché le cassette si rompevano, la
condizione di agilità della scimmia consentiva qualche successo iniziale poi le possibilità si
riducevano perché con le cassette rotte non poteva più arrivare ad impilarle come avrebbe dovuto.
La sua stessa agilità contribuiva a fracassare delle cassette.
Questa è una metafora di un apprendimento senza fatica. La condizione dell’apprendimento è anche
quella di poter scoprire lo scenario su cui si organizza meglio, quindi l’evocazione, il mio
apprendimento ma poi non fermare la propria energia su quello ma allargare. Ed è lì che interviene
la necessità di incontro reale con gli altri, che pongono dei quesiti, che pongono delle condizioni,
per esempio di espressione. Il soggetto può aver capito molto bene una cosa ma se non sa
esprimerla agli altri risulta che la sua comprensione non è apprezzata. E quindi deve trovare le
modalità espressive utili perché arrivi la sua comprensione anche agli altri. E se la parola non gli è
molto facile può trovare dei sussidi nel disegno, nello schema, nella lavagna, tradizionale ma tanto
utile. E questo è un primo punto che va chiarito per illustrare come l’apprendere sia un’azione
individuale ma non solitaria.
1. 2. Non è semplice affrontare il tema della separazione. Non lo è per molte ragioni. Certamente
una è la ragione sentimentale, ma, in una relazione, il tema della separazione consente molte
interpretazioni di carattere terapeutico, e si può certamente sviluppare un percorso che porta ad
utilizzare parole come immagine fantasmatica, elaborazione del lutto, e molte altre che vanno verso
direzioni che non sono quelle che seguirò.
Io rimarrò al tema dell’apprendimento per considerare, molto brevemente, come la separazione sia
la fonte maggiore delle ragioni dell’apprendimento. E la separazione più radicale è quella della
morte. Nella vita di una persona che ha l’età di chi fa questa riflessione vi sono già state molte
morti. E viene il momento in cui una morte in particolare, come è accaduto per me, ha avuto più
netta la sensazione di una perdita che doveva essere compensata con il dovere dell’impegno di
apprendimento. In altre parole, la perdita non è rimpiazzabile sul piano umano, sul piano affettivo e
anche delle competenze, ma il dovere è quello di fare in modo che soprattutto queste ultime, le
competenze, nella loro scomparsa, siano riprese da chi rimane in termini di apprendimento. Non
sempre ci si riesce perché le intelligenze sono individuali. Ma vi sono degli aspetti che possono
essere ripresi con altri stili, con altre modalità, ma nello stesso segno. La scomparsa non consente
più di rivolgersi alla fonte di una competenza per poter avere indicazioni o poter avere prestazioni, e
bisogna riorganizzare la propria mente avendo già appreso qualche cosa e avanzando degli
apprendimenti.
Nel primo punto è già stata messa in moto una riflessione circa un isolamento accompagnato da un
insegnante che si dedica esclusivamente a un bambino o a una bambina. In quella logica la
separazione è considerata negativa: l’assenza per malattia, per maternità, il poco numero di ore
disponibile per seguire da vicino quel bambino, quella bambina, sono considerate negativamente. In
questa prospettiva il negativo può diventare positivo. La separazione esige che quel soggetto impari
quello che di solito è fatto insieme o da qualcun altro. La separazione può essere traumatica, e
questo non è certamente il senso di ciò che stiamo riflettendo, o può essere elaborata anche quando
fosse traumatica, in modo che non sia confermata nella sua negatività ma diventi occasione di
crescita degli apprendimenti. Sembra paradossale: la separazione sembra dire “tu da solo”, e noi
abbiamo detto, nel titolo di questa riflessione, che la solitudine non va bene ma l’azione individuale
sì. Allora, quella solitudine che si raggiunge con la separazione non è una vera solitudine. E’ la
possibilità
di
elaborare
un
accompagnamento
di
altro
livello,
in
cui
l’organizzazione
dell’apprendimento stesso diventa possibilità di considerare la presenza anche quando questa non è
fisicamente reale. Ma è reale nella mente, quindi non possiamo dire: “Una è presenza reale e l’altra
no!”. Fisicamente reale, mentalmente reale, e quindi con la possibilità e necessità di riferirsi ancora
ad altre presenze fisiche reali. In realtà non è più, quindi, solitudine ma è azione individuale. Può
darsi che sembri tutto un gioco di parole ma nell’organizzazione di questa riflessione estrapolare un
termine non è consentito, come non è mai consentito, e quindi il senso giustifica questa distinzione
fra azione individuale e azione solitaria, considerando l’azione individuale come quella in cui ci si
trova quando si apprende, ma non è un'azione solitaria perché questa è sterile per l’apprendimento.
E certamente la responsabilità educativa fa sì che un abbandono sia solitudine oppure azione
individuale, e quindi apprendimento.
II
RIDUZIONE DELL’HANDICAP
2.1 La qualità del tempo: policromia o monocromia
Immaginiamo la rappresentazione del tempo e della sua qualità con i colori e immaginiamo
come possa essere scombinata la vita di una persona, di una famiglia, dalla presenza di un evento
inatteso e nei confronti del quale si ritiene di non avere nessuna risorsa, nessuna preparazione,
quale può essere la nascita di un bambino o di una bambina con delle esigenze particolari dovute
a un deficit. Questa
situazione può rendere la vita, anziché una combinazione di colori, una
policromia perché è fatta di tanti elementi diversi tra loro che si combinano più o meno
armoniosamente, in una vita che ha solo un colore. Esempio: una vita tutta fatta di dedizione, di
oblatività. Questa situazione monocromatica è tanto più evidente quando la situazione di
handicap è grave, e gli elementi di quotidianità sono così costantemente bisognosi di una
presenza accanto a chi è handicappato, bambino o bambina, da costituire un vincolo e rendere
impossibile lo svolgimento di altri compiti talmente marginali da non essere neanche avvertiti
come presenze nella vita. Sembra quindi che vi siano delle riduzioni continue delle altre
possibilità che vengono allontanate, rese più difficili, sporadiche, acrobatiche, per concentrare
tutta la propria vita, la propria esistenza attorno alla vita e all'esistenza di un soggetto. Non è, è
evidente, solo l’aspetto materiale di vita quotidiana ma anche l’occupazione della mente. Vi
possono essere anche persone, familiari, che svolgono molti compiti professionali ma tutta la
loro vita mentale è occupata dalla presenza costante di quel figlio, di quella figlia, se sono
genitori, o di quell’individuo, se hanno altri rapporti sia di famiglia, sia di amicizia. Questo rende
importante capire quanto il tempo vada restituito a una policromia, e rende importante capire
quale sia il successo di quelle proposte che occupano, anche materialmente, il tempo delle
persone che vivono accanto a una persona handicappata, a un individuo handicappato, uomo o
donna, bambino o bambina, ed anche il tempo dell’individuo che ha delle esigenze particolari. Al
di là della comprensione di efficacia, vi sono delle suggestioni potenti che fanno aderire a una
proposta, quasi unicamente perché può qualificare il tempo. Ora è quasi evidente che il giudizio
relativo a certe proposte può essere anche negativo, ma non raggiunge il nucleo essenziale di
quelle stesse proposte. Sembra che vi sia la necessità di qualificare il tempo attraverso una
proposta che lo riempia di attività. Se poi vi è anche la speranza che queste attività abbiano un
valore abilitativo e terapeutico questo è un valore aggiunto ma non indispensabile.
Abbiamo l’impressione che a volte vi sia una necessità quasi fisiologica di avere qualcosa che
impegni il tempo. E allora se questo è un punto di partenza di una riflessione bisogna andare
oltre per capire come in presenza di una situazione di handicap sia importante ragionare per
restituire al tempo una qualità di policromia: restituire diversi colori. Certo, non abbiamo con
questo la possibilità di essere sicuri che i diversi colori armonizzino tra loro, che siano
organizzati in termini unitari e non dividano la vita in termini tali da frantumarla, per cui
dobbiamo aggiungere che la policromia va costruita insieme, non può essere dettata dall’esterno
ma fatta nascere da un progetto in cui l’individuo che è protagonista sia aiutato certamente, ma
faccia delle scelte. Questo individuo lo vogliamo concretizzare in una figura femminile, e ancora
di più in una madre – ma è un esempio e potremmo sostituirlo benissimo anche con una figura
maschile, e forse con un padre. Scegliamo una madre anche per un doveroso riconoscimento che
buona parte delle riflessioni sul tempo viene da donne. Personalmente credo di dovere molti
meriti a molte donne, ma mi conviene riassumere e attribuire un merito specifico a Matilde
Callari Galli che su questa questione del tempo delle donne ha molto riflettuto e aiutato altri a
riflettere. Un tempo monocromatico vuol dire, per quella figura che ho scelto come esempio, un
tempo tutto dedito alle operazioni quotidiane di assistenza a un figlio, a una figlia; nell’esempio
che facciamo è questo.
Già dicevamo della possibilità che questo tempo di dedizione sia qualificato da una proposta;
rimane un tempo tutto oblativo, quindi monocromatico, ma almeno organizzato in un percorso, o
tale si presenta. Nello stesso modo di proporre, però, vi sono a volte aspetti che vengono
sottovalutati, e che riguardano una possibilità che la proposta di un programma intenso, di
attività da svolgere quotidianamente, minuto per minuto, sia accompagnata da una spiegazione di
quelle che sono le condizioni che quel bambino, quella bambina, vive. A volte chi è del mestiere,
e ha una preparazione tecnica e scientifica, considera quelle spiegazioni molto superficiali se non
erronee, e non prende in considerazione l’aspetto che invece noi qui vogliamo esaminare: che in
quella proposta vi è anche una valorizzazione del potenziale cognitivo, detto in un gergo che può
essere anche fastidioso, della mamma presa nel nostro esempio. Anziché ritenerla una persona
senza una preparazione accademica e scientifica, e quindi incapace di comprendere la situazione,
quella proposta ha fatto in modo, forse superficialmente, forse erroneamente, ma noi qui
vogliamo trascurare questo aspetto, che quella persona fosse apprezzata per la sua possibilità di
comprensione anche intellettuale. Entra, in questo aspetto, una considerazione che già può essere
sviluppata per la nostra ipotesi di tempo a più colori. Possiamo fare, se siamo capaci, meglio di
quella proposta ipotizzata e allusa che fa riferimento a delle spiegazioni o erronee o comunque
semplificanti. Abbiamo una letteratura che ha alcune scritture, alcuni libri rivolti in particolare ai
familiari,
ai
genitori,
alle
mamme.
Questa
letteratura
può
essere,
a
grandi
linee
e
schematicamente, divisa in due settori: uno è un settore che chiameremo “demagogico” e l’altro
è un settore che chiameremo “dialogico”. Il settore demagogico ha delle semplificazioni
eccessive, ha la caratteristica di essere a-storico, descrive una situazione di bisogni particolari
come se fosse un dato, e non come elemento di una ricerca che ha avuto una sua storia e quindi
delle evoluzioni, delle capacità di essere espresso in termini diversi di quelli in cui vengono
espressi oggi. E’ a-storico, è a-problematico, è un genere letterario che si configura come
semplificatorio, riduttivo, e considera quindi i suoi lettori e le sue lettrici come delle persone
incapaci di sostenere il confronto con un’opera in cui vi siano delle parti da approfondire, perché
alla prima lettura sono oscure. Deve quindi svolgersi secondo una chiarezza artificiale. Una
seconda categoria di libri è dialogica. Considera quindi chi legge come persona che può
affrontare anche delle difficoltà, può non capire subito, ha bisogno di approfondire, ha bisogno di
collocare le conoscenze che riceve in una problematica non sempre precisa, ha bisogno anche di
incontrare i dubbi e di non avere delle posizioni trionfalistiche, sicure di sé. Nella categoria
demagogica dubbi non ve ne sono, si fa così, quindi la traduzione è: “tuo figlio, tua figlia, è, ed
ha bisogno di..”, tutto è molto semplice, sicuro, chiaro. Vi è una proposta, ed è quella che
funzionerà se tu la saprai far funzionare. Nell’altra letteratura, anche rivolta a chi è genitore, a
chi è mamma, vi è una linea di continuità con la letteratura scientifica che non si indirizza a
questi lettori. Vi è quindi una possibilità che quel libro permetta l’inizio di una riflessione più
ampia non necessariamente solo in termini scientifici ma anche in termini letterari, poetici,
storici, analogici; si può scoprire che la situazione di chi vive attorno a chi ha esigenze particolari
può essere analoga ad altre situazioni molto diverse, di altre popolazioni, di usi e costumi, ecc.
Vi è la possibilità che il tempo cominci a colorarsi e che accanto a una vita monocromatica, tutta
dedita all’assistenza vi sia anche una vita intellettuale, che a sua volta si apra in molte possibilità.
Forse si riscopre, o si scopre, qualcosa che permette di avere delle risorse non solo di
compensazione. La compensazione è necessaria: chi ha una sofferenza cerca, ed è umanamente
molto giusto, di compensarla con qualche gratificazione, con qualche compensazione; può essere
nella religiosità, può essere nell’attività sociale e politica. Non solo, però, compensazioni, non
solo, quindi, riequilibrio ma anche sviluppo, possibilità di procedere, di regalarsi delle
soddisfazioni non per restaurare l'ordine o per pareggiare i conti, ma per andare avanti. La
policromia, la colorazione del tempo è molto importante, e diventa anche un elemento di
comprensione di cosa può accadere qualora qualcuno ,in una posizione di generosità, certamente,
sottragga all’altro il dolore, la pena, l’afflizione; anziché entrare per collaborare alla costruzione
della policromia vi può essere una assunzione dell’afflizione dell’altro in termini che
generosamente sono: “ti tolgo l’afflizione”, ma che possono essere letti come: “mi togli l’unica
cosa che ho”: il vuoto di colore; anziché la monocromia, vi è una monocromia spenta; si spegne
anche l’unico colore che c’era, quella dedizione me la prendo io. Nel rapporto con chi vive la
situazione di handicap vi può
essere questa generosa proposta di assunzione totale
dell’afflizione: può essere rivolta a chi è direttamente protagonista, a chi ha dei bisogni
particolari; può essere rivolta a chi è vicino. La policromia è una proposta che serve a tutti, in
particolare a chi vive la situazione di handicap, sia perché è handicappato, è handicappata, sia
perchè vive accanto. Sottrarre il dolore, sottrarre l’afflizione è una logica molto presente nelle
persone generose, ma è una generosità poco costruttiva che rischia di degenerare in
assistenzialismo, e nell’assistenzialismo una presenza costante è quella di accentuare i bisogni o
moltiplicarli, per costringere l’altro ad occuparsi sempre della situazione. Quindi l’assunzione
dell’afflizione non è efficace, perché ve ne è sempre dell’altra. Questa è con tutta evidenza una
descrizione schematica; ciascuno la può articolare a seconda delle diverse realtà che vive. In
positivo noi dobbiamo riflettere sulla utilità di svolgere una azione che permetta la costruzione di
un policromia; la parola “policromia” può essere però anche sostituita dalla parola “policronia”, i
colori possono essere sostituti dal tempo: più tempi e non solo un tempo: il tempo dell’assistenza
ma anche il tempo dell’intelletto, il tempo della riflessione quindi anche la possibilità che nei più
tempi, nei diversi tempi, vi sia un’occupazione di ruoli diversi; in un tempo un soggetto è
protagonista, in un altro tempo è spettatore. E questo è un elemento importante perché a volte la
vita di chi ha dei bisogni particolari è ancorata a un solo ruolo, sempre spettatore, sempre
comparsa, oppure sempre protagonista. Il protagonismo di alcune persone handicappate è
evidente, così come è anche evidente, anche se meno imponente, si impone meno, il ruolo di
comparsa di tante altre persone handicappate. Occupare un solo ruolo vuol dire vivere una vita
vincolata a una sola posizione e quindi, a rappresentarla in un’immagine, fortemente anchilosata,
in cui è più facile che si sviluppino delle piaghe da decubito, in senso figurato e a volte anche in
senso reale, ma più spesso in senso figurato. Più spesso di quanto si creda. Diventa una vita che
appoggia sempre in un solo punto, mentre
la policromia, che diventa in questa descrizione
policronia, permettendo lo svilupparsi di diversi colori e in diversi tempi, permette anche di
cambiare ruolo, e quindi di avere una rappresentazione di sé variata, e di migliorare
l’apprendimento. Il cambiamento di ruolo permette di imparare, cioè di trasportare qualche cosa
da una posizione all’altra e alimentare le nostre riserve di apprendimenti.
2.2 Appartenenza: la lacerazione dell’appartenenza e la ricostruzione della stessa
La riflessione fatta sulla qualità del tempo può essere rifatta, quasi ripercorsa con lo stesso
pensiero, però con un’altra chiave di lettura che è quella dell’appartenenza. “Appartenenza” è un
termine che ha una particolare attualità dal momento che, nell’epoca in cui la parola
“globalizzazione” è diventata sempre più una realtà, vi sono anche delle forti tendenze a creare
delle appartenenze localistiche e quindi a rompere l’appartenenza a una società ampia per
individuare nella piccola patria il motivo di appartenenza. In alcuni casi questo ha sviluppato dei
frazionamenti tragici, che hanno comportato dei conflitti; la ex Jugoslavia non finisce di vivere
questa situazione. Anche dove la condizione non è tragica vi sono rivendicazioni localistiche per
attribuire all’appartenenza locale un primato e quindi per essere più portati a riconoscerci in chi
abita da tempo in un certo contesto e vedere in chi arriva da lontano un usurpatore, un invasore.
Il termine “appartenenza” sta prendendo un posto importante nella nostra riflessione. Vorremmo
capire quanto è importante sentirsi parte, e anche quanto è importante sentirsi parte del mondo,
non solo di una piccola zona.
L’appartenenza ridotta alla piccola zona facilmente sconfina nella xenofobia e nella conquista o
nella difesa di privilegi. Appartenenza al mondo, all’umanità. Vi sono momenti in cui si può
vivere una lacerazione dell’appartenenza, oppure si può nascere sentendosi come lacerati rispetto
all’appartenenza, ed è questo il caso di persone che noi definiamo handicappate, o delle persone
che vivono con lacerazione: si rompe un concetto e una realtà sedimentata; nasco handicappato
quindi faccio fatica ad appartenere, ad essere parte di un tutto, non vengo riconosciuto parte e ho
bisogno di ricostruire o costruire un’appartenenza, con il rischio di costruirla in una categoria.
La ricostruzione dell’appartenenza o la costruzione dell’appartenenza significa procedere a un
riconoscimento di elementi che sono comuni. A volte un eccesso di naturalismo banalizza gli
elementi comuni. Trovare il valore simbolico nella respirazione e nel battito del cuore può essere
un riscoprire qualcosa che è in tutti ed è tutt’altro che banale; e il valore simbolico è l’elemento
aggiunto dell’umanità rispetto alle bestie. Si potrebbe pensare che abbiamo molti elementi in
comune con le bestie. Ma il respiro fatto di pieni e di vuoti diventa un ritmo che può avere una
sua musicalità, essere sviluppato in una musicalità creativa, e questo il mio cane non lo saprà
fare; forse lo saprà riconoscere perché lo educherò a riconoscere il mio fischio che è la
modulazione di un ritmo. Da respiro a ritmo vi è un’aggiunta di creatività, di costruzione
simbolica a cui il mio cane si adegua e a cui contribuisce passivamente perché forse mi ispira,
ma non sa aggiungere altri elementi intellettivi. Non posso pensare che un soggetto gravemente
handicappato sia comparabile al cane perché, come il cane, non parla. L’assenza di parola non lo
fa appartenere agli animali che non parlano ma gli consente ancora di essere parte degli animali
parlanti, perché ha una potenzialità di accesso al linguaggio che rimane inalterata. I parlanti
possono essere anche "insegnanti", ovvero coloro che tra i sordi seguono il linguaggio dei segni.
Si può parlare attraverso gli ausilii. La parola non è unicamente quella che si emette vocalmente
ma anche quella che si rappresenta. Non abbiamo nessuna possibilità che il mio cane acceda alla
parola se non per addestramento riconoscendo alcune parole; il mio cane sapiente si può esibire
in un circo riconoscendo un certo numero di parole, ma è frutto di un addestramento e non è
generatore di linguaggio, e non aggiungerà una parola. Il concetto di appartenenza ha dei risvolti
molto pratici e la ricostruzione dell’appartenenza vuol dire ricostruire degli elementi primordiali
che permettono di riconoscerci appartenenti al genere umano. Questo può essere un contributo
fondamentale che le persone handicappate, che hanno esigenze particolari, possono dare al
nostro tempo così bisognoso di “ricapire”, o capire, originalmente, che cosa significa
appartenenza. Ma così bisognoso anche di vivere l’appartenenza, nella quotidianità, e non solo di
capirla nei momenti alti della nostra riflessione.
2.3 Una esclusione particolare: esclusione in categorie, esclusione mascherata
Già dicevamo come vi può essere un tentativo di superare la lacerazione dell’appartenenza
costruendo una appartenenza in una categoria ed escludendo la possibilità di appartenere a
qualcosa fuori da quella categoria. Bisogna intendersi: se io fossi un pensionato e mi sentissi
appartenere alla categoria dei pensionati questo avrebbe un significato più che tranquillo e
componibile nel fatto che io mi sento anche appartenente a un genere umano più ampio. E’
diverso se io caricassi l’appartenenza alla categoria dei pensionati di un significato di esclusione
dall’appartenenza al resto del genere umano, riconoscendomi unicamente in coloro che hanno
una certa età, che hanno avuto un’esperienza lavorativa in un certo settore e vivendo ostilmente
ogni altro contatto: è un’esclusione. Alcune appartenenze sono costrette a nascere nel segno
dell’esclusione. Vi è la possibilità che questa diventi un’appartenenza mascherata e che in realtà
tutta una categoria continui ad essere esclusa. In questo punto della riflessione è necessario fare
anche un riferimento a quella discriminazione positiva che consiste nel considerare una certa
categoria, ad esempio, gli invalidi, come protetta rispetto agli altri. E’ quasi banale dirlo: nel
mondo molte situazioni di protezione hanno consentito una esclusione altrettanto efficace di altre
esclusioni violente. In genere le categorie protette, come le riserve indiane, sono state protette
dopo essere state perseguitate e quindi sono i resti protetti. Questo appunto potrebbe permetterci
un approfondimento storico che è anche necessario individuare come pista di riflessione e di
lavoro. Qui ci preme però ricordare come la categorizzazione sia una maschera, e quindi come
tale sempre ricostruita, non tanto identificabile nelle forme che ha assunto in passato quanto
riscoprire nelle forme nuove, non sempre individuabili.
Diventa quindi un segnale, o una chiave di lettura, di situazioni che possono anche presentarsi ed
essere ispirate a dei criteri di integrazione, e quindi alla possibilità e alla speranza che vi sia
un’ampia appartenenza. Abbiamo una serie di dizioni che possono essere elencate, e ciascuno
potrebbe trovare che hanno un’esclusione mascherata oppure una possibilità di attuare
l’appartenenza. Si pensi alla dizione “laboratorio protetto” che per molti ha significato un
avanzamento nella possibilità di integrazione poi, a un certo punto, è stato avvertito invece come
un limite; ma che in un progetto potrebbe risultare ancora come un percorso, una parte di
percorso verso l’appartenenza. Si pensi alla dizione “terzo settore” ispirata a una necessità e a un
desiderio di creare delle possibilità di appartenenza ampia, con il rischio, però, che era presente
anche nel laboratorio protetto. Non vi sono proposte garantite a priori rispetto all’esclusione
mascherata, quindi a questo tipo di esclusione dall’appartenenza del tutto particolare che
esprimiamo nell’espressione semplificata “esclusione in categoria”.
2.4 La definizione di situazione di handicap
E’ venuto il momento di capire cosa si dice usando l’espressione “situazione di handicap”.
Probabilmente in una certa logica sarebbe stato necessario iniziare questa riflessione da questo
punto. Quello che ha trattenuto dal seguire un andamento di questo tipo e il non ricadere in una
modalità banalizzante. Posta a questo punto della riflessione la definizione “situazione di
handicap” dovrebbe essere già più chiara: non si parla unicamente di individuo che ha un deficit
ma del contesto in cui abitualmente vive il singolo individuo che ha dei bisogni particolari.
Parlare della situazione di handicap significa prendere in considerazione i diversi soggetti che
sono abitualmente collocati in questa situazione, e quindi anche dei familiari. Ancora si può dire
che il soggetto deficitario vive la situazione di handicap allo stesso modo di come vivono le
situazioni di handicap i suoi familiari e le persone che abitualmente risiedono o vivono con lui o
lei. E’ quindi necessario, riducendo l’handicap, affrontare tutta la situazione e non unicamente
gli aspetti legati al singolo che ha un deficit. Un processo riabilitativo, ad esempio, può
consentire l’applicazione di un trattamento tecnico relativo al soggetto, e deve però anche
prendere in considerazione la vita delle altre persone che vivono nel contesto. Questa definizione
di “situazione di handicap” permette di rileggere i punti precedenti nella logica di questo
intervento, cercando quali sono i modi per ridurre l’handicap. Allora si può riprendere la
questione relativa alla qualità del tempo, alla policromia, che sostituisca la monocromia, per
capire come questo sia un modo importante per ridurre l’handicap. Si può riprendere il tema
dell’appartenenza per capire come questo sia un elemento fondamentale della riduzione
dell’handicap
ed
ancora
riprendere
l’attenzione
alle
nuove
forme
di
esclusione
nelle
appartenenze categoriali per capire come anche questo sia un punto importante nella riduzione
dell’handicap. “Riduzione dell’handicap” è accompagnata da una ricerca di comprensione di ciò
che è l’elemento dato, cioè il deficit: l’elemento dato non può essere ridotto mentre tutti gli
elementi variabili, e sono da scoprire, possono essere ridotti. Abbiamo già visto come una
riduzione dell’handicap che sia operata in termini tali da non consentire la partecipazione a
questo sforzo possa rischiare di produrre nuovi handicap. La diminuzione dell’afflizione operata
da un agente totalmente esterno può ridurre sì l’afflizione ma provocare risentimento, cioè un
nuovo handicap. Ed è questo uno dei punti principali della necessità di collegare ogni intervento
tecnico ad una capacità di sviluppare l’attenzione partecipativa, la tensione partecipativa. E’
questa una delle buone ragioni per pensare che una diffusione delle informazioni non possa
sostituirsi alla struttura dialogica diffusa sul territorio. Vi possono essere molte buone occasioni
perché le tante persone che sono in qualche modo connesse alle situazioni di handicap abbiano
un miglioramento delle informazioni. Questo è un compito importante da assumere socialmente.
Questo non toglie la necessità di avere delle buone possibilità di incontro. L’elemento
partecipativo non può rimanere legato a dei mezzi freddi, va anche espresso e vissuto attraverso
degli incontri umanamente caldi. Su questo bisogna avere una riflessione operativa che comporti
un chiarimento sulle professioni che chiamiamo “di aiuto”. Ma prima di abbordare a
quest’ultimo punto della nostra riflessione conviene ancora esaminare l’aspetto della riduzione
dell’handicap legato proprio alla possibilità che vi siano maggiori informazioni diffuse e quindi
la possibilità che vi siano delle strutture che chiamiamo Centri di Documentazione, ben
organizzati e diffusi in una forma che riteniamo debba essere riferita alla dimensione provinciale.
Oltre a questo elemento di diffusione dell’informazione è importante sottolineare quanto sia
utile, nello specifico della scuola, permettere e favorire la qualità dell’integrazione nel curricolo,
vale a dire la possibilità che chi studia studi anche integrando alle aree disciplinari il tema del
deficit e dell’handicap e non lo consideri un elemento di benevolenza; un elemento di solidarietà
e una sfida cognitiva. Bisogna che chi è a scuola con un compagno, una compagna handicappata
abbia la possibilità di conoscere, cioè di studiare, quello che è l’aspetto scientifico, letterario,
artistico, relativo alla tematica del deficit – handicap a partire anche dallo specifico del
compagno, della compagna, cercando, e quasi scontato dirlo in questo contesto, di rispettare
l’altro e di sviluppare un livello di dignità nei confronti del tema e delle persone che lo vivono
con maggiore intensità.
Il quadro delle professioni di aiuto
Abbiamo già fatto riferimento a una necessità di chiarire quelle che sono le professioni definite
“di aiuto”. Non sono necessariamente le sole professioni che hanno a che fare con il deficit ma
riguardano l’arco di vita di ogni individuo. Nelle professioni di aiuto non vi sono unicamente
quei ruoli che entrano in contatto con un individuo quando vengono meno delle reti sociali
abituali, o quando insorgono dei problemi specifici. Sono professioni di aiuto quelle, e
soprattutto quelle, che entrano in rapporto con un bambino, una bambina, al momento che
frequenta un nido, una scuola dell’infanzia, un percorso scolastico, una polisportiva, ecc. Quindi
le professioni di aiuto sono quelle che permettono di sviluppare la propria crescita e la propria
vita per tutto l’arco della stessa. Vi sono poi delle specificità che riguardano i momenti o le
situazioni che esigono delle attenzioni particolari. Questa definizione delle professioni di aiuto,
come si può capire, è sufficientemente ampia da comprendere una quantità di professioni
sfumata verso quelle che hanno dei ruoli sociali senza avere un mandato specifico di aiuto. E’
quasi evidente che nella vita sociale la possibilità di vivere in una situazione in cui i negozi sono
presenti e hanno degli esercenti di una certa qualità umana permette di vivere meglio. La
possibilità di avere dei mezzi di trasporto pubblici decenti permette di vivere meglio. Queste,
quindi, sono figure sfumate. Tante altre professioni sono anche queste relative a un certo aiuto a
una qualità della vita. Ma il fuoco, cioè il nucleo centrale delle professioni di aiuto, sono quelle
che hanno a che fare con il binomio educazione-salute, per tutto l’arco della vita. E queste
professioni hanno in questo momento storico un quadro molto poco chiaro: poco chiaro il ruolo
degli educatori professionali in rapporto agli insegnanti, poco chiaro il rapporto tra riabilitatori e
volontariato. E’ quindi necessario ridefinire un quadro delle professioni di aiuto in cui sia
possibile individuare i percorsi formativi e i collegamenti, le connessioni, fra una professione e
l’altra. Questo oltre ad essere un elemento importante per il tema della riduzione dell’handicap
costituisce anche un elemento importante per il controllo e la qualificazione della spesa. Non
saremmo molto soddisfatti se ci fosse unicamente il controllo della spesa non accompagnato da
una qualificazione della spesa relativamente alle professioni di aiuto. Mancando un quadro è
complicato, se non impossibile, avere una definizione della finalità della spesa, e quindi una
qualificazione sua progressiva. Investire in un quadro sicuro significa poter poi avere delle
progressive riduzioni della spesa o comunque avere vantaggi tali da permettere delle forti
economie. E anche questa è una riduzione dell’handicap perché, lo abbiamo potuto constatare
vivendo questo problema, l’assenza del controllo della spesa può portare a delle ondate
favorevoli seguite poi da riflusso, e rendere il tutto molto precario. E’ questo il punto importante
della riduzione dell’handicap legato allo specifico del quadro delle professioni di aiuto: uscire da
una sensazione, che non è solo un sentimento ma è anche un dato, di precarietà, di provvisorietà:
quello che mi è offerto oggi è incerto che io me lo ritrovi domani. Un esempio: nella realtà in cui
opero sono presenti delle strutture specifiche che riguardano gli handicappati adulti. Sono state
indicate come Poli Handicap Adulti con una sintesi di vocaboli e di dizione che non è
perfettamente adeguata alla comprensione di ciò che fanno. Dovrebbe essere Poli per la
riduzione dell’handicap in persone adulte, ma diventa molto lungo e allora la sintesi è Polo
Handicap Adulti. E’ questa è una realtà importante perché permette di avere una struttura leggera
composta da non molti operatori capaci di connettere i diversi interventi e di seguire per un arco
di tempo molto ampio i soggetti che hanno delle esigenze particolari. Ma la sensazione che molte
persone che si rivolgono a questi servizi hanno è di avere a che fare con una struttura ai limiti del
provvisorio e sicura fino a un certo punto, con operatori che non sono sempre garantiti del
prosieguo del loro lavoro. Vi sono a volte cambiamenti dovuti al fatto che il contratto di un
operatore scade, o si è passati a regime con dei cambiamenti di personale; cambiamenti che non
sono stati bene illustrati e che quindi vengono capiti come conferma di grande provvisorietà. Il
riferimento al tema del quadro delle professioni di aiuto vuol dire rimboccarsi le maniche, per
ridurre questo handicap così grande che è la provvisorietà, la precarietà, per dare invece una
possibilità progressiva di certezze. Avere delle certezze è uno degli elementi fondamentali della
riduzione dell’handicap. Ed è per questo che il punto conclusivo fa riferimento alla parola
“quadro”, come a qualcosa che ha un insieme, che deve costituire un insieme in cui gli elementi
dinamici possono e devono sussistere: elementi di crescita, di maggiore precisazione, di
cambiamenti continui, ma all’interno di un quadro che da sicurezza di certezze.
Concludiamo con un nota inevitabile. Il tema “Riduzione dell’handicap” è enorme e quindi
abbiamo dovuto per forza scegliere alcuni dei punti su cui svolgere una certa riflessione. Lo
abbiamo fatto con la convinzione che siano punti nodali, che non siano esaustivi ma permettano
di irrigare un ampio territorio e di arrivare ad elementi più nascosti e forse importanti che a
prima vista non si scorgono. Questa è stata la scelta per affrontare un tema così vasto, così
importante ed anche, sia detto senza retorica, così appassionante.
III
LA RELAZIONE D’AIUTO: ASPETTI METODOLOGICI E OBIETTIVI
EDUCATIVI
3.1. Un modo di dire semplice per qualche cosa che forse non è sempre semplice
Le parole relazione d’aiuto sembrano raggiungere tutti con un significato chiaro, perché tutti
possano sapere cos’è una relazione e cos’è un aiuto. La relazione presume un qualche contatto che
già si aveva, o che si ha quando si entra in contatto. E l’aiuto presume che qualcuno ne abbia
bisogno e altri possa fornire risposta a quel bisogno. Questa semplicità è, per fortuna, reale, ed è in
molte delle nostre azioni quotidiane. Ma, sempre in molte delle nostre azioni quotidiane, vi sono
delle complicazioni che rendono queste parole così semplici la fonte di una necessità di riflessione
che non si esaurisce facilmente. In un incontro fra persone che, a vario titolo, riflettevano sulla
relazione d’aiuto, uno dei partecipanti, all’invito a fornire un ricordo di un aiuto ricevuto negli
ultimi tempi, ha raccontato come, trovandosi con una gomma sgonfia, in una notte invernale, nella
periferia di una città, si sia sentito in grande difficoltà, non avendo nessuna attitudine , né abitudine,
a cambiare la ruota della macchina. E mentre perplesso studiava la situazione, ha avuto l’aiuto di
qualcuno che si è fermato in auto e che era un immigrato del Nord Africa. Con molta semplicità e
disinvoltura ha capito le sue difficoltà, gli ha cambiato la ruota e si è allontanato senza pretendere
nulla di particolare. Una relazione d’aiuto svolta, chiusa e senza seguito, ma che ha permesso a una
persona in difficoltà di ritrovarsene fuori. Potremmo sciupare un piccolo episodio, caricandolo di
molta riflessione, e questo è sempre il rischio del minimalismo, che parte da piccoli episodi,
racconti di vita quotidiana su cui tentiamo di fare delle riflessioni più ampie. E, certo, il rischio di
sciupare c’è.
Val la pena, però, immaginare qualche cosa per capire di più come l’immigrato nordafricano si sia
trovata l’energia, per fermarsi ed aiutare, come abbia dovuto vincere una possibile immagine,
certamente stereotipata, che può essergli arrivata dai grandi mezzi di informazione, per cui un
nordafricano che si ferma in macchina in una zona deserta e periferica, di notte, non è rassicurante e
può provocare delle reazioni di panico anziché rassicurazioni di aiuto. Potremmo anche immaginare
che, proprio per quello, quell’individuo abbia desiderato fermarsi, aiutare e smentire uno stereotipo
di pericolo che l’immagine del nordafricano, nelle nostre periferie, si porta dietro. Quindi, possiamo
immaginare che, chi aiuta, in questo caso abbia voluto fare qualcosa per a sua volta essere aiutato,
ad uscire da uno stereotipo negativo.
Questa situazione può essere il motivo di riflessione per capire alcune delle dinamiche della
relazione di aiuto, che non esauriscono il tema, ma che sicuramente possono aiutare a capire
qualcosa.
Chi aiuta può trovare, nell’aiuto che dà, un aiuto. E non sembri, questo, un imbroglio di parole. E’
certamente qualcosa che accade quando chi aiuta si sente prigioniero di un’immagine che non è la
sua, come nel caso ipotizzabile del nordafricano del piccolo racconto. Vi è anche la possibilità che
chi aiuta abbia una storia da riscattare, anche personale; non solo, quindi, per rompere la gabbia di
uno stereotipo, ma anche per una vicenda personale; si trovi nella circostanza di potere finalmente
esprimere una propria statura diversa. Come si suol dire, crescere attraverso un’azione che non è
abituale. Queste sono le relazioni di aiuto straordinarie, sono quelle più vistose nella quotidianità,
ma anche al di là della quotidianità, nel panorama che coinvolge la grande informazione. E
diventano, poi, a tal punto straordinarie da creare anche dei piccoli miti. Possono anche essere
grandi miti.
Una delle figure più interessanti, utile a riflettere su questo aspetto della relazione d’aiuto è l’Abbé
Pierre. L’Abbé Pierre è noto a una certa generazione, mentre ai più giovani forse non è così
familiare, come fondatore dei Compagni di Emmaus, cioè di quell’iniziativa che ha raccolto
persone senza fissa dimora, ex detenuti, alcoolisti, aiutandoli a trovare un tetto, una casa, un riparo,
e nello stesso tempo costruendo un’attività, su suggerimento di alcuni degli stessi aiutati, di
“raccolta differenziata” dell’immondizia: il lavoro nelle discariche per raccogliere il ferro che vi
poteva essere, il cartone, il vetro, differenziare quello che veniva buttato, e cominciare a
valorizzarlo. Per una dinamica che diventa metafora, accadeva al materiale gettato quello che era
accaduto agli uomini, che stava accadendo alle persone: venivano gettate, e venivano riscattate. E
dimostravano di avere ancora un valore.
Nella biografia dell’Abbé Pierre vi sono buoni motivi per credere che la sua “vocazione” non fosse
così sintonica con gli ordini religiosi in cui era passata, e che avesse bisogno di trovarsi uno spazio
proprio e una sua collocazione dinamica molto più autonoma rispetto ad altri religiosi. Ed ecco che
la realizzazione di una forma di aiuto così importante, necessaria, come è Emmaus, dà la possibilità
a questo personaggio di grande carattere, di grande spessore, di liberarsi da alcuni, vincoli.
La Parigi del dopoguerra vive degli inverni di grande freddo, e le persone che hanno la possibilità di
viverli nelle case riscaldate non hanno tanti problemi. Ma sono numerose le persone che, invece,
vivono nelle condizioni della strada e hanno quindi dei rischi enormi. Il circolo vizioso “freddocattivo
vino-alcoolismo” prende molti di costoro, uomini e donne, persone che hanno
anagraficamente un’età giovane e che diventano rapidamente vecchi relitti. E l’Abbé Pierre lavora
con questi. Chiama, lancia degli appelli a tutta la società, diventando un elemento anche simbolico,
e nello stesso tempo molto operativo, nelle relazioni d’aiuto, facendo della sua persona un vero e
proprio mito delle relazioni d’aiuto, e costruendo: costruendo strutture, un’associazione, dei luoghi
che hanno una diffusione nel mondo, e permettendosi poi, in tarda età, anche delle dichiarazioni che
potrebbero
essere
dette,
eufemisticamente,
anticonformiste,
ma
che
per
alcuni
sono
malinconicamente il segno di una perdita di riferimento e di controllo sulla realtà. Ci riferiamo, alla
sua difesa d’ufficio di panflé antisemita, scritto da un vecchio filosofo, suo coetaneo, che non aveva
bisogno della sua difesa perché era da far cadere nell’oblio, non faceva onore né al vecchio filosofo,
né all’Abbé Pierre.
Ha scandalizzato, l’Abbé Pierre, per questo. E’ il segno di una dimensione “mitologica” che rischia
molto. Da l’impressione che la relazione d’aiuto possa in qualche modo, - non è l’accusa che
facciamo all’Abbé Pierre; ci serviamo dell’Abbé Pierre per riflettere sulle nostre condizioni –
sottrarre gli individui a valutazioni comuni, e mettersi al riparo da confronti, nel mito. In qualche
modo, chi diventa un personaggio simbolo nelle relazioni d’aiuto si può permettere quello che altri
non si possono permettere: si sottrae al confronto. Le relazioni d’aiuto hanno anche questo rischio:
chi aiuta può credere di avere delle ragioni che vanno al di là delle regole e delle ragioni comuni.
Può ritenere di avere tanti meriti e tanta sensibilità, o che quello che fa valga talmente da andare
oltre quelle che sono le convenzioni. E a volte è vero. Si può anche ritenere che questo sia un
elemento da pagare, che sia un anticonformismo eroico, e che sia quindi un’avanguardia su una
pigrizia storica di altri.
Le relazioni di aiuto eccezionali, quando hanno bisogno di essere ripetute sistematicamente,
interpellano una società che non sa assumere le relazioni d’aiuto come un’ordinaria necessità.
Dovrebbe provvedere non più attraverso l’eccezionalità, ma attraverso l’organizzazione e le
competenze. Consideriamo che “la logica dell’emergenza” è anche la logica dell’eccezionalità.
Nelle relazioni d’aiuto ci si consente tutto perché sembra necessario. Chi vede qualcuno che sta
affogando non si domanda: “Sono il bagnino autorizzato a fare opera di salvataggio?”, ma se sa
nuotare si butta e salva. Così, se vede delle persone che hanno delle ferite e devono essere curate
non si domanda: “Sono abilitato a curare?, Sono infermiere?, Sono dottore?”, ma cerca di fare il
possibile per fare azione infermieristica e azione sanitaria. Negli incidenti, l’emergenza va oltre
quelle che sono le competenze stabilite. Tutti possono diventare protagonisti di relazioni d’aiuto.
Protagonisti: parola importante che può fare avviare una deriva pericolosa. Chi è stato protagonista
un giorno fa fatica a ritornare fra le comparse, il giorno dopo. Può far fatica, ma non è detto. Questo
è un tipo di relazione d’aiuto che ci permette di intravedere alcune delle piccole e grandi
complicazioni che si possono nascondere dietro a parole semplici. Ma ci sono altre complicazioni.
Le complicazioni sono legate al fatto, presenti nella storia odierna, che le relazioni di aiuto hanno
bisogno di un tessuto consolidato per essere vissute nella quotidianità. Prendiamo due situazioni che
incontrano un elemento per cui occorra chiedere aiuto. Si tratta di due persone, di età adulta, che si
trovano a vivere l’esperienza di sofferenza per tumore. Una vive in una rete sociale molto solida, in
cui gli elementi della vita di lavoro, della vita di vicinato, di parentele, sono molto solidamente
intrecciati e sfumati l’uno nell’altro. E il periodo del tumore diventa un rinsaldare vincoli già
presenti e vivere intense relazioni di aiuto che si appoggiano su relazioni già precedentemente molto
solide. L’altra persona ha invece avuto un lungo periodo di lavoro che l’ha portata fuori dal contesto
in cui abita, e si ritrova a ritornarvi essendo poco conosciuto dal vicinato, e anche dai parenti che
pure ha. Dal momento in cui appare il tumore, devono essere riprese delle relazioni che si
intensificano a causa proprio del tumore e che erano molto allentate precedentemente.
E’ facile capire che nella prima situazione le relazioni di aiuto sono molto più vitali e capaci di
rapportarsi all’interezza della persona. Nella seconda situazione è facile anche capire che le
relazioni di aiuto si stanno orientando a prendere in considerazione quella persona ammalata, quindi
non collegando la sua vita precedente di persona sana con la presenza del tumore. E’ evidente che
l’irruzione di una malattia grave o di altri eventi, in una vita, fanno cambiare la persona stessa. Ma
non c’è una metamorfosi assoluta, bensì una dimensione nuova in qualcosa di già presente. Se
l’individuo è conosciuto, se la rete di amicizia, la rete sociale, era già viva si intensificano dei
legami già presenti con molta intensità. Diversamente c’è qualche rischio in più. Ed è lì, allora, che
si ha bisogno di fare una riflessione di tipo più professionale. C’è bisogno che, allora, i
professionisti, in questo caso i professionisti della medicina e della terapia, tengano conto di queste
differenze; evitino di trattare neutralmente le situazioni senza rendersi conto del contesto in cui
queste situazioni vivono, e ancor più della storia del contesto.
Questi sono gli elementi su cui bisogna cominciare a riflettere in rapporto alle qualità
metodologiche professionali, e non più alla buona volontà, perché non basta. Ci vuole qualcosa di
più: uscire della buona volontà portandosi dietro tutto quello che la buona volontà ha di positivo,
ma andando oltre, e considerando quegli aspetti che una parola dovrebbe richiamare. Il termine è
clinico. Molte volte il termine clinico è stato usato più per indicare un luogo specialistico in cui
ricoverare, ma la sua etimologia ci porta a parlare del luogo in cui vive un individuo. Vive nel
contesto in cui la vita si svolge. Un’attività clinica dovrebbe essere un’attività che si svolge andando
verso il contesto in cui l’individuo, di cui si prende cura il professionista, vive. Per qualche
misteriosa trasformazione paradossale, invece, il termine clinico è diventato proprio il contrario:
trasportare da un contesto e ricoverare in una clinica. Questa paradossalità va esplorata per capire
cosa ha voluto dire e perché si è verificato questo.
Per certi versi le intenzioni, leggibili dentro al cambiamento di significato, possono essere anche
riportate a una visione positiva, che era quella di sottrarre alla disattenzione qualcuno che aveva
bisogno di cure particolari, quindi di permettere che le richieste di una situazione potessero essere
tenute più in considerazione, in un luogo organizzato, e non lasciate in un luogo che poteva essere
caratterizzato da molti rischi. Quindi le intenzioni potevano essere anche le migliori, per aver
trasformato il termine clinico in un senso così diverso dal suo significato etimologico originale.
Però il rischio è stato quello di far prevalere l’organizzazione del luogo rispetto ai bisogni
dell’individuo, e quindi a far diventare la clinica un luogo organizzato, a prescindere da chi vi
arriva, che deve conformarsi, deve stare agli orari, all’organizzazione, all’alimentazione, ecc. ecc.
Questo è proprio il rischio della relazione d’aiuto. Le professioni della relazione d’aiuto hanno
la necessità di essere, e quindi di avere una data conoscenza, professioni; ed hanno un rischio,
paradossale, che è quello di permettersi una disinvoltura che proprio la professione rende
possibile.
Vi è però anche un altro rischio, che deve essere assunto da una buona metodologia: quello
dell’eccesso di ascolto. E’ un elemento particolarmente evidente nella prevalenza data ai grandi
mezzi di comunicazione, alla esibizione del proprio bisogno di aiuto, e quindi nella organizzazione
di un ascolto che si trasforma in audience, parola che fa parte di un gergo e che trasforma, appunto,
quello che può essere un rapporto, una relazione, in uno sfruttamento. Non ha una difesa facile da
parte delle professioni, che possono cominciare a far prevalere un atteggiamento di ascolto
sull’intreccio che dovrebbe esserci tra ascolto per aiutare. Ne può nascere, diciamolo in termini
molto schematici, una sorta di divisione del lavoro per cui vi sono delle metodologie improntate
esclusivamente all’ascolto, che però possono avere come effetto quello di fare andare con più forza
verso altre metodologie più pragmaticamente ancorate al fornire aiuto senza ascoltare. E’ tipico di
certe situazioni in cui i cambiamenti sono avvenuti all’interno di una dinamica personale che aveva
certamente scoperto una fragilità, aveva individuato in una certa attenzione, basata sull’ascolto, la
possibilità di uscire da quella difficoltà, e si è ritrovata invece a vivere sempre più faticosamente la
difficoltà, e senza uscirne, e improvvisamente ha scoperto, ad esempio, gli psicofarmaci, cioè una
soluzione ritenuta istantaneamente e clinicamente capace, di risolvere la situazione. Ci può essere
anche il contrario: un’assunzione di psicofarmaci che va verso una incapacità di liberarsene per
cercare chi sia capace solo di ascolto.
E’ questa divisione del lavoro che rende difficile la carica complessa della relazione d’aiuto. La
semplificazione può essere una mistificazione. Bisogna tenere insieme diverse dimensioni e bisogna
sapere che il rischio maggiore della relazione di aiuto è quella di perpetuare la necessità di aiuto, e
quindi di raffigurare l’uscita dall’aiuto in termini che sono irrealistici per quella persona, che non
fanno uscire quella persona dall’aiuto ma la pongono sempre in confronto a perfezionismi, a ideali,
a immagini che sono al di là delle possibilità raggiungibili. A volte l’atteggiamento giusto è proprio
quello di porre dei traguardi molto avanzati, ma delineando anche i gradini dell’”un po’”. Tutto si
potrebbe fare, ma cominciando dal “fare un po’”.
Fare: parola che ha un evidente impasto pragmatico, collegato al bisogno proprio di realizzare
qualche cosa. Fare significa cominciare a muovere un passo. Nelle relazioni d’aiuto che
individuiamo come particolarmente interessanti per la formazione di una modalità professionale,
abbiamo l’esempio di qualcuno che professionista non era ma che di professionisti, forse, ne ha
incontrati molti. E’ il mitico Bill che è all’origine della realtà degli Alcoolisti Anonimi, e quindi di
tutte le forme di autoaiuto che sono nate da quella straordinaria esperienza, individuando un
percorso fatto di “passi”, in cui il tutto è presente come orizzonte ultimo, ma ha bisogno di essere
messo nei passi che ciascuno sta facendo. E quindi ha bisogno di sentire che un passo è un valore, e
non il raggiungimento dell’orizzonte è l’unico valore.
E’ una relativizzazione, qualcuno potrebbe dire. Questo è un termine che è vissuto come qualche
cosa di sbagliato, “Non bisogna relativizzare” si dice. E’ una relativizzazione, certamente, ma è
rendere possibile un percorso, e quindi è la liberazione da un atteggiamento di totale dipendenza da
qualcuno o da qualcosa, per cominciare a pensare in termini di dipendenza che consente l’autoaiuto,
e non di falsa indipendenza. Dipendenza: un soggetto dipende dalla sua fragilità nei confronti
dell’alcool, della droga, nei confronti del gioco d’azzardo, nei confronti dell’incapacità di assumere
il deficit è. Comincia ad elaborare la dipendenza, paradossalmente, come forza che consente di fare
un passo, e poi un altro. Nel settore più specifico di mia maggiore pratica, e quindi di qualche
competenza, che è quello delle situazioni di handicap, si può immaginare che certe forme
associative abbiano formato, non come obiettivo primario ma come elemento indotto, delle
organizzazioni di autoaiuto, cominciando a sentire il bisogno di capire il percorso attraverso i passi
da fare, uno dopo l’altro, e non unicamente attraverso quell’orizzonte assoluto della liberazione
totale: la conquista di una maggiore disinvoltura nei confronti del proprio deficit, o del deficit del
proprio figlio, della propria figlia, del proprio congiunto.
La necessità è quella di capire la costante dipendenza che si ha, con la possibilità che l’accettazione
della dipendenza sia il muovere il primo passo. E’ il primo passo dei dodici ipotizzati dai gruppi di
autoaiuto, e che permettono di avanzare in rapporto anche ad altri, non più in rapporto alla diade io
e lo specialista, un soggetto debole e l’altro forte, ma in rapporto ad altri deboli, che sono diversi
ma che hanno in comune proprio la dipendenza. Questo del gruppo di autoaiuto è uno degli
elementi più interessanti da esplorare per capire come far propria una metodologia di autoaiuto di
chi, professionista, dovrebbe ritenersi assolutamente fuori dalla debolezza di coloro che sono parte
del gruppo di autoaiuto. Chi fa una professione per cui non ha vissuto in prima persona
l’alcoolismo, ma ha trattato gli alcoolisti, sembrerebbe non essere nella necessità di rivolgersi agli
stessi alcoolisti per apprendere delle tecniche d’aiuto. Invece è così. Invece, questa dimensione
dell’autoaiuto si rivela feconda, si è già rivelata tale, proprio anche nel riverbero che ha dato a
coloro che svolgono delle professioni di aiuto.
Il quadro delle professioni di aiuto è cambiato, in questo senso, perché ha messo in moto delle
dinamiche interessanti, di complementarietà e non più di assoluto. Anche su questi aspetti si arriva
al relativo: “io sono specialista, ma sono sempre relativamente specialista perfezionabile con
l’incontro di colui che mi chiede aiuto”.
La dinamica dell’aiuto diventa importante per fare uscire dalla condizione di vittima, e quindi per
tenere sotto controllo la tentazione di trasformare la condizione di vittima in vittimismo, cioè in una
situazione in cui si comincia ad apprezzare il fatto che la condizione di vittima fornisce qualche
privilegio non cambiabile con altri ipotetici, e non certi, vantaggi che potrebbero essere all’uscita
della condizione stessa di vittima.
Questa è una situazione che si ingarbuglia quando si sviluppa in climi familiari, e vi sono ruoli
familiari che vanno a “parlare per…”, e quindi chiedono aiuto per altri, che hanno bisogno di essere
aiutati, ma sembrerebbero non avere la forza di domandare. Si innestano dinamiche complicate, per
interposte persone, e il professionista ha bisogno di ascoltare chi parla al posto di un altro, e nello
stesso tempo deve stare attento a non diventare una variabile dipendente da chi parla al posto di…
Sono relazioni complicate, complesse, in cui la formula più importante è proprio ancora quella
dell’autoaiuto: “Tu mi dici qualcosa che rivela la necessità di creare una dinamica di autoaiuto, e
quindi di fare in modo che chi ha più bisogno diventi anche protagonista del suo aiuto, non solo
colui nei confronti del quale si eroga l’aiuto. E’ la cosa più difficile, se la si dice, e diventa più
semplice quando la si pratica. Perché è evidente che molte delle attività che si svolgono all’interno
delle relazioni di aiuto fanno parte di quelle che spesso, nelle riflessioni svolte su questo tema,
vengono indicate come pratiche non discorsive: qualcosa che ha un suo svolgimento nelle
quotidianità pratiche, e che può essere certamente anche espresso anche in parole, raccontato, e
indicato, sapendo bene che le parole trasferiscono una parte minima, perché il più rimane proprio
nelle prassi.
Le relazioni d’aiuto sono costituite in gran parte di pratiche non discorsive, ed è in queste pratiche,
appunto, che quelle che sembrano, e sono, grandi difficoltà, rischi continui, si sciolgono
maggiormente. La conclusione non può che essere dunque quella che chi è professionista non può
fare della sua professionalità un motivo per sottrarsi alle pratiche che sono insite nelle relazioni
d’aiuto.
3. 2. Raggiungere l’altro là dove è arrivato
La relazione d’aiuto contiene alcuni elementi di difficoltà quando ha origine da un fatto tragico o
comunque traumatico. Le difficoltà possono essere insite nella stessa causa che ha determinato il
fatto traumatico: un incidente, un evento che interrompe un decorso, e può essere la nascita di una
situazione non prevista. Ma, oltre a questo, vi sono degli elementi che fanno ritenere più difficile
svolgere una relazione d’aiuto, proprio perché il rapporto può essere unicamente fissato sulle
deficienze, sulle calamità. Questo è quanto accade quando vi sono aiuti che nascono da eventi
calamitosi. E’ accaduto per la guerra della ex Jugoslavia, e può accadere per molte altre situazioni
di cosiddette cause naturali.
Chi aiuta incontra l’altro nel dolore, nella sofferenza, nelle difficoltà, e a volte non sa nulla di quella
che era la sua vita precedente. Il rischio maggiore, dunque, è quello di fissare l’altro nell’immagine
che si incontra nel momento dell’aiuto. Perché questo è un rischio? Perché contiene implicitamente
una sorta di amputazione di quelle che erano le dinamiche precedenti della vita dell’altro, e la
possibilità che nasca da quel momento un desiderio di assimilazione, non di raggiungere il
superamento della difficoltà nella propria normalità, piuttosto nella normalità di chi aiuta. Certo,
questo non può avvenire sempre nei termini così schematici, come lo stiamo profilando, proprio
perché l’uscita dalla situazione di difficoltà può consentire all’altro la ripresa dei suoi elementi di
volontà, e quindi il collegamento con la sua storia. Il vittimismo è però in agguato. La possibilità di
consentire il volere di chi aiuta, ritenendolo necessario per mantenere gli aiuti, è il rischio maggiore
che si corre in questa situazione. Quando poi è una situazione che non ha dei singoli come
protagonisti ma intere popolazioni, si può con molta facilità arrivare a cancellare la pluralità che è
all’interno di una comunità nazionale, o comunque territoriale, per rinchiuderla in uno stereotipo
unico. E allora si comincia a delineare la tipologia molto pericolosa etnica o etnoculturale,. Sempre
la ex Jugoslavia può essere il motivo di riflessione per capire quali sono le difficoltà delle relazioni
d’aiuto, a questo livello.
Ma per cercare di collegare situazioni così vaste a episodi e a vicende molto più minute, può essere
interessante riflettere sulla qualità, e quindi l’efficacia, della riabilitazione, quando essa può tenere
conto di quelle che sono le caratteristiche del soggetto, precedentemente all’evento traumatico. Un
caso è rimasto, nella letteratura, abbastanza interessante e per certi versi unico per le caratteristiche
del soggetto che ha vissuto l’evento traumatico. Si tratta del caso di un disegnatore, il quale per un
incidente visse un trauma che gli procurò la perdita del linguaggio. Sabadel è un disegnatore
conosciuto nell’ambiente, e le sue disgrazie cominciarono dal momento in cui, in vacanza, ebbe un
trauma per un incidente. Fu ospedalizzato e si ritrovò incapace di usare il linguaggio, quindi afasico,
in una situazione che, apparentemente, gli impediva anche di organizzare dei processi logici.. Il
tentativo della rieducazione linguistica fu sviluppato attraverso una concessione, una prassi
inconsueta, dovuta alla conoscenza delle caratteristiche di Sabadel. L’ortofonista, o logopedista,
apparentemente abbandonò la rieducazione fonologica mettendo a disposizione del paziente fogli di
carta bianchi, e di colore, e una certa quantità di pastelli, matite, pennarelli, che consentissero la
scelta dello strumento più morbido o più duro, più adatto alla sua espressione grafica. La
rieducazione linguistica, paradossalmente, cominciò non dalla parola ma dal tratto grafico.
La documentazione del percorso riabilitativo è assai intelligente e interessante perché Sabadel
arrivò a ricostruire col segno grafico quello che era accaduto alla sua testa, al suo cervello. Arrivò a
disegnare una figura con una testa dimezzata, in cui una parte era molto ben raffigurata, mentre
l’altra non c’era, per poi passare ad una testa aperta da cui erano scappati fuori tanti omini, come se
fossero le parole, trasformate ciascuna con la sembianza di un individuo, e che erano scappate
chissà dove. E poi questi omini ritornavano. Ma le sequenze dei disegni sono molto più lente di
quanto dice la ricostruzione, anche perché gli omini-parole uscivano e entravano, quasi fossero
incerti se abitare il cervello oppure lasciarlo vuoto. E la ricostruzione del cervello avvenne
attraverso una serie di disegni che erano anche il tormento di qualcosa che sembrava non essere più
proprio, ma che piano piano si poteva invece riorganizzare nell’ambito della propria identità.
Parallelamente alla precisione del disegno e alla nitidezza di una ricostruzione che il disegno voleva
sempre più completa riapparivano anche i fonemi, l’organizzazione del linguaggio e, poco dopo,
con la capacità di padroneggiare la figura umana e di completare il percorso di riambientamento
della sua testa, Sabadel poteva riprendere a parlare.
Questa documentazione è straodinariamente interessante e ci può dimostrare qualcosa che non ha
una specificità straordinaria e irripetibile, ma che può essere ripetuta, ed è di fatto ripetuta, tutte le
volte che la relazione d’aiuto non si chiude a una tecnica senza riconoscere la dinamica storica
personale dell’altro, ma riesce ad individuare il collegamento fra la proposta tecnica, che ci deve
essere, e senza la quale non si può procedere, e la vita dell’altro con le sue caratteristiche. Non è
sempre facile, anzi, si può dire che è l’aspetto più difficile delle relazioni d’aiuto, perché il pronto
intervento non consente il tempo della conoscenza dell’altro. Però è possibile. Non nella nitidezza
del percorso compiuto dal caso Sabadel, ma nel rapporto che può venire attraverso i gesti, attraverso
i segni dello sguardo, e le possibilità di curare con molta attenzione l’organizzazione della
quotidianità. Non sempre questo è possibile. Evocando gli aiuti alle popolazioni che hanno
complessivamente
vissuto
degli
eventi
drammatici
che
possono
essere
guerre,
terremoti,
inquinamenti atmosferici, alluvioni, si capisce bene come si giocano le relazioni d’aiuto in
situazioni che sono quantomai disordinate, catastrofiche, e in cui proprio la quotidianità subisce dei
duri attacchi. Lo stesso momento del cibo, che potrebbe essere il segnalatore di molti elementi
caratteristici della vita dell’altro incontrato in quel momento, diventa un momento particolarmente
caotico, complicato. Però la situazione di emergenza dovrebbe finire, e nella situazione di normalità
dovrebbero essere possibili le letture dei segni che permettano di riallacciare l’intervento di
emergenza e l’aiuto che in quel momento si è dato, alla precedente storia di quella popolazione e dei
suoi individui, nella loro molteplicità. Dovrebbe riaprirsi la molteplicità degli individui, e aprire,
quindi, la possibilità di non avere unicamente l’aiuto ma di avere anche una vita propria, privata,
non esibita, in cui l’invadenza non è ammessa.
Nella relazione di aiuto un altro dei punti delicati è quello che riguarda la necessità di non essere dei
profittatori della situazione, invadendo il privato dell’altro. E’ necessario poter mantenere una
riservatezza. Chi aiuta deve sapere che un suo compito consiste nel proteggere l’altro da una troppo
rapida messa a disposizione di tutto quello che è il suo spazio intimo. Per essere aiutato, una
persona può veramente sacrificare tutto; è chi aiuta che deve sapersi fermare, saper rispettare o
sapere che anche quell’invasione che è stato costretto a fare dell’intimità dell’altro deve essere poi,
in qualche modo, circoscritta e ritenuta eccezionale, per riprendere una possibilità di vita propria
distinta dalla vita comune. Queste situazioni sono sicuramente sotto gli occhi di tutti, e quindi
hanno una possibilità di avere una riflessione molto più ampia e completa di quella che altre
situazioni di cura non rendono possibile. Le psicoterapie, a volte, sono un fatto del tutto privato che
nessuno conosce, mentre gli aiuti evocati da questa riflessione sono sotto gli occhi di tutti. E qui vi è
l’altra ben nota deriva possibile, che è verso la spettacolarizzazione e verso la complicazione
dell’attivismo d’aiuto, che non consente più riflessione, per cui chi aiuta ha una sorta di frenesia di
aiutare, senza più avere una possibilità di riprendere un tempo di riflessione, per capire quanto sia
stato possibile uscire dall’aiuto e dall’emergenza.
Vi sono regole che possono costruire un vero e proprio piccolo percorso di prassi delle relazioni
d’aiuto. Una fondamentale è quella che nelle relazioni d’aiuto nessuno deve uscire sconfitto. Se si è
in una relazione d’aiuto non possiamo assumere il tono e la volontà di vedere l’altro sconfitto, cioè
di arrivare a determinare il torto dell’altro. L’aiuto esige che tutti possano avere la loro parte di
ragione. Questo è molto interessante se riportato a quelle che sono, ormai, le offerte di cure
alternative, molto divulgate e che introducono, a volte, nella situazione d’aiuto un elemento che
porta a situazioni quasi da tifo sportivo, per cui bisogna essere pro o contro una certa cura. Si pensi
al fenomeno molto divulgato dai grandi mezzi di informazione del caso Di Bella, in cui si rischiava,
e si rischia tuttora, di perdere di vista la relazione d’aiuto per determinare esaltazioni di un metodo,
oppure accanimento contro lo stesso metodo. Analoga situazione avvenne al tempo in cui San
Patrignano e il suo fondatore, Muccioli, erano agli onori della cronaca: si rischiava continuamente
di perdere di vista la regola aurea della relazione d’aiuto per determinare la volontà di mandare
qualcuno a casa sconfitto, giudicato perdente, oppure vincente, a seconda se si era a favore o contro
il metodo. E’ vero che certe situazioni di “protagonismo degli inventori” di un metodo hanno come
conseguenza proprio questa organizzazione da fanatismo. Ma sta a noi riprendere il tono più adatto
e più giusto, in cui si devono collocare queste situazioni, che è quello delle situazioni d’aiuto in cui
nessuno deve andare via sconfitto.
Nelle riabilitazioni di soggetti handicappati è presente qualche proposta che rischia sempre di
mettere in atto delle dinamiche da sette o da tifo sportivo. La nostra professionalità si gioca sulla
possibilità di capire il perché una certa proposta viene accettata, e questo non è solo per la proposta
in sé quanto per gli elementi che induce e che apre, di contorno, e che, per chi vive una situazione di
handicap, possono essere fondamentali. Può essere, per esempio, la possibilità di avere un certo
numero di volontari, che aiutano, entrano in casa, tolgono dalla solitudine; e quindi di ricostruire
quella rete, che all’inizio della nostra riflessione avevamo indicato come fondamentale. La rete
sociale sembra sparire, lasciando il vuoto attorno. La proposta riabilitativa ha l’effetto di
sembrare ricostruirla. Se non si capiscono questi elementi complessi, mettendosi nei panni
dell’altro, si arriva facilmente a rompere la regola della necessità di non mandar nessuno via
sconfitto. E si arriva a considerare l’altro come a uno che ha torto, a cui si deve dare torto, in nome
della scienza. La scienza, con la relazione d’aiuto, ha necessità di fare alleanze precise, che sono
proprio in questa regola: conoscere molto bene la realtà, e non solo un suo aspetto.
Un secondo elemento importante, una seconda regola, è quello di ritenere utile non perpetuare la
relazione d’aiuto con una divisione di ruoli, “chi aiuta” e “chi è aiutato”, ma cercare di aprire
quanto prima possibile una dinamica di rovesciamento dei ruoli o di apertura a terze situazioni, che
permettono a chi è aiutato, a sua volta di aiutare. L’abbiamo già trovata, questa situazione e questa
regola, negli esempi dei gruppi di autoaiuto.
La terza regola è quella di non pensare che un aiuto possa diventare l’aiuto. L’universalismo
dell’aiuto non esiste. L’assoluto dell’aiuto può essere la più grande violenza che si possa
commettere, anche perché sembra, può sembrare, un’aureola, e quindi una semplificazione, mentre
l’aiuto non esiste ed esistono gli aiuti, sempre rapportabili a contesti. Abbiamo già fatto riferimento
a questa necessità di un relativismo, che non ha possibilità di essere negativo. Come tutte le parole
ha una polisemia: in questo caso, il significato è positivo, e dobbiamo fare che sia positivo. Perché
la pericolosità dell’assolutizzazione di un aiuto è insita in tante le violenze che possiamo leggere,
anche attraverso questa chiave di lettura.
Infine, la regola che per questa riflessione consideriamo conclusiva, è quella del realismo. Realismo
significa considerare la realtà dell’altro. Nella realtà c’è certamente la possibilità di una crescita, di
una dinamica; ma crescita e sviluppo compatibili, quindi capaci di trovare nelle proprie risorse la
possibilità progressiva, e non nelle risorse di altri, forse dei salvatori. Imporre dei modelli attraverso
gli aiuti è un elemento di violenza. Su questo punto è utile, però, fare un’ulteriore piccola riflessione
che riguarda la possibilità che, uscendo dai ruoli rigidi di chi aiuta e chi è aiutato vi sia una certa
confusione feconda, che permetta di avere delle commistioni, e quindi di mettere qualche cosa nella
vita degli altri lasciando, però, che qualche cosa della vita degli altri entri nella nostra. Questo è
l’elemento più interessante di chi ha delle esperienze d’aiuto ed è quello che compensa, a volte, di
una certa fatica. Scoprire che l’altro, che poteva essere percepito unicamente come individuo da
aiutare, ha capacità di aiutare: invece di essere solo aiutato diventa anche aiutante. E’ qualcosa che
noi dovremmo ricordare e riprendere sempre a proposito di quel filone della Pedagogia che si
chiama Pedagogia Istituzionale, in cui il punto più delicato è quello di non isolare mai l’elemento
istituzionale solo nell’istituito, ma di permettere sempre un’apertura all’istituente. Ed è questa la
carta vincente della dimensione educativa, senza la quale si ha un’imposizione d’aiuto, e non una
relazione d’aiuto.
NOTA BIBLIOGRAFICA
Alcolisti Anonimi,A.A. Alcolisti Anonimi, Roma, 1991.
SABADEL, L’homme qui ne savait plus parler, Nouvelles éditions Baudinière, Millau, 1980.
IV
AIUTARSI AD IMPARARE
4.1. Una classe come gruppo di auto-aiuto
Proviamo ad immaginare che una classe abbia le stesse caratteristiche di un gruppo di auto-aiuto. La
prima cosa è capire meglio che cosa significa essere un gruppo di auto-aiuto. L’esperienza più nota
dei gruppi di auto-aiuto è quella degli alcoolisti anonimi. Il mitico fondatore degli alcoolisti
anonimi è stato Bill, l’alcoolista. Quindi non uno specialista, ma qualcuno che, vivendo una vera e
propria tragedia personale, capì quanto poteva essere utile incontrare altre persone che avevano lo
stesso bisogno, perché vivevano analoghe tragedie. e come potesse essere importante iniziare un
percorso, che divenne poi organizzato in dodici tappe, a partire dal riconoscimento di una propria
incapacità ad essere più forti dell’alcool, quindi a partire dalla propria debolezza e dal
riconoscimento della propria dipendenza.
La storia di questo modo di trovare aiuto in se stesso e con altre persone che vivono dello stesso
bisogno e della stessa dipendenza è diventata quasi leggendaria, e ha trasmesso, come una proposta
con le sue caratteristiche tecniche, la stessa possibilità ad altri che vivono altri bisogni e altre
dipendenze: la dipendenza dalle droghe, quella dal cibo, anche quella dal gioco, ed altre diverse
dipendenze. Viene da domandarsi che possibilità ha questa riflessione di avere uno sviluppo pratico
e di proporsi con una certa coerenza, dal momento che una classe non è composta da persone che
hanno dipendenze da sostanze. Proviamo, invece, a ragionare in questi termini: una classe è un
gruppo che ha una dipendenza dal fatto che deve apprendere ed è ignorante o, per dir meglio, ha un
bisogno in comune: quello dell’apprendimento. Se poi siamo in una classe composta da bambini e
bambine o da ragazzi e ragazze il gruppo ha bisogno di crescere e di crescere apprendendo. E’
proprio nell’incontro che possiamo provare - si potrebbe anche quasi dire inventare, nel senso di
scoprire qualcosa che però è già presente nella realtà - che vi possono essere delle interessanti
analogie con il gruppo o i gruppi di auto-aiuto.
Occorre mettere da parte un certo pregiudizio e cioè che il termine “aiuto” diventi attuale
unicamente in presenza di situazioni anomale, atipiche, in presenza di incidenti o di bisogni
particolari. E’ un pregiudizio; in realtà ci possono essere necessità specifiche per aiuti specifici, ma
tutti coloro che fanno parte di un gruppo che ha una sua finalità hanno bisogno di un aiuto per
raggiungere quella finalità, e in particolare un gruppo classe ha bisogno di aiuti per arrivare a
realizzare quello che è l’obiettivo complessivo dell’incontro che si realizza con l’ingresso in una
classe, quello di crescere apprendendo, di imparare crescendo. Proviamo ad avere un’attenzione
strutturale all’aiuto nell’apprendimento senza che questo sia attivato unicamente per situazioni
particolari. Proviamo, quindi, a immaginare che la programmazione di un gruppo classe parta
proprio da quelle che sono le attività necessarie per aiutare e creare un gruppo di auto-aiuto. Molte
volte succede esattamente il contrario: si pensa a tutto, si pensa a quali attività didattiche svolgere,
si organizzano i tempi e gli spazi per queste attività e non si prevedono tempi e spazi per sviluppare
una dinamica di aiuto e di auto-aiuto. Solo quando vi fossero casi particolari, difficoltà particolari,
sarebbero ricercate delle forme di aiuto altrettanto particolari.
Riteniamo che questa sia una logica difettosa perché la particolarità viene in qualche modo
invocata, indotta, anche senza volerlo. E’ una nota dinamica oggi più che mai richiamata dai grandi
mezzi di informazione: chi ha bisogno di aiuto deve affacciarsi alla vita degli altri con qualche cosa
che sia più visibile, più clamoroso di quello che è il semplice aiuto. Deve quindi drammatizzare. La
mancanza di un’attenzione all’aiuto che vorremmo chiamare “normale”, proprio di un gruppo che
deve apprendere, che incontra il bisogno di organizzare il proprio apprendimento, fa nascere la
drammatizzazione dell’aiuto. E chi è più fragile, chi ha maggiori difficoltà, diventa l’elemento che
apre una prospettiva sperando – questa è la nostra speranza, naturalmente – che la prospettiva sia
del gruppo classe e non sia una prospettiva che divida.
Come si sviluppa la proposta dall’auto-aiuto legata alla tradizione – ormai si può parlare in questi
termini – dei gruppi di auto-aiuto? Va rilevato che i gruppi di auto-aiuto non sono nati da chi era
fuori dal bisogno ma direttamente da chi viveva il bisogno. Questa potrebbe essere una difficoltà,
perché potrebbe tradursi letteralmente che in questo:noi siamo fermi e aspettiamo che sia un
bambino o una bambina, un ragazzo o una ragazza, ad attivarsi per organizzare il gruppo di autoaiuto. In realtà questo accade, ma ha bisogno, proprio per la natura estrinseca e intrinseca del
gruppo classe, di una rilevanza e di una legittimazione da parte dell’insegnante. Gli elementi che
possono far nascere l’auto-aiuto sono propri del gruppo e di un singolo o di alcuni singoli che fanno
parte del gruppo. L’insegnante che nel gruppo è parte e nello stesso tempo è osservatore, o
osservatrice, ha la possibilità di valorizzare e dare forza alla dinamica dell’auto-aiuto.
L’insegnante può formalizzare alcune forme spontanee o implicite ai rapporti fra pari. Tale è, ad
esempio, il rapporto e la proposta di aiuto-reciproco. Il rapporto di aiuto reciproco è, con tutta
probabilità, presente nelle dinamiche che si sviluppano spontaneamente in un gruppo di pari. Se vi
sono le condizioni – certamente -; perché potrebbero essere soffocate sul nascere da condizioni
avverse. Ma, qualora vi fossero spazi e tempi per tale sviluppo, vi potrebbero essere dei rapporti di
mutuo aiuto. L’insegnante non si accontenta di essere spettatore passivo di tali possibili, non
scontati, rapporti di mutuo aiuto, ma deve anche proporli. E allora deve dare a questa proposta una
sostanza strutturata; è per questo che è consigliabile essere molto attenti a non individuare il tutore,
nella coppia di aiuto, fra coloro che possono essere definiti i primi della classe, così come è molto
importante individuare uno spazio dove si svolga l’attività della coppia di aiuto-reciproco, e
sottolinei l’importanza di questo impegno e non venga invece interpretato come uno spazio
continuamente disturbato da ingressi, marginale rispetto alle attività che hanno dignità nella
struttura scolastica o connotato come un luogo in cui si depositano le cose che non servono:
scatoloni, mobili, o altro. Deve essere uno spazio tale da confermare quello che dovrebbe essere
espresso nelle parole, e cioè che si tratta di un impegno di una qualche importanza.
E’ anche utile strutturare bene il tempo e dare delle consegne tali da permettere l’instaurarsi di un
rapporto di aiuto non sottoposto all’arbitrio. E’ bene avere, nello svolgimento dell’aiuto, del
materiale che organizzi il rapporto secondo una certa mediazione, e non pensare che il risultato
debba essere necessariamente legato al raggiungimento di una performance ma debba essere più
legato al tempo che passa: mezz’ora è un tempo di una certa importanza e deve passare quella
mezz’ora in una attività prevista, non deve esserci un tempo aperto e che si chiude unicamente
quando si raggiunge una performance. Non è questo il buon motivo dell’aiuto reciproco. L’aiuto è
più legato a una possibilità di trascorrere una unità di tempo rilevante, ma non esagerata, facendo
una certa attività in due ruoli diversi.
E’ poi anche utile non pensare ad un lungo calendario di incontri di aiuto reciproco ma a un breve
calendario, composto da quattro incontri, forse rinnovabili, una volta alla settimana, tali da
consentire una prova che è sostenibile. Possiamo immaginare che ci possa anche essere una coppia
male assortita o una sopraffazione da parte di chi è nel ruolo di aiuto all’altro. Questa sopraffazione
è sostenibile per qualche tempo, e non sarebbe sostenibile se durasse tutto l’anno. E’ poi la necessità
di capire che non si tratta di gerarchizzare i ragazzi e le ragazze in chi aiuta e chi è aiutato, ma di
entrare in ruoli diversi. Questa è una proposta che nasce da una possibilità presente nelle dinamiche
informali e spontanee tra coetanei e che viene ripresa e formalizzata dall’insegnante. Ci si potrebbe
allora domandare se la proposta di aiuto reciproco debba essere tale unicamente quando si siano
osservate delle attività di mutuo aiuto spontanee. Non è così. Riteniamo che si possa presumere che
in qualsiasi gruppo di pari, in qualsiasi condizioni di vita non costretta, nascano delle dinamiche di
mutuo aiuto, ed è quindi da questa presunzione di una realtà, non dalla necessità di rilevarla nel suo
svolgimento, che nasce la proposta. Questo è certamente un’assunzione di responsabilità da parte
degli insegnanti ma è tale in rapporto a una possibilità affermata e verificabile, e non in base a un
giudizio arbitrario.
Questo esempio ci può far capire che il punto di partenza è analogo a quello dell’esperienza storica
dei gruppi di auto-aiuto: i protagonisti sono gli stessi che vivono la situazione di bisogno. Può
essere pensato, il gruppo di auto-aiuto, anche in funzione di una vita sociale, che è propria del
gruppo classe, non clandestina, non ritenuta indegna di essere affrontata con la parola. E questo è
l’altro strumento interessante che si chiama il Consiglio. Di cosa si tratta? Si tratta di un tempo
preciso, in calendario, concordato, durante il quale il gruppo classe ha la possibilità di affrontare
quelle che sono le problematiche, i temi, gli argomenti che riguardano la vita di relazione del
gruppo classe stesso. Non vorremmo enfatizzare gli aspetti relazionali, e dare a questi un primato
assoluto su tutta l’attività didattica. Ma proprio per non enfatizzarli è opportuno dare loro lo spazio
giusto. Come per la proposta di aiuto in generale, gli aspetti relazionali non possono essere imposti
unicamente a seguito di incidenti, a seguito di presenze che rendano le situazioni difficili. Non è
tanto sensato, e non è neanche giusto, accorgersi dell’importanza delle relazioni unicamente quando
vi sono difficili relazioni. Non è neanche sensato e non è neanche giusto fare che tutto il tempo del
gruppo classe sia una continua esplorazione delle relazioni. Si può immaginare che l’attività
didattica sia come il lavoro: occorre lavorare, occorre applicarsi e realizzare determinati impegni
che sono propri dell’apprendimento, e quindi anche dell’insegnamento, visto che parliamo anche di
una possibilità di presenza anche di aiuto reciproco e di mutuo insegnamento.
Affermato questo va anche detto che gli aspetti delle relazioni che in un gruppo sono inevitabili
possono avere la loro importanza proprio in funzione dell’apprendimento. Gli apprendimenti hanno
bisogno di un contesto che sicuramente è composto da una parte materiale: spazio, arredi, e, sembra
immateriale ma collocato all’interno di questa dimensione, vi è anche il tempo, l’organizzazione del
tempo, e un aspetto legato alle presenze e alle relazioni che si stabiliscono fra i diversi soggetti.
Il Consiglio è il tempo, precisato dal calendario – si può pensarlo con un ritmo bisettimanale -,
dedicando ad esso un tempo preciso che può essere di un’ora e mezza o di un tempo che si ritiene
compatibile con l’organizzazione di un calendario permanente, e ha una sua strutturazione
organizzativa che prevede un presidente, che presiede il Consiglio, un verbalizzatore, la definizione
di un ordine del giorno, e quindi la possibilità, che è da segnalare, che troppi argomenti in ordine
del giorno o un tempo dedicato a un solo argomento, non permetta di affrontare come si deve tutti i
punti.
Il tempo non è aperto a ciò che si vuole ma è stabilito in partenza: non si può ritenere che non
avendo conclusa una discussione o uno scambio di idee su tutti i punti dell’ordine del giorno non si
chiuda all’ora stabilita il Consiglio ma lo si tenga aperto finché non sono esauriti gli argomenti.
Questo non funziona, e perché non funziona? Perché questo darebbe luogo a quello che proprio
l’attenzione allo stabilirsi di una dinamica di auto-aiuto nel gruppo classe non vuole che diventi
l’unico modo di funzionare, e cioè la logica dell’emergenza. La possibilità di riprendere, al
prossimo incontro, e di organizzarsi meglio nelle proprie logiche permette di educarsi all’auto-aiuto
e di educarsi alla strutturazione del Consiglio. E’ quindi uno strumento che esige una pratica per un
lungo periodo. Neanche, potremmo dire, per un anno ma per più anni. Se gli insegnanti possono
fare un ragionamento su più anni di permanenza nello stesso gruppo classe è pensabile e possibile
che il Consiglio diventi un’abitudine organizzativa che consente di affrontare gli argomenti così
come si producono, e anche di avere una memoria della vita del gruppo e della sua crescita. Non è
tempo, quindi, che debba essere ricavato unicamente se nascono delle difficoltà ma deve essere
organizzato indipendentemente dall’insorgere di incidenti o dalla presenza di casi particolari che
esigono particolare attenzione.
Anche in questo senso vi può essere un’ analogia con la dinamica e l’organizzazione dei gruppi di
auto-aiuto che esigono tempo, esigono un percorso. Ricordavamo, all’inizio di questa riflessione,
che nella strutturazione che l’esperienza storica degli alcoolisti anonimi ha dato al percorso
dell’auto-aiuto vi sono dodici tappe. E vi sono quindi delle possibilità di crescita individuale, il
punto in cui ciascuno è su questo percorso delle dodici tappe, che stanno insieme alla logica del
gruppo. Vi è quindi una strutturazione che è nello stesso tempo di percorso individuale e di vita di
un gruppo, di crescita di un gruppo. Il percorso individuale è molto importante e permette di avere
sempre una capacità che si esercita, che non è un dato scontato piuttosto una costruzione, di vedere
nello stesso tempo il proprio punto, il proprio percorso, e il percorso degli altri, e di avere quindi
sempre delle possibilità di comparazioni costruttive perché ciascuno è, nello stesso tempo, nella
possibilità di essere punto di riferimento di qualche altro, vi è la possibilità di avere in altri un punto
di riferimento. C’è, quindi, chi è a una tappa più avanzata, di un percorso, e ha la possibilità di far
vedere il percorso già svolto, e c’è chi invece ha avuto un rallentamento, una marcia più difficile e
vede negli altri lo sviluppo, ma è visto anche come chi deve essere in qualche modo orientato verso
le tappe successive, incitato.
Nella possibilità di sviluppo del Consiglio il gruppo classe struttura il tempo e la capacità di vivere
il tempo dominando le ansie. E’ questo un elemento che può essere anche difficile per gli stessi
insegnanti. Una delle caratteristiche che riteniamo più importanti del Consiglio è quella che
potremmo definire la lealtà al Consiglio, l’impegno di trattare gli argomenti che vengono proposti
all’ordine del giorno unicamente all’interno del Consiglio, e di non riprenderli fuori dal tempo del
Consiglio. E’ un punto, questo, che deve essere osservato in primo luogo dagli insegnanti. Potrebbe
esservi una difficoltà, da parte di chi è in un ruolo adulto ed insegnante, ricordare questa realtà,
perché potrebbe ritenere in certi momenti doveroso dire e richiamare a un bambino, a una bambina,
a un ragazzo, a una ragazza, l’impegno preso nel Consiglio. In questo modo romperebbe la lealtà e
sarebbe un’autorizzazione a che tutti possano riprendere gli argomenti del Consiglio in qualsiasi
momento.
E’un’altra delle caratteristiche che si potrebbe vedere analoga ai gruppi di auto-aiuto che vedono un
gruppo impegnato con l’affidamento al tempo del gruppo e la fiducia che ciò che esce del gruppo
non sia poi ripreso – sarebbe a sproposito – fuori dal tempo del gruppo e fuori del gruppo. Questo
potrebbe sembrare un vincolo anche dannoso, per certi versi, perché se qualcuno nel momento del
gruppo, del Consiglio per la classe, del gruppo per il gruppo di auto-aiuto, svelasse le difficoltà in
cui sta vivendo e queste fossero ritenute anche gravi qualcuno potrebbe sentire il vincolo di
riprendere questi temi, queste confidenze unicamente al prossimo gruppo, al prossimo Consiglio,
come un modo di non aiutare. In effetti bisogna essere più precisi.
E’ possibile che dal gruppo e dal Consiglio nascano delle attività di aiuto anche impegnative per
tutto il resto del tempo, fuori dal gruppo, fuori dal Consiglio, ma una cosa è l’impegno di aiuto che
deriva dalla riunione di Consiglio, dalla riunione del gruppo, una cosa è riprendere l’argomento
come discussione o come ammonimento. Per intenderci meglio, se nel gruppo di auto-aiuto o nel
Consiglio si capisse meglio la necessità che un soggetto ha di essere aiutato nel controllo della
propria aggressività e si capisse anche le modalità che possono essere realizzate per controllare
quella aggressività, queste dovrebbero essere esercitate anche nel tempo fuori dalla riunione di
Consiglio, dalla riunione di gruppo. Non devono essere discusse, quelle tematiche, non devono
essere oggetto, se si può dire, di rimprovero pubblico o privato. Bisogna controllare le proprie ansie
e essere capaci di riprendere l‘argomento unicamente nel tempo del Consiglio.
Questo è un elemento importante che struttura il gruppo di auto-aiuto in una prospettiva, e non con
una logica del pronto intervento o nell’attività di pompiere. E’ un gruppo classe e come tale ha
bisogno di strutturare il tempo dell’apprendimento come un percorso ampio, di respiro. E anche
coloro che dovessero non avere prospettiva dovrebbero, con questi strumenti, con questa dinamica,
imparare, formarsi ad avere una prospettiva. E noi dovremmo sapere che l’apprendimento è
facilitato da una possibilità di prospettiva, ed è reso molto più difficile, e a volte, anche, quasi
impossibile quando manca una visione prospettica, una proiezione nel futuro, una capacità di
individuare e di riformulare in situazioni che potrebbero accadere e che ancora non sono accadute.
La formulazione di un progetto per l’apprendimento è quindi connessa alla possibilità di dare al
gruppo classe una connotazione di gruppo di auto-aiuto.
Vi è un altro aspetto, nelle pratiche di auto-aiuto, che va ripreso con un certo interesse. Il fatto che il
più conosciuto dei gruppi di auto-aiuto si chiami “alcoolisti anonimi” può creare qualche malinteso,
può far pensare che nell’anonimato vi sia anche un non assumere l’identità, un non parlare a partire
da quello che ciascuno è. Chi conosce un poco i gruppi di auto-aiuto, e in particolare i gruppi in cui
il termine “anonimo” è presente, sa che è esattamente il contrario. Nelle situazioni di bisogno per
dipendenze che fanno soffrire, la possibilità di assumere la parola e di dire “io” è garantita proprio
dall’anonimato, dalla non necessità di presentarsi nel proprio ruolo professionale, nel proprio ruolo
sociale, ma di presentare il proprio nome senza contorni, per esplorare insieme gli elementi della
propria vita che sono più fragili e anche per scoprire insieme le risorse che il singolo può avere e
che può offrire agli altri, può mettere nel gruppo. Proprio quello che già si diceva: l’importanza di
non dividere il gruppo in chi aiuta e chi è aiutato ma di sentire che in ciascuno c’è una parte che ha
bisogno di aiuto e una parte che può aiutare permette l’assunzione della parola a partire da “io
sono”: essere presente con la propria individualità e quindi anche assumere una responsabilità
crescente, in divenire, che può svilupparsi.
Anche su questo l’apprendimento è avvantaggiato, perché il gruppo può risultare una forzatura che
nasconde il singolo. Ha bisogno, invece, di prendere dall’esperienza dei gruppi di auto-aiuto il
rispetto ma anche lo stimolo a che il singolo soggetto si presenti come tale e non si nasconda. Ora,
noi abbiamo tante esperienze di gruppi classe in cui qualcuno ha potuto nascondersi, cioè rimanere
uno sconosciuto, un anonimo. Paradossalmente, in questo caso, l’anonimità voleva dire la persona
che non ha avuto modo di dire: “Io sono”, e quindi ha reso meno presente le sue competenze e ha
sicuramente utilizzato poco dal gruppo per quanto riguarda la finalità maggiore che è quella
dell’apprendimento. Questo non vuol dire avere delle forzature ad affermare la propria presenza e
doversi
immediatamente
porre
al
centro
dell’attenzione
degli
altri,
sotto
un
riflettore.
L’articolazione del gruppo attraverso le sue componenti permette, non tanto una forzatura verso
l’esibizionismo individuale, quanto l’articolazione delle stesse componenti e la possibilità per
esprimere la propria originalità all’interno di un clima che può essere di conquista dell’accettazione
ma anche di stimolo a superare le proprie condizioni e i propri limiti. Il tempo dell’apprendimento è
anche un tempo di sfida, che dovrebbe esser accettata a partire dall’assunzione di consapevolezza
della propria presenza in un contesto. Quanti sono i ragazzi, le ragazze che vivono la scuola come
una parentesi noiosa, da sopportare - e a volte non la sopportano -, in attesa di potersi esibire in altri
contesti, a volte non propriamente ripaganti di quelle che sono le attese, e che esauriscono
nell’apparizione ogni altra possibilità di gratificazione. L’ambiente del gruppo classe può costruire,
invece, una presenza significativa del singolo collegando il termine “gruppo” all’assunzione di
responsabilità e di presenza responsabile di ciascuno. Questo significa evitare di incentivare il
protagonismo. Soprattutto significa evitare di far vivere l’esperienza dell’istante, senza prospettiva,
con quella sensazione che la buona sorte debba accompagnare le sfide. La buona sorte, la fortuna.
Non la propria organizzazione, le reti sociali di competenza, l’aiuto solidale e la possibilità di far
tesoro dell’esperienza; per cui quello che non riesce immediatamente diventa esercitazione perché
riesca in un tempo successivo.
Questo è un richiamo ad un altro aspetto che la ricerca ci propone e riguarda lo stile di
apprendimento. E’ uno stile individuale, ciascuno conosce secondo una propria organizzazione, ma
nello stesso tempo è conoscibile da ciascuno grazie al fatto che è esposto allo sguardo, all’ascolto,
all’indagine discreta degli altri. Lo stile di apprendimento è individuale ma non può fare a meno di
un contesto di gruppo. Allo stesso modo, come nei gruppi di auto-aiuto, il percorso è individuale ma
non può fare a meno dell’ascolto, di un ascolto che potremmo chiamare interrogante
silenziosamente ma anche esplicitamente, degli altri, del gruppo. E allora questo richiama la
possibilità che vi sia un’attenzione allo stile di apprendimento, che è certamente l’altra faccia di una
stessa medaglia che riguarda anche lo stile di insegnamento. Una ricerca che ormai ha fatto scuola
ci indica due modalità di organizzare la propria memoria e quindi anche di organizzare la propria
riformulazione continua, in vista delle risposte ai problemi che pone la realtà e che formula anche la
scuola. Due modalità, una organizzata attorno alla rappresentazione iconica, vale a dire le
immagini, e l’altra organizzata attorno all’evocazione concettuale, vale a dire le parole. Lo stile di
apprendimento e lo stile di percorso, di processo, è quello che in maniera ben diversa, con meno
attenzione alla finalità dell’apprendimento, è presente anche nei gruppi di auto-aiuto. Nell’incontro,
e partecipando alle cerimonie che sono particolarmente intense relativamente al “compleanno di
pulizia”, cioè alla celebrazione di un tempo senza assunzione di droghe, per esempio - o di
alcoolici-, si nota la possibilità propria di un’organizzazione del proprio ricordo, della propria
argomentazione, attorno o alle immagini o alle parole. E questo è un elemento che caratterizza la
personalizzazione del percorso e la possibilità che questo avvenga in maniera del tutto spontanea
nei gruppi di auto-aiuto, perché non hanno una finalità legata all’apprendimento, e invece avvenga
in maniera intenzionale, seguita, proposta nel gruppo classe inteso anch’esso come gruppo di autoaiuto.
La
proposta
contiene
alcune
tappe
fondamentali
per
capire
meglio
i
meccanismi
dell’apprendimento, e capirli come soggetto che apprende, non come ricercatore che osserva. Il
soggetto che apprende, a sua volta, può essere in qualche misura soggetto che osserva, ma osserva
anche se stesso, perché una delle pratiche che deriva da questa proposta è quella che riguarda la
riflessione introspettiva. Siamo sempre, giustamente, molto lamentosi nei confronti di un’epoca, di
un modo di vivere che induce a non avere più tempi di riflessione. Nel percorso di apprendimento,
per capire la propria modalità di organizzare le connessioni, l’apprendimento, la memoria, nel
gestire la propria attività mentale, vi è un tempo di introspezione, di riflessione introspettiva. La
proposta viene anche spesso accompagnata da una pratica molto interessante che è quella di invitare
coloro che hanno più facilità di apprendimento, coloro che sono più brillanti nell’apprendere, a
compiere questa attività di riflessione introspettiva e di esporla. L’esposizione è aiutata dalle
domande degli insegnanti. L’insegnante deve potere mettere la propria professionalità anche in
questa preparazione specifica consistente nel fare le domande giuste e quindi nel proporsi in una
dimensione dialogica perché emergano le attività mentali di chi apprende con migliori risultati e
diventino un servizio fatto agli altri. Ciascuno, poi, è invitato a compiere una riflessione
introspettiva per capire come procede l’organizzazione delle risposte nelle varie aree disciplinari.
Questa pausa di riflessione introspettiva è molto interessante proprio per capire una procedura che
ha bisogno di tempi, e non solo di un tempo. Ha bisogno di una comprensione della richiesta, di una
riflessione
secondo
le
proprie
modalità
organizzative
dell’attività
mentale
e
quindi
di
un’elaborazione della risposta. I tre tempi potrebbero diventare anche quattro e poi cinque, se si
considera la possibilità dell’errore e della correzione dell’errore, e quindi la comprensione degli
errori compatibili e degli errori incompatibili. Questa è una delle ragioni che permette
all’apprendimento di avere molte buone carte da giocare nei confronti della vita sociale, di non
chiudersi a risultati validi solo all’interno della logica scolastica. Nello stesso tempo permette alla
logica scolastica di risultare molto più comprensibile e valida e meno, se si può dire così,
burocratica, meno chiusa in aspetti unicamente formali, che a volte sono giocati su due tasti: una
certa rigidità severa oppure un lassismo che non lascia molto spazio all’elaborazione di una capacità
di autodisciplinarsi nell’organizzazione dell’apprendimento.
Anche in questo caso è il gruppo che diventa interessante ed è l’organizzazione del gruppo che
permette il percorso individuale. E anche in questo caso crediamo di potere intravedere dei
collegamenti utili tra le pratiche e la storia dei gruppi di auto-aiuto e il gruppo classe inteso come un
originale gruppo di auto-aiuto. Il contesto del gruppo classe valorizza, quindi, i singoli non
unicamente quando un singolo è attivato nell’interrogazione o tutti sono attivati nel compito ma
valorizza i singoli nelle diverse dimensioni che ciascuno contiene. Per dirla in termini molto
semplici, nella parte attiva di protagonista momentaneo, nella parte altrettanto attiva di spettatore
interessato, nella parte attiva, certamente, di indagatore dell’attività dell’altro per capire la propria, e
sempre insieme nella parte di collaborazione alla creazione di una realtà che deve essere aperta al
futuro e che non deve accontentarsi di vivere, in quel momento, una realtà piacevole. Per certi versi
lo slogan “star bene a scuola”, che è stata anche una interessante proposta della nostra scuola, può
diventare limitante perché può togliere quello squilibrio determinato dalla curiosità e dall’apertura,
così necessario nel procedere. Star bene non significa star tanto bene da non muoversi più, ma
significa star bene in movimento, cioè star meno bene se stiamo fermi. Capire come non sia utile
star fermi ma avere la curiosità per andare avanti. E questo può richiamare uno degli elementi
fondanti di quella che viene chiamata la pedagogia istituzionale che è il rapporto fra istituito e
istituente.
La pedagogia istituzionale, per qualcuno, è datata. Noi riteniamo che sia tuttora una proposta
quantomai viva e quantomai utile in prospettiva, non quindi legata a una stagione e a un paese.
Certo ha avuto nella Francia una culla in cui ha avuto i primi momenti di vita, ma certamente si è
mossa, si è allargata, si è collegata, ha trovato delle corrispondenze in molte pratiche, in molte
riflessioni, in molte indagini che forse non stavano sotto questa etichetta ma che non sono
contrapponibili. Istituito e istituente: ciò che è già dato e ciò che è invece costruito grazie al fatto
che si conosce ciò che è istituito. Il gruppo può essere più capace di costituirsi in una proposta attiva
se ha anche, se matura, la capacità di conoscere il dato da cui parte, l’elemento organizzato, che è la
scuola, l’elemento organizzante che è la vita originale del gruppo classe. E’ un collegamento, quello
della pedagogia istituzionale, che permette di realizzarsi tra alcune delle linee che abbiamo trovato
in analogia con i gruppi di auto-aiuto e quelle proposte che vengono a volte ricordate come proposte
di laboratorio.
4. 2. L’organizzazione per laboratori
Il gruppo classe ha bisogno di produrre delle attività. Abbiamo la sensazione che a volte continui ad
esserci una contrapposizione e una divaricazione fra lo star bene, gli elementi relazionali, la
capacità di convivere, e il produrre apprendimenti. Abbiamo cercato di riflettere sulla possibilità
che i due elementi, le due dimensioni, siano strettamente intrecciati. Ma, siccome questo equivoco
dura da molto, molto tempo, è possibile che vada ancora avanti per molto tempo.
Crediamo che in questi decenni e nei prossimi anni le attività della scuola abbiano dei forti impegni
nei confronti della pluralità dei soggetti che interverranno nel contesto scolastico. Il possibile
mutare della popolazione scolastica, secondo le ondate migratorie, è certamente il fatto più vistoso,
e sarà necessario essere molto attenti a non condurre le attività della scuola secondo una modalità
che è più propria delle attività televisive. Quella possibilità, cioè, di far convivere in un palinsesto
tanti volti, tante attività, tante immagini, quindi sicuramente una pluralità, ma senza minimamente
preoccuparsi di intrecciare tra loro queste attività. Sarà necessario costruire, invece, un intreccio e
permettere che vi siano degli elementi condivisi. La pluralità dei soggetti può voler dire anche una
pluralità di linguaggi. Non ci riferiamo certamente alla pluralità delle comunicazioni ma proprio dei
linguaggi, cioè delle strutture comunicative con una costruzione simbolica e con una organizzazione
grammaticale e sintattica con delle condivisioni semantiche. E’ possibile che manchino proprio le
condivisioni semantiche. E per costruirle, per permettere che queste costruzioni avvengano con
delle radici, è necessario avere delle possibilità di lavoro comune., cioè organizzare dei tempi di
laboratorio durante i quali il riscontro tra le parole che evocano, che rappresentano, che annunciano,
e gli oggetti, permetta di costruire il condiviso. Questo è realizzato dall’immigrazione che ha come
primo impatto il luogo di lavoro. L’apprendimento della lingua avviene attraverso la corrispondenza
delle parole con gli oggetti, con le azioni, con il contesto che è il mondo del lavoro. Ed è possibile
quindi che un lavoratore proveniente da un altro paese conosca bene la lingua italiana,
limitatamente a un vocabolario ristretto al luogo di lavoro, forse anche con delle capacità tecniche
non comuni ma senza l’ampiezza di conoscenza linguistica che caratterizza chi arriva al lavoro
mediante un percorso di esperienza vitale. Per bambini e bambine questo potrebbe non essere
identico ma potrebbe rappresentare una possibilità di non avere eco nel vocabolo e nei vocaboli
della scuola con l’esperienza familiare. Ma vi sono anche percorsi che hanno nella televisione
l’interlocutore inerte, ahimè, privilegiato, e quindi anche per coloro che sono non di famiglia
culturalmente proveniente da altri paesi ma di famiglia autoctona vi possono essere degli
impoverimenti legati al fatto che il linguaggio è sempre in relazione con una attualità di immagine
ed ha scarsa possibilità evocativa e rielaborativa della previsione.
Il laboratorio ha anche una valenza organizzativa dei concetti scientifici. Alcuni bambini, alcune
bambine, hanno già pratiche di curiosità scientifiche ma molti sono inerti nei confronti della
sperimentazione con le cose, nel giocare con gli oggetti, nell’accorgersi della loro materialità, della
differenza che è legata ai diversi materiali, ecc. E quindi diventa ancora più importante il permettere
che l’esperienza scolastica sia arricchita da una serie di attività che non sono “altro” rispetto al
percorso degli apprendimenti ma che diventano sostanza per gli apprendimenti. La preoccupazione
da palinsesto è quella di far star tutto nel programma. E probabilmente è una preoccupazione che
nuoce perché carica la vita scolastica di una serie di frantumi difficili da amalgamare, difficili da
intrecciare, e non di indagini sulla realtà attraverso quelle importanti chiavi di lettura che sono le
aree disciplinari. E’ difficile rinunciare alle discipline perché sarebbe come rinunciare alla storia
delle indagini scientifiche e quindi alla trasmissione degli strumenti per entrare nella realtà. Sono
chiavi per entrare in una realtà da indagare e come tali devono essere dotate anche di un campo
esperienziale.
Il laboratorio disciplina le discipline, se si può dir così, e organizza il gruppo classe secondo ancora
una dinamica che è analoga a quella dell’auto-aiuto, con più capacità di accogliere le pluralità, e
quindi di rispondere a quelle che sembrano essere le esigenze maggiori di questo periodo non breve
della scuola, in Italia e in Europa. Nell’attività di laboratorio il gruppo si misura con due possibilità
e non deve rimanere prigioniero né nell’una né nell’altra. Una è la possibilità della dimensione che
viene chiamata fusionale, cioè la possibilità che il gruppo persegua, e metta come finalità maggiore
quella della fusionalità di tutti i suoi membri in una compattezza, certamente interessante sul piano
anche dell’educazione sentimentale, ma limitante per quanto riguarda la capacità di apprendere
crescendo e di crescere apprendendo. Fusionalità significa sentire in un modo solo e quindi avere
una possibilità di fare gruppo in termini tali da rassicurare ciascuno dei suoi componenti con il
senso di appartenenza al gruppo. Per certi versi, quindi, potrebbe sembrare un elemento così
importante da diventare irrinunciabile nella formazione e nell’educazione scolastica attuale perché
può farci pensare di assolvere all’importantissimo compito di educare all’appartenenza. Nello stesso
tempo la fusionalità in un gruppo può chiudere al gruppo stesso altri orizzonti. Il concetto di
appartenenza ha un’ambivalenza che è probabile sia della polisemia del linguaggio, e quindi che
ogni parola in qualche misura contiene. Per certi versi è una prospettiva affascinante, importante, di
conoscenza del mondo intero. Per altri versi potrebbe diventare il rifugio nella piccola patria e la
chiusura dei confini a ogni elemento che viene ritenuto estraneo e come tale, di per sé, invasore.
Ecco i rischi della fusionalità.
L’altra dimensione e l’altra possibilità del gruppo è quella della produttività. Al primo posto mettere
la produttività significa anche selezionare la partecipazione attiva dei suoi componenti in modo tale
che abbiano più spazio e più senso di protagonismo coloro che meglio lavorano, che quindi sono
più adatti a conseguire quella produzione che diventa priorità.
Queste due possibilità hanno, a volte, una percorrenza oscillante. Vi sono momenti in cui un gruppo
sente più il bisogno di fusionalità, altri in cui sente più il bisogno di produttività. L’organizzazione
del gruppo classe secondo l’analogia con il percorso di auto-aiuto deve permettere di superare
questi rischi e di sentire questi rischi come i due limiti da tenere come tali, e non da ritenere termini
di una scelta. La possibilità di scelta fra queste due dimensioni non c’è. Vi sono delle oscillazioni,
questo è quanto abbiamo ritenuto già possibile dire, ma verso un percorso che è quello
dell’apprendimento per l’oltre la scuola, quindi superando la fusionalità del gruppo classe e
superando anche la possibilità che il gruppo, in quanto tale, sia narcisisticamente gratificato di una
produttività che non corrisponde alla capacità dei singoli di realizzare. In questo senso il gruppo
copre -–e questo è un punto già trattato in questa riflessione – la possibilità di vedere come i singoli
stanno nel gruppo e oltre il gruppo. Questa doppia dimensione di rischio è interessante da conoscere
anche negli aspetti che hanno costituito una traccia storica, che è dietro la parola “laboratorio”. La
traccia storica ha molte componenti e a noi interessa riprenderne e analizzarne alcune, senza
nessuna necessità di esaurire il campo di indagine, ma solo di rintracciare alcuni fili per permettere
di capire che non stiamo improvvisando ma che, in questa nostra riflessione, sentiamo i
collegamenti con delle radici anche abbastanza profonde. Se crescere vuol dire assumere la propria
immaturità, oggi più di ieri l’immaturità è accentuata e mascherata perché molti che crescono non
hanno le occasioni, non vivono quelle esperienze, che permettono di stabilire un rapporto con le
cose, con la materialità e con la cura della quotidianità. Non sono né spettatori né artefici delle cure
materiali nella quotidianità perché la vita nelle case, la vita nei gruppi familiari, è ridotta da questo
punto di vista e, meno che meno, è invitante il prendersi cura del rapporto tra la vita familiare e i
dintorni, i negozi. Se un tempo qualcuno, e non pochi, venivano mandati a fare la spesa, oggi questo
è più difficile, è ritenuto pericoloso. Se crescere, dunque, è assumere la propria immaturità,
nell’immaturità ci sono anche le goffaggini, le difficoltà, in quelle che vengono chiamate le pratiche
non discorsive, cioè quelle pratiche che non possono essere riportate in un discorso perché devono
essere realizzate: sono nel fare. Senza esaltare ed enfatizzare questi aspetti, dobbiamo però
assumere questa immaturità per poter crescere. E l’assunzione dell’immaturità può avvenire proprio
strutturando i gruppi classe in rapporto a delle attività che chiamiamo “di laboratorio”. Il termine
“laboratorio” contiene la parola “labor”, che significa anche “fatica”: è imparare a sopportare e a
dar senso alla fatica. E anche questo è uno dei tratti della fragilità della nostra epoca. La difficoltà
ad assumere la fatica, a dare un senso e quindi a sopportarla. Una maggiore fragilità, incapacità, nei
confronti di ciò che costa fatica. E tutto ciò può avere un senso perché il gruppo, nella sua pluralità
di componenti e di soggetti, accolga chi ha delle difficoltà maggiori, delle disabilità.
Chi scrive queste note si occupa, d’abitudine, più specificamente di questi aspetti ed è però
interessato a capire se è proponibile una realtà di classe che permetta i progetti di integrazione. E’
quella che paradossalmente si può chiamare un’integrazione che può realizzarsi anche sé non c’è
una persona handicappata, perché è una realtà che permette l’ipotesi, e quindi permette poi lo
sviluppo, qualora si passasse dall’ipotesi alla realtà, dall’ipotesi al fatto. Queste sono le ragioni per
cui è opportuno occuparsi di una progettazione per laboratori e di una comprensione che non riduca
un’attività di laboratorio unicamente all’attualità, ma ne capisca il carico di storia, e quindi anche
per una indispensabile dimensione di apertura che la storia contiene, il carico di possibilità
progettuale.
Vivere un progetto, realizzare un progetto, significa, ce lo insegnano i gruppi di auto-aiuto, non
avere il domani come alibi ma costruirlo accettando di vivere nel presente. Non vivere, quindi, il
presente come tutto, con l’alibi e la giustificazione di volere tutto nel presente; il domani ci aspetta.
Costruire il domani significa proprio prendere sul serio il presente. C’è un elemento paradossale in
queste espressioni. I gruppi di auto-aiuto hanno una grande capacità di dare la dimensione della
durata, a partire dal fatto che subito bisogna essere sobri. Il laboratorio esige subito una attenzione
al contesto, alla materia per poterla lavorare. Per potere costruire quello che è il progetto. La parola
“progetto” richiama qualcosa che si butta in avanti. Bisogna però avere i piedi ben saldi sul terreno
che è adesso. E in questo senso il termine “laboratorio” è interessante per capire questa
coniugazione del crescere con l’apprendimento: apprendere crescendo, crescere apprendendo.
Consideriamo i laboratori come una possibilità di ripensare la didattica curricolare. Gli
apprendimenti di base possono essere conseguiti grazie all’attività di laboratorio. E, per sostenere
questa affermazione, dobbiamo cercare di fornire alcune indicazioni relative all’apprendimento.
Un neonato impara, informalmente, avendo delle iniziative (ad esempio: gorgheggia) che possono
essere collegate a elementi già elaborati dalla comunità in cui è entrato (ad esempio: le parole).
Così, in modi che chiamiamo spontanei o naturali, le iniziative individuali trovano un senso in
elaborazioni già esistenti, che le potenziano e nello stesso tempo le ordinano in codici. Gli
apprendimenti informali contengono gli elementi costitutivi degli apprendimenti formali, e quindi
scolastici.
Un soggetto che impara vive alcune condizioni:
?? trova un senso nel tempo e nella situazione di apprendimento
?? vive un’abilità cognitiva, con una strategia personale
?? sa organizzarsi per poter utilizzare la strategia personale
?? sa collegare una nuova abilità con altre
?? ha la dimostrazione di aver conseguito o meno un risultato
Cerchiamo di spiegare il senso dei laboratori mettendoli in rapporto con i problemi degli insuccessi
scolastici, ed in particolare gli insuccessi per trauma. Il trauma può essere interpretato come
invasione di dolore, tale da occupare tutto, e non lasciare spazi per nuovi.
Il trauma può portare all’impotenza appresa. Cosa significa? Il trauma può portare a ritenere che vi
sia una pressoché totale perdita di possibilità (appunto: impotenza). Siccome l’apprendimento è
scoperta di possibilità, si può dire che il trauma inibisce gli apprendimenti. E’ il soggetto che ha la
convinzione di non riuscire a far lavorare la propria testa per realizzare un apprendimento, per
imparare. Il laboratorio che è nella testa è tutto bloccato dal senso di impotenza, dalla calamita
dell’insuccesso. E’ allora che è bene riferirsi ad un laboratorio esterno, non più nella testa. E se le
attività di laboratorio sono organizzate attorno a culture (piante) o allevamenti (animali), risulterà
evidente la necessità di vivere una struttura temporale non più risucchiata dal trauma.
Vorremmo considerare, in termini reali ed in termini simbolici, la mano. La mano che scrive, e la
mano che lavora; che è aperta o che è chiusa. La mano laboriosa.
La mano di un bambino o di una bambina esplora materiali che possono guidare e suggerire
un’attività. Nel laboratorio quella mano trova una disciplina che la aiuta; trova – nella mano esperta
che lavora accanto a lei – un modello a cui riferirsi e da imitare. Può produrre qualcosa. Chi è
traumatizzato non ha un “luogo” in cui collocare ciò che può produrre: forse la “sua” casa non
esiste più, e forse la sua dimensione interiore è tutta occupata dal dolore, dalla ferita profonda. La
situazione di laboratorio propone in sé una collocazione delle produzioni del singolo individuo nella
codifica più ampia delle produzioni.
Come le prime parole di un bambino piccolo, o di una bambina: non si perdono, se ci sono persone
che ascoltano ma soprattutto se sono accompagnate a far parte di una codifica ampia come una
lingua.
Le produzioni di un laboratorio fanno parte, cioè, appartengono, ad un genere codificato. Se un
individuo produce una marmellata in un laboratorio di marmellate, la produzione individuale
appartiene ad un genere codificato, e in questo è accolta.
L’individuo traumatizzato è spesso con una appartenenza in crisi. Il laboratorio, attraverso
un’attività materiale, visibile, controllabile, può avere una dimensione simbolica importante, e
aiutare a ritrovare o a trovare un’appartenenza.
In italiano – come si è detto -, la parola “laboratorio” ha una derivazione dal termine latino “labor”
che vuol dire “fatica. “Labor” porta a “laborare”, che significa “operare faticando”. La radice di
questa parola è “labh”, che sembra avere il senso proprio di “afferrare” e quello figurato di
“indirizzare il desiderio, la volontà, l’intento, l’opera a qualcosa”.
E’ un significato analogo a quello di avere voglia di intraprendere, mettersi in cammino, avere
padronanza di qualcosa per un progetto.
Ma non dimentichiamo la fatica.
Un ragazzo con sindrome di Down ha risposto a suo fratello che gli chiedeva proprio cosa vuol dire
sindrome di Down: “è che sono intelligente, ma è fatica stare al mondo”.
Riflettendo tante volte su questa risposta abbiamo trovato che possiamo avere la tentazione di
impegnarci soprattutto o esclusivamente a togliere la fatica di quel ragazzo (che all’epoca aveva 15
anni). Ma se “stare al mondo” fosse legato strettamente alla fatica? Se così fosse, rischieremmo di
rendere più difficile – pur con le migliori intenzioni – lo stare al mondo di quel ragazzo.
E’ più giusto impegnarci a trovare insieme il senso per quella fatica. E, quindi, pensare il mondo
stesso come un laboratorio.
Vi è una reciprocità fra laboratorio e fatica. Il laboratorio può dare senso alla fatica; e la fatica può
trasformare un luogo, una situazione, un laboratorio. Ma questa reciprocità non può essere vissuta
senza sporcarsi le mani. Non si può trasformare gli altri in “cavie da laboratorio”. E’ necessario
sporcarsi nel senso di coinvolgersi, accettando i rischi di sbagliare e di dover rimediare; ma nello
stesso tempo prendendo tutte le cautele per non commettere errori, e capire quali errori sono fattibili
e quali non fattibili perché catastrofici. Le nostre energie si allenano a mobilitarsi più
completamente per evitare errori catastrofici; sono vigili ma senza spreco per gli errori possibili.
Questa conoscenza degli errori può avere presa come un indicatore della realtà delle situazioni da
laboratorio. Perché gli errori si imparano dalla pratica e dalle parole intrecciate tra loro. Se prevale
una sola dimensione, la situazione è poco da laboratorio. Forse lo diventerà, ma per il momento non
lo è. Si può imparare a far da mangiare in biblioteca, con molti libri di ricette e senza mai mettere
piede in una cucina?
Chi ha vissuto una situazione di violenza, chi ha subito un trauma, chi si sente fragile e vulnerabile,
può aver paura di fare qualsiasi cosa. La paura che il più piccolo errore riproponga una tragedia può
essere collegata ad un continuo spaesamento: trovarsi in un luogo che non è quello amato, dove ci
sono – o vi erano – oggetti, colori, sensazioni e volti familiari.
Per chi ha vissuto violenze e subito traumi vi può essere una profonda sensazione di estraneità al
mondo. E’ difficile e sembra impossibile vivere il mondo come un laboratorio. E’ impossibile
vivere il mondo come un laboratorio. E’ impossibile vivere la fatica di stare al mondo come
qualcosa di sensato. E’ allora si può avere paura di fare anche piccole cose perché potrebbero avere
nascosto l’orrore che nasconde la tragedia; ma si può anche ritenere che non importi più niente di
niente, che fare o non fare, sbagliare o no, sia già tutto tragedia. Ci si può attaccare ad un angolo di
sopravvivenza e cercare neanche di respirare, e s i può credere che tutto è già perduto e che si
sopravvive senza vivere. Sono due modi apparentemente antitetici di essere profondamente feriti,
vulnerabili.
Allora è impossibile pensare al mondo come un laboratorio appassionante. Ma è meno impossibile
– e quindi possibile – vivere come laboratorio un piccolo allevamento di animali, una falegnameria,
una serra di fiori: un luogo circoscritto, che impegna per qualcosa che può apparire limitato, che
richiede qualcosa e non tutto.
Ma questo luogo che è un laboratorio ha la possibilità di “riaprire il tempo e lo spazio”. Il trauma è
come un’invasione del dolore, una potente calamita delle disgrazie e di altri dolori. Ci si sente
vulnerabili in ogni parte del nostro essere. Il laboratorio ci chiede di seguire dei tempi e di
organizzare degli spazi, magri per degli animali, o per dei fiori. Si riapre il tempo e lo spazio non è
più occupato da ciò che è stato.
E’ un passaggio piccolo che può permettere di scoprire che la vulnerabilità ha risparmiato una
piccola parte del nostro essere o forse si è un po’ ritirata, permettendo alle nostre mani di fare un
lavoro, alla nostra mente di seguire un ritmo, alla nostra attenzione di accorgersi di questo giorno e
di questa notte, di questa stagione, e forse di fare previsioni sulla stagione che verrà.
Senza enfasi, un pezzo di legno che diventa la testa di un burattino o un cucchiaio, è capace di dare
un pezzetto di futuro.
Maria Montessori ha detto e scritto che ogni aiuto inutile è un ostacolo allo sviluppo. E’ però molto
difficile, a volte, distinguere con nettezza l’aiuto utile e quello inutile prima di averne potuto
constatare l’esito. Per capire meglio, possiamo fare ricorso al rapporto di maternage, fornendone
una certa interpretazione.
La parola maternage richiama immediatamente la figura materna, e quindi evoca un rapporto fatto
di tenerezza, di carezze, di parole dolci. Ma al di là di questi aspetti, quello che può meglio
caratterizzarlo è il fatto che una madre possa sostenere un neonato per esempio prendendolo in
braccio, sentendo col proprio corpo il corpo dell’altro, e quindi allentando o rinforzando la presa
secondo le esigenze, istante dopo istante. Questa elasticità permette di dare aiuti utili e di evitare
aiuti inutili. Se quel bambino – o quella bambina – farà movimenti che potrebbero compromettere
l’equilibrio, il braccio e il corpo di quella madre assumeranno una presa più ferma. E, al contrario,
si allenteranno quando i movimenti non rappresentano alcun rischio.
Questa elasticità sensibile è il maternage. E per spiegare meglio a me stesso questa situazione, ho
tante volte fatto ricorso alla scuola guida, e alla vigilanza sensibile che deve esercitare chi istruisce
nei confronti di chi impara, permettendo libertà della guida, e sapendo intervenire quando vi fosse
un pericolo.
Gli interventi inutili, e quindi dannosi, sono certo possibili, ma ridotti al minimo.
In un laboratorio è possibile vivere una situazione di maternage. Quello che nel rapporto madrebambino era giocato dal contatto del corpo a corpo, è qui svolto da uno spazio attrezzato per una
finalità chiara e che si chiarisce operando. Chi istruisce può lasciare fare, e anche sbagliare, ma
interviene quando vi è il rischio di compromettere la stessa finalità del lavoro. E il senso
dell’intervento, in rapporto all’opera, è chiaro.
Per chi ha vissuto la violenza, subendo traumi, il troppo aiuto può confermare il senso profondo di
vulnerabilità. Ma anche l’assenza di aiuto può confermare nel senso di solitudine e di
irraggiungibilità della propria condizione.
Per tutto questo, un laboratorio può rappresentare una situazione adatta a sviluppare una dinamica
evolutiva degli aiuti, e fornire una condizione in cui gli aiuti inutili siano molto limitati. Il fatto che
gli obiettivi del lavoro siano riconoscibili nell’aspetto del materiale (dello spazio, degli oggetti) e
diventino sempre più chiari operando, rende possibile ridurre anche le parole inutili, o renderlo
meno dannose e a volte anche piacevoli. Ed è bello riscoprire il piacere dell’inutilità, accanto al
gusto dell’utilità.
Le modulazioni degli aiuti e l’importanza dell’interscambio di aiuti ha suggerito a educatori del
passato la creazione di laboratori. E’ sempre importante riconoscersi in una storia e scoprire di
avere degli antenati. Gli antenati sono sicuramente molti, rendendo possibile a ciascuno di trovarsi
l’antenato in cui meglio si riconosce e da cui riceve più aiuto.
Ovide Decroly (1871 – 1932) era una un medico belga, ed è stato un educatore che ha organizzato il
suo impegno attorno ai centri di interesse. Possiamo vedere in questi una forma di laboratorio. Dai
centri di interesse deriva un pedagogia del progetto, in cui è importante la rappresentazione del
progetto e la sua organizzazione anche materiale e che comporta cooperazione, negoziazione,
responsabilità, valutazione, contratti.
Il gruppo è anche il riferimento costante di un educatore, maestro di scuola, francese: Célestin
Freinet (1896 – 1966). Freinet realizza la cooperazione educativa, che si basa sullo scambio e sulla
valorizzazione delle competenze, più che sulla competizione. E il gruppo ha un valore perché è
composto di individui con diverse capacità. Deve avere una strutturazione e di ruoli funzionali alla
sua vita e agli obiettivi che vuole realizzare. E una delle caratteristiche importanti della pedagogia
di Freinet è costituita dal fatto che gli obiettivi devono essere condivisi e verificabili da tutti ci
componenti del gruppo.
Questa è una caratteristica che è tipica di una situazione di laboratorio, dove la stessa riuscita
materiale del lavoro può far capire a tutti che gli obiettivi vengono raggiunti. Ma per dare a
ciascuno la giusta collocazione è utile pensare che sia bene fare una doppia analisi dei bisogni: i
bisogni dei singoli ed i bisogni del gruppo, ovvero del laboratorio o del progetto. E’ da questa
analisi, che a volte è fatta molto empiricamente e osservando i bambini e le bambine anche durante i
loro giochi, che chi ha il compito di guidare l’attività di laboratorio (educatore, insegnante,
istruttore) può strutturare il gruppo per la realizzazione di un progetto.
Queste caratteristiche sono veramente interessanti e utili per permettere a bambini e bambine, ma
anche ad adulti, che hanno vissuto violenze e vivono stati di vulnerabilità, di ritrovare la capacità di
avere fiducia. Ed anche bambini e bambine con bisogni particolari possono vivere l’esperienza dei
laboratori positivamente.
Le due “schede” che seguono – sulle strategie del lavoro di gruppo e sul contratto pedagogico –
esemplificano due realizzazioni metodologiche richiamate in questa riflessione.
4.3 SCHEDA:LA STRATEGIA DEL LAVORO DI GRUPPO
(Definire e condurre bene un progetto, valutarne i risultati)
1. L’essenziale da tenere presente:
?? Non esiste un “progetto-modello”: un progetto non esiste, né può avere valore, che
relativamente a una situazione locale data.
?? Un progetto si costruisce nel tempo: è modificato, fatto maturare, negoziato dalle persone che vi
sono coinvolte (e eventualmente dalle opposizioni che incontra).
?? Prima di qualsiasi progetto conviene quindi chiedersi:
-
quali sono le finalità, i fini, gli obiettivi?
-
sono compatibili con i dati della situazione concreta?
-
qual è la storia del nostro Progetto? Quali tempi ci siamo dati, quali tappe?
2. I punti di riferimento di cui si dispone:
?? Il
dato
di
partenza:
che
cosa,
nella
situazione
locale
(geografica,
sociologica…)
favorisce/ostacola il nostro progetto?
?? Le risorse umane:
-
nella scuola: a quali competenze, a quali entusiasmi ci si può rivolgere?
-
al di fuori della scuola: chi potrebbe aiutarci?
?? Le risorse materiali: di cosa abbiamo bisogno (materiali, finanziamento …)? Dove potremmo
trovarlo?
?? Il fattore tempo: quali momenti di consultazione sono stati previsti (nel tempo scolastico o al di
fuori?)
3. Le difficoltà e i limiti da superare
?? All’interno del gruppo:
-
la dimensione del gruppo è adatta al nostro progetto? (che il gruppo sia troppo o troppo poco
numeroso può costituire un handicap)
-
i rapporti tra i partecipanti sono propizi al lavoro? Come risolvere le eventuali difficoltà
relazionali tra i membri del gruppo?
?? All’interno della scuola:
-
il progetto è stato presentato chiaramente a quelli che non hanno partecipato alla sua
elaborazione? (quale immagine se ne sono fatta?)
-
ci sono persone che si sono opposte? perché? come discutere con loro?
-
quali problemi materiali si pongono? (finanziari, disposizione e qualità dei locali ecc.)
4. Le degenerazioni da evitare
?? Come impedire che col tempo il progetto si DILUISCA in un consenso vago o, al contrario, si
IRRIGIDISCA, diventando un vero dogma e i suoi responsabili un ghetto o un club chiuso?
?? C’è identificazione tra il progetto del gruppo e il progetto della scuola? Se si, quali sono i
vantaggi e gli inconvenienti?
4.4 SCHEDA: IL CONTRATTO DI LAVORO COME STRUMENTO DELLE
DIFFERENZIAZIONE PEDAGOGICA
1. L’essenziale da ricordare
?? Bisogna essere in due per dialogare, lo stesso vale per un contratto! Un contratto è un impegno
tra due parti. La pedagogia del contratto non è una pedagogia della solitudine per l’alunno, ma
una pedagogia del dialogo con l’insegnante. Un contratto pedagogico non può essere formulato
interiormente. Ha senso solo davanti a UN TESTIMONE (l’insegnante, un latro adulto, ecc…)
?? Un contratto non è una vaga promessa, ma un impegno preciso e dettagliato che indica scadenze
e mezzi. Un contratto che non implica PROCEDURE DI VALUTAZIONE non è che un
discorso decorativo.
?? Un contratto fa un’ipotesi sull’avvenire (“mi impegno a fare questo, a sapere quello entro un
certo tempo…”). Suppone quindi una MEMORIZZAZIONE DELL’IMPEGNO PRESO fino
allo scadere del termine che è stato fissato. Valutare se un contratto è stato rispettato è ricordare
al contraente i termini precisi del suo impegno e comparare il suo progetto e la realizzazione.
?? Nella pedagogia del contratto, l’educatore è dunque l’INTERLOCUTORE dell’alunno (il
contratto immaginato è realistico? Adatto ai bisogni e alle possibilità dell’alunno?). L’educatore
è allo stesso tempo il TESTIMONE che ricorda gli impegni presi (per cui si suppone ci siano
strumenti di memorizzazione: scheda, quaderno, ecc….). E anche colui che valuta (Il contratto è
stato onorato? In che misura? Perché?).
2. Gli strumenti pedagogici del contratto
?? INFORMAZIONI SULLE ESIGENZE ISTITUZIONALI: quali sono i saperi, saper fare, saper
essere, che possono essere pretesi dall’alunno e secondo quale scadenza? (programmi di
apprendimento, regole del gioco sociale nell’edificio scolastico). L’alunno può difficilmente
formulare un contratto se gli obiettivi della formazione che segue non gli sono stati
esplicitamente spiegati. In cosa potrebbe impegnarsi senza sapere cosa ci si aspetta da lui?1
?? SENSIBILIZZAZIONE AL CONCETTO DI CONTRATTO: la parola e l’idea possono non
essere familiari a molti ragazzi. E’ meglio chiarire il termine con esempi scolastici e non. Si può
anche immaginare di sperimentare su un “campione”, cioè far vivere la realtà contrattuale in
situazioni semplici (per esempio: la puntualità degli alunni …e del professore).
?? L’INCONTRO PER L’ELABORAZIONE DEL CONTRATTO: è importante che l’alunno sia
libero di scegliere il proprio interlocutore perché il contratto corrisponda a un percorso
personale e non a un rito da compiere meccanicamente. L’adulto sarà attento a lasciare
esprimere le RAPPRESENTAZIONI che l’alunno si fa di se stesso, del proprio avvenire, delle
proprie capacità, delle possibilità che gli si presentano, anche se in questo primo incontro il
ragazzo, la ragazza, si esprime con impaccio o in modo estremo. Si mostrerà accogliente nei
confronti di tutto quello che viene detto, senza giudizi di valore (anche positivi), senza
interpretare (“dici questo perché …”), evitando di esagerare nel consolare o incoraggiare (“Su,
dai, non sei poi così male!”)
?? CIO’ CHE E’ NEGOZIABILE E CIO’ CHE NON LO E’ in un contratto:
??NEGOZIABILE:
?? L’ESISTENZA STESSA DEL CONTRATTO (un contratto è un percorso libero. Non si può
obbligare nessuno a fare un contratto, si accetterà quindi che alcuni alunni rifiutino di
impegnarsi in un contratto e preferiscano una gestione meno autonoma, coercitiva, della loro
formazione).
?? La possibilità di rompere il contratto prima del termine e di rientrare in una pedagogia meno
autonoma.
?? La scelta delle parti. Ha importanza per la validità dell’impegno la qualità del rapporto che si ha
con i testimoni davanti ai quali è stipulato il contratto. Può allora essere interessante ricorrere a
persone che non siano gli insegnanti: operatori psico-pedagogici, documentaristi, ecc.
??NON NEGOZIABILE:
?? la necessità di definire con precisione e in termini concreti l’impegno dell’alunno. Si possono
utilizzare con profitto i principi di redazione degli obiettivi operativi, precisando (a)il
comportamento da osservare, (b) le condizioni in cui si rileva, (c) la scadenza, (d) il livello di
riuscita richiesto. Per esempio: (a) l’alunno ipotizza di poter recitare (b) a memoria, (d) facendo
meno di due errori, (c) l’elenco dei verbi irregolari, per Pasqua.
?? la necessità di fissare una scadenza precisa e datata, non modificabile
?? la necessità di porre modalità e tappe di valutazione (la scelta stessa di questi strumenti potrà
essere discussa, ma una volta accettati, non vengono rimessi in causa).
3. Le difficoltà
?? La pedagogia del contratto è un’auto-valutazione anticipata delle competenze da acquisire:
l’alunno giudica che, entro un tempo dato, sarà in grado di… Cole tale, pone gli stessi problemi
di ogni forma di auto-valutazione. La valutazione è l’operazione intellettuale più difficile. Nella
tassonomia di Bloom, è l’attitudine più elaborata che presuppone la padronanza delle altre
attività intellettuali: memorizzazione, analisi, produzione, ecc. Ne consegue, evidentemente,
che, quando l’alunno è in grado di valutarsi da solo, non ha più bisogno di un formatore, è
arrivato al termine della sua stessa formazione! Si pretende allora di utilizzare uno strumento, il
contratto
di
auto-valutazione,
che
presuppone
l’avvenuta
formazione!
In
realtà,
la
contraddizione si risolve nella dinamica: l’auto-valutazione non è imposta tutta d’un colpo, ma
appresa a poco a poco. Inizialmente si aiuta l’alunno a elaborare il suo contratto e ad autovalutarsi, affinché diventi capace di farlo da solo. La pedagogia del contratto è una forma di
auto-valutazione assistita (o se si preferisce una pedagogia del dialogo)
?? La pedagogia del contratto è una pedagogia per tempi di pace. Porta a ottimi risultati quando il
contratto è seguito: ma cosa succede se non è rispettato? Non fare nulla, in quel caso, significa
non prendere sul serio il contratto; ma punire vuol dire abbandonare la pedagogia
dell’autonomia per cadere nella peggiore eteronomia! Anche questa volta, la contraddizione si
risolve in una prospettiva di dialogo pedagogico.
4. Le degenerazioni da evitare
?? LA DEGENERAZIONE PROCEDURALE. Con la pedagogia del contratto c’è forse il rischio
che chi educa il professore sia un notaio puntiglioso che passa il suo tempo a redigere atti
notarili insieme agli alunni e li perseguita per un codicillo ambiguo o per una virgola mal
riposta! Con lui, gli alunni, qualunque cosa facciano, non sono mai liberi dagli impegni presi!
?? LA DEGENERAZIONE DEMAGOGICA. Al contrario, il professore che educa può non
prendere abbastanza sul serio i contratti stipulati con gli alunni…Considera questi impegni
come un programma elettorale e assolve le mancanze con benevola indulgenza. Con lui, gli
alunni, qualunque cosa facciano, sono sempre liberi dagli impegni presi! Nei due casi,
mostrandosi troppo o troppo poco esigenti, si perde la dimensione del dialogo che dovrebbe
essere l’essenza della pedagogia del contratto.
NOTA BIBLIOGRAFICA
M.G. BERLINI, A.CANEVARO, a cura di, Potenziali individuali di apprendimento, La Nuova
Italia, Scandicci (FI), 1996.
A.SEMERARI, I processi cognitivi nella relazione terapeutica, N:I:S:, Roma, 1991.
A.DE LA GARANDERIE, Profili pedagogici, La Nuova Italia, Scandicci (FI), 1989; ediz. originale
1987.
Ph. MEIRIEU, Lavoro di gruppo e apprendimenti individuali, La Nuova Italia, Scandicci (FI),
1987; ediz. originale 1984.
I Consigli e L’aiuto reciproco, in A.CANEVARO, a cura di, Handicap a scuola, N:I:S:, Roma,
1983, e ristampa.