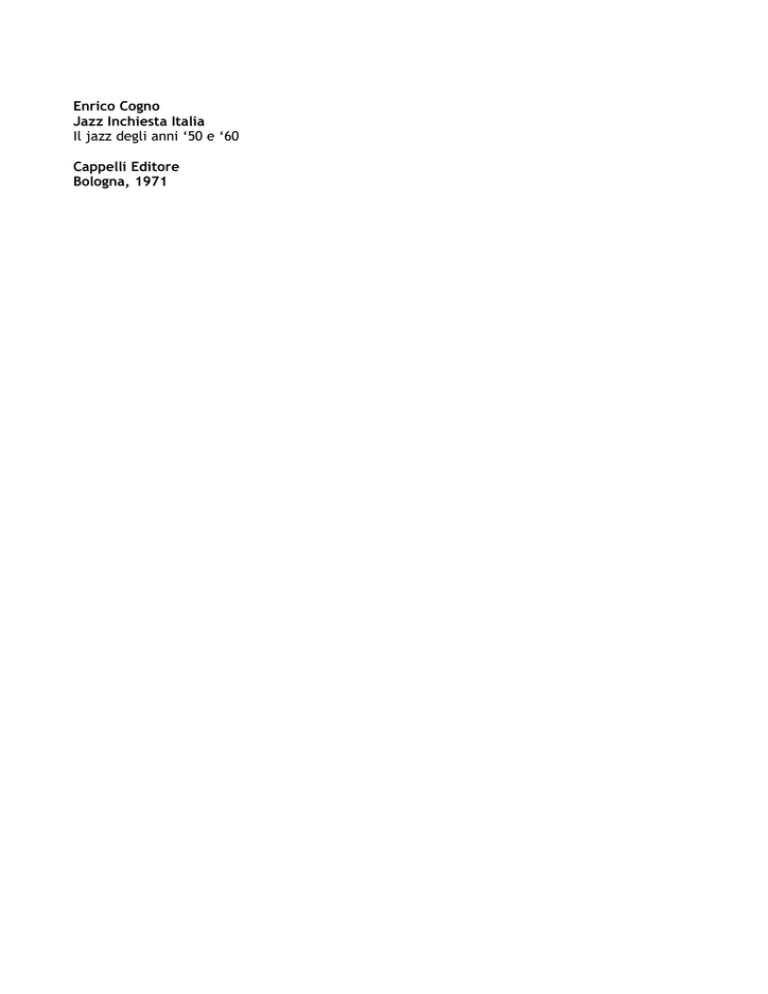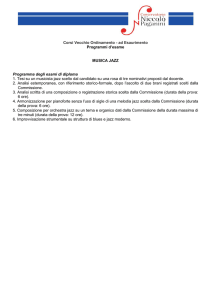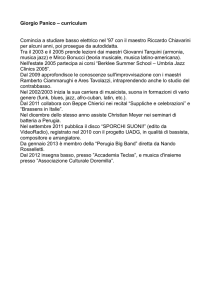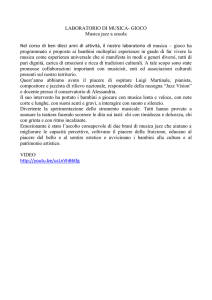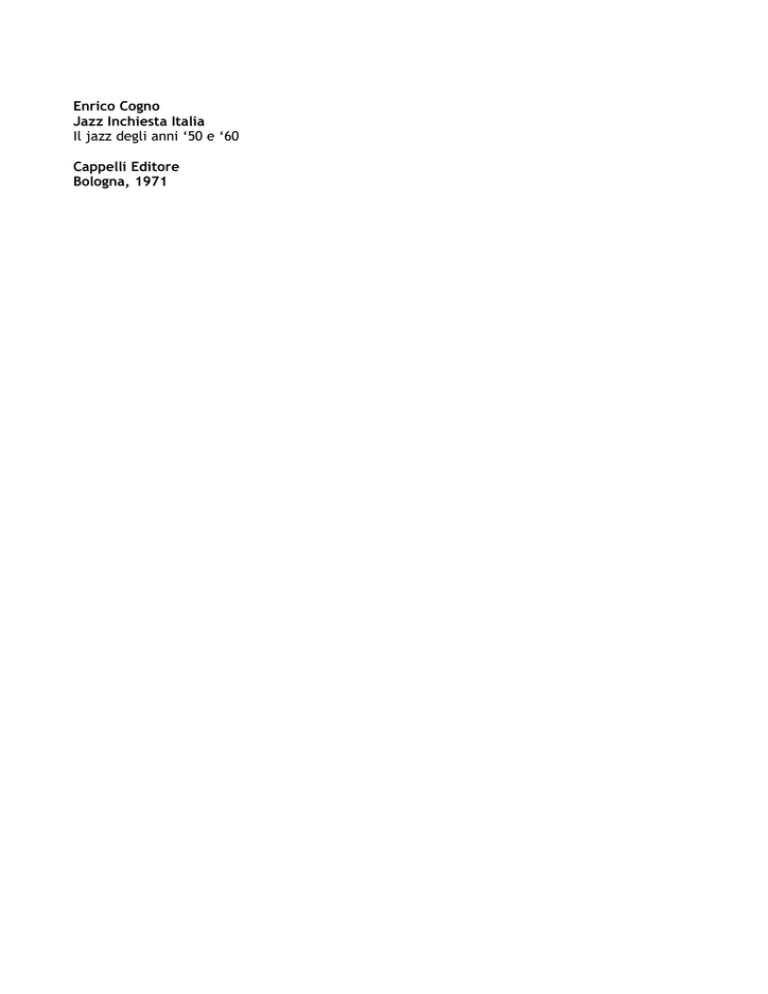
Enrico Cogno
Jazz Inchiesta Italia
Il jazz degli anni ‘50 e ‘60
Cappelli Editore
Bologna, 1971
Introduzione
Chi è l’uomo del jazz italiano?
Un poeta o un artigiano della musica?
Chi è il critico italiano di jazz?
Un giornalista reduce dal Cantagiro? Un musicista fallito? Un esaltatore d'avanguardie per credo
politico o un conservatore per inadeguatezza culturale?
E per la folla, il jazz italiano cos’è?
JAZZ INCHIESTA ITALIA, propone le risposte a questi nuovi interrogativi più con finalità di
“informazione stimolante” che di trattazione dotta del fenomeno.
E’ un racconto giornalistico formato dalle testimonianze di musicisti, critici, attori, studenti,
tutte piastre di un mosaico alternate in modo solo apparentemente casuale, una sequenza che
del jazz ha il ritmo e la visceralità.
Prefazione
Il jazz moderno è diventato un fenomeno complesso e multiforme, chi si dirama in varie
articolazioni e che non teme all’occorrenza di accostarsi alla ricercatezza dell’arte moderna.
Soltanto la presenza di qualche glorioso superstite può restituire ancora nella sua autenticità
quel senso univoco di robusta ispirazione popolare che, più di quaranta anni fa, aveva attirato
sul jazz l’interesse e la simpatia di quasi tutte le forze vive della musica contemporanea. Oggi
anche il jazz percorre vie difficili, non meno difficili di quelle degli indirizzi più avanzati della
odierna musica d’avanguardia. Ed è giusto che sia così: probabilmente sarebbe un errore volerlo
mantenere a forza, come se fosse imbalsamato, su quelle posizioni di semplicità popolare di cui
solo Armstrong e gli artisti della sua epoca conservano il segreto. Ma anche il jazz di oggi
comprova la propria positività precisamente attraverso l’evoluzione che subisce: proprio perché
alle
sue origini c’erano la verità e la forza dell’ispirazione popolare, il jazz si dimostra capace di
sopravvivere e di seguire un proprio destino artistico, che magari lo allontana dalle posizioni
originarie. Ma non si vive senza trasformarsi, e anche chi è rimasto sentimentalmente attaccato
alla nostalgia del jazz della sua giovinezza, anche chi ha perduto il contatto con la molteplicità
degli sviluppi più recenti, così prolifici di nuove formule e nuovi stili, se fa tanto di accostarvisi,
non tarda a riconoscere in questi sviluppi le conseguenze inevitabili dell’antico ceppo.
E’ ancora l’antico incendio che alimenta le nuove fiamme, o fiammelle che siano, e anche nelle
sue recentissime formulazioni il jazz resta tuttora una manifestazione genuina della musica del
nostro tempo: senza avere spento l’originario impulso popolare, ne documenta le possibilità di
affinamento e di evoluzione stilistica in accordo con il volgere dei tempi: basterebbe questo per
fare del jazz un capitolo insostituibile nella musica moderna.
Massimo Mila
Feeling: tocco, sensibilità, sentimento.
E’ scritto sui dizionari, ma la gente del jazz non usa tradurlo.
Dice: il jazz è feeling (o è swing, è blues) come chiave di un codice che sconfina in campi
semantici che un dizionario non riporta. Parlando (o scrivendo) di jazz, è importante far rivivere
un tratto spontaneo, non mediato, che proceda sul piano dell’emotività più pura (pulsazione,
fremito, mixage di sentimenti tra il lirico e il disincantato), un modo di rendere jazz le parole,
di usare un segno in sintonia con i problemi degli uomini che del feeling ne hanno fatto un modo
di vivere.
Il jazz è compromissione e comprensione: per parlarne serve compromettersi con chi lo produce
e capirne il perché.
Le biografie da sole non servono a questo.
Per sensibilizzare anche il fruitore meno attento serve scoprire la seconda parte di ogni
musicista.
Si sa qualcosa sempre e soltanto della prima, quella che va dallo strumento in avanti, mentre
dell’altra (quella che tira fuori dall’ oggetto le note, le idee, i suoni della rabbia, dell’amore, la
poesia, la vita) l’uomo, insomma, la gente, l’uomo, lo conosce sempre troppo poco o troppo
tardi.
Il jazz in Italia, ha avuto molti giudici e pochi testimoni.
Ora che serve affermarlo (a fianco dei fenomeni della cultura ufficiale) come musica di poesia e
non di consumo, serve, paradossalmente, la tecnica del consumo, non quella della poesia: una
inchiesta rivolta a scoprire l’ambiente e la problematica di chi produce il jazz, di chi lo giudica e
di chi lo ascolta. Il tutto impregnato di feeling, fatto con discorsi grintosi, diretti a stimolare
oltre che a informare.
Negli anni ’70 una storia (in senso tradizionale) del jazz soddisferebbe chi infila i libri sugli
scafali con amore feticistico e lascerebbe insensibili quelli che, di una musica viscerale come il
jazz, vogliono un documento che ne analizzi la sfera sociale ed umana. Vivere il jazz al di fuori
di questo contesto significherebbe esaminarlo spogliato della sua caratteristica più importante.
Così l’uomo del sassofono sarà del fianco del vigile urbano, il critico di fronte alla fioraia, lo
studente con il programmatore RAI: un collage che tenderà a creare un habitat in cui le
testimonianze (non i giudizi) cercheranno di distinguere i buoni poeti dai buoni artigiani, sul
piano dello stimolo emozionale.
Nel jazz la saggistica, caricata di feeling (denominatore comune per questo dialogo) può
sconfinare e fondersi con la narrativa, può vivere di ricordi e da questi, operando per sintesi,
trasformarsi in ricerca.
Non potrebbe, trattandosi di jazz, non essere racconto di vita.
“Dobbiamo andare e non fermarci mai finché non arriviamo”
“Per andare dove, amico?”
“Non lo so, ma dobbiamo andare”
On the road
Jack Kerouac
Incontro Enrico Intra alla Galleria del Corso, a Milano.
“Libro bianco sul jazz italiano: uomini e problemi nostri. Il tuo pensiero?”
“Viviamo, vedi in un momento di crisi per la fusione (o lo scontro) di una civiltà nuova contro
una vecchia e decadente. Del jazz si ha un’immagine superata, del negro sudato che suona in
una “cave”: no! Servono suoni che rispecchino la nostra società.
Non un discorso alla moda, ma un discorso attuale. L’unica salvezza contro le imposizioni della
moda è la ricerca di un linguaggio personale. Serve il coraggio di cercare una strada propria.”
“L’hai trovata?”
“Almeno la cerco.”
“Come definiresti il jazz, oggi?”
“Come da sempre: musica, musica totale. Questo fatto probabilmente non è accettato da chi
vive dicendo ai miei tempi…
Molti confondono (hanno confuso) i propri momenti belli del passato con la musica di quei
momenti e quando si guardano attorno (si sono guardati attorno) hanno rifiutato la realtà e si
sono ributtati nel mondo dei loro ricordi, non accorgendosi dell’effetto deformante del tempo.
Per questi il jazz è già morto da anni”
“Com’è il modo del jazz italiano?”
“Ammalato.”
“Di cosa?”
“Di ignoranza, di un provincialismo ottuso, spaventoso.”
“Di jazz si può vivere?”
“Vivere e morirne (per fame).”
“Non pensi che il così poco ampio respiro del jazz in Italia sia dovuto ad un centro
compiacimento di tutti noi, jazzmen, nel considerarci un’èlite?”
“Qualunque forma d’arte parte da un’èlite e parla ad una èlite, quest’ultima intesa come crema
di un qualunque strato sociale, anche del più basso.”
“Una forma per fare del jazz e riempire ugualmente lo stomaco potrebbe essere il
dilettantismo?”
“Con i risultati che il dilettantismo italiano ha fornito? Assolutamente no.
Il dilettante deve soddisfare solo se stesso e lo fa principalmente copiando. Si suona addosso e
se ne compiace.”
“E il professionista?”
“Ha un impegno. E’ compromesso. Ha degli obiettivi da raggiungere. La salvezza (e la fatica) del
professionista passano attraverso la consapevolezza. Il dilettante si
auto-assolve con la clausola della buona fede. Al professionista la buona fede non serve a
salvarlo da certi impegni che si è preso operando, aprioristicamente, una scelta. Oltre a
raggiungere certi risultati, è importante esaminare come questi sono stati raggiunti.
“Nella tua musica, ad un certo punto si è avvertita una rottura: hai cambiato strada. Perché? “
“Ero obbligato a creare degli standard, non c’era più improvvisazione.”
“E la coerenza?”
“Detesto la coerenza. L’uomo ha il dovere di cambiare la sua opera, se crede, dopo un’ora.
Questo è sentirsi vivi, operare proiettati nel presente–futuro.
Questo può avvenire con fratture nette, oppure con l’inserimento graduale di nuovi stimoli.
Recentemente ho affrontato questo problema per la mia Messa d’Oggi:con una chiesa allineata e
rispettosa della tradizione quale abbiamo sarebbe stata improduttiva una rottura brusca, una
uscita violentata dai canoni. Ho preferito socchiudere, e non spalancare, una porta arrugginita.”
“Il risultato?”
“I valori reali delle cose li decide il tempo.”
“Questi stimoli nuovi li raccogli dalla musica che ascolti?”
“Ascolto pochissimo la musica degli altri .”
“Proposte: cosa fare per smuovere la situazione?”
“Portare l’educazione musicale nelle scuole. Non quando è tardi, come avviene adesso. Inoltre
occorre agire presso l’ente radiotelevisivo affinché i programmi non continuino ad essere
modellati sui risultati del grande spettro, l’indice di gradimento. Basterebbe, per vergognarsi,
fare un confronto con i programmi delle altre nazioni europee. Sia la musica classica sia il jazz
devono essere inseriti nei grossi spettacoli, quelli diretti al grande pubblico. Sino a che andranno
in onda sul terzo programma convinceranno solo gente già convinta.”
“Quale via d’uscita vedi per il jazz, al di fuori della Rai?”
“Nei giri che ho fatto in Italia per conto della Gioventù Musicale ho notato un grande interesse
proprio nei giovani. Anche tra gli operai, nei concerti presso le fabbriche. Loro, il jazz, lo
vorrebbero seguire, ma non sanno come. Dove vanno a finire le centinaia di milioni che lo Stato
destina ai programmi culturali? Ogni città dovrebbe avrebbe il suo teatro stabile di jazz. Il fatto
è che di fondo, rimane (e siamo negli anni ’70!) ancora da risolvere il problema sociale e
culturale italiano. Anche il cinema potrebbe trovare nel jazz un filone meraviglioso. Lo hanno
fatto, in alcuni casi, sempre ottenendo ottimi risultati. La ricerca del rapporto musica–immagine
è affascinante.”
“Grazie. Biografia? “
“Niente! Enrico Intra vive. E’ vivo, basta.”
Quattordici anni dopo di Dino Piana è rimasto uguale soltanto l’involucro, la parte che si vede
quando uno conosce poco una persona. Dentro, è maturato, non lo conosco più.
E’ esigente con il jazz, critico, consapevole.
Ci ritroviamo in una Roma accaldata, luglio, mogli in vacanza, casa libera per sentire Roswell
Rudd e Gato Barbieri nell’ultimo free; poi Miles Davis, gustato come un vecchio cognac, con i
piedi sul tavolo.
Prima, in trattoria, dopo quattro birre ghiacciate, eravamo riusciti a sentirci di nuovo amici,
piemontesi emigrati senza rimpianti, immunizzati dai problemi del mondo grazie alla birra forte,
felici, caldi e storditi per ricordare bene.
Quattordici anni.
Piana arrivò una domenica mattina (solita jam session al Circolo Torinese del Jazz) con il suo
furgone rosso del Lyon’s Tea. Era triste o allegro a seconda di quante scatole di tè vedeva,
povero Dino sbattuto sul lastrico da un giorno all’altro, lui con tutto quel jazz che gli rodeva
dentro mentre prendeva gli ordini nelle drogherie. Timido, buono, la parlata ancora un po’ larga
degli alessandrini, tirò fuori il suo trombone (suonavamo un blues, era di tiro, una specie di
segno della croce prima di mangiare) e ci annientò, uno per uno, senza strafare; era una spanna
sopra il migliore di noi.
La ritmica aveva trovato quattro mani e dieci cuori in più, tutto bolliva, lo swing usciva dalla
finestrella della cantina e rotolava sulla strada .
Alla fine (chi ha il coraggio di chiudere un blues così in una jam? Durò due ore) non ci andava
neanche di parlare perché i sei bravo o i Dio, che forza suonavano falsi quando stavamo per dirli.
Venne a trovarci tutti i pomeriggi nel negozio dove Bob Brookmayer e Maynard Ferguson giravano
per ore a tutto volume. Aveva sete di jazz e ne bevve da morire. Con la Coppa del jazz, ne ’60,
lo conobbe il resto dell’ Italia.
Il resto fu facile. Con dieci anni di successi, dischi, concerti (tutto è documentato sulla parete
dei ricordi belli, quella dei ritagli, delle foto, delle locandine di tutto il mondo: la vendetta sul
Lyon’s Tea dei tempi duri) Dino Piana è arrivato agli anni ’70 in tempo per aver importato tutta
la lezione del jazz ed aver capito quanto poco sia servito fatto in questo modo.
“Abbiamo copiato tutto, sempre. Abbiamo prefabbricato ogni cosa. Per molto tempo questo è
andato bene: il piano gettava un accordo e si imbastivano sopra le idee, belle, rotonde, giuste in
ogni nota, leziose.
Ad un certo punto, sullo stesso accordo, si è sentito quanto fosse stancante , vuoto, mentre altre
note, sempre giuste, sempre belle, sempre più leziose.
Le cose da dire erano più grandi di un accordo, serviva più spazio”.
Mi parla di Un frenetico sapore che ha registrato con Franco Tonani, una delle cose che ricorda
con più simpatia fra tutta la sua produzione. Mi parla (nello stesso momento, è indicativo) di suo
fratello, che ora dipinge con una certa convinzione e che nella pittura arriva a momenti di
grande crisi e con l’ultimo quadro spesso capisce di dover annullare tutto quanto prodotto
prima.
In questo trovo Dino Piana cambiato dentro.
Tra una forchettata e l’altra mi spiega i movimenti dei temi che ha inciso.
Imita il trombone con la voce (il cameriere non ci fa caso, è il ristorante vicino alla Rai dove si
va a mangiare all’uscita delle prove e di gente che suona senza strumento ne vede molta) e
scopro che nell’ampiezza di questa musica (apparente agio, libertà, assenza di limiti) il rischio è
grosso, stimolante: o suoni con la scintilla o smetti.
Tre note di questo mare di libertà devono dire quello che trecento non riuscivano a dire in un
chorus completo. O il bluff è totale o è totalmente assente.
Parli di te stesso, ti scavi nello stomaco tutto il blues che hai accumulato, filtri lo swing per
dire, in modo che non ti possa ingannare, tutto quello che hai imparato dal jazz. Devi strappare
l’idea dal cervello di chi suona con te, prendere al volo la frase che qualcuno ha buttato e
stenderla con ordine sul filo che ti sei teso davanti.
Piana, adesso che è un professionista arrivato, quando passa negli uffici amministrativi Rai per
ritirare una busta che gli ha risolto la vita spicciolata , da buono e semplice com’è, potrebbe
anche sforzarsi di pensare che in quella busta esiste la risoluzione di tutti i problemi, anche
quelli relativi alle cose che non ci comprano ai supermercati. Invece se li crea, o meglio, non
svia i problemi che esistono per un musicista che voglia fare del jazz negli anni ’70.
Lui che non è un teorico, che non potrà certo essere accusato di voler dire con la sua musica le
stesse cose che potrebbe dire alzando un cartello di una marcia contestatrice, lui che potrebbe
continuare a fare il suo onesto jazz come da quindici anni sta facendo e improvvisare con
armonizzazioni perfette su giri complicati, vivere di rendita, insomma, lui sente la necessità di
una nuova produzione, sente il bisogno di abolire le battute che costringono il discorso musicale,
capisce che è proibito proibire.
Una ricerca scomoda, non richiesta, stimolante. Questa capacità di vivere così intensamente il
jazz, di buttarsi allo sbaraglio, mi fa pensare che sia tempo di dare al jazz italiano un valore che
prima non ha mai avuto (e che non ha mai voluto o potuto avere).
Sono sicuro, ora che ha imboccato le strade del mondo alla ricerca di stimoli nuovi, che il jazz
potrà ricevere degli apporti significativi anche dai nostri musicisti, a patto che noi si sia i primi a
credere in questo. Noi, musicisti e critici. Direi soprattutto i secondi.
Rubo una frase a Alberto Rodriguez: “La critica deve diventare sempre più una scelta,
individuale, politica, umana. E’ una vecchia questione, questa, già sostenuta da Baudelaire,
Marx, Apollinaire e cento altri, ma che forse richiede una continua ripetizione. Bisogna cioè che
il critico, e chi per professione e privilegio può scrivere ed essere intermediario, suggeritore e
soprattutto formatore di coscienze, impari a schierarsi, ed insieme (sono due condizioni molto
legate) a mettersi in crisi con la musica di cui segue parallelamente la vita.”
Roma, 1971
Rava, fratello
hai fatto troppa strada perché possa crederci. Per me hai ancora i capelli a spazzola, sei l’amico
da chiamare con il cognome, come fanno i ragazzini a scuola. Per me Rava è quello che veniva
con Belgrano (che tenerezza il Rosso che copiava Zoot Sims e “squadrava” anche il blues) la
domenica pomeriggio, nel laboratorio di “ceramiche artistiche” di mio padre; ti nutrivi di Miles
Davis per settimane, consumavi i dischi anche quando non c’era più una frase, un accordo, un
fruscìo che non sapessi già a memoria. Per me Rava è quello che viveva, come tutti di noi
(eravamo giovani borghesi, ma allora esserlo non ci sembrava così grave) nei negozi di dischi ad
aspettare che arrivassero i long playing d’importazione, e con noi Franco Mondini, Maurizio
Lama, Dino Piana, Raoul Marietti.
Ecco, butti lì un po’ di nomi e ti viene un groppo in gola. Maurizio Lama era appena arrivato a
Torino, ancora intatto il suo accento romano, un ragazzone buono più di tutti noi, un grande
pianista poi distrutto nelle lamiere di un auto.
Quando morì andai nel bagno a piangere (e l’ho fatto solo per mio padre).
Voi due eravate inseparabili. Alla sera si provava (ti ricordi?), sere d’estate che a Torino ti fanno
pensare a Pavese, con la collina che ti manda l’odore di terra bagnata, i ragazzini sino a tardi a
correre sui viali e noi a rifare Gerry Mulligan e Chet Baker.
Ho ancora le fotografie della Big Band di Pedro Brovarone, quel pazzesco incrocio di gente in
gamba e di scarti musicali, cosa da libro Cuore, studenti, portalettere e muratori.
Tu fingevi di leggere i pezzi (anch’io, quanto a questo); fingevamo di leggere, Rava, ma ci
importava così poco sbagliare sempre le terzine e
i trentaduesimi; il jazz l’avevamo nel corpo, non era sul leggio. Tu l’avevi piantato in modo così
profondo da far male.
Poi, per me la 46° Aerobrigata a Pisa, Servizi Operativi Generali: jazz, addio.
E tu hai incominciato a fare sul serio. Ci siamo rivisti ad un concerto ed eri già un altro. Il primo
disco per la collana del jazz della Centra era ancora intriso di californiano, ma era un passo
importante.
Il salto l’avevi già fatto: avevi rotto i flirts con le nostre amiche borghesi, lasciato l’azienda di
tuo padre (non ci poteva credere, quando lo incontrai, anni dopo, non sapeva rassegnarsene).
Con Gato Barbieri e Steve Lacy avevi già visto oltre la sponda del Po.
Tu sei uno dei pochi, che non ha suonato altro che jazz.
Non una stagione al mare da studente ( cha- cha- cha- contro vitto e alloggio per un mese a
Castiglioncello) non un contratto ad Amburgo (dalle ventuno alle cinque, a St. Pauli, venti
marchi, puttane e ubriachi) non una veglia a Capodanno (caffè dei musicisti: “uno libero per
stasera, con vestito nero?”): mai.
Soltanto jazz, prima dolciastro (Chet Baker ci sembrava tanto grande) poi Miles Davis (diceva
molto di più : “ha cuore e cervello”). Davis drago, mostro scorbutico, furb’uomo che entra nelle
porte aperte dai geni, butta due note (sordina alla tromba) e solleva un mondo di cose così
belle da sembrare un po’ magiche (colore, piccole luci, bolle leggere) un mondo libero, libero.
Cosa vuol dire per un italiano la libertà? Nell’arte, nella musica, ma anche soltanto libertà
toutcourt. Oggi leggevo la risposta che Montanelli dava ad un collega, a questa domanda: “La
libertà, per noi, consiste nel fare il comodo proprio. Questo è il concetto dell’anarchia, e
l’italiano lo confonde con la libertà, che è invece possibile solo con l’autocontrollo.”
Come reagisce un italiano di fronte ad una musica libera? Del jazz, io credo, possiamo farcene
un alibi o una ragione di vita. Può essere una scusa per eludere e armonie di un giro troppo
complicato o un modo per prendere coscienza della nostra posizione nel sistema. Tu, con i
romani del free jazz, hai avuto il coraggio di fare la tua scelta: no alla jam session borghese, alla
macchina di papà, all’azienda avviata. Avresti ugualmente potuto evitare di contaminare il tuo
jazz con le canzonette, facilmente, senza merito, rimanendo nel tuo ambiente. Avresti potuto
(meno facilmente, ma sempre senza merito) fare il free jazzman della domenica.
Avresti potuto ancora inventare (lo fanno in molti, li conosco) scuse tecniche
(“Adesso studio due ore al giorno, quando sarò a posto con lo strumento mi lancerò“) e avresti
aspettato tutta la vita, spostandoti sempre in avanti il traguardo, in una stupida corsa che non
avrebbe mai avuto un arrivo.
Invece sei partito: con una imboccatura così così, copiando Miles Davis, seguendo le mode,
facendo tanti trilli quando non ti veniva l’idea, mai hai avuto la meravigliosa faccia tosta di
comprometterti con il jazz.
Non sei solo bravo, Rava, perché hai suonato a New York con Ruswell Rudd.
Sei bravo perché hai saputo comprometterti sino al collo, lasciando le sabbie mobili di una
vischiosa borghesia torinese per immergerti nella vita di jazzman, buttando fuori dalla tromba
tutta la repulsione per questo nostro modo di vivere, soffocato dai non si può e non si deve della
vita. Voglio dire, Rava, che essere un uomo del jazz (e dire qualcosa nel mondo) oggi è possibile
anche per uno nato a Torino o a Roma, Merano, Caserta, Vercelli o Dovevuoi).
Prima non sapevano si potesse dire qualcosa che qualche negro in America non avesse già detto.
Non sapevamo o non c’erano i motivi per farlo, mancava forse la condizione ambientale perché
ciò potesse accadere. O forse c’era tutto questo e non abbiamo (o non hanno, loro, quelli venuti
prima, perché noi allora leggevamo Salgari) saputo scoprirlo.
Siamo (e sono) stati sviati dai giudizi di imbecilli come Panassiè, che non ammetteva il jazz
suonato dai bianchi, razzista alla rovescia. Siamo (e sono) stati coperti di nazionalismo ottuso
che ci ha costretto ad intendere il jazz come un fenomeno negro che nasce e si coltiva, come un
tubero, tra questo e quel parallelo. No. Il jazz non appartiene più al folclore americano, ma alla
cultura del mondo. Accetto la tesi di Umberto Santucci, quando apre l’Enciclopedia Universale
dell’Arte e traccia la differenza tra arte provinciale e arte periferica. La prima, pur ricevendo
moduli e proposte originali dalla cultura della madrepatria, partecipa attivamente a tale cultura
perché ne rielabora i moduli, tenendo conto della propria tradizione culturale e si realizza come
arte fortemente influenzata da quella originale, ma al tempo stesso dotata di caratteri distintivi
sufficienti a individualizzarla. L’arte periferica, invece, riceve passivamente i moduli che le
giungono dai diversi centri culturali e, assolutamente priva com’è di risorse proprie, riduce
presso questi stimoli in elementi cristallizzati ed esteriori. Tutto il jazz non americano deve
essere considerato arte provinciale. Basta prendere coscienza di questa funzione del jazz
suonato oltre un certo parallelo, basta non scadere nel discorso periferico.
Basta voler vivere, intensamente, il jazz dal di dentro.
Ti sei buttato, Rava, hai avuto il coraggio di essere un pazzo di vivere.
Per questo, bravo.
Roma. Giorgio Gaslini mi fa strada nel suo ministudio di via Gregoriana: lo spazio è tutto preso
dal pianoforte, dal tavolo gonfio di spartiti.
Sopra i pentagrammi è posato un foglio bianco, scritto con un pennarello rosso a grandi lettere:
danza, poesia, ferocia. Gaslini si mette sempre davanti dei cartelli quando compone, per avere
fissa, di fronte a sé, l’idea centrale della composizione che sta creando.
Parliamo di questa idea dell’inchiesta (una conseguenza del mio bisogno di scrivere o parlare di
jazz, che è come suonarlo: diverso è solo lo strumento)
“E’ il momento giusto” – mi dice Gaslini – “per far prendere coscienza del fatto che il jazz
incomincia ad essere accettato dagli ambienti della cultura.
Da neorinascimentale quale sono, ritengo indispensabile affermare che il musicista d’oggi (ma
soprattutto quello dei prossimi anni) deve essere un individuo al quale si possa chiedere sia un
concerto di jazz, sia un brano di musica elettronica, o un balletto, o un’opera. Non è più
accettabile
lo specialismo, perché è il risultato di una visione settoriale dell’uomo, incompleta, non totale.
E’ un frammentarismo sciocco di nascita centroeuropea.
Io sono partito dal jazz, sulle barricate del dopoguerra, e nel jazz mi sono realizzato. Nel 1949
mi sono ritirato dalla scena pubblica per otto anni, per due motivi: andavo maturando delle
sintesi successive più ampie, sia umanamente, sia musicalmente. Inoltre si trattava di decidere
se entrare, o no, nel mondo del consumo. Quelli che sono stati al gioco sono entrati nel giro
commerciale. Il bivio era: integrarsi o uscire. Io, tra le due soluzioni, ho scelto la terza. Mi sono
ritirato in silenzio ed ho fatto delle sintesi mie per riproporle quando mi sono sentito pronto.
Infatti nel ’57 sono uscito con Tempo e Relazione, la sintesi, appunto, delle nuove esperienze
jazzistiche e di quelle della musica contemporanea, sintesi nate attraverso sei diplomi di
conservatorio, attraverso Kenton e Stravinsky. Sono praticamente approdato alla dodecafonia
senza accorgermene. Dopo, naturalmente, non ero soddisfatto, nel senso, che questi risultati
raggiunti non risolvevano i problemi che erano principalmente di ordine esistenziale, oltre che
musicale. Quindi sono venuto fuori con proposte staccate e con proposte sintetiche, come Totale
1 e 2.
Poi mi sono orientato verso il teatro. Opere tascabili, opere da strada, come Un quarto di vita,
ora richiesta a Broadway, sino a Colloquio con Malcolm X, che è un azione musicale, una forma
di jazz- theatre.
Ora sento che il discorso è maturo, sento che il jazz è un fatto culturalmente importante per
quello che ha detto (e per come lo ha detto) negli ultimi anni”
Salvatore Quasimodo di Gaslini ha scritto: “E’ uno degli interpreti più vivaci e profondi della
voce contemporanea (non direi d’avanguardia nel senso specifico e decadente del termine) e si
rivela autore degno di segnare la sua disperazione interna nella struttura della musica d’oggi.”
Dopo Tempo e relazione, Gaslini ha pubblicato quaranta dischi. I più importanti: Oltre, Dall’alba
all’alba, Nuovi sentimenti (che ha ricevuto le cinque stelle dal Down Beat), La stagione
incantata, Grido, Jazz Microkosmos 1968 e 1969 e più recentemente, Africa. La formazione del
quartetto è quella collaudata in infiniti concerti: Giorgio Gaslini, pianoforte, Gianni Bedori, sax
tenore e flauto, Bruno Provetto, controbasso, Franco Tonani, batteria. Di Gaslini il registra
ungherese Miklo Jansco ha scritto, dopo la sua collaborazione alla colonna sonora del film
“Smetti di piovere” : “Secondo me, l’arte è un servizio, un servizio per il popolo. Ma fare questo
servizio e rimanere degli innovatori, rimanere fedeli a se stessi, alla propria individualità, non è
facile. Amico mio, a te è riuscito”.
Gil Cuppini: “Mancava la spinta della critica. Si svegliano tutti, adesso che il jazz in Italia si è
svegliato. Come si siamo arrivati, a questo momento? Facendo spesso la fame, per passione. La
passione è la mia vita, che suono anche per due soldi, non quella di chi vive di rendita con i
contratti alla Radio. Ricerca! Rivoluzione! Ma cosa vuoi rivoluzionare, se ancora dobbiamo
assimilare la maggior parte del jazz che abbiamo ascoltato sino adesso! Io sono per l’evoluzione,
non per la rivoluzione. Quando si è sovvertito un sistema non si è fatto altro che crearne un
altro. Le avanguardie dovrebbero essere un punto di partenza e sono invece un punto di arrivo,
per molti. Operare delle ricerche indirizzate verso la musica europea ci fa correre il rischio di
copiarci da noi. Porta ad una stasi. Arriveremo a scoprire una musica di secoli prima. Il jazz è il
prodotto di un connubio di razze, non solo di quella negra. I negri sono stati il medium che ha
permesso l’inizio di un nuovo linguaggio musicale, ma la musica che hanno usato aveva, per
l’aspetto armonico–melodico, già delle matrici europee. Adesso serve sviluppare l’essenza di
questo discorso, perché ai musicisti (in particolare agli italiani) è mancata la base culturale per
farlo. La ricerca che è utile oggi nel jazz è una ricerca orientata all’interno del jazz stesso,
perché siamo andati molto avanti senza aver analizzato con la profondità necessaria le tappe
precedenti. Non deve essere disconosciuto il valore del classico: dobbiamo dire cose nuove, ma
passando attraverso quello che è già stato fatto. Mi sta bene il free-jazz per la sua libertà di
espressione, ma non dimentichiamoci che ci sono cento, mille Ornette Coleman in Asia, e
suonano così da sempre, perché usano un diverso modo tonale. Per il free-jazz il setaccio del
tempo sarà inesorabile.
Io amo comporre, più che suonare. Quando compongo trovo il modo di sviluppare una ricerca
che è ancora vastissima, enorme, della quale non vedo un possibile esaurimento. Ne ho avuto la
conferma con la prima parte di un’opera musicale che ho incominciato a concepire molti anni fa,
A New Day, che è solo un aspetto di un discorso che ancora si sta sviluppando: è l’inizio, la
genesi. E ‘ solo un nuovo giorno, non un giorno nuovo. Spiega musicalmente, il ciclo nascita-vitamorte: si apre il giorno, poi inizia
il lavoro, poi ti assalgono i pensieri del giorno precedente, ti ritrovi nella routine, infine scoppia
il tema d’amore. Questa suite è il primo punto di una intuizione che risale al 1958. La storia, per
attrazione allegorica, di come il discorso sociale sia in contrasto con quello culturale. Si svolge
nei grandi magazzini (un punto in comune di tutte le società del mondo: li trovi a Milano come
ad Hong- Kong, a Vienna come a New York), luoghi dove puoi trovare di tutto, dai fazzoletti alle
pentole, dalle scarpe alla cipria, ma non puoi fare all’amore. Un po’ la storia di Adamo ed Eva:
quando Dio ha dato la donna ad Adamo, questa era come un manichino. Una donna che hai ma
che non puoi avere. Eva è un manichino parlante: Adamo, cioè l’uomo, un uomo di oggi, è un
jazzman. Ebbene in questa storia che io vivo musicalmente trovo modo di scoprire tante cose.
Soltanto girando un accordo riesco a riproporre una cosa diversa da quella che ho appena
annotato. Perché dovrei lasciare questa ricerca che è ancora così lontana dal punto di arrivo per
farne altre, oggi che ancora devo finire di scoprire un discorso che ho iniziato molti anni fa?
Molti giovani hanno preso una parte della tradizione, arrivando, a volte, a degli assurdi: l’altra
sera (è un esempio banale, ma ha la sua morale) dopo un concerto a Medina con Romano
Mussolini, un batterista beat mi ha domandato cosa fossero quelle cose che adoperavo, oltre alle
bacchette che erano l’unico mezzo a lui noto per battere le pelli. Erano delle “spazzole”
comuni, semplici brush. Ma non le aveva mai viste!” .
Questi sono gli appunti che sono riuscito a prendere (non avevo con me il registratore)
inseguendo per Milano il batterista Gil Cuppini, maglietta rossa, crocefisso hippy, zazzera nuova
fiammante. Riscritti molto tempo dopo, sono slegati almeno quanto turbinosa è stata
l’intervista. Di Gil Cuppini hanno il carattere prevaricatore, trascinante, convinto, assolutista:
hanno la grinta di ha vent’anni di jazz da raccontare, iniziando dal 1° Festival di Parigi nel 1949:
“Calò il sipario e Bird mi si avvicinò barcollando. Piangeva. Era in uno stato pietoso. Quando fu a
pochi centimetri da me si afflosciò: lo afferrai, lo sostenni per cinque minuti. Ero commosso,
atterrito, confuso: avevo tra le braccia Charlie Parker!“
In quell’occasione, sul palco erano schierati tre batteristi: Max Roach, Kenny Clarke, e lui Gil
Cuppini, al suo primo (e forse più bello) di molti successi in venti anni di jazz.
”Facciamo un disco o un concerto a Roma, o comunque facciamo qualcosa insieme alla radio. E’
stata realmente una grande esperienza, quella seduta di fiati alla radio, e tu suonasti veramente
in modo meraviglioso, quando finalmente riuscimmo a farti suonare! Il tuo spirito è molto
sviluppato e bellissimo. Nunzio, e questo è il modo in cui si crea la musica. Sono convinto ora,
che sentimenti, come l’amore, la comprensione, il rispetto e la gentilezza devono resistere..”
(Sonny Rollins)
”Scriverò volentieri le note di copertina per il tuo disco, Nunzio: tu sai che sei uno dei miei
musicisti preferiti..”
( Dizzy Gillespie)
“Vedi, queste sono le cose che contano per me”: Nunzio Rotondo ha cercato queste lettere in
tutti i cassetti di casa. Me lo avevano descritto scorbutico, chiuso, inavvicinabile (“il suo
telefono ce l’ho, ma non ti posso dare il numero, oppure non dirgli che te l’ho dato io”) ed è
invece un personaggio dolce, caldo, ha l’umanità di chi a provato a mangiare le patate lesse e
basta, pur di fare soltanto del jazz. E’ molto timido, si. Non sposta l’orologio sull’ora legale, non
scrive il suo nome sulla porta, non lo vedi ai concerti (ma quando ci va si entusiasma come un
bambino ed è un piacere vederlo sciolto di piacere nello swing).
Parla poco, ma solo quando l’argomento non lo interessa. Adesso ci accade spesso di passare la
serata al telefono a parlare di jazz. Rotondo non vive che per la musica e questa frase che, così,
è retorica e abusata, si scopre che è la sola giusta per definirlo dopo che lo si è conosciuto. Non
gli interessa veramente niente altro. Vive di jazz.
Le tentazioni le ha avute (“Maestro, un programma speciale per lei, poi due canzonette e
qualche vedette, ecco l’assegno”) e lui avanti a patate lesse, a scrivere gli argomenti
fischiettando perché il pianoforte era un lusso, a scoprire nuove sonorità, un linguaggio sempre
più suo (e non fuori del tempo).
Suonava già del jazz quando non sapeva neppure cosa fosse. Il vibrato, lo swing, li scoprì quando
imparava la musica all’Accademia di Santa Cecilia, da solo. Improvvisare era una necessità, un
modo liberatorio con il quale realizzarsi.
“Fare del jazz è una cosa talmente bella e completa che ti da tutto. Tu dovresti riuscire a far
capire, con le tue parole, che il jazz è la cosa più bella che ci sia”.
E’ il discorso di un innamorato. Lo ripete.
“Devi riuscirci: trova il modo per dire che il jazz è la cosa più bella.”
Se bastassero le definizioni.
E’ un fatto di pathos. Un blues lento, in quattro battute, è rivelatore. La prima volta che Miles
Davis (è uno dei pochi che Rotondo ascolta) suonò a Milano, Roberto Capasso cercò di fare le
presentazioni. Miles ascoltò le frasi che magnificavano Nunzio Rotondo. Mano tesa ad attendere
una stretta che non ci fu: Davis voltò le spalle e li lasciò a guardarsi imbarazzati. Più tardi
Rotondo riuscì a suonare ed alla fine del blues, sempre senza una parola, Miles lo abbracciò. Un
abbraccio lungo e commosso. Gli altri impacciati ridevano e applaudivano. Si scambiarono la
tromba. Miles scosse la testa e disse a Nunzio di buttare quel bocchino, gli consigliò il suo. Un
abbraccio ancora e se ne andò. Quattordici anni dopo, Miles è di nuovo in Italia e Rotondo è
raggiante al pensiero di rivederlo. E’ al Sistina di Roma, nel camerino, pantaloni di lucertola
nera, sciarpa hippy. Cammina, muto, davanti e dietro. Una pantera.
Una signora dice a Rotondo di lasciar perdere tanto è imbestialito, morderebbe anche sua
madre. Rotondo si appiattisce in un angolo, buono e zitto. Che momento infame, ma fa sempre
così? Adesso che porto i baffi e i capelli lunghi, non mi riconosce, dopo quattordici anni. Ma che
aspetto a fare? Miles Davis esce, gli passa davanti, lo guarda male e tira dritto. Poi si volta e
torna indietro. Gli occhi tondi adesso ridono, si tocca il labbro (il bocchino, ricordi my brather?).
Si abbracciano di nuovo per un minuto.
Miles Davis e Nunzio Rotondo non si parlano, non si scrivono. Si riconoscono a distanza di anni sul
filo del blues,in quattro battute rivelatrici.
In quella prima sera a casa di Rotondo, con Walter Cianfrocca che stemperava con il suo humour
da simpatico romanaccio il contatto con l’estraneo che raggela Nunzio, ho capito che Rotondo è
un ricercatore istintivo. Non si pone la ricerca come problema, ma come soddisfazione del
proprio bisogno di essere, domani, diverso da oggi.
“Sento di non aver detto tutto.”
Si troverà poi a dire, lui sulla via Cassia a Roma, le stesse cose che qualche altro musicista sta
dicendo a New York o a Parigi. Non ha un giradischi funzionante in casa (i bambini li trovano
deliziosi come giocattoli) e ascolta pochissimo la musica degli altri. Eppure riesce sempre a
suonare le cose che si suoneranno domani.
Mi ricorda Julian Cortazar ne “Il precursore”, quando descrive gli ultimi anni di Charlie Parker:
“Suonavano con piacere, senza nessuna impazienza e il tecnico del suono dava segni di
contentezza di là dal finestrino come un babbuino soddisfatto. E proprio in quel istante, quando
Johnny (è lo pseudonimo con il quale viene indicato Charlie Parker) era come sperduto nella sua
letizia, di colpo smise di suonare e lasciando andare un pugno non so a chi, disse: “Questo lo sto
suonando domani”. I ragazzi rimasero di stucco, due o tre soli continuarono per qualche battuta,
come un treno che tarda a frenare e Johnny si picchiava la fronte e ripeteva: “Questo l’ho già
suonato domani, è orribile, Miles, l’ho già suonato domani questo!”. E non riuscivamo a
distoglierlo in nessun modo da quesa idea. Dopo d’allora tutto andò male. Johnny suonava senza
voglia e desiderando solo di andarsene (a drogarsi di nuovo, disse il tecnico del suono, morto di
rabbia), e quando lo vidi uscire , barcollando e con la faccia color cenere, mi domandai se
sarebbe durato ancora molto.”)
Charlie Parker, the Bird, impazzì sopra l’idea di stare suonando quello che aveva già suonato
domani. Ci morì sopra. Era uno di quelli che voltano le pagine della storia del jazz (e dopo di
loro non si può più suonare come si suonava prima). Nunzio Rotondo suona alla Nunzio Rotondo e
al di là dell’apparente pleonasticità dell’affermazione, non rimane (per capire che non è un
pleonasmo) che chiedersi per quanti altri in Italia si possa dire, con sincerità, la stessa cosa.
Arrigo Polillo, direttore di Musica Jazz, critico per jazz del GIORNO e di PANORAMA, vicechairman della Divisione Critici e Giornalisti per l’Italia della Federazione Europea del Jazz.
Coautore dell’Enciclopedia del jazz (1953), nel 1958 ha pubblicato il volume Il jazz moderno:
musica del dopoguerra, nel 1961 Il jazz d’oggi e nel 1968 Conoscere il jazz.
“Anni fa, Gigi Campi, oggi manager della orchestra di Clarck e Boland, ma da parecchi anni
mecenate del jazz in Germania, mi mise una pulce nell’orecchio parlando del sole italiano (era,
me lo ricordo benissimo, una bellissima giornata): “Ma come si fa a fare del jazz con un clima
come questo?” – mi disse- “Per fare del jazz – non ricordo esattamente le parole, ma il senso era
questo- bisogna essere infelici, vivere in qualche grande, brutta e fredda città come quelle
nostre in Germania, come quelle svedesi, e come naturalmente, New York e Chicago.”
Era una battuta, ma nemmeno poi tanto. Al fondo c’è una verità incontestabile: il jazz è
espressione di una certa cultura – in senso sociologico – ad anche di una certa classe sociale. Nel
suo processo di internazionalizzazione – che ha incontrato dei limiti, naturalmente – ha potuto
attecchire e talvolta prosperare solo là dove ha trovato un humus culturale favorevole.
E’ questo il caso dell’ Italia? Probabilmente no . Qui – anche a prescindere dal cielo azzurro e dal
sole splendente di cui parlava Campi – certe angosce, certi disadattamenti sono (per il momento
almeno) abbastanza rari; certi atteggiamenti e certi comportamenti, altrove serenamente
accettati, sono ancora ritenuti fuori dalla norma.
Così il musicista di jazz italiano si trova fin dall’inizio nella necessità di far violenza
all’ambiente, che non lo aiuta minimamente; non può – salvo casi eccezionali – considerare il
jazz quale fonte esclusiva del proprio reddito, deve anzi – per vivere- cercare di scordare il più
possibile il jazz, il suo spirito, le sue regole. I più sono professionisti della musica leggera,
mentre come musicisti di jazz non possono che essere dilettanti, nel senso più nobile del
termine. Dilettanti, perché si dedicano al jazz soprattutto per amore, e con scarso profitto
economico; dilettanti perché per loro – quasi tutti loro- il jazz costituisce purtroppo soltanto un
diletto, una lieta vacanza. Il fatto che, in epoca recente, le occasioni di vacanza siano
notevolmente aumentate, non muta la sostanza delle cose: soprattutto non basta a far sentire i
nostri musicisti dei jazzmen a tempo pieno.
Parlo dei musicisti professionisti, naturalmente, perché i veri dilettanti, quelli che in Italia si
dedicano soprattutto al jazz tradizionale, a questo status non hanno mai aspirato. Entro i limiti
che si sono prefissi i nostri dilettanti sono felici: quando prendono in mano uno strumento è per
fare del jazz.
Questa situazione, determinata dall’ambiente, è all’origine di tutte le difficoltà che i nostri
musicisti di jazz incontrano sulla loro strada e che non sempre superano facilmente. Spiega certi
loro atteggiamenti, l’amarezza di molti, l’aggressività di alcuni (che si traduce magari
nell’animosità verso i critici, o verso gli appassionati, definiti nella migliore delle ipotesi,
esterofili) e le ritrosie di altri.
Forse si può dire che il musicista di musica leggera e di jazz italiano recita un ruolo pienamente
accettato socialmente, ma è insoddisfatto della musica che fa (non fosse altro perché suona solo
episodicamente ciò che più gli piace); mentre, al contrario, il suo collega americano, che fa
soltanto del jazz, è soddisfatto della musica che fa, ma non è affatto pienamente accettato
dalla società dominante. Altrove in Germania, in Francia, in Scandinavia, dove il jazz è certo più
prospero che da noi, la situazione dei jazzmen è più simile a quella che si riscontra in America
che a quella esistente in Italia.
Peculiare, e certo fra le meno felici, è poi la situazione dei nostri jazzmen se si tiene conto
dell’importanza nel costume italiano, dell’invadenza tracotante, dei caratteri della musica
leggera nostrana, che nelle sue forme più tipiche – e quindi più congeniali all’indole degli
italiani- è quanto di più lontano dal jazz si possa immaginare.
Se non si dimentica tutto questo, i nostri migliori musicisti di jazz- quelli di livello
internazionale, come si usa dire – appaiono degli eroi, o poco meno.
E si può anche comprendere chi, sentendosi appunto eroe, finisce per sopravvalutarsi.
Naturalmente, chi ama di profondo amore il jazz, anche quello italiano, non può non
rammaricarsi per l’esiguo numero di questi musicisti.
Una gran parte di loro è sulla breccia da quindici, vent’anni. Veterani di tante battaglie, solo da
poco tempo riescono a dar concerti in numero sufficiente per essere incoraggiati ad allargare il
loro repertorio e a far qualche esperimento, che però i discografici troppo raramente
documentano.
Ora (continua Arrigo Polillo) – all’inizio del 1971 – molti di loro sono impegnati a fondo: pare
anche si sia finalmente spezzato quel circolo vizioso che si era determinato fino ad epoca
recente (i musicisti non si impegnavano perché non avevano un pubblico, ed il pubblico non li
seguiva perché troppo pochi fra loro si impegnavano) e che aveva messo il nostro jazz in una
pericolosa situazione di stallo. Ora non c’è che approfittare del momento, ed augurarci che
anche i giovani, oggi in gran parte impegnati nei complessi rock, vogliamo unirsi ai loro fratelli
maggiori che hanno scelto la difficile strada del jazz.
E’ il solo nome delle nuove leve che mi hanno citato tutti i musicisti, senza nessun accento
polemico, un nome usato come bandiera, come diploma di maturità: Franco D’Andrea, il delfino
del jazz italiano.
La prima volta che lo incontrai (mi aspettava per l’intervista sotto casa) mi resi conto che il
delfino non avrebbe potuto essere diverso (maglione dolce vita, accento interregionale, figlio
della provincia, educato, più giovane dei suoi anni, colto e sensibile, delicatissimo nella stretta
di mano- un oggetto prezioso , quella destra, una cineseria sottile e fragile, pensavo alle tazze
di porcellana trasparenti), la somma e l’espressione più giusta dei musicisti italiani di jazz.
La serata fu fantastica, parole sino a notte, dischi sottovoce, appunti e registrazioni per un buon
profilo.
L’esperienza jazzistica di Franco D’Andrea è incominciata in modo vero con Gato Barbieri al
Clubino di Roma. Prima, autodidatta a Merano (vita provinciale senza sbocchi) il rapporto con il
jazz era solo un modo per respirare: il mondo di Louis Armstrong, tra due i muri della musica
seria e di quella leggera, costituiva l’attrattiva logica per un diciottenne alla ricerca del nuova,
del libero, dal momento universalistico, al di fuori di quella problematica sociale che solo più
tardi può essere avvertita come implicita nel binomio musica-società. Una cosa alla quale
D’Andrea poté arrivare attraverso gli studi ed un processo di maturazione di tipo fisiologico.
Con Gato Barbieri venne sottoposto a verifica tutto quello che aveva imparato: fu in fondo un
processo di riascolto (con mente ed orecchie nuove)
di tutto quello che il jazz aveva sino a quel momento prodotto. Per D’Andrea, suonare in quel
periodo, significò smontare pezzo per pezzo il meccanismo di questa musica e ricostruire tutto
da capo: un processo, questo, di simbiosi in chiave umana, senza chiacchiere, senza scambi di
opinione se non a livello musicale e strumentistico.
Una precedente intervista, raccolta da Alberto Rodriguez per Musica Jazz, n. 4, 1969, riporta il
significato che Franco D’Andrea è riuscito a dare fenomeno della riproposta dei modelli originali
da parte dei jazzmen non appartenenti al mondo americano.
“L’influenza più forte all’inizio l’ha esercitata su me Bill Evans. Era una influenza tremenda.
Entro l’ambito jazzistico Evans stava esplorando, come nessuno aveva fatto, tutte le possibilità
del dominio tonale. Per un certo periodo ciò mi è apparso come il risultato più ampio che
potesse raggiungere, ed ho creduto che non si potesse suonare in modo diverso. Con Gato però
ho capito che non potevo imitare Bill Evans, e subirne l’influenza, per tutta la vita. Gato allora
suonava in modo molto legato allo stile di Coltrane ed in un certo senso aveva anche lui il mio
stesso problema. Bisogna dire, tuttavia, che la musica di Gato non era copiata da quella di
Coltrane. Lui mi ha insegnato una cosa di straordinaria importanza: che il jazz è soprattutto
umanità e partecipazione. Queste due qualità facevano si che la musica di Gato possedesse una
sostanza che la differenziava in modo significativo da quella di Coltrane. Anche con Gato si
suonavo pezzi modali, ed anch’io, seguendo lo stesso procedimento di McCoy Tyner, ho
cominciato ad armonizzare per quarte sovrapposte e nello stesso tempo a liberarmi dal
condizionamento di Bill Evans.
Ma c’era un altro aspetto che arricchiva l’esperienza con Gato.
Lui comunicava agli altri qualcosa di impalpabile ed insieme di molto concerto. Il suo approccio
con la musica era fondato su una straordinaria sincerità. Suonare diventava quindi, per tutti noi,
un dare senza inibizioni. Per la prima volta io riuscivo a suonare rimuovendo una serie di conflitti
interni, di blocchi psichici che sino ad allora mi aveva impedito una espressione libera ed anche
una ricerca spregiudicata. Il jazz non era più una formula da applicare matematicamente, ma
diventava esperienza vitale, in cui l’obbiettivo principale era liberarsi e comunicare. La musica
diventava allora veramente un’esperienza collettiva, non per una èlite, ma per il grosso
pubblico. Non credo che una musica popolare ci costringerebbe a diminuire o sacrificare
l’impegno, la libertà della ricerca e della sperimentazione, portandoci verso il commerciale: non
bisogna avere complessi in questo senso. Il jazz ha bisogno, a mio avviso, di mantenere certi suoi
valori originali: lo swing è di certo il più importante di questi valori. Cerco di fare una musica
che recuperi l’umanità integrale dell’individuo, nei valori della sensibilità, soprattutto. Non
vogliono fare una musica d’evasione che separi artificiosamente il momento artistico e quello
reale. Per questo cerco un rapporto col pubblico, voglio realizzare una musica comunicante,
come ha fatto Archie Shepp, anch’io cerco di farlo, in un certo senso, secondo differenti termini
formali. Come musicista e come uomo mi sento al centro di una crisi. E’ con la gente che io
voglio fare i conti: la mia preoccupazione è di fare una musica che reintegri l’uomo in se stesso,
che colleghi i visceri con la testa e che possa servire a qualcosa. La crisi di crescenza che sta
attraversando il jazz ci ha portato a risolvere i problemi intellettuali a scapito del discorso
viscerale. Nel jazz italiano, ad esempio , c’è un disco molto importante: Dall’alba all’alba di
Giorgio Gaslini, dove si avverte che il ricercatore è arrivato a combustione, è entrato
profondamente nella realtà con il ragionamento, non con le budella. I popoli del terzo mondo
stanno facendo invece affluire al filone europeo quella musicalità brada e selvaggia, viscerale,
di cui siamo carenti. Io adesso continuo a lavorare sulla base di un idea di tonalità che rimanga
come centro tecnico ed emotivo, cercando di costruire una materia melodica che abbia richiami
alla musica popolare. Trovare forme che abbiano una loro razionalità interna ma che permettano
anche un approccio budellare con il pubblico. Il ritmo è un elemento a cui io credo molto,
proprio per le implicazioni umane e reali che esso comporta.”
Alberto Rodriguez, giornalista, vive a Cagliari dove è redattore della Rinascita Sarda. Collabora a
Musica Jazz e ad altre riviste.
“Che cos’è il jazz italiano? Chi sono i musicisti più significativi e qual è il loro valore? Quale
opinione si può esprimere sul jazz italiano? Domande elementari ed insieme così generali, alle
quali è terribile rispondere. Mi viene in mente un’intervista fatta ad Arrigo Polillo in televisione,
durante un programma di Renzo Arbore: Polillo (che scrive e parla di jazz quotidianamente da
venticinque anni) aggredito di brutto con la domanda “Che cos’è il jazz” (questione, posta in
questo modo, vecchia ed inutile) non ha saputo combinare, lì per lì, una risposta soddisfacente.
Ed è comprensibile: quando ha riproposto la stessa domanda ai lettori della sua rivista, Musica
Jazz, dando loro il tempo di riflettere e di ragionare, le risposte giunte in redazione sono state
altrettanto insoddisfacenti e generiche. Definire in modo sistematico e universale è infatti
impossibile. Resta solo la possibilità di descrivere o di compiere valutazioni relative, fondate su
una premessa ideologica, o politica (o anche solo di gusto). Ma per far questo occorre lo spazio
necessario per svolgere, in modo più possibile chiaro, un discorso che, coinvolgendo problemi di
estetica, di comunicazione, di linguistica, ed insieme di psicologia, di sociologia, ed anche di
politica, possa essere autenticamente critico; diventi quindi uno strumento utile per il giudizio
della massa dei fruitori, e non una opinione impressionistica, generica, isolata, espressa alla
buona o magari con pretese d’importanza. Anche parlare del cosiddetto jazz italiano, in termini
valutativi comporta le stesse difficoltà definitorie. Per questo motivo trovo utile fare un discorso
di pura testimonianza, un discorso in cui il critico diventa partigiano e militante così come lo è il
musicista.
Devo confessare invece che questo problema delle definizioni è una spina che crea molta
confusione, e rende più difficile l’esercizio del giudizio critico, in una formulazione organica,
chiara e coerente. Quale testimonianza si può dunque portare sul jazz italiano? Rispondendo a
botta calda, e dall’angolazione geograficamente provinciale in cui io vivo, mi viene da dire che il
jazz italiano si comincia a farsi sentire negli anni ’50. Certo chi vive a Roma o a Milano, ed ha
passato da tempo la quarantina, giudicherà eretica questa affermazione. Gli torneranno infatti
alla mente gli anni sacri in cui andava ad ascoltare nelle cantine gli amici che suonavano sul giro
di blues, ed in cui la comunità dei jazzofili (allora gli appassionati si chiamavano così) si sentiva
addosso il destino di una minoranza esclusa ed una condizione neo-carbonara.
Ma a mio avviso questi sono episodi che competono alla storia del costume e non veramente ad
una cronaca minimamente storica della vita musicale, nel nostro caso, jazzistica.
Negli anni ‘50 si ha la prima generazione di musicisti di jazz con un minimo “assetto
professionale”. E’ la generazione che poi verrà assestandosi negli anni ’60 e che comprende in
sostanza pochi nomi: Basso, Valdambrini, Volontè, Masetti, Cuppini e, più in là, Nunzio Rotondo
e pochi altri. Negli anni ’60 viene ad aggiungersi un altro gruppo di giovani musicisti, sempre con
forte accentuazione di professionalità: Dino Piana, Franco D’Andrea, Franco Tonani, Giovanni
Tommaso. Il jazz italiano ufficiale mi sembra sia tutto qui.
E non c’è, a mio avviso, problema se per caso in questo elenco qualcuno si sentirà dimenticato. I
nomi indicati sono emblematici di tutto un atteggiamento musicale, di un certo modo di suonare
il jazz. Ad essi possiamo aggiungere un altro piccolo nucleo di musicisti che, con diverse qualità
anche strumentali, si è coagulato a Roma, provenendo da località diverse, ed ha tentato,
qualche anno fa, le prime esperienze free: mi vengono in mente i nomi di Giancarlo Schiaffini, di
Marcello Melis, di Enrico Rava, del discusso Mario Schiano, di Ivan Vandor (che si è mosso
piuttosto nell’ambito di Nuova Conoscenza) e poi di Franco Mondini (un musicista che risiede a
Torino e che ha trovato una nuova strada, pur essendo cresciuto insieme alla generazione dei
Piana e dei Tonani).
Il jazz italiano è sempre stato una musica priva di cultura, a lontano rimorchio delle esperienze
americane. L’unica eccezione si può ritrovare forse, in Giorgio Gaslini, che si è qualificato come
musicista aperto agli stimoli della musica contemporanea esterna al jazz. E’ innegabile che in
Italia ci sono stati e ci sono jazzmen di qualità (penso ad esempio Franco d’Andrea) che hanno
cercato agganci ampi, sia con le esperienze americane che europee, cercando di assimilare
dentro una ricerca che, dopo molti tentativi, approdasse ad una autonoma espressione musicale.
Non si può riscontrare, tuttavia, nei nostri musicisti, la capacità di inventare forme nuove, di
cercare una collocazione originale nell’ambito non solo del jazz ma della musica in generale. I
musicisti italiani non hanno mai seriamente lavorato sull’esperienza musicale, studiandone in
modo finalizzato il ritrovamento di un proprio linguaggio, le forme storiche e stilistiche, lo
sviluppo strutturale. Per questo il jazz nel nostro paese è sempre stato una musica di imitazione.
Anche nel campo cosiddetto free si è avuto lo stesso fenomeno. I musicisti che iniziarono con il
“Gruppo Romano Free jazz”, ad esempio, non sono mai riusciti a superare lo stadio del puro
rifiuto del vecchio jazz, per arrivare alla definizione di un nuovo discorso musicale. E’ mancata
la coscienza (altri diranno la capacità inventiva, o il fondo culturale) del nuovo tipo di lavoro da
svolgere per individuare una serie di ipotesi formali (quello che volgarmente si dice stile) dotate
di coerenza interna, di una struttura precisa e riconoscibile. Il free italiano si è quindi limitato
ad una fuga travolgente (a volte persino folkloristica) dalla tonalità e dalle angustie del giro
armonico; ha finito poi con trasformarsi in un modo (incolto e sprovveduto) di ripercorre le
esperienze genericamente aleatorie e già molto datate, che la musica contemporanea aveva
compiuto, ed in parte superato, da anni. Mentre il free in America compiva una evoluzione
quotidiana (almeno se pensiamo a Shepp, che dopo il primo stadio di puro rifiuto, in cui la
materia musicale veniva accumulata in modo informale, è andato precisando i termini di un
nuovo modo di far musica, di una nuova struttura formale dove i modi del blues e l’atonalismo si
mescolavano originalmente) i nostri musicisti free non hanno mai superato l’assemblage caotico
e privo di scheletro strutturale dei suoni. Molti a questo punto obietteranno: eppure ci sono
musicisti italiani che “suonano bene”.
Certo, anche a me è capitato di sentire Franco D’Andrea con Keith Jarrett, con Gato Barbieri,
con Dino Piana, e poi ancora Gianni Basso, o che so, Franco Mondini, suonare “bene”, spesso
anche in modo originale, non imitavo. Sono però eccezioni, episodi isolati, dovuti a maestria
strumentale, a quello che i musicisti chiamano “ buon feeling” o, se derubiamo il linguaggio
sportivo, giornate di “buona vena” o di “ buona forma”. Mancano tuttavia, a mio modo di
vedere , le testimonianze in disco che provino l’esistenza di una autentica invenzione musicale,
di un linguaggio originale, di nuove ipotesi formali.
Vi sono precise ragioni che spiegano questa carenza del jazz italiano. La maggioranza dei
musicisti che suonano jazz non sono jazzmen a tempo pieno.
Per vivere sono costretti a fare un altro lavoro, che spesso toglie loro la libertà di diventare
musicisti diversi da ciò che attualmente sono. Quasi tutti si trovano infatti obbligati alla routine
dalle prestazioni nella grande orchestra RAI o dei turni nelle sale dove si incide la musica
leggera. L’ambiente che frequentano è quindi quello artigianale e buontempone dei sidemen ,
dove mai si discute, mai si lavora intorno ad ipotesi musicali, ma magari ci si racconta
barzellette negli intervalli tra una incisione e l’altra. Quali stimoli possono derivare da una vita
in cui la musica diventa soprattutto esercizio strumentale, ed in cui i musicisti entrano
nell’ordine di idee che campa meglio chi ha più capacità tecnica sia sullo strumento che sulla
lettura del pentagramma?
La maggioranza dei musicisti italiani non ha mai studiato seriamente la musica, e chi ha studiato
ha dovuto seguire i corsi burocratici e stantii dei nostri Conservatori, da cui, come è noto, i
giovani studenti escono con un brevetto di più o meno alibi strumentisti, ma con una
preparazione culturale ed una coscienza musicale generiche ed insufficienti.
Ma vi sono anche spiegazioni più profonde.
Se consideriamo la situazione dei musicisti negri americani che suonano, ad esempio, free jazz
(ma quanto è poco chiara e poco utile questa etichetta) scopriamo che essi vivono dentro una
specifica condizione ambientale, culturale e politica.
La loro consistenza culturale è bene identificabile e deriva dal loro status esistenziale (essere
negri del ghetto, minoranza all’interno di una società repressiva e sfruttatrice);
le loro idee, oltre che da questa esperienza sociale, sono determinate dalla giovane tradizione
politica che ha identificato i termini di una nuova cultura ed una musicalità negra (da Malcom X
a Le Roy Jones, a Eldrige Cleaver ai Black Panthers).
Qual è invece l’ambito culturale in cui si identifica il musicista italiano di jazz? E’ facile
rispondere: l’ideologia e la visione del mondo piccolo-medio borghese, priva di agganci culturali,
di riferimenti se non quelli del qualunquismo e del rifiuto della politica.
Potrà sembrare ad alcuni che inquadrare il problema in questo modo costituisca una
testimonianza demagogica, o accodata alla moda gauchista .
Non è così. La musica come altre espressioni cosiddette artistiche, riflette in modo vivace e
stretto l’ambiente sociale, la situazione socio-culturale che la produce.
E’ un concetto, questo, accettato da tutti gli storici dell’arte ed ampiamente acquisito dalla
storiografia. Se noi pensiamo ai musicisti italiani, al loro status ed alla loro cultura, li scopriamo
agganciati all’etica piccolo borghese, privi di impegno, di scelte ragionate, se non quelle
quotidiane legate ad una sopravvivenza che sia la più comoda e quieta possibile.
Ma vi sono altre spiegazioni. Ancor più degli anni ’50 e ’60, oggi i musicisti italiani appaiono
slegati dal loro tempo, perché dopo il 1968 (e le profonde scosse sociali che ne sono derivate sia
in Europa che in America) il mondo è venuto assumendo un nuovo ritmo di sviluppo. Tutto è
stato nuovamente messo in questione, dalle gestioni autoritarie dello stato, alla scuola, alla
cultura. Il processo di proletarizzazione crescente, che ha accomunato alla classe operaia gli
strati intermedi (tecnici, professori, piccoli professionisti, ecc.) ha creato una massa di persone
che ha perso coscienza del proprio stato subalterno. La cultura ufficiale e la cultura borghese
(ma anche quella tradizionale di sinistra, diciamolo per chiarezza) hanno subìto un colpo
pesante. Rapidamente sono scomparsi tutta una serie di artisti (scrittori, musicisti, pittori,
cineasti) considerati come pietre miliari intramontabili. La nuova cultura, rivoluzionaria, che
sarebbe dovuta emergere da questi profondi rimescolamenti, solo in parte è venuta fuori. La
letteratura, la pittura, il cinema riflettono questa crisi, in cui due modi opposti si trovano a
confronto.
E’ comprensibile, quindi, come, in campo jazzistico, non sia riuscito ad emergere saldamente un
nucleo alternativo contro la generazione di musicisti classici degli anni ’60. Ciò è avvenuto, in
parte, in America e solo qualche traccia si è avuta in Europa; in Italia dopo i timidi tentativi
romani (ed anche milanesi) di free, la nuova generazione di musicisti non è riuscita a farsi
avanti. I giovani hanno cercato di percorrere la strada del free jazz erano troppo poco
agguerriti, privi di consistenti contenuti, senza solide basi, per poter riuscire ad emergere, ed
elaborare un linguaggio adeguato. Non era, d’altra parte, un‘impresa facile. Di fronte
all’esplodere della nuova situazione politica, di fronte alla crisi delle ideologie gestite dalle
istituzioni politiche e culturali tradizionali, anche nuclei densi, ben agganciati all’industria ed
alla moda culturale (penso al Gruppo ’63, all’avanguardia letteraria italiana riunita intorno a
Quindici ed all’editore Feltrinelli) hanno dovuto gettare le armi, senza che altre generazioni di
scrittori venissero a rimpiazzarle. Dopo la data emblematica del maggio parigino si è anzi, da più
parti, ricominciato a parlare della “morte dell’arte”, della necessità che ogni operazione
intellettuale si ponga solo finalità politiche. Ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano.
Ad accrescere l’isolamento culturale dei musicisti viene poi l’isolamento culturale della critica
jazzistica. I critici italiani (e la cosa riguarda tutti, con minor o maggior responsabilità) hanno
ereditato gli atteggiamenti metodologici dei colleghi americani ed europei, e quindi tutte le
carenze: in Italia si è avuta una letteratura critica attenta soprattutto alla ricostruzione fedele e
cronologica del fenomeno jazzistico ed alla esatta elencazione dei reperti discografici . E’
mancata invece la prospettiva sociologica e l’analisi specificamente stilistica nella
considerazione e nella valutazione della musica jazz. Si possono riconoscere nella critica italiana
i limiti di un fondo culturale tipicamente crociano, così come in quella europea il taglio è stato
generalmente idealistico. I critici italiani ci sono formati in gran parte su autori americani che,
trascurando quasi completamente di formulare una rigorosa trama di criteri estetici, hanno
affrontato il jazz in termini monografici, lavorando intorno alla raccolta di una enorme massa di
notizie e di dati. Hugues Panassiè, che è stato uno dei primi responsabili dell’orientamento
critico europeo, ha aggravato la situazione. Le sue opere considerano il jazz in termini
addirittura feticistici (e freudiani) con una esaltazione irrazionale del musicista negro,
dell’anima e del soul negro, intesi come unici depositari dello specifico jazzistico, della jazzità.
Anche Andrè Hodier, che negli anni ’60 ha avuto in Italia ed in Francia una certa fortuna critica,
pur muovendosi sul piano di una analisi e di una descrizione prevalentemente tecnico- musicale,
non esce dai limiti dell’indagine di Panessiè né da un atteggiamento universalistico e magicomitico nella valutazione delle opere di jazz. E l’elenco potrebbe continuare. Con questa pesante
eredità, la critica italiana solo negli ultimi anni ha tentato di staccarsi dalle promesse
idealistiche per affrontare un discorso sul jazz legato ad una consapevolezza di metodo e ad una
analisi il più possibile legata (oltre che alla prospettiva storicistica) all’individuazione delle
caratteristiche semantiche del linguaggio jazzistico, per poi risalire alle ipotesi di significato. I
risultati sono, però ancora informi. Resta da dire, tra l’altro, che l’estetica musicale, è, rispetto
ad altre estetiche (mi si perdoni il linguaggio generico) in una situazione di maggiore difficoltà.
La lingua musicale non si presenta infatti (poiché non è così referenziale) ad essere descritta
come la lingua letteraria o cinematografica. Lo sforzo del critico musicale, per arrivare ad un
discorso chiaro, plausibile, rigoroso, è quindi faticoso ed assai duro. Ma vi è una colpa nella
critica italiana, nei confronti dei musicisti, che difficilmente può trovare scusanti. Non è una
critica militante, capace di affiancarsi alle esperienze di un determinato gruppo di musicisti,
condividendole, tentandone una teorizzazione ed una spiegazione ed insieme proponendo linee
varianti o indicazioni di ricerca. E non è militante anche perché al rigoroso impegno culturale (e,
perché no, ideologico) proprio di ogni critica militante, ha sempre sostituito il disimpegno
aristocratico o perfino qualunquista. Se i musicisti ci fossero trovati di fronte una critica
aggiornata, schierata, combattiva (ma su fondo culturale e non su pregiudizi), forse sarebbero
rimasti più stimolati. Non sarebbe stato possibile cambiare la mentalità professionale dei vari
Basso-Valdambrini, però certo i giovani musicisti sarebbero diventati degli autentici
interlocutori, e sentendosi seguiti, stimolati, avrebbero, forse, ricercato di più.”
Franco Cerri è uno smussatore d’angoli, un gentiluomo old fashion, un conversatore incantevole,
un chitarrista sofisticato, un personaggio piacevolissimo che si può immaginare in tutte le
situazioni tranne che attaccato ai muri di tutta Italia immerso vestito nell’acqua e
biologicamente deterso.
Lo incontro di pomeriggio, sul palcoscenico del Sistina, durante la prova del suo concerto
romano con Martial Solal. Gli lascio nell’orecchio l’eco di alcune domande (la situazione del jazz
in Italia com’era, com’è, come sarà; chi è jazzisticamente Franco Cerri?) che gli impediranno di
dormire, nonostante la stanchezza, nell’intervallo prima del concerto. Dopo il concerto, tutti a
cena, con il piacere addosso dei bis sinceri e del buon successo decretato dai quattro gatti
presenti alla serata.
“Io non sono mai stato tenero con i critici mancati e gli impresari da serie B, ma devo dire che vi
sono delle scusanti per quello che in Italia non si è fatto a favore del jazz. Mancava
praticamente tutto quello che serve per fare bene del jazz, dai locali, all’ambiente (nel senso di
atmosfera), alla preparazione della critica. In più, in Italia siamo malati di esterofilia e quindi
noi musicisti siamo stati spesso boicottati, messi da parte e, sempre poco seguiti. Da parte
nostra abbiamo fatto ben poco per cambiare questa situazione , studiando poco, creando l’alibi
dei vittimismo, scannandoci tra di noi.
Le eccezioni ci sono, come sempre, ma il quadro della situazione generale è pressappoco
questo.
Adesso le cose stanno anche qui cambiando, gradatamente, per una maggior consapevolezza
della critica che si è spostata su binari di maggior obiettività e soprattutto perché un gruppo di
musicisti, raggruppati sotto la U.I.M.J (Unione Italiana Musicisti di Jazz) ha incominciato ad
alzare la voce.”
Che è, jazzisticamente, Franco Cerri?
“Un Petersoniano, anzi, un Petersonista, legato al modo melodico-armonico e ad una concezione
tradizionale del jazz. Non sono riuscito ad accettare il free-jazz proprio per l’atteggiamento
dissacrante mostrato nei confronti della tradizione. In Italia posso ammirare sconfinatamene solo
Franco D’Andrea, un pianista (anzi, un musicista) che si fa largo prepotentemente perché la sua
è musica libera, ma legata alla tradizione. Il suo discorso mi affascina perché trattiene, anche se
solo per un capello, il passato musicale, nel quale inserisce degli stimoli nuovi. Una via molto,
molto giusta.
In altre parole, riesco ad apprezzare chi ha continuato a progredire stilisticamente, senza
voltare la schiena al jazz. Quello che conta, è che il jazz oggi sia un linguaggio internazionale
accettato in tutti gli ambienti. Sbagliano gli impresari quando organizzano (per essere alla page)
solo concerti di free- jazz. So che la critica oggi vuole solo questo, ma è un grosso errore. Sono
state superate molte forme tradizionali senza che fossero state fruite completamente. Non è
vero che non c’è ricerca, se non a livello dell’ultima moda, perché il musicista matura strada
facendo, scopre delle cose (arricchito dall’esperienza) ed è ingiusto che il frutto di questa
ricerca venga sciupato solo perché questa non segue i sentieri della nuova avventura. Perché
vogliamo sciupare il risultato di questa maturazione? Forse è vero, che io fossi sollecitato da un
bisogno di sopravivenza, sul piano spirituale e materiale, più spinto di quanto oggi non sia il mio
bisogno (forse grazie a Bio Presto), la mia ricerca sarebbe più appariscente, perché
approderebbe a fenomeni evidenti. Oggi non ho questo tipo di sollecitazione: quindi smusso gli
angoli, arrotondo il sound del mio quartetto, cerco delle soddisfazioni timbriche che nascono
però da una ricerca (inserita nell’ambito della tradizione e del classicismo) che mi rifiuto di
veder buttata nella spazzatura.”
Franco Cerri ( Milano, 29 gennaio 1926)
1943: muratore e ascensorista ( per vivere) durante la guerra;
1944: guitto tra imbonitori e ballerine;
1945: la chitarra è uno svago, con lezioni prese da Radio Londra che trasmette Eddie Lang e
Charlie Christian;
1949: suona con Django Reinhardt all’Astoria Club, Milano;
1951: con Sandro Bagaglini, Vittorio Paltrinieri, Alberto Pizzigoni e Rodolfo Bonetto forma il suo
primo complesso;
1955: in Norvegia alla scoperta del jazz scandinavo;
1957: Taverna Messicana, Milano: nuovo complesso con Livio Cerveglieri, Renato Sellani, Giorgio
Buratti, Gianni Cazzola e Nicola Arigiliano. Qui suona con Chet Baker, Bud Shank, Claude
Williamson, Billie Holiday, Gerry Mulligan, Lars Gullin, Lee Koniz, Buddy Collette ed il Modern
Jazz Quartet;
1959: inizia a comporre musiche per shorts pubblicitari;
1960: rappresenta l’Italia a Berlino nella European Jazz All Stars;
1963: partecipa al Festival di Comblain-La-Tour;
1966: due concerti alla Philarmonic Hall di New York come solista;
1970: con Angelo Arienti forma un duo di chitarre e ritmica.
Franco Tonani, prima di parlare di jazz, vuole sgombrare il campo delle idee distorte che le
definizioni, le sigle, le etichette hanno messo nella mente di molti.
“Basta con la parola jazz, con la parola pop, o beat o rock, se ciò che doveva servire da codice
per una chiara classificazione è stato scambiato per uno stemma corporativo. Esiste la musica,
un fenomeno totale, universale. Jazz è una parola superata: la musica oggi, può essere intesa
soltanto come fenomeno sociale di portata mondiale. Se tuttavia vogliamo continuare ad usare
queste definizioni in funzione di codice, possiamo dire che jazz può riassumere la funzione di
elemento catalizzatore degli interessi musicali dell’uomo anche in senso umano, sociale e
politico.
La musica (lo è sempre stata, ma oggi lo comprendiamo con chiarezza) è socialità. Lo sforzo
degli uomini in questi anni, e lo attestano i fatti, è la ricerca di una forma politica
universalistica che possa servire da abito comune a tutti gli uomini del mondo. Nell’ambito di
questa ricerca si fanno proprie le esperienze delle altre civiltà, non copiandole, ma vivendole (o
rivivendole) come fenomeno di arricchimento del proprio patrimonio culturale. Il jazz, in questa
ricerca, è la forma musicale più rappresentativa, riuscendo a svolgere la funzione di comune
denominatore proprio per le caratteristiche del suo linguaggio, estremamente moderno, ma
radicato nella rinnovata sensibilità delle masse, alla luce dei problemi comuni e perciò schivo da
arroganze settarie ed intellettuali.
Non dimentichiamo Platone: “Le arti possono essere deleterie ai fini di una socialità perfetta”.
A lungo abbiamo considerato le espressioni artistiche come un fenomeno a se stante, quasi un
secondo abito umano, una possibilità dell’uomo di elevarsi sull’uomo, riducendo così l’arte ad
una intensità metafisica.
Considerando che l’arte ha poca importanza ai fini dell’evoluzione sociale dell’uomo (la vera
determinante è la politica) si può dire che questa forma musicale possiede tutte le doti per
essere compendiata nel moderno contesto politico-culturale.
Il jazz può utilizzare qualunque forma folkloristica; può allo stesso tempo, sfruttare e
influenzare ogni forma di musica popolare. Tutto ciò presuppone perciò che il musicista sia in
grado di mandare avanti il suo discorso con disponibilità per una ricerca ampia e approfondita,
sia sul piano formale e compositivo. Al di fuori di questa linea si potranno produrre opere magari
di ottimo livello estetico, ma nullo più.
In Italia, a mio avviso questa esigenza è stata sentita in special modo da Giorgio Gaslini,
soprattutto in alcuni dischi, come Nuovi Sentimenti e Africa, per il quale ho realizzato la parte
ritmica. A mio avviso anche nel mio disco Un frenetico sapore con Dino Piana, Gianni Basso,
Franco D’Andrea e Bruno Tommaso, questo stimolo di rinnovamento si è concretizzato con
convincente chiarezza.”
Presentazione al disco Un frenetico sapore di Franco Tonani:
Il jazz è swing
il jazz è feeling
il jazz è musica universale
è il linguaggio dello spirito
che ha fuso le diverse espressioni popolari in
una dimensione nuova e reale
il bisogno di esprimere artisticamente
i problemi comuni, il benessere industriale
la divinità delle macchine, la crisi dell’intellettuale
l’alienazione ai sistemi, la pianificazione dell’uomo.
I giovani sono beat.
Loro swingano la paura,
la felicità, il progresso.
Parlano colori di poesia.
Il tempo che respira faticosamente
le spoliazioni dello spirito
la fame
la pace dei popoli e
la giustizia sociale.
L’amore è la fede nell’uomo,
il riscatto dalla servitù,
il sacrificio dei grandi poeti,
oltre i confini del tempo e dello spazio.
L’arte è il pensiero libero,
è l’edificazione della cultura,
incitamento all’unita degli uomini.
Il jazz è la nostra musica,
il nostro folclore moderno.
È lo spirito che anima
le composizioni di questo disco,
con le sue canzoni di città
e di sagra paesana.
L’impronta indelebile dei maestri del jazz,
l’incitamento alla scoperta del mondo
attraverso la cultura popolare.
A Renzo Nissim, uomo di cultura, pittore, inconfondibile “voce dell’America” degli anni del
dopoguerra, programmatore, radiofonico e vecchio innamorato del jazz, ho chiesto: perché ci si
accosta al jazz.
“Se ne avverte la sincerità. La fruizione è istintiva. La protesta del blues è, in sostanza, un grido
ed un grido si avverte. Viene raccolto da chi è disposto ad accostarsi ad un fenomeno
antiretorico, quindi viene solitamente percepito da una èlite. Spesso, per questo, la passione per
il jazz diventa un fatto snobistico. La massa è legata alla retorica, quindi poco attratta da un
tipo di musica quale il jazz. La riprova di questo si ha analizzando le caratteristiche
dell’affermazione del jazz nei vari paesi del mondo: si è affermato ovunque con grande
profondità e ridottissima estensione.”
Interrompo le prove di Giorgio Albertazzi (in un teatrino fuori mano, utile per metter su gli
spettacoli: Anna Proclemer e Gabriele Ferzetti mi guardano male, sono in ritardo con le prove,
non è un bel momento per un’intervista) ma lui parla volentieri di jazz (mi sorprende un poco,
anzi, quando prima di rispondere, mi chiede se alludo al jazz vero, puro, non a “ quello
manipolato”) ed il discorso viene fuori liscio ed interessante.
“Il jazz è un momento di fondo della cultura moderna, soprattutto per il ritmo che ha dato alla
nostra concezione del mondo. Il cinema per esempio, ha fatto tesoro del jazz: anche il teatro
moderno considera il jazz. Questo che stiamo vivendo, è un momento molto particolare, perché
si tende all’integrazione delle diverse forme di spettacolo. Si tende tutti ad uno spettacolo
totale in cui compaiono sullo stesso livello parole, musica, ballo, ecc.
In fondo tutti avremmo voluto, a suo tempo, aver firmato, pur con tutti i suoi limiti, un’opera
come Hair, anche se poi è uno spettacolo fatto per i mass-media, o per i borghesi, in ogni caso”.
Gli riporto la mia impressione (di spettatore deluso) sul risultato di Slaveship di LeRoi Jones,
andato in scena nel Premio Roma 1970, in cui le musiche di Archie Shepp avevano perso quasi
completamente la loro validità jazzistica.
L’aderenza all’effetto scenico (perfetta) era andata a scapito dal contenuto della musica, forse
anche perché mal eseguita.
“Purtroppo questo è il limite di quando si mette della musica in uno spettacolo. Per quanto sia,
la musica raramente tende all’espressione totale.”
Chiedo, in tal caso, quale sia il possibile sbocco del jazz nei confronti del teatro, specialmente
oggi che viviamo in Europa un momento elettrizzante, che sarebbe bene non sciupare. Chiedo,
in sostanza, se gli uomini di spettacolo sono consapevoli e pronti ad accettare il fenomeno jazz
come entità culturale da salvare. Quali, in sostana, i rapporti futuri tra il jazz ed il teatro?
“Io penso si possano nutrire delle speranze, in questo senso. Personalmente sto pensando ad uno
spettacolo tratto da un testo classico (completamente rivisto) che avrà una partecipazione
musicale jazz, in cui la musica cercherà di avere appunto una funzione espressiva totale. Io
penso che non si riuscirà più a prescindere dal fatto che il jazz è entrato talmente nell’inconscio
collettivo e che si avrà sempre più l’impressione di averlo addosso in ogni momento. Ricordo, ad
esempio, che una volta mi trovai in difficoltà nel ricreare il mondo di un personaggio di Ibsen,
negli Spettri, un mondo quindi assolutamente lontano (storicamente) dal jazz, ma pieno di
analogia da un punto di vista esistenziale. Non riuscivo a trovare il modo, ricordo, di
rappresentare questo canto nostalgico del personaggio per una Parigi vista utopisticamente
come un paese di artisti, di gente libera, anarchica. Non riuscivo a cogliere il metro giusto per
trasmettere il dramma di questo uomo. Mancava l’idea coerente che legasse il tutto e la scoprii,
per caso, ascoltando Charlie Parker. Compresi che quel personaggio era the Bird e lo riproposi
cosi, completamente, dall’inizio alla fine: avevo trovato un mondo jazz di recitare. Oggi il jazz,
è vero, non compare nel teatro come aspetto funzionale, operante da un punto di vista
musicale, ma la contrazione e la ritmica del jazz sono insite in tutte le manifestazione teatrali
moderne. Appare come patrimonio dell’uomo, che si è arricchito appunto di un ritmo che gli ha
permesso di abbandonare quel tanto di strascicato, di vecchio, di inutile che si sentiva nella
vecchia recitazione.”
Giorgio Azzolini riesce a “parlare senza accento la lingua internazionale del jazz moderno”
secondo una bellissima nota di Demètre Joakimidis.
Novantadue traversate di Atlantico, due anni in Germania, studi serissimi sul contrabbasso con
Godoli a Firenze (“Per fare delle musica bisogna saper suonare”) Azzolini, antidivo,
professionista serioso, della musica ha il culto di chi suona per consapevolezza e non per
casualità.
Il curriculum è di quelli che si mandano volentieri per i cataloghi dei concerti: inizia a Milano
con il trio Enrico Intra, poi con il quintetto di Basso e Valdambrini: infine è bassista in quasi
tutte le formazioni, combos o big-band: quindici LP, infiniti 45 giri, cinque dischi da “leader” tra
i quali Crucial Moment (inciso nel 1968) ha ricevuto l’Oscar dalla critica quale miglior disco
italiano. Ispirato da Red Mitchel, da Ray Vinnegard e da Ray Brown sugli inizi, Azzolini ha poi
trovato un suo pulsare ritmico, tanto rigoroso quanto disposto a lanciare gli strumenti che
accompagna. I discorsi musicali di Azzolini, condotti con l’archetto, svelano la sua natura di
jazzman che dello swing conosce l’importanza ma, anche, la necessità di non renderlo l’unico
elemento caratteristico di un contrabbassista jazz. Ama i piccoli complessi (What’s happening?
con Franco D’Andrea e Franco Tonani dice quando il trio lo attragga più della big-band) ma nella
grande formazione riesce a trovare il fuoco giusto per sorreggere le sezioni dei fiati.
Il suo modello espressivo rimane comunque quello di un contrabbassista che galvanizzi con il
suono, non con l’atteggiamento, la musica di un piccolo complesso.
Giorgio Azzolini lotta per suonare solo del jazz; rifiuta, quando può, le convocazioni televisive
nelle orchestre commerciali.
Parliamo del futuro del jazz italiano nella sua casa milanese. Azzolini ha trascorso la mattinata
negli studi della Rai ad accompagnare Dora Musumeci (tre ore di blues fuori quadratura, di swing
finto, di jazz da strapazzo: la musica della Musumeci è buon jazz solo per gli incompetenti
funzionari televisivi, dice) ed il discorso è un po’ amaro.
“Mancano i rincalzi. Non esistono i locali per fare del jazz, manca la possibilità di suonare. Leggi
cosa scrive questo critico sul jazz italiano.”
Sono le note di copertina di Whas’s happening?, dove Joachin-Ernest Berendt, dopo aver detto
che Azzoloni è uno dei migliori contrabbassisti da lui ascoltati in Europa, confessa che “resterà
sempre un mistero il fatto che i brillanti jazzisti italiani non trovino maggior riconoscimento. Nel
jazz americano, i jazzmen italo-americani si pongono subito dopo i negri e i musicisti d’orgine
ebraica. Nessun altro popolo ha dato al jazz americano rappresentanti cosi validi come l’Italia.
In Europa però, soprattutto in Italia, i musicisti jazz italiani sono quasi completamente
sconosciuti.”
Qui, in via Tagliamento (tram che sferragliano in strada, appartamento lindo, i dischi in ordine,
la moglie gentile che prepara il caffé) Giorgio Azzolini è contornato da vicini che lo chiamano
maestro solo il giorno dopo che ha accompagnato Gianni Morandi a Canzonissima. Di lui e del suo
jazz, dell’Azzolini vero, non sanno niente. Forse perché potrebbe essere, indifferentemente, un
ragioniere delle Assicurazioni Generali, un cassiere del Banco di Napoli o un notaio. Lui, come
quasi tutti i jazzmen italiani, ha l’aspetto del signore distinto del piano di sopra, dell’italiano
medio, dell’impiegato puntuale, non del trincatore di whisky, fumatore di paglia, hippy per
moda, come il jazzista-medio americano od europeo. Le ragioni di questo perbenismo
dell’abbigliamento (ma quasi per tutti, oltre alla barba fatta e all’ordine formale, c’è anche un
ordine morale altrettanto rigoroso) potrebbe essere spiegato con l’inquadramento orchestrale
RAI-TV (cartellino, libro paga, sissignore). Non credo questo basti a spiegarlo: la ragione più vera
sta forse nel fatto che non esistendo un mondo del jazz italiano, non esiste la necessità di
caratterizzazione tipica dei mondi autonomi. Il personaggio, cioè, nasce come conseguenza del
bisogno di affermare (anche sul piano esteriore) l’appartenenza ad un ambiente, che è spesso
espressione reazionaria nei confronti di un establishment, al quale tende a contrapporsi per
ragioni di ordine sociale, politico e culturale. La camicia bianca e la cravatta dell’Upim degli
italiani sono per prima cosa il risultato di una pigrizia costituzionale (o attaccamento alla
tradizione) e renitenza (sempre più indebolita dai continui stimoli all’acquisto) a cedere alle
mode. Ma più ancora, in questo fatto di avere dei jazzmen asettici, atipici, anodini,
anacronistici, conta l’atteggiamento della massa nei confronti del jazz: a differenza di quanto
accade negli Stati Uniti, dove il jazz è molto meno apprezzato di quanto in generale si creda (è
musica da negri, si suona per accompagnare le cene rozzamente galanti nelle Steak’s House), da
noi il jazz è circondato del rispetto che si deve agli sconosciuti. Non serve, allora, una divisa di
gruppo. Per degli rispettati sconosciuti vanno bene le camicie e le cravatte dell’Upim.
“Il mio sfogo” (dice Marcello Rosa, ex-trombonista della Roman New Orleans Jazz Band,
attualmente leader del New Dixieland Sound, programmatore Rai) “sembrerà quello di un pazzo
o di un frustrato. Ma la situazione del jazz in Italia deve essere affrontata di petto, ormai. Per
anni io, come tutti, ho resistito alle provocazioni passive di chi, almeno in teoria, dovrebbe
rappresentare il potere esecutivo per quanto riguarda il jazz.
Il menefreghismo dei dirigenti e funzionari della Radiotelevisione è assoluto.
Parlo di questo ambiente perché tutti noi sappiamo quale importanza rivesta, sul piano della
ripartizione dei valori da assegnare ai mass-media, la Rai TV.
Ho sempre incontrato incredibili difficoltà per qualsiasi proposta di miglioramento dei
programmi di jazz. Ho ancora nell’orecchio la risposta di rito: ”Ma Lei, maestro, è sempre cosi
intransigente…”.
Programmi a 75 lire al minuto, ignoranza completa a tutti i livelli musicali, tacita approvazione
per i favoritismi ai programmatori: un’attività commerciale senza alcun riguardo per i gusti del
pubblico! Non basta. Oltre all’ignoranza dei funzionari, c’è l’atteggiamento inconscio
(eufemismo: potrei dire in molti casi invidia) da parte di tutti gli ex più o meno falliti che
ricoprono (grazie al jazz che li ammanta di una sensibilità musicale fuori dell’ordinario) cariche
importanti presso le case discografiche, presso la stessa Rai o le redazioni dei giornali. Il loro è
un atteggiamento di sufficienza che rende avvilente, non solo difficile, la vita del jazzman che
insiste.”
Milano. Si cena al Dollaro, tra una prova ed un concerto: pizza e problemi del jazz in Italia. Con
Claudio Lo Cascio si parla più di quanto si riesca a mangiare.
Palermitano, trentasettenne, pianista e compositore, giornalista e funzionario d’industria gruppo
ENI, lo chiamano Acido Prussico (e Polillo ne sa qualcosa della sua acidità, dopo dieci anni di
polemiche su Musica Jazz).
Lo Cascio, in una Sicilia che rappresenta lo schieramento più avanzato dell’apartheid culturale
italiano, si sente un negro bianco e le forme di reazione a questo stato di cose conducono alla
più assoluta e totale autonomia. Lo Cascio ha creato, in questa sua autonoma vita da jazzman,
un proprio studio di registrazione professionale, una propria società (Jazz Society) che da dieci
anni stampa bollettini di informazione, una produzione discografica edita e diffusa in proprio, un
proprio complesso musicale che suona del jazz ispirato dal folklore locale, riproposto come
musica propria: insomma, tutto in proprio.
“La vita di stenti condotta fino ad oggi dal jazz italiano è frutto non soltanto di uno stato di
grave arretratezza culturale, generalizzata nel nostro paese (e di cui la colossale ignoranza in
campo musicale è solo uno degli aspetti), ma anche dell’ostilità (ieri) e della prevalente
indifferenza (oggi) manifestata nei confronti del jazz dalla RAI-TV.
La sua progressiva politicizzazione a tutti i livelli, e soprattutto i costi comportati da tale
politicizzazione, hanno costretto la Rai a realizzare praticamente quasi tutto il proprio
autonomo apparato artistico, cosa che ha messo la Rai inevitabilmente in una condizione di
assoluta dipendenza dall’industria discografica nazionale. Questa, che deve obbedire come
qualsiasi altra industria alle ferree leggi della creazione e del collocamento di un prodotto
industriale, emargina il jazz sia perché questo è, da sempre, una merce povera, sia perché è una
industria che manca dell’attrezzatura mentale capace di farle comprendere ciò che il jazz- pur
con i suoi limiti- può renderle sotto il profilo commerciale: e ciò per gli stessi motivi per cui
l’industria discografica- che non è esente dal gap culturale generale – riesce a creare in Italia
solo prodotti il cui consumo, salvo un paio di eccezioni che confermano la regola, non varca le
nostre frontiere. Oggi, la situazione sembra, ma sembra soltanto, essersi sbloccata. In realtà il
jazz TV non ha fatto passi avanti, semmai il contrario: lo stesso può dirsi della radio dove il jazz
è stato pressoché interamente relegato sul Terzo programma che ha indici di ascolto di gran
lunga inferiori ai due nazionali.Le nuove leve, poi, non appaiono all’orizzonte in numero
sufficiente a garantire un effettivo ricambio dei quadri dei musicisti.
L’unica nota lieta viene dai festival: effettivamente un numero crescente di enti turistici locali,
opportunamente sensibilizzati da attivisti più o meno disinteressati, si va rendendo conto di
potere allestire con il jazz manifestazioni di prestigio a basso costo. Senza l’aiuto di una serie di
concause (intervento della RAI-TV alle manifestazioni, apertura seria e costante dei grandi
rotocalchi al jazz, ecc.) è presto quindi per concludere che la situazione si sia sbloccata.
Nel futuro è ragionevole prevedere una sperimentazione sempre meno ingenua dei mezzi
espressivi offerti dalla musica elettronica e dalla musica concreta. Parallelamente, uno studio
accurato del folklore musicale italiano (su cui tranne rare pubblicazioni manca un panorama
veramente esauriente anche dal punto di vista metodologico) potrebbe offrire spunti e
indicazioni originali ai compositori e in genere ai musicisti i quali dovrebbero ricavare solo il
senso di certe articolazioni del musicale dei vari Ayler, Shepp, ecc., anziché, come invece
purtroppo avviene sempre- ritenersi soddisfatti di una imitazione esteriore dei modelli di oltre
Oceano. Una cosa questa, di cui quasi nessuno dei musicisti attivi in Italia, fatta eccezione per
Giorgio Gaslini ed Enrico Intra, sembra avvertire la mortificazione duplice: del jazzista
imitatore, e del jazz che, in quanto oggetto di riverente ed incondizionata imitazione, viene
svilito della sua enorme importanza di espressione di un sentire universale, espressione alla
quale tutti hanno tutti il diritto-dovere di apportare il proprio contributo, piccolo o grande che
sia. Su questo punto le colpe della critica italiana sono gravi, perché è stata fino ad oggi
incapsulata da una forma mentis che è poco definire provinciale e che ha condizionato la quasi
totalità dei musicisti: questi, infatti, solo in casi rarissimi (e come tali irrilevanti) hanno avuto la
forza di resistere alle prospettive-allettanti anche dal punto di vista promozionale e quindi in
definitiva molto prosaicamente professionale – di una o più o meno incondizionata adesione ad
una impostazione critica la cui assurdità verrebbe automaticamente dimostrata qualora si
potesse calare, per qualche anno, fra noi e gli Stati Uniti- e per estensione il restante mondo
occidentale- una specie di cortina di ferro con relativo embargo discografico e radiofonico.”
Sulla Nuova Rivista Musicale (n. 4, 1968) in un brano di “Diario e viaggio musicale”
Leone Piccioni afferma: “ Conosco molti bravi jazzisti italiani d’oggi: quelli che seguono il
genere tradizionale (in modo forse un poco anacronistico, specie qui in Italia e non sulle grandi
barche del Mississippi); quelli che hanno assimilato il be-bop, il cool jazz ed il new sound, che
sono andati avanti nella loro ricerca avanzata ma in un ambito di struttura melodica (e per tanti
altri nomi, mia sia consentito da nominare almeno Nunzio Rotondo, non fosse altro perché l’ho
ascoltato proprio quando incominciava e so che specie di “orribile fanatismo”, per dirla con
Leopardi, usi contro se stesso in questo suo amore della pura musica jazz); quelli infine che si
sono collocati nella strada di free jazz, capitolo a parte. So in quali difficili condizioni lavorino
in Italia: non incidono dischi, i locali da ballo non vogliono jazz, scarsi sono i circoli e i concerti;
le possibilità di lavoro si riducono alle scarse richieste radiofoniche e televisive (si pensi al
naturale modo della radio di far programmi con dischi e, per il jazz, al parco dischi stranieri di
cui può far uso quotidiano). Lo so bene anche io che non depongo, in alcun modo, l’idea di
programmare in radio molti appuntamenti musicali fissi con il jazz, anche se il cosiddetto – e
certamente attendibile- indice di gradimento, per questo genere, proposto a “recinto chiuso”,
raramente superi il 50%. Pessimo indizio”.
Jazz più radio uguale Adriano Mazzoletti.
Andiamo a prendere il tè in un bar dei Prati, al termine di una giornata in via Asiago. Chiedo a
Mazzoletti un confronto tra il numero delle ore di jazz programmate nelle altre nazioni europee
rispetto all’Italia.
“La nazione che trasmette più jazz è l’Inghilterra, seguita dalla Germania. Ma un confronto di
questo tipo non è possibile senza aver chiarito prima il sistema radiofonico degli altri paesi,
molto differente dal nostro. In Germania, ad esempio, esiste la Comunità delle Radio Tedesche,
nove stazioni legate tra di loro, ma autonome come programmazione, anche dal punto di vista
economico. Così in Inghilterra, in Francia, in Belgio, in Spagna. In sostanza, al di fuori degli stati
dell’Est europeo, il sistema di ente radiofonico unico quale quello esistente in Italia lo si trova
soltanto in Scandinavia, in Grecia e in Irlanda.”
“Nelle nazioni con più enti radiofonici la concorrenza porta il livello culturale dei programmi su
piani più elevati?
“No, assolutamente. La radio italiana assolve questo compito, nel senso che soddisfa le esigenze
culturali di un determinato tipo di pubblico, a mio avviso molto bene, con il terzo programma.
Per ritornare comunque al problema del jazz, in Italia la radio ne trasmette tre ore alla
settimana; più specificamente: tre ore sotto l’etichetta jazz, più i programmi che contengono
del jazz per scelta dei programmatori, più ancora le trasmissioni del tipo di quella di Nunzio
Rotondo ed altre.”
“Quindi in generale, di più o di meno delle altre nazioni europee?”
“Di meno. Sai, l’indice di gradimento del jazz è piuttosto basso, inferiore al 50 %.”
“Quindi la radio dà al pubblico ciò che il pubblico vuole.”
“Non esattamente: la radio dà al pubblico certe cose e poi chiede al pubblico se le ha gradite.”
“In ogni caso le trasmissioni tengono conto, vengono anzi modellate, sull’indice di gradimento.
Ora vorrei chiederti, non senza sottolineare il fatto che la radio in Italia agisce in regime di
monopolio ed ha quindi una precisa responsabilità sul piano formativo e informativo nei
confronti del pubblico, se non ti pare curioso che le programmazioni, con le loro “ implicazioni”
didattiche, vengano impostate chiedendo al pubblico cosa preferisce.
Un po’ come un insegnante che depenni dal programma didattico, se non graditi agli alunni, i
nomi di Sofocle, Eurìpide, ecc.”
“Giusto, ma la radio non ha mai escluso dalle programmazioni nessun fenomeno, musicale o no,
soltanto perché l’indice di gradimento era basso.”
“Per quanto riguarda il jazz ed il suo futuro alla radio, sei ottimista o no?”
“Sono ottimista, certo. In particolare io sono per il jazz italiano, al quale è dedicata la stagione
in corso. Io spero si possa arrivare ad avere un’ora di jazz al giorno, di alta qualità, inteso come
programma di cultura, ricco di informazioni. Non è un’utopia. Penso ci si possa arrivare molto
presto. Il jazz è entrato nell’atmosfera generale, ormai, molto più di quanto non fosse un
tempo. Ventidue anni fa il jazz dovevi davvero andarlo a cercare, e con fatica. Oggi lo senti alla
radio (poco, forse, ma è sempre qualcosa), lo senti nella filodiffusione, nei negozi di dischi, al
cinema, in una infinità di festival. A Roma, Milano, Torino, Genova esistono locali
esclusivamente dedicati al jazz, aperti tutte le sere. Il problema è semmai quello di riuscire a
dare al pubblico un jazz di qualità, sfrondato di tutti i bluff e le falsità che oggi più di prima
esistono. Un tempo si avevano due nette separazioni, di qua poniamo, Duke Ellington e di là,
dico a caso, Perez Prado. Oggi hai una musica molto meno definita nella quale si nasconde tanta
impurità. Non è poi da dimenticare il fatto che la Rai è stata la prima tra gli enti radiofonici
europei ad organizzare un programma come la “Coppa del Jazz” (idea che è poi stata raccolta
dalla RTF francese) programma dal quale sono emersi nomi come quelli di Dino Piana, Franco
Tonani, Antonello Vannucchi, Giovanni Tommaso e molti altri. Ha poi organizzato cinque stagioni
di concerti jazz nelle quali sono passati i nomi dei più grandi jazzmen americani, da Ornette
Coleman a Max Roach, da Lionel Hampton a Barney Kessel, da Slide Hampton ad Art Farmer, ed
in questi concerti il 53% era rappresentato da musicisti italiani.
Cinquantatre musicisti italiani su cento non italiani: il calcolo lo feci a suo tempo per via di una
polemica sorta su Musica Jazz nella quale si lamentava una troppo massiccia presenza degli
stranieri in confronto a quella dei nostri musicisti.
La stagione 1971 la Radio l’ha dedicata esclusivamente ai musicisti italiani, proprio per
permettere una specie di censimento delle forze nazionali. Questa è quindi la situazione del jazz
alla radio. I programmi sono curati da Roberto Nicolosi, Francesco Forti, Marcello Rosa e Nunzio
Rotondo, oltre che da me. Inoltre la radio partecipa a delle manifestazioni internazionali di jazz,
esattamente due ogni anno: una è un concerto internazionale, l’altra uno spettacolo di quiz sul
jazz. I concerti vengono fatti, a turno, in ogni città europea.
Nelle ultime stagioni la Radio RAI ha inviato Sergio Fanni, Dino Piana, Franco D’Andrea, Enzo
Scoppa, Giovanni Tommaso, Cicci Santucci.
“Come avviene la scelta di questi musicisti?”
“Viene fatta secondo la segnalazione della radio straniera che organizza il concerto, la quale
richiede determinati strumenti, pianificando tali richieste in modo uniforme, allo scopo di
evitare la presenza, poniamo, da cinque batteristi. La Rai interpella alcuni musicisti che
rientrano nella suddivisione strumentale che ha ricevuto. Ad esempio, se si tratta di una tromba:
Rotondo, Valdambrini, Fanni, Santucci. I più conosciuti, in pratica, e chi decide di andare, va.”
“Bene. Come giudichi il jazz italiano, in generale?”
“Io sono un grande estimatore del jazz italiano. Vedi, io trovavo nel nostro jazz un grande
entusiasmo, una grande modestia, strumentisti con grandi possibilità…”
“Scusa, usi il tempo passato intenzionalmente?”
“Si, volutamente, perché oggi trovo (anche se continuo ad essere estimatore del jazz italiano,
sia ben chiaro) che queste doti di entusiasmo, di modestia, sono un po’ diminuite. Non lo so
perché. Certo trovo adesso molta presunzione. Gli italiani hanno ancora moltissimo da imparare,
nel jazz. Vi è da dire che il jazz italiano è ancora molto giovane. Soltanto dagli anni ’50 in poi si
è avuto un regolare svolgersi di concerti dei grandi jazzmen americani. Si tratta quindi, tutto
sommato, di un jazz molto giovane. C’è da augurarsi che cresca ritrovando lo stesso entusiasmo
(un entusiasmo enorme, assolutamente enorme) degli anni ’50, con la stessa modestia, ma,
naturalmente, con una diversa maturità.”
Gli strumenti già dentro agli astucci, infilati sotto il piano. Un disco di Coltrane che gira, qui al
Blue Note, con la voce raschiata dei dischi ascoltati troppo, un ultimo whisky e il pensiero
“Serata gradevole”, quello che si pensa quando si è delusi, per non ammetterlo, con un Jean Luc
Ponty che, qui a due passi, è meglio che a teatro, ma non riesce a trovare la scintilla, perché
non può convincere soltanto girando le manopole del megageneratoresuperamplificato.
Prima, il locale scoppiava di folla (Pepito Pignatelli rideva con gli occhi), tutto ribolliva dello
swing nato dalla poliritmia di Aldo Romano inanellata con le sincopi di Michele Graillier, suono
forte, pulito, un basso deciso, un pulsare viscerale: Ponty (occhi chiusi, gambe strette e piegate
ad inseguire le fasce sonore che l’archetto non fa in tempo a finire, tensione, volto da monello
capellone) crea ondate di scale, frasi musicali formate dalla somma di periodici e non di note: il
volume cresce (ginocchia strette), la spirale diventa ossessiva (è tutto contratto), il ziz zag
dell’archetto è al parossismo (è quasi inginocchiato a terra)!
Poi tutto sfuma, ci si accorge di respirare di nuovo, lo stomaco si decontrae
(“Una sigaretta, per piacere”), Jean Luc posa il violino e ridiventa un ragazzino con gli occhi
guizzanti. Locatelli, il chitarrista, nella “cave” gremita, con meno spazio sonoro, meno bisogno
di generare suoni apocalittici, suona quasi bene.
E’ così per un’ora (poi ancora intervallo, con il fruscio dei dischi immortali sentiti tante volte),
dopo Ponty di nuovo. Alle due e mezza (i rimasti sono sette, più il barman) uno pensa: “ serata
gradevole”, per non dire chiaro a se stesso che questo Ponty ( adesso) procede per linee
stereotipate, che crea delle immagini belle, ma vuote, molto sonore ma insignificanti, calde ma
gelide; che suona per formule, lui! Il numero 1 del jazz europeo. Il dubbio allora incomincia a
prendere forma. In breve si avvia a divenire consapevolezza: “Siamo noi ad essere fuori dal giro,
non possiamo opporci alla moda, la potenza sonora ha un significato, il lavorio delle manopole è
il nuovo codice.”
L’ultimo whisky mette quasi tutto a posto, colloca in ordine la confusione delle idee, quasi non
c’è più da pensare al problema, ormai è risolto: viva il rumore!
Gli strumenti già dentro agli astucci, qualcuno reclama la jam ( “Dai, è ancora presto”).
Giovanni Tommaso sfodera il contrabbasso, il chitarrista capellone dorme come un orso a bocca
aperta, Graillier passa al pianoforte a coda, Aldo Romano torna alla batteria e butta fuori il suo
uragano percussivo (uno swing, implicito, formidabile) e Jean Luc, il monello di Avranches,
arriva saltellando, riapre la custodia dei violini, imbraccia quello rosso, regola al minimo le
manopole e manda all’aria, frantuma, fa a pezzi l’ordine nuovo che si era appena dato alle cose.
Non è più rumore, è jazz di livello fantastico, pieno di frasi così fitte di idee che ognuna ne
genera altre venti (che poi si spaccano, fuchi artificiali, mille luci in tutte le direzioni); il free
jazz dei quattro è un discorso ricco di stimoli. Sale il volume solo per portare a galla un
significato.
Il calore è autentico, la bellezza indiscutibile, lo swing trascinante. Ponty è quasi inginocchiato,
si sfibra in una donazione totale di ogni briciola di energia; l’onda che sale (si va al parossismo)
non è più frutto di un cliché, è jazz autentico, è carica emotiva liberata dal peso delle formule,
un tappo di bottiglia che sbatte sul soffitto: questo è Ponty alle tre del mattino, in sette a
sentirlo, monello felice, insensibile alle mode, grande jazzman, ragazzo con la scintilla.
Si va a casa credendo ancora al jazz, a quello che viene fuori nei club quando i metronotte
infilano i biglietti nelle saracinesche, le ore giuste per non aver più voglia di bluffare con il
mondo e con se stessi.
Poi, giorni dopo, ne parlo con Giovanni Tommaso, di questo Ponty new look.
Tommaso ha suonato in America per quattro anni, dal ’60 al ’64, ha inciso con Lee Konitz, Chet
Baker, Barney Kessel. Con John Lewis ha registrato la colonna sonora di Una storia milanese. Si è
formato con Antonello Vannucchi nel Quartetto di Lucca.
Lui pensa, che il monello Ponty abbia suonato in modo diverso soltanto perché inseriti in una
jam session con una atmosfera già tratteggiata, classica.
Ponty (il discorso è su lui, ma parlando del suo jazz ci si riferisce soprattutto al jazz europeo in
generale ed, in sostanza, al jazz tout-court) sente di dover mandare avanti un discorso e lo fa
procedendo per sintesi nate dalle esperienze della musica dei giovani del mondo.
Su una cosa siamo d’accordo: che Ponty (e per lui il jazz) si avvale di questa piattaforma sonora
come di un ponte per scendere in un punto che nessuno conosce ancora. Se questa nuova forma
(l’etichetta, già pronta, è di pop jazz, ma vogliamo proprio incollarla?) è un mezzo per andare
avanti, bene: in marcia.
Franco Fayenz, Padova, 1930, musicologo, dall’immediato dopoguerra si interessa di musica
classica e di jazz. Dal 1951è redattore della rivista Musica Jazz e collaboratore di numerosi
giornali e riviste. Nel 1962 ha pubblicato il volume I grandi del jazz, nel 1970 Il jazz dal mito
all’avanguardia e nel 1971 Anatomia elementare del jazz.
“Caro Cogno,
la richiesta di una testimonianza sul jazz italiano mette un poco imbarazzo chi, come me,
s’interessa al jazz ormai da molti anni, e quindi si sente, in qualche modo, corresponsabile della
situazione. D’altra parte mi offri un’occasione di parlare con franchezza, e te ne ringrazio.
Il nostro jazz, in Europa, occupa una posizione di retroguardia, su questo non c’è dubbio,
quantunque in questi ultimi tempi il quadro clinico sia andato migliorando. Le cause sono
numerose. In ordine di tempo ci sono il fascismo e la seconda guerra mondiale. Gli amatori più
anziani si ricordano bene di quando ascoltare un disco di jazz tra amici equivaleva, pressappoco,
a girare la manopola su radio Londra. L’atmosfera era la stessa. I nostri governanti in orbace
avevano cominciato durante gli anni trenta ad opporsi alla diffusione del jazz, la musica di una
razza inferiore, per di più proveniente dalla plutocrazia americana, e comunque dall’estero,
avrebbe potuto fuorviare la coscienza granitica dei giovani fascisti.
Erano i tempi in cui ci si dava del voi, il bar era diventato il quisibeve, lo sport si chiamava il
ludo. E’ troppo facile riderne, oggi. Deve trattarsi di un tarlo sotterraneo dell’anima nazionale,
visto che si diletta ancora di simili argomenti. Anche le poche etichette di jazz ne soffrirono. St.
Louis Blues, per esempio, fu italianizzato come Le tristezze di San Luigi, On The Sunny Side of
The Street, fu ribattezzato, non senza preteste poetiche, Dal lato aprico della strada:
Honeysuckle rose divenne Pepe sulle rose, ma la sfortuna maggiore toccò a un brano del
Quintetto dell’Hot Club de France, HCQ Strut, che evidentemente pose agli acuti traduttori dei
problemi insolubili: ogni preoccupazione di fedeltà all’originale venne messa da parte, e il titolo
italiano fu Signor commendatore pazzerellone. Il nome di Louis Armstrong fu tradotto in quello
di Luigi Braccioforte e quello di Benny Goodman in Beniamino Buonuomo.
I cinque anni di guerra e di separazione dalla fonte primaria del jazz, gli Stati Uniti, fecero il
resto. Fino al 1945, il jazz italiano è stato sporadico, pionieristico, quasi eroico.
Scontiamo dunque una partenza ritardata, sia nel suonare il jazz che nel giudicarlo. Ma questo
spiega solo in parte lo stato delle cose. Anche la Germania è partita dal medesimo start, ma si
trova a un punto ben più avanzato del nostro. La verità, caro Cogno, è che malgrado i luoghi
comuni in contrario l’Italia non è un paese musicalmente educato. Dalla nostra scuola, a causa
dell’apprendimento globale e nozionistico suggerito dall’idealismo, che guarda con diffidenza le
tecniche settoriali, la musica è stata esclusa per lunghissimo tempo. Mi chiedo che cosa
accadrebbe se da noi, come si è potuto fare senza difficoltà in Inghilterra, venisse programmata
la commedia musicale di Crozier e Britten “Facciamo un’opera“, nella quale- è Giorgio Pestelli,
che ce lo ricorda- “Ad un certo punto a fare l’opera partecipa anche il pubblico, il pubblico
nuovo e occasionale di tutte le sere, che canta la musica leggendola semplicemente su un foglio
distribuito all’ingresso del teatro”
Meglio non pensarci. E’ chiaro di ciò ha sofferto e soffre anche il jazz. Attualmente la musica è
materia obbligatoria d’insegnamento per un solo anno nelle scuole medie, ma non ha influenza
sul profitto. Pertanto l’ora di musica è analoga a quella che ai nostri tempi era (e mi si dice sia
tuttora) l’ora di religione. Non oso prevedere che il miglioramento in atto nel jazz diventerà
travolgente, a breve scadenza, per l’apporto delle nuove leve avviate all’amore per la musica
della scuola dell’obbligo.
La nostra ineducazione musicale ha avuto i riflessi più clamorosi, per quanto riguarda il jazz,
nel corso negli anni cinquanta, durante l’esplosione europea del dixieland revival. Salvo
eccezioni, le peggiori orchestre di dilettanti sono state quelle italiane, e il jazz suonato male,
com’è noto, è insopportabile, fa una pessima propaganda a se stesso, aiuta la missione a
rovescio della radiotelevisione. Purtroppo nello stesso periodo la critica specializzata ha
commesso un errore tattico, comprensibile ma non lieve: dopo aver aiutato, direttamente o
indirettamente, perfino la più sprovveduta delle bande paesane, ha perso la pazienza, ed ha
avuto parole dure per tutti i musicisti, sia dilettanti che professionisti.
Al jazz italiano è venuto a mancare il terreno sotto i piedi, un terreno che in ogni caso non è mai
stato piano e praticabile. Ci sono stati anni oscuri, caratterizzati dall’estrema difficoltà di
organizzare concerti con musicisti nazionali, e ci sono state orchestre anche pregevoli che non
hanno potuto farsi luce per il solo fatto d’esser nate in una città di provincia, anziché a Milano o
a Roma. Molti musicisti hanno assunto posizioni polemiche ed hanno additato ad esempio il
comportamento della critica francese, che ha sempre sostenuto oltre misura i propri jazzisti. Si
deve a questo, essi affermano, se nella Francia degli anni settanta ci sono Martial Solal, Jean
Luc Ponty e un pubblico vasto, reattivo e cosciente, con tutte le conseguenze del caso.
D’altronde, se questo è vero, la ragione, come spesso succede, è ben lontana dall’essere tutta
da una parte. Ognuno di noi può segnare a dito dei jazzisti italiani che studiano poco, non si
tengono informati, e accompagnano questo atteggiamento con una presunzione sconfinata e
irritante, che fa scappar la voglia di dargli una mano. Nel recente passato, più d’una volta ci
siamo fatte delle illusioni, smentite dal primo confronto con un solista francese, tedesco,
jugoslavo. I più seri fra i nostri professionisti lo ammettono apertamente.
Ho già accennato che oggi la situazione sembra stia per uscire dall’impasse. La critica è
predisposta per davvero a rinnovare la cambiale ai jazzisti di casa, mentre i musicisti si stanno
impegnando maggiormente; viene alla ribalta qualche nome nuovo e le possibilità obbiettive
sono migliorate, grazie a numerose tournèe di artisti americani, che hanno spiantato la strada.
Non esito a dichiararmi fra i più convinti fautori del nuovo corso. Da un buon jazz italiano
abbiamo tutto da guadagnare. Certo è che una nuova delusione sarebbe irreparabile: me per mio
conto ripongo molte speranze in Giorgio Buratti, contrabbassista e leader trascinante, del quale
ho ascoltato cose splendide ancora inedite: nel pianista e compositore Enrico Intra, che in questi
ultimi tempi mi par cresciuto a vista d’occhio; nei bravissimi Cicci Santucci, Enzo Scoppa, Franco
D’Andrea; in Giorgio Gaslini, compositore di ampie vedute e pianista eccellente: nei sempre
validi Oscar Valdambrini, Gianni Basso, Giorgio Azzolini e in altri che mi permetto di non citare,
perché i loro nomi non direbbero ancora nulla.
Per quanto riguarda l’originalità o meno del jazz italiano (se sia preferibile, cioè, che esso si
ispiri ai modelli americani, e si aggiorni secondo i medesimi, oppure se sia da incoraggiare la
ricerca di un’autonomia e di un linguaggio che, in qualche modo, si proponga come europeo) ti
confesso che il problema mi interessa poco. L’importante mi pare, è che si faccia del jazz di
qualità. Nondimeno, al limite, preferisco il ricalco degli americani, dal quali non vedo come si
possa prescindere, piuttosto che la ricerca di un’originalità a tutti i costi e di punti di
riferimento europei che porti ad elaborazioni ibride, discutibili e inutilmente complicate.
Tuo Franco Fayenz”
“Il Buratti è uno che dà fastidio a tutti”.
Me lo dice non appena entro nel suo superattico elettronico, pareti acustiche, piano, basso,
batteria, dieci bass- reflex, camera di regia per le registrazioni, pipe, tabacco e whisky. Un
regno.
Qui si può jazzisticamente, nascere, vivere e morire. Giorgio Buratti ha fatto una decina di
concerti, sempre ottenendo ottime recensioni.
“Pochi; vorrei farne di più. Questo mi permette di maturare tra un concerto e l’altro e di
presentare cose sempre nuove, ma rinuncerei volentieri a questo vantaggio pur di poter suonare
di più in pubblico. L’atmosfera del concerto è irrepetibile. Per me poi è tutto. Quando dico
tutto, forse non riesco a dare realmente l’idea di cosa significhi per me fare del jazz. Mi sono
costruito le apparecchiature” (Buratti è un tecnico di automazione elettronica) “per lavorare
come voglio io, per vivere immerso nel jazz in ogni momento. Non ho voluto, per non scendere a
compromessi, vivere professionalmente di musica e mi sono scelto il mestiere più vicino. Ora
posso lavorare come voglio io. Da tre ore di registrazioni, ne tiro fuori, se è il caso, venti minuti.
La composizione è a posteriori. Lavoro di forbici. I miei dischi sono frutto di mixage,
sovrapposizioni, effetti sonori. Io ad esempio giro con il registratore per le fabbriche, fermo i
rumori della natura. Adesso, noi, parlando, stiamo creando, senza accorgercene, delle
modulazioni, dei salti di tono. Io registro sempre, anche le voci degli amici qui dentro, quando
proviamo. Poi prendo degli spunti meravigliosi: sto preparando un disco di musica elettronica,
una specie di concerto nato dagli stimoli sonori di una conversazione di gruppo.”
Giorgio Buratti è un personaggio.
Di lui mi hanno detto molto bene e molto male. Franco Cerri, che gli ha insegnato le prime
posizioni sul contrabbasso, dice che è un bravo elettronico. Giorgio Azzolini (ma bisogna cavargli
il giudizio in bocca, ha rispetto per tutti) mi ha detto che il solo guaio è che non sa suonare il
basso. Io credo che a musicisti come Buratti non si possa mettere davanti una forca caudina
fatta di prime e seconde posizioni sulla tastiera, di passaggi con l’arco, di pizzicati a 600 battiti
di metronomo.
Buratti è genuinamente, un uomo di jazz. E’ un trascinatore, un istrione produttivo.
Mi stordisce di whisky e di fumo di pipa, con una Milano molle di caldo che tremola di fuori,
sotto di noi. Ha messo in azione la stanza dei bottoni e siamo avvolti da un’onda di suono
apocalittica.
E’ inutile discutere. E’ il titolo del disco che sta girando. L’ha registrato in questo studio nel
’68. La note di copertina, di Daniele Ionio, sono stimolanti:
“Bisognerebbe cominciare con il chiedersi perché si fa del jazz. O forse, addirittura, perché lo
si ascolta. L’oggettivazione è infatti la carta segreta dei musicisti europei che non vogliono
cadere nell’imitazione. Il linguaggio jazzistico viene in questo caso usato e ricondotto
all’atteggiamento musicale tipico della cultura europea. Oggi questo modo ha finito per
dimostrare il fondo di alterità di chi lo pratica nei confronti del linguaggio jazzistico e di quella
realtà e cultura che gli stanno dietro. L’altra strada, tutto sommato, è ancora più facile, se ci si
limita al puro gioco: l’adozione del linguaggio jazzistico finisce pur sempre per essere una sua
più plateale utilizzazione e ovviamente , l’alterità rimane. E’ la strada seguita da Giorgio
Buratti, non senza coraggio, adesso che è svanito anche l’alibi della musica proibita. Buratti ha
scelto il jazz non per funzionalizzarne il linguaggio né per farsi funzionalizzare: ha rinunciato al
compromesso con la musica che gli sta alle spalle per virtù di generazioni e abitudini d’ascolto.
E’ europeo, e il suo atteggiamento culturale non è aggirabile. Fin dai primi passi, ha buttato nel
linguaggio, che pur s’era scelto, non una equivoca immedesimazione nell’altra realtà, ma una
sua inquietudine esistenziale di europeo che, nel jazz, cerca una continua verifica…”.
Buratti mi parla della scelta dei titoli. Lato A :
Cadenza per una rivoluzione, “E’ il ritmo, lo schema, il sistema integrante. Infatti qui puoi
sentire la cadenza del tema tradizionale sul quale viene, prima gradualmente, poi sempre più in
evidenza, il rovescio di tutto quanto: io sovrappongo il violoncello, Pat Neuburg il solo bocchino
del sax, Barney Martin una seconda batteria: la rivoluzione! La rivoluzione crea Il problema, che
esiste, innegabilmente, non lo si può risolvere soltanto a parole,
E’ inutile Discutere, bisogna agire, anche se non vuoi, devi arrivare alla Violenza, Facciata B: a
questo punto ci si chiede Cosa si può fare. Bisogna rifare qualcosa. Si torna allora ad una
Situazione d’inizio, la quale porta a Nuove idee, le quali, inesorabilmente, portano a Nuove
violenze.”
Il fondo del discorso è amaro. E’ l’utopia spiegata al popolo.
Fuori è sempre più sera. Copio la biografia: nato a Milano il 21 maggio 1935. Nell’ottobre è al
Festival del jazz di Bologna con Enrico Intra e Franco Mondini, poi incide il primo disco sempre
con Cuppini, partecipa l’anno seguente al Festival del jazz di Sanremo e nel giugno ’60 vince la
Coppa del Jazz. A settembre dello stesso anno è a St. Vincent, nel ’61 nuovamente a Sanremo e
sempre con Cuppini prosegue l’attività nei festival principali sino al ’62. Forma il suo primo
complesso, con Al Korvin, Enrico Rava, Gato Barbieri, Angel Pocho Gatti e Jimmy Pratt, che
riduce a quartetto nel ’63 con il quale, oltre a girare in Jugoslavia, vince il 1° Festival del Jazz
Contemporaneo di Foligno. Nel ’64 suona a Bologna prima del suo idolo Charlie Mingus. Nel ’66
sperimenta un nuovo sestetto, con Valdambrini, Fasoli, Piana, Barigozzi e Cuppini; nel ’68 incide
con Pat Neuburg e Barney Martin, per arrivare al ’69 in cui scopre Sante Palombo (o meglio,
Palombo dimentica di aver accompagnato per anni Tajoli e scopre il jazz): sono con lui Eraldo
volontà e Carlo Sola. Nel ’70 incide e si esibisce a Lerici e Padova con il nuovo quintetto formato
da Fanni, Volontà, Palombo e Liguori. Nella primavera del 1971 pubblica la registrazione
effettuata con i musicisti di Charlie Mingus durante il Festival del Jazz di Milano del 1970.
Ora l’orgia di suoni si spegne e nel suo regno al nono piano il megamusicista Buratti deposita
pipa e whisky. Dixie, il cane jazzofilo, ci segue triste per le scale. Per lui senza musica, come
per Giorgio Buaratti, non c’è vita.
Eraldo Volontè (figlio d’arte, cinque anni di violino poi abbandonato per il sax, anni di giri nelle
balere dell’hinterland milanese) è dalla vecchia guardia. Quando nacque si sparavano le ultime
fucilate sul Carso, nel ’18 ma ancora sembra, perché lo è dentro, un ragazzo. I dischi, nel ’64
l’avventuroso My Point of View, nel 1966 Jazz (now) of Italy premiato con l’Oscar della critica
quale miglior disco dell’anno, ed il recente Free and Loose, fanno pensare ad un personaggio
grintoso, provocatorio.
Quando lo scopro timido, dolce, introverso, mi chiedo chi è Eraldo Volontè? L’uomo timido o
quello deciso dei dischi, dei concerti? Il Volontè vero è solo il musicista.
In questo caso l’Uomo è solo un’immagine sviante, che non serve a chiarire il personaggio. Lui
farebbe a meno di parlare (sarebbe una fatica risparmiata) perché le cose che vuol dire le fa
passare attraverso l’ancia dello strumento.
Nel 1966, da mesi in ospedale per una grave affezione renale, e clinicamente quasi morto, si
rimise per la solo idea fissa di ricacciarsi in bocca il sassofono. Quando i medici vollero
impedirglielo, pensò realmente di farla finita. Suonò invece, meglio e più di prima. Il primo
concerto lo diede proprio in ospedale e fu il suo grazie alla gente in camicie bianco.
Suona ore su ore alla Rai, poi, quando torna a casa, studia ancora almeno un’ora al giorno.
Nauseato dal Cantagiro, rimpinzato di stupida musica televisiva (“di jazz si muore, ma per
fame”) ascolta Coltrane e Rollins con la cuffia per notti intere.
Così dal 1947, quando formò la sua prima big-band con Gil Cuppini, Impallomeni, Boneschi,
Ceroni, De Serio; poi con Pino Calvi e Giorgio Gaslini. Nove festival del Jazz di Sanremo: conteso
in tutte le sezioni delle grandi orchestre, compresa quella di Bill Russo che, parlando di
strumentisti italiani, indicò come strumento meglio suonato il sax-tenore a aggiunse: “Volontè
ne è un esempio.”
La frase ha voluto che la leggessi io, riportata su un vecchio fascicolo di Musica Jazz, per quel
pudore che Volontè ha del parlare di sé.
Ora sto pensando che a Eraldo Volontè (e con lui molti altri) sarebbe bastato nascere in America
per ottenere una diversa valutazione. Qui dobbiamo conservare nell’album dei ritagli le frasi di
elogio di un Bill Russo (il buffetto di incoraggiamento del papà quando gli mostriamo un nove sul
compito in classe); mi sto chiedendo se è giusto buttare una vita per il jazz, mettersi la cuffia
agli orecchi per purificarsi, dare anche i visceri in quei chorus in cui si cerca di condensare le
convinzioni, le esperienze, il motivo vero per cui si tira avanti: mi chiedo se è giusto.
Volontè, e con lui moti altri, è in credito di un riconoscimento che non è venuto, per tanti
motivi, nella misura giusta. Giorgio Gaslini ha firmato le note di copertina di Free and Loose ed è
indicativo che si sia espresso con affermazioni di simile chiarezza: “Riuscire a iniziare un
discorso lirico e a proseguirlo per anni ad anni come ha fatto Eraldo Volontè sin dal 1945 ad oggi,
è un fatto decisamente importante. Perché di lirismo si tratta, di lirismo vero, passato
attraverso un’attenta, fedele e dotata natura di musicista, filtrato da una autentica spiritualità
di uomo. Nella musica di Volontè vi sono sia le ragioni sociologiche, sia quelle del personaggio,
sia quelle della ricerca. Quelle sociologiche, perché esprimono la condizione che la società
impone al musicista italiano; quelle del personaggio, perché dalla sua musica, Eraldo Volontà
traspare con quella delicatezza umana che lo contraddistingue e che lo rende caro; le ragioni
della ricerca, perché, specialmente nei soli, vi è uno studio sugli intervalli melodici del tutto
contemporaneo e sorprendente nel panorama del jazz italiano, così dotato, ma anche così poco
ricercatore. Volontà raggiunge un livello validissimo di ricerche jazzistiche musicali. E vi arriva
attraverso le vie giuste del jazzman moderno.”
“Enrico Maria Salerno” (è lui a dirmelo, nel camerino del Quirino a Roma, in vestaglia a righe, in
relax pre-spettacolo) “ non sarebbe quel attore conosciuto che è se non ci fosse stata la
televisione. Io penso che il jazz debba essere strumentalizzato, cioè accostato al grossissimo
pubblico. Mi pare di che consideriate il jazz come un fatto di èlite, invece è una musica
altamente, profondamente popolare.”
Un fatto di èlite? Quali le cause?
“Non si può dimenticare che i rotocalchi (penosi!) tendono a creare, prima ancora che delle
manifestazioni artistiche, dei personaggi. Probabilmente la stampa non ha creato un personaggio
del jazz, in Italia. Forse creare, non dico il divo, ma il personaggio, aiuterebbe a sfondare presso
quel tipo di pubblico che oggi è assolutamente digiuno di jazz. Eppoi, forse gli Enrico Intra, i
Giorgio Gaslini, che sono grandissimi musicisti ma non vivono in una certa maniera, non si
dimenano in un certo modo, non si mettono la conchiglia sull’inguine come molti individui della
musica leggera, interessano meno, sono forse proprio i meno seguiti da un punto di vista
popolare.”
La grossa finestra dalla quale far entrare l’ossigeno per il jazz, dove si apre: sul teatro? Sul
cinema? Dove?
“Sulla radiotelevisione, perché attraverso il teatro il jazz rischia di rivolgersi ancora ad una
èlite, quella stessa che oggi frequenta (e non sono più di quaranta, cinquanta, sessantamila
persone) il teatro, che è un genere di spettacolo che affascina e spaventa, un po’ medioborghese, quindi una cerchia di pubblico che ha un ricambio ridottissimo.”
I giovani non si inseriscono in questo ricambio significativamente?
“Si, certo, ma un fenomeno di volgarizzazione, nel senso di rendere noto ad un grande pubblico
il jazz, rimane un fatto radiotelevisivo. Come ho detto, Giorgio Albertazzi, io e molti altri attori
saremmo noti soltanto a quelle sessantamila persone, senza la televisione. Mi sembra che
bisognerebbe trovare il modo di sensibilizzazione i responsabili di questo grosso mezzo, magari
facendo uno spettacolo che non sia completamente di jazz, perché probabilmente questo
lascerebbe molti spettatori perplessi. Non si può dare un piatto cinese a chi ha sempre mangiato
bistecche alla fiorentina. Si può arrivare a gradi, a questo, inserendo il jazz nei grossi spettacoli
del sabato sera, non isolatamente, ma contornandolo di un tipo di spettacolo che possa far
accettare anche al grosso pubblico.
Quanto questo possa piacere, non lo so. In ogni caso manca la prova contraria per bocciare la
cosa. Le leve da manovrare e le pressioni da fare, secondo me, sono in quella direzione, proprio
per farlo conoscere, per dare almeno alla gente la possibilità di esprimere una opinione. Il jazz
a teatro è subito un sinonimo di concerto, e questo è automaticamente un fenomeno selettivo.
Anche le presenze televisive dei musicisti che prima ho citato, Intra e Gaslini, hanno sempre
avuto un valore di concerto.
Forse questo è sbagliato: il jazz io lo vedrei a Studio Uno, a Canzonissima, nel grande spettacolo
popolare. Diversamente aumentiamo il culto del jazz come fatto d’èlite.”
“Cinema. Prospettive?”
“Gli sviluppi in questo senso sono da rapportare alla scelta che i registi e gli autori compiono
nell’attimo in cui concepiscono l’opera. Se la scelta include il jazz, piuttosto che l’opera lirica o
la canzone napoletana nella tematica che l’autore intende illustrare, allora esistono delle
possibilità. E’ un fatto di scelta, quindi. Certo la scelta fatta da questi uomini di spettacolo può
venir condizionata dalla loro più o meno buona conoscenza del jazz.
Sono convinto che il jazz debba essere proposto con i grandi mezzi di diffusione anche perché
non perderà nulla nel diventare un grande fatto popolare. L’approccio deve solo essere dosato
con intelligenza, perché l’omino che guarda la televisione ha dalla sua il tasto per il cambio di
canale.”
Umberto Cesari è entrato nella leggenda.
Pianista geniale, pilota di jets, medium, corridore, automobilista, adoratore di Art Tatum, ora
vive (uomo triste o felice?) dietro i vetri di una finestra, a guardare il mondo del quale non vuole
fare parte.
Nel 1950, trentenne, sbalordì l’Italia con la sua tecnica incredibile e venne considerato il miglior
pianista italiano. Suonò a lungo alla radio, incise con Pes e Loffredo, in trio, e con il quartetto di
Aurelio Ciarallo.
Adesso di Cesari si parla come si usa fare per le figure mitiche, con affetto, rimpianto,
ammirazione. In un’epoca votata alla divulgazione, al consumo, allo scambio informativo, un
pianista che non divulga, non consuma, non scambia informazioni e vive in una stanza guardando
il mondo da dietro i vetri ha, in effetti, qualcosa di irreale e magico.
E’, anche se vivo, già uomo- leggenda.
Chiedere ad un giovane musicista se conosce il nome di Cesari sarebbe tempo perso.
Non saprebbe chi è. E’ fuori del mondo.
Chiedere a Cesari se conosce il mondo è tempo perso.
E’ fuori dalla finestra.
Franco Pecori. Redattore di Film Critica. Insegna cultura cinematografica agli studenti di una
scuola statale media di Roma. Collabora a Musica Jazz dal 1966. E’ copywriter presso un’agenzia
di pubblicità romana.
“Caro Cogno, mi chiedi un intervento sulla situazione del jazz in Italia. Rispondo volentieri.
Maxicritica e minimusica.
C’è da chiedersi quale discorso si possa fare oggi nei confronti di una cultura che a tutti i livelli
e in tutti settori (anche quello jazzistico) bada quasi esclusivamente a salvare la faccia e a
mantenersi aperte le porte delle corti socialdemocratiche.
Da noi si continua a parlare di universalità dell’arte (e del jazz), ma di universale c’è solo il
maxicappotto dei critici: questi fedeli servitori, che si allineano ogni volta col nuovo padrone. In
termini tecnici (e attuali): inglobamento del free come fatto ormai acquisto e corteggiamento
delle ultimissime correnti del free-pop, che a differenza del free, lasciano intravedere qualche
spiraglio per un inserimento nel mondo della prostituzione e della pornografia discografiche.
Parlo del free perché è il nodo principale della cultura jazzistica degli ultimi tempi.
Nel giro di pochi anni il free si è trovato due volte contro la testarda opposizione delle tendenze
reazionarie. Un po’ come il socialismo: prima i “ liberal- clericali”, poi la “socialdemocrazia”. E’
una specie di rigurgito periodico delle forze retrive della società.
Un libro-inchiesta sul jazz italiano, è in questo momento, una cartina al tornasole per verificare,
da un punto di vista eccentrico, ma per molti versi estremamente significativo, l’ottusità,
l’arretratezza e lo snobismo di provincia della cultura italiana, sempre a metà tra l’entusiastica,
acritica adesione alle nuove ventate e la pregiudiziale, idealistica opposizione ad ogni proposta
concretamente rivoluzionaria.
Lode a te, Cogno. Temo che, però la situazione non si muoverà. Perché non è questione di
correnti, di rinnovamenti, ecc…ma semplicemente di onestà, di autenticità.
Dice: ma il jazz non lo fanno i musicisti?
E, infatti, questo discorso non è solo per la critica. Però, chi fa il jazz in Italia?
Lasciamo stare i tradizionalisti, per i quali è sufficiente ripetere la domanda di Spelman, citato
da Leroi Jones nel suo libro Il popolo del blues: “ Chi sono questi signori bianchi che si sentono
paladini del blues dell’altro ieri?”..
Ma anche i moderni, chi sono? Sono una cultura?
A me sembra che la regola sia il conformismo. Si fanno discorsi di punta in salotto, con tutte le
mogli riunite che frattanto si raccontano del parrucchiere (mettere insieme un resoconto
significa fare un campionario di pettegolezzi. Sono salotti: ci sono tutti gli elementi più tipici,
compresa la compiaciuta accondiscendenza di chi presta il registratore o la tipografia).
E poi si fa la musica del conformismo, delle frustrazioni e delle sclerosi di musicisti professionisti
mortificati da pesanti turni commerciali.
Le pochissime eccezioni non autorizzano a parlare di jazz italiano. Allora invece di stabilire una
scali di valori, facciamo un discorso indiziario. Si sa che la funzione dell’arte si è andata sempre
più delimitando: dalle intenzioni risolutorie degli anni ’30, alla protesta , alla semplice denunzia
ed ora alla testimonianza, all’inizio. Chi ha nostalgie? Ebbene, una cosa è sicura, credo: un’arte
indiziaria pone l’artista di fronte a scelte precise, a tutti i livelli. Se queste scelte si fanno in
maniera autentica, si hanno prodotti senza significato autonomo; prodotti che non indicano
alcuna direzione, perché in realtà manca un’intenzionalità autentica, una vera coscienza della
comunicazione come in-tenzione che trasformi la realtà non significativa in realtà con un senso.
Ora, per il jazz italiano in genere, il fatto rilevante di questi ultimi tempi è un fatto di ordine
organizzativo. Alcuni strumentisti hanno intrapreso una specie di crociata per difendere il loro
valore di musicisti e il loro diritto all’attività jazzistica ufficiale in un paese musicalmente
sottosviluppato come il nostro. La musica però è rimasta sempre la stessa: ad ascoltare la
maggior parte dei jazzisti italiani si rimane profondamente delusi. Non perché non siano bravi
strumentisti: alcuni sono degni del massimo rispetto. La loro musica, però, si muove in una
dimensione manieristica e la sua debolezza non è che il portato della base retorica (di tipo
mistificatorio rispetto ai referenti americani equivocamente modellizzati) su cui poggia. Sicché,
non mi pare che si sia differenza tra il jazz italiano del dopoguerra e quello degli anni ’50, tra il
cortese adeguamento ai dettami dei grandi post-parkeriani (fino a Coltrane) e il tronfio
competitismo di certi avanguardisti, che fanno il free pensando a Firenze e Raffaello (noi che
abbiamo Firenze e Raffaello…..sono frasi, che si sentono nell’ambiente).
E’ inutile snocciolare la solita decina di nomi, la situazione è sempre la stessa. Con la differenza
che oggi i jazzisti pretendono di fare i discorsi teorici e magari anche di punta. Oppure prendono
delle iniziative di ordine pratico, come quella a cui accennavo sopra. Intendo dire l’Unione
Italiana Musicisti da Jazz, costituitasi il 22 settembre ’69 ( soci fondatori: Gianni Basso, Giorgio
Gaslini, Carlo Loffredo, Franco Tonani, Dino Piana, Umberto Santucci, Francesco Forti, Giorgio
Azzolini, Oscar Valdambrini, Marcello Rosa, Franco D’Andrea), e l’intento di “valorizzare e
promuovere l’attività dei musicisti italiani di jazz, in Italia e all’estero.”
Certo una nobile causa. Dal resto, l’iniziativa si giustifica pienamente in riferimento alle
condizioni veramente misere in cui la musica è costretta a vivere dalla dittatura schiacciante
della canzonette. Un maggior contatto col jazz non potrebbe essere che educativo per il
pubblico italiano.
Senonchè, a leggere poi lo Statuto dell’Unione, vien fatto di chiedersi se proprio si debba
schierare in linea di principio con chiunque tenti di organizzare un’opposizione allo stato
attuale. Nessuna arte, e nemmeno la musica, è mai pura; questo è un equivoco idealistico.
Altrimenti, non si capirebbe la nascita e la relativa fioritura della dodecafonia proprio nella
Vienna degli anni tra le due guerre; e neanche si capirebbe l’esplosione del free negli anni ’60,
in un tipo di società impostata sull’imperialismo economico, seriamente minata dall’alienazione
dei consumi e lacerata da profondi contrasti razziali. Il jazz in se stesso non esiste: esistono i
jazzisti e i jazzisti fanno parte di una società. Questo mi sembra ovvio e l’ho già detto e ripetuto
per iscritto (vedi Free come relazione, in Musica Jazz, n.254).
Allora, non possiamo accogliere come un fatto semplicemente di organizzazione musicale, come
un fatto sociologicamente e ideologicamente neutro neanche lo Statuto dell’Unione. Tanto più
che le prime adesioni furono raccolte facendo circolare una lettera-programma scritta in toni
apocalittici e con un linguaggio vecchio ormai di trenta anni: “ Ancora una volta l’Italia è giunta
impreparata”, “ Caro collega (…), questa è l’ultima occasione “, “Tentiamo (…) di prendere in
mano le redini della situazione.”
Tra i punti del foglio programmatico si poteva leggere: “Definizione dell’essenza, dei requisiti e
della cultura del musicista italiano di jazz”, “Controllo della critica e del
giornalismo”,“agganciamento alla cultura ufficiale.” Franco Tonani sembrava il più attivo dei
promotori e lo volli intervistare per Musica Jazz (l’avv. Polillo pensò bene di non pubblicare
l’intervista).
Tonani mi lasciava di stucco con la violenza conservatrice di certe sue dichiarazioni
(cordialmente, perché è un amico, voglio ricordarle a lui stesso):
“Bisogna cercare di distruggere ciò che non è verità, sia a livello jazzistico, sia a livello di tutte
le altre arti, sia a livello della vita in generale”; “La parola reazionario può anche non significare
niente. La reazione, in un paese dove ci sia il disordine, non è più reazione, è rivoluzione.”
A questo livello, l’azione dell’Unione si inquadra bene come sbocco naturale di una lotta
intestina tra due parti dello stesso sistema: il gruppo (che sarà poi appunto dell’Unione) e
Adriano Mazzoletti, il più prossimo responsabile della poca considerazione in cui sarebbero
tenuti i jazzisti italiani alla Rai. Mazzoletti in verità, è una figura particolare del jazz italiano. Mi
ricordo l’intervista che gli feci per Musica Jazz (n. 240), nel maggio ’67.
Ad un certo punto venne fuori questa domanda: “Volevamo sapere se ci sono dei segni precisi di
una interna corrispondenza tra lo sviluppo della civiltà e lo sviluppo del jazz. Cioè, se siamo
giunti ad una certa coscienza dell’appartenenza del jazz alla sfera della cultura.” La risposta di
Mazzoletti : “Ma lei parla di civiltà o di cultura? Perché i fatti sono ben differenti. Il jazz è
chiaro, fa parte della cultura, è entrato nella cultura. L’ha modificata. Ma civiltà è un’altra
cosa. La civiltà è la cultura e tante altre cose messe insieme. Dunque, credo che non c’entri
assolutamente niente. Cioè c’entra come ci può entrare la musica beat. Per conto mio, è un
fatto di costume e di cultura, e basta. Il jazz e la rivoluzione industriale credo che siano due
cose che non c’entrano niente l’una con l’altra.”
Ed ora lo Statuto dell’Unione Italiana Musicisti di Jazz:
1) E’ costituita, fra coloro che esercitano l’attività di musicista di jazz, una associazione
con denominazione “Unione Italiana Musicisti di Jazz.“ Detta associazione aderisce alla
Federazione Europea del Jazz.
2) L’Unione ha sede in Roma; non ha fini di lucro; nell’ambito delle sue competenze si
propone quanto segue
a) tutelare gli interessi morali e materiali della categoria
b) svolgere opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore dell’attività
jazzistica, studiando le condizioni in cui tale attività si svolge, e i bisogni e le
aspirazioni della categoria, raccogliendo le proposte dei singoli soci e
promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti;
c) regolamentare le prestazioni professionali secondo norme precise di carattere
nazionale e locale;
d) promuovere la creazione o favorire lo sviluppo di istituti o enti a carattere
nazionale, aventi per scopo l’istruzione professionale e tecnica e l’utilizzazione
professionale dei musicisti stessi;
e) tenere un albo aggiornato dei musicisti iscritti all’Unione Italiana Musicisti di Jazz;
f) esperire in forma di consulenza azione conciliatrice nelle controversie interessanti
la categoria rappresentata e adempiere a tutti gli altri compiti che le derivano da
leggi, regolamenti e disposizioni, nonché dal presente statuto;
3) L’adesione alla Federazione Europea del Jazz impegna l’Unione a
uniformarsi per
quanto possibile allo Statuto della E.J.F. ed a strutturare i propri programmi inserendoli
in ambito europeo.
4) Per essere ammessi a far parte dell’Unione come soci effettivi di categoria A è
necessario:
a) dimostrare le proprie capacità di musicista di jazz o con un’audizione da
sottoporre al capo- servizio di consulenza musicale, o con la garanzia di almeno
due soci;
b) essere cittadino italiano, cittadino straniero di paesi le cui associazioni pratichino
la reciprocità, cittadino straniero domiciliato in Italia da almeno un anno;
c) versare le quote di cui all’art. 7. Sull’accettazione delle iscrizioni giudica con
poteri discrezionali il Consiglio Direttivo. E’ istituita la categoria dei soci
Sostenitori, alla quale può appartenere chiunque versi quote superiori a quelle di
qui all’art. 7, con un minimo di 10.000 all’anno.
5) Per essere ammessi a far parte dell’ Unione come soci effettivi di categoria B è
necessario essere musicisti di jazz anche principianti e avere i requisiti di cui all’art. 4,
lettere b e c. I soci di categoria B vengono ammessi alla categoria superiore non appena
vengano loro riconosciuti i requisiti necessari di cui all’art. 4, lettera A.
6) L’Albo dei musicisti comprende i soci effettivi di categoria A. L’iscrizione all’Albo avviene
automaticamente all’atto dell’iscrizione all’Unione.
7) Tutti coloro che richiedono l’iscrizione all’Unione devono versare un diritto una tantum
di L. 1.000
Quote annuali: L. 4.000 per soci di categoria A, L. 2.000 per soci di categoria B.
La quota annuale si intende per l’anno solare, a meno che l’iscrizione non avvenga nei
mesi di novembre e dicembre, nel qual caso la quota vale per l’anno solare successivo.
L’ammontare delle quote di cui sopra viene annualmente fissato per l’anno successivo
dall’Assemblea Generale Ordinaria dei soci.
8) L’Unione si riserva il diritto di trattenere una percentuale da 2% all8%, a seconda dei
casi, per coprire le spese organizzative, sui compensi ai Soci per lavori procurati
dall’Unione stessa.
9) L’Unione gradua i servizi che offre agli iscritti, in modo da riservare i più vantaggiosi ai
soci di cat.A, e gli altri ai soci di cat. B.
10) La qualifica di Socio può essere perduta per dimissioni, morosità o radiazione. La
radiazione di un socio è pronunciata dal Consiglio Direttivo trascorsi 6 mesi dall’inizio
dell’anno solare, senza che egli si sia messo in regola con il pagamento delle quote
sociali. La radiazione di un socio è pronunciata dal Consiglio Direttivo quando il Socio
abbia contravvenuto alle norme di colleganza che debbono esistere tra i soci e in ogni
altro caso di indegnità professionale.
11) L’Unione è retta da un Consiglio Direttivo formato da un Presidente, un Vicepresidente,
due consiglieri segretari e due Consiglieri Vicesegretari, che vengono eletti dai soci con
voto segreto e durano in carica un anno. Per il funzionamento del Consiglio le liste vanno
votate con nomi accoppiati, nel seguente modo:
Presidente- Vicepresidente
Segretario- Vicesegretario
Segretario- Vicesegretario;
12) Il Consiglio Direttivo designa i Capi Servizio relativi a ciascun servizio elencato nell’art. 13.
Il Consiglio Direttivo è investiti di tutte le facoltà necessarie per amministrare l’Unione e
rappresentarla in tutte le circostanze e altresì del potere di svolgere qualsiasi azione e di
prendere tutte le decisioni del caso per il raggiungimento degli scopi prefissi di cui all’art.2.
Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei suoi membri, il Consiglio
Direttivo chiama a sostituirlo in via provvisoria un supplente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese da almeno tre membri del Consiglio
stesso.
13) Il Consiglio Direttivo, con l’aiuto dei Capi Servizio da esso designati, svolge i seguenti servizi:
I.
Stampa
II.
Pubblicità e pubbliche relazioni
III.
Contatti Rai-TV
IV.
Contatti concerti e festivals
V.
Contatti esterno e Federazione Europea del Jazz
VI.
Conservatori e scuole, Ministero Pubblica, Istruzione, Consulenza, Insegnamento
VII.
Contatti con associazioni culturali
VIII. Servizio sindacale
IX.
Contatti con autorità governative e Ministeri
X.
Amministrazione
Le cariche di Capo Servizio sono cumulabili.
14) Il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione di gruppi regionali o provinciali, quando
i soci nella regione o nella provincia siano almeno 5. Il tal caso il Consiglio Direttivo designa uno
dei soci appartenenti al gruppo regionale come delegato regionale dell’Unione con l’incarico di:
a) mantenere i collegamenti con la Sede
b) esprimere il proprio parere sulle nuove domande di iscrizione all’Unione di musicisti o
sostenitori residenti nella regione;
c) promuovere, in accordo con Consiglio Direttivo dell’Unione, lo sviluppo dell’Unione nella
regione e le iniziative locali idonee a conseguirlo. Il Delegato Regionale o Provinciale può
assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
15) L’Amministratore può assistere di diritto alla prima riunione del Consiglio Direttivo o a tutte
le riunioni nelle quali si discutono i bilanci preventivi e consuntivi e la situazione finanziaria
dell’Unione. La carica di amministratore è incompatibile con quella di consigliere.
16) L’Assemblea Generale ordinaria dei soci viene convocata entro il primo semestre di ogni
anno a mezzo di comunicazione personale indirizzata a ciascun socio almeno otto giorni prima
della convocazione. L’Assemblea controlla ed approva l’operato del Consiglio Direttivo, discute
ed approva i bilanci preventivi e consuntivi presentati dal Consiglio, rinnova ogni anno il
Consiglio Direttivo, decide su tutte le questioni portate all’o.d.g. sia dal Consiglio sia da almeno
un quarto dei soci in regola con le quote.
17) L’Assemblea Generale straordinaria dei Soci viene convocata quando se ne
presenti la necessità dal parte del Consiglio Direttivo oppure quando venga richiesta per iscritto
da almeno un quarto dei soci in regola con le quote.
18) Possono prendere parte alle assemblee solo i soci in regola con i pagamenti delle
quote e contro i quali non penda un giudizio di radiazione. Per la validità delle assemblee è
necessaria la presenza, personale o per rappresentanza scritta di almeno la metà più uno dei
soci regolarmente iscritti. I soci impossibilitati a intervenire possono farsi rappresentare da altro
socio, che non potrà disporre di più di due deleghe, tranne i rappresentanti dei gruppi regionali
e provinciali, che possono rappresentare tutti gli iscritti al gruppo e a loro volta affidare la
delega dell’interno gruppo ad altro socio.
19) Le votazioni possono essere fatte o partecipando all’apposita assemblea, o per
posta. A tale proposito verrà inviata agli iscritti una scheda con la lista da votare e da rispedire
in sede. Gli scrutini verranno fatti da tre capi- servizio uscenti. A parità di voti si proclamerà
eletto il socio più anziano per data di iscrizione o per età.
20) Qualsiasi modifica allo Statuto o lo scioglimento dell’Unione , possono essere
decisi solo all’Assemblea Generale straordinaria dei Soci, con l’approvazione da parte dei 3/5
dei soci presenti.
Questo lo statuto dell’associazione. Rispetto alla lettera programmatica, sono stati attenuati i
toni (eliminato accortamente l’articolo circa il controllo della critica) e la denominazione si è
trasformata da Unione Nazionale in Unione Italiana. Lo spirito però è quello che è corporativo.
La forma rasenta a volte il grottesco, come al numero 4, da cui risulta che si può essere ammessi
alla categoria A, dimostrando al capo-servizio di consulenza musicale di essere musicisti di jazz.
Ma chi è il capo-servizio di consulenza musicale?
In effetti, l’unico modo per essere ammessi all’Unione sembra quello di ricorrere alla formula
della garanzia, per cui due soci già iscritti rispondono delle qualità del terzo. Ma validità
dell’iscrizione potrebbe venire contestata da chiunque non fosse d’accordo sul significato da
dare all’espressione musicista di jazz; fino al punto di poter/dover dubitare sulla legittimità
dell’iscrizione dei due stessi musicisti che si offrono come garanti delle qualità del terzo. E cosi
via. A meno che, la garanzia, di cui all’art.4°, non debba intendersi sul piano della fede. Ma
questo equivarrebbe a ridurre l’Unione a una conventicola settaria. E allora, a che serve questa
Unione?
Sia ben chiaro che sto cercando solo di mettere insieme alcuni elementi per definire
concretamente una situazione.
Certo, la botta del free è stata forte e qualche ripercussione s’è avuta anche da noi. Ma su quale
piattaforma culturale! In piena esplosione free, Musica Jazz ospita sulle sue pagine un corso
propedeutico sul jazz ( ùL’ABC del jazz ), scritto nientemeno che da Livio Cerri.
Questo Cerri, nel 1969, pubblica un libro (Jazz in microsolco, Nistri-Lischi ed.) in cui se ne
leggono di tutti i colori. Vale la pena di riportare uno o due esempi:
“Confesso che ho deliberatamente atteso molti mesi prima di decidermi a prendere in
considerazione un disco (This is our music) dell’altista Ornette Coleman, salutato da molti e
troppo benevoli critici nordamericani e da alcuni giovani nostrani come l’idolo del jazz d’oggi.
Non mi piace esprimere sinceramente un mio giudizio per poi sentirmi dire che un bieco
reazionario o peggio, e quindi cerco di evitarlo. Ora che anche i sostenitori di Coleman
cominciano a manifestare qualche dubbio e che la ventata di moda sta passando mi sento già un
po’ più tranquillo.
Una cosa che avevo molto ammirato nel jazzisti del dopoguerra era quella indiscutibile rifinitura
tecnica, che non mi faceva sfigurare quando mettevo sul giradischi le loro incisioni per farle
ascoltare a musicisti accademici. Ma credo che non farò mai ascoltare un disco di Coleman ad un
musicista classico, altrimenti dovrei arrossire dalla vergogna.
Infatti, il simpatico Ornette vorrebbe dire cose nuove o crede di dirle, ma manca di ogni
preparazione fondamentale per poterlo fare: la sua sonorità al contralto è quanto di più brutto e
volgare abbia ascoltato da molti anni.”
Questo è Livio Cerri.
“Devo premettere che il sassofonista John Coltrane è stato molto gonfiato da alcuni
nordamericani ed europei e che io ho espresso molte riserve su di lui sin dal tempo in cui venne
in Europa col quintetto di Miles Davis, suscitando molte reazioni fra i cultori più sprovveduti e
che credono ciecamente a ciò che viene stampato negli Stati Uniti. Con questo disco (Africa
Brass) abbiamo la quintessenza di Coltrane; penso perciò che esso sarà molto ammirato da
coloro che ritengono Coltrane una specie di caposcuola del nuovo jazz. Quanto a me, non posso
che confermare i miei precedenti giudizi: non voglio dire che non si tratti di jazz, ma se davvero
il jazz odierno dovesse prendere questa piega, potete star sicuri che lo abbandonerei
decisamente malgrado i trenta anni di costante fedeltà di studio. Pertanto dirò semplicemente
che si tratta di musica che decisamente non mi piace e di cui assolutamente nulla mi attrae: né i
gargarismi di saxofono-cornamusa (sia nel caso del tenore che del soprano) del titolare, né il
modesto pianista Mc Coy Turner (!), né gli assoli di batteria…”
Capitolo terzo – “E’ stato un grosso personaggio,Trane: forse (ma, per chi scrive queste note,
senza forse) il più grande affermatosi sulla scena del jazz dopo la morte di Parker (…) A certi
risultati Coltrane è pervenuto con fatica, gradualmente, attraverso un puntiglioso lavoro di
ricerca e di perfezionamento durato anni; e ha penato molto prima di farsi accettare” ( “Musica
Jazz”,n. 243- agosto- sett. ’67 ) .
Capitolo secondo – “Se John Coltrane suonasse sempre, avesse suonato sempre, come fa nel
brano che dà il titolo a questo microsolco, My Favorite Things, sarebbe uno dei più grandi solisti
contemporanei (…) Il guaio è che Coltrane ha dietro le spalle molti anni di mediocre mestiere
(…) Prendete i dischi da lui incisi con Miles Davis fino al 1957, ed anche quelli di poco posteriori
(…) : il suo discorso è insignificante e francamente noioso, intessuto com’è dei più bolsi luoghi
comuni. E ricordatevi dello schiamazzante sassofonista che si presentò lo scorso anno, a Milano,
col quintetto di Davis (…)
Che uomo è mai questo, che non ha detto assolutamente nulla di interessante negli anni in cui di
solito un musicista di jazz dice le cose migliori e dà tutto se stesso ? E come si spiegano i tonfi
che di tanto in tanto fa anche ora (…) ?
C’è solo un modo per spiegare tutto questo: che la recente, improvvisa e stupefacente fioritura
artistica di John Coltrane sia stata determinata, in grandissima parte, da uno straordinario
sforzo di volontà, è che il suo stile quindi il risultato di una scelta arbitraria, fatta con fredda
determinazione. “ (Musica Jazz, n. 176 – luglio- agosto 1961 ).
Nello stesso numero, rispondendo ad un lettore: “ La verità è che il Nostro non è un artista nel
senso pieno del termine: è musicista ingegnoso che dopo infiniti sforzi (ci sono voluti quindici
anni!) ha inventato uno stile originale, che però è cosi poco naturale da scivolare spesso
nell’assurdo e quindi nel brutto. “
Capitolo primo – “ Davis e Coltrane hanno fatto fiasco, a Milano come nelle altre città europee,
anche se non sono mancanti coloro che hanno applaudito con entusiasmo, convinti di aver
assistito ad uno spettacolo straordinario, e più precisamente di essere stati i testimoni oculari di
una svolta nella storia del jazz (…) Se qualche dubbio di non aver capito bene mi era rimasto
dopo l’ascolto dei suoi dischi, esso si è dissolto come neve al sole all’audizione diretta. Vi dirò
quindi, senza alcun rimorso, che Coltrane è, a mio sommesso parere, una caricatura di Sonny
Rollins, su cui non vale la pena (Dio mi perdoni) di spendere parole. Anziché geniale, il suo
discorso solistico mi è parso bislacco e sgangherato, ed anche volgare (…) Come poi si possa,
dopo aver sentito per un’ora Getz, prendere sul serio Coltrane, ha costituito per me l’enigma
della serata” ( “ Musica Jazz”, n.163 maggio ’60)
Ecco, questa la storia ufficiale di Coltrane in Italia. Ci sarebbe anche l’articolo di Umberto
Santucci (Jazz + Microstruttura + John = Coltrante, in “ Musica Jazz” n.198 luglio agosto 1963)
ma riproporne la lettura non farebbe che aggravare la situazione, visto che si trattava di un
dilettantistico tentativo di fusione della cultura scientifica con la cultura estetica su una base di
idealismo velato fino al limite del qualunquismo: “Dal Baumagartner al Croce, fino ai moderni
teorici dell’estetica (Pareyson, Eco, ecc.) è riconosciuto dell’arte un valore conoscitivo, che si
realizza mediante un processo di intuizione-espressione, anziché mediante un processo logico,
proprio alle scienze e alla filosofia “ L’equivoco sta tutto in quel ecc…
Ma spostiamoci: passiamo da Coltrane a Shepp e compagni. La situazione non sembra delinearsi
diversamente. E’ inutile stare a fare anche per il free un’altra storia del cammino della critica.
C’è da notare, comunque, che con il free le cose si sono complicate ulteriormente, perché i
musicisti che hanno inventato questa musica hanno inteso fin dall’inizio impegnarsi di un
discorso ideologico e politici ben preciso: e dunque i giudizi sulla loro musica non possono più
essere idealisticamente estetici. E’ l’oggetto stesso che rifiuta una considerazione di questo
tipo. L’esigenza di una critica che si assumesse le proprie responsabilità a tutti i livelli fu sentita
proprio dal sottoscritto, il quale, nel dicembre ’66 scrisse al direttore di Musica Jazz (n. 235) una
lettera, sulla quale penso valga la pena ritornare un attimo, visto che a distanza di cinque anni,
risiamo più o meno allo stesso punto. Dunque, rileggiamo rapidamente:
“ Premesso che:
a) l’oggettualità dell’opera d’arte, in base alla quale l’opera si distingue, è data dalle sue
modalità tecnico-linguistiche;
b) l’internazionalità dell’opera d’arte, in base alla quale l’opera si diversifica, è data dalla
sua qualificazione storico-culturale;
e premesso che:
nel giudizio estetico le due componenti (distinzione-diversità) sono connesse (un ‘analisi
oggettuale, cioè riguardante solo la struttura tecnico-linguistica dell’opera, non ha significato,
poiché manca la rivelazione dell’intenzionalità, la quale appunto fa sì che l’opera sia strutturata
e non un causale incontro di elementi: né ha un senso un esame solo intenzionale, perché allora
si riduce l’oggetto ad un indefinibile fenomeno culturale essendosi perduto ogni carattere di
empiricità);
si può dire che, con l’allargamento delle sfere d’interesse della cultura, sono venute alla luce,
proprio sul piano intenzionale, modalità diverse, le quali hanno imposto una metodologia diversa
da quella delle “ arti belle”. (…) Quando si dice: questo non è jazz, ci si deve preoccupare che il
giudizio sia frutto di un esame oggettuale-intenzionale e non solo di una analisi empirica
(mi riferisco, specialmente ma non unicamente, a certi atteggiamenti che si sono presi nei
confronti del free…) Altrimenti, non si ha il diritto di dire: questo non significa niente, questo
significa poco.
C’è infatti, una stretta connessione tra semanticità e internazionalità. (…)
Alla base di un segno istituzionalizzante, quale può essere anche lo scarabocchio sul foglio di
carta o la successione di poche note (o suoni) prodotte dal musicista free, si trova sempre una
storia di segni che presiede, per così dire, alla nascita di quel segno ed è condizione del suo
relativo sviluppo.”
Questa lettera oggi avrebbe oggi avrebbe ancora il medesimo valore di attualità sulle pagine di
Musica Jazz. Infatti dopo, una serie di articoli, come Le ragioni del free, n.237; Le ragioni del
pubblico, n.245; Free come relazione, n.254; Analizzare il contino, n.262, nel 1968 ( n.247 della
rivista), l’atteggiamento critico di Polillo (e quindi tutto sommato, di Musica Jazz, le opinioni
contrarie vengono democraticamente ospitate…) nei confronti di uno Shepp non è molto diverso
da quello di alcuni anni prima nei confronti di Coltrane (ovviamente, dopo quella esperienza, la
forma almeno è più pacata).
“Da quando l’ineffabile Archie Shepp ha fatto la sua apparizione da choc, come quella di
Madama Pace nei pirandelliani Sei personaggi, io ho finito di vivere tranquillamente. Sono infatti
diventato inviso sia ai fautori del jazz “regolare” (stavo per dire “perbene”) sia a coloro che
sostengono il free jazz senza riserve”.
Certo che contrapporre il free al jazz “regolare” o “perbene” mi sembra proprio una bella
impostazione metodologica! E’ l’impostazione che porterà il direttore della rivista di jazz
italiana (solo per questo sto facendo il discorso: perché il jazz italiano si identifica per forza di
cose con questa rivista) a precisare in questi termini le sue idee sull’impegno della critica nei
confronti del jazz attuale (sono considerazioni recenti, tratte dal n.278 del nov. ’70): “Noi che
vogliamo prima di tutto capire un certo tipo di musica, e valutarne la complessa e cangiante
fenomenologia, dobbiamo anzitutto dimenticare l’homo politicus che c’è in ciascuno di noi, e
chiederci, prescindendo dal consenso o dal dissenso coi contenuti e con le motivazioni, quali
risultati estetici siano stati conseguiti nei singoli concerti, casi in esame.”
Siamo in pieno idealismo. Il piano estetico del discorso è contemplato come assoluto e
autosufficiente. Nei paradiso degli artisti non c’è posto per i cattivi. E nell’inferno dei cattivi c’è
posto per l’arte? Chi fa il jazz in Italia?
Tuo
Franco Pecori”
Mario Schiano è un jazzista perché ha, come il jazz, il coraggio di essere antipopolare. La
differenza tra coraggio e incoscienza, ormai lo abbiamo imparato, sta nell’aver paura e vincerla.
Schiano ama da morire (mi piace che non faccia niente per nasconderlo) il riconoscimento, la
critica lusinghiera, ma non la cerca. Suona a dispetto delle gente, pur non volendo fare.
“Voglio stimolare una reazione. Mi hanno detto che sono fuori del mondo, che la musica del mio
sax è libera perché non saprei costringerla negli schemi giusti. No, ditemi che non ho tecnica,
che la voce non va, che non vi piace quello che suono, ma che non la mia libertà è una scusa. Io
vedo le armonie di un chorus come un tunnel, vedo i buchi nei quali mi posso infilare con un
movimento che è un’onda, che lo prende di fianco, che si infila di sotto, che esce di lato e ci
ritorna se ne ha voglia, ma non per cercarmi degli alibi.
Io sono piantato in terra ben più di chi ascolta, quando suono. Vivo la gente, vivo il fumo, i
colori alle pareti, la meraviglia di suonare tutto quel mare di cose che ti gonfia dentro sino a
ingigantirti. La musica diventa un monte di idee, più grande di quello che puoi concepire con la
mente, enorme rispetto a quello che puoi realizzare con le dita.
Il fiato non ti basta, mio Dio ti scoppia tutto dentro, un’ora di sfogo da impazzire. Se senti bene
la mia musica, dentro c’è il blues, ti giuro, è tutto blues vestito con altri stracci.
Ma se non lo vuoi sentire (perché non hai dodici battute, in sibemolle, batto quattro e via con il
riff), se non si sovrappone a quello che hai in testa da settanta anni, allora niente da fare. Ti
capisce di più l’operaio di Piombino che non sa cos’è un sibemolle però ti segue: non sa cosa
diavolo suoni, mi riceve lo stimolo, si eccita. E’ più disposto, più libero dentro: non ha
sovrastrutture da abbattere per decodificare il messaggio che gli trasmetti.”
Mario Schiano infila il free jazz nei teatrini, nei cabaret, nei dopolavori degli altiforni. Il tatto è
di una gazza ladra che nasconde gli anelli (per amore) nei punti oscuri.
Per anni ricerca gli accoppiamenti più inquietanti: a Roma nel ’66 mischia il free jazz
(Tendenziale Numero Uno) con la poesia di Juke box all’Idrogeno assieme a Marcello Melis,
contrabbasso e Franco Pecori, batteria. E’ il Gruppo Romano Free Jazz che nasce, e con una
certa elasticità di organico, si instaura al Folkstudio ed al Beat 72.
L’anno seguente, con Giancarlo Schiaffini al trombone ed un rinforzo alla percussione portato da
Bruno Biriaco, va in onda nel concerto Rai, Addio e Molti Auguri a Rituccia.
Nel marzo del ’67, Schiano commenta dal vivo la vernice romana di Ugo Sterpini, uno che il jazz,
non sapendolo suonare, lo dipinge.
Nel settembre del ’67 è con Gato Barbieri: il sassofonista argentino, dopo le sue perfomances
americane con Ornette Coleman, giunge a Roma stracolmo di musica stimolante e nuova. Poi
l’anno seguente, con Enrico Rava, anche lui appena sbarcato d’oltreoceano, mette “il free jazz
di fronte a quattro realtà del sistema”.
E’ uno spettacolo duro, provocatorio, che va in scena a Roma al Beat 72.
Quattro modi di morire: per aborto illegale, per fame, sul lavoro e morire credendo di
continuare a vivere (il morto-vivo è l’integrato nel sistema).
Il jazz è sposato allo stimolo visivo: non si può capire quanto sia la musica a commentare le
immagini piuttosto che i segni e i colori a formare le note nella testa dei musicisti.
Su una delle pareti della “cave” un proiettore staglia fotografie, titoli di giornali, inserti di
pubblicità: vi sono cartelli, segni fatti con il gesso; voci che recitano, luci che prendono a
schiaffi. Lo spettacolo è un pretesto per fare del free jazz.
Dalla cave sotterranea allo stadio sportivo: nel mese di agosto del 1966 Schiano, con Pecori e
Tommaso, crea le musiche del Mutilato di Toller che il gruppo Teatroggi di Bruno Cirino mette
in scena al campo sportivo di Pietralata. E’ un teatro coraggioso, fatto con pochi soldi, che va
dove il teatro serve di più, tra la gente del Tiburtino, in mezzo ai palazzoni di cemento
soffocanti, mostruosi, che gravano sullo stadio con i loro televisori a tutto volume.
Ma il jazz è più forte dei televisori, la recitazione è generosa: la gente spegne i televisori ,
mette la seggiole sui balconi e, uomini in canottiera e donne in sottoveste, segue Toller.
Schiano si unisce poi al sassofonista belga Jacques Pelzer e dà concerti dappertutto.
In seguito, con Marcello Melis e Marco Cristofolini, esegue la colonna sonora di Apollon, una
fabbrica occupata che Ugo Gregoretti ha girato in otto giorni per riprendere dal vero la lotta
operaia a Roma. Il film (uno dei primi esempi italiani di cinema parallelo) viene proiettato anche
al Modern Art Museum di New York.
Nel novembre ’69 Schiano è chiamato a realizzare dal vivo le musiche di Paradise Now che il
Living Theatre ha in programma ad Urbino. E’ un’esperienza traumatizzante, un’apparente
mancata rappresentazione che è invece ben più teatro di quello che avrebbe potuto essere se lo
spettacolo si fosse svolto. Sergio Saviane, su l’Espresso, ne fa una recensione illuminate: “Sono
le nove di sera e comincia lo spettacolo. Non sulla pedana, naturalmente, perché non si può
entrare a causa della ressa, ma sulle scalette che portano nella cantina-teatro. Gli spettatori
non lo sanno ancora che lo spettacolo è già incominciato: nessuno se n’è accorto. Schiano,
Pecori e Tommaso riescono a conquistare i primi tre scalini, ma rimangono là bloccati. Non
possono né tornare indietro, né avanzare. Gli spettatori protestano per il ritardo; quelli esterni
reclamano a loro volta per entrare. Cosa si deve fare? In questo preciso momento si sente
intonare un salmo marocchino. Sono gli attori che arrivano coperti di stracci. Ma restano bloccati
anche loro sui primi scalini, tra le urla, gli insulti, gli spintoni. Lo spettacolo quindi continua là,
fra le scale, la cantina e la piazza, da cui arrivano minacciose proteste. Finalmente Julian Beck
riesce a farsi strada con pochi compagni e a raggiungere la pedana. Sulla sua scia, si muovono
anche i tre musicisti, che si installano come passeri infreddoliti nel loro angolino di un metro
quadrato di spazio.
“Piazza, piazza”, gridano gli spettatori “Trasferiamoci tutti in piazza“.
“Ci vuole un teatro più grande per fare Paradise Now – dice Beck, rivolgendosi verso gli stessi
organizzatori: “Non c’è posto qui … Che impresari siete voi di Urbino che non sapete fare bene
le cose. Noi non vogliamo fare lo spettacolo per una èlite…”.
“E voi quanto vi fate pagare per queste burattinate?” gridano dalla platea.
”Andiamo in piazza…visto che siete già stati pagati…Ricevete denaro anche dai teatri borghesi,
cinquemila lire al biglietto!”.
“Ma noi dobbiamo mangiare” risponde Beck.
E così, cantina, piazza, scale, lo spettacolo va avanti per un’ora. I tre musicisti suonano con i
gomiti degli spettatori sullo stomaco. Sembra impossibile che riescano a soffiare e a battere sui
loro strumenti. Nel caos generale si sentono soltanto i sibili del sassofono di Schiano, il quale
incurante del groviglio, continua a suonare. E gli studenti di Urbino mostrano ora di preferire il
trio agli attori del Living. Nei brevi intervalli alcuni gridano a Schiano: “Buttateli fuori gli attori,
suonate voi…soli!”
Finalmente tutta la compagna è riuscita a mettere i piedi nel centro della pedana. Agli insulti
del pubblico rispondono sorridendo prima e spogliandosi poi. Quindi si mettono in cerchio e
fumano la loro pipa gigante della pace.
“Non si può fare niente qui” ripete Julian Beck, che non riesce a distendersi per terra con gli
altri.
Ora c’è una matassa di corpi umani al suolo.
“Volete la comunione col pubblico?” gridano gli spettatori, “ora ce l’avete”
“Noi la comunione la otteniamo dappertutto, anche dove c’è posto…”
“Andate via” - rintuzzano altri spettatori - “vi fate pagare per spogliarvi… un pezzo di sedere
maschile non vale tanti soldi…. siamo capaci anche noi di spogliarci e fumare la pipa..”
E così va avanti fino all’una di notte, mentre i musicisti continuano a suonare.
Lo spettacolo è finito, ma nessuno ha visto Paradise Now. Ora sono tutti nell’unica trattoria
aperta, studenti, attori, musicisti. Se ne parlerà fino alle quattro del mattino.”
Dopo Urbino e quella notte folle, Schiano accoppia il free jazz al cinema muto napoletano, a
Nettuno inserisce un concerto nella Prima rassegna di ricerca teatrale, poi apre le porte agli
studenti ed opera al Beat 72, dove sono free il jazz e l’ingresso. Le offerte vanno a favore degli
operai della Vegua Stampa.
Nel 1971, Schiano incide il suo primo disco: If not ecstatic we refund. Il brano migliore Collage,
è una visione antologica della musica del trio.
Le marce grottesche, la sonorità sgradevole, il tono dissacrante usato per la citazioni di classici
tunes, servono da stimolo a Schiano, Tommaso e Pecori per elaborare nuove proposte musicali.
Schiano ha una caratteristica: non suona il sax come si suona il sax. Non ha il perbenismo dei
musicisti che strumentalizzano la musica anziché lo strumento: rinuncia cioè, a conservarsi
sassofonista.
Umberto Santucci, artista, pubblicitario, redattore di Musica Jazz e collaboratore della Nuova
Rivista Musicale Italiana, autore del ciclo di trasmissioni radiofoniche “Impariamo cos’è il Jazz”
realizzato con Nunzio Rotondo, promotore della U.I.M.J. Unione Italiana Musicisti di Jazz.
“Io penso che si debba distinguere fra il jazz in Italia e il jazz italiano. Il jazz in Italia, considera
il modo in cui viene presentato e recepito il fenomeno jazzistico nella nostra società. Cioè
Armstrong, Parker e Archie Shepp di fronte all’avvocato italiano, al muratore italiano, alla
prostituta italiana, all’intellettuale italiano. Il jazz attraverso i dischi, la Rai, la stampa. Il jazz
italiano considera i musicisti italiani che suonano jazz, la loro importanza in Italia e in campo
internazionale, la possibilità di fare un jazz diverso da quello americano, di fare cioè un jazz
italiano.
Sul jazz in Italia ci sarebbe molto da dire, ma mi sembra che tutto si può ridurre alla posizione
non ben definita che occupa in Italia, una posizione fatta da una serie di negazioni: il jazz non è
musica di massa, non è musica tradizionale, non è musica d’avanguardia. Penso che per risolvere
questi problemi si debba affrontare un discorso critico che riesca a smantellare con serie
argomentazioni tali considerazioni negative. Si può dire che l’unica vera affermazione del jazz
nel costume italiano è avvenuta come musica di commento per cinema e televisione. Tutto il
resto (concerti, festivals, locali, ecc.) ha avuto un’incidenza talmente marginale da potersi
ritenere presso che
trascurabile.
La situazione sta cambiando negli ultimi tempi, perché il jazz comincia ad entrare nel giro delle
attività finanziarie con denaro pubblico, cioè comincia ad essere considerato come una cosa
“seria”.
Ma non so se ci si debba veramente rallegrare della piega che hanno preso le cose perché questo
riconoscimento da parte degli uffici pubblici è avvenuto in ritardo, quando cioè le cose
veramente interessati non avvengono più nel jazz che è possibile presentare con l’aiuto dei
finanziamenti pubblici. A questo riguardo penso esistano due sole possibilità: o si finanziano
tutte le attività che, anche se non hanno una immediata e vasta rispondenza di massa, possono
contribuire ad un progresso culturale, o non si finanzia nulla, Io non accetto che l’opera lirica
mangi dieci miliardi solo in un teatro, mentre un jazzista deve sentirsi dire che la sua musica
non si vende. Sarei piuttosto propenso all’abolizione di ogni tipo di finanziamento culturale, per
vedere fino a che punto la cultura può vendersi in una società, e per dare alla società la cultura
che si merita. Non sarebbe un gran male la morte dell’opera lirica, o del teatro di prosa, se da
questa assenza nascesse il bisogno di proporre una nuova cultura spontanea.
Questa è una possibilità. L’altra è quella di aggiornarsi e impadronirsi delle cose più aggiornate
che accadono nel mondo (è quello che fanno i giapponesi) per arrivare a competere col mercato
internazionale. In questo caso il compito spetterebbe all’industria musicale, statale, parastatale
o privata che sia. E penso che una delle prime cose da fare sarebbe quella di combattere il
monopolio della RAI.
C’è poi un terzo tipo di intervento, che diventa una politica di investimenti a lungo termine. Se
si devono spendere soldi, spendiamoli nella scuola per costruirci il patrimonio di domani, come
artisti e come pubblico.
E veniamo alla scuola musicale e all’insegnamento musicale nelle scuole, che in Italia sono in
una situazione pressoché scandalosa. Da noi manca, ad esempio, una scuola di batteria, mentre
tutti i complessi dalle orchestrine da balera fino alle orchestre stabili della RAI, hanno bisogno
del batterista. Manca una scuola di chitarra elettrica, di basso pizzicato, di arrangiamento, di
big band, di sassofono, e così via. Tutte cose che ormai da anni sono normalmente,
copiosamente entrate nel costume e nel consumo musicale e che offrono posti di lavoro
numerosi e ben retribuiti. Poiché una delle funzioni della scuola moderna è quella di preparare
al lavoro, la mia proposta è quella di costituire una scuola professionale di musica, che non
abbia la ambizioni puristiche del conservatorio, ma che si preoccupi di fornire alla società gli
elementi di cui essa ha bisogno. Si dovrebbe partire dai tipi e dalle possibilità di lavoro, e
costituire i corsi d’insegnamento in funzione di questi. E a questo punto si dovrebbero fare le
cose in grande, mandando i nostri insegnanti ad addestrarsi presso scuole del genere che già
esistono in America, e chiamando a tenere i seminari strumentisti e maestri fra i migliori del
mondo. Penso che se si fa sentire in concerto a un giovane animato dai migliori proposti un
grosso jazzista americano è quasi certo che egli ne ricavi un’esperienza frustrante, perché gli si
fa sentire quanto è bravo quel maestro e quanto non potrà mai esistere bravo lui stesso. Se
invece si prende il maestro, e lo si mette a disposizione dei giovani in un seminario di un mese,
si dà loro un’esperienza tutt’altro che frustrante perché li si chiama a far parte di un mondo.
E qui entriamo direttamente nel secondo argomento: il jazz italiano. Anche questo problema va
impostato sotto due aspetti: il jazz italiano come jazz non negro, non americano, e il jazz
italiano in quanto linguaggio ben caratterizzato e tipico di un italiano che voglia esprimersi col
jazz.
Considerando il primo aspetto, il jazz italiano si trova più o meno nelle stesse condizioni del jazz
europeo, o giapponese, o australiano. Quando si dice che i musicisti italiani non sono dei colossi,
bisogna sempre tenere presente che non lo sono di fronte ai maestri americani, ma più o meno
sono alla pari con i loro colleghi non americani. Alcune altre civiltà jazzistiche possono vantare
grossi nomi di livello veramente internazionale, ma si tratta sempre di eccezioni rispetto al
livello medio, e di casi in cui c’è stata una stretta comunanza con musicisti americani.
D’altronde il fatto che un italiano possa essere un grosso jazzista, purché viva in un altro
ambiente, è dimostrato dai molti oriundi che hanno detto la loro nella storia del jazz.
In realtà il grande handicap è costituito dalla nostra società, o quanto meno dalla posizione nella
quale si sono sempre messi i nostri musicisti di fronte ad essa. Tutti i nostri musicisti mirano ad
integrarsi nella società, più che contestare un sistema che crea loro una rete di bisogni e di
convenzione da cui è difficile districarsi. Il musicista italiano è troppo borghese, troppo
rispettabile, e invece di sacrificare tutto alla musica che ama cerca piuttosto di subordinare la
musica al benessere, al denaro, alla macchina, alla famiglia, alla bella cena al ristorante. Il
nostro musicista vive facendo altri lavori, altra musica, e suona la sua musica solo se deve
presentarla in un concerto o inciderla su un disco. Nella maggior parte dei casi, salvo
naturalmente qualche eccezione, ne viene fuori una musica ben concepita, ben suonata, ma in
un aspetto più o meno latente di in autenticità, che può spiegare la scarsa risposta del pubblico
e della società in genere.
Considerando la possibilità di un jazz italiano devo dire che è senz’altro possibile la sua
esistenza, anche se è molto difficile. Io penso che il jazz sia un linguaggio universale, o meglio
internazionale, e che la sua lingua è l’inglese. Il tentativo di tradurre il jazz in lingua italiana
non mi sembra molto interessante, mentre è senz’altro giusto quello di tradurre contenuti
italiani nell’accademia, non folkloristica, e nemmeno commerciale, con la quale il musicista
poteva esprimersi liberatamene, senza sottostare alle costrizioni di una partitura rigida ed alle
regole di una tecnica strumentale di conservatorio; al tempo stesso poteva sentire la
soddisfazione intima di usare un linguaggio internazionale, che andava oltre i limiti della musica
tipica e folkloristica, e di sentirsi libero dalle imposizioni dell’industria e dalle leggi della moda
e del consumo. A tale atteggiamento liberatorio partecipava anche l’ascoltatore, direttamente
coinvolto nell’azione del musicista che creava la sua musica, e riscatto dalla sua passiva
funzione di consumatore, per diventare vivo testimone di fatti unici e irrepetibili, in quanto nati
dall’improvvisazione. A ciò è dovuto quel senso di privilegio che il jazzista sente di fronte a chi,
non comprendendo e amando il jazz, deve accontentarsi di subire passivamente le imposizioni
del mercato.
Ma, diciamo dai Beatles in poi, si è venuto man mano configurando un genere di musica,
etichettato prima come beat, poi come pop o rock, che pone il musicista e l’ascoltatore nelle
stesse condizioni in cui ci si trovava prima con il jazz.
Contemporaneamente, il jazz ha imboccato con il free una strada che, da un lato, lo ha portato
tanto lontano dallo specifico jazzistico da renderne problematica la possibilità di classificarlo
ancora come jazz, dall’altro ne ha chiuso il discorso ad una minoranza negra estremista. I
musicisti che non suonano free si sono commercializzati e continuano a suonare più o meno bene
la musica che fecero dieci, venti o trenta anni fa. Pochissimi fra i più vivi sono diventati
decisamente musicisti pop.
Data questa situazione, non c’è da stupirsi se i giovani non si riconoscono nel jazz, mentre è
perfettamente naturale che si riconoscano nel pop, e cioè nella musica che attualmente gioca
nello stesso ruolo che prima era stato del jazz. Per le ragioni dette, i giovani non hanno bisogno
del jazz, mentre hanno bisogno della loro musica.
Io sono convinto, e l’ho anche sperimentato, che l’unico modo per proporre il jazz ai giovani sia
quello di presentarlo come ascendente del pop, un ascendente che è doveroso conoscere per
poter suonare e comprendere meglio il pop, per cominciare a vedere quest’ultimo in una
prospettiva storica. Bisogna spiegare a un giovane se vuole suonare la batteria deve studiare
Buddy Miles e Ginger Baker, e risalire a Philly Joe Jones, ad Art Blakey, fino ai ritmi africani: il
giovane amerà Kenny Clarke, e gli sarà riconoscente, perché sentirà che gli è stato utile per
capire e suonare meglio la sua musica. Se invece si affronta il giovane dicendogli che Ginger
Baker è un poveraccio di fronte a Max Roach, gli si fa un discorso incomprensibile, perché si
pretende da lui che trascuri la musica di oggi per dedicarsi ad una musica di venti anni fa, è
cioè di un’epoca in cui non era ancora nato. D’altronde, Ginger Baker non suona né meglio né
peggio di Max Roach, così come Max Roach non suona meglio o peggio di Zutty Singleton.
Ognuno suona molto bene la sua musica e non suonerebbe altrettanto bene la musica dell’altro.
Naturalmente, quando parlo dei giovani, mi riferisco alla parte migliore di essi, perché fra i
diciottenni e i ventenni ce ne sono tanti che sono soddisfatti di vedere Canzonissima e di
comprare l’ultimo successo, quale che sia. Si tratta sempre di una minoranza, come erano pochi
i giovani che dieci anni fa preferivano Sonny Rollins a Tony Dallara, ma è una minoranza più
ampia, più appariscente e meno inibita di quanto non fosse stato prima. Se il jazz ha perso, o sta
perdendo questa minoranza, la colpa non è dei giovani, ma del jazz, che sta assumendo gli
atteggiamenti tipici della cultura di mezza età, intransigente, moralista, incapace di accettare
e di comprendere tutto quello che viene dopo.
Le esperienze dirette a cui alludevo prima, le ho fatte con due manifestazioni che ho curato
recentemente per conto di Centri Servizi Culturali ISES di Lanciano e di Vasto, ambedue in
Abruzzo. La prima era dedicata al jazz, e l’ho impostata cercando di sdrammatizzare le
incompatibilità fra jazz e pop, facendo constatare ai giovani che la musica di Miles Davis,
Charles Lloyd, dei Chicago e di Jimmi Hendrix, appartiene tutta alla stessa realtà e allo stesso
mondo: questo discorso per loro è stato pienamente comprensibile e li ha portati a risalire con
entusiasmo a Parker, a Errol Garner, fino a Bessie Smith. Purtroppo il mio discorso, che aveva
creato un clima di totale confidenza con i ragazzi, è stato smentito da Tonani, che avevo
inviato a tenere il concerto di chiusura, seguito da un dibatto. Dopo il concerto, peraltro
egregiamente tenuto dai musicisti, Tonani ha aggredito i ragazzi presenti dando più o meno loro
degli incolti perché apprezzavano il pop e non conoscevano il jazz. I ragazzi hanno
candidamente replicato che la musica di Tonani, di fronte a quella di Santana, Zeppelin o
Jeferson Airplane, a loro sembra vecchia, o almeno non attuale. A questo punto non era
possibile continuare la discussione con la speranza di un accordo.
A Vasto ho impostato la manifestazione tutta sulla cultura pop, nei suoi aspetti musicali, visivi di
costume ecc., ed ho portato il “ Brainticket” , un nuovo complesso formato per metà da jazzisti
di solida preparazione, e per metà da giovani musicisti pop. Nonostante la musica molto
avanzata, il successo è stato strepitoso e i giovani sono rimasti per ore a parlare con i musicisti,
mostrando tutta la loro vivacità, curiosità e disponibilità ad imparare. Si sono accorti da soli
dell’importanza della preparazione jazzistica dei musicisti e hanno finito col parlare anche di
jazz. Ora mi chiedo: è stata più positiva nei confronti del jazz la prima o a seconda
manifestazione?
Penso che il problema dei giovani per il jazz in Italia sia di primaria importanza, perché al jazz
mancano i giovani, sia come musicisti che come pubblico e il jazz senza di loro diventa un fatto
nostalgico, inattuale, senza prospettive future.
Ma se vogliamo i giovani dobbiamo farci giovani, dobbiamo andare loro incontro, parlando il loro
linguaggio, e mettendo umilmente a loro disposizione la nostra esperienza.
Un ultimo argomento: i critici e i promotori di attività varie. Quando si parla e si scrive del jazz
italiano il discorso è sempre fatto dai critici e sul banco degli imputati vengono messi sempre i
musicisti, che sembrano gli unici responsabili di certe situazioni. Per una volta invece facciamo
la critica alla critica. Se in Italia non ci sono musicisti di livello mondiale, non ci sono neanche
critici di tale livello. Naturalmente ci sono ottimi critici, ma il loro valore dipende più che altro
dalle capacità professionali o personali che rifluiscono in un’attività necessariamente episodica e
marginale. Da noi i problemi del critico sono gli stessi del musicista: come per il musicista è
impossibile trarre dal jazz un minimo per vivere dedicandosi esclusivamente ad esso, così il
critico non può assolutamente pensare di vivere solo con il jazz. Inoltre al critico italiano
mancano discoteche e biblioteche attrezzate (ognuno di noi si serve dei dischi e delle
pubblicazioni personali e di qualche amico) che gli permettano di fare studi sistematici:
fatalmente la critica italiana si riduce alle recensioni dei concerti e dei dischi, a qualche
intervista e a qualche saggio, tutte cose che si possono fare rubando qualche ora ai programmi
serali e domenicali.
Ma la caratteristica più preoccupante dei nostri critici è quella di vivere lontano dai musicisti, e
quindi di non poterne mai condividere il feeling più intimo e più spontaneo. Anche per i critici si
può dire la stessa cosa detta per i musicisti: sono troppo per bene, troppo borghesi, troppo
integrati in un sistema sociale che ha pochissimo da spartire con lo spirito del jazz
(naturalmente io non intendo ergermi a giudice dei miei colleghi, ma cerco soltanto di
individuare alcune circostanze che hanno ostacolato prima di tutto me e poi in misura più o
meno marcata gli altri critici italiani). Infine anche i critici non hanno saputo (o non hanno
voluto) aprirsi verso i giovani che hanno mancato di impostare una critica rock e al tempo stesso
di tessere quei collegamenti necessari fra la cultura jazz e quella rock.
Per quanto riguarda i promotori e gli organizzatori vari, vanno distinti in due settori: quelli che
hanno in mano il potere politico e industriale e quelli che con il loro entusiasmo e la loro
intraprendenza organizzano tutto ciò che possono. I secondi vanno elogiati perché hanno creato
in Italia un giro di concerti e manifestazioni che non hanno nulla da invidiare a molte altre
nazioni. I primi invece sono fra i maggiori responsabili del provincialismo in cui tutti ci troviamo,
perchè non hanno voluto svolgere un’azione di bonifica del pubblico, per operare la metamorfosi
dal consumatore passivo al fruitore attivo e consapevole e non hanno voluto puntare su musicisti
che non avevano evidenti possibilità di tradursi in un alto e immediato indice di consumo.”
Milano di sera mi è estranea, mi mette la paura delle città nelle quali il rifugio è una camera
d’albergo senza volto (n.310, terzo piano, letto vuoto, appunti da sviluppare senza voglia,
nebbia odiosa). Telefono a degli amici. Gianni Basso e Oscar Valdambrini mi raggiungono alle Tre
Gazzelle. Milano, con loro, è di nuovo quella città di luci che conosco.
Guida Gianni alla ricerca di una bettola con vini astigiani. La trova a due passi e il Gattinara sul
tavolo è un piacere, mi ricorda la polenta mangiata nella stalla con i contadini del pinerolese
quando i B59 andavano a bombardare Torino (un pericolo lontano, non per noi che eravamo al
caldo tra le mucche e la paglia): il jazz non c’entra niente, bisogna infilarlo tra l’elenco delle
annate favolose dei vini piemontesi che Gianni Basso sta complottando con il cameriere.
Li ho lasciati che suonavano Ciao Turin alla Shorty Roger e me li ritrovo impegnati nelle suites
sui modelli free.
“Vedevamo i film di Alan Ladd” Oscar riporta, lievissima, l’ironia dei torinesi del borgo
Vanchiglia, che riconoscono nel modo (solo apparente) di parlare come se le cose non fossero
importanti “e ci piacevano. Il discorso free lo abbiamo maturato a grandi, lasciandolo
decantare. Ci siamo allineati solo per convinzione, non per seguire la moda.”
“Per il californiano” si inserisce Gianni Basso “ci siamo passati tutti. Nella storia c’è sempre un
periodo nero ma importante. In fondo, il jazz non è una questione di formule, ma di linguaggio e
oggi la maniera più libera mi dà il modo di esprimere tutto quello che sento.
I giri armonici prestabiliti mi hanno sempre condizionato.”
Chiedo se non riusciremo mai ad avere in Europa ed in Italia un linguaggio jazzistico che non
nasca in ritardo di dieci anni. E incominciamo, come possono farlo degli amici, a litigare.
Oscar Valdambrini mi ricorda come è nato il jazz, certe scale negre con il terzo e quinto tono
abbassati, mi inchioda con le blue notes, con il patrimonio ritmico africano, mi rinfaccia che per
un D’Andrea o un Ponty che nascono in Europa,oltre oceano sono pronti a vernirci ad insegnare il
jazz migliaia di negretti sfornati dai colleges, in cui il jazz si prende nel latte a colazione, nella
bistecca a pranzo, nel dolce della sera e nella jam sessions sotto casa.
“Non avremo”, mi scandisce , “mai un solista a livello americano: il loro vivaio è troppo ampio.”
Si aiuta con gli esempi: 6.000 piscine soltanto in una città come Los Angeles e noi 52 in tutta
Italia. Loro migliaia di jazzmen potenziali, depositari alla storia del jazz, pronti a surclassarci
come i nuotatori sfrontati dalle loro seimila piscine per città polverizzano i nostri. I negri,
decide, sono e saranno sempre superiori nel jazz.
Gianni (è una testa calda, cuore grande così) prende fuoco. Lui crede, ha fiducia nei giovani.
Lotta con me, Gattinara in corpo, per affermare che il jazz è, ora, figlio del mondo e che i
giovani diranno il parola nuova e risolutrice su questo punto. Il disaccordo dilaga rumorosamente
sui vicini infastiditi. Oscar rinfaccia ai giovani di imbottirsi di droga, poveri debosciati incapaci di
vivere senza stimoli artificiali. I giovani (e qui Gianni è trascinante ) si drogano solo in modo
diverso, hashisc al posto delle false demagogie, delle droghe che le religioni ci hanno impartito
per secoli. Le cose in Italia, possono andar meglio lottando. Stanno (puntualizza) andando
meglio dopo che i musicisti italiani hanno imposto la loro partecipazione ai concerti sulla base di
una percentuale di presenze rapportata a quelle degli stranieri.
“Dove arriveremo?” chiede Valdambrini, con ironia aperta. “Togli il patrimonio negro,
inventiamo un nuovo jazz, sotto le avanguardie, buttiamo via lo swing, largo ai giovani drogati:
tra venti anni non lo chiameremo più jazz.”
Ma è poi tanto importante chiamarlo così?
“Si, jazz italiano! Ma se non esiste una nazione, forse ti abbuono la Turchia, “incalza Oscar ”in
cui ci sia una tale apatia tra i musicisti, che sono orchestrali (vestito Facis, 850 Fiat, famiglia, al
mare d’agosto alla pensione Ausonia di Cesenatico); se siamo la quart’ultima nazione al mondo
in fatto di educazione musicale. Non abbiamo un folklore utilizzabile per il jazz. Il nostro
folklore sone le polche.”
Ci racconta di un clarinettista da balera tutto fuoco che gli ricordava Gianni Basso quando
improvvisa, senza irriverenza per il compagno con il quale suona, con affetto enorme, da
quindici anni: vuol significare che quel tipo di linguaggio, anche se genuino, lo stesso di Gianni,
non serve al jazz; un folklore fatto di ¾, di 6/8.
“Ecco, escluso il 6/8 della tarantella e della monferrina, non abbiamo altro, quando altri popoli
hanno tempi pazzeschi, in cui puoi raccogliere lo swing a manciate e buttarlo sulla gente. In Sud
America - continua a raccontarci- copiavo per ore, senza riuscire a rifarla bene, la scansione
ritmica che gli operai battevano sui tavoli delle bettole con le mani. Se vogliamo basare
l’avvenire del jazz sui temi folkloristici, potremo farlo (ma già ho detto a Gaslini, copieremo
soltanto Pizzetti, Malipiero e Casella) raccogliendo spunti melodici.
Una volta esposto il tema, non ci sarà più folklore. Come una volta i temi erano di Cole Porter o
George Gershwin (e quando iniziava l’improvvisazione Porter e Gershwin sparivano) ora ci sarà
un tema e uno svolgimento (come a scuola): finito il tema, sarai Coltrane, Rollins, Parker”.
Il Gattinara è finito. Abbiamo riscoperto quanto è bello e stupido litigare per il jazz. Per fare
pace leggo a Oscar quello che ho scritto sui nostri amici torinesi e lui (troppo buono, è sempre
un gentiluomo) lo trova bellissimo. Forse perché così ricorda (con nostalgia) quando tirava i
“cartocci” con lo spillo nel sedere delle signore, sui balconi di borgo Vanchiglia, con la
cerbottana fatta con i tubi del leggio.
E’ bello (anche utile) litigare per il jazz, sentirsi vivi, accapigliarsi, nutrirsi delle idee degli altri.
Il jazz è bianco,
il jazz è nero,
la colpa è vostra,
il free, il rock, l’anarchia,
ai miei tempi, i giovani, l’universalità,
il valore sociale, l’ambiente,
discuterne?, finisce tutto in spaghetti,
non è vero!
Hanno parlato tutti, una jam fantastica, poeti e artigiani, massaie e attori, sul filo del blues.
Io testimone e non giudice, ho passato le notti a trascrivere i nastri, ho verniciato lo strumento
della tradizione nel colore dei giovani (targato made in Italy, pieno di bucatini) per stimolare
una reazione.
Lo strumento (dipinto pop non mi disturba) ora l’ho capovolto, ed è vuoto.
Per liberarlo dagli spaghetti è bastato voltarlo.
Il jazz italiano (verniciato da giovane mi sta bene) ora si è ripulito del sugo della pasta
casereccia.
E’ figlio del mondo.
E’ jazz. Musica.
Un patrimonio culturale da salvare.
Enrico Cogno
l