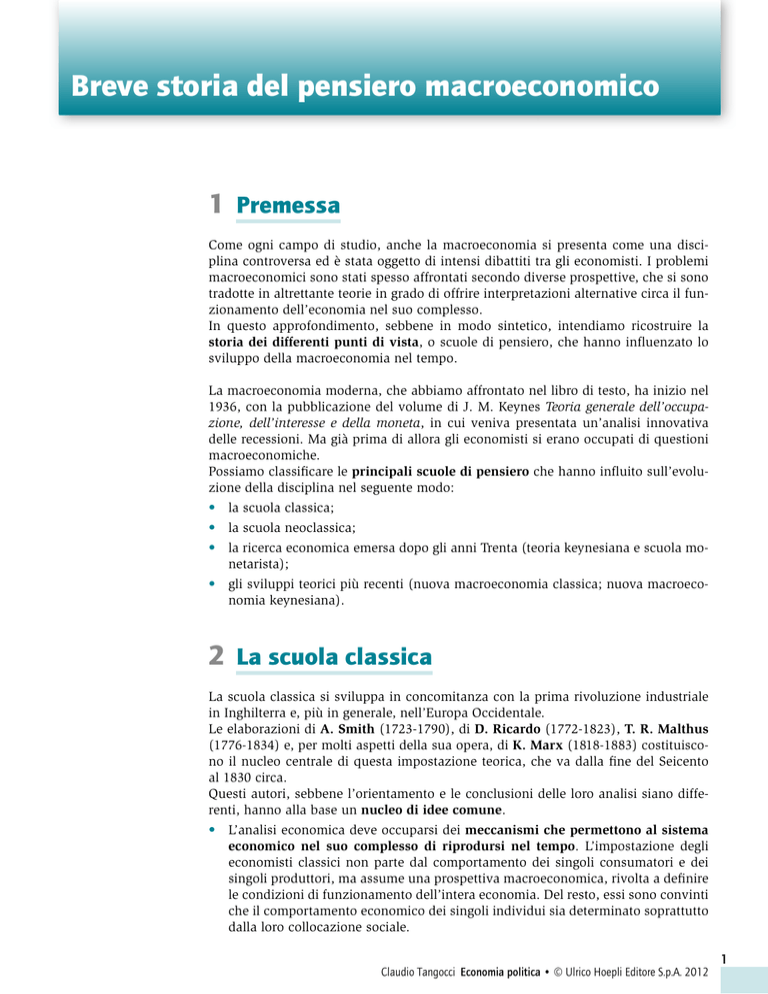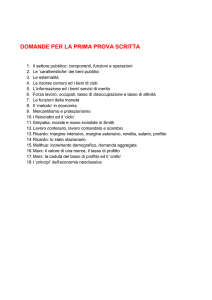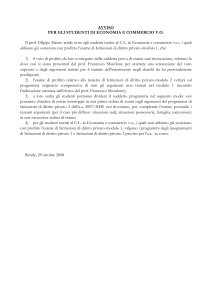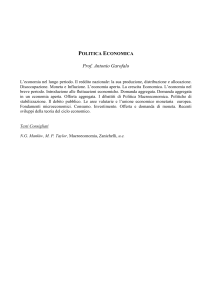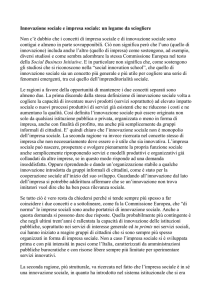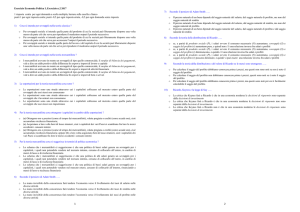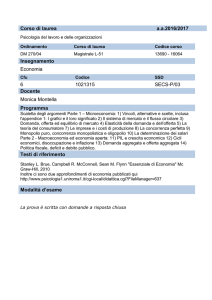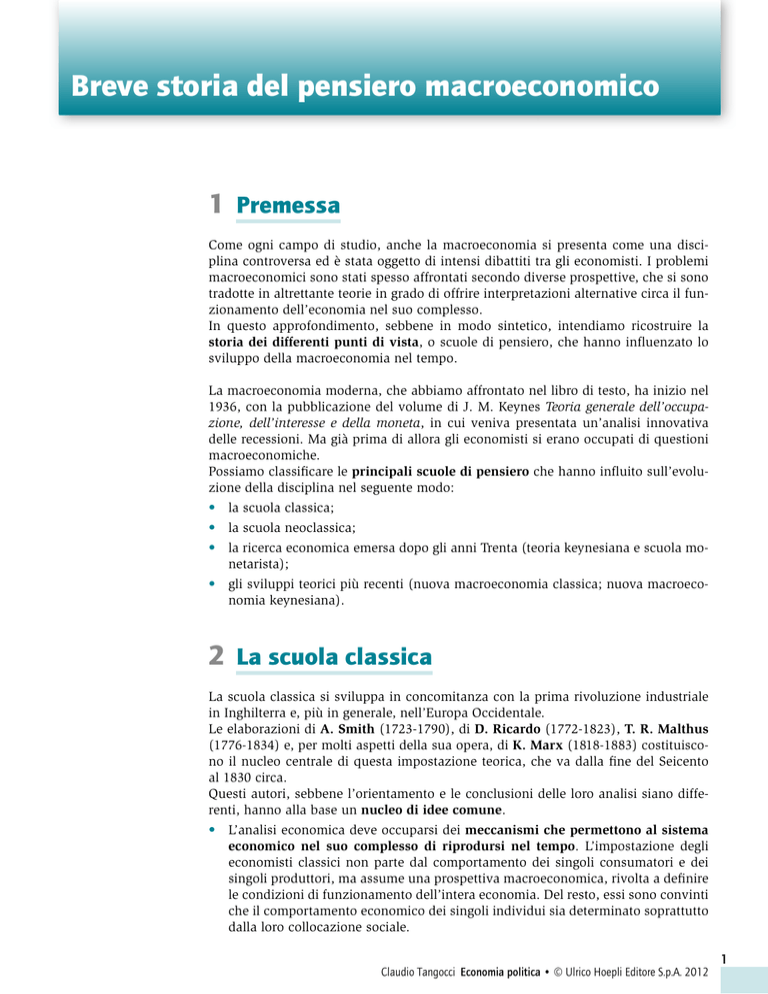
Breve storia del pensiero macroeconomico
1 Premessa
Come ogni campo di studio, anche la macroeconomia si presenta come una disciplina controversa ed è stata oggetto di intensi dibattiti tra gli economisti. I problemi
macroeconomici sono stati spesso affrontati secondo diverse prospettive, che si sono
tradotte in altrettante teorie in grado di offrire interpretazioni alternative circa il funzionamento dell’economia nel suo complesso.
In questo approfondimento, sebbene in modo sintetico, intendiamo ricostruire la
storia dei differenti punti di vista, o scuole di pensiero, che hanno influenzato lo
sviluppo della macroeconomia nel tempo.
La macroeconomia moderna, che abbiamo affrontato nel libro di testo, ha inizio nel
1936, con la pubblicazione del volume di J. M. Keynes Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, in cui veniva presentata un’analisi innovativa
delle recessioni. Ma già prima di allora gli economisti si erano occupati di questioni
macroeconomiche.
Possiamo classificare le principali scuole di pensiero che hanno influito sull’evoluzione della disciplina nel seguente modo:
• la scuola classica;
• la scuola neoclassica;
• la ricerca economica emersa dopo gli anni Trenta (teoria keynesiana e scuola monetarista);
• gli sviluppi teorici più recenti (nuova macroeconomia classica; nuova macroeconomia keynesiana).
2 La scuola classica
La scuola classica si sviluppa in concomitanza con la prima rivoluzione industriale
in Inghilterra e, più in generale, nell’Europa Occidentale.
Le elaborazioni di A. Smith (1723-1790), di D. Ricardo (1772-1823), T. R. Malthus
(1776-1834) e, per molti aspetti della sua opera, di K. Marx (1818-1883) costituiscono il nucleo centrale di questa impostazione teorica, che va dalla fine del Seicento
al 1830 circa.
Questi autori, sebbene l’orientamento e le conclusioni delle loro analisi siano differenti, hanno alla base un nucleo di idee comune.
• L’analisi economica deve occuparsi dei meccanismi che permettono al sistema
economico nel suo complesso di riprodursi nel tempo. L’impostazione degli
economisti classici non parte dal comportamento dei singoli consumatori e dei
singoli produttori, ma assume una prospettiva macroeconomica, rivolta a definire
le condizioni di funzionamento dell’intera economia. Del resto, essi sono convinti
che il comportamento economico dei singoli individui sia determinato soprattutto
dalla loro collocazione sociale.
Claudio Tangocci Economia politica • © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2012
1
Breve storia del pensiero macroeconomico
• Questi autori partono dall’assunto che il sistema economico da analizzare sia
composto di tre grandi classi: i proprietari terrieri, gli imprenditori (capitalisti) e
i lavoratori salariati.
• Le loro teorie sono costruite attorno a un concetto fondamentale: quello di sovrappiù economico. Il sovrappiù è costituito dalla produzione netta, cioè dal
prodotto che residua quando l’insieme dei lavoratori impiegati nell’attività economica produce di più di quanto consuma per il suo sostentamento. All’origine
del sovrappiù sta, dunque, il lavoro. La creazione del sovrappiù è il fine di ogni
economia di mercato. Senza sovrappiù l’economia non si espande, la produzione
non si amplia, ma al limite si ripete identica nel periodo successivo. Correlato
al problema del sovrappiù si pone il problema della sua destinazione. La teoria
economica studia la produzione e la distribuzione del sovrappiù.
• La centralità del lavoro è un concetto fondamentale, che emerge soprattutto nella
teoria del valore che questi studiosi elaborano. La loro idea è che il valore di una
merce è proporzionale al tempo di lavoro che è stato necessario impiegare per
realizzarla (teoria del valore-lavoro).
Adam Smith
Si può considerare la Ricchezza delle Nazioni (1776) di Adam Smith come il primo libro
di economia politica che mostra davvero un carattere di compiutezza. Obiettivo principale dell’opera è elaborare una teoria della crescita economica, ovvero fornire una
spiegazione delle cause che determinano gli aumenti di ricchezza di una società.
SCHEDA
I fisiocratici
Ancora prima degli economisti classici, la scuola fisiocratica, sviluppatasi in Francia a partire dalla metà del Settecento, il cui principale esponente è F. Quesnay (16941774), individua nell’analisi del sovrappiù il principale
problema della teoria economica.
Nella sua opera principale, il Tableau Economique (175859), Quesnay descrive il sistema economico della sua epoca, ancora fondato sull’agricoltura, sulla base di un modello in cui i processi della produzione, della distribuzione
e del consumo si intrecciano continuamente.
Semplificando al massimo, il Tableau Economique individua tre classi sociali:
• i proprietari terrieri;
• i lavoratori agricoli, che sono dipendenti dei proprietari
terrieri;
• gli artigiani, che svolgono la loro attività in settori diversi dall’agricoltura.
Supponiamo che all’inizio di un anno una scorta della
produzione agricola dell’anno precedente sia a disposizione dei lavoratori agricoli. Questi ultimi utilizzano la scorta
di prodotti agricoli come alimenti e come materie prime
da impiegare nel nuovo processo produttivo. Durante
l’anno, coltivando la terra, essi sono in grado di ottenere
un raccolto che è maggiore dei prodotti che hanno usato
per il loro nutrimento e come sementi per la coltivazione,
ossia realizzano un prodotto netto.
Parte del nuovo raccolto viene destinata a ricostituire la
scorta utilizzata durante l’anno, mentre l’eccesso, il prodotto netto, viene dato in pagamento ai proprietari della
terra. In altri termini, il sovrappiù si trasforma interamente in rendita dei proprietari; i lavoratori agricoli non partecipano alla sua distribuzione.
I proprietari utilizzano parte della rendita per il loro mantenimento; la parte restante la usano per acquistare i beni prodotti dagli artigiani, che in questo modo possono
far fronte al loro sostentamento. Gli artigiani percepiscono il valore esatto dei loro prodotti, quindi non realizzano
un sovrappiù, e per questa ragione sono considerati sterili o improduttivi.
Il sovrappiù ha luogo solamente in agricoltura, ed è attribuibile esclusivamente alla fertilità del terreno.
Malgrado questa impostazione possa oggi apparire semplice, ha il pregio di attirare l’attenzione su aspetti importanti per la scienza economica, quali la determinazione del
sovrappiù e le relazioni che intercorrono tra attività produttiva e circolazione dei prodotti in un’economia mercantile.
Claudio Tangocci Economia politica • © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2012
2
Breve storia del pensiero macroeconomico
Divisione del lavoro e mercato
Per Smith la misura della ricchezza di una società è data dal complesso di prodotti di cui la popolazione può disporre (“le cose necessarie e comode della vita”).
All’origine dell’aumento di questa ricchezza vi è la divisione del lavoro: quanto più
il lavoro umano si specializza in particolari compiti e si parcellizza, tanto più sviluppa efficienza e diventa produttivo. Ma la divisione del lavoro progredisce solo se
c’è un’estensione dei mercati, che è necessaria per assorbire quantità maggiori di
prodotti. A sua volta, l’ampiezza dei mercati è favorita dallo sviluppo dei trasporti e
dalla diffusione dei sistemi creditizi che rendono più facile la commercializzazione
dei prodotti. Anche gli scambi a livello internazionale, che aumentano la dimensione dei mercati, permettono una maggiore divisione del lavoro. Da qui la posizione
di Smith contro ogni restrizione al commercio, perché solo così si può innescare una
spirale virtuosa favorevole alla crescita economica.
Qualsiasi iniziativa tendente ad alterare il funzionamento del mercato è da considerarsi, per Smith, contraria all’interesse della società. Si possono raggiungere risultati
efficaci soltanto lasciando che il coordinamento delle attività economiche sia assicurato dalla “mano invisibile” del mercato, che premia quanti producono ciò che è
maggiormente richiesto.
In un’economia di mercato, il settore pubblico deve ridurre al minimo il suo intervento nella vita economica, in quanto il benessere collettivo può essere perseguito
affidandosi a libere scelte compiute dai soggetti privati, i quali operano basandosi sul
proprio interesse individuale.
Il prezzo naturale
L’importanza che Smith attribuisce al libero commercio gli impone di concentrare l’attenzione anche sulle interazioni economiche che avvengono nel mercato, e in particolare sul modo in cui si determina il prezzo relativo dei beni, o valore di scambio. In quale modo si forma il prezzo di ogni particolare bene in rapporto al prezzo di altri beni?
Per Smith, se si considera una società primitiva, in cui “l’intero prodotto del lavoro
appartiene al lavoratore”, i beni sono scambiati confrontando le rispettive quantità di
lavoro che sono state impiegate per produrli.
“Se in una nazione di cacciatori, per esempio, per uccidere un castoro occorre usualmente una quantità di lavoro che è doppia di quella richiesta per uccidere un cervo,
un castoro dovrà naturalmente scambiarsi contro due cervi.”
In questo caso, il valore di scambio di un bene dipende dal lavoro contenuto in quel
bene (cioè, dal lavoro che è stato necessario impiegare per produrre il bene), ed è
uguale alla quantità di lavoro che esso permette di acquistare (o ricevere in cambio)
nel momento in cui venga scambiato con prodotti appartenenti ad altri soggetti.
Per esempio, se il bene X si scambia con il bene Y nel rapporto 1:1, significa che:
Lavoro contenuto in X = lavoro contenuto in Y
Ma anche che:
Quantità di lavoro che il bene X
permette di ricevere in cambio = lavoro contenuto in Y
La situazione, però, cambia quando si considera uno stadio evoluto dell’economia,
dove i soggetti sono differenziati in tre classi fondamentali: lavoratori, imprenditori
(o capitalisti), che hanno il controllo delle aziende e dei mezzi di produzione, e proprietari fondiari, che hanno la proprietà della terra e delle risorse naturali.
Claudio Tangocci Economia politica • © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2012
3
Breve storia del pensiero macroeconomico
In questo stato di cose, la quantità di lavoro di cui un bene può disporre è superiore
alla quantità di lavoro in esso contenuta, in quanto comprende, oltre al salario, anche
la quantità di lavoro acquistata da quella parte del valore del bene che corrisponde al
profitto degli imprenditori e alla rendita dei proprietari delle terre. Il valore di scambio si risolve in salario, profitto e rendita. Quando si verifica questa coincidenza si
può anche parlare di prezzo naturale.
Si noti che il prezzo di mercato potrà risultare inferiore o superiore al prezzo naturale. Tuttavia, il prezzo naturale è una sorta di baricentro attorno al quale gravitano
i prezzi di mercato: qualora vi sia piena libertà di scambio, le forze della domanda e
dell’offerta tenderanno a sospingere i prezzi di mercato verso il prezzo naturale.
David Ricardo
Il sistema economico ai tempi di David Ricardo (1772-1823) era diverso da quello in
cui visse Adam Smith. La rivoluzione industriale, ormai pienamente affermata, aveva
posto al centro dello sviluppo l’impresa e aveva delineato con più precisione le classi
sociali protagoniste della vita economica.
Con la sua opera principale, Principi di economia politica e della tassazione (1817),
Ricardo fornì un contributo notevole alla comprensione di un moderno sistema economico.
Il problema distributivo
Nella prefazione della sua opera, Ricardo dichiara che il problema fondamentale
dell’economia politica è quello di determinare le forze che influenzano la distribuzione del prodotto fra le classi sociali. L’aspetto del processo distributivo ritenuto
decisivo da Ricardo è la determinazione dell’entità dei profitti, cioè la parte del
prodotto destinata agli imprenditori che anticipano i capitali e organizzano l’attività
produttiva. È dall’aumento del volume dei profitti che dipendono le tendenze dinamiche del sistema economico. Solo un ammontare adeguato di profitti, infatti, può
incentivare gli imprenditori a eseguire nuovi investimenti, che sono fondamentali per
l’espansione economica.
L’idea fondamentale di Ricardo al riguardo è che, se i meccanismi del mercato e della
concorrenza funzionano in maniera regolare, le condizioni di produzione nel settore
agricolo hanno un’influenza decisiva sulla formazione dei profitti nell’intero sistema
economico.
Ricardo attribuisce un ruolo speciale all’agricoltura per due ragioni.
In primo luogo, nel settore agricolo si producono i mezzi di sussistenza per tutti i
lavoratori, per cui i prodotti agricoli sono indispensabili e vengono impiegati in tutti
gli altri tipi di produzione.
Inoltre, l’agricoltura è il solo settore in cui il medesimo bene (per esempio i cereali)
può essere considerato sia come fattore di produzione (sono la semente da impiegare
nella coltivazione; forniscono il nutrimento della manodopera, cioè i salari possono
essere considerati come se fossero costituiti solo di cereali) sia come risultato del processo produttivo. Di conseguenza, il calcolo del profitto in agricoltura può essere
fondato su grandezze fisiche, senza fare riferimento ai prezzi monetari: il profitto è
ciò che rimane detraendo dall’intero prodotto, misurato in termini di derrate agricole,
le spese relative alla coltivazione, anch’esse misurate in derrate agricole.
Si noti che in questo modo la determinazione quantitativa del profitto è concepita
come un residuo e coincide con il sovrappiù, ossia è l’eccedenza delle quantità prodotte su quelle che si sono impiegate nell’attività produttiva.
Questo significa, tra le altre cose, che i salari, la parte del prodotto che riceve la
manodopera, si determinano indipendentemente dall’entità del sovrappiù; in altri
termini, i lavoratori non partecipano alla distribuzione del sovrappiù. Secondo RicarClaudio Tangocci Economia politica • © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2012
4
Breve storia del pensiero macroeconomico
do, infatti, i salari tendono a stabilizzarsi attorno al livello di sussistenza abituale,
ovvero tendono corrispondere ai consumi necessari, a quelle quantità di beni che
sono considerate dai lavoratori, in un determinato periodo storico, come irrinunciabili per garantire condizioni di vita appena decorose. Se i salari fossero superiori al
livello di sussistenza, si avrebbe un miglioramento del tenore di vita dei lavoratori
che, nel lungo periodo, comporterebbe un incremento demografico; l’aumento della
popolazione farebbe crescere l’offerta di lavoro e questo provocherebbe la diminuzione dei salari al livello di sussistenza (e viceversa, nel caso di livelli del salario al
disotto della sussistenza).
La rendita differenziale
L’analisi della formazione del profitto in agricoltura è svolta sulla base del presupposto che tale questione sia strettamente legata all’andamento della rendita fondiaria.
La preoccupazione dominante nell’opera di Ricardo è quella di un possibile calo dei
profitti e di un aumento delle rendite. Il motivo è dovuto al fatto che il sistema economico, spinto dalla necessità di maggiori generi alimentari conseguente all’incremento
della popolazione, deve ricorrere alla coltivazione di terreni meno fertili. Su questo
punto Ricardo fa propria la tesi avanzata da Malthus nel suo Saggio sul principio della
popolazione, secondo cui la popolazione tenderebbe a crescere rapidamente se non
fosse frenata dalla carenza di mezzi di sussistenza, la cui disponibilità può incrementare, ma in maniera molto più lenta.
I terreni meno fertili presentano rendimenti decrescenti, ossia il raccolto di derrate
agricole aumenta meno che proporzionalmente rispetto alle maggiori quantità di
lavoro e mezzi impiegati nella produzione. Per esempio, se su un terreno fertile si ottengono 300 quintali di cereali in un anno, impiegandovi un capitale (inclusi i salari)
del valore di 200 quintali di cereali, il profitto è 100 quintali, il saggio del profitto è
100 su 200, ossia il 50%. Se in seguito la coltivazione è estesa a terre meno fertili, per
ottenere la stessa quantità di prodotto (300 quintali) occorre l’impiego di un capitale
maggiore, diciamo 210 quintali, di conseguenza, il saggio del profitto scende dal 50
al 43%, ossia diventa 90 su 210.
Per effetto della concorrenza tra gli imprenditori agricoli (gli imprenditori sono disposti a pagare un affitto più elevato per ottenere i terreni più fertili), il saggio del profitto
sulla terra coltivata per prima scende al livello di quello che si consegue sul terreno
meno fertile. Questo significa che di quei 100 quintali di cereali che si ottengono sul
terreno più fertile soltanto 86 quintali saranno destinati a profitto (86 su 200 è pari a
un saggio del profitto del 43%), mentre 14 quintali (il 7%) costituiranno la rendita
del proprietario del terreno.
Quando si mettono a coltura terre meno fertili, con rendimenti via via minori, la
rendita sale a scapito del profitto. Si tratta, dunque, di una rendita differenziale: le
terre di qualità migliore danno una rendita, le terre peggiori no. Per usare le parole
dello stesso Ricardo: “La rendita è in ogni caso una quota dei profitti precedentemente ottenuti dalla terra. Non è mai nuova creazione di reddito, ma è sempre una parte
del reddito già creato. I profitti del capitale possono diminuire soltanto perché non si
può ottenere nuova terra egualmente adatta a produrre viveri; e la rapidità con cui i
profitti calano, così come quella con cui le rendite aumentano, dipende interamente
dalle maggiori spese di produzione”. (D. Ricardo, Saggio sull’influenza di un basso
prezzo sui cereali, da D. Ricardo, Principi dell’economia politica e delle imposte con
altri saggi sull’agricoltura e la moneta, UTET, 1965).
Per sostenere i profitti, a meno che non vi siano progressi tecnici in agricoltura che
compensano la minore fertilità dei terreni, secondo Ricardo occorre importare prodotti agricoli da Paesi in grado di fornirli a un prezzo inferiore. Occorre, quindi, una
politica di abolizione dei dazi sulle importazioni. I singoli Paesi possono solo trarre
vantaggi dal commercio internazionale.
Claudio Tangocci Economia politica • © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2012
5
Breve storia del pensiero macroeconomico
La tendenza alla diminuzione del saggio del profitto, dovuta al fatto che si mettono
a coltura terre peggiori, non coinvolge solo il settore agricolo, ma l’intero sistema
economico. Il progressivo innalzamento della rendita fondiaria, infatti, finisce per
provocare un aumento del prezzo relativo dei prodotti agricoli (si modifica il valore
di scambio dei prodotti agricoli rispetto a quello di tutte le altre merci) e, per questa
via, fa aumentare il livello dei salari da corrispondere ai lavoratori in tutti i settori
produttivi (i salari che sono al livello di sussistenza, per sua natura incomprimibile,
devono crescere per adeguarsi all’aumento dei prezzi, affinché la loro capacità di
acquisto resti immutata) con conseguenze negative per i profitti.
Il calo dei profitti riduce gli investimenti e, quindi, rallenta la crescita economica,
orientando il sistema economico verso uno stato stazionario.
La teoria dei prezzi
Questo modo di argomentare, però, va incontro a un’importante obiezione: nell’economia non vi è alcun settore, neppure quello agricolo, in cui capitale anticipato e prodotto
sono composti dalla stessa merce. Per esempio, tra i mezzi di produzione, oltre ai cerali
da utilizzare come semente, occorrono anche trattori e fertilizzanti, e i lavoratori non
consumano solo derrate agricole, ma anche prodotti dell’industria. Se si considerano
beni eterogenei, non potendosi sommare per esempio quintali di cerali con tonnellate di
acciaio, la valutazione del prodotto richiede la conoscenza dei prezzi di tali beni. Più precisamente, per capire come il prodotto è distribuito tra le classi sociali (il problema fondamentale di Ricardo), è necessaria una teoria dei prezzi (o del valore delle merci).
Proprio per rispondere a questa esigenza, Ricardo si propone di trovare uno strumento mediante il quale ricondurre a un denominatore comune i prezzi dei molteplici
prodotti realizzati nell’economia.
Ricardo individua tale strumento nella quantità di lavoro contenuto nei prodotti. Il
problema è dar conto delle leggi che regolano la determinazione dei prezzi relativi,
e dal momento che i beni sono forniti dal lavoro, gli appare logico affermare che i
prezzi relativi corrispondono alle quantità di lavoro impiegate per produrli.
Ricardo, però, non riesce a sviluppare pienamente questa idea. Le difficoltà sono
dovute al fatto che per produrre beni non occorre soltanto lavoro, ma più input, che
vengono impiegati nel processo produttivo secondo tecniche differenti. Una volta
ammessa questa diversità, viene a cadere la possibilità di sostenere che i prezzi relativi riflettono la quantità di lavoro impiegata.
Inoltre, i periodi di tempo richiesti per la produzione dei vari beni sono differenti: sebbene due beni possano richiedere l’impiego di identiche quantità di lavoro per essere
prodotti, avranno prezzi diversi se uno dei due ha richiesto un impiego di capitali per un
periodo più lungo, prima che fosse possibile realizzare un ricavo dalla sua vendita.
Le idee di Ricardo hanno però dato in seguito i loro frutti. Un grande economista
italiano, Piero Sraffa (1898-1983), in una sua opera molto importante, Produzione di
merci a mezzo di merci (1960), ha mostrato in maniera ineccepibile come sia possibile misurare prodotti e capitale anticipato in valore e, quindi, esprimerli in termini
di grandezze omogenee.
Karl Marx
Nel corso della prima metà del XIX secolo, la situazione economica dei Paesi dell’Europa Occidentale aveva subito cambiamenti profondi: l’industrializzazione e la crescita
della produzione manifatturiera avanzavano a un ritmo sostenuto, così pure il volume
degli investimenti a fini produttivi e degli scambi commerciali a livello internazionale.
Queste trasformazioni, seppure importanti, avevano recato ben pochi benefici per la gran
parte della popolazione. Le ore di lavoro dei salariati erano molte, mentre le retribuzioni
rimanevano a livelli bassi, ben poco oltre lo stretto necessario per vivere; numerosi erano
Claudio Tangocci Economia politica • © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2012
6
Breve storia del pensiero macroeconomico
i disoccupati e, comunque, era sufficiente un periodo di rallentamento dell’attività produttiva per privare consistenti gruppi di lavoratori dei mezzi di sostentamento.
Di fronte a queste condizioni, diversi pensatori fecero sentire la loro voce critica e
provarono a elaborare sistemi economici alternativi all’economia di mercato. Tra
i critici più accesi del sistema economico allora esistente in Europa senza dubbio
dominò il nome di Marx.
Karl Marx (1818-1883) fu un filosofo, uno storico e un economista, ma anche un
uomo politico impegnato a realizzare un radicale cambiamento sociale.
La maggior parte dei suoi scritti come economista è dedicata all’analisi dell’economia
di mercato, del capitalismo. Lo scopo della sua opera maggiore, Il capitale (1867),
è di “mettere a nudo la legge economica del movimento della società moderna”. La
legge che egli mira a svelare non è né naturale né eterna, ma valida unicamente per
una fase particolare dello sviluppo storico, destinata dunque a terminare.
La teoria del valore-lavoro
Marx ritiene che il capitalismo, come fase storica, sia un modo di organizzare l’attività economica basato su uno sfruttamento continuo del lavoro. La spiegazione
dello sfruttamento del lavoro parte dalla teoria del valore-lavoro che Marx pone al
centro della sua analisi teorica.
Per Marx il valore di una merce è dato dalla quantità di lavoro (espressa, per esempio, in ore di lavoro) che è necessario impiegare mediamente per produrla. Affermare
che il lavoro conferisce valore a una merce non significa sostenere che i lavoratori
producono usando solo le proprie mani. I lavoratori utilizzano anche strumenti di
produzione e materie prime, che Marx definisce capitale costante, che trovano a
loro disposizione prima che la produzione abbia inizio, in quanto l’imprenditore ha
anticipato un capitale per acquisire tali strumenti. Ma i macchinari e le materie prime
possono essere considerati come accumulazione di lavoro precedentemente prestato, sono prodotti del lavoro impiegato in passato.
Pertanto, il valore di una merce è composto sia dal lavoro diretto, svolto dal lavoratore per produrla, sia dal lavoro indiretto, incorporato nel capitale costante adoperato durante il processo produttivo.
quantità di lavoro diretto
Valore di una merce = e indiretto necessaria per produrla
Le merci, una volta prodotte, si scambiano sul mercato ai loro valori definiti in termini di quantità totale di lavoro che si è resa necessaria nel processo produttivo.
Nel capitalismo anche il lavoro è una merce, o meglio, è una merce la capacità di
lavorare del lavoratore (le sue prestazioni), che Marx chiama forza lavoro.
Il lavoratore non è né uno schiavo né un servo della gleba. Egli si impegna a lavorare
un certo numero di ore al giorno alle dipendenze di un imprenditore (capitalista)
sulla base di un rapporto contrattuale, e stipula il contratto di lavoro solo se vuole;
formalmente non è obbligato a farlo.
Il lavoratore vende la sua capacità di lavorare contro un salario. Marx ritiene che il
salario corrisponda al valore della forza lavoro, ossia al valore dei beni di sussistenza che sono necessari alla ricostituzione della forza lavoro.
Valore forza lavoro =
tempo di lavoro necessario a produrre
i beni di sussistenza del lavoratore
La forza lavoro è una merce e, nello scambio, essa viene pagata secondo il suo valore:
sul mercato del lavoro lo scambio tra forza lavoro e salari, che vengono anticipati
Claudio Tangocci Economia politica • © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2012
7
Breve storia del pensiero macroeconomico
dall’imprenditore prima che il prodotto sia realizzato, è uno scambio tra equivalenti.
Marx definisce le anticipazioni salariali capitale variabile (V).
Tuttavia, quando il lavoratore presta concretamente la sua opera sotto la direzione
dell’imprenditore, non c’è più un rapporto tra equivalenti, ma, al contrario, di dipendenza. Ed è per questa ragione che l’imprenditore riesce alla fine a utilizzare i dipendenti per un numero di ore maggiore di quello che è necessario al loro mantenimento.
Di conseguenza, i lavoratori svolgono un lavoro eccedente (un pluslavoro), producendo al termine di questo processo un valore superiore a quello anticipato come salario,
un valore in più, un sovrappiù o plusvalore (S), di cui si appropria l’imprenditore.
Sta qui l’origine dello sfruttamento e del profitto: è legato al fatto che l’imprenditore
paga ai dipendenti solo una frazione del valore del loro prodotto.
Supponiamo che in media la quantità di merci necessarie al mantenimento di un
lavoratore abbia un valore pari a sei ore (perché questa è la quantità di lavoro complessiva occorsa per produrle); se l’imprenditore fa lavorare un suo dipendente non
sei ore ma dieci ore, significa che le quattro ore addizionali producono un plusvalore
(un valore in più rispetto al valore delle merci necessarie alla sussistenza acquistate
dal lavoratore con il salario) che va all’imprenditore.
Come è stato osservato (cfr. J. Robinson, J. Eatwell, Economia politica, Etas Libri,
1982), questa conclusione non va intesa nel senso che i lavoratori hanno diritto all’intero valore che producono. Se i salari assorbissero l’intero plusvalore non potrebbe
esservi accumulazione di capitale, cioè investimenti produttivi che fanno progredire
la capacità produttiva e permettono al sistema economico di espandersi. Per Marx
è però un dato di fatto che l’accumulazione di capitale e la crescita dell’economia
avvengono a partire dallo sfruttamento dei lavoratori, sottraendo parte del valore
prodotto dal lavoro.
Plusvalore e saggio del profitto
Marx distingue tra plusvalore e saggio del profitto. Nel caso in cui il plusvalore si
traduca interamente in profitti, il saggio del profitto è dato dal rapporto tra il plusvalore e l’insieme del capitale costante e variabile:
Saggio del profitto =
S
C+V
(1)
Dividendo per V abbiamo:
SP =
S
V
C
+1
V
(2)
S/V è il rapporto tra profitti e capitale variabile impiegato; Marx lo chiama saggio di
sfruttamento.
C/V indica in quale proporzione il capitale complessivo si divide tra capitale costante e
capitale variabile; Marx chiama tale rapporto composizione organica del capitale.
È il capitale variabile, cioè la forza lavoro, che genera plusvalore; mentre il capitale
costante non altera il suo valore nel processo produttivo: i macchinari e le materie
prime si limitano ad aggiungere alla merce il proprio valore.
La caduta tendenziale del saggio del profitto
Tuttavia, secondo Marx, c’è una tendenza di lungo periodo nell’ambito del sistema
economico ad accrescere nei processi produttivi l’impiego di capitale costante rispetClaudio Tangocci Economia politica • © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2012
8
Breve storia del pensiero macroeconomico
to a quello variabile; in breve, a sostituire C a V e, quindi, ad aumentare la composizione organica del capitale. Perché? I motivi sono due:
• la propensione dei singoli imprenditori a diventare sempre più competitivi e ad
allargare il proprio mercato richiede l’introduzione di nuovi macchinari in grado
di aumentare la produttività del lavoro;
• sostituire strumenti di produzione al lavoro fa crescere la disoccupazione (Marx
chiama i disoccupati esercito industriale di riserva), permettendo di mantenere
bassi i salari. È evidente, in tal caso, il conflitto di interessi che oppone i salariati
agli imprenditori.
Tutto ciò, però, ha come conseguenza di diminuire il saggio del profitto (nella (2)
aumenta il denominatore), e qui sta la contraddizione del sistema capitalistico.
Via via che il saggio di profitto si abbassa, diminuiscono gli investimenti all’interno
dell’economia, le imprese che producono a costi più elevati sono sospinte fuori dal
mercato, i cicli economici diventano più intensi, i lavoratori si impoveriscono sempre
più e il sistema economico va incontro a crescenti difficoltà di funzionamento.
Più esattamente, Marx parla di caduta tendenziale del saggio del profitto, perché
riconosce che vi sono forze di segno opposto che potrebbero arrestare, per periodi
più o meno lunghi, la caduta del saggio del profitto.
Il problema della trasformazione
In base all’esperienza storica possiamo dire che le previsioni di Marx non hanno trovato riscontro nella realtà: non si è verificata nessuna tendenza alla caduta del saggio
del profitto, né l’impoverimento crescente della classe dei lavoratori.
Inoltre, la teoria del valore-lavoro va incontro a una difficoltà, della quale Marx era
consapevole: il problema di come i valori delle merci possono essere trasformati
nei prezzi.
In termini sintetici, consiste nel fatto che le merci si possono scambiare nei termini
del lavoro incorporato solo se il saggio del profitto è uniforme in tutti i settori produttivi. Questa condizione richiede, come si desume dalla (1), che siano uniformi in tutti
i settori produttivi il rapporto S/V e il rapporto C/V. Ebbene, se è possibile supporre
che S/V sia uniforme in tutti settori, perché la concorrenza tra i lavoratori rende credibile che la giornata di lavoro sia la stessa ovunque e uguali siano i salari, è alquanto
improbabile che il rapporto C/V non cambi da merce a merce, dal momento che i vari
settori impiegano tecniche produttive molto differenti (si pensi, per esempio, quanto
sono diverse le tecniche impiegate nel settore tessile rispetto a quello automobilistico). Proviamo a esporre questo punto con un facile esempio.
Consideriamo la produzione annuale di due merci, A e B.
Per A abbiamo: V = 20 ore di lavoro, C = 175 ore di lavoro, S = 20 ore di lavoro.
Per B abbiamo: V = 10 ore di lavoro, C = 40 ore di lavoro, S = 10 ore di lavoro.
In base alla teoria del valore-lavoro, il prezzo di A = 215; il prezzo di B = 60.
Il saggio annuo del profitto di A corrisponde al 10,2% (20/175 + 20); il saggio annuo
del profitto di B è uguale al 20% (10/10 + 40).
Poiché il saggio del profitto non è uguale, la concorrenza tra le imprese comporterà
una diminuzione degli impieghi nella produzione di A, dove il saggio del profitto è
minore, e un aumento nella produzione di B, che promette un saggio del profitto
maggiore. Di conseguenza, il prezzo di A tenderà ad aumentare, mentre il prezzo di
B a diminuire, fino a che i saggi del profitto saranno diventati uguali. A quel punto,
però, i prezzi delle due merci saranno differenti dal lavoro in esse incorporato.
Claudio Tangocci Economia politica • © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2012
9
Breve storia del pensiero macroeconomico
3 La scuola neoclassica
Alla fine del XIX secolo, i Paesi occidentali, sebbene non in modo lineare, registrarono
una forte crescita economica. La loro struttura economica aveva subìto significative
trasformazioni e permesso una prosperità senza precedenti. Gli ammonimenti dei
classici e di Marx circa le possibili interruzioni dell’espansione economica sembravano non trovare un effettivo riscontro nella realtà. Inoltre, il progredire dell’economia
appariva in grado di attenuare anziché accentuare le tensioni sociali. Un ripensamento del modo di funzionare dell’economia di mercato era, pertanto, maturo.
È in questo contesto che prese avvio e si consolidò una nuova scuola di economia
politica: la scuola marginalista o neoclassica.
Al successo di questa scuola contribuirono inizialmente le opere di tre autori che
elaborarono, in maniera indipendente, teorie sostanzialmente simili. I lavori a cui ci
riferiamo sono: Teoria di economia politica di W. S. Jevons (1835-1882); Principi di
economia politica di C. Menger (1840-1921); Elementi di economia politica pura di
L. Walras (1834-1910).
A questa nuova impostazione, in poco tempo, si dedicò un numero sempre maggiore
di studiosi, quali A. Marshall (1842-1924), E. von Bohm-Bawerk (1851-1914), J. B.
Clark (1847-1938), V. Pareto (1848-1923).
Generalizzando, possiamo dire che la nuova scuola marginalista intende elaborare un
sistema teorico valido per qualsiasi periodo storico e luogo, rinunciando quindi a impiegare concetti quali classi sociali, sovrappiù, forza lavoro, sfruttamento ecc., elaborati
dagli economisti classici con esplicito riferimento a un contesto economico particolare.
Essa propone un’analisi economica basata sul comportamento individuale. Punto
di partenza divengono le scelte che i singoli individui compiono nella veste di consumatori e produttori e le conseguenze di tali scelte.
La condizione che rende ogni singola azione umana suscettibile di assumere rilevanza sul piano economico è di essere rivolta alla soddisfazione dei bisogni. Infatti, il
nocciolo del problema consiste nell’individuare le condizioni in cui ripartire i fattori
produttivi disponibili (lavoro e capitale) fra impieghi alternativi con risultati ottimi:
ottimi nel senso di soddisfare al massimo le esigenze dei consumatori. La teoria dei
prezzi di mercato fornisce la risposta a tale problema.
I meccanismi di mercato, che determinano i prezzi tanto dei beni di consumo quanto dei fattori di produzione che servono a produrli, sono in grado di garantire un tipo
di organizzazione economica che è prossima all’ideale. I prezzi liberamente determinati dall’interazione tra domanda e offerta di mercato, poiché sono in grado di fornire incentivi agli individui per modificare le loro scelte di produzione e di consumo,
diventano il perno di tutto l’apparato teorico degli economisti neoclassici.
Anche il problema della distribuzione viene considerato un aspetto particolare della
teoria dei prezzi di mercato. I fattori di produzione di cui i soggetti sono proprietari
ricevono una remunerazione perché concorrono alla produzione dei beni richiesti dai
consumatori. Il salario percepito dai lavoratori corrisponde al contributo dato dal fattore
lavoro al processo produttivo; allo stesso modo, il profitto è la remunerazione del capitale, ed è tanto maggiore quanto maggiore è la produttività di tale fattore. In questo modo
viene eliminato qualsiasi possibilità di conflitto sul piano della distribuzione: le quote di
reddito spettanti ai soggetti proprietari dei fattori non sono altro che il giusto compenso
della loro produttività, quindi per il contributo da essi dato all’attività di produzione.
La legge di Say
Una simile impostazione ha conseguenze rilevanti anche sul modo di concepire l’analisi macroeconomica. La teoria neoclassica è essenzialmente microeconomica, in
quanto il comportamento dei singoli consumatori e produttori è alla base dell’intero
Claudio Tangocci Economia politica • © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2012
10
Breve storia del pensiero macroeconomico
edificio teorico, ma si pronuncia anche sul funzionamento del sistema economico
nel suo complesso: funzionamento che viene concepito come esito aggregato di
comportamenti individuali.
Sotto questo profilo, per i neoclassici crisi e disoccupazione sono soltanto fenomeni
accidentali che i meccanismi di mercato, se lasciati funzionare in modo autonomo,
senza interferenze di alcun genere, sono sempre in grado di riassorbire.
La teoria neoclassica si basa sull’ipotesi del pieno impiego del lavoro e degli altri
fattori di produzione. Se i soggetti proprietari dei fattori di produzione accettano una
remunerazione proporzionata al contributo che sono in grado di fornire al processo
produttivo, l’intera capacità produttiva verrà sempre utilizzata, e la produzione che
ne risulterà verrà sempre venduta.
Infatti, la teoria neoclassica fa propria la cosiddetta legge di Say (formulata dell’economista francese J. B. Say, 1767-1832), secondo la quale l’offerta crea la propria
domanda, ovvero esisterà sempre, in un’economia di mercato, un livello di domanda
dei beni prodotti sufficiente a mantenere la piena occupazione dei fattori produttivi.
In breve, la legge di Say nega che si possa verificare, con riferimento all’economia
nel suo complesso, un eccesso di produzione, ovvero la possibilità che la domanda
globale di beni sia inadeguata a riacquistare il livello di produzione realizzato (l’offerta totale di prodotto).
Questa conclusione non può essere alterata neanche dalla presenza della moneta. Per
i neoclassici la moneta serve solo a rendere più facili gli scambi e a evitare gli inconvenienti del baratto. Pertanto, la moneta ha un ruolo soltanto tecnico, è neutrale,
nel senso che la quantità di moneta esistente non ha alcuna influenza sulle grandezze reali dell’economia: un aumento dell’offerta di moneta provoca un aumento del
livello generale dei prezzi (genera inflazione), ma lascia invariata l’occupazione e la
produzione aggregata.
Identità tra risparmio e investimento
La legge di Say si fonda sul presupposto che tutto il reddito generato dalla produzione
venga speso, cioè si trasformi in domanda di beni e servizi. Ma nell’economia una
parte del reddito ottenuto dalle persone può essere risparmiato, quindi non speso. La
formazione del risparmio può mettere in discussione la validità della legge di Say?
Per gli economisti neoclassici la formazione del risparmio non rappresenta un ostacolo, perché essi assumono che il risparmio sia destinato alle imprese, le quali hanno
necessità di prendere fondi a prestito per acquistare beni capitali, cioè per effettuare
investimenti.
Il meccanismo in grado di garantire che il risparmio sia interamente investito è rappresentato dalle variazioni del tasso d’interesse. Una tendenza del risparmio ad
aumentare non è motivo di preoccupazione, in quanto l’eccesso di risparmio provoca
una riduzione del tasso d’interesse, che fa diminuire l’incentivo a risparmiare e aumentare la spesa per investimenti.
Il laissez faire
Gli economisti neoclassici traggono dalla loro analisi la convinzione che l’economia di
mercato sia un sistema perfettamente in grado di autoregolarsi, ossia di raggiungere
e assicurare automaticamente il pieno impiego di tutti i fattori di produzione. Di conseguenza, l’intervento del settore pubblico nella sfera economica non può che ostacolare
il corretto funzionamento del sistema economico. La politica economica più adeguata è
il liberismo (o laissez faire): il settore pubblico deve astenersi il più possibile dall’intervento diretto nella produzione e sul mercato, limitandosi ad assicurare dall’esterno le
condizioni legislative e di ordine pubblico che permettono a un’economia basata sulla
libertà di iniziativa dei soggetti privati di funzionare regolarmente.
Claudio Tangocci Economia politica • © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2012
11
Breve storia del pensiero macroeconomico
4 La ricerca economica
emersa dopo gli anni ’30
La teoria neoclassica prevalse nell’ambito della scienza economica sostanzialmente
fino alla Grande depressione degli anni ’30. Sebbene le cause che determinarono la
Grande depressione siano ancora controverse, è un fatto indiscusso che tale evento
mostrò come l’economia di mercato possa essere incapace di regolarsi autonomamente e garantire un efficiente impiego delle risorse produttive disponibili.
La Grande depressione fu, infatti, un evento catastrofico a livello mondiale. La maggior parte dei Paesi industrializzati fu colpita da una crisi di proporzioni senza precedenti. La disoccupazione salì a livelli mai raggiunti prima, crollarono i listini di
borsa, fallirono banche e fabbriche, ingenti quantità di merci rimasero invendute, il
commercio internazionale registrò una discesa impressionante. Per oltre un decennio
venne a mancare anche una timida speranza di ripresa.
Le teorie economiche prevalenti, persuase che l’economia tendesse spontaneamente al
pieno impiego, apparivano inadatte a spiegare in modo convincente i fenomeni legati
alla depressione. La situazione imponeva una riconsiderazione critica di tali teorie, che
avvenne a opera di una nuova corrente di pensiero diventata nota come scuola keynesiana, in quanto J. M. Keynes (1883-1946) fu il più famoso dei suoi esponenti.
Altri due grandi economisti, però, con le loro opere giunsero a risultati per molti versi
simili a quelli di Keynes: M. Kalecki (1899-1970) e G. Myrdal (1898-1987).
La teoria di Keynes
Nella sua opera maggiore, la Teoria generale, pubblicata nel 1936, Keynes vuole dimostrare che un’economia di mercato non è in grado di garantire automaticamente
la piena occupazione delle risorse disponibili, e che solo un intervento del settore
pubblico può risolvere questo problema.
Keynes organizza l’analisi economica incentrandola sul comportamento aggregato
dell’economia nel breve periodo.
Il tema centrale è la determinazione del livello di produzione aggregata e dell’occupazione in un’economia di mercato, ovvero l’individuazione delle cause delle fluttuazioni economiche nel breve termine.
Si tratta di un’impostazione opposta a quella della scuola neoclassica, in quanto le
condizioni di funzionamento dell’intero sistema economico non vengono affrontate
semplicemente come somma di risposte individuali, ma in base a un quadro di riferimento generale, che permette alla macroeconomia di emergere come un ambito di
analisi separato dalla microeconomia.
È per questo motivo che la storia della macroeconomia modera inizia con Keynes.
Lo stesso termine macroeconomia, contrapposto a microeconomia, fu coniato in seguito al lavoro di Keynes.
La domanda aggregata
Abbiamo visto che la scuola neoclassica, nella sua componente macroeconomica, dava
per scontata l’accettazione della legge di Say, la quale affermava che la produzione complessiva del sistema economico avrebbe trovato sempre una collocazione sul mercato.
Nel modello keynesiano vale una logica opposta. Nel breve periodo, il livello di produzione totale nel sistema economico è determinato dalla domanda aggregata, cioè
dalla spesa totale per beni e servizi effettuata dagli agenti economici.
Una bassa utilizzazione della capacità produttiva disponibile nell’economia è originata da un’insufficiente domanda aggregata.
Claudio Tangocci Economia politica • © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2012
12
Breve storia del pensiero macroeconomico
Quali siano le cause dell’insufficienza della domanda aggregata è un argomento che
abbiamo affrontato nel volume. Per considerare solo un aspetto di questa tematica,
si può ricordare che per Keynes assume un ruolo determinante la spesa per investimenti proveniente dalle imprese. Gli investimenti sono l’elemento instabile della
domanda aggregata e a essi sono riconducibili le fluttuazioni della produzione e
dell’occupazione.
Il motivo principale dell’instabilità degli investimenti è da ricercare nell’informazione
incompleta a disposizione delle imprese, che rende precarie e variabili le loro aspettative circa i rendimenti futuri corrispondenti ai diversi livelli di investimento.
A sostegno di quest’ultima osservazione concorrono altri aspetti della teoria keynesiana. In particolare, il concetto di domanda di moneta (che Keynes chiamava
preferenza per la liquidità) a fini speculativi, che spiega come la moneta possa influenzare il tasso d’interesse e, quindi, la domanda aggregata, dal momento che il
tasso d’interesse è una delle determinanti degli investimenti.
L’intervento pubblico per combattere la recessione
Per Keynes l’insufficienza di domanda non è una possibilità remota. Al contrario,
con la sua analisi intende proprio dimostrare che l’economia di mercato non produce
automaticamente piena occupazione, e che solo il ricorso all’uso attivo della politica
economica, destinata a manovrare il livello della domanda aggregata, può risolvere
questo problema.
Sotto questo profilo, Keynes enfatizza il ruolo cruciale della politica fiscale espansiva, cioè la scelta dei livelli di tassazione e di spesa pubblica, per combattere le
recessioni. Secondo Keynes una politica fiscale espansiva può avere effetti rapidi e
affidabili, in quanto è in grado di influenzare direttamente la domanda e l’attività di
produzione. Mentre egli ritiene la politica monetaria espansiva, orientata a variare il
tasso di interesse, non altrettanto efficace per contrastare una congiuntura negativa;
nell’ipotesi della trappola della liquidità, addirittura, la politica monetaria è del
tutto inefficace.
Il monetarismo
Le politiche macroeconomiche di gestione della domanda aggregata praticate in molti
Paesi industrializzati dopo la Seconda guerra mondiale hanno permesso di evitare
le situazioni disastrose, in termini di disoccupazione, che avevano caratterizzato gli
anni ’30.
Si noti che la politica di stabilizzazione della domanda aggregata è stata spesso
associata alla costituzione del così detto Stato sociale, cioè a quella forma di Stato
caratterizzata dalla tassazione progressiva del reddito e dalla erogazione, attraverso
apparati amministrativi, di numerosi servizi destinati alla collettività (istruzione, previdenza, assistenza sanitaria ecc.).
Tuttavia, negli anni ’70, la comparsa nelle economie più sviluppate di situazioni in
cui coesistevano un’alta inflazione e un’alta disoccupazione (stagflazione), le difficoltà sempre maggiori che incontravano i governi nel finanziare la spesa pubblica, la
quale molto spesso aumentava per motivi che non erano sotto il controllo e la regolazione deliberata delle autorità pubbliche, come pure l’enorme espansione del debito pubblico, sollevarono numerosi dubbi sull’efficacia delle politiche economiche
incentrate sulla manovra della domanda aggregata e favorirono l’affermarsi di nuovi
indirizzi di pensiero macroeconomico in netto contrasto con la teoria keynesiana.
La sfida teorica più importante è stata condotta da una corrente di pensiero sviluppatasi a partire dagli anni ’70, nota come nuova macroeconomia classica, il cui
esponente più significativo è l’economista statunitense R. Lucas (1937). Ma i primi
Claudio Tangocci Economia politica • © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2012
13
Breve storia del pensiero macroeconomico
rigorosi attacchi contro la teoria keynesiana furono lanciati già a partire dagli anni
’50 dal monetarismo, una corrente di pensiero macroeconomica legata all’economista statunitense M. Friedman (1912-2006) e alla “scuola di Chicago” (così definita
perché ha avuto il suo centro di diffusione nell’università di Chicago).
Il monetarismo è una teoria delle determinanti della domanda aggregata. Come tutte
le scuole di pensiero, si compone di differenti contributi e idee. Ma la tesi essenziale,
comune a tutti gli economisti della scuola di Chicago è che le variazioni della domanda aggregata influenzano prevalentemente il livello dei prezzi.
La percezione dell’inflazione come principale problema degli anni ’70 è stato un
aspetto importante per spiegare l’influenza crescente che questa teoria ha avuto sullo
sviluppo della macroeconomia.
Per il monetarismo i prezzi e i salari non sono rigidi, ma si adattano gradualmente alle
variazioni della domanda aggregata. In virtù di questa relativa flessibilità dei prezzi e
dei salari, il sistema economico tende spontaneamente a raggiungere una posizione
ottimale, che consente il pieno impiego di tutte le risorse produttive, compreso il lavoro
(anche se i monetaristi, per realismo, sono disposti a riconoscere che una certa disoccupazione esiste sempre, ovvero esiste un tasso naturale di disoccupazione dovuto
soprattutto a ritardi e imperfezioni di aggiustamento sul mercato del lavoro).
Il raggiungimento della posizione ottimale può richiedere tempo, ma ciò che conta è
l’intrinseca stabilità di cui è dotato il sistema economico.
Le ragioni di fondo delle fluttuazioni dell’economia sono legate per i monetaristi alle
politiche economiche di gestione della domanda aggregata. Più precisamente, si originano dalla crescita irregolare dell’offerta di moneta, che a sua volta dipende dagli
interventi discrezionali della banca centrale.
Per i monetaristi la domanda aggregata è influenzata principalmente dalle variazioni
dell’offerta di moneta, mentre ritengono che la politica fiscale provochi effetti trascurabili.
Essi ammettono che, nel breve periodo, lo spostamento della domanda determinato
dalla politica monetaria possa esercitare un’influenza sulla produzione e l’occupazione. Ma tali effetti sono temporanei e di modesta entità. Poiché il sistema economico
tende sempre a operare vicino alla piena occupazione, l’effetto principale si esercita
sul livello dei prezzi.
Una regola di politica monetaria
L’inflazione, pertanto, è un fenomeno esclusivamente monetario, dovuto a misure di
politica monetaria inadeguate. L’inflazione non dipende dalle decisioni di prezzo delle imprese, né dal forte potere contrattuale dei lavoratori dipendenti. Gli aumenti del
salario possono verificarsi solo se la banca centrale mette a disposizione la quantità
di moneta necessaria a finanziare tali aumenti. Scelte diverse da parte della banca
centrale spingerebbero le imprese a un comportamento più intransigente nelle trattative, perché cedendo alla richiesta di retribuzioni più elevate disporrebbero di una
quantità di moneta e di credito minore da destinare ad altri scopi.
Le conseguenze sotto il profilo della politica monetaria sono evidenti. Le autorità monetarie, tenendo conto del ritmo di espansione dell’economia, devono annunciare e
mantenere costante il tasso di crescita dell’offerta di moneta (regola della crescita
monetaria costante). Solo in questo modo è possibile dare certezza agli operatori privati, evitare le fluttuazioni del sistema economico e assicurare l’assenza di inflazione.
Le posizioni dei monetaristi, dunque, sono molto lontane dal punto di vista keynesiano. Per Keynes, il sistema economico è instabile, precario, e per questo motivo
affida alle autorità di politica economica il compito di regolare la domanda aggregata.
All’opposto, il pensiero monetarista indica la necessità di evitare forme di discrezionalità nelle scelte di politica economica, per non nuocere all’economia, e in particolare di aderire alla regola della crescita monetaria costante.
Claudio Tangocci Economia politica • © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2012
14
Breve storia del pensiero macroeconomico
L’inesistenza di un trade-off tra disoccupazione
e inflazione nel lungo periodo
La critica del monetarismo a un uso attivo della politica economica si incentra anche sulla curva di Phillips. Negli anni ’60, molti economisti erano convinti che fosse
possibile aumentare il livello dell’occupazione al costo di un’inflazione più elevata
anche nel lungo periodo. Friedman dimostrò che se le autorità di politica economica
avessero cercato di ridurre la disoccupazione a un livello inferiore al tasso di disoccupazione naturale, avrebbero portato a una accelerazione dell’inflazione.
La maggioranza degli economisti, attualmente, condivide l’ipotesi del tasso naturale
di disoccupazione e, quindi, è convinta che la politica economica non possa essere
usata per ottenere una riduzione del tasso di disoccupazione naturale.
5 Gli sviluppi teorici più recenti:
la Nuova macroeconomia classica (NMC)
La NMC, sebbene abbia inizio come tentativo di rendere più esplicite le proposizioni
del monetarismo, introduce dei cambiamenti radicali nel pensiero macroeconomico.
Al centro dell’analisi vengono posti due punti teorici essenziali:
• gli operatori economici formulano le loro aspettative in modo razionale;
• i prezzi sono perfettamente flessibili, cioè si adeguano rapidamente per assicurare condizioni di equilibrio su tutti i mercati, compreso il mercato del lavoro.
Le aspettative sono le previsioni che gli operatori economici formulano in merito
all’andamento futuro delle condizioni economiche. Molte decisioni economiche importanti che gli operatori sono chiamati ad assumere sono orientate dalle aspettative
sul futuro.
Secondo l’ipotesi delle aspettative razionali, gli operatori economici conoscono le modalità di funzionamento del sistema economico e sono in grado di guardare al futuro
utilizzando tutte le informazioni disponibili. Per questa ragione, gli operatori possono
essere considerati soggetti lungimiranti che prevedono correttamente l’assetto futuro,
ossia nel loro insieme formulano aspettative che trovano riscontro nella realtà.
Il punto di forza di questa ipotesi è che un diverso modo di concepire la formazione
delle aspettative (per esempio, che le aspettative si formano sulla base dei precedenti
errori di valutazione) deve ammettere la possibilità che gli operatori commettano
errori sistematici di previsione (per esempio, che sottostimino sempre l’inflazione
quando sale). Questo è difficile da sostenere, perché quando si compie un errore
sistematico diventano potenzialmente disponibili informazioni che possono essere
usate per evitare tale errore.
L’ipotesi delle aspettative razionali combinata insieme con l’ipotesi che i prezzi sono
perfettamente flessibili conduce la NMC a sostenere che la politica monetaria non
ha effetti sulla produzione aggregata, neanche nel breve periodo, perché gli operatori sono in grado di prevedere l’efficacia dell’intervento delle autorità monetarie
e, quindi, di anticiparne l’esito. Per esempio, se le autorità monetarie annunciano di
voler praticare una politica espansiva, le imprese scontano nelle loro previsioni che
tutti i prezzi (che sono perfettamente flessibili) nell’economia aumenteranno immediatamente. Perciò, restando invariati i prezzi relativi, le imprese non varieranno la
quantità offerta e la produzione aggregata non cambierà.
Le politiche economiche prevedibili destinate a manovrare il livello della domanda
aggregata non sono in grado di influenzare la produzione aggregata, ma solo il livello
generale dei prezzi.
Claudio Tangocci Economia politica • © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2012
15
Breve storia del pensiero macroeconomico
Rimane la possibilità che errori di percezione, sbagli di previsione da parte degli
agenti economici, dovuti a fattori imponderabili o a carenze di informazioni, possano
determinare fluttuazioni dell’economia. Si tratta però di situazioni transitorie, brevi,
rispetto alle quali politiche economiche di regolazione della domanda sono inefficaci
oppure, con ogni probabilità, dannose.
La Nuova macroeconomia keynesiana (NMK)
La NMC con aspettative razionali, per asserire l’inefficacia della politica economica,
suppone che i prezzi siano perfettamente flessibili. La risposta di fonte keynesiana
alla NMC ha dato inizio a una nuova scuola di pensiero macroeconomico, nota
come NMK, la cui caratteristica distintiva è supporre che i prezzi e i salari siano
rigidi, oppure che tendano ad aggiustarsi lentamente in risposta a eventuali squilibri
economici.
Secondo la NMK, anche se gli operatori fossero in grado di prevedere correttamente
il futuro, nel caso di prezzi rigidi potrebbero fare ben poco per aggiustarli quando un
mutato stato delle aspettative rendesse indispensabile tale operazione. Per esempio,
se l’inflazione si scosta dalle aspettative precedenti, la NMC afferma che gli agenti
economici, utilizzando le informazioni che sono diventate disponibili, rivedono le
loro aspettative. Ma se hanno stipulato dei contratti che li vincolano a livelli dei
prezzi e dei salari nominali basati su aspettative di inflazione che, sebbene razionali,
si sono formate in un periodo precedente (si pensi, per esempio, a contratti di lavoro
con scadenza a lungo termine), per un certo intervallo di tempo non possono apportare appropriati aggiustamenti ai prezzi e ai salari. Durante quell’intervallo, che può
durare a lungo, la politica economica riacquista efficacia reale, cioè può essere
correttamente attuata per tenere a freno l’ampiezza delle fluttuazioni economiche e
orientare il sistema economico verso situazioni preferite dalla collettività.
Claudio Tangocci Economia politica • © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2012
16