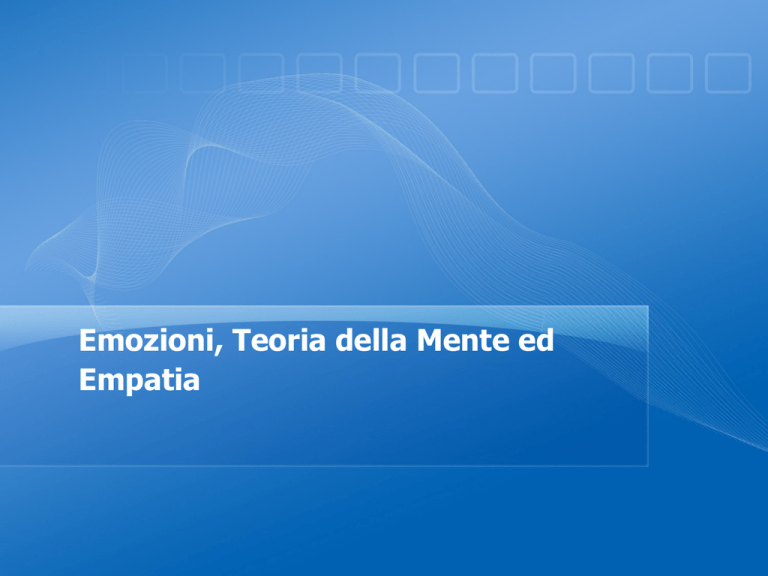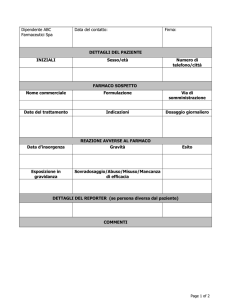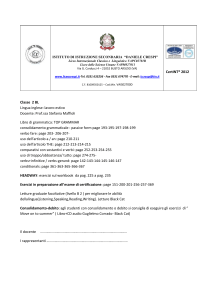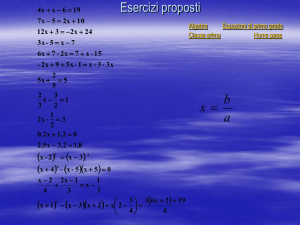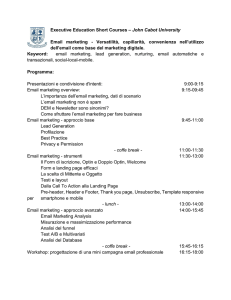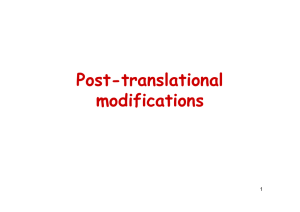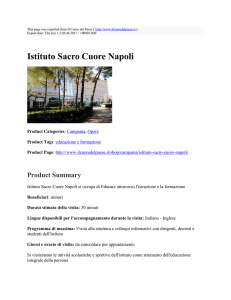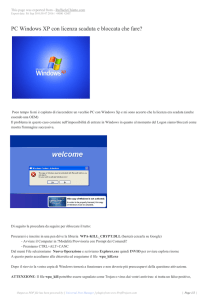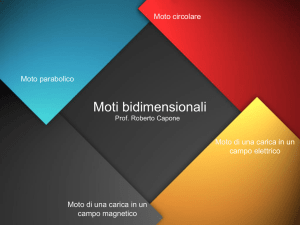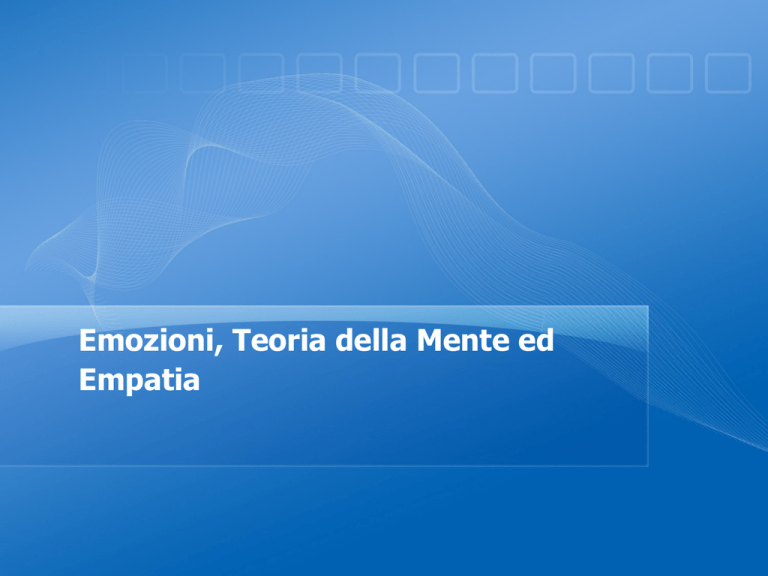
Emozioni, Teoria della Mente ed
Empatia
A seconda che si ponga l'accento sulle reazioni psico-fisiologiche,
sui processi cognitivi che accompagnano le emozioni o sugli
eventi che scatenano le emozioni si avranno delle definizioni del
concetto di emozione piuttosto diverse.
Kleinginna e Kleinginna (1981) hanno tentato di definire il concetto di
emozione nel modo più completo possibile:
"L'emozione è un insieme complesso di interazioni fra fattori soggettivi e
oggettivi, mediati dai sistemi neurali-ormonali, che può:
•suscitare esperienze affettive come senso di
eccitazione, di piacere e dispiacere
generare processi cognitivi come effetti percettivi
emozionalmente rilevanti, valutazioni cognitive, processi di
etichettamento
•attivare adattamenti fisiologici diffusi di fronte a
condizioni di eccitamento
Page 2
TEORIE EVOLUZIONISTICHE
Le emozioni primarie
Sul piano finalistico, le emozioni elementari hanno significato
comunicativo ed adattivo.
Molte di esse si associano anche a precise modificazioni dei
parametri fisiologici, come la temperatura corporea, il battito
cardiaco, la pressione arteriosa e la conduttanza galvanica
cutanea
Le emozioni primarie, per Ekman, sono quelle che hanno un chiaro
radicamento biologico e filogenetico e che presentano nove
caratteristiche ben precise:
Presenza di distinti segnali non verbali
Presenza in altri primati.
Distinte reazioni fisiologiche.
Presenza di eventi antecedenti distinti e universali.
Coerenza tra le risposte emozionali.
Rapida insorgenza.
Breve durata.
Valutazione cognitiva automatica.
Page 3
•L’AFFETTIVITA’ può essere intesa come il colorito soggettivo dei processi
mentali in rapporto alla realtà vissuta, esterna ed interna.
Essa risulta costituita dalla tride:
Emozione: stato affettivo intenso, a insorgenza e declino rapidi,
legato alla presenza di stimoli esterni od interni e accompagnato da
fenomeni vegetativi.
Sentimento: stato affettivo più duraturo e meno intenso, più
spesso legato ad esperienze mentali interne (pensiero, memoria,
immaginazione...).
Umore: stato affettivo di base che sottende il fondo su cui
nascono emozioni e sentimenti. Esempio: umore depresso >
tristezza (emozione)
• Per gli anglosassoni, invece, la principale differenza tra emozione
(emotion) e sentimento (feeling) è che il primo solitamente riferisce
alla sola componente somatica dell’esperienza emozionale, mentre il
Page 4
secondo ne costituisce la componente cosciente.
RABBIA
FELICITA’
SORPRESA
TRISTEZZA
DISGUSTO
PAURA
Le emozioni primarie
Le emozioni primarie individuate in base alle nove caratteristiche sono sei:
Paura
Rabbia
Tristezza
Felicità
Disgusto
Sorpresa. Page 6
Le emozioni primarie
In una rassegna di
letteratura,
Kemper (1987)
elenca le emozioni
primarie che sono
state proposte.
Per Kemper vi sono
almeno 4 emozioni
primarie a base
fisiologica: paura,
rabbia, tristezza e
soddisfazione.
Page 7
TEORIE FISIOLOGICHE
• T. Periferica di James-Lange: 1884, “le emozioni derivano dalla
percezione delle modificazioni fisiologiche indotte dallo stimolo”.
Teoria che cercò di sfidare il senso comune che piangiamo perché
siamo tristi o che il nostro cuore batte più forte perché siamo
arrabbiati; per questi studiosi era tutto il contrario. Poco sostenuta
perché:
non spiega come le emozioni possono persistere allo stimolo che le
ha generate
non fornisce nessuna spiegazione dell’esperienza cognitiva
• T. Centrale di Cannon-Bard: 1928, misero in dubbio la teoria di JamesLange e sottolinearono l’importanza del talamo e dell’ipotalamo
nell’emotività; queste strutture avrebbero una duplice funzione:
induzione delle risposte comportamentali periferiche e proiezione delle
informazioni sensoriali alla corteccia, ove ne avrebbe luogo
l’elaborazione cognitiva.
Page 8
TEORIE COGNITIVE
•
•
T. dell’Apprezzamento Cognitivo della Arnold: anni ’60, sostiene che perché uno
stimolo produca un’esperienza emozionale, il cervello ne deve prima valutare
l’importanza, anche a livello subconscio; tale valutazione porterà poi ad una
certa tendenza all’azione, da dove deriverà l’emozione. Sottovaluta l’importanza
delle risposte somatiche, perché non considera necessario l’avvenire dell’azione
(risposta comportamentale).
T. dell’Apprezzamento Cognitivo di Lazarus: anni ’90, sottolinea che le nostre
emozioni dipendano da come la nostra coscienza interpreta le condizioni in cui
si verificano. Per Lazarus, la cognizione è una condizione sia necessaria sia
sufficiente per l’emozione. Anche questa teoria sottovaluta l’importanza delle
reazioni somatiche.
Ipotesi del Marcatore Somatico di Damasio: anni ’90, è una rielaborazione di
quella di James-Lange e di Schachter-Singer. Per Damasio, le emozioni sono il
risultato dell’interpretazione delle reazioni somatiche in risposta a determinati
stimoli ambientali. Ogni esperienza somatica viene etichettata come piacevole
o spiacevole e di seguito associata ad un contesto ambientale che ne provoca
l’insorgenza: in questo modo si formano dei marcatori somatici, che possono
essere riattivati ogni volta che l’organismo si trova ad affrontare situazioni
Page simili
9
a quelle che ne hanno determinato la formazione. Attualmente questa
teoria gode di largo credito.
•
Emozioni
Le emozioni sono modificazioni del sistema motorio
e viscerale
elicitate da stimoli interni ed esterni all’individuo (all’organismo).
La struttura classicamente associata alle emozioni è il Sistema Limbico
più recentemente gli studi hanno evidenziato il ruolo fondamentale di
strutture quale l’AMIGDALA, e del ruolo della CORTECCIA in particolare
del LOBO dell’Insula.
Page 10
Page 11
SISTEMA MOTORIO ED EMOZIONI
.
•
•
G. Duchenne fu tra i primi a progettare modelli di ricerca sulla genesi delle espressioni
facciali: nel 1862 gli capitò un paziente con paralisi facciale, capace di sopportare la
stimolazione elettrica dei muscoli del viso.
Il sorriso è una delle modalità espressive più utili per studiare l’origine della mimica
emotiva:
siamo capaci di controllare intenzionalmente i muscoli periorali
ma non abbiamo nessun controllo sulla muscolatura periorbitale
esiste spesso una leggera asimmetria dell’espressività nella metà sinistra della
faccia
conclusioni:
1. esistono circuiti separati per
l’innervazione volontaria e spontanea
della faccia
2. il controllo della mimica emotiva è
Page 13
soprattutto
a carico dell’emisfero DX.
Sorriso
finto
Sorriso
vero
Rimuovendo gli emisferi cerebrali ai gatti essi reagivano a degli stimoli dolorosi non con
la fuga o l'evitamento (come succede normalmente) ma con un comportamento di
rabbia, definita pseudorabbia, che si distingue dalla rabbia normale perché l'animale
attacca qualsiasi cosa gli capiti sotto tiro e si estingue immediatamente con il cessare
dello stimolo.
Esperimenti di pseudo-rabbia
(Philip Bard, 1928)
Vista medio-sagittale dell’encefalo di
un gatto che mostra le regioni
essenziali per l’espressione dei
comportamenti emotivi.
A) La sezione trasversale attraverso il
mesencefalo, disconnettendo
l’ipotalamo dal tronco encefalico,
abolisce la “pseudo-rabbia”.
B) Le risposte emotive integrate
associate con la “pseudo-rabbia”
sopravvivono alla rimozione degli
emisferi cerebrali fintanto che
l’ipotalamo caudale rimane intatto.
Nel 1948 W.Hess stimolando diverse zone dell’ipotalamo indusse
comportamenti differenti
La stimolazione elettrica dell’ipotalamo laterale del gatto provocava ira
La lesione dell’ipotalamo laterale del gatto provocava docilità
L’ipotalamo è critico per regolare le risposte corporee legate alle emozioni
Ipotalamo
Svolge funzioni di
integrazione delle
informazioni provenienti
dal prosencefalo, dal
tronco dal midollo
spinale e da vari
neuroni intrinseci
chemiosensibili
Controlla Flusso sanguigno, il metabolismo energetico, l’attività
riproduttiva, la coordinazione delle risposte a condizioni ostili.
Page 17
SISTEMA LIMBICO
Page 18
Circuito di papez
Circuito di Papez
Corpi mamillari
N. Anteriore del
talamo dorsale
Giro Cingolato
Ippocampo
Fornice
Page 19
Successivamente Corteccia prefrontale mediale e orbitale
Parte ventrale dei gangli della base
Talamo nucleo medio dorsale
Amigdala e Corteccia Paraippocampale
Sistema Limbico
Page 20
Sindrome di Kluver Bucy e gli esperimenti di Jhon Downer 1950
Jon Downer 1950
Resezione chiasma ottico e
amigdala mono laterale
R Normale in presenza Amigdala
R Kluve –Bucy assenza Amigdala
R normale Tatto
Page 21
Amigdala
GRUPPO MEDIALE BULBO OLFATTIVO
CORTECCIA OLFATTIVA
GRUPPO BASALE LATERALE
GRUPPO CENTRALE IPOTALAMO
TRONCO ENCEFALICO
Page 22
ESPERIMENTI SUI RATTI DI CONDIZIONAMENTO CLASSICO LEDEUX
RUOLO DELL’AMIGDALA
Page 23
Figure 29.12 Activity of ventral tegmental area
dopamine neurons during stimulus–reward learning
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Biology and the future of Psychoanalysis
1.
la natura dei processi mentali inconsci memoria non
dichiarativa
2.
la natura della causalità psicologica condizionamento
classico inteso come previsione probabilistica di un evento a
partire da uno stimolo
3.
la causalità psicologica e la psicopatologia il ruolo
dell’amigdala nella genesi delle emozioni
4.
le esperienze precoci in quanto fattori di predisposizione alla
malattia mentale le prime relazioni e la risposta biologica
allo stress
5.
la correlazione tra preconscio e inconscio e la corteccia
prefrontale,
6.
l'orientamento sessuale,
7.
la psicoterapia ed i cambiamenti strutturali del cervello,
8.
la psicofarmacologia come strumento coadiuvante la
psicoterapia.
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
ToM Significati
Nell'ambito della "Filosofia della Mente", il modello ontologico e
strutturale dei processi mentali
In psicologia cognitiva, come equivalente del modello del
funzionamento della psiche.
•In psicologia dell'apprendimento e psicologia del pensiero, è stato
spesso usato come analogo di "metacognizione" (ovvero di
capacità osservativa ed automodulante dei propri stessi processi
cognitivi)
•In psicologia clinica, come equivalente funzionale delle "Funzioni
del Sè riflessivo".
•In psicologia dello sviluppo, epistemologia genetica e psicologia
dinamica, come la capacità del bambino di costituirsi una
rappresentazione adeguata dei processi di pensiero propri e
dell'Altro significante.
Page 38
Metacognizione
La metacognizione indica un tipo di autoriflessività sul fenomeno
cognitivo, attuabile grazie alla possibilità - molto probabilmente
peculiare della specie umana- di distanziarsi, auto-osservare e
riflettere sui propri stati mentali. L'attività metacognitiva ci
permette, tra l'altro, di controllare i nostri pensieri, e quindi anche
di conoscere e dirigere i nostri processi di apprendimento.
In termini cognitivi, è la fondamentale capacità umana di
comprendere e riflettere sul proprio e l'altrui stato mentale, e sulle
proprie ed altrui percezioni, riuscendo così a prevedere il proprio e
l'altrui comportamento. È questo il significato che viene sviluppato
nell'ambito degli studi metacognitivi.
La percezione comprende sensazioni, credenze, sentimenti, disagi,
etc. Tale abilità cognitiva si acquisisce normalmente intorno ai 3-4
anni e gli adulti ne fanno uso nella vita di tutti i giorni senza averne
consapevolezza.
Page 39
Neuroscienze Sociali
Identificare le strutture cerebrali dell’interazione sociale sarebbe
stato considerato improbabile o ridicolo solo 20 anni fa.
La ricerca sul comportamento degli scimpanzé Premackand
Woodruff (1978),ha dato un grande impulso allo sviluppo della
teoria della mente, ma ancora oggi non siamo in grado di
rispondere alla domanda se gli animali hanno una ToM.
Gli studi animali hanno permesso di identificare i neuroni
specchio (Rizzolati) che hanno importanti funzioni nei processi
sociali che sono implicati nei processi di imitazione, risonanza
emotiva ed empatia.
Anche le ricerche sui processi decisionali in economia che hanno
investigato i processi di fiducia ed altruismo hanno prodotto
conoscenze nell’ambito del cervello sociale
Page 40
Neuroscienze Sociali
Le persone reagiscono automaticamente ad un volto spaventato con un
reazione di paura
Questo è vero anche se il viso è mascherato in maniera che il soggetto
non sia consapevole dell’espressione di paura
Il pregiudizio razziale con una risposta di paura alla vista di un uomo di
colore è associata ad una attivazione dell’amigdala. Questa reazione è
maggiore se lo stimolo compare per un tempo molto breve (30ms) e
tende a decrescere se lo stimolo è presentato per un tempo più lungo
(535ms)
Page 41
L’amigdala
LeDoux _ L’amigdala riceve
due tipi di connessioni
Via Corticale _ riceve afferenze
dalle aree secondarie_ ricca
di informazione_ conceptual
level Leventhal
Via sottocorticale Talamica _ dai
nuclei posteriori del talamo
all’amigdala _ povera di
informazione sullo stimolo _
risposta emotivamente
indifferenziata_schematic
level Leventhal
Page 42
Paul J. Whalen et al. Masked Presentations of Emotional Facial
Expressions Modulate Amygdala Activity without Explicit Knowledge J.
Neurosci., Jan 1998; 18: 411 - 418
Page 43
I soggetti erano esposti alla visione di volti spaventati, felici
e neutri. I volti spaventati e felici non erano percepiti perché
Presentati per un tempo inferiore ai 33 msec. Il confronto tra
queste due condizioni mascherate tuttavia mostra una attivazione
dell’amigdala che risponde ai volti spaventati
Cunningham WA et al.,Separable neural components in the processing of
black and white faces. Psychol Sci. 2004 Dec;15(12):806-13.
Aumento del segnale per volti
presentate a 30ms
Aumento del
segnale
a 535 ms
Page 44
ToM Sviluppo Baron- Choen
Condividere
l’attenzione
Gioco
Simbolico
Vedere
per credere
Test della
falsa
credenza
Sapere che
cosa ferisce
l’altro
Page 45
14 mesi
24 mesi
3 anni
4 anni
9 anni
ToM- Seguire lo sguardo
Page 46
ToM - Test di Sally
La capacità di identificare le false credenze è già presente a 3 anni. Nei
bambini autistici questo non avviene. Tuttavia in una parte di questi soggetti
è in grado riconoscere le false credenze mediante processi
di apprendimento formali
Page 47
Page 48
Page 49
Disturbi pervasivi dello sviluppo
I Disturbi Pervasivi dello Sviluppo sono caratterizzati da compromissione
grave e generalizzata in diverse aree dello sviluppo:
capacità di interazione sociale reciproca,
capacità di comunicazione, o presenza di comportamenti, interessi, e
attività stereotipate.
Le compromissioni qualitative che definiscono queste condizioni sono
nettamente anomale rispetto al livello di sviluppo o all’età mentale del
soggetto.
Disturbo Autistico,
Disturbo di Rett,
Disturbo Disintegrativo dell’Infanzia,
Disturbo di Asperger,
l Disturbo Pervasivo dello Sviluppo NAS
Page 50
How the Mind reads other Minds
Solco temporale superiore si attiva
alla visone di un movimento
umano, es del braccio
Il polo del temporale è
essenziale nel recupero di
memorie
Porzione anteriore del giro del
cingolo, Gioco Morra, Discriminazione
Attribuzione intenzionalità, distinzione Sé Altro
Gallagher HL, Frith CD. Functional
imaging of 'theory of mind'.
Trends CognSci. 2003 Feb;7(2):77-83.
Page 51
Amigdala
Test che indagano le funzioni attentive e frontali
Page 52
Trail Making Test B
Page 53
Wisconsin Card Sorting Test
1) 1.CFNA
2) ../. CFNA
3) ..1. CFNA
Page 54
4) ../ CFNA
ToM nei pazienti con Variante Frontale della Demenza
Fronto temporale (FvFTD)
FB False Belief del primo livellotest di selly
In questo caso Sally, all’insaputa di Ann, sbircia e vede
FB secondo livello : dove Ann sposta l’oggetto.
– Quando Sally ritorna, Ann
penserà che Sally cercherà
l’oggetto …
Faux pas Test
Mind in the Eyes
Page 55
Gregory C, et al Theory of mind in patients with frontal variant frontotemporal dementia and
Alzheimer's disease: theoretical and practical implications. Brain. 2002Apr;125(Pt 4):752-64.
Mind in the Eyes
Scherzoso Consolatorio Irritato Annoiato
Irritata Ostile Esterrefatta Preoccupata
Terrorizzato Sconvolto Arrogante Irritato
Inorridita Sognante Impaziente Allarmata
Page 56
http://www.glennrowe.net/BaronCohen/Faces/EyesTest.aspx
ToM nei pazienti con Variante Frontale della Demenza
Fronto temporale (FvFTD)
Page 57
Working Memory
Alcune evidenze mostrano che
pazienti
con grossolane alterazioni della
memoria a lungo termine erano in
grado di ricordare racconti di 20
item superando sia del loop
fonologico sia l’estensione del
taccuino visuo spaziale. Per questo
nel 2000 Baddeley descrive un
modulo in grado di integrare le
informazioni provenienti da diverse
strutture
sensoriali
e
di
interfacciarsi con i moduli i
strutturali della memoria a lungo
termine.
Page 58
Working Memory
È la memoria a breve termine, opera nello spazio di alcuni secondi ; è la
memoria che usiamo costantemente, qella che è sempre “in linea”
quando dobbiamo comprendere qualcosa o risolvere un problema o
fare un ragionamento. Il concetto emerge negli anni intorno al 1960
discutendo su casi di pazienti con amnesie ma che presentavano una
capacità intatta a ricordare immediatamente serie di numeri.
La memoria di lavoro può essere considerata come un “ingresso” per la
memoria a lungo termine;
Si pensa anche che potrebbe essere composta da alcuni sotto insiemi:
Una memoria breve centrale di piccola capacità, una specie di agenda per
appunti;
Un circuito riverberante fonologico che permette di tenere a mente un
piccolo numero di informazioni linguistiche, non necessario all’accesso
alla memoria a lungo termine;
Un circuito riverberante per le informazioni visuospaziali.
Page 59
Tasks di working memory
RST READING SPAN TEST
I soggetti dovevano giudicare se
ogni frase era semanticamente
vera
o
falsa
mentre
contemporaneamente
memorizzavano una parola target.
Il target era sottolienato. Ogni
blocco consisteva di 5 frasi, dopo
di
che
ogni
tre
secondo
comparivano tre parole tra le
quali poteva esserci una delle
parole target
READ CONDITION i soggetti
dovevano leggere le frasi e
decidere se erano vere o false
CONTROL PERIOD i soggetti
schiacciavano il tasto dx se la
parola compariva a dx o a sx se
compariva a sx
Page 60
Osaka M. et al. Neuroimage 18 (2003)
Working memory e attivazione cerebrale
Page 61
Osaka M. et al. Neuroimage 18 (2003)
Page 62
Localizzazionismo vs Connessionismo
Bullmore, E. and O. Sporns 2009.
"Complex brain networks: graph
theoretical analysis of structural
and functional systems.
" Nat Rev Neurosci 10(3): 186-98.
Page 63
Il ruolo dell’Amigdala in ToM
Page 64
ToM ed Empatia sono la stessa cosa?
Carl Rogers
Percepire la matrice dei riferimenti interni di un altro come se si fosse l'altra
persona ma senza perdere la condizione come se.
Entrare nella nella percezione private del mondo di unaltro, come andare
nella sua casa
Baron choen il collante della vita sociale
Shamansurdan un atteggiamento di apertura mentale e tolleranza per
l'ambiguità e la complessità.
Page 65
Neuroni specchio
I neuroni specchio sono una particolare classe
di neuroni visuomotori, orginariamente scoperti
nell'area F5 della corteccia premotoria dello
simpanzé, che scaricano quando la scimmia fa una
particolare azione o quando osserva un altro
individuo (uomo o scimmia) fare la stessa azione
I neuroni specchio scaricano solo quando vi è una interazione tra un
effettore biologico (mano o bocca)e un oggetto (che può appartenere a
diverse classi). L'effetto non cambia se l'azione è osservata da vicino o da
lontano, o se l'azione permette di ricevere una ricompensa. I neuroni
specchio che codificano per lo stesso tipo di stimoli si distinguono due
classi a stretta congruenza a congruenza allargata, questi ultimi scaricano
anche quando l'azione è simile ad uno specifico target.
Page 66
Neuroni specchio
Page 67
Neuroni specchio
La parte superiore
dell'area F5 codifica
per i movimenti della
mano mentre quella
laterale ed inferiore
per quelli della bocca I
ns in questa zona si
dividono di ingestione e
comunicativi Nella
scimmia i primi sono
più numerosi (80%).
Page 68
Neuroni specchio
Page 69
Vi sono altre aree dove si trovano neuroni connessi con i
specchio. Nel solco temporale superiore (STS) vi sono dei
neuroni che si attivano in relazione all'osservazione di
determinate azioni: camminare, girare la testa, curvare il
busto, muovere il braccio.
Neuroni specchio
Page 70
Vi è un'altra area nella quale vi sono i neuroni specchio ed è
la PF ossia la parte rostrale del lobo parietale inferiore. che
riceve imput dalla STS e li invia alla F5.La funzionalità dei
neuroni parietale è piuttosto varia, nel 90% dei casi essi
scaricano per stimoli sensoriali, ma il 50% scarica anche dei
casi quando vengono effettuati dei movimenti.
Azione e comprensione
I NS permettono di apprendere dei comportamenti per imitazione.
L’imitazione è già una forma di comprensione.
Ulteriore conferma di processi di comprensione deriva dal dato che
I NS si attivano anche in assenza di stimoli visivi infatti il 15%
dell’area F5 rispondono anche a stimoli di tipo sonoro es
(Stracciare la carta).
Esperimento di Umiltà MA, Kohler E, Gallese V, Fogassi L,Fadiga L,
et al. 2001. “I know what you are doing”: a neurophysiological
study. Neuron32:91–101
Page 71
Azione e comprensione
Page 72
I neuroni specchio nell’uomo
Studi elettrofisiologici hanno dimostrato Potenziali evocati Motori in
regione frontale quando il soggetto osservava un modello che
eseguiva un gesto di prensione.
A differenza delle scimmie nell’essere umano i neuroni specchio,
con le loro caratteristiche di attivazione corticale, sembrano
intervenire anche nel processo di preparazione dell’azione aspetto
essenziale nei processi di imitazione.
Page 73
Neuroimaging
Page 74
Neuroimaging
La maggiore attivazione frontale
zona opercolare della corteccia
frontale inferiore specie a sinistra
probabilmente dipende
dall’attivazione di programmi
motori di gesti che i soggetti sono in
grado di riprodurre.
Page 75
Mirror neurons nell’uomo
Lobulo parietale inferiore
Giro frontale inferiore
(Pars Opercularis) area 44
Corteccia premotoria adiacente
Page 76
Mirror neurons e linguaggio
Il sistema dei neuroni a specchio ha un grande vantaggio: La sua
semantica è inerente al gesto usato per comunicare. Questo
manca nella parola dove la relazione tra suono e significato è
convenzionale.
Ma il movimento delle mani e delle braccia e il linguaggio sono
legati dal medesimo substrato neurologico.
Gentilucci (2001) ha dimostrato che i movimenti di prensione sono
correlati alla dimensione dell'oggetto, tanto più grande è l’oggetto
tanto è maggiore la velocità. Inoltre quando i soggetti dovevano
emettere un suono mentre prendevano l'oggetto aumentavano
inconsapevolemente il volume della voce in relazione alla
grandezza dell’oggetto.
E' probabile che da un punto di vista evoluzionistico il gesto abbia
preceduto il linguaggio e quest'ultimo si sia sviluppato a partire
proprio dall'associazione tra gesto e suono.
Page 77
Mirror Neurons ed empatia
Il termine empatia si riferisce alla capacità di
percepire,immaginare e avere una comprensione diretta degli
stati mentali e dei comportamenti altrui.
Recenti evidenze supportano l'ipotesi di molteplici “sistemi
neurali risonanti” analoghi al sistema mirror per le azioni,
coinvolti nella simulazione interna degli stati emotivi e percettivi
delle altre persone. Ad esempio, è stato recentemente
dimostrato che osservare espressioni facciali di disgusto in altre
persone attiva quei settori dell'insula anteriore (AI)e della
corteccia anteriore del cingolo (ACC) che sono attivi quando si
prova disgusto in prima persona .
Page 78
“EMBODIED SIMULATION”
Page 79
(SIMULAZIONE INTERNA)
Page 80
Mirror neurons ToM teoria E-S
Punti di forza della teoria
Limiti
Alterazioni della pragmatica del
linguaggio.
Non spiega gli aspetti non sociali,
es focalizzazione dell’attenzione
Indipendente dall’età e dal QI
ToM = da empatia che comporta
anche l’intensità emozionale
Network cerebrale identificabile:
Corteccia prefrontale, giunzione
parieto temporale, giro del
cingolo anteriore, amigdale e
insula
Possibilità di predire un disturbo
dello spettro autistico. (12/24m)
Sviluppo di interventi appropriati
Page 81
Alterzioni della ToM sono presenti
anche in altre patologie come la
schizofrenia, disturbi borderline, ed
alcuni disturbi dello sviluppo
Alcuni studi non hanno evidenziato
alterazioni della ToM nei disturbi
autistici, probabilmente perché non
hanno valutato gli elementi di
compenso
La Teoria si focalizza sui limiti più
che sui punti di forza
Teoria E – S
Empatia - Sistematicità
Difficoltà della socializzazione come deficit dell’empatia ed eccesso di
utilizzo di un approccio sistematico
ToM non contempla un elemento fondamentale nell’empatia ossia
l’appropriatezza della risposta emotiva agli stati interni dell’altro.
Sistematicità, si intende la spinta a ad analizzare e costruire sistemi di
conoscenza, dove ogni elemento ha un ruolo definito: sistemi meccanici,
numerici, linguistici (regole della sintassi) sociali (gerarchia) motori
(organizzazione di un certo movimento).
Esistono due scale che valutano sia la capacità di empatia Empathy
Quotient (EQ), sia la tendenza alla sistematicità Sistemizing Quotient
(SQ).
Page 82
Teoria E – S
Page 83
Empatia - Sistematicità