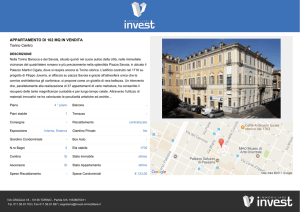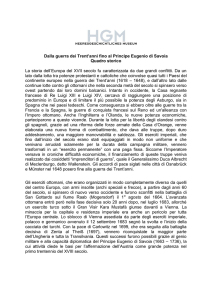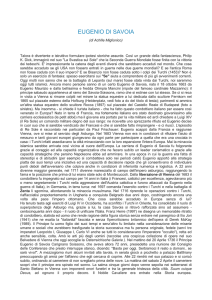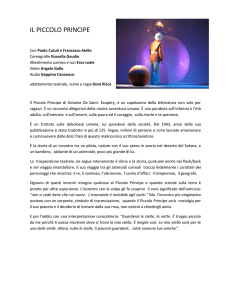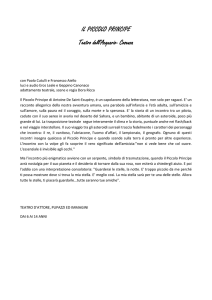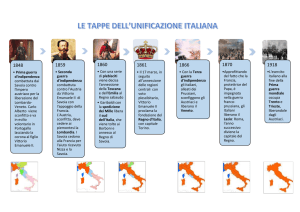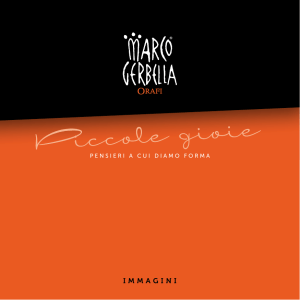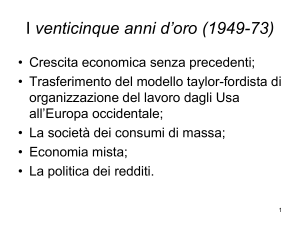N 47 – Anno XXII – Settembre 2016 – Pubblicazione riservata ai soli Soci
La storia di un sigillo amministrativo
Quante volte mi è stata rivolta la domanda sul perché io possa
amare la storia, oppure se valga veramente la pena dedicare il
tempo libero allo studio dell’araldica. Ora mi sovvengono
ricordi con risposte fin troppo ridondanti di motivazioni.
Mentre, giunto al termine di questa ricerca mi giunge più
facilmente alle labbra la spiegazione di quanto mi viene
domandato; oggi appare semplice e chiaro il vero fine delle
nostre appassionati ricerche. Infatti, seppur da semplice dilettante, proprio grazie a queste mie appassionate letture, sono in
condizione di dare un senso storico ad un oggetto che ben
rappresenta la grande quantità di cui la nostra Italia è cosi
ricca. E di non ultima importanza ho la fortuna di poter trovare
un’associazione di appassionati che, come me, condividono la
passione per la ricerca e per queste piccole scoperte, che donano una grandissima soddisfazione.
Viviamo in una nazione dotata di un patrimonio vasto ed inestimabile, un paese che ha dissipato moltissimo delle sue
bellezze e che, in molti casi, ha addirittura scelleratamente e
volontariamente distrutto tantissimo, ma che ancora oggi conserva infinite testimonianze storiche tangibili.
Così come spesso accade a noi appassionati cultori, mi sono
imbattuto in un oggetto che merita a mio avviso la nostra
attenzione.
L’oggetto che mi ha catturato e che intendo descrivere è un
semplice sigillo da ufficio, entrato recentemente in una collezione privata lombarda e che, a mio avviso, rappresenta
l’enorme potenzialità di narrazione storica, contenuta in
manufatti spesso a torto considerati come documenti minori.
Non ci resta che analizzare queste capsule del tempo per
scoprire un racconto storico di sorprendente interesse.
Questo sigillo è stato realizzato in ottone, una lega di rame e
zinco e presenta una forma ovale; costituito dal consueto
corpo matrice su cui sono incise lettere ed immagini ed una
corona metallica superiore atta a contenere il manico.
Oggi, l’oggetto in questione risulta privo dell’ impugnatura,
una mancanza piuttosto comune nei tempi passati. Questa
situazione era dovuta alla consuetudine tipica dell’esercizio
concreto della buona amministrazione dei patrimoni, che suggeriva il riciclo delle impugnature dei sigilli spesso realizzate
in legni rari o costosi come il legno di bosso. Un legno duro e
pregiato dal colore giallo o marrone chiaro, che per la sua caratteristica di durabilità meritava il recupero.
Infatti, al momento del cambio d’autorità o proprietà era
consuetudine ricevere dall’ente preposto un nuovo sigillo dotato della nuova matrice che veniva completato per l’uso con
l’impiego del vecchio manico.
Il sigillo veniva considerato il più importante mezzo di prova
per la genuinità e per il valore giuridico dei documenti e, seppur oramai fuori uso, spesso veniva conservato nel medesimo
archivio che aveva deciso di sostituirlo. Perché da quest’ oggetto era possibile anche a distanza di tempo, continuare ad
avvalorare l’autenticità documentale. Il sigillo in questione
viene definito dagli specialisti di archivistica di tipo aderente e
fu realizzato per essere impiegato con la ceralacca. Infatti,
fino al sec. XVI le impronte del sigillo furono realizzate in
prevalenza in metallo o in tenera cera; solo in seguito s’iniziò
ad usare la ceralacca (XVII – XIX sec). Infine, in epoca
moderna si ebbe la sostituzione dei sigilli con timbri in metallo o gomma che impiegano inchiostri nero o di altro colore.
La matrice centrale risulta incisa con uno stemma piuttosto
complesso di buon gusto e realizzato graficamente secondo i
dettami della moda araldica tedesca. La scritta posta nel contorno come si conviene per un sigillo pubblico recita testualmente.:
Scrittura maiuscola capitale o meglio lapidario romano
“AMNE DI S.A.R. IL P. EUG. DI LEUCHTENBERG
IN SENIGALLIA” entro ovale verticale a due filetti continui.
Nel campo stemma principesco con padiglione.
Così, con l’aiuto di quest’oggetto, iniziamo un viaggio storico
sorprendente, che ci condurrà ad alcune vicende storiche
piuttosto singolari. Per conoscere meglio quest’oggetto sarà
utile principiare con metodo e quindi dall’analisi del titolo
feudale riportato. Il Duca di Leuchtenberg fu un titolo che fu
creato storicamente per ben due volte, dai sovrani di Baviera
con lo scopo di onorare i propri parenti.
La prima creazione fu assegnata da Massimiliano I, elettore di
Baviera a suo figlio Massimiliano Filippo Girolamo, alla cui
morte senza figli le terre passarono a suo nipote l'Elettore
Massimiliano II. In seguito il titolo fu ricreato da Massimiliano I Giuseppe, Re di Baviera il 14 novembre 1817 e concesso
al genero Eugenio di Beauharnais.
Mi sembra utile accennare qualche nota su Massimiliano
Giuseppe. Quest’ultimo il 1º aprile 1795 succedette al fratello, Carlo II, come duca del Palatinato Zweibrücken, ed in
seguito il 16 febbraio 1799 divenne principe elettore di Baviera e conte palatino del Reno, a causa dell'estinzione della
casata dei Wittelsbach-Sulzbach avvenuta con la morte
dell'elettore Carlo Teodoro. Le sue simpatie per gli ideali
francesi dell'illuminismo furono presto note a tutti. Infatti,
nella riorganizzazione dei ministeri, il conte Massimiliano
Giuseppe di Montgelas, che in precedenza era caduto in
disgrazia sotto Carlo Teodoro, ritrovò l’incarico di segretario
personale di Massimiliano, divenendo un personaggio influente in grande vicinanza con la Francia.
Massimiliano Giuseppe sin dal 1803 divenne uno dei più importanti alleati tedeschi di Napoleone; un’alleanza che fu definitivamente suggellata con il matrimonio della figlia maggiore di Massimiliano con Eugenio di Beauharnais.
In cambio dell’amicizia e dell’alleanza con Napoleone, Giuseppe ottenne con il trattato di Presburgo (26 dicembre
1805), il titolo regale per la Baviera ed alcuni territori come
Svevia e Franconia situati attorno al proprio regno.
Assumendo definitivamente la corona il 1º gennaio 1806. Il
nuovo re di Baviera fu una delle personalità più influenti degli
stati facenti parte della Confederazione del Reno, e rimase
alleato di Napoleone sino alla battaglia di Lipsia dove, grazie
al trattato di Ried (8 ottobre, 1813), mantenne l'integrità dei
propri domini. Successivamente, con il trattato di Parigi (3
giugno 1814), dovette cedere il Tirolo all'Austria in cambio
del formale ducato di Würzburg. Al Congresso di Vienna, a
cui partecipò personalmente, Massimiliano dovette fare numerose ed ulteriori concessioni all'Austria, cedendo Salisburgo e la zona del fiume Inn con Hausruck in cambio del
vecchio Palatinato. Il re si batté in modo arduo per mantenere
l'integrità dei domini bavaresi, ma fu costretto a rinunciare ad
una possibile successione al granducato di Baden per ordine
di Metternich. Massimiliano morì al castello di Nymphenburg, presso Monaco, il 13 ottobre 1825 e gli successe il
figlio Luigi I.
Compresa l‘origine del titolo a la fons honorum di provenienza ritengo utile indagare più approfondi-tamente sul
duca di Leuchtenberg cercando anche di comprendere meglio riguardo alla legittimità del trattamento di Principe, così
come citato dal sigillo.
Eugène nacque il 3 settembre 1781 a Parigi e fu il figliastro
adottivo del deposto Imperatore Napoleone I di Francia, e
figlio di Alexandre François Marie, Visconte de Beauharnais,
nato a Fort-Royal Martinique, il 28 Maggio del 1760. La
famiglia aveva diversi rami si suppone originaria del ducato di
Bretagna. Molti illustri componenti della Casata sono ricordati
per aver ricoperto incarichi prestigiosi nella marina reale e
nell’amministrazione delle colonie francesi in America. Il
Visconte Alexandre de Beauharnais, padre di Eugene, era un
militare di carriera. Egli entrò in servizio nella « 1re compagnie des mousquetaires » e in seguito nel 1775, fu nominato sottotenente nel Reggimento de Sarre-Infanterie e
partecipò all’assemblea Costituente . Nominato generale nel
1792 (durante le guerre della Rivoluzione francese), si
rifiutò, nel giugno del 1793, di divenire ministro della Guerra.
Venne in seguito nominato generale in capo delle Armate
rivoluzionarie del Reno nel 1793. Successivamente arrestato
venne ghigliottinato dal terrore giacobino a Parigi, il 23 luglio
1794. Alexandre venne ghigliottinato, insieme al fratello
Augustin, nella Place de la Révolution, l'attuale Place de la
2
Concorde, solo cinque giorni prima della caduta e decapitazione del suo persecutore, Robespierre.
Nella stessa prigione fu rinchiusa anche la moglie Giuseppina,
arrestata il 21 aprile 1794, ma quest’ultima venne liberata tre
mesi dopo, grazie all'interessamento personale dello stesso
Robespierre. Eugenio crebbe nell’era turbolenta della rivoluzione si trovò al centro degli eventi quando la madre si
sposò con il giovane generale Bonaparte nel 9 Marzo 1796.
Napoleone prese Eugenio come proprio aiutante di campo e lo
portò con sé in Egitto. Il colpo di Stato del 18 brumaio, con il
quale divenne console, lanciò nel firmamento europeo pure
Eugenio, ormai divenuto giovane ufficiale. Eugenio era
presente a Marengo e, con la proclamazione dell'Impero, il 18
maggio 1804, fu nominato grand'ufficiale della Legion
d'onore, generale di brigata e colonnello generale dei
cacciatori della guardia. Anche il re Massimiliano Giuseppe
ebbe grande affetto e stima per il genero. Infatti, lo ricompensò quando con l’eclissi delle fortune napoleoniche egli
venne a perdere gli altri suoi titoli nominandolo erede al
regno; ovviamente in successione ai discendenti in linea
maschile della casa reale e prossimo in precedenza, dopo la
famiglia reale. Contestualmente ricevette anche titolo connesso, che lo ascriveva nella matricola della nobiltà bavarese.
Il titolo di Principe di Eichstätt venne restituito dal IV Duca al
re di Baviera nel 1855.
Pertanto, chiarite le vicende storiche che legano lo stemma al
personaggio e, dimostrato come il nostro titolare sia venuto in
possesso di questi titoli, diventa opportuno esaminare in
dettaglio la simbologia araldica contenuta.
Lo stemma in questione è posto al centro del sigillo e presenta
un padiglione in ermellino caricato con uno scudo sannitico
affiancato da due aquile nere al naturale che si sostengono su
un ramo verde
Al 1° d’argento con una fascia azzurra che è quella dei conti
di Leuchtemberg una famiglia nobile già estinta nel lontano
1646
Al 2° smalto rosso a un muro merlato con nel mezzo una porta
aperta della città in argento, i lati del castello sono un muro
merlato sovrastato da due torri anch’esse a loro volta merlate e
dello stesso smalto argento. Ciascuna torre sostiene a sua volta
una quercia verde
Al 3° stemma di Eichstatt: smalto verde caricato di una spada
con la punta posta verso l’alto dall’elsa d’oro e dalla lama
d’argento. Avvicinate alla lama tre stelle d’oro poste in ordine
due ed una per lato come a triangolo rovesciato Inizialmente
per secoli fu un feudo assegnato ad un Principe Vescovo
divenne un Principato sotto il Regno di Bavaria assegnato al
Principe Eugenio dal 1817 al 1855.
Al 4° arma dei de Beauharnais: smalto d’argento con fascia
nera caricata da tre merlotti dello stesso posti in capo.
Stemma de Beauharnais: D’argento alla fascia di nero
accomapagnati da tre merlotti dello stesso posti in capo. Il
motto : « Autre ne sers » antico o « Honneur et fidélité. »del
periodo napoleonico
Su tutto la corona di Principe del S.R.I.
Ci resta infine da chiarire quale fosse l’ufficio amministrativo
a cui apparteneva l’uso del timbro ovvero la gestione della
Amministrazione feudale della Casa Ducale del Principe
Eugenio .
Così il Decreto napoleonico del 2 aprile 1808, le Marche
entravano a far parte del Regno Italico, già istituito il 26
maggio del 1805 con l'incoronazione di Napoleone Bonaparte
Re d'Italia. Contestualmente quale Vicerè del Regno fu
nominato il Principe Eugenio di Beauharnais.
Al Vicerè Eugenio venne assegnato un appannaggio costituito
da una parte dei beni immobili ecclesiastici confiscati alla
Chiesa per volere di Napoleone; tali beni vennero intestati per
voltura catastale come: "APPANNAGGIO DI S.A. IL
PRINCIPE VICERE' D'ITALIA EUGENIO NAPOLEONE".
Una proprietà davvero consistente che contava ben 2300
tenute agricole e 137 palazzi urbani.
Dopo l'abdicazione di Napoleone e la caduta del Regno Italico
nel 1814, il Congresso di Vienna confermò l'appannaggio dei
"BENI DELLA CASA DUCALE" a Eugenio, nominato Duca
di Leuchtemberg.
Quest’ultimo doveva pagare alla Camera Apostolica 160.000
scudi romani, a titolo di laudemio. (Questo era un istituto che
prevedeva una prestazione di norma in denaro che era versata
al concedente dall'enfiteuta nel momento in cui si trasferiva il
diritto di enfiteusi, in altre parole con la concessione del solo
diritto di utile dominio.) . Era altresì previsto un canone annuo
per una somma pari a 4.000 scudi. L'8 maggio 1816 fu
stipulato un atto notarile tra il Governo Pontificio ed il
Principe Eugenio, con il documento si precisava che i beni
posseduti da quest'ultimo erano concessi in enfiteusi (
l’istituto prevede in generale l ‘obbligo di miglioramento del
fondo, il divieto di alienazione dello stesso ed era previsto il
pagamento di un canone annuale). Inoltre, la Camera Apostolica poteva riscattarli quando lo avesse ritenuto opportuno.
Per l'amministrazione dei beni ducali fu istituito un ufficio
centrale ad Ancona con sedi distaccate site in altre città
marchigiane; contestualmente vennero inviati dalla Germania
(dove Eugenio risiedeva) alcuni abili amministratori ed esperti
dirigenti d'azienda, che introdussero nuovi metodi di
coltivazione e di produzione agricola. In particolare, tra questi
amministratori si contavano diversi ufficiali napoleonici e
persone che a causa della loro comprovata compromissione
con il vecchio regime napoleonico non avevano altre
possibilità di poter facilmente trovare spazio nelle istituzioni
del regime pontificio restaurato. Questo fatto creava non poca
apprensione allo Stato della Chiesa. Sembra che il Papa Leone
XII avrebbe voluto affrettare il riscatto di tali beni poiché
temeva che all’interno di queste proprietà ed attraverso
numerosi amministratori di vecchia tradizione napoleonica, si
potessero avviare moti rivoluzionari.
Tra questi uffici amministrativi periferici troviamo quello di
Senigallia che ci viene contestualizzato e valorizzato dallo
studio del nostro sigillo.
Nel 1845 sotto il Pontificato di Papa Gregorio XVI
(Bartolomeo Eugenio in religione Mauro Cappellari)si giunse
al riscatto dell’ appannaggio in virtù di un atto dato in Roma il
3 Aprile 1845 tra Filippo Rousc De Damianio, il quale si
trovava in Ancona, sede dell’amministrazione generale
dell'Appannaggio, in qualità d’intendente generale delle
proprietà di Eugenio ed il Cardinale Mario Mattei,
rappresentante della Santa Sede.
Il Cardinale Giacomo Antonelli, in quel tempo Gran
Tesoriere, sembra sia stato il grande regista di questa
operazione che restituiva alla Chiesa delle importantissime
proprietà nelle Marche. L’atto fu rogato dal Cancelliere
Felice Argenti e prevedeva l’acquisto della proprietà per
3.740.000 scudi. Una somma sicuramente cospicua per
l'epoca. Il palazzo dell’amministrazione di Senigallia
diventerà in seguito parte dell’Opera Pia Mastai per espressa
volontà del Papa Pio IX. Il monumento è tuttora visibile e
degno di nota. Si realizzava per gli eredi del Principe Eugenio
quella che si potrebbe definire una simpatica plusvalenza.
Carlo Del Grande
Ricordo di Roberto Nasi
La S.I.S.A. ha perso recentemente, con la dolorosa dipartita terrena di Roberto Nasi, colui il quale fu in realtà l’iniziale fondatore del nostro sodalizio, insieme a Salvatorangelo Palmerio Spanu, altro caro consocio scomparso da
tempo.
Fu infatti, esattamente trent’anni or sono che fu fondata la
S.I.S.A. proprio nella bella casa torinese di Roberto e consorte, essendosi trattato più precisamente della trasformazione di un precedente sodalizio di appassionati araldisti e cultori delle scienze ausiliari della storia in generale.
Roberto Nasi, scomparso poco prima di avere compiuto 85
anni di età (era nato il 1 maggio 1931) era dotato delle migliori qualità di un gentiluomo piemontese di antico stampo che lo resero popolarissimo tra tutti coloro che lo frequentarono ed in particolare tra noi consoci.
La sua vita professionale di Dirigente industriale, nella
quale raggiunse importanti livelli di responsabilità, fu
sempre accompagnata da intensa attività culturale e varie
sono le pubblicazioni storiche, di carattere prevalentemente militare da lui lascateci; in realtà la sua vocazione
inespressa fu proprio quella definita da un grande letterato francese «servitude et grandeur de la vie militaire»,
avendo Roberto peraltro assolto brillantemente a suo
tempo gli obblighi di servizio militare di leva quale ufficiale complemento di cavalleria.
Cavaliere egli fu realmente nel vero senso della parola, in
ogni contesto da lui frequentato dove ricoprì quasi sempre
ruoli significativi, essendo in ogni caso universalmente
stimato, apprezzato ed amato, in particolare dai noi tutti
3
soci S.I.S.A. che lo conserveremo sempre presente nel
nostro cuore.
Gustavo di Gropello
Janus Gerbaix de Sonnaz
e il corpo dei volontari Savoiardi
Nella storia degli ultimi duecento anni si è quasi sempre
parlato con entusiasmo di quanti nei diversi stati italiani si
schierarono con la Francia, raccontando di mirabolanti
imprese da questi compiute combattendo negli eserciti napoleonici, in genere in occasioni di eroiche sconfitte, come
quelle durante la guerra in Spagna, la campagna di Russia o a
Lipsia, poco, ma più spesso nulla, si dice di quanti non accettarono l’occupazione francese e quando poterono insorsero
contro di essa. Quasi che i veri patrioti non fossero quelli che
erano attaccati al loro paese e che si battessero per la sua
indipendenza ma piuttosto coloro che avevano accettato la
dominazione straniera, ammantata dalla grandeur dell’astro
napoleonico.
Così si tacciono ad esempio le insurrezioni di quanti nel
Veneto, in Romagna, in Toscana e in Savoia, si ribellarono
agli occupanti non appena le condizioni glielo consentirono, o
respinsero come in Sicilia i tentativi d’invasione, aiutati in
questo dall’Austria e dall’Inghilterra. Dei falliti tentativi
insurrezionali in Sardegna sponsorizzati dalla Francia e tutti
falliti perché senza alcun sostegno popolare, in genere gli
storici risorgimentali tacciono se non per raccontare di feroci
repressioni, che nella realtà non ci furono, limitandosi ad
interessare qualche capo bandito.
Già dopo la sconfitta in Russia, nel corso del 1813 era risorta
contro Napoleone la Prussia e l’intera Germania si era liberata
dell’ingombrante presenza francese, nel giugno di quello
stesso anno, falliti i tentativi per una pace l’Austria si schierò
di nuovo contro la Francia e fu Lipsia. Napoleone, in quel
periodo si rese responsabile di gravi errori, sia politici, sia
militari che lo portarono alla rovina. Quello più grave fu di no
essersi reso conto che in Europa regnava un nuovo spirito, che
la Francia non era più la sola nazione ad essere animata da un
vero spirito nazionale e che stavano impiegando la loro nuova
energia contro di lui e ciò che rappresentava.
La battaglia di Lipsia
Così anche nell’Italia settentrionale con l’aiuto dell’Austria
sorsero unità di insorgenti quali il corpo franco italiano, al
comando del capitano Mistruzzi, il corpo franco Finetti, gli
insorti Toscani, mentre in Sicilia erano sorti i tre reggimenti
dell’Italian Legion che unitamente alle truppe regolari borboniche ed inglesi nel 1814 liberarono dai Francesi Toscana e
Liguria.
4
Se i bravi Piemontesi, inglobati nella nazione francese,
rimasero tranquilli, per lo stretto controllo della polizia napoleonica, non così avvenne in Savoia, anche per l’approssimarsi
alla frontiera dell’esercito austriaco. Diversi erano i fattori il
primo di essi era quello della mancata assimilazione della popolazione, la Francia aveva occupato al Savoia da 20 anni , ma
molti si consideravano ancora come dei prigionieri che gli
Alleati stavano per liberare. L’occu-pazione francese era stata
contrassegnata al suo inizio da un’ estrema violenza, spesso la
ghigliottina e la fucilazione erano stati i principali argomenti
dei seguaci delle idee nuove. Quando era tornata la tranquillità, le continue guerre, la cos-crizione obbligatoria avevano generato odio contro la politica napoleonica cui si era
contrapposto il secolare amore dei Savoiardi per i loro antichi
sovrani, sostenuto e propagandato questo sia dal clero, assai
influente nella regione, sia dal-l’aristocrazia, i cui membri
erano rimasti in gran numero in patria a difesa dei propri
interessi. Esponente di spicco di questo ceto era il generale
conte Janus Gerbaix de Sonnaz. Appartenente ad un’antica
famiglia che per tradizione aveva servito nella magistratura e
nell’esercito Casa Savoia, Janus era nato a Thonon il 3
settembre 1736, a 13 anni era stato nominato paggio di S.A.R
la duchessa di Savoia, e nel 1755 era stato promosso alfiere
nel reggimento delle Guardie.
Conte Janus Gerbaix de Sonnaz
Aveva così iniziato la sua lunga carriera militare che per un
lungo periodo, sino al 1792, contrassegnato dalla pace. Da
secoli il Piemonte e la Savoia non avevano goduto di tanti
anni di assenza di guerra sul loro territorio. La carriera di
Janus era stata così lenta, d’altra parte così era per le
condizioni di avanzamento previste dalle leggi del tempo, Nel
marzo del 1781, era sttao promosso maggiore e dal
reggimento delle Guardie era passato alla Legione degli
Accampamenti, un nuovo reparto d’élite voluto da Vittorio
Amedeo III. Nel 1792 venne promosso colonnello e nominato
comandante del reggimento di Savoia, dislocato in maggior
misura in Piemonte, che partecipò quindi solo con qualche
distaccamento alla difesa della Savoia dall’invasione francese.
Nell’aprile del 1793, Janus venne promosso generale di
brigata e gli venne affidato il comando delle truppe incaricate
della difesa della valle Po. I baracons de l’Argentera costituivano la sua avanguardia, rimase quindi in quella posizione
tutta l’estate del ‘93 alloggiando sotto una tenda a Pian del Re
ai piedi del Monviso, avendo ai suoi ordini parte del reggimento di Savoia e le compagnie delle milizie delle vallate del
Cuneese. Al comando della difesa di questo settore, dove si
trovavano tre tradizionali direttrici di penetrazione francese
verso il Piemonte, le valli dello Stura, del Maira e del Varaita,
rimase anche per il 1794 ed il 1795.
Forte dell’Argentera
Tenne in questo periodo in rispetto forze francesi assai
superiori per numero, realizzando un sistema di ridotte e
batterie che assicurassero la copertura col fuoco di tutti i più
facili ed importanti passaggi. di strade che consentissero il
facile arroccamento delle poche unità a sua disposizione e di
ripari che durante la dura stagione invernale permettessero la
permanenza delle truppe ad alta quota. Dopo la sfortunata
battaglia di Mondovì, nell’aprile del 1796 venne chiamato ad
assumere il comando della divisione che avrebbe dovuto
assicurare la difesa di Fossano e fermare il Bonaparte, cosa
che non si verificò essendosi firmato l’armistizio di Cherasco.
Arma Gerbaix de Sonnaz
Merita essere ricordato la lettera che indirizzò al sovrano,
quando dovette lasciare il comando del settore montano:«
Sire, non so rendere a Vostra Maestà completa testimonianza
dello zelo e della fermezza con i quali i miei ufficiali e soldati
hanno sopportato il continuo ed inevitabile malessere delle
posizioni che occupiamo, dove sopportiamo i rigori
dell’inverno e dell’estate. Riguardo ai quali nessuno di essi si
è però mai permesso non tanto di lamentarsi ma nemmeno di
mormorare.
Supplico Vostra Maestà di volersi nell’occasione, ricordare le
prove di attaccamento al suo servizio dategli in questa
campagna dal reggimento di Savoia e dalle milizie e dagli
abitanti della Val Maira».
Janus, malgrado fosse Savoiardo (quindi Francese per il
governo di Parigi) poté continuare a servire Vittorio Amedeo
III e quindi Carlo Emanuele IV, sino al dicembre 1798,
quando a seguito della partenza del sovrano da Torino lasciò il
servizio. Nel breve periodo fra l’arrivo degli Austro-Russi nel
1799 e Marengo, venne chiamato a ricoprire l’incarico di
governatore di Alessandria, poi tornò a ritirarsi nel castello di
Arenthon ove vennero a cercarlo gli avvenimenti del 1813 e
1814.
L’avvicinarsi delle armate alleate agli antichi confini della
Francia, aveva provocato anche in Savoia, da parte di
rappresentanti del potere napoleonico, il prefetto Finot e il
generale Desaix, la necessità di ordinare una leva di massa con
la quale venivano chiamati alle armi tutti gli uomini dai 20 ai
60 anni. La leva avrebbe dovuto fornire circa 9700 uomini con
i quali riportare a numero le unità esistenti, ma fu un
fallimento. Sia la rapida avanzata, del’avversario, l’armata
austriaca, sia i timori, sia la propaganda alleata, sia la
stanchezza della popolazione, sia la presenza di un movimento
a favore del re di Sardegna a capo del quale si era posto Janus,
fecero sì che i risultati di questa chiamata alle armi fossero
meno che mediocri. Janus, fedele servitore di Vittorio Amedeo
III, aveva mantenuto il suo affetto e la sua dedizione a Casa
Savoia, per lui i Francesi erano rimasti il nemico. Così quando
Thonon venne abbandonata dalle truppe francesi, alzò lo
stendardo della rivolta ed inviò al generale Schwarzemberg
una delegazione per sottomettere alla approvazione di questo
il suo piano di una sollevazione tesa a restituire la Savoia ai
suoi antichi sovrani. La delegazione, della quale facevano
parte anche due figli di Janus, venne poi ricevuta
dall’Imperatore d’Austria e dallo zar di Russia che la
accolsero con favore. Lo stesso generale che comamdava il
corpo d’armata austriaco indirizzò alla popolazione della
Savoia un proclama nel quale scriveva: «Vecchi guerrieri
della Savoia, radunatevi di nuovo sotto le bandiere del vostro
amato monarca».
Il 21 di gennaio il generale de Sonnaz decretava la formazione
a la Roche, Annecy, Rumilly e Thonon dei quattro antichi
reggimenti del ducato: Savoia, Chablais, Moriana, Genevese.
La reazione francese con la parziale riconquista del terreno
perduto e la morte del generale Janus stroncarono però tale
progetto. Lo sforzo del generale non fu tuttavia vano in quanto
venne a costituirsi un battaglione savoiardo , corpo dei
volontari savoiardi al servizio del re di Sardegna, che si
affiancò agli Austriaci sino alla conclusione del conflitto. Ne
facevano parte quali ufficiali: il cav. Ippolito de Sonnaz (già
cornetta delle guardie del Corpo di S.M.), il cav. De Ruphy
(già maggiore dei granatieri), il conte Gaspard de Maréchal
(già capitano del rgt di Saluzzo); cav. Francesco de Ruphy
(già capitano del rgt di Savoia), Jaillet d’Annemasse (già capitano del rgt del Genevese); barone Luigi de Villars de Thoire
(già capitano del rgt di Savoia); conte Ippolito de Sonnaz (già
capitano al servizio austriaco); Paul Seillard (già capitano al
servizio britannico), barone Filiberto de Thoire (già ten. nel
rgt di Savoia), cav. Giacinto de Constantin (già ten. nel rgt di
Moriana); cav. Gaspard de Ruphy (già ten. nel rgt della
Regina); cav. Amedeo de Ruphy (già ten. nel rgt di Savoia);
cav. Francesco de Chissée de Polinge (già sten nel rgt di Moriana); conte Giuseppe de Sonnaz (già sten nel rgt di Savoia);
Giacinto Frèzier (sergente decorato di medaglia d’argento nel
rgt di Savoia); cav Gabriele de Launay (già cap. della guardia
nazionale); cav. Alfonso de Sonnaz (già volontario nel rgt di
Chablais); conte Giuseppe de Forax (ten. della guardia urbana
a Thonon); conte Giuseppe de Constantin (già volontario nel
rgt di Savoia); Felix Challud (già volontario nel rgt nel rgt dello Chablais); nobile Francesco de Saxel (già volontario nel rgt
5
dello Chablais); cav Clemente de Maugny, nobile Luigi
d’Araine, Urbano Rogès (tutti già volontari nel rgt di Savoia).
Poco meno di cinquanta anni dopo a riconoscimento dell'
impegno prestato verso quella che ritenevano la loro patria
vennero ceduti alla Francia.
ALFS
La corona Liturgica Ortodossa
- rilievi storico-ecclesiastici ed araldici «...il Signore ti ha posto sul capo la corona di pietre
preziose...... vita gli hai chiesto ed Egli ti ha concesso
lunghezza di giorni....», con questa preghiera, i prelati di Rito
Orto- dosso, vestendo i sacri paramenti e, dopo aver ricevuto
tra le mani “la Corona”, e, baciatone il medaglione centrale
anteriore - rappresentante l'effige di Gesù - la pongono in
capo, esaltando, in questo modo, la Regalità di Cristo, paragonandola al Sacerdozio del Pontefice, secondo quanto stabilito dallo Ordine di Melchisedecco.
Nelle diocesi, nelle quali si pratica la liturgia di Rito Orientale,
pur essendo cattoliche, i riti, peraltro si riferiscono ad altre
espressioni liturgiche.
Tra queste, voglio ricordare, quelle che si rapportano al rituale
greco, a quello melkita, a quello ruteno, rumeno, bulgaro, slavo e russo.
Questi rituali liturgici hanno, da sempre, adottato l'uso di un
copricapo sacerdotale denominato “Corona” - in contrapposizione alla “Mitra” di Rito Occidentale, che si diffuse in
tutte le Chiese Ortodosse e che, sul piano strettamente
liturgico, si rifà, alla Tiara Pontificia – sia a quella Romana sia
a quella Alessandrina -.
Questo copricapo origina dagli “Antichi Berrettoni Bizantini”
che, si ricordano, quali “progenitori” di quasi tutte le corone di
sovranità occidentali (per eventualmente approfondire l'argomento, mi permetto di suggerire la lettura di un mio studio
recente: «le Corone Nobiliari etc. etc.» in Atti della Società it.
di Studi Araldici - Torino - Società del Whist-Filarmonica ottobre 2014) e, si definisce, esteticamente, quale turbante quasi quadrilobato - arricchito da ornamentazioni ricamate in
oro e tempestato di pietre preziose contenenti, sopra i quattro
lati, ciascuno, un medaglione smaltato.
In centro, sul lato frontale, è raffigurata la rappresentazione
del Volto di Cristo.
Sui lati, la raffigurazione del Volto della Vergine e di quella di
S.Giovanni Battista. Posteriormente, l'effige di S. Nicola.
Sulla sommità è posta una piccola Croce Greca d'oro oppure
d'argento.
Questo particolare “simbolo crociato” è, tuttavia, presente
esclusivamente se, il dignitario ecclesiastico, rientra nelle
categorie degli Arcivescovi o Metropoliti.
La testimonianza più antica dell'uso di questo tipo di “Corona
Liturgica”, sembra sia stato presente già a Costantinopoli –
dopo la caduta dell'Impero Romano d'Oriente – ed, alcuni
storici, vorrebbero, che ciò, stesse a simboleggiare il ripristino
della “già perduta sovranità” da parte del Patriarca.
Tuttavia, la prima documentazione ufficiale dell'uso di tale
copricapo liturgico, è rilevabile attorno al 1621, allorquando,
il Patriarca Cirillo Lukaris, trasferendosi da Alessandria a
Costantinopoli, rinunciò alla “tiara” in uso, per adottare la
“Corona” che, così, venne definitivamente mantenuta.
La portarono, successivamente, per primi, i Patriarchi di
Antiochia e, quindi, quelli di Gerusalemme; poi la adottarono,
altresì, tutti i Metropoliti, gli Arcivescovi Maggiori ed, infine,
anche i Vescovi.
Nella Chiesa Russa, questa “Corona” fu concessa agli
6
Archimandriti (superiori di un monastero oppure di una
Congregazione Cristiano-Ortodossa) ai Protopresbiteri Mitrati
(simili, per dignità,agli Abati Mitrati del Rito Latino
d'Occidente) sia, per privilegio, ad importanti prelati per
missioni od incarichi speciali cui erano demandati.
Gli Archimandriti iniziarono ad assumerla, per la prima volta,
dello Zar Paolo I.
Sul territorio italiano esistono “due enclaves” di Rito GrecoBizantino-Uniate: le diocesi di Lugro, in Calabria, (eretta da
Benedetto XV il 13 febbraio 1919) e di Piana degli Albanesi,
in Sicilia, (eretta da Pio XI il 26 ottobre 1937).
A capo di questa diocesi è posto un Esarca (Vescovo) che
esercita la propria funzione spirituale sopra i paesi di lingua
“Arbaresche” (albanese) sia insulari che continentali che,
anche, esteri.
Parimenti l'Archimandrita del Monastero Esarchico di
S.Maria di Grottaferrata, fondato da S.Nilo nel 1200, nel Lazio, retto da monaci basiliani, usa gli stessi apparati liturgici.
Tutti i summenzionati ecclesiastici, appartenenti al “Rito
Greco”, usano la “Corona” così come tutti gli altri paramenti
sacri relativi a questa liturgia: la Croce Astile Trilobata ed il
Pastorale “a TAU”, /oltre ad altre numerose varianti rituali ed
oggettistiche.
Il simbolismo araldico, rappresentativo di questi presuli,
anch'esso si differenzia da quello in uso per le dignità corrispondenti, dal Rito Latino d'Occidente.
Essi innalzano, infatti, la propria arma di dignità nel seguente
modo: lo Scudo Personale, risulta, infatti, accollato ad una
croce astile trilobata - detta, anche, greca - ed al bastone
pastorale ortodosso (a forma di “una TAU” costituita da due
serpenti affrontati miranti una piccola croce) posti in decusse;
il tutto accollato ad un manto scarlatto legato e frangiato d'oro
(simile a quello principesco o ducale) cimato dalla “Corona
Liturgica” sopra descritta.
Arma -vacua - per la dignità archimandritica
Questo bastone pastorale “serpentifero” merita un cenno: i
pastorali di rito orientale presentano, al proprio apice, due
serpenti controaffrontati, miranti un globo cerchiato e crociato.
Essi vogliono simboleggiare, infatti, l'apporto di benefici spirituali sul mondo dei credenti; infatti:« come il serpente di
bronzo di Mosè, essi, rappresentano il Cristo».
Il Cristo-serpente, posto sopra i detti bastoni, si ispira, infatti,
al racconto biblico secondo il quale: «avendo, il Faraone, chiesto a Mosè e ad Aronne di manifestargli un prodigio, quest'
ultimo, non fece altro che gettargli ai piedi la propria verga, la
quale, tosto, si tramutò in serpente».
Il serpente di Aronne è, quindi, paragonato al Cristo vittorioso
sopra le colpe dell'umanità, in ragione della propria morte
sulla Croce.
Il bastone pastorale (poi simbolo vescovile) è, quindi,
considerato un oggetto antichissimo proprio per la sua storia
rituale simbolica.
Si vuole, infatti, raffigurato, già, nel mito di Osiride e, posto,
nel “vincastro dei pastori”.
Furono, secondo la tradizione, proprio i Celti irlandesi, ad
assegnare il pastorale ai propri capi religiosi e a definire il
valore simbolico alla “spirale romanica” che sostiene la
“testa” del pastorale medesimo (già usata dai propri antenati).
A testimonianza, infatti, del valore simbolico della spirale
romanica, concorrono, anche, i coronamenti, in avorio, della
TAU, la cui formula, ha preceduto il pastorale propriamente
detto.
Questi coronamenti, infatti, si riferiscono alla “TAU di
Ezechiele” che fu tracciata, dal Profeta, sulla fronte degli
Ebrei e, nel qual simbolo, i Padri della Chiesa, hanno poi
ravvisato una prefigurazione del Segno della Croce e nello
stesso tempo, un'immagine della Trinità.
Sopra quest'asta tortile, però, i serpenti sono due.
Uno rappresenta, come accennato, il Cristo, l’altro, il suo
oppositore: la bestia infernale.
Ambedue mirano al controllo del mondo (rappresentato dal
globo)!
Noi sappiamo che, il Cristo, risulterà vincitore; infatti, sul
globo, trionfa la Croce (simbolo della “totalità della Fede
Universale”).
Queste tipologie araldiche, così ben definite nei secoli passati,
vennero ad assumere, specialmente dal sec. XX, sempre
“maggior confusione”, riscontrandosi, frequentemente, sgradevoli commistioni estetiche, causate da un “maldestro scambismo simbolico” tra le usanze rituali sia d'Oriente che d'Occidente.
La superficialità dell'uomo contemporaneo e la scarsa conoscenza della Tradizione, anche in ambito ecclesiastico..... ha
fatto il resto!
Alberto Gamaleri Calleri Gamondi
Emilio RICCIARDI, L’Ordine di Malta nel Regno di
Napoli (secoli XVI-XIX), con presentazione di Angelandrea
CASALE, Collana Parva Melitensia diretta da Angelandrea
Casale, Centro Sudi Archeolici di Boscoreale Boscotrecase
Trecase, Nepi, 2014. pp. 87.
Quella di Angelandrea Casale è una figura a me
particolarmente cara non soltanto sul piano amicale, ma per la
sua infaticabile, poliedrica passione per la cultura, nella più
ampia accezione del termine, e per il suo diuturno impegno al
fine di salvare e valorizzare l’immenso patrimonio del
Mezzogiorno in generale e della Campania in particolare,
purtroppo troppo spesso posto in pregiudizio dalla criminalità
di pochi e dalla ignavia di tanti. Ha saputo creare attorno a sé
un autentico cenacolo di giovani (tali sempre, malgrado il
trascorrere degli anni) studiosi, che danno prove crescenti di
valore scientifico e di dedizione piena all’obiettivo primario,
che è la generosa diffusione del sapere. Ciò avviene mediante
convegni, pubblicazioni, interventi, corsi e iniziative varie di
sostegno, facenti capo a una serie di sodalizi, che operano su
un numero notevole di campi. Naturalmente ci sono araldica,
la sfragistica, la diplomatica, ma non manca la storia in tutte
maiuscole in ogni suo comparto, la magistra vitae di cui esse
sono operose ausiliarie. Il territorio – siamo a due passi da
Pompei, a tre da Stabia ed Ercolano e a pochi in più da
Paestum e da Velia – esige e sollecita una forte azione sul
piano della conoscenza – non meno che della difesa – dei
tesori archeologici, accanto a quella volta all’approfondimento
delle storie municipali e dei personaggi che ne furono anima.
L’arte di ogni epoca, il pensiero e la scienza trovano degna
celebrazione, come può rilevare chiunque dalla larga messe di
produzioni a stampa.
Questa pubblicazione, la decima di Parva Melitensia, collana
che ospita pregnanti sudi sulla storia dei Gioanniti nel già
regno di Napoli, espone due precedenti saggi di Emilio Ricciardi: L’Ordine di Malta in Campania (2010) e Rileggendo
Michele Gattini. Brevi note sul Priorato di Capua (2011). In
certo senso, l’attuale lavoro costituisce il prosieguo del secondo di essi. Purtroppo, non conosco personalmente l’autore, ma
di lui so che si è laureato in biologia, prima che in conservazione dei beni culturali, che si è addottorato in storia e critica
dell’architettura e che insegna scienze naturali al liceo ‘Sannazzaro’ della sua città (Napoli), oltre a rivestire ruolo di docente in storia dell’architettura e di museografia all’ Università ‘Orsola Benincasa’. Naturalmente, ha dato alle stampe
numerosi volumi e tanti articoli su riviste di alto profilo, aventi a prevalente oggetto architettura e urbanistica napoletana.
Quello che stupisce, nel volumetto, è la capacità di sintesi di
Ricciardi, che, senza sacrificare proprio nulla, consente,
qualora non si conosca che di nome la fondamentale opera del
Gattini, di ‘leggerla’ assieme a lui, acquisendo peraltro integrazioni, mende e un vasto repertorio di fonti, assai apprezzato da chi voglia approfondire i temi.
Al conciso capitolo introduttivo, seguono quelli dedicati
all’organizzazione dei benefici dell’Ordine di San Giovanni
Gerosolimitano nelle province del regno. Campania e Terra di
Lavoro con la precettoria di Capua, risalente al secolo XII, cui
seguirono le domus di Marigliano, di Aversa, di Arinzo, di
7
Caiazzo, Di Maddaloni, di Nola, di Pietramolara, di San’Agata
de’ Goti, di Scafati. Si descrivono edifici di culto, si citano
diplomi e cabrei.
Eccellenti le quattro appendici, riportanti la cronotassi dei titolari dei benefici (con successione nominativa); la riproduzione
di una serie di tabelle, conservate presso l’A.S. di Napoli e
rappresentanti dati statistici sulla situazione della Lingua
d’Italia nel 1776, vale a dire imposizione tributaria, numero
dei cavalieri e delle dignità, numero delle commende, rendite,
pet i sette priorati italiani; Roma, Lombardia, Venezia, Pisa,
Barletta, Messina e Capua; infine la serie di ricevitori di
Napoli tra i XVII e il XIX secolo e l’elenco delle commende
‘della ricetta’ di Napoli.
Angelo Scordo
Francesco ALLIATA, Il Mediterraneo era il mio regno –
Memorie di un aristocratico siciliano. Introduzione e
didascalie di Stefano Malatesta, Neri Pozza editore, Vicenza,
2015, pp. 346.
Negli Abruzzi e Molise, la presenza gerosolimitana si
riscontra dal 1297, cioè dalla caduta di San Giovanni d’Acri.
Nel 1312 l’Ordine si avvantaggiò della soppressione del
Tempio, acquisendone numerose magioni. Si tratta, quindi,
delle vicende di numerose precettorie e domus molisane ,
confluite nel ‘500 nelle tre commende di San Giovanni di
Boiano, di Isernia e di Larino, centri di notevole rilievo sotto
più profili e sedi episcopali. Le commende abruzzesi furono
riunite in due: quella dell’Aquila, rientrante nella giurisdizione
del priorato di Roma, e quella di Chieti, spettante al priorato di
Capua.
In Calabria, gli insediamenti dell’Ordine risalgono al XII
secolo e di essi, quello di gran lunga più importante,fu il
baliaggio di Sant’Eufemia, che il Gattini definì splendido e
che possedeva un patrimonio feudale e immobiliare più che
ragguardevole. Malgoverno, usurpazioni e tragedie telluriche
portarono alla sua concessione in affitto e, successivamente, al
suo parziale smembramento, che dette vita a sei nuove
commende: Crotone, San Francesco, Santa Maria Carolina,
San Sidero, Belcastro ‘prima’ e Belcastro ‘seconda’. La
precettoria di Cosenza era stata la prima sede dei cavalieri di
San Giovanni in Calabria e il suo territorio, disseminato di
grance, comprendeva quello dell’attuale provincia. La
commenda di Castrovillari, presente già alla fine del
Duecento, aveva ‘ereditato’ diverse terre appartenute ai
Templari. Quella di San Giovanni di Melicuccà e di San
Martino di Drosi provenivano da uno scorporo, operato nel
1550 sul Baliaggio di Sant’Eufemia. Risaliva al 1612 circa
l’istituzione della commenda di Santa Maria Rocca Verdara di
Cannitello, tra Reggio e Scilla; al 1616 e al 1642 quelle delle
due maggiori commende di giuspatronato: quella di Roccella,
istituita dai Carafa, principi di Roccella, e quella di Bagnara,
creata da Ruffo, duchi di Bagnara. Nella metà del Seicento fu
fondata anche la commenda di Reggio, che non ebbe, però,
vita facile.
In Puglia l’Ordine disponeva molte sedi, ubicate per lo più nei
pressi dei porti di Barletta, Monopoli, Trani e Molfetta. A
Barletta aveva sede il priorato, cui facevano capo i baliaggi di
Santo Stefano e di Venosa, le camere magistrali di Maruggio e
di Casaltrinità e molte commende. Monopoli vantava il
baliaggio di Santo Stefano e la commenda di San Giovanni
Battista e l’importante feudo di Putignano.
La presenza gioannita in Basilicata è documentata dal 1149 a
Melfi, La Santa Sede donò all’Ordine nel 1297 l’abbazia
benedettina della Santissima Trinità di Venosa, assieme ai
suoi tanti beni, cui si aggiunsero assai presto quelli dei soppressi Templari.
8
Ho inveterato il vizio di orientare le mie letture, prevalentemente notturne, sull’ago della bussola dello stato d’animo e dell’interesse prevalente del momento, il che mi induce a
‘prendere e lasciare’ un numero di volumi talora non
irrilevante. Le memorie di Francesco Alliata di Villafranca
rientrano tra le rare eccezioni: una volta aperto il libro, in
ottobre, la lettura ha registrato poche stasi, dovute in via
esclusiva allo stimolo di recuperare e integrare il testo recuperando informazioni e organizzando personali ricordi. L’ho
riletto ai primi del nuovo anno e una ulteriore lettura, in chiave
interrogativa, è di fatto intervenuta nel corso della stesura di
queste righe.
Come definire Francesco Alliata di Villafranca? Lungo l’elenco, che provo a ridurre a estrema sintesi: uomo di cinema di
prim’ordine, imprenditore di genio, narratore considerevole
(torneremo sul tema) e, in più, gran signore, non soltanto
per nascita.
Accantonando la gens Allia e analoghe ipotesi genealogiche di
terzo tipo, gli Alliata, olim Agliata, sin dal XIII secolo erano
numerosi e di censo più che ragguardevole nella loro patria, la
repubblica di Pisa. A partire dal Trecento, assieme a tanti altri
esponenti di famiglie pisane che, da un canto, mal sopportavano l’incombente signoria medicea, e, dall’altro, ravvisavano nella Sicilia un’ottimale allocazione per dare libera
stura alla loro imprenditorialità, estrinsecatesi prevalentemente nel binomio mercatura-banca, alcuni rami degli Alliata si trapiantarono in Sicilia. Acquisita nel 1413 la cittadinanza palermitana, indispensabile premessa al trionfale
successo che ben presto loro arrise, impressero ritmo crescente
ad attività e investimenti, oculatamente indirizzati all’acquisto
di feudi e di offici di grande rilievo o altamente remunerativi.
Dettero capitani di giustizia e pretori di Palermo, mastri
razionali, deputati, pari e vicari generali del regno di Sicilia;
l’acquisto dell’officio di Protonotaro del regno da parte di
Gerardo, alla metà deel secolo XV, è di particolare significatività e non lo è meno quello, altamente redditizio, di
corriere maggiore del regno di Sicilia, esercitato dalla metà del
Cinquecento alla fine dell’ancien régime, accanto al quale si
collocano cariche e privilegi a spiccata valenza commerciale e
industriale, quali la privativa della neve. Gli Alliata, grazie
anche a un’attenta politica di cospicue alleanze matrimoniali
(dei grandi nomi della feudalità siciliana, a guardar bene,
manca soltanto quello dei Chiaramonte: per la semplice
ragione che s’erano estinti, in pratica, nel primo periodo della
immigrazione pisana, quando i toscani indulgevano a sposalizi
endogami all’interno della comunità d’origine), si inserirono a
pieno titolo nei ranghi della grande aristocrazia isolana, senza
mai venir meno, però, all’antico loro credo nella operatività
industriale e commerciale. Francesco Alliata e Paruta, che
dall’avo Andriotto, dottor di leggi, aveva ottenuto nel 1499 il
jus populandi nel suo feudo di Troccola sulla terra (per tal
motivo) denominata Villafranca, ne ricevette titolo di principe
il 16 aprile 1610, che potè abbinare, tre lustri più tardi, con
quello di duca di Salaparuta, titolo conferitogli sul feudo di
Sala, ereditato dalla famiglia materna. Nel 1722, Giuseppe
Alliata e Colonna, 4° principe di Villafranca, che nel 1710
aveva sposato Anna Maria Di Giovanni, di gran sangue
iberico (erano una diramazione della storica casa dei
Centelles), della cui dote facevano parte i principati di
Trecastagni, di Buccheri e di Castrocarao, e che era stato
capitano di giustizia di Palermo e tenente maresciallo di
campo, ottenne dall’imperatore Carlo VI, al tempo re di
Sicilia, il Grandato di Spagna di 1a classe, che gli Asburgo
seguitavano a conferire, malgrado il trattato di Utrecht avesse
assegnato a un Borbone, nipote di Luigi XIV, le corone di tutti
i regni di Spagna (Leòn, Aragona, Castiglia e Granada). Il 5°
principe di Villafranca, Giuseppe, tolse in moglie un’altra Di
Giovanni, Vittoria, che portò agli Alliata, tra i tanti feudi e
titoli, anche la pretenzione alla dignità di principe del Sacro
Romano Impero, titolo riconosciuto dal regno d’Italia con
D.M. 9 aprile 1904. Passati per giustizia nell’Ordine Gerosolimitano fin dal 1530 con Giovan Battista, da Palermo (la
diramazione rimasta a Pisa farà il suo ingresso nel 1586 e, dal
1601, esprimerà buon numero di Cavalieri di Santo Stefano),
vestirono anche i prestigiosi abiti di altri ordini, tra i quali
Calatrava e Costantiniano di San Giorgio, cumulando alle
croci le fasce rosse del Supremo Insigne Real Ordine di San
Gennaro, dei quali l’ultimo fregiato fu, nel 1969, Giuseppe
Alliata, fratello maggiore (di quattro anni) del nostro
Francesco. Dal 1722, come s’è detto, vantano il Grandato di
Spagna di 1a classe, puntualmente rinnovato ai primogeniti,
sino al nostro autore. Ma abbandoniamo il notorio, lasciando a
chi voglia saperne di più l’imbarazzo della scelta
Data la sede, si permetta, però, una breve digressione araldica.
A Maruggio, presso Taranto, al di sopra dell’ingresso di quella
Matrice spicca l’arma di Giovan Battista Alliata, che dal 1560
fu titolare di quella ricca Commenda Magistrale. Lo scudo
appuntato, accollato ad eleganti svolazzi rinascimentali,
mostra l’arma Alliata, che era ed è D’oro, a tre pali di nero.
Essa, considerata la dignità ricoperta nell’Ordine da Giovan
Battista, ha il capo di Malta, cioè, di rosso, alla croce
ottagona d’argento. Detto capo, detto della Religione, è
normalmente caricato, però, di croce piana (1).
Sulla facciata di palazzo Villafranca, nella piazza Bologni di
Palermo, fanno bella mostra due ‘grandi’ armi Alliata, realizzate in stucco nella prima metà del Settecento dal famoso
scultore Giacomo Serpotta. Entrambe risultano:: Inquartato:
nel 1°, d’azzurro, alla pianta di frumento d’oro, spigata di tre
pezzi e nodrita su una zolla di terreno al naturale, accostata
da due leoni d’oro, affrontati e controrampanti (Di Giovanni);
nel 2°, d’oro, alla pianta sradicata di ruta (Paruta); nel 3°, di
rosso, alla colonna d’argento, con la base e il capitello d’oro,
coronata dello stesso (Colonna); nel 4°. di rosso, a due spade
d’argento, guarnite d’oro, passate in decusse, accantonate da
quattro spronelle d’oro (Morra); col capo di rosso, alla croce
d’argento (capo di Malta); sul tutto: d’oro, a tre pali di nero
(Alliata). Lo scudo in petto all’aquila bicefala di nero, beccata
e membrata d’oro, lampassata di rosso, le due teste sormontate dalla corona di principe del Sacro Romano Impero,
sorretta da due puttini alati. Dalla punta dello scudo, accollato
alla croce Melitense e posante sul manto di Principe del S.R.I.,
carico in basso di un trofeo d’armi, pende una corona di
rosario con croce ottagona di Malta, che viene a sormontare la
croce dell’Ordine di San Gennaro. Naturalmente (e ciò vale
anche per lo stemma che precede), l’assegnazione degli smalti,
assenti nel manufatto, è avvenuta sulla base della notorietà
araldica delle armi spettanti a famiglie di primaria nobiltà,
quali le predette. Da rilevare la persistenza del capo della
Religione con croce piana, non spettante alla famiglia, in
quanto non è traccia di concessione ereditaria, ma si tratta,
piuttosto, un diritto all’arricchimento dell’arma, spettante a
dignitari dell’Ordine Gerosolimitano. Ancora, l’errore nella
raffigurazione dell’arma Morra, rappresentata con le punte
delle spade verso l’alto, mentre la loro posizione corretta è
orientata in basso, verso la punta dello scudo. Va peraltro
detto che l’alleanza Morra non è da considerare ‘diretta’, ma
derivata. Anna Maria Di Giovanni, infatti, moglie – come s’è
ante scritto – di Giseppe Alliata, 4° principe di Villafranca, era
figlia di Domenico, principe di Trecestagne e di Isabella
Morra dei principi di Buccheri e di Castrocarao e da queste
nozze pervennero agli Alliata i tre principati. .Considerazione
d’ordine generale: essendo stato l’Insigne Reale Ordine di San
Gennaro istituito da Carlo III nel 1738 e di esso insignito,
primo della famiglia, il principe di Villafranca Domenico
Alliata nel 1747, i due grandi stucchi araldici devono avere
subito un più tardo intervento ‘integrativo’, dato che Giacomo
Serpotta si era spento nel 1732. (2)
All’interno del palazzo, in una sala detta oggi ‘dello stemma’,
si ammira un mosaico a piastrelle maiolicate di scuola
napoletana di fine Settecento, riproducente anch’esso una
‘grande arme’ Alliata. Anche questo splendido azulejo riporta
manto, aquila bicipite, trofeo d’ami, corona da principe del
Sacro Romano Impero e scudo inquartato, carico di scudetto
sul tutto, ma, dulcis in fundo, viene finalmente meno
l’improprio capo della Religione. Le quattro armi dell’
inquartato sono: Di Giovanni, Paruta, Colonna e Morra e
naturalmente, Alliata domina dallo scudetto sul tutto. Non
manca qualche stranezza: il manto, foderato d’ermellino,
appare d’oro, al pari del campo dell’arma Morra (le cui spade
seguitano a puntare verso il basso), che dovrebbe essere rosso.
Nell’arma del 3° punto si distingue malamente un tronco di
colonna, peraltro addestrato e non centrato, in uno sfondo
verdastro. Tale ultimo disastro araldico è parzialmente
imputabile alle ingiurie degli uomini e del tempo, considerato
che il mosaico, prima di essere portato a parete, dove oggi si
trova, era terragno, facendo parte della pavimentazione. (3)
In ultimo, ho rappresentato graficamente la blasonatura data
alla ‘grande arme’ Alliata da Palazzolo Drago, facendo
giustizia delle imprecisioni di cui sopra: Inquartato: d’oro,
alla panta di ruta, sradicata, di verde (Paruta); nel 2°,
d’azzurro, alla pianta di frumento d’oro, spigata di tre pezzi e
9
nodrita su una zolla di terreno al naturale, accostata da due
leoni d’oro, affrontati e controrampanti (Di Giovanni); nel 3°.
di rosso, a due spade d’argento, guarnite d’oro, passate in
decusse, accantonate da quattro spronelle d’oro (Morra); nel
4°, d’argento, a due fasce di rosso (Valguarnera); sul tutto:
partito: a) d’oro, a tre pali di nero (Alliata), b) scaccato
d’argento e di nero; colla bordura di rosso, carica di otto
crocette di Sant’Andrea d’oro (Bazan). Lo scudo in petto
all’aquila bicefala di nero, rostrata e membrata d’oro,
sormontata tra le due teste dalla corona di principe del Sacro
Romano Impero. Maria Bazan, di grande casa spagnola, era
figlia del barone Alvaro e nel 1870 andò sposa a Giuseppe,
11° principe di Villafranca e avo paterno di Francesco, al
quale facevano capo il titolo di principe del Sacro Romano
Impero, 8 principati, 2 ducee, 1 marchesato, 6 baronie, 20
signorie e, in più, il Grandato di Spagna di 1 a classe. Questa
imponente titolatura, alla sua scomparsa, è passata a Gabriele,
suo nipote ex fratre..
,
(1)
(2)
(3)
(4)
10
Tornando al volume, non è certamente il suo pregio minore la
freschezza. La raccolta di ricordi sembra stesa non da un
signore novantacinquenne, ma da un uomo nel pieno vigore
della giovinezza. È arduo compito una sintesi di queste pur
succinte (per numero di pagine) memorie, che abbracciano,
però, quasi un secolo, giacché lo stile, lucido e scarno, esige
decisa attenzione del lettore, che voglia andare oltre la semplice narrazione dei fatti ed entrare in sintonia con l’autore, il
quale non affida al caso:una sola virgola, ma talora, mediante
un sapiente aggettivo, conferisce colore, suono e valore a
quello che rimarrebbe soltanto un nome. La sua penna è un
obiettivo fotografico, capace di formare l’immagine, latente
non soltanto nel senso caro agli adepti di Nièpce, ma riferità
alla interiorità del personaggio ritratto.
È appena giusto che nell’infanzia giganteggi la figura ardita e
colta di mamà, Vittoria San Martino de Spucches, figlia di
quel Francesco, duca di Santo Stefano di Briga, storico eminente ben noto ai cultori dei nostri studi, in quanto autore della
monumentale, pregevolissima Storia dei feudi e dei titoli
nobiliari di Sicilia, pubblicata a Palermo in ben dieci volumi
dal 1924 al 1940. Ciò grazie anche al settenne nipote omonimo, che, su disposizione materna, pestò sui tasti di una macchina da scrivere, degna oggi di essere esposta in un museo, la
correzione delle bozze, che inevitabilmente risultarono infarcite di una caterva di comprensibili errori in tema di luoghi e
di nomi. Donna Vittoria, soprannominata dagli umili con grato
affetto la principona, è sicuramente la prima delle donne che
hanno arricchito la mia esistenza alla quali è dedicato il
volume. Credo che accanto ad essa si possa collocare la zia
paterna Felicita, autrice di un volume di memorie familiari
pubblicato nel 1946 da Flaccovio e plasmatrice sapiente di
apprezzate, baffutissime ‘teste di turco’, forse in qualche
modo ispirate dagli archetipi, costellanti l’incredibile palazzo
Beneventano di Scicli. Fu la nubile zia a donargli, quand’era
ancora un bambino la sua prima macchina fotografica, una
Kodak box, sulla quale esercitò la sua passione per l’immagine fissa, in attesa di passare alla tecnologicamente superavanzata Exacta. Fu sempre lei a sollecitare il suo interesse
per l’immagine dinamica mediante le proiezioni casalinghe su
Pathé Baby, sollecitando alla cognata l’asserzione secondo la
quale suo figlio Francesco sarebbe nato con la pellicola
attorcigliata al collo.
La guerra è finita. Nel campo Arar di Livorno ritrova e acquista la stessa Arriflex 35 mm con cui ha ripreso, per servizio, gli effetti dei bombardamenti e la distruzione dell’abbazia
di Montecassino. Ora l’amore di sempre per la natura e i mare,
esaltato dalla lettura di un libro galeotto, Tra squali e coralli
di Hans Haas, lo portano a catalizzare attorno a sé un piccolo
gruppo di amici e parenti e, con Pietro Moncada di Paternò,
Renzino Avanzo e il cugino (figlio di una sorella del padre),
Quintino di Napoli, fonda nel 1946 la Panaria Film. Intorno ai
fondatori ruoteranno i simpatizzanti, tra i quali il cugino
d’acquisto Fosco Maraini, consorte della cugina Topazia
Alliata, genitori di Dacia Maraini. Teatro d’azione, le splendide Eolie, al tempo pressoché ignote e del tutto incontaminate, nei cui fondali si iniziano a immersioni in apnea con
maschere e pinne di fortuna. Scafandra ingegnosamente una
Rolleiflex, ma gli scatti non bastano più: aspira a immagini
dinamiche. Superando grosse difficoltà d’ordine tecnico, primo nel mondo, realizza in quell’anno un lungometraggio
girato in mare aperto, Cacciatori sottomarini, che l’anno
successivo viene premiato al Festival di Cannes. Tonnara
(coevo, grosso modo, di Bianche Eolie, Isole di cenere e di
Tra Scilla e Cariddi) si afferma al Festival di Edimburgo del
1948 e Opera dei pupi è applaudito al Festival di Bruxelles del
1949. Anno fatidico questo, che vede i soci della Panaria
impegnati nella progettazione di Vulcano, ispirato dalla
vicenda di una ragazza di Filicudi, conosciuta al tempo delle
riprese di Cacciatori sottomarini. Se ne innamora Roberto
Rossellini, che è cugino di Renzo Avanzo, ma, purtroppo, un
altro amore, di fisica tangibilità, quello per Ingrid Bergman, lo
soppianta e gli fa abbandonare il set di Vulcano e la
protagonista, compagna nella vita, Anna Magnani. Le spese
corrono in salita e Rossellini (che frattanto, con faccia di
bronzo, sta plagiando pari pari il soggetto di Panaria e attende
alla realizzazione di Stromboli, interprete – manco a dirlo –
Ingrid) viene sostituito dal grande regista tedesco William
Dieterle, che l’hanno precedente ha trionfato a Hollywood con
Portrait of Jenny, la cui protagonista, Jennifer Jones, è la
moglie del grande produttore David O. Selznick. Attorno alla
Magnani ronzano ‘disturbatori’ come Raimondo Lanza di
Trabia ed Errol Flynn. Si erano conosciuti durante la guerra di
Spagna e l’attore, noto per le sue interpretazioni di don Juan
Tenorio, anche nella vita teneva fede al personaggio di gran
seduttore, al pari di Bela Lugosi che, a forza di vestire i panni
di Drakula, si convinse di essere un vampiro. Flynn era allora
proprietario di quella che era considerata l’imbarcazione più
bella del mondo, lo yacht “Zaca”, a bordo del quale raggiunse,
dalle coste della California, le isole Eolie.
Moncada, Maraini, Avanzo Alliata, di Napoli
Lo “Zaca”
Magnani, Flynn, Lanza
Le sorti di Vulcano non furono delle più felici, perché la
Bergman mise al mondo un figlio, Robertino, che esaltò la
platea del gossip e decretò un quasi successo a Stromboli,
mentre Vulcano venne considerato un suo plagio, malgrado
vero fosse esattamente il contrario. Ma non fu questo l’ultimo
danno, accompagnato da beffa (a dr poco) che Panaria Film
ebbe a subire dai mostri sacri del neorealismo, perché il colpo
grosso venne tre anni più tardi, a opera di Luchino Visconti,
celebre allora nel mondo cinematografico per Ossessione e La
terra trema. Era cognato dell’innocente Renzo Avanzo (che,
peraltro, ne subì non pochi sgarbi), che lo propose alla regia di
La carrozza d’oro, un film, tratto da un lavoro di Prosper
Mérimée, ambientato nell’America latina del Settecento,
protagonista ancora una volta la Magnani, nelle vesti di donna
di piccola virtù e di grande cuore. La carrozza del titolo era lo
stupendo cocchio, fabbricato nel 1766 per il principe di Butera
(oggi esposto a Palazzo dei Normanni), sottoposto a
scrupoloso restauro e, nel film, simbolo di corsa al successo.
Francesco Alliata appare quasi benevolo, quando definisce
Visconti ‘personaggio perverso’: lo specifico comportamento
tenuto dal pur grande regista nei confronti di Panaria Film,
per come descritto, sarebbe stato meritevole delle sanzioni
previste dall’art. 340 del codice penale e non soltanto. Per
oltre un anno non produsse un solo rigo di sceneggiatura, ma,
in compenso esigette un crescente numero di collaboratori alla
sua stesura (almeno quattordici), con nomi che andavano da
Moravia a Suso Cecchi D’Amico, tutti iperpagati. Quando
Alliata riuscì, dopo infiniti solleciti, a ottenere un abbozzo di
sceneggiatura, da presentare a De Pirro, direttore generale
dello Spettacolo, ebbe in mano una trama in cui, con tinte
granguignolesche, veniva sferrato un gratuito e volgare attacco
alla Chiesa, laddove le linee guide concordate prevedevano
nulla di più di una commedia scanzonata.. Interpellato,
Visconti rifiutò sdegnosamente di apportare alcuna modifica
al suo testo, per cui si rese necessario ricorrere a un altro
sceneggiatore, sopportando ulteriori spese. Era ormai evidente
che la posizione di Luchino era tale da portare alla rovina
Panaria e Francesco Alliata decise di giungere a un aut-aut
alla presenza di testimoni (occultati da un telone). Così,
quando venne consegnata al regista la nuova sceneggiatura,
con l’ordine di tradurla sul tamburo in narrazione filmica e
Visconti andò in escandescenze, Francesco, senza perdere
tempo in ulteriori chiacchiere, lo mise direttamente alla porta,
rifiutando cortesemente, poi, di addivenire a una sanatoria,
proposta da eminenti personaggi del cinema. Si apprese, poco
più tardi, che Luchino Viscconti, nel lungo periodo di
colpevole inerzia, aveva, a spese di Alliata & Soci, girato
Bellissima, interpretato da Anna Magnani, la quale, peraltro,
non si fece scrupolo di esigere da Panaria un aumento di 18
milioni sul cachet (per allora, favoloso) di 60 milioni,
concordato per la La carrozza d’oro, a causa proprio dei
ritardi viscontiani. Naturalmente, tutti i registi italiani,
chiamati a sostituire Luchino, si tirarono indietro,per
solidarietà coatta, ma fu tutt’altro che un male, perché la
realizzazione del film, alla fine, fu affidata a Jean Renoir, che
viene definito gran signore, oltre che magnifico artista, il
figlio dell’impressionista Claude-Auguste. Tra i tanti films,
aveva diretto l’indimenticabile La grande illusione e, peraltro,
era stato nell’anteguerra il maestro di Visconti. La carrozza
d’oro è opera di primo livello, il capolavoro di Renoir, che
ancora stupisce per l’elevatissimo livello estetico, ma, ai costi
sopportati a causa della scorretta ignavia di Luchino, si
aggiunsero quelli, al tempo ingentissimi, del pur splendido
Technicolor e la necessità di girare in teatro di posa, stante la
selva di cavi svettante per ogni dove nella Sicilia barocca. Il
bilancio economico di La carrozza d’oro, purtroppo, si
posizionò sul grande rosso, anche perché i media specializzati,
legati a Visconti, fecero barriera. I soci e i finanziatori, uno
dopo l’altro, si ritirarono e Francesco, rimasto solo, progettò
Sesto continente, la cui direzione tecnica fu affidata al
giovanissimo Folco Quilici, scopertto e formato sul campo (i
fondali di Ponza) da Francesco Alliata, al quale si associarono
personaggi della Technicolor, che, profittando di una malattia,
giunsero al punto impadronirsi della produzione, di
escludendo Alliata anche dai titoli del filmato.
Chiuso l libro sull’amatissimo cinema, nel 1956 Francesco
fondò la Sikelia, avendo a socio Pietro Moncada, l’amico di
sempre. Lo scopo era la rinascita e la diffusione, in chiave
forzatamente industriale, di quella sintesi armoniosa di gusti e
di profumi, che è il gelato siciliano, noto in Europa non
soltanto grazie ai partecipanti al Grand Tour, ma anche
11
all’intraprendenza di personaggi come il siciliano Procopio de
Curtellis (forse appartenente alla nobile famiglia Cutelli di
Catania), che, durante il regno di Luigi XIV, aprì a Parigi il
primo caffè d’Europa, dove grandi personaggi della corte e
delle lettere (da Saint-Simon a Voltaire, per esempio)
gustavano celebrati sorbetti. Il café Procope, si sa, esiste
ancora. I Valguarnera vantavano ‘diritto proibitivo’ sulla neve
(il ghiaccio) delle Madonie, per privilegio loro conferito dal
Senato di Palermo nel 1557. Tale privativa aveva, come
contropartita, l’obbligo di non farla mai mancare alla capitale,
per cui, ove le Madonie ne fossero state disgraziatamente
sprovviste, erano obbligati a procurarsela altrove e, per
fortuna, l’Etna non ne era mai sprovvisto. Pian piano, le
richieste si estesero a tutta l’isola, compresa la Malta dei
Cavalieri, e la neve divenne un business tutt’altro che
trascurabile. Sotto il marchio storico di Duca di Salaparuta,
nato nel 1824 per la commercializzazione dei pregiati vini di
Bagheria, la Sikelia ha prodotto granite, sorbetti e finanche
creme gelate, rappresentanti tutti un compromesso ottimale tra
artigianato e produzione industriale. A Pietro Moncada si
aggiunse una socia: Arabella Salviati, figlia di un rampollo
della storica famiglia fiorentina e di Igea Florio, ultimo rejeton
della famosa dinastia di armatori, sposa di un Lanza di Scalea,
dotata di notevole spirito imprenditoriale e di buone
introduzioni in campo politico. Con sostanziosi contributi
della Cassa del Mezzogiorno, Alliata entrò nei mercati della
floricultura e della surgelazione, ma l’odoree del sangue
richiama gli squali e ne giunsero tanti, per di più sponsorizzati
dalla Regione Siciliana. Ma non basta: intervennero gravi
boicottaggi di vario genere, immissioni sui mercati di prodotti
squalificati, intralci burocratici, atti vandalici, sottrazioni
sistematiche e, infine, venne dichiarato il fallimento di Sikelia,
malgrado il sui amministratore fosse disponibile al pagamento
della somma, rientrante nella sua disponibilità.
L’ultima battaglia di Francesco Alliata è certamente quella
che, se da un lato lo ha grandemente amareggiato, dall’altro
gli ha innegabilmente riservato soddisfazioni non da poco,
dato che ha ottenuto più di una vittoria contro avversari dotati
di enorme potere. Suo fratello Giuseppe muore nel 1979, lasciando erede universale la moglie, Saretta Correale Santacroce (Francesco ne ha sposato in prime nozze la sorella minore, Teresa, ancora vivente), che si spegne dopo lunga malattia nel febbraio 1988. Lascia con testamento il palazzo Villafranca di piazza Bologni alla Curia arcivescovile di Palermo
e la Villa Valguarnera all’Opus Dei. Nrll’ultimo periodo della
sua vita è stata assistita (e, di fatto, assolutamente isolata da
tutti, congiunti compresi) da una terza sorella Correale, che s’è
monacata l’anno precedente e si avvale di un factotum, ex
autista, che finirà col divenire custode per la Curia e custode
giudiziale per villa Valguarnera, quando, inopinatamente,
l’arcipotente prelatura personale (come tale, unica e senza
precedenti), fondata da padre Escrivà deciderà di rinunciare al
pingue lascito. Scempi d’ogni genere, ruberie, incuria
colpevole delle istituzioni preposte alla salvaguardia, si
abbattono sullo splendido palazzo e lo stesso archivio
gentilizio (che Francesco descrive nelle prime pagine: 34
armadi alti m.5, zeppi centinaia e centinaia di faldoni, ove è
tutta la documentazione storico-economica degli Alliata da
quando misero piede in Sicilia, appare grandemente
depauperato. L’ex autista si dà a una speculazione edilizia,
ovviamente all’insegna dell’abusività, realizzando un quartiere
nel parco della dimora, oggetto peraltro, di episodi misteriosi e
di minacciose presenze. Si scoprirà più tardo che il vecchietto
dai baffoni (finti), che circola nei viali e abita nella villa, altri
12
non è che don Binnu, al secolo Bernardo Provenzano, il
latitante al vertice della cupola mafiosa isolana.
Vittoria Alliata, la figlia Antea con le sue due bambine e il
bisnonno Francesco Alliata
Ma, fortunatamente, non è solo a combattere la battaglia,
perché accanto a lui è la terza donna della sua vita, la figlia
Vittoria, accorsa al suo richiamo, abbandonando le tante vie di
mondi lontani, percorse da lunghi anni nella ricerca della
conoscenza. Dietro l’aspetto, oscillante tra una basilissa e una
belle dame sans merci, si cela una determinazione d’acciaio,
degna degli avi pisani. Non soltanto insegue col fiuto del colto
segugio, nell’avita villa, tracce probanti della presenza
dell’Algarotti e di seguaci di Swedenborg, di von Hund, di
Naselli e di latomisti settecenteschi di diverse osservanze, ma
si batte lucidamente, coraggiosamente ed efficacemente su
mille fronti, senza mai prendere pur lontanamente in considerazione l’ipotesi di una resa e, così, è riuscita, tra mille
traversie, a salvare non solo a sé e ai suoi, ma a tutti noi, villa
Valguarnera, che era ormai sulla buona strada di fare la triste
fine di altri monumenti. Gli Alliata hanno già visto sparire, tra
l’Ottocento e i primi decenni del secolo scorso, quell’autentico
giardino dell’Eden, noto come Firriato Villafranca (settanta
ettari di meraviglie della fauna e dell’arte nel centro di Palermo), e il castello, d’età aragonese, di Villagonia, che impreziosiva la costa di Taormina. L’augurio è il palazzo, gemma
dell’antica capitale, torni agli Alliata, alla Sicilia, agli Italiani.
Un libro da leggere e da conservare per rileggere, insomma,
cui – per quanto mi sforzi – non posso attribuire altro che un
neo: l’assenza di un indice di nomi e di luoghi.
Angelo Scordo
Sul tutto periodico della SISA riservato ai Soci
Direttore
Alberico Lo Faso di Serradifalco
Comitato redazionale
Marco Di Bartolo, Andrew Martin Garvey,
Vincenzo Pruiti, Angelo Scordo
Testata del periodico
di † Salvatorangelo Palmerio Spanu
Indirizzi postali
Direttore: Piazza Vittorio Veneto n. 12 10123 Torino
Redattore: Marco Di Bartolo, via IV novembre n. 16 10092 Beinasco
(Torino)
Sito Internet
www.socistara.it
Posta elettronica
[email protected], [email protected]
Segreteria della Società
Arch. Gianfranco Rocculi. Via S. Marco 28 20121 Milano