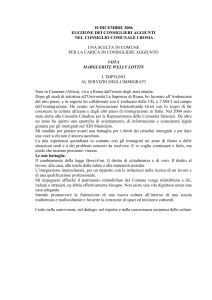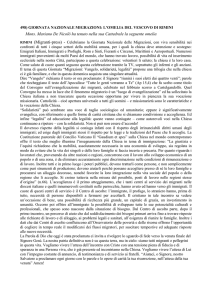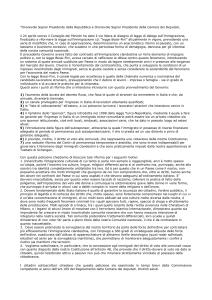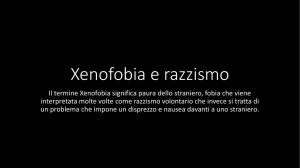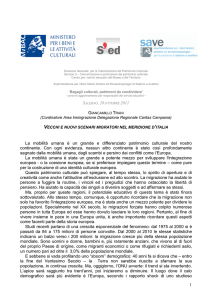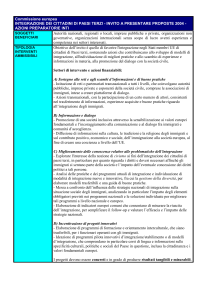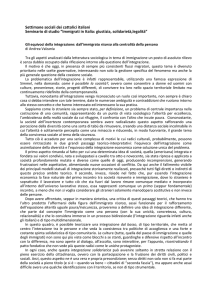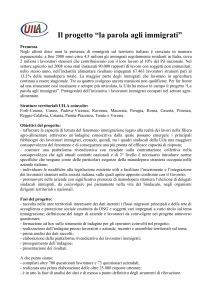64
2/2008
Sommario
Dossier
A
frica
e Mediterraneo
C
U L T U R A
E
S
O C I E T À
MEDICINA E MIGRAZIONE
Introduzione. Immigrazione e povertà: una risorsa per il Nord del Pianeta
Globalizzazione e culture della salute. Corpi migranti e società plurale
I paradigmi del diritto umanitario e delle politiche del trauma in Italia
Verso una clinica costituita da teorie molteplici
Salute mentale e migranti.
Il lavoro nel Dipartimento di Salute mentale di Bologna
ESPERIENZE: Le service de psychopathologie de l’enfant et de
l’adolescent de l’Hôpital Avicenne
La salute delle persone in viaggio
ESPERIENZE: Fondazione europea per la Genetica
Una sfida per il futuro. L’INMP
Chi cura la salute dei cittadini stranieri?
ESPERIENZE: Centro Frantz Fanon; Centro di consulenza
sulla relazione - Associazione Shinui
La salute delle donne migranti
Tubercolosi e immigrazione
ESPERIENZE: Alimentazione e immigrazione: problemi aperti
2
di Stefano Allievi
8
di Sarah Klingeberg
14
di De Timmerman, Hounkpatin, Stortoni, Zountekpo 21
di Aldo Morrone
di Silvia Festi e Paolo Ballarin
25
par Marie Rose Moro
30
31
35
36
39
di Rabih Chattat
di Serena Paterlini
di Aldo Morrone e Ottavio Latini
di G. Dallari, T. Paganelli, P. Schildkraut
di Nicola Villanova
46
47
51
58
La crisi somala e la partecipazione delle donne alla ricostruzione dello Stato
di Elisa Pelizzari
59
Musei READ-ME. Musei etnografici e diaspora
di Anna Maria Pecci
Femmes dans les arts d’Afrique
di Francesca Fattori
62
64
Intercultura I “luoghi comuni” dell’intercultura
di Lorenzo Luatti
Interacció 2008: politiche locali per l’intercultura
di Sandra Federici
a cura di Silvia Festi
di Tatiana Di Federico e Marco Minarelli
di A. Matteelli, I. El-Hamad, M.C. Raviglione
Situazioni
67
71
Eventi Sala 1 - Viaggio in Burkina Faso, Aubervilliers portraits sensibles
73
Libri V.Y. Mudimbe, José Eduardo Agualusa, Fabrizio Gatti, Pedro F. Miguel Muxima, Jean-Philippe Stassen
76
DOSSIER
Castel
Sant’Angelo,
Roma 2007.
Foto di Sarah
Klingeberg
2
Introduzione.
Immigrazione e povertà:
una risorsa per il Nord del Pianeta
di Aldo Morrone
Molti anni fa un ragazzo genovese di tredici anni, figliuolo
d’un operaio, andò da Genova in America, solo, per
cercare sua madre. Sua madre era andata due anni prima
a Buenos Aires, città capitale della Repubblica Argentina,
per mettersi al servizio di qualche casa ricca, e guadagnare
così in poco tempo tanto da rialzare la famiglia, la quale,
per effetto di varie disgrazie, era caduta nella povertà e nei
debiti. Non sono poche le donne coraggiose che fanno un
così lungo viaggio con quello scopo, e che grazie alle
grandi paghe che trova laggiù la gente di servizio,
ritornano in patria a capo di pochi anni
con qualche migliaio di lire.
(Edmondo De Amicis, Cuore)
Oggi l’esule incarna, modificandone il senso originario,
l’ideale formulato nel XII secolo da Ugo di San Vittore: L’uomo che trova dolce la sua patria non è che un
tenero principiante; colui per il quale ogni terra è come
la propria è già un uomo forte; ma solo è perfetto colui
per il quale tutto il mondo non è che un paese straniero
(…). Io che sono un bulgaro che vive in Francia, prendo a
prestito questa citazione da Edward Saïd, palestinese che
vive negli Stati Uniti, il quale l’aveva trovata, a sua volta,
in Erich Auerbach, tedesco esule in Turchia.
(T. Todorov, La conquista dell’America)
U
no dei paradossi più complessi attualmente correlati al fenomeno immigratorio è la sua costante percezione come problema di sicurezza sociale, come
paura dell’Altro, del diverso, la terribile sensazione che
possano essere veicolate malattie infettive emergenti e riemergenti, apparentemente scomparse dai nostri territori.
L’inquietudine legata alla presenza di “qualcuno” che non
conosciamo, che non sappiamo bene cosa voglia fare “sul
nostro territorio” e soprattutto cosa voglia portarci via e
casa imporci, rimane una costante del nostro immaginario
collettivo che, soprattutto in quest’ultimo periodo, alcune
forze politiche tentano di manipolare, per imporre un clima di paura, di xenofobia se non di razzismo.
Dall’altra parte la presenza di fasce di popolazioni immigrate sembra aver risvegliato in alcune coscienze una sorta
di bisogno di prendersi cura dei fratelli minori e bisognosi
di tutto, in nome di una solidarietà, troppe volte incentrata
più sul donatore e sui suoi interessi che non sulla figura,
peraltro nobile e portatrice di valori e non solo di necessità, che dovrebbe essere oggetto di questa benevolenza.
Siamo quasi all’esaltazione, grazie all’immigrazione, di una
bontà a volte ambigua, di una solidarietà disgiunta dalla
giustizia. Ma sappiamo che non vi può essere pace e riconciliazione, senza giustizia.
Superare l’emergenza
L’immigrazione non è più un fenomeno emergenziale, ciònondimeno le novità legislative, economiche e culturali determinate da questa nuova realtà non sono sempre di alto
profilo, né condivise da tutti. Infatti occorrerebbe oltrepassare il livello delle iniziative, dettate dall’emergenzialità
e dalle politiche umanitarie in genere condannate ma nei
fatti accettate perché foriere di fondi e contributi economici. Infatti essendo queste politiche attuate soprattutto con
la giustificazione dell’emergenza, sono difficilmente controllabili e verificabili riguardo all’efficacia e alla validità.
Si tratta di un “pantano” di iniziative che spesso non contribuiscono a migliorare il quadro sociale dell’immigrazione mentre consumano finanziamenti pubblici, pagati dai
contribuenti. Inoltre si tratta di una ambigua gestione di
fondi, talora concessi a pioggia, pur di evitare di scontentare qualche associazione o lobby pseudo-solidaristica.
Oggi abbiamo di fronte una sfida alla quale eravamo fortemente impreparati, ma che dobbiamo affrontare in termini
di analisi serie e di interventi altrettanto elaborati e competenti. Non è più il tempo per iniziative empiriche e prive
di prospettive.
Innanzitutto, nell’impegnarsi fortemente per gli immigrati,
persone impoverite, è necessario chiedersi chi o che cosa,
quale sistema economico o sociale, li abbia costretti alla
perdita del lavoro, del sostegno economico, o addirittura
del loro futuro e della loro dignità.
Il fenomeno immigratorio inoltre si presenta sempre più
diversificato, nel territorio, nel tempo e nelle sue caratteristiche. Si può disegnare una mappa delle presenze di immigrati alquanto fluttuante, con luoghi che si riempiono o si
svuotano, spesso con frequenza stagionale. Non riusciamo
ancora a comprendere l’inesistenza del contenuto della parola “immigrato”. Troppo diverse sono le realtà dei paesi
da cui provengono queste persone, troppo diverse le stesse
persone, donne, bambini, uomini, giovani, anziani, rifugiati, richiedenti asilo politico, vittime della tortura, vittime
della tratta sessuale, migranti per lavoro, familiari ricongiunti, studenti stranieri. Cattolici, islamici, protestanti,
ortodossi copti, indù, buddisti, solo per citare le principali
religioni di appartenenza. Culture e colori della pelle innu-
3
AeM 64 nov. 08
merevoli non semplificabili con la parola “immigrati”. Portatori di valori, di concezioni della salute e della malattia
così diversificate da non essere uniformabili da un minimo
comune denominatore. Fortunatamente.
4
Disuguaglianza e salute
Cosa significhi l’espressione “corpi migranti” ce lo spiega
in questo dossier Stefano Allievi, che sottolinea il cambiamento del paesaggio dovuto all’immigrazione, gli effetti
sistemici e i cambiamenti sia nel sapere medico che nelle
sue pratiche, già particolarmente complesse prima dell’arrivo degli immigrati. La cultura della salute può migliorare
grazie alla presenza di tante diversità o si trova prigioniera
di un metodo clinico-sperimentale che non prevede modifiche da parte dei soggetti che lo dovrebbero applicare? In
altre parole, può migliorare una medicina troppe volte attenta più ai profitti che può realizzare nella sua estensione
pratica, che non alle persone malate, ormai comunemente
definite “pazienti” o peggio ancora“utenti”, creando una
nuova categoria di passivi consumatori di prestazioni sanitarie e farmacologiche, spesso inappropriate, inutili e
talora dannose?
Alcune malattie sembrano emergere, o meglio, riemergere,
perché in effetti non erano mai state definitivamente eradicate, ma solo ridotte o scomparse tra le fasce alte della
nostra popolazione. La tubercolosi è una di queste. Solo il
nome richiama alla memoria dei medici più anziani immagini di sanatori, di corpi violati nella loro forza e giovinezza.
Montagne di pagine di letteratura e di arte. Oggi, anche
dinanzi a un sistematico armamentario diagnostico-terapeutico mai immaginabile nel passato, riesce a spaventare e
a offrire lo spunto per rilanciare la “pericolosità” dell’altro,
dello straniero. Eppure noi avevamo assistito a un forte aumento della presenza di questa malattia, ben prima dell’arrivo degli immigrati, quando scoprimmo che una nuova
sindrome, chiamata poi AIDS, portava alla morte tante
persone, proprio a causa della tubercolosi, che rappresentava l’evento fatale in soggetti colpiti da questa immunodeficienza acquisita che consentiva a batteri, a virus, presenti
in forma parassitaria o saprofitica, di sviluppare la malattia
di cui erano portatori. Alberto Matteelli, Issa El Hamad e
Mario C. Raviglione ci offrono la descrizione clinica delle
diverse forme di TB negli immigrati, gli aspetti legati alla
loro cura in Italia e in Europa, dati scientifici sugli approcci
intrapresi per incrementare e facilitare l’accesso alla diagnosi e alla cura della TB e sul rapporto costi-efficacia per
la sua prevenzione e eradicazione.
Strettamente legata a questo argomento è l’analisi condotta da Giovanna Dallari, Tommaso Paganelli e Pirchia
Schildkraut sulle ineguaglianze dello stato di salute tra i
diversi individui presenti nella nostra società. È noto che a
parità di patologie acquisite, le persone con minore istruzione presentano un rischio di morire notevolmente maggiore, rispetto a soggetti laureati. Per i disoccupati, inoltre,
il rischio di ammalarsi seriamente di patologie gravi e debilitanti è proporzionalmente legato al tempo di disoccupazione vissuto. Numerosi studi hanno documentato che la
mortalità, in Italia come in altri stati, cresce con il crescere
dello svantaggio sociale. Alcune ricerche mostrano che le
diseguaglianze nella mortalità non si riducono nel tempo,
anzi sembrano ampliarsi, almeno tra gli uomini adulti.
Effetti diretti della povertà e dell’emarginazione sono misurabili sulla mortalità delle persone e delle famiglie assi-
stite dai servizi sociali per problemi di esclusione (malattie mentali, dipendenze, povertà, disoccupazione), che in
alcune zone presentano uno svantaggio nell’aspettativa di
vita di 13 anni per gli uomini e 7 per le donne, rispetto al
resto della popolazione.
Altri studi epidemiologici sottolineano dati che coloro che
lavorano tra i più poveri e gli emarginati ben conoscono: i
disoccupati hanno una probabilità di morire tripla rispetto a quella degli studenti loro coetanei, e più che doppia
rispetto a chi ha una occupazione (…). Da numerosi anni
sono noti alla comunità scientifica questi dati. Ci si sarebbe
aspettato un intervento forte di politica sanitaria di prevenzione e promozione della salute che cercasse negli anni di
invertire questa tendenza, che invece in ogni ulteriore studio clinico-epidemiologico di settore ha sempre confermato l’aumento delle disparità tra ceti sociali differenti.
Il bambino che nasce oggi in un Paese industrialmente sviluppato ha una prospettiva di vita media intorno ai 75-80
anni, mentre dai tempi greco-romani a tutto il XVIII secolo
questa attesa di vita non eccedeva il trentennio. La stessa
differenza corre, oggi, tra un bambino che nasce nei nostri Paesi industrializzati e un neonato dei Paesi in via di
“ulteriore sottosviluppo”. Notizie di questo genere sono
oggetto di costante e persino scolastica divulgazione: tutti
le conoscono, ma nessuno agisce conseguentemente. Però
non si sa che la vita media non usava distinguere per classi
sociali, per livelli culturali, fino all’inizio della rivoluzione
industriale: è in questo periodo che la vita, la morte e la
malattia imparano a discriminare sempre più severamente e
attentamente, entro una stessa collettività, tra ricchi e poveri, tra autoctoni e immigrati. Numerosi studi epidemiologici dimostrano questa semplice tesi: si vive, ci si ammala e si
muore di classe, come sulla tragica tolda del Titanic.1
Anche la malattia, come la cultura, è diversamente percepita dalle diverse persone che la vivono. Il termine stesso
di malattia esprime in realtà significati diversi rispetto a chi
la subisce e a chi la cura. Il modello antropologico statunitense ha distinto due diversi concetti di malattia: disease
e illness. Disease è la malattia intesa come realtà oggettiva, misurabile con metodi matematico-sperimentali, con
visualizzazione dei diversi organi, separati dal contesto
culturale.
Illness esprime la malattia così come è vissuta e percepita dal paziente, con tutta la sua cultura, i suoi sentimenti
e emozioni (Fabrega 1974). È stato affermato che illness
è quello che vive e sente il paziente quando va dal medico, disease è quello che ha quando torna dall’ambulatorio
(Cassel 1976). Se ciò accade nella stessa cultura immaginiamoci quanto diverse sono le percezioni tra persone appartenenti a culture diverse. Lo stesso può affermarsi per
quanto riguarda il concetto di “salute”.
Dare una definizione di malattia non è certamente facile.
Esiste una fondamentale differenza tra “essere malato” e
“avere una malattia”. Gli autori anglofoni contemporanei
hanno introdotto una sottile e fondamentale distinzione
con l’uso dei termini illness e disease, che si ritrova anche in
autori di lingua tedesca (Erkrankung e Krankheit), mentre
in francese, italiano e spagnolo è assente ogni distinzione.
Il termine illness dovrebbe essere usato per designare l’esperienza diretta del malato, il “vissuto della malattia”, mentre
disease dovrebbe essere riservato alla concettualizzazione
della malattia da parte del medico. Esiste però anche una
differenza fra “essere malato” (sentirsi tale) e “essere un
malato” (e cioè essere riconosciuto come tale), da cui deriva la necessità di introdurre un terzo termine, sickness, per
indicare la percezione della malattia da parte dell’ambiente
non medico che circonda il soggetto.
Vittime o cittadini?
L’immigrazione è sempre stata e rimane un processo altamente differenziato. Vi possono prendere parte sia coloro
che hanno un progetto migratorio definitivo, sia quelli con
una mentalità solo conoscitiva e temporanea. In Europa,
negli anni Settanta, gli immigrati si sono trasformati da “riserva di manodopera straniera” in comunità di immigrati
o comunità etniche. Questo ha reso insufficienti i meccanismi di integrazione che avevano funzionato sino ad allora,
comportando conflitti di livello nazionale e locale nei vari
paesi dove l’immigrazione era maggiore. Fino ad allora
gli immigrati erano stati considerati prevalentemente forza lavoro, un contingente relativamente strutturato la cui
integrazione faceva automaticamente seguito all’impiego,
mentre la forza propulsiva dell’immigrazione era l’elevata
domanda di manodopera. Ora con la riunificazione familiare e la crescita della seconda generazione emergono in
primo piano questioni quali alloggio, scuola, associazionismo e commercio. Le questioni relative all’integrazione
non sono più rimaste confinate nei luoghi di lavoro e si
sono considerevolmente ampliate le basi da cui formulare richieste. L’esperienza dimostra che l’integrazione è
agevolata anche dalla promozione di associazioni e attività culturali. Si deve cercare di realizzare un’integrazione
molto diversa da quella originariamente pensata in Francia, in Germania o nel Regno Unito alla quale gli immigrati dovevano adeguarsi. Alcuni articoli di questo dossier
(Nathalie De Timmerman, Lucien Hounkpatin, Federica
Stortoni e Anne Zountekpo, Silvia Festi e Paolo Ballarin,
Marie Rose Moro) riportano alcune importanti esperienze
nell’ambito dei servizi di salute mentale offerti ai cittadini
di origine immigrata in una prospettiva etno-psichiatrica in
Francia e in Italia.
Certamente, la presenza di numerose donne e di intere
famiglie ha cambiato notevolmente lo scenario immigratorio e su questo tema si sofferma l’articolo di Tatiana di
Federico e Marco Minarelli. Di conseguenza, si sarebbe
dovuto modificare anche il modello di assistenza sanitaria
proposto dal nostro Servizio sanitario nazionale. Eppure,
così non è stato. Invece di accettare la sfida rappresentata
dalla realtà di persone provenienti da culture altre, e rimodellare una offerta di servizi socio-sanitari diversificati, elastici e soprattutto a misura umana, si è preferito cercare di
rivolgere agli stranieri quegli stessi servizi che spesso non
erano più attenti alle persone, ma solo alle malattie, o ancora meglio alla logica di produrre profitto dalle malattie.
Si è travasato nella sanità una massa di persone straniere
che hanno sostituito nelle fruibilità del servizio stesso gli
italiani che ormai, ad eccezione dei servizi di emergenza e
di alta tecnologia, si rivolgono al servizio sanitario privato,
potendo detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese
sostenute. Si tratta di una percentuale di oltre il 25-30 per
cento dell’intera popolazione che utilizza i servizi pubblici.
È ancora lontano lo sviluppo di una medicina attenta alle
complesse problematiche delle persone, al rispetto delle
diverse dignità e culture, al disagio esistenziale dei migranti economici (Rabih Chattat), alla condizione di trauma dei
richiedenti asilo e dei rifugiati (Sarah Klingeberg).
Tra gli immigrati infatti un ruolo particolare assume la presenza di richiedenti asilo politico e vittime di tortura. A
livello mondiale e istituzionale la tortura è oggetto di una
incondizionata condanna in tutti i documenti internazionali sui diritti umani eppure la sua pratica è stata denunciata in oltre cento Paesi.
Il dibattito sulla tortura è molto antico, quasi quanto la storia del genere umano. Ne hanno discusso filosofi dell’antichità classica, dell’età moderna e del XX e XXI secolo.
Oggi si lavora sapendo che le carte dei diritti e legislazioni internazionali, unanimemente e apparentemente, la
condannano. È vero, la tortura è vietata, ma certamente
non impedita e non passa giorno senza che venga messo al
centro del dibattito internazionale il tema della sicurezza
cui tutto si deve piegare, anche la tutela dei diritti umani.
Quando le immagini dei corpi nudi, umiliati e accatastati
della prigione di Abu Ghraib furono divulgate nel 2004,
non si poteva più negare l’uso della tortura da parte delle
forze armate statunitensi in Iraq, ma si cercò di sminuire e ridurre. Newsweek, nel 2004, intitolava una delle sue
copertine: “Legittimare la tortura?”. Questo vuol dire che
assistiamo a una regressione, in fatto di diritti umani, sul
piano culturale prima che su quello giuridico, .
Un altro elemento da sottolineare è il rischio di trasformare una popolazione, quella immigrata, considerata da tutti
come una popolazione giovane, acculturata, sostanzialmente sana, in una massa di persone bisognose di tutto, quasi
prive di dignità, di ricchezze culturali e professionalità diverse. Spesso un’errata percezione di questa popolazione,
in una prospettiva di pseudo solidarietà, non riconosce la
forza di innovazione, di arricchimento culturale e politico
che deriva dalla loro presenza e anche il loro apporto in termini di rimodulazione dell’organizzazione dei servizi sociali, scolastici e sanitari. Importante è anche il loro contributo
al mondo dell’economia, della finanza e del lavoro.
Gli immigrati spesso vengono percepiti e rappresentati
solo come passivi fruitori di servizi e non cittadini partecipi della complessità della vita delle nostre città e del nostro
Paese. Osservato dall’esterno il mondo dei migranti appare
come quello dei poveri: è tutto negatività. Chi vive invece
all’interno del mondo dell’immigrazione conosce bene la
sua vitalità e la sua creatività. Gli immigrati lottano per sopravvivere, sfidano la sorte e il destino contrario, pronti ad
affrontare viaggi della disperazione: il mar Mediterraneo
per molti di loro, per troppi di loro, rappresenta ormai la
fine definitiva dei loro sogni. Gli immigrati hanno inventato lavori informali, si pensi solo ai lavavetri, ai venditori
ambulanti agli incroci, alla nuova professione di “mediatore culturale”. Costruiscono comunità caratterizzate dalla solidarietà, da un forte anelito di giustizia. Le persone
immigrate si riconoscono uguali nella diversità di origine,
con proprie forme di espressione, comprese l’arte, la narrazione letteraria e la poesia.
Credo che dovremmo imparare a riconoscere nel fenomeno immigratorio la grande sfida dei poveri all’intera società
dei ricchi. Nella tradizione biblico-cristiana la salvezza per
tutti viene solo dal mondo dei poveri. Per questo i portatori simbolici della salvezza sono il debole e il piccolo,
l’orfano e la vedova, lo straniero e la vittima. Nel mondo
dei poveri, quindi, c’è un principio dinamico di salvezza,
che dà avvio a elementi e impulsi di salvezza.
Noi riteniamo che questa prospettiva di cambiamento, tenendo al centro della società i più poveri, sia consegnata
5
AeM 64 nov. 08
dalla storia specificamente a loro, soprattutto nella loro dimensione di “umanizzazione”, nella loro capacità di prendersi cura dell’intera famiglia umana.
Questa tesi è certamente controcorrente, poiché il mondo
dell’abbondanza crede già di aver conseguito la salvezza
o, per lo meno, di essere ben avviato sulla strada per raggiungerla.
Di conseguenza il fatto che la salvezza venga dal basso è
tanto alternativo quanto lo sono, nell’ambito della fede,
le parole di D. Bonhoeffer «Solo un Dio che soffre può
salvarci».
Il nostro mondo è configurato da una civiltà della ricchezza che fa dell’accumulo di capitale il motore della storia e
del suo possesso e sfruttamento il principio di umanizzazione. Questa civiltà non soddisfa, non civilizza. Pur essendoci eccedenze, essa non soddisfa le necessità basilari delle
maggioranze del pianeta, il che mette in grave pericolo la
specie umana e non favorisce le relazioni fraterne. Occorre
quindi favorire una civiltà della povertà che abbia come
principio dello sviluppo la soddisfazione delle necessità
basilari e faccia della crescita della solidarietà condivisa e
della giustizia il fondamento della umanizzazione. Perché
una civiltà della povertà si realizzi è necessario il massimo
contributo da parte di tutti, ma una simile civiltà scaturisce
più naturalmente dal mondo dei poveri e degli esclusi.
Dalla solidarietà ai diritti
Ogni giorno veniamo bombardati da messaggi sulla necessità di essere solidali. Sembra quasi che l’interesse maggiore della nostra società sia la solidarietà. Ma è davvero
così? È possibile che una società come la nostra, cinica,
ipocrita e pronta alla guerra per esportare ovviamente la
democrazia, sia sinceramente interessata alla solidarietà?
Eppure apparentemente sembra così: la solidarietà ormai
è un fatto di costume.
Le sue manifestazioni esterne sono ogni giorno sotto i riflettori dei mass media. Ai poveri non viene lasciata più
neanche la dignità della loro privacy.
Dubitiamo fortemente che l’attenzione ai problemi che ci
circondano possa essere praticata come se si sfilasse su una
passerella cinematografica.
Crediamo che l’assunzione di responsabilità storiche appartenga a tutti noi come esseri umani e che investire sulle
creature più fragili sia l’unica scelta che possiamo fare se
vogliamo un futuro per noi e per i nostri figli.
Eppure la solidarietà rafforza la sua faccia “pubblicitaria”.
Non c’è trasmissione televisiva in cui non venga declamata. Nessuno può permettersi di non dirsi solidale, senza
pensare che cosa tale qualifica possa comportare nella sua
vita, quale cambiamento. Occorre diffidare di tale inflazione, perché si rischia l’appiattimento, la negazione del
conflitto.
Giovanni Franzoni in uno straordinario libro dall’eloquente titolo La solitudine del samaritano ci ricorda che talvolta
l’assistenza e la beneficenza sembrano ignorare le cause del
bisogno e dell’impoverimento sistematico di alcune fasce
sociali. È bene quindi interrogarci spesso sulla validità e
sulla correttezza delle istituzioni della solidarietà e della
carità, siano esse di ispirazione cristiana o laica. Siamo in
presenza di poveri o di impoveriti? Gli immigrati clandestini: chi li ha resi clandestini?
L’esperienza ci ha insegnato che spesso la carità è carica di
pericoli. L’aiuto al prossimo tocca lati profondi della per-
sonalità, segnati da ambiguità. L’amore si può trasformare
in possessività e in potere. Il dono può liberare una persona dal bisogno immediato, ma può creare una dipendenza
legata alla gratitudine che non è certo liberatoria. Telethon
fa a gara per pubblicizzare i nomi dei benefattori assieme
al loro potere.
È ormai ampiamente noto quanto le varie forme di aiuto
allo sviluppo dei Paesi cosiddetti in via di sviluppo possano essere in realtà forme di incremento della ricchezza
dei Paesi donatori. Un’altra forma di ritorno oltre all’autogratificazione e al rendimento, è forse la più sottile: la
solidarietà come forma di controllo sociale.
Filippo Gentiloni, in un suo articolo, pur non proponendo
ricette, indica alcuni percorsi. Evidenziare prima di tutto i
conflitti. La solidarietà non li elimina, ma rischia di occultarli, se la si invoca quale terreno di incontro tra le parti,
“valore” sul quale ci sarebbe accordo, anche se poi li divide il denaro, il colore della pelle, il sesso.
Molti hanno interesse a far apparire la società “solidale”:
dolce, cortese e affettuosa, preoccupata dell’Altro. Chi sta
bene avrà anche la soddisfazione di sentirsi solidale: a posto con la coscienza, gratificato, buono. Chi sta male non
avrà il diritto di protestare, beneficiato e schedato com’è.
Attenzione dunque a non credere a una società senza
dramma, scontro, tragedia, senza “peccato”.
Nella parabola del samaritano, l’amore è un atto generativo che non controlla le risposte. L’amore del samaritano si
esprime come vita che restituisce vita e non si consuma in
un intreccio di amore reciproco. C’è il più assoluto disinteresse a sapere come reagirà l’altro, così come una madre
nel dare alla luce non si pone il problema di come il figlio
si orienterà sull’apprezzamento della vita.
L’insegnamento di Gesù, nella parabola del samaritano, si
conclude in una esortazione ad assumere come modello
un gesto di compassione totalmente disinteressato e immotivato. Nella mia esperienza quotidiana di medico, ho
potuto incontrare tante persone che in questi anni hanno
reso possibile garantire il diritto alla tutela della salute agli
immigrati clandestini presenti in Italia. Sono persone che
con grande sacrificio e sofferenza personale testimoniano
la loro fedeltà all’umanità sofferente, con discrezione e riservatezza, senza richiedere nulla in cambio, senza imporre
nessuna onerosa gratitudine.
Per quanto riguarda il grande tema della salute, l’immigrazione e la povertà potranno essere paradossalmente una
spinta per favorire un nuovo modello di sanità più attento alla realtà delle persone che ai ricavi nell’erogazione di
prestazioni sanitarie inappropriate. Il Sistema sanitario nazionale può rappresentare uno straordinario strumento di
inclusione sociale e di integrazione, sempre che venga realizzato privilegiando la prevenzione e l’accesso appropriato
ai servizi, senza “dopare” artificialmente la domanda di salute dei cittadini. Si tratta di impedire la realizzazione di un
Sistema sanitario che imponga una sorta di “consumismo
farmacologico” e di prestazioni sanitarie inappropriate e
inutili. Negli ultimi anni sembra di assistere a un progressivo slittamento verso una gestione della sanità improntata a
un forte economicismo, con il risultato di mettere in secondo piano la complessa strategia necessaria per promuovere
e tutelare la salute dei cittadini: sembra emergere una riduzione impropria della tutela della salute al mero processo
di erogazione di prestazioni sanitarie. In questo contesto
spesso le regioni si sono limitate a erogare o “vendere” pre-
stazioni sanitarie senza intervenire sulle cause delle malattie e senza promuovere un’adeguata prevenzione.
Oggi siamo riusciti a rendere fruibili servizi alle donne e
alle famiglie immigrate, ma senza che la medicina indagasse sulle cause di malattie dovute al lavoro nero; siamo
capaci di praticare interruzioni volontarie di gravidanza
nelle strutture pubbliche, ma non siamo ancora in grado di
favorire la maternità responsabile per le donne immigrate,
che percepiscono spesso la gravidanza come l’anticamera
del licenziamento. Ci sembra di essere nella direzione giusta, ma occorre ancora fare molta strada affinché la promozione della salute e la prevenzione delle malattie siano
assicurate alle fasce più povere della popolazione, e in particolare alle donne, siano esse straniere o italiane.
Aldo Morrone è Direttore generale dell’Istituto Nazionale
per la promozione della salute delle popolazioni Migranti
e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) di
Roma. Esperto di Medicina delle Migrazioni, delle patologie tropicali e della povertà, è docente in numerose università italiane e straniere e consulente dell’Ufficio dell’OMS
di Venezia su Povertà, Salute e Sviluppo. È autore di oltre
cinquecento articoli scientifici e di venti libri
NOTE
1 - Quando il Titanic andò a cozzare contro un iceberg durante il
viaggio inaugurale nel 1912, si ebbe la dimostrazione di quanto affermato. In quella catastrofe, la classe sociale di ciascun passeggero fu uno dei fattori che determinarono se egli sarebbe annegato
o sopravvissuto. La lista ufficiale delle vittime dimostrò che, su un
totale di 143 viaggiatrici di prima classe, solo 4 perirono (delle quali
3 avevano scelto volontariamente di rimanere sulla nave). Fra le viaggiatrici della seconda classe, le vittime furono 15 su 93 e nella terza
classe 81 donne su 179 affondarono con la nave. I passeggeri della
terza classe ricevettero l’ordine di rimanere sotto coperta e in alcuni
casi l’ordine fu fatto eseguire sotto la minaccia delle armi. (W Lord,
A Night to Remember, H. Holt & Co, New York 1955, p. 107, cit.
da A.B. Hollingshead e F.C. Redlich, Classi sociali e malattie mentali,
Einaudi, Torino 1965, p. 12).
A pag. 6
dall’alto:
Due
immagini
dell’Istituto
Nazionale
per la
promozione
della salute
delle
popolazioni
Migranti.
© INMP
Permesso di
soggiorno,
Roma 2007.
Foto di Sarah
Klingeberg
T
he phenomenon of immigration and health:
the solidarity and the right to health care; Aldo
Morrone invites us to reflect on these fields through
ideas develope during his long experience as General
Director of the National Institute for Health,
Migration and Poverty (INMP).
Morrone tackles the issue of immigration as a process
that requires services, but, at the same time, that
offers modern medicine the possibility of revising its
approach towards both illness and the patient.
7
AeM 64 nov. 08
DOSSIER
Globalizzazione e culture della salute.
Corpi migranti e società plurale
di Stefano Allievi
Yo llevo en el cuerpo un dolor
Que no me deja respirar
Llevo en el cuerpo una condena
Que siempre me hecha a caminar
(Manu Chao, Clandestino)
I
l paesaggio socio-culturale nel quale siamo inseriti sta
cambiando in maniera radicale e con rapidità inaspettata. Non solo cambiano alcuni elementi della società,
ma si sta producendo un nuovo tipo di società, e una
nuova comprensione della medesima. Un cambiamento
che include la comprensione della medicina, e delle idee
che abbiamo di corpo e di salute.1
Globalizzazione e migrazioni hanno avuto l’effetto paradossale e non intenzionale di rendere “disponibili” su scala
globale culture altre, lontane, sconosciute o misconosciute. Esse ci stanno ora, per così dire, rimbalzando addosso,
proiettate su uno scenario globale e ri-localizzate altrove,
in particolare proprio nell’Occidente da cui origina anche
il macro-processo della globalizzazione. Un effetto, questo,
che hanno osservato, forse prima e meglio di altri, alcuni
antropologi, a diretto contatto con le culture altre e i loro
cambiamenti.
8
Il caleidoscopio delle culture,
ovvero l’importanza del fattore “C”
È insomma in corso un processo di de-ri-territorializzazione
delle culture che sta mostrando esiti di un certo interesse,
per vie differenti, fondamentalmente riconducibili a due.
La prima è la “scoperta” (da parte nostra), o la ri-scoperta
di culture e saperi altrui, che troviamo in territori lontani,
apprendiamo e riportiamo “a casa”, mettendoli a confronto
con i saperi attuali (per esempio quelli prodotti dalla “ragione scientifica”), e anche con i nostri saperi “tradizionali”,
sviluppando confronti diacronici che cominciano a dare
frutti di qualche interesse. La presenza in Occidente di “rappresentanti” di questi saperi, ormai sempre più numerosi e
ricercati dall’Occidente stesso, è un altro modo per far viaggiare mentalità, conoscenze, simboli, visioni del mondo.
La seconda è l’arrivo, attraverso le migrazioni, di quelli che
possiamo definire “saperi condivisi”: si tratta in questo caso
non solo di conoscenze e idee sul mondo, ma di pratiche
sociali e culturali diffuse e condivise all’interno di gruppi
sociali (le comunità immigrate) sempre più ampi, in grado
di viverle, di farle riprodurre, e anche di contaminarle con
forme di conoscenza altre.
L’effetto più immediato e evidente di questi processi è
l’aumento del livello di pluralizzazione – non solo “teorica”, ma effettivamente, concretamente e immediatamente
disponibile – dell’offerta culturale, che ha quindi potenziato le possibilità di scelta offerte nel concreto a ciascun
individuo. Nel nostro caso, questo significa tra le altre cose
riaprire la strada, accanto al sapere medico “ufficiale” e
stabilito, anche a forme e credenze “tradizionali”, più o
meno reinterpretate.
Le migrazioni, soprattutto da paesi extraeuropei, hanno
infatti favorito la presenza e la diffusione di modalità di
credere “altre”, dato che i nuovi immigrati hanno portato
con sé, come ovvio, anche il proprio bagaglio culturale. Tali
processi non riguardano tuttavia solo le culture e le religioni: insieme a un discorso di “salvezza”, gli immigrati portano con sé anche un discorso di “salute”. Un discorso tanto
più forte e convincente in quanto tali culture e religioni
non sono rappresentate solo da individui e famiglie, che
in qualche modo progressivamente si integrano, o al limite
si incapsulano nella società di accoglienza. Esse trovano e
assumono forme di radicamento collettivo e comunitario,
che consentono di “trapiantare” anche forme e modalità
di vissuto quotidiano e di appartenenza e identificazione
culturale, concernenti anche l’idea di corpo, di malattia, di
salute, di guarigione, di morte.
Con queste modalità culturali di interrogare il corpo
e l’idea di salute, ha sempre più possibilità di entrare in
contatto anche l’autoctono: per via di “impollinazione”
culturale (attraverso libri, viaggi o incontri personali); o
per mezzo dell’incontro con le comunità immigrate che ne
sono portatrici.
Diventa o ridiventa dunque cruciale e strategico riflettere
sulle implicazioni del “fattore C”: “C” come cultura. Non è
un caso che si diffondano espressioni che fanno riferimento
al “mosaico delle culture” o al patchwork religioso che si starebbe formando. Ma queste espressioni mettono in evidenza solo l’aspetto statico, rigido, di quanto sta succedendo,
ovvero l’aumentata pluralizzazione culturale delle nostre
società. In realtà, si tratta di un processo dinamico e alquanto complesso, che si lascia meglio descrivere dall’immagine, non statica ma dinamica, e in continua evoluzione, del
caleidoscopio delle culture: i cui pezzi, sia quelli piccoli sia
quelli più grandi (fuor di metafora, sia le nuove forme culturali, sia quelle vecchie, in passato monopolistiche e tuttora
dominanti, o almeno maggiormente istituzionalizzate) sono
in continuo movimento. Fuor di metafora, i vari pezzi in
movimento del caleidoscopio potremmo chiamarli medicina
Claudio
Capanna,
Due donne
malate
nell’ospedale
di Ariwara.
Repubblica
Democratica
del Congo,
provincia
dell’Ituri,
2007.
© Claudio
Capanna
scientifica occidentale, cura d’anime e del corpo in chiave
cristiana, medicine tradizionali, pratiche sociali e religiose
legate alla vicinanza al paziente, al morente, allo stesso corpo cadavere, da parte di diversi soggetti ad esso deputati.
Lo scambio culturale, come pure la presenza di immigrati,
costituiscono alcuni tra i motori che muovono il caleidoscopio. E il sovrapporsi dei vari pezzi, quelli nuovi e quelli
preesistenti, produce nuove forme e nuove sfumature di
colore, ovvero produce fenomeni di “meticciato” e di sincretismo culturale. Ha effetti, insomma, anche “interni”,
di peso tutt’altro che trascurabile. La tesi che qui sosterremo è che questo processo si manifesta – e forse anche in
forma eminente – laddove sono in gioco gli elementi fondamentali dell’essere e del ben-essere: il corpo, e il sapere
su di esso, con i molti richiami a valori ultimi e penultimi
che esso comporta.
Il caleidoscopio delle culture ha naturalmente effetti profondi anche sulle istituzioni sanitarie. Di fronte a questa situazione notevolmente più complessa, infatti, le istituzioni
cui è demandata la cura del corpo nelle sue varie fasi, dalla
nascita alla malattia alla morte, acquisiscono con fatica strumenti e chiavi di lettura utili a risolvere i problemi pratici
che si pongono, che mettono in crisi le forme di funzionalità acquisite, e il significato stesso di queste istituzioni.
Il mondo sanitario, tuttavia, insieme alla scuola (e anzi
prima di essa, perché ad esso prima o poi si rivolge già la
prima generazione di immigrati), è uno dei primi in cui la
pluralità culturale e in particolare religiosa portata dagli
immigrati – cui sempre fanno riferimento le idee di corpo,
salute/salvezza e malattia, laddove non prevale la razionalità scientifica – si manifesta, si rende visibile, e può anche
rendersi problematica.
Ma questi cambiamenti, alla lunga, finiscono per coinvolgere anche le popolazioni autoctone, che a loro volta
cominciano a includere forme di cura e idee di salute/ma-
lattia che prendono in prestito e rielaborano elementi culturali importati dalle culture alloctone, dando vita a modalità espressive nuove, di fatto “autoctonizzate”. Inoltre
i meccanismi di confronto e di scontro passano anche per
altri canali, che non sono solo il confronto con pazienti che
della diversità sono portatori.
Effetti sistemici: la malattia declinata al plurale
L’insistenza sul cambiamento del paesaggio sanitario dovuto all’immigrazione è doverosa, essendo l’elemento di
novità per certi aspetti più dirompente per gli equilibri
acquisiti, proprio perché si tratta di un’alterità più “altra”,
nei confronti della quale c’è meno abitudine al confronto. Questo fattore è decisivo nel produrre trasformazioni
tanto sul piano delle culture della salute, quanto su quello
delle pratiche sociali e dei modelli di funzionamento delle
istituzioni sanitarie, inducendo trasformazioni sia nel sapere medico che nelle sue pratiche.
Ma la dimensione della pluralizzazione delle culture della
salute è molto più ampia: e riguarda anche, e forse eminentemente, le popolazioni autoctone, coloro che non hanno
vissuto l’avventura dell’emigrazione. Sono infatti in corso
trasformazioni interne estremamente significative: e il cambiamento passa anche per gemmazione interna, non solo
per innesto dall’esterno. Si pensi al successo sempre più
ampio, e che coinvolge un numero sempre più alto di operatori e utenti, delle medicine dette in passato alternative:
dall’omeopatia all’agopuntura, ad altre pratiche mediche
“recuperate” nel sapere occidentale senza bisogno della
presenza di comunità immigrate (sono immigrati tuttavia
alcuni degli operatori del settore), come la medicina sciamanica, ayurvedica, tibetana, cinese, e più in generale le
varie forme di medicina variamente definita naturale, olistica, non convenzionale, e in fondo la stessa maggiore enfasi
sulla prevenzione, sullo stare bene, anziché solo sulla cura.
9
AeM 64 nov. 08
Claudio
Capanna,
Suora
canossiana
ugandese.
Lweza,
Kampala.
Uganda,
2007.
© Claudio
Capanna
10
È utile a questo punto porsi una domanda: c’è un rapporto
tra queste due modalità del cambiamento? Tra modalità
interna e esterna, tra gemmazione e innesto? La risposta
è certamente positiva. E insieme, questi due cambiamenti
– non solo sommati ma, come si vedrà, “incrociati” – producono un cambiamento ulteriore: sul piano quantitativo,
ma anche sul piano qualitativo.
Le affinità con le trasformazioni nel paesaggio religioso
d’Occidente sono sorprendenti. E tuttavia non devono
stupire, perché sono entrambe parte di quel cambiamento
più generale, figlio e compagno della globalizzazione e dei
suoi effetti, cui abbiamo accennato.
Anche in ambito religioso, come in ambito sanitario, sono
presenti sia forme di cambiamento interne che esterne.
Vale la pena a questo punto proseguire nel parallelo: non
solo sul piano dell’offerta, in cui è evidente l’effetto di pluralizzazione, l’aumento del numero dei soggetti presenti
sul mercato (dei beni sanitari come dei beni religiosi) e anche delle loro dimensioni, delle quote di mercato, per così
dire, conquistate dai nuovi soggetti presenti.
Il cambiamento avviene infatti anche sul piano della domanda, cioè dell’utente. Non solo sono a disposizione modelli
diversi, alternativi o anche solo sovrapponibili e integrantisi
reciprocamente. Si fanno evidenti forme diverse di fruizione. Non cambiano solo i soggetti in campo e le loro forme;
si manifestano anche forme diverse di appropriazione del
campo stesso, diverse modalità soggettive di viverlo.
Nel mondo delle religioni la forma di appartenenza classica
è quella per nascita: sono di una certa religione perché “ci
sono nato”, perché vi appartenevano i miei genitori. Nel
mondo della medicina, in qualche modo è lo stesso: seguo
una certa modalità di cura, e di pensare il corpo, perché
l’ho appresa socialmente, perché è quella dominante nella
società in cui vivo, e da cui l’ho ereditata. Mi preesisteva, e
mi ci sono per così dire incorporato.
Ma il mondo delle religioni, oggi in una fase storica di progressiva soggettivizzazione e privatizzazione del rapporto
con la sfera del sacro, produce anche comportamenti differenziati: che, in buona parte, troviamo anche nel campo
della salute.
Nella religione, oltre alla modalità di appartenenza religiosa classica – per nascita – sono variamente visibili almeno
altre tre modalità di fruizione, tre tipi principali di comportamenti: che non è difficile applicare anche al mercato
dei beni di salute, del resto parallelo piuttosto che alternativo al mercato dei beni di salvezza.
1) Il primo è quello del supermercato dei beni religiosi, o
dell’“assortimento di significati ultimi”. Ci si “fa” la propria religione, la si costruisce, in qualche modo la si compra, in maniera individualizzata e personalizzata: a partire
magari da qualche frammento di educazione religiosa, poniamo cristiana, ricevuta durante l’infanzia, cui si aggiunge
il frutto di proprie esperienze, di letture, di amicizie, di
corsi a cui si partecipa, e così via. È un modo di credere
particolarmente visibile ad esempio nel mondo new age,
ma non riguarda solo esso, e è più diffuso di quanto si creda. Quando viene condiviso con altre persone dà luogo a
quello che si chiama sincretismo, che a sua volta può dare
origine a una nuova religione: un processo che contribuisce
a produrre ulteriore pluralizzazione sul lato dell’offerta.
Anche nell’ambito della salute sono sempre più diffusi
elementi di “supermercato”: ci si cura prendendo un po’
qui e un po’ là, secondo moda o convenienza, o sfruttando
brandelli di sapere man mano acquisiti, spesso per canali
informali – quello che gli anglosassoni chiamano shopping
around; le medicine prescritte dal medico, ma con gli alimenti naturali al posto delle vitamine sintetiche, i consigli
della nonna insieme a quelli della rivista di riferimento,
il balsamo tigre e le tisane ayurvediche, l’agopuntura e il
massaggio cinese, i consigli del medico insieme a quelli del
pranoterapista e dello sciamano di turno. E anche in questo caso, se si forma uno “zoccolo duro” di condivisione
delle pratiche in questione, da parte di piccoli gruppi che
poi man mano si allargano e diventano scuole di pensiero,
si può parlare di sincretismi in fieri, che con il tempo diventano scuole attestate e pratiche diffuse.
2) Il secondo tipo di fruizione soggettiva della religione potremmo chiamarlo inclusione. Significa che si parte dalle
credenze tradizionali, e dalla propria appartenenza a una
religione, integrandole però con nuove “sensibilità”, apprese altrove, o con altre credenze, anche contraddittorie con
il sistema di appartenenza. Un esempio tipico, per chiarire,
è la sempre più frequente credenza nella reincarnazione
misurata da diverse ricerche tra praticanti cristiani.
Nell’ambito della salute, sempre più spesso si includono
elementi di medicina non convenzionale nelle proprie pratiche di cura, senza abbandonare tuttavia una preferenza
istituzionale, diciamo per default, nei confronti della medicina ufficiale. Ricordiamo che non si tratta solo di pratiche
(ad esempio curarsi anche con i fiori di Bach), ma anche
di teorie: si può benissimo continuare a prendere antibiotici, ma includere nel proprio modo di pensare, e per così
dire di “credere” la salute, anche un principio, ovvero una
credenza – poniamo, nei chakras – perfettamente contraddittoria, o il meno che si possa dire irrilevante, rispetto al
sistema medico ufficiale.
3) Il terzo tipo di comportamento, infine, è quello della
conversione religiosa. In questo caso non si sceglie di “includere” una credenza, anche molto diversa, aggiungendola alle proprie. Ma si sceglie direttamente un’altra credenza
e un’altra comunità religiosa di appartenenza. Si cambia,
insomma. Anche se non bisogna credere che il cambiamento sia necessariamente solido e duraturo. Vi sono infatti anche conversioni temporanee, intermittenti, part-time,
e figure di “convertiti professionali”.
Nell’ambito della salute, ci si può convertire, e di fatto spesso accade, a un nuovo tipo di medicina: poniamo l’omeopatia. Anche se magari solo temporaneamente: fino a quando,
eventualmente, il bisogno di un intervento più radicale non
ci faccia tornare tra le braccia della medicina “scientifica”.
Peraltro, a completare la similitudine, non sono spesso le
conversioni interpretate da chi le vive come guarigioni? E
talvolta lo sono di fatto, in termini di salute mentale, di ritrovato equilibrio, provocando quello che spesso, nei racconti dei convertiti, viene interpretato come un miglioramento della propria condizione psicologica generale.
Queste tre modalità di fruizione soggettiva della religione,
naturalmente, non sostituiscono l’appartenenza di default:
quella per nascita. La integrano, corrono in parallelo ad
essa, consentendo tuttavia margini di libertà e di scelta in
passato (in presenza di una sola legittima ortodossia) semplicemente impensabili. Lo stesso avviene negli approcci
alla salute.
Cambiamenti sul piano dell’offerta, e cambiamenti sul piano della domanda, insieme, producono dunque un nuovo
paesaggio. Che intacca anche i saperi “interni” delle varie
discipline mediche. Già il sapere che il mercato è aperto, e
modalità alternative di cura sono disponibili al consumatore, mette in concorrenza i vari soggetti in grado di offrire
prodotti alternativi. Inoltre – per uscire dal semplice modello della rational choice, che non crediamo sia, da solo,
convincente – vi sono forme di influenza (chiamiamola
pure culturale) reciproca. E dalla conoscenza di concezioni
diverse possono nascere nuove domande anche per quella
cui facciamo riferimento: fino a integrarla, o abbandonarla, o a “mischiarla” sincreticamente con altre. È precisamente quanto avviene per le religioni: che, in situazione di
pluralità, non possono più non tener conto dell’esistenza
delle altre, continuando ad arroccarsi in un facile extra ecclesiam nulla salus, per il semplice fatto che l’argomento è
sempre meno convincente agli occhi dei loro stessi utenti.
Esse sono costrette dunque a cambiare (senza darlo troppo
a vedere) le loro stesse teologie e i loro stessi criteri di statuizione della verità – fino ad accettare progressivamente
nei propri orizzonti anche elementi di verità “altrui”.
Non mancano ad esempio, in campo sanitario – come non
mancano in campo religioso – gruppi (anche, in senso
proprio, di pressione) e movimenti culturali che, come le
religioni e le medicine tradizionali, pongono sempre più
l’enfasi sull’aspetto collettivo, olistico appunto, della guarigione, combattendo l’enfasi tutta occidentale e moderna
sulla salute (e la salvezza) individuale. Dall’ecologia profonda all’ipotesi Gaia, passando magari per la profezia di
Celestino, e in generale per molte teorizzazioni in tema di
ben-essere corporale e spirituale, l’interconnessione globale (almeno con la natura) viene esplicitamente teorizzata e
ricercata, e si trasforma anche in un atteggiamento culturale
favorevole alle medicine alternative e non convenzionali.
Incidentalmente, crediamo che la diffusione di questi modi
di pensare getti nuova luce su quella che il pensiero razionale occidentale definisce come l’ambiguità del termine
“male”, che può intendersi sia in senso psico-biologico che
morale.
Conclusioni: feedback e meticciato culturale
Uno schema idealtipico di feedback culturale nel campo
della salute, dovuto alla presenza di immigrati, potrebbe
essere descritto più o meno così:
- il malato straniero si pone di fronte, con la sua diversità di
intendere il corpo, la salute e la malattia, al
- medico autoctono. Questi inizia una
- riflessione sulla diversità culturale di fronte alla malattia,
che, a sua volta, può arrivare ad una
- nuova concettualizzazione, che include elementi eteroctoni (si pensi all’etnopsichiatria, ma anche a molte altre forme di sapere medico). Questa nuova concettualizzazione
si manifesta dapprima nel medico stesso, come una sorta
di “risonanza” interna (comincia a farsi domande nuove,
inattese), ma può successivamente tradursi in una
- riflessione collettiva, con colleghi e sodali impegnati nello
stesso tipo di ricerca, che può arrivare fino alla
- elaborazione di un nuovo paradigma interpretativo, sia in
polemica/rottura con la classe medica e la scienza ufficiale
in quanto tali, che cercando sintesi e mediazioni. L’esistenza di un mercato in crescita per le medicine non convenzionali (di una “soglia” culturale e economica che comincia ad essere appetibile, quindi)2 è naturalmente un aiuto
potente nello svilupparsi di questo processo.
Si tratta, come detto, di un modello idealtipico, che si presta quindi a molte varianti empiriche, fino all’inversione
11
AeM 64 nov. 08
12
stessa degli attori (malato autoctono/medico straniero), e
alla produzione di questo stesso processo “dal basso” (il
cambiamento culturale avviene in questo caso nel paziente
e in generale tra i fruitori del sapere medico, prima ancora
che tra i suoi produttori).
Esempi di questo tipo sono rilevabili in varie forme di sapere medico, sia legato al corpo che alla mente. Un esempio più evidente di altri è quello dell’etnopsichiatria, che
se non altro, il suo cambiamento di prospettiva, o più incisivamente di paradigma, ha il pregio di dichiararlo, anzi di
teorizzarlo esplicitamente. In essa sono evidenti anche vari
tipi di feedback e di forme di “creolizzazione” del sapere
medico che sono visibili anche in altri ambiti.
Ma, al di là dell’etnopsichiatria, possiamo trovare tanti altri esempi di feedback: ad esempio nella medicina islamica
concretamente praticata da una parte delle popolazioni
musulmane, ma che entra anche nelle pratiche di certo
mondo new age come medicina sufi, e nell’incontro tra le
due su internet o nella produzione e vendita di prodotti
naturali, prodotti da musulmani in base a logiche culturali
proprie, ma offerti ad un pubblico indistinto. Lo stesso si
può dire di gruppi religiosi provenienti dall’oriente rispetto alle medicine tradizionali indiane e tibetane. E, ancora
più comune, nell’acquisto da parte di autoctoni, in negozi
etnici, di prodotti cinesi legati alla sfera della salute (magari
non considerati propriamente medicinali dai cinesi stessi,
ma “interpretati” come tali dagli autoctoni).
Si delinea in definitiva un progressivo sfumare dei confini
tra le une e le altre discipline, tra le une e le altre credenze.
La nozione stessa di confine, anche culturale, la sua stessa
esistenza, è del resto intrinsecamente ambigua, e sempre
più comincia a venire messa in discussione. Confine è cumfinis: ciò che separa e nel contempo ciò che abbiamo in
comune con l’altro. Dove c’è il confine c’è appunto anche
chi lo transita: e questo vale anche nel nostro caso. Così
come si può essere cattolici o miscredenti ma preferire
tanto la medicina ufficiale quanto l’omeopatia, si può essere musulmani e scegliere la medicina occidentale. O più
spesso, come sovente succede, si può essere l’una e molte
altre cose, a seconda della situazione, e scegliere l’altra o le
molte altre forme di medicina. Se la pluralità di opzioni e
di possibilità è diventata un dato, anche la variabilità delle
scelte, e la loro incostanza, lo diverrà necessariamente, e di
fatto lo è già diventata.
Inoltre sempre più il campo della salute diventa anche
un campo non solo di concorrenza tra visioni diverse, ma
anche di negoziazione, tra soggetti concorrenti presenti
nello spazio pubblico, con le loro rispettive istituzioni e
lobbies di rappresentanza, ma anche con i poteri pubblici
(alla ricerca ad esempio di riconoscimenti anche legislativi
e istituzionali, o al contrario di delegificazioni che legittimino attività e pratiche prima osteggiate). Si tratta di un
processo che è peraltro più generale, e riguarda il campo
scientifico nel suo complesso, in specie laddove si discutono temi rilevanti per il ben-essere dell’uomo, o temi limite
dell’etica e della bioetica. Dire negoziazione, naturalmente, significa dire e nominare il conflitto tra visioni diverse,
di cui la negoziazione non è che la forma “civilizzata”.
Torna dunque prepotentemente in risalto l’immagine del
caleidoscopio delle culture, con cui abbiamo aperto queste considerazioni. Il passaggio generazionale tra gli immigrati, per esempio, mescola ulteriormente le carte. E apre
interrogativi sulle trasformazioni culturali nelle concezioni
del corpo e della salute tra quelli che, dopo tutto, non sono
più (anzi, non sono mai stati) immigrati. Le seconde generazioni non si sono mai mosse: sono di qui. Dovremmo
semmai chiamarle, più correttamente, le prime generazioni
di neo-autoctoni. E tra loro è più facile, rispetto ai loro
padri, trovare forme di mixité culturale, e anche maggiore
disponibilità alle medesime.
Nello stesso tempo sono gli autoctoni a cambiare, nell’interazione con gli immigrati ma più in generale con la pluralità culturale. Pluralità che, sempre più, con il passare
del tempo, diventa – per usare una terminologia di provenienza medica – fisiologia e non patologia. Essa stessa,
insomma, condizione normale. Che tende, incidentalmente, a diventare anche norma, legge: le battaglie per l’accettazione, l’inserimento, la parificazione di medicine diverse
da quella attestata (si pensi all’omeopatia, all’agopuntura,
ecc.), ne sono degli evidenti esempi. La pluralità di “vie”,
ancora una volta a somiglianza di quanto avviene nel paesaggio religioso, si afferma progressivamente. E l’esclusivismo monopolistico fatica a sostenersi, a giustificarsi, se
non ricorrendo ad argomenti autoreferenziali, come il già
citato extra ecclesiam nulla salus, o ad argomenti autoritativi, di difesa corporativa attraverso il mantenimento delle
posizioni di potere (sul piano legislativo, istituzionale, accademico, economico). La similitudine tra mondo medicoscientifico e mondo religioso potrebbe in fondo legittimamente proseguire (accennando a dogmi, verità, chiese,
chierici in concorrenza, ad esempio): la parola latina ce lo
consente. Salus, dopo tutto, include tanto la dimensione
della salute quanto quella della salvezza.
Stefano Allievi è Professore di Sociologia all’Università
di Padova; le sue ricerche si focalizzano sui cambiamenti
culturali e religiosi in Occidente soprattutto a proposito
dell’Islàm in Europa; su questi argomenti ha scritto numerosi libri pubblicati in Italia e all’estero
BIBLIOGRAFIA
AA.VV., Medicina e multiculturalismo. Dilemmi epistemologici e etici nelle politiche sanitarie, Apeiron, Bologna
2002
S. Allievi, L’ultimo tabù: individuo e società di fronte alla
morte, in M. Bucchi, F. Neresini (a cura di), Sociologia della
salute, Carocci, Roma 2001, pp. 295-324
S. Allievi (a cura di), Salute e salvezza. Le religioni di fronte
alla nascita, alla malattia e alla morte, EDB, Bologna 2003
S. Allievi, Islam italiano. Viaggio nella seconda religione del
paese, Einaudi, Torino 2003
S. Allievi, G. Guizzardi, C. Prandi, Un Dio al plurale. Presenze religiose in Italia, EDB, Bologna 2001
J. Arpin, L. Comba, F. Fleury (a cura di), Migrazione e salute mentale in Europa, in «Antropologia Medica», n. 4,
1998
D. Atighetchi, Islam, musulmani e bioetica, Armando,
Roma 2002
M. Augé, C. Herzlich (a cura di), Il senso del male. Antropologia, storia e sociologia della malattia, il Saggiatore,
Milano 1986
R. Beneduce et alii, La salute straniera. Epidemiologia culture diritti, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1994
R. Beneduce, Frontiere dell’identità e della memoria. Etnopsichiatria e migrazioni in un mondo creolo, Franco Angeli, Milano 1998
M. Castiglioni (a cura di), Percorsi di cura delle donne immigrate. Esperienze e modelli di intervento, Franco Angeli,
Milano 2001
R. Colasanti, S. Geraci, F. Pittau, Immigrati e salute. Paure,
miti e verità, Edizioni Lavoro, Roma 1991
J.K. Cruickshank, D.G. Beevers, Ethnic factors in health
and disease, Wright, Oxford 1989
G. Da Villa, W. Pasini, Aspetti sanitari del fenomeno immigratorio in Italia, Istituto italiano di medicina sociale,
Roma 1995
G. Devereux, Saggi di etnopsichiatria generale, Armando,
Roma 1978
G. Favaro, M. Tognetti Bordogna (a cura di), La salute degli immigrati, Unicopli, Milano 1988
D. Frigessi Castelnuovo, M. Risso, A mezza parete. Emigrazione, nostalgia, malattia mentale, Einaudi, Torino 1982
S. Geraci (a cura di), Medicina e migrazioni. Traumi e problemi di salute fisica e mentale in immigrati e rifugiati. Atti
del II Congresso Internazionale, Presidenza del Consiglio,
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1992
S. Geraci (a cura di), Argomenti di medicina delle migrazioni, Associazione Peri Tecnes, Roma 1995
S. Geraci (a cura di), Immigrazione e salute: un diritto di
carta? Viaggio nella normativa internazionale, italiana e regionale, Anterem, Roma 1996
Grassivaro Gallo P., Figlie d’Africa mutilate. Indagini epidemiologiche sull’escissione in Italia, L’Harmattan Italia
Torino 1998
P. Grassivari Gallo, C. Cortesi, Linee guida per il personale
medico di fronte a casi di mutilazione genitale femminile,
Osservatorio Regionale Immigrazione Veneto, Quaderni
di ricerca, n. 5, Venezia 1999
L. Grinberg, R. Grinberg, Psicanalisi dell’emigrazione e
dell’esilio, Franco Angeli, Milano 1990
A. Henley, J. Schott, Culture, religion and patient care in
a multi-ethnic society. A handbook for professionals, Age
Concern, London 1999
P. Inghilleri, F. De Cordova, M. Castiglioni, Medicina tradizionale, immigrazione e domanda di salute: Una ricerca a
Milano, in «IKON. Forme e processi del comunicare», n.
40, 2000, pp. 61-139
I.-B. Krause, Therapy across culture, Sage, London 1988
R. Littlewood, M. Lipsedge, Aliens and alienists. Ethnic
minorities and psychiatry, Unwin Hyman, London 1989
N. Losi, Gli amici dell’acqua. Medici, pazienti e medicine
alternative, Franco Angeli, Milano 1990
N. Losi, Vite altrove. Migrazione e disagio psichico, Feltrinelli, Milano 2000
M. Mazzetti, Strappare le radici. Psicologia e psicopatologia
di donne e di uomini che migrano, L’Harmattan Italia, Torino, 1996
M. Mazzetti (a cura di), Senza le ali. Le mutilazioni genitali
femminili, Franco Angeli-ISMU, Milano 2000
S. Mellina, La nostalgia nella valigia. Emigrazione di lavoro
e disagio mentale, Marsilio, Venezia 1987
A. Morrone, Salute e società multiculturale. Medicina transculturale e immigrati extracomunitari nell’Italia del 2000,
Raffaello Cortina Editore, Milano 1995
A. Morrone, M. Mazzali (a cura di), Le stelle e la rana. La
salute dei migranti: diritti e ingiustizie, Franco Angeli, Milano 2000
T. Nathan, La follia degli altri. Saggio di etnopsichiatria,
Ponte alle Grazie, Firenze 1986
T. Nathan, Princìpi di etnopsicanalisi, Bollati Boringhieri,
Torino 1996
Ospedale San Carlo Borromeo di Milano, Nuove povertà,
vecchie malattie. Aspetti sanitari dell’immigrazione, Centro
Congressi Cariplo, Milano 2002
N. Pasini, A. Pullini (a cura di), Immigrazione e salute in
Lombardia. Una riflessione interdisciplinare, ISMU-Regione Lombardia, Osservatorio regionale per l’integrazione e
la multietnicità, Rapporto 2002, 2003
W. Pasini (a cura di), Il medico e il paziente immigrato. Manuale per il medico, Alfa Wasserman, Bologna 1996
M. Risso, W. Böker, Sortilegio e delirio. Psicopatologia
dell’emigrazione in prospettiva transculturale, Liguori, Napoli 1992
R. Rizzi, A. Iossa Fasano (a cura di), Ospitare e curare. Dialogo interculturale e esperienze cliniche con gli immigrati,
Milano, Franco Angeli 2002
A. Sayad, La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato
alle sofferenze dell’immigrato, Raffaello Cortina Editore,
Milano 2002
M. Tognetti Bordogna, Disuguaglianze di salute e immigrazione, Franco Angeli, Milano 2008
A. Yahyaoui (a cura di), Travail clinique et social en milieu
maghrébin, La Pensée Sauvage, Paris 1987
NOTE
1 - Il presente testo è derivato, pur tra modifiche e integrazioni, dal
mio più ampio saggio Corpi migranti. Culture, religioni, salute e malattia in una società plurale, pubblicato in G. Guizzardi (a cura di),
Star bene. Benessere, salute, salvezza tra scienza, esperienza e rappresentazioni pubbliche, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 285-342, in cui
si trova anche la necessaria bibliografia di riferimento. Di questioni
correlate mi sono occupato anche in S. Allievi (a cura di), Salute e
salvezza. Le religioni di fronte alla nascita, alla malattia e alla morte,
EDB, Bologna 2003. L’interesse per i temi del pluralismo culturale e
religioso è invece di lunga durata. Tra gli esiti più recenti S. Allievi,
G. Guizzardi e C. Prandi, Un Dio al plurale. Presenze religiose in
Italia, Bologna, EDB, 2001, e S. Allievi, Pluralismo, EMI, Bologna
2006. Con un’attenzione allo specifico islamico si vedano almeno S.
Allievi, Islam italiano. Viaggio nella seconda religione del paese, Einaudi, Torino 2003, e l’ultimo Le trappole dell’immaginario: islam e
occidente, Forum, Udine 2007.
2 - Riprendiamo il concetto in voluta assonanza con quello di “soglia etnica”, che consente agli immigrati di riprodursi culturalmente,
parlando una lingua comune, ecc.
G
lobalization and immigration have had the
immediate effect of bringing different cultures
closer to each other: this cultural exchange has also
influence the health system, changing its culture
and medical institutions. This process, which closely
affects the local population, has create an integrationoriente medical culture: today’s traditional medical
practices often mix with western science-base
medicine. All this opens the doors to reciprocal
exchange and continuous co-influence.
13
AeM 64 nov. 08
DOSSIER
Occupazione
Capannone
Tiburtina,
Roma 2004.
Foto di Sarah
Klingeberg
14
I paradigmi del diritto umanitario e delle
politiche del trauma in Italia
di Sarah Klingeberg
O
gni giorno, da tutte le parti del mondo, migliaia di
persone fuggono senza meta e senza protezione,
vittime di persecuzioni, di violenze, di torture, di
conflitti interni e di guerre spesso sconosciute all’opinione
pubblica. Le ragioni che costringono queste persone a fuggire dal loro paese sono, oltre ai già citati conflitti armati e
alla violazione dei più elementari diritti umani, sempre più
spesso le carestie e i disastri ecologici.
Alla fine della seconda guerra mondiale, la presenza di
migliaia di profughi, sfollati e esiliati in Europa portò la
questione dell’asilo al centro dell’agenda politica della comunità internazionale. I drammatici eventi politici e sociali
dell’epoca generarono un esteso senso di responsabilità fra
gli Stati europei, che li portò ad affrontare con strumenti
giuridici di protezione internazionale le conseguenze umanitarie delle atrocità commesse ai danni di milioni di persone vittime dei regimi nazifascisti.
La definizione del termine “rifugiato” fu quindi influenzata dalla realtà politica e sociale del tempo, e dalle diverse
categorie di persone che avevano sofferto la persecuzione.
nenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trovi fuori dal paese di cui è cittadino e
non può, o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi
della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo
una cittadinanza e trovandosi fuori del paese in cui aveva
residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o
non vuole tornarvi per il timore di cui sopra» (Convenzione
relativa allo status di rifugiato 1951, Art. 1A).
Quando è stata stipulata, la Convenzione poneva due limitazioni al riconoscimento dello status di rifugiato: una
temporale – solo avvenimenti verificatisi anteriormente al
1951 potevano dare luogo alla richiesta e al riconoscimento – e una geografica (la cosiddetta riserva geografica) – con
la quale veniva lasciata alla discrezionalità degli Stati contraenti di scegliere a chi applicare la Convenzione, quindi
anche solo a richiedenti asilo di provenienza europea.
Con lo scoppio di nuove crisi politiche e conflitti armati,
alla fine degli anni Cinquanta e nei primi anni Sessanta, è
divenuto però necessario ampliare il raggio d’azione della
Convenzione. Di conseguenza, nel 1967 è stato elaborato e
adottato un Protocollo alla Convenzione per eliminare tali
limiti nella definizione di rifugiato data dalla Convenzione
del 1951 (Protocollo di New York del 1967 relativo allo status dei rifugiati).
L’Italia e la normativa sull’asilo
L’adozione di una normativa nazionale sui rifugiati, basata
su standard internazionali, costituisce la chiave per rafforzare il diritto d’asilo, rendere la protezione più efficace e
fornire le basi per la ricerca di soluzioni al problema dei
rifugiati. Incorporare il Diritto Internazionale nella normativa nazionale diventa particolarmente importante per
quelle tematiche sulle quali la Convenzione relativa allo
status di rifugiato del 1951 tace, quali ad esempio le procedure per la determinazione dello status di rifugiato.
L’Italia ha ratificato la Convenzione di Ginevra nel 1954,
adottando sia la limitazione geografica che quella temporale. In seguito alla ratifica del Protocollo di New York, avvenuta con la Legge n. 90 del 1970, per l’Italia è venuta meno
la limitazione temporale, mentre la limitazione geografica
è caduta solamente nel 1990 con la Legge n. 39. Fino ad
allora i richiedenti asilo provenienti da Paesi extraeuropei,
non potendo richiedere asilo allo Stato italiano, si rivolgevano alla delegazione dell’ACNUR, che aveva il mandato
dell’Assemblea Generale dell’ONU per il riconoscimento
dello status di rifugiato.
Purtroppo, ad oggi, in Italia non esiste una legge organica
in materia di asilo,3 né il sistema di protezione per i rifugiati vigente nel nostro paese (pur avendo già recepito una
serie di Direttive europee) è sufficiente per rispondere alle
esigenze di questa categoria di persone che si trova in una
condizione di grave fragilità fisica e psicologica.
I rifugiati nel diritto internazionale
Lo strumento giuridico fondamentale per la protezione internazionale dei rifugiati e dei richiedenti asilo è la Convenzione relativa allo status di rifugiato, approvata a Ginevra
nel 1951 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite,1
poco dopo la creazione dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR/UNHCR). Secondo
la Convenzione di Ginevra il termine “rifugiato” si applicherà a colui che, temendo a ragione di essere perseguitato
«(…) per motivi di razza,2 religione, nazionalità, apparte-
Il concetto di trauma e lo status di rifugiato
La Convenzione di Ginevra, come spiegato in precedenza,
è stata pensata in un momento storico in cui l’intolleranza
e le persecuzioni erano prevalentemente espressione della
repressione di regimi politici dispotici e autoritari verso
individui politicamente dissidenti o appartenenti a gruppi
considerati pericolosi per motivi di razza, religione, nazionalità o per credo politico. In tal senso, sono stati esclusi
tutti coloro che si sono trovati in situazioni di conflitto generalizzato o di violazione sistematica dei diritti umani.
15
AeM 64 nov. 08
Nell’attuale scenario geopolitico mondiale, profondamente modificatosi rispetto agli anni Cinquanta, è questa la
situazione in cui viene a trovarsi la maggioranza dei richiedenti asilo, per la quale la definizione di rifugiato, secondo
la Convenzione del 1951, appare sempre più inadeguata.
D’altronde, le possibilità di una revisione e di un aggiornamento del termine rifugiato appaiono nulle, visto l’inasprimento delle politiche europee in materia d’asilo, la
chiusura delle frontiere legata al controllo delle politiche
migratorie e la sempre maggiore selettività e rigidità nella
concessione della protezione internazionale.
Per risolvere la situazione gravissima dei gruppi perseguitati non contemplati nella Convenzione di Ginevra,
l’Unione europea ha trovato l’escamotage della protezione
temporanea o umanitaria. Una protezione internazionale e
“temporanea”, cioè per gli sfollati e per quanti si trovino
in una situazione di pericolo e di necessità simile a quella
dei rifugiati, ma che non rientrano in questa definizione
restrittiva.
In tale quadro il concetto di “trauma” ha assunto una
importanza predominante nella procedura del riconoscimento dello status di rifugiato da parte degli stati europei.
Infatti, l’aumento esponenziale dei movimenti di popolazioni per cause umanitarie ha portato i Paesi riceventi a
ri-definire le politiche di accettazione in senso restrittivo,
scegliendo di privilegiare una prospettiva biomedica nella
definizione dei parametri per il riconoscimento dell’idoneità. «In questo modo la storia “traumatica” costituisce
il capitale simbolico del migrante, che esalta la sofferenza
individuale del singolo a dispetto di qualunque altra cosa
che la condizione di rifugiato e l’esperienza ad essa legata
possa essere e rappresentare» (Vacchiano 2005, p. 92).
16
I paradigmi del diritto umanitario e delle politiche
del trauma in Italia
La nascita del concetto di “rifugiato” è inestricabilmente
connessa a quella dell’aiuto umanitario, un rapporto di assistenza che si è trasformato in un’“industria dell’aiuto”
(Summerfield 1996 e 2000).
L’aiuto umanitario è diventato oggi una forma discorsiva
dominante, ma, pur ponendosi come indipendente e neutrale, è gioco forza investito in progetti che sono inevitabilmente politici, poiché parte attiva nei rapporti di forza
mondiali.
La teoria antropologica ha un approccio spesso critico nei
confronti delle organizzazioni umanitarie, avendo riscontrato nelle loro politiche assunti etnocentrici e una scarsa
comprensione delle culture locali. La “cultura umanitaria”
infatti sembra imputare la permanenza di manifestazioni
di violenza nel mondo contemporaneo ad arretratezza e
sottosviluppo, ciò richiama alla memoria i tentativi di dominazione e civilizzazione dell’Altro durante l’esperienza
coloniale occidentale (Van Aken 2005).
Nei progetti di sostegno umanitario, i rifugiati sono molto
spesso categorizzati e concepiti unicamente come “vittime”: la perdita dei propri punti di riferimento viene infatti fatta coincidere con la perdita di proprie risorse di
“resilienza”,4 di proprie reti di assistenza. Tale assenza
presupposta può essere messa alla base dell’asimmetria
e della passività forzata di molte relazioni d’aiuto (Van
Aken 2005). Infatti, «coloro che offrono servizi sociali
creano solitamente un’immagine del “rifugiato” tale per
cui, in quanto “esperti”, se ne possono prendere cura. Gli
individui sono trasformati in “clienti” attraverso un loro
etichettamento impersonale. La linea di condotta è decisa
in modo deduttivo e unilaterale, con pochi contributi da
parte degli stessi rifugiati. Questo crea “un’epistemologia
causale non-reciproca” tra professionisti, dove i rapporti
di causa e effetto (…) sono ovvi, dove il fatto di essere rifugiati è costruito come problema sociale e dove esiste una
prescrizione standardizzata di come gli esperti dovrebbero agire per assicurare la salvezza dei loro clienti» (Indra
1993, p. 234).
Anche la studiosa Barbara Harrell Bond, nel suo lavoro
sull’Esperienza dei rifugiati in quanto beneficiari di aiuto
(2005), mette in evidenza come una delle principali cause del malessere debilitante dei rifugiati possa essere tale
“struttura” del regime assistenziale. Questo perché i programmi d’assistenza per i rifugiati finiscono spesso per
spersonalizzare gli stessi. L’aiuto umanitario è fondato, infatti, sull’assunto secondo cui la popolazione beneficiaria
è una massa omogenea e indifferenziata e nel rapporto con
gli operatori i rifugiati diventano il più delle volte numeri
senza nome. Si può affermare, quindi, che nel quotidiano
i lavoratori dell’umanitario si prendono cura della “nuda
vita” (Agamben 1995) dei rifugiati, considerandoli come
vittime assolute, spogliate di ogni forma di socialità.
Sempre più oggetti di politiche e contese sull’assistenza,
di interventi militari in loro nome e quindi sempre meno
soggetti politici, oggi «essere rifugiati rimanda inevitabilmente a un “diventare rifugiati”. Non solo la fuga e il
tentativo di ottenere un nuovo status, ma anche la relazione burocratica dell’assistenza definiscono nuove identità
e ruoli: una relazione polarizzata tra vittime e agenti, tra
riceventi di doni e di carità esterna e benefattori. Parlare
quindi di rifugiati presuppone inevitabilmente il “paradigma dell’umanitario”, da cui dipendono e in cui vengono
definiti coloro che scappano» (Van Aken 2005, p. 6).
In Italia, e ancor prima in Francia, negli ultimi anni, il numero di persone cui è stato garantito il diritto d’asilo è
diminuito notevolmente e ciò dipende principalmente da
due fattori distinti ma collegati: il numero delle domande
presentate è diminuito e la proporzione di quelle accettate si è più che dimezzata. Il significativo calo del numero
dei rifugiati riconosciuti è il risultato dell’intensificazione
della pratica del rimpatrio – pur essendo questa vietata
dal principio di non refoulement nella Convenzione di
Ginevra del 1951 – da parte degli stati europei, oltre che
della severità di coloro che sono predisposti a valutare le
domande di asilo. L’atteggiamento oramai consolidato
da parte delle Commissioni Territoriali in Italia è quello
di valutare le richieste con sospetto: tanto è vero che la
tendenza è sempre più quella di riconoscere permessi di
soggiorno per motivi umanitari, anziché lo status di rifugiato.
La Convenzione di Ginevra viene dunque applicata in maniera sempre più restrittiva e le domande di asilo vengono
sempre di più viste come “strumentali” a un ingresso “legale” nella “Fortezza Europa”. Non solo, «(…) oggi lo status di rifugiato è concesso primariamente in relazione alla
possibilità – e talvolta persino alla capacità – di produrre,
per se stessi, una “giustificata” storia traumatica. È la dimostrabilità di un pericolo strettamente individuale e non
di un potenziale motivo di appartenenza – alle classi citate
dalla Convenzione di Ginevra: razza, opinione politica,
religione, nazionalità o appartenenza a un determinato
gruppo sociale – a consentire il riconoscimento del rifugio.
(…) Ciò che deve essere dimostrato è la possibilità di sperimentare la violenza direttamente, ossia individualmente,
e l’unico modo possibile consiste non nell’argomentare i
traumi potenziali, ma nel certificare quelli subiti; è solo
grazie a una storia di violenza diretta, di cui la persona sia
stata oggettivamente vittima, che la domanda di asilo viene oggi considerata attendibile dal paese di accoglienza»
(Vacchiano 2005, p. 90).
Ciò è dimostrato da un numero crescente di persone a cui
viene riconosciuto lo status di rifugiato o un permesso per
motivi umanitari sulla base di una certificazione medicolegale che attesti traumi o segni evidenti sul corpo di tortura o di trattamenti inumani e degradanti.
Viene così, come spiega l’antropologo Didier Fassin per la
Francia, «attribuita maggiore importanza al corpo sofferente rispetto al corpo minacciato, e il diritto alla vita viene spostato dall’ambito politico a quello umanitario. Per
lo Stato è più accettabile bocciare una richiesta di aiuto,
dichiarandola infondata, che rifiutare un’opinione medica» (Fassin 2006, p. 309).
La studiosa Liisa Malkki ha utilizzato l’espressione evocativa di “umanitarismo clinico” per sottolineare questa
propensione, sottolineando inoltre come «le ferite sono
accettate come evidenze oggettive, in quanto fonti più
affidabili di conoscenza rispetto alle parole delle persone
sui cui corpi le ferite stesse si trovano» (Malkki 2002, p.
351).
È come se il corpo prendesse il sopravvento a scapito del
soggetto stesso, che resta il più delle volte inascoltato. È la
ricognizione della “nuda vita”, archetipo contemporaneo
che sostituisce il biologico al sociale, confermando il «primato della vita naturale sull’azione politica» (Agamben
1995, p. 6).
Il “corpo sofferente” ha imposto, quindi, la propria legittimità laddove altre basi per il riconoscimento venivano
progressivamente messe in questione (Fassin 2006).
È inoltre importante sottolineare come questo statuto
privilegiato, concesso al corpo nelle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato, influisca sulla coscienza
che i richiedenti asilo hanno della propria identità. Nel
legittimare il trauma o i segni evidenti sul corpo della
tortura, fino a renderli la sola giustificazione dello status
di rifugiato, la società condanna molti stranieri a esistere ufficialmente solo in quanto traumatizzati o in quanto
vittime. In questo senso Didier Fassin afferma che si può
parlare di incorporazione delle condizioni sociali da parte
del richiedente asilo: «il corpo sofferente viene presentato ai medici che devono decidere se garantire o meno lo
status legale: l’immigrato/a cerca nella sua storia e nei suoi
sintomi qualcosa che lo/a aiuterà a ottenere l’autorizzazione legale cui aspira, con il rischio di sentirsi rispondere
che la patologia non “è abbastanza grave” per sostenere
la richiesta. In questa interazione sociale, in cui l’immigrato deve dar prova della sua malattia, la distinzione tra
manipolazione, che emerge quando i dati medici materiali provocano una malattia, è spesso tanto più difficile da
discendere, quanto più gli immigrati vivono in situazioni
precarie che producono effetti sia psicologici che fisici.
(…) La vita quotidiana degli stranieri irregolari diventa
quindi spesso un’esperienza sociale di sofferenza, dove il
pathos esprime la durezza delle circostanze e simultaneamente serve da risorsa per giustificare la propria esistenza.
La relazione narrativa con la propria storia e il proprio
corpo, creata dalla ripetizione di racconti di autogiustificazione di fronte alle autorità statali, genera una patetica
immagine di sé» (Fassin 2006, p. 311).
Lo straniero finisce così per percepirsi come una vittima ridotta a dover suscitare compassione (Fassin 2006).
Il corpo personifica quello che Giorgio Agamben chiama “nuda vita” (1995), un’esistenza cioè ridotta alla sua
espressione fisica o, in questo caso, al riconoscimento
dell’essere umano attraverso la sua patologia.
Continuità della violenza nel contesto di asilo
Nancy Scheper-Hughes, nel suo testo Questioni di coscienza. Antropologia e genocidio, sostiene che esista un continuum genocida tra la violenza di massa e le pratiche di
controllo operate dallo Stato moderno. La studiosa si riferisce in particolare a quelle violenze quotidiane, nascoste
e spesso autorizzate dall’autorità, che si praticano «negli
spazi sociali normativi: nelle scuole pubbliche, nelle cliniche, nei pronto soccorso, nelle corsie d’ospedale, nelle
case di cura, nei tribunali, nelle prigioni, nei riformatori e
negli obitori pubblici» (Scheper-Hughes 2005, p. 282).
Questo continuum di violenza rimanda alla capacità
dell’uomo di ridurre l’Altro alla condizione di non-persone per mezzo di tutte quelle forme di esclusione sociale,
disumanizzazione e spersonalizzazione sempre più praticate all’interno degli Stati.
Alla base dell’analisi della Scheper-Hughes è la nozione di
“crimini di pace” introdotta da Franco Basaglia (Basaglia,
Ongaro Basaglia 1975) a proposito di tutte quelle forme
quotidiane della violenza di Stato, di quelle pratiche repressive perpetuate dalle istituzioni totali, come le forme
di disciplinamento dei corpi e delle menti che vertono
alla cancellazione della dignità degli individui trattandoli
come non-persone (Scheper-Hughes 2005).
Quando parliamo di continuum di violenza in riferimento alla categoria dei rifugiati, ci si riferisce all’importanza
di non perdere di vista la continuità che collega ciò che
accade nei paesi di fuga e nei paesi di asilo. La continuità
qui tratteggiata sta nella violenza strutturale5 insita nelle
procedure di sorveglianza, accoglienza e regolamentazione che le istituzioni attuano nei confronti dei richiedenti
asilo e rifugiati (Vacchiano 2005). Tali pratiche rimandano
infatti a quelle forme di violenza quotidiana definite da
Nancy Scheper-Hughes come «le piccole guerre e invisibili genocidi» (Scheper-Hughes 2005, p. 282).
Si può affermare, quindi, che se quella del rifugiato non
rappresenta in sé una condizione patologica, lo può diventare se il paese d’asilo non prevede un efficace sistema
di accoglienza e di inserimento nella società d’arrivo. Il
continuum di violenza può essere infatti riscontrato nel
vuoto sociale, nell’assenza di prospettive e nell’insicurezza esistenziale in grado di influire patologicamente su tale
categoria di persone.
Questa situazione di “non accoglienza” espone, appunto,
i richiedenti asilo e i rifugiati ad eventi che possono essere
causa di continue traumatizzazioni.
La letteratura bio-medica dimostra, infatti, che nella popolazione rifugiata fattori come la disoccupazione, la perdita di attività quotidiane costruttive e l’inadeguata padronanza della lingua del paese di accoglienza sono spesso
correlati a depressione e altri disordini mentali (Saraceno,
Safena, Maulik 2002).
17
AeM 64 nov. 08
Manifestazione
richiedenti
asilo,
Roma 2007.
Foto di Sarah
Klingeberg
18
L’esperienza stessa dell’esilio, come spiega la psicoterapeuta Anna Sabatini Scalmati, e l’improvviso abbandono
del proprio paese d’origine «(...) per una terra per latitudine e longitudine distante dalla propria – espone alla paura
di perdere ciò che plasma, definisce la propria identità e
tiene coesa la propria esperienza individuale e sociale; di
perdere cioè gli affetti, le relazioni, i costumi, la cultura,
la religione, la lingua, i riti, il cibo, i suoni, che gli sono
propri e sono il cemento che tengono assieme il suo Io»
(Sabatini Scalmati 2000, p. 175).
A tale proposito Ernesto De Martino in La fine del mondo
(2002), parlando dell’Italia degli anni Cinquanta, descrive in termini evocativi cosa significasse l’allontanamento
dai propri punti di riferimento per un pastore calabrese di Marcellinara: «gli offrimmo di salire in auto per
accompagnarci fino al bivio giusto, a pochi chilometri
di distanza: poi lo avremmo riportato al punto in cui lo
avevamo incontrato. Salì in auto con qualche diffidenza,
come se temesse un’insidia, e la sua diffidenza si andò via
via tramutando in angoscia, perché ora dal finestrino, cui
sempre guardava, aveva sperduto la vista del campanile di
Marcellinara, punto di riferimento del suo estremamente
circoscritto spazio domestico. Per quel campanile scomparso, il povero vecchio si sentiva completamente spaesato: e solo a fatica potemmo condurlo fino al bivio giusto
e ottenere quel che ci occorreva sapere. Lo riportammo
poi indietro in fretta, secondo l’accordo: e sempre stava
con la testa fuori dal finestrino, scrutando l’orizzonte, per
rivedere riapparire il campanile di Marcellinara: finché,
quando finalmente lo vide, il suo volto si distese e il suo
vecchio cuore si andò pacificando, come per la riconquista di una “patria perduta”. Giunti al punto di incontro
si precipitò fuori dall’auto senza neppure attendere che
fosse completamente ferma. (…) Oramai (era) fuori della
tragica avventura che lo aveva strappato dallo spazio esistenziale del campanile di Marcellinara. (…) Certamente
la presenza entra in rischio quando tocca il limite della sua
patria esistenziale, quando perde “il campanile di Marcellinara”» (De Martino 2002, pp. 480-481).
De Martino spiega come sia nelle pratiche quotidiane che
sembrano automatiche, perché incorporate e elaborate
dal corpo e quindi rese “naturali”, che avviene l’“appaesamento nel mondo”. Quindi, con la perdita di questo rapporto di “oggettivazione della realtà”, ha luogo una “crisi
di presenza”. In tal senso, “la crisi della presenza” svela
che il mondo non è già dato, ma è costruito, e che l’“appaesamento” è una continua produzione culturale data dalla
nostra capacità di abitarlo e trasformarlo, essendone al
tempo stesso abitati e trasformati.
Per De Martino infatti: «(...) la “presenza” nel mondo è
fondamentalmente la capacità di riunire nell’attualità della coscienza tutte le memorie e le esperienze necessarie
per rispondere in modo adeguato a una determinata situazione storica, inserendosi attivamente in essa mediante
l’iniziativa personale, e andando oltre di essa mediante
l’azione» (De Martino 2002, p. 480).
Tale “crisi della presenza” è maggiormente decisiva
nell’esperienza del rifugiato che, il più delle volte, ha subito traumi già prima della fuga. La vita post-traumatica
infatti, come la definizione dello psicologo Pieron mette
in luce, è caratterizzata da una ipersensibilità a successive esperienze traumatiche (traumi secondari). Si evince,
quindi, che rischi di traumatizzazioni secondarie posso-
no essere una diretta conseguenza patologica del trauma
primario, che, determinando nella persona uno stato di
estrema vulnerabilità, ne diminuisce le capacità adattive
di fronte a ulteriori eventi stressanti.
Sarah Ann Klingeberg è laureata in Teorie e pratiche
dell’antropologia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università La Sapienza di Roma con la tesi Il trauma
fra richiedenti asilo e rifugiati in Italia. Ha svolto ricerche
nell’ambito di progetti europei e ha partecipato, in qualità
di relatrice, a numerose conferenze sul tema delle vittime
d’immigrazione e dei rifugiati. Attualmente frequenta il
Master in Antropologia presso l’École des Hautes tudes
en Science Sociales di Parigi
BIBLIOGRAFIA
G. Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita,
Einaudi, Torino 1995
A. Appadurai, (1996), Modernità in polvere, Meltemi,
Roma 2004
F. Basaglia, F. Ongaro Basaglia (a cura di), Crimini di pace,
Einaudi, Torino 1975
R. Beneduce, Frontiere dell’identità e della memoria. Etnopsichiatria e migrazioni in un mondo creolo, FrancoAngeli, Milano 1998
R. Beneduce, Pensare la violenza: un approccio etnopsichiatrico alla tortura, in Associazione Franz Fanon e ICS (a
cura di), Pensare la violenza. Atrocità di massa, tortura e
riabilitazione, Edizioni ICS, Roma 2003, pp. 85-101
P. Bourdieu, (1972), Per una teoria della pratica, Raffaello
Cortina, Milano 2003
F. Dei (a cura di), Antropologia della violenza, Meltemi,
Roma 2005
E. De Martino, (1948), Il mondo magico. Prolegomeni a
una storia del magismo, Bollati-Boringhieri, Torino 2003
E. De Martino, (1977), La fine del mondo. Contributo
all’analisi delle apocalissi culturali, Einaudi, Torino 2002
P. Farmer, (2003), Sofferenza e violenza strutturale, in I.
Quaranta (a cura di), Antropologia medica, Raffaello Cortina, Milano 2006, pp. 265-302
D. Fassin, (2001), La biopolitica dell’alterità, in I. Quaranta (a cura di), Antropologia medica, Raffaello Cortina,
Milano 2006, pp. 303-321
D. Fassin, R. Rechtman (a cura di), Les usages sociaux du
traumatisme psychique. Enjeux d’une catègorie réinventée
de la santé mentale, Maison des Sciences de l’Homme de
Paris Nord, Cxresp e Cesames, Paris 2006
D. Fassin, R. Rechtman, L’empire du traumatisme. Enquete
sur la condition de victime, Flammarion, Paris 2007
B. Harrel-Bond, (1999), L’esperienza dei rifugiati in quanto
beneficiari d’aiuto, in «Antropologia», n. 5 (5), Meltemi,
Roma 2005
ICS, Fondazione Cecchini Pace/Istituto Transculturale
per la Salute, Associazione Frantz Fanon, Percorsi delle
vittime di tortura in Italia. Fattori di rischio e di protezione,
Edizioni ICS, Roma 2003
D. Indra, The spirits of the gift and the politics of resettlement: the Canadian private sponsorship of South East
Asian, in V. Robinson (a cura di), The international refugees crisis: British and Canadian responses, Mc Millan,
London 1993
L.H. Malkki, Purity and exile. Violence, memory and national cosmology among Hutu refugees in Tanzania, The
19
AeM 64 nov. 08
University of Chicago Press, Chicago-London 1995
L.H. Malkki, Speechless emissaries: Refugees, humanitarianism and dehistoricization, in A.L. Hinton (a cura
di), Genocide. An anthropology of genocide, University of
California Press, Berkeley-Los Angeles-London 2002, pp.
348-381
M. Mauss, Le tecniche del corpo, in Id., Teoria generale
della magia e altri saggi, Einaudi, Torino 1991 (1936), pp.
385-409
Ministero dell’Interno (a cura di), Linee guida per il riconoscimento dello status di rifugiato, Ministero dell’Interno,
Roma 2005
R. Papadopoulus (a cura di), (2002), L’assistenza terapeutica ai rifugiati, Edizioni Scientifiche Ma.Gi, Roma 2006
H. Pieron, Vocabolario di psicologia, La Nuova Italia, Firenze 1973
G. Pizza, Antropologia medica, Carocci, Roma 2005
I. Quaranta (a cura di), Antropologia medica. I testi fondamentali, Raffaello Cortina, Milano 2006
A. Sabatini Scalmati, Memorie congelate, memorie evitate:
a proposito della relazione terapeutica con le vittime di tortura, in Richard, Pigole, Studi psicoanalitici del bambino e
dell’adolescente, 2/2000, pp. 170-180
A. Sabatini Scalmati, Extracomunitari e rifugiati politici:
dramma culturale e traumi psichici, in «Giano», 41, 2002
B. Saraceno, S. Safena, P.K. Maulik, Mental health problems in refugeees, in N. Sartorius, W. Gaebel, J.J. LopezIbor, M. Maj (a cura di), Psychiatry in society, John Wiley
& Sons, New York 2002
N. Scheper-Hughes, Il sapere incorporato: pensare con il
corpo attraverso un’antropologia medica critica, in R. Borofski (a cura di), L’antropologia culturale oggi, Meltemi,
Roma 2000 (1994), pp. 281-292
N. Scheper-Hughes, (2002), Questioni di coscienza. Antropologia e genocidio, in F. Dei (a cura di), Antropologia della
violenza, Meltemi, Roma 2005
N. Scheper-Hughes, M. Lock, The mindful body: a prolegomenon to future work, in «Medical Anthropology
Quarterly», n. 1, 1987, pp. 6-41
F. Sironi, (1999), Persecutori e vittime. Strategie di violenza, Feltrinelli, Milano 2001
D. Summerfield, The Impact of war and atrocity on civilian
populations: basic principles for NGO interventions and a
critique of psychosocial trauma projects, RRN-ODI, London 1996
D. Summerfield, The invention of post-traumatic stress disorder and the social usefulness of a psychiatric category, in
«British Medical Journal», n. 9, 2000, pp.61-64
UNHCR, Unione Parlamentare, Guida al diritto internazionale del rifugiato, Stampa a cura del Senato della Repubblica Italiana, Roma 2001
F. Vacchiano, Cittadini sospesi: violenza e istituzioni
nell’esperienza dei richiedenti asilo in Italia, in «Antropologia», n. 5 (5), Meltemi, Roma 2005
M. Van Aken, Introduzione, in «Antropologia», n. 5 (5),
Meltemi, Roma 2005
A. Young, The harmony of illusions. Inventing post-traumatic stress disorder, Princeton University Press, 1995
NOTE
20
1 - «L’Assemblea generale può esaminare i principi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i principi regolanti il disarmo e la disciplina degli
armamenti, e può fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia
ai Membri. sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni e all’altro» (Statuto delle Nazioni Unite, capitolo IV, articolo 11).
L’Assemblea generale è il principale e più rappresentativo dei sei
organi istituzionali di cui è composta l’Organizzazione delle Nazioni Unite. È formato dai rappresentanti di tutti gli stati aderenti
alle Nazioni Unite, ad essere esclusi attualmente sono solo Taiwan
e Città del Vaticano.
2 - Tale definizione del 1951, elaborata in un determinato contesto
storico e politico, non è stata mai rivista, come si può notare dall’uso
del termine obsoleto di razza.
3 - Il diritto di asilo è sancito dall’art. 10 comma 3 della Costituzione
Italiana e la procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato
è definita dalla Legge 286/1998 - il Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, la c.d. Turco/Napolitano - così come modificato
dalla Legge 189/2002 - Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, c.d. Bossi/Fini.
4 - Con il termine “resilienza” nelle Scienze Sociali si intende la
capacità umana di affrontare le avversità della vita, superarle e uscirne rinforzato o, addirittura, trasformato. Roberto Beneduce spiega
come, relativamente al concetto di resilienza, l’enfasi sulla categoria
del PTSD e i suoi criteri patologici rischia di sopprimere o indebolire quei processi sociali e culturali che spontaneamente tendono
a risolvere le conseguenze individuali delle esperienze traumatiche
(Beneduce 1998).
5 - A tal proposito è importante ricordare il concetto di violenza
strutturale, così come definito dal filosofo Jhoan Galtung, «come
quella particolare forma di violenza che non richiede l’azione di un
soggetto per essere compiuta, nella misura in cui a caratterizzarla è la sua natura processuale e indiretta. Nel parlare di violenza
strutturale si vuole dirigere l’attenzione verso gli effetti iatrogeni dei
rapporti sociali, in diretto riferimento al tema delle disuguaglianze,
tanto locali quanto nazionali e internazionali, responsabili di creare
ineguali speranze di vita per i soggetti in base alla loro posizione
sociale» (Quaranta 2006; p. XXIII).
I
n this article the author deals with the international
debate on the definition of trauma with reference
to people who are given a refugee status. What is
presente is a more in depth analysis of the term, using
the tools of medical anthropology, and proposing a
new concept of “the body” not only as a biological
entity, but also as a strongly cultural, historical and
political product. More specifically, the author focuses
on the political, social and cultural implications of the
concept’s use in the institutions dedicate to welcoming
and assisting refugees and asylum-seekers.
di Nathalie De Timmerman, Lucien Hounkpatin, Federica Stortoni, Anne Zountekpo
DOSSIER
Verso una clinica costituita
da teorie molteplici
Thierrie
Collet, Le
dispositif
d’ethnopsychiatrie.
21
AeM 64 nov. 08
L
e relazioni tra le caratteristiche della personalità e
il contesto sociale e culturale in cui la stessa si sviluppa sono state oggetto di numerose teorizzazioni
in ambito psicodinamico e psicosociale a partire dall’inizio del XX secolo. Le teorizzazioni più importanti sono
state elaborate all’interno dell’antropologia culturale (Malinowski 1922; Benedict 1934; Mead 1931), dell’etnopsicoanalisi (Rohéim 1943), della psichiatria transculturale
(Kleinmann 1985; Good 1985), dell’etnopsichiatria (Devereux 1961; Nathan 1996), della clinica della molteplicità (Hounkpatin 2006). Queste discipline situate nell’intersezione tra psiche e cultura hanno messo in evidenza
problematiche diverse: l’esistenza ad esempio di sindromi
culturalmente determinate in gruppi etnici specifici, la relazione tra i processi di non adattamento-integrazione-assimilazione e l’aumento della sofferenza psichica che può
prendere la forma di veri e propri disturbi psicologici.
In Francia le tradizionali scuole di psicoanalisi e di etnologia hanno contribuito allo sviluppo, nell’ambito dell’indirizzo teorico generale dell’etnopsichiatria (Devereux
1961, 1970). A questo proposito uno dei modelli clinici
con pazienti provenienti da altre culture riconosciuto tra
i più organici e ambiziosi è quello elaborato e fondato da
T. Nathan (1993, Hounkpatin 2006) che accoglie i pazienti immigrati e le loro famiglie fin dagli anni ’80. Questo
centro chiamato Georges Devereux è un centro clinico,
di ricerca e anche di formazione per psicologi clinici e psicoterapeuti.
22
Psicoterapia e cultura
Il disagio delle famiglie che riceviamo nel centro Georges
Devereux può manifestarsi in diverse forme. Riscontriamo
molte problematiche infantili (autismo, disturbi del sonno,
insuccesso scolastico precoce…), problematiche legate ai
“minori non accompagnati”, e adolescenti descolarizzati
che commettono reati. Spesso il giudice dei minori ci sollecita per consulenze etno-psichiatriche per giovani nati
in Francia da genitori immigrati da altri Paesi che hanno compiuto reati (leggeri o gravi). I giudici manifestano
una mentalità di notevole apertura richiedendo un lavoro
di consulenza per meglio saper “leggere” la situazione e
prendere delle decisioni adatte che possano portare a uno
sviluppo positivo della situazione problematica in corso.
I pazienti e le loro famiglie sono sempre accompagnati
dall’équipe con cui stanno svolgendo un lavoro in ambito
istituzionale (medica, psicologica o giudiziaria). Le famiglie si trovano in uno stato di sofferenza e talvolta l’équipe
si trova in difficoltà (incomprensioni, malintesi, mancanza
di “alleanza”) nello svolgimento del proprio lavoro. La
famiglia necessita di un aiuto etno-clinico (che prenda
quindi in considerazione la complessità della situazione
tenendo presente anche la dimensione di alterità culturale) e l’équipe necessita di allargare i propri strumenti per
poter lavorare in modo costruttivo con le stesse.
Il lavoro clinico con questi giovani nati in Francia i cui
genitori provengono da altri universi culturali ci insegna
a [co-] costruire in gruppo “un pensiero nuovo” che si
adatti alle peculiari situazioni. Come se le parole d’ordine
di queste sedute dovessero essere: non tradurre, non semplificare, “complessificare”, creare...
Ma allora, come poter aiutare questi giovani e le loro famiglie? Come aiutare il lavoro delle équipe in difficoltà?
Come poter costruire una clinica che prenda in conside-
razione la molteplicità delle teorie, delle istituzioni e delle
identità in gioco?
Per meglio rispondere a questi interrogativi entriamo ora
in un frammento di consultazione con Mamadou e la sua
famiglia, per rendere più concreto il nostro modo di fare
la clinica e di teorizzarla.
Mamadou: dagli elementi distruttivi al lavoro di soggettivazione tenendo conto degli elementi identitari molteplici
Mamadou ha 15 anni, il signore e la signora H, i genitori,
sono originari del Senegal, di etnia bambara.
In seguito ai reati commessi il giudice ha ordinato, due
anni fa l’inserimento di Mamadou in un istituto educativo. Dopo che Mamadou ha commesso il reato, il giudice
ha preso la decisione di allontanarlo dalla famiglia e ha
ordinato a Mamadou di vivere in un istituto educativo. Lo
sviluppo positivo dei comportamenti di Mamadou porterà il giudice a rivedere la sua decisione e a rimandare Mamadou in famiglia. Dopo poco tempo, Mamadou manifesta gli stessi problemi di comportamento, lo stesso tipo di
atti delittuosi e il giudice decide di rimetterlo nell’istituto
educativo. Questa volta però Mamadou si ribella alla decisione del giudice, entrando in conflitto costante con il suo
educatore. Il giudice dei minori richiede allora l’intervento di un lavoro clinico con Mamadou e la richiesta di una
perizia etnopsichiatrica al Centro Georges Devereux che
chiarisca i problemi in atto.
Durante la prima seduta la nostra équipe riunita in cerchio
è costituita dallo psicoterapeuta principale che conduce
la seduta e da un’insieme di co-terapeuti: psicoterapeuti,
psicologi clinici, psichiatri, pediatri, etnologi e il mediatore “etnoclinico”. Accogliamo Mamadou, il suo educatore,
l’assistente sociale, il padre, la madre e la sorella maggiore.
Il mediatore etnoclinico è seduto vicino alla famiglia. Il
mediatore è un traduttore “particolare” della stessa origine della famiglia. Non traduce infatti solo parola per parola ma ha una conoscenza approfondita di questo mondo
e traduce da un sistema di riferimento a un altro. Aiuta il
terapeuta principale a pensare a una clinica che implichi
la presa in considerazione delle “teorie del mondo” da cui
proviene il paziente, «l’involucro identitario costituito da
luoghi, odori, suoni costituisce la superficie sensoriale e
esperienziale che permette la costruzione della struttura e
del funzionamento psichico» (Nathan 1996). Si potrebbe
dire che il mediatore etnoclinico crea le “aperture essenziali” all’interno del discorso del paziente portando alla
luce gli impliciti teorico-culturali. Egli partecipa quindi
all’elaborazione di un nuovo discorso, alla produzione
di un nuovo significato sulla situazione. In questo caso la
presenza del mediatore bambara è necessaria per permetterci di trovare un senso “sulla situazione in atto” condivisibile dalla famiglia.
In questo nuovo “setting”, chiamato dispositif d’ethnopsychiatrie (dispositivo etnopsichiatrico) (Nathan 1993),
sono così rappresentate tutte le teorie che permettono
ad ognuno di pensare la problematica di Mamadou che
è all’origine di questa seduta. Emergono infatti diverse
opinioni sulla situazione: quella della famiglia, quella dei
rappresentanti dell’istituzione che sono invitati per primi
a esporre la situazione e i loro interrogativi, e quella dei
terapeuti e dei co-terapeuti. Il terapeuta principale e i suoi
colleghi, con l’aiuto del mediatore etnoclinico, analizzano
la situazione conflittuale in gioco. In questo caso i conflitti
sono plurimi: tra l’educatore e la famiglia, tra la famiglia e
Mamadou, tra i suoi genitori.
Vediamo ora come queste professionalità lavorano durante la prima consultazione con Mamadou e la sua famiglia.
Durante la seduta Mamadou è nervoso, il clima è teso.
L’educatore prende subito la parola e inizia a sottolineare
la gravità dei fatti compiuti da Mamadou, esprime le preoccupazioni sul suo gruppo di amici, che definisce come
giovani delinquenti della zona. L’aggressività di Mamadou e i suoi atti violenti ci portano immediatamente ad
affrontare in clinica la questione della distruttività. Infatti,
ancora prima che l’educatore finisca di parlare e che si
specifichi nei dettagli il senso di questo incontro e delle
problematiche che riscontra l’educatore, la tensione del
signor H ha già fatto irruzione. Il signor H alza la voce con
l’educatore e esprime chiaramente il suo dissenso dicendo: «Je suis très fâché... Comment se fait-il qu’on s’attaque
à mes enfants?» (Sono molto arrabbiato… com’è possibile
attaccare in questo modo i miei figli?). L’educatore sottolinea allora la sua difficoltà a creare una relazione con la
famiglia e la difficoltà che i genitori hanno nel capire la
funzione del suo lavoro con Mamadou. Secondo lui i genitori sono aggressivi nei suoi confronti perché hanno vissuto come una punizione nei loro confronti la decisione del
giudice d’aver allontanato Mamadou da casa mettendolo
in un istituto: «Pendant six mois, j’ai eu des difficultés
pour entrer dans la famille; les deux premiers mois, c’était
impossible... Avec le père, la discussion était difficile. Il ne
voyait pas ce que je faisais là...». (Durante i primi sei mesi,
ho avuto delle difficoltà per entrare in famiglia, i primi
due mesi è stato impossibile… con il padre di Mamadou
era difficile discutere. Non capiva quello che facevo…).
Il signor H vive la presenza dell’educatore nella sua famiglia come un rimprovero implicito, come se non avesse
educato bene suo figlio, e per questo si sente “attaccato”
dalla decisione presa dal giudice. Per lui suo figlio non
è responsabile dei delitti che gli sono rimproverati. Mamadou è spinto, infatti, dalla forza di uno spirito, ch’egli
identifica come uno “spirito della terra”. Il signor H esprime in questo modo le basi dell’eziologia del “Male” che
colpisce suo figlio. Per essere il più vicino al pensiero della
famiglia di Mamadou, il mediatore etnoclinico ha invitato il signor H ad esprimersi nella sua lingua d’origine. Il
mediatore etnoclinico restituisce al gruppo il pensiero del
padre «Mamadou, ce qui lui arrive, c’est la chose de la
terre. Quand elle prend l’enfant, il peut faire pipì au lit,
faire des cauchemars, mais l’enfant ne sait pas ce qui lui
arrive... Les djinnas dont je parle ne sont pas de ceux avec
lesquels on traite; ce sont des djinnas récalcitrants.» (Mamadou, quello che gli capita, viene dalla terra. Quando
questo spirito entra nel bambino, può fargli fare pipi a
letto, fargli fare degli incubi ma il bambino non sa quello
che gli capita… i djinns di cui parlo sono difficili da mandare via, si tratta di djinns recalcitranti). I djiinns possono
essere considerati in questo caso come dei “miti viventi”
«(…) il mito permette di riconoscersi in quanto individuo
e in quanto membro di un gruppo » (Green 1992).
L’emergere dell’eziologia dei djinns è stata possibile grazie
al mediatore. I sintomi di Mamadou sono quindi pensati
dalla famiglia secondo un’eziologia culturale tradizionale specifica “possessione da djinns recalcitranti”. Vista la
gravità della situazione il padre pensa che sia necessario
inviarlo al Paese per guarirlo. In questo caso il terapeuta
principale non può eliminare l’eziologia dei djinns portata
dai genitori senza rischiare di inficiare la relazione terapeutica. È necessario quindi portare gli interrogativi della
famiglia a un altro livello passando attraverso la mediazione del mondo in cui i djinns fanno parte delle possibilità
per interrogare “il Male” in corso. L’essenziale non è di
porre delle domande alla famiglia ma di portarla a porsi
dei nuovi interrogativi sulla situazione in atto portando,
in questo modo, gli interrogativi a livello dei “mondi”. In
questo caso il mondo dei djiinns. La questione diventa allora perché i djinns hanno attaccato Mamadou? Perché
sono entrati in questa famiglia? Talvolta i djinns attaccano
un membro della famiglia quando si è compiuto un’effrazione grave…
Durante la seduta emergono poco a poco profondi disaccordi tra i genitori che sembrano esistere da lunga data.
La violenza di questi conflitti ha creato in Mamadou
un’agitazione massiva che non gli permette di trovare una
calma interna e lo porta a manifestare dei continui “passaggi all’atto”. La distanza nei discorsi tra Mamadou e suo
padre è evidente, ci troviamo di fronte a due “quasi estranei”: Mamadou rivendicando le sue affiliazioni moderne
e il padre sentendosi parte del suo mondo tradizionale.
Mamadou è come molti dei ragazzi che incontriamo che
sono costituiti da appartenenze molteplici: gli elementi del
paese in cui sono cresciuti, gli elementi del paese d’origine
di cui i loro genitori sono portatori e gli elementi della cultura d’origine che hanno assorbito anche a livello inconscio (e che possono essere analizzati solo in un contesto
clinico). I genitori spesso si trovano in difficoltà a integrare questa molteplicità di appartenenze, venendosi così a
creare delle tensioni e incomprensioni tra genitori e figli,
in cui ciascuno riflette sulla propria identità. Si presenta
in questo modo un sentimento di “familiarità-estranea”
(Hounkpatin 2006). Mamadou e suo padre si conoscono poiché sono padre e figlio ma sono, allo stesso tempo,
stranieri poiché essi non riconoscono le loro reciproche
appartenenze. Il motivo di questo contrasto risiede nella
complessità della posizione del padre di Mamadou che
rende questo sentimento di “familiarità-estranea” ancora
più accentuato.
Nel corso delle consultazioni infatti, la problematica dei
djiinns porta il signor H a un movimento interno di riflessione sulle sue trasgressioni e sulla sua storia. Mamadou,
pur mantenendo una posizione di perplessità sull’eziologia dei djiinns, per la prima volta si mette in posizione
d’ascolto nei confronti della storia paterna. Il signor H
ha trasgredito alle regole tradizionali delle alleanze familiari, rompendo i contatti con la sua famiglia, fondando
il proprio nucleo familiare al seguito della rottura con il
suo, ponendosi come individuo solo, nella migrazione.
Queste rotture sono alla base anche dei conflitti di lunga
data con la signora H. La posizione paterna è complessa
e particolare: egli è completamente affiliato al mondo culturale d’origine anche se in rottura, nei fatti, con esso. Di
conseguenza, il mondo del signor H, anche se familiare,
rimane enigmatico agli occhi di Mamadou. Il lavoro svolto
nelle sedute successive ha permesso al padre di affrontare
la sua storia personale attraversata da violente rotture e
di cominciare lentamente a rimettere ordine nelle alleanze familiari. Si potrebbe dire che gli atti di trasgressione
(della legge) di Mamadou hanno portato a interrogarsi nel
corso del lavoro clinico su un altro tipo di trasgressione:
23
AeM 64 nov. 08
quella del padre rispetto alle regole del suo gruppo culturale. Infatti attraverso l’eziologia dei djiinns, è stato possibile arrivare alle trasgressioni paterne e permettere al
signor H di elaborare le molteplici rotture familiari. Solo
in seguito all’elaborazione paterna delle “fratture” e della
gravi trasgressioni in atto Mamadou ha potuto iscriversi in una “collettività familiare”. Questo passaggio gli ha
permesso di non sentirsi più attratto verso un’altra collettività, quella criminale. L’assenza del gruppo familiare
paterno non aveva permesso a Mamadou di riconoscersi
nei valori paterni e di conseguenza di costituirsi in modo
sufficientemente compatto a livello identitario. Le consultazioni funzionano allora per Mamadou come luogo
di ri-trasmissione e ri-elaborazione, della propria storia,
dei propri miti, e come momento per confrontarsi con
i suoi elementi costitutivi: elementi che fino ad ora gli
erano “familiari-estranei” perché trasmessi in assenza del
gruppo.
Il terapeuta principale per essere più vicino al suo paziente ha costruito con l’aiuto del mediatore e del gruppo
un pensiero formato dall’incontro di più pensieri, di più
mondi, che permettono la co-costruzione di un senso pensabile per Mamadou e la sua famiglia che porterà a una
progressiva modificazione della situazione. Il dispositif è
quindi luogo di tensioni, in cui si incontrano e scontrano
“mondi” e teorie, in cui emergono i malintesi, le incomprensioni teoriche delle parti in gioco che impediscono la
costruzione di un lavoro comune. Le sedute funzionano
come uno spazio terzo in cui i malintesi costituitisi anche
con gli operatori, che accompagnano le famiglie, possono essere chiariti e in cui la dimensione d’aiuto clinico
prende in considerazione anche le teorie formatesi in altri
contesti culturali.
Ora che Mamadou si sente parte di una collettività (di una
famiglia, di un gruppo, di un mondo coerente) si pone la
necessità di rafforzare la dimensione di individualità per
arrivare a una posizione di soggettivazione dagli elementi
molteplici della sua identità.
Possiamo “provvisoriamente” concludere sottolineando
che per poter trasformare l’agire di questi ragazzi in un
pensiero pensabile bisogna saper ascoltare la loro “irriducibile singolarità” identitaria. Questi giovani ci insegnano
a tener conto delle molteplici teorie che li abitano simultaneamente, ossia le teorie dei diversi mondi di cui fanno
parte, quello francese e quello dei loro padri e dei loro avi
che vorrebbero in parte rigettare e in parte trasmettere a
loro volta ai loro figli. È necessario, allora, prendere in
attenta considerazione le molteplici teorie dei mondi che
abitano questi giovani per riconoscere la loro singolarità
e aiutarli a costituirsi a livello identitario: abbiamo visto
in questo modo che la distruttività di Mamadou ha effettivamente cominciato a trasformasi in un’elaborazione
costruttiva, trama di nuove possibilità.
Ecco alcuni dei nuovi quesiti che questi ragazzi ci insegnano ad affrontare e che ci portano sempre di più a parlare di una «nuova clinica della molteplicità» (Hounkpatin 2006).
24
Nathalie De Timmerman è psicologa e psicoterapeuta
d’orientamento psicoanalitico. Lavora nel Centro medicopsicopedagogico di la Meuse e al Centro Georges Devereux. È attualmente dottoranda dell’Università di Paris 10
Lucien Hounkpatin è psicanalista. Dirige attualmente
il Centro Georges Devereux. Insegna psicologia clinica
all’Università di Paris 10. È l’autore del libro: Psicopatologie yoruba insieme al Prof. Tobie Nathan
Federica Stortoni è psicologa e psicoterapeuta d’orientamento psicoanalitico. Lavora con le famiglie immigrate al
Centro Georges Devereux. Ha svolto un dottorato di ricerca in etnopsichiatria all’Università di Paris 8 in cotutela
con l’Università di Bologna sulle tematiche identitarie
Anne Zountekpo è psicologa clinica, lavora al Centro
Georges Devereux. I suoi lavori di ricerca si concentrano
sulle tematiche adolescenziali nei figli degli immigrati nati
in Francia
BIBLIOGRAFIA
R. Benedict, Patterns of culture, Mifflin Company, Boston,
Houghton 1934
G. Devereux, (1961), Ethnopsychiatrie des Indiens Mohaves, Synthélabo, les Empêcheurs de penser en rond, Paris
1996
B. Good, Culture and depression, University of California
Press, Berkeley 1985
A. Green, La Déliaison. Psychanalyse, anthropologie et littérature, Hachette Pluriel, Paris 1992
L. Hounkpatin, Coy, N. De Teillermann, C. Mesmin, Babar
l’éléphant à la rencontre de l’enfant Léopard. «Je suis d’ici,
mon grand-père de là-bas… et mon père alors?», 2006
A. Kleinman, B. Good, Culture and depression, University
of California Press, Berkeley 1985
B. Malinowski, Argonauts of western Pacific, E.P. Dutton,
New York 1922
M. Mead, Growiong up in New Guinea. A comparative study of primitive education, Morrow, New York 1931
T. Nathan, (1993), Principi di etnopsicoanalisi, Bollati Boringhieri, Torino 1996
G. Rohéim, (1930), L’animisme, la magie et le roi divin,
Payot, Paris 2000
T
he relation between individual personalities and
the social and cultural context in which they live
is very strong; in this framework, since the 1980s the
clinic “George Devereux” in France has opene its
doors to immigrant patients and their families. In this
centre various experts act as clinical psychologists and
cultural mediators, taking care of young immigrants
that have gone through different problematic
situations, mainly relate to their identity, which lies in
between the cultural practices of their mother country
and the ones of the country they inhabit.
di Silvia Festi e Paolo Ballarin
I
l 10 ottobre 2008 presso l’Università di Bologna ha
avuto luogo un convegno dedicato alla riflessione sui
dati di attività del Dipartimento di Salute mentale di
Bologna relativi alla cura di persone provenienti da altre
culture, e due letture magistrali condotte rispettivamente
da Marie Rose Moro e da Roberto Beneduce.
Marie Rose Moro è psichiatra infantile, psicoanalista e docente all’Università di Parigi (Paris XIII), dirige il Servizio di
psicopatologia del bambino e dell’adolescente dell’ospedale
Avicenne a Bobigny, in cui ha organizzato e è responsabile di
un consultorio di etnopsichiatria specificamente pensato per
i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie. La sua cultura e
esperienza clinica nell’ambito della psichiatria del bambino e dell’adolescente hanno origine nell’insegnamento di
Serge Lebovici. La sua formazione in campo etnopsichiatrico ha preso l’avvio dalla scuola di Tobie Nathan presso
il Centre Devereux di Parigi.
Roberto Beneduce è etnopsichiatra, professore di Antropologia culturale presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Torino, presidente e psicoterapeuta del Centro
Frantz Fanon di Torino (vedi box a p. 46), che si occupa
di psicoterapia, supporto psicosociale e counselling per
immigrati, rifugiati e vittime della tortura. Ha svolto varie
attività di ricerca sul campo per conto dell’ONU, OMS,
UNICEF e CNR presso vari paesi dell’Africa e dell’Europa
Balcanica.
Il convegno è stato promosso dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna e patrocinato dall’Istituzione Gian
Franco Minguzzi della Provincia di Bologna.
I lavori della mattinata hanno visto al centro delle relazioni
e degli interventi principalmente i bambini e le loro famiglie, mentre il pomeriggio è stato dedicato agli adulti.
Il tema del convegno, evidenziato dal sottotitolo: “Dalla
formazione degli operatori alla presa in cura di bambini,
adolescenti e adulti di altre culture”, è parso suscitare molto interesse non solo negli operatori che si occupano direttamente di salute mentale, ma anche in insegnanti, ricercatori, operatori di cooperative e volontari di associazioni
che lavorano con migranti. Negli ultimi anni stanno aumentando i momenti pubblici di analisi e di riflessione sul
tema dell’accesso e della fruizione del sistema dei servizi da
parte dei cittadini di origine straniera e sulla corrispondente capacità dei servizi e dei suoi operatori di comprendere
e rispondere ai bisogni che questi nuovi cittadini esprimo-
no. In particolare, le forme di disagio e sofferenza espresse
attraverso quei canali che la nostra cultura definisce in termini psico-patologici stanno assumendo un rilievo sempre
più significativo.
Il Dipartimento di Salute mentale dell’ASL di Bologna, che
da anni investe nella formazione del proprio personale alla
presa in cura dei cittadini migranti, non si è sottratto a tale
analisi, effettuando un’attività di monitoraggio che ha interessato buona parte del territorio provinciale e in occasione del
convegno ha presentato i dati raccolti nell’arco di un anno di
attività nelle aree della Neuropsichiatria infantile, della Psichiatria adulti e del Servizio per le tossicodipendenze.
L’attività di monitoraggio e analisi quantitativa dei casi presi
in carico mostra un’importante consapevolezza dei servizi
di salute mentale relativa alla necessità di meglio conoscere
DOSSIER
Salute mentale e migranti.
Il lavoro nel Dipartimento
di Salute mentale di Bologna
Laboratorio
di
espressione
artistica.
Calderara di
Reno giugno
2008. Foto di
Gail Pomare
25
AeM 64 nov. 08
Laboratorio
di
espressione
artistica.
Calderara di
Reno giugno
2008. Foto di
Gail Pomare
26
la realtà del fenomeno migratorio nell’impatto con i servizi
stessi e, a partire da questa conoscenza e da un percorso
formativo pluriennale che ha interessato gli operatori del dipartimento, porsi alla ricerca non solo di risposte innovative
nell’ambito della cura, ma prima ancora di strumenti conoscitivi e prospettive di comprensione.
Una prima sensazione che è emersa nel corso di questa giornata e che sembrava pervadere l’insieme dei partecipanti
all’iniziativa era quella di trovarsi immersi in un clima di
consapevolezza della complessità delle tematiche in gioco.
Ci troviamo infatti di fronte alla necessità di assumere l’interdipendenza tra differenti livelli: sanitario, psicologico,
sociologico, antropologico, sociale, politico e al tempo
stesso tra il piano teorico e quello operativo.
Ma non solo. La presa in carico di persone immigrate ci
costringe a (e al tempo stesso ci permette di) assumere il
relativismo nel nostro stesso modo di concepire non solo
ogni “relazione d’aiuto” e non solo la concezione di salute e malattia, di adattamento e disadattamento, (ovvero
la loro dimensione di costruzione sociale, culturalmente
connotata), ma anche le premesse che sottendono la nostra
visione della realtà.
Pensiamo ad esempio alla centralità del soggetto, inteso
come individuo singolo e separato, contrapposta a una concezione plurale e collettiva dell’identità, alla concezione del
ruolo della tecnologia nell’esistenza umana e all’idea stessa
di progresso e di sviluppo scientifico, sociale e culturale.
Allo stesso modo, il concetto di persona come agente di
scelte libere e responsabili non è certo la visione della natura umana prevalente in ogni contesto culturale, così come
l’idea che il nostro benessere psicologico dipenda dalla
qualità delle relazioni che abbiamo avuto con le “figure di
accudimento”.
Ci sembra quindi importante la riflessione sul contributo
che la presenza di “altri” può offrire alla consapevolezza
dei limiti del nostro modo di guardare all’essere umano e
al mondo: l’esperienza dell’immigrato, che ha perso qualsiasi riferimento certo e che si ritrova all’incrocio di mondi diversi, sembra rispecchiare la condizione esistenziale
stessa di noi occidentali, privati della illusoria certezza di
una Ragione capace di spiegare tutto e di offrire certezze
normative e classificatorie. «Se il modello di razionalità
occidentale ha ormai fallito nella sua pretesa di universalità, è il momento di riconoscere l’esistenza di altre forme
storicamente assunte dalla ragione in altre civiltà. (…) La
psicologia, e più in generale le scienze dell’uomo, quindi
anche la medicina, devono rendersi conto che stiamo balbettando e che la presenza qui da noi degli “altri” mette
ancora più in risalto questo balbettio. Forse in epoche passate, quando era più semplice usare la nostra cultura come
egemone e totalizzante, come unico punto di riferimento,
non abbiamo prestato sufficiente attenzione alle razionalità e alle culture degli altri.» (N. Losi, 2000, pp. 16-17)
Occorre mettersi in una posizione di reale apertura alla
complessità e alla differenza, assumere e non negare queste
dimensioni, sospendere il giudizio nei confronti dell’altro e
delle sue convinzioni (a partire dalla necessità, per non dire
ossessione, per le classificazioni diagnostiche), rendersi disponibili a mettersi in gioco in un percorso dove l’incontro
diventi un momento creatore di senso sia per l’operatore
che per il fruitore del servizio.
Diventa allora necessario uscire dal proprio ambito di intervento, in un certo senso protetto e scontato, e leggere la
società in cui siamo immersi, riconoscere il razzismo non
solo nei fenomeni eclatanti riportati nella cronaca ma anche negli elementi legislativi che governano la vita dei migranti nei paesi di arrivo, per chiedersi finalmente, grazie
all’incontro con uomini e donne migranti simili e diversi da
noi, quanto siamo capaci di tutelare i diritti di coloro che,
anche non migranti, portano una forma di diversità.
E, spingendoci più oltre, possiamo prendere a prestito le
parole di Benasayag (2003, pp. 84-85): «A nostro parere,
sia l’integrazione che la cura devono passare attraverso il
riconoscimento della molteplicità della persona. Riconoscimento che non dovrebbe riguardare solo le persone
che hanno problemi, ma anche quelle che si considerano
“normali”, affinché possano finalmente disfarsi, con loro
grande sollievo, della terribile e dolorosa etichetta di “normale”, per poter assumere e abitare le molteplici dimensioni della fragilità. Nella nostra società della durezza e delle
passioni tristi ci interroghiamo sullo scacco di quelli che
vengono definiti “deboli”, mentre dovremmo, ci pare, interrogarci un po’ di più su ciò che viene riconosciuto come
“trionfo” e successo.»
In questa prospettiva, lo sforzo di conoscere le peculiarità
(o presunte tali) della cultura di provenienza del cliente/
paziente/utente può paradossalmente risultare fuorviante:
un conto è se tale sforzo viene posto in subordine e al servizio della comprensione dell’altro secondo il suo proprio
modo di costruire l’esperienza, un altro è se diventa una
scorciatoia e una semplificazione della complessità di cui
la persona è sempre portatrice. Nel secondo caso possiamo
immaginare che l’operatore sia (magari inconsapevolmente) guidato dalla necessità di individuare una scorciatoia
che serve probabilmente all’operatore per rassicurarsi di
fronte a quella che rappresenta in un qualche modo una
difficoltà aggiuntiva nella comprensione empatica, perché
davvero può essere difficile comprendere in modo profondo l’esperienza di una persona che utilizza differenti parametri riguardo ad alcun valori e costrutti fondamentali
(pensiamo ad esempio al significato della proprietà privata
nella vita sociale, al peso che ha la comunità allargata nel
definire il senso di identità, al ruolo del mondo degli spiriti
nella vita quotidiana, ai valori legati alla tradizione nel rapporto tra generi e tra generazioni).
Al tempo stesso dobbiamo tenere presente il fatto che la
presunta facilità di comprensione del significato dell’esperienza personale di qualcuno con cui condividiamo la lingua, la nazionalità di provenienza e i riferimenti culturali
possa rivelarsi una trappola dalla quale dovremmo guardarci e che proprio la pratica di relazioni d’aiuto con migranti può aiutarci a vedere.
Un ulteriore elemento di riflessione deriva dai risultati delle ricerche che evidenziano l’assenza di qualsiasi specificità
psicopatologica nelle persone di origine straniera e al tempo stesso significative differenze nelle modalità di richiesta
di aiuto e di presa in carico. Come se la specificità risiedesse piuttosto in questioni di ordine socio-politico piuttosto
che clinico e culturale.
L’intervento di Marie Rose Moro ha sottolineato sin dal
principio la necessità di considerare la migrazione come
un fattore di rischio per la salute dei minori.
Per questo motivo vanno considerati in egual modo numerosi fattori che intervengono nell’incontro transculturale,
in cui nulla deve essere dato per scontato, tra i quali vengono indicati: l’importanza dello spazio interno (alla famiglia,
27
AeM 64 nov. 08
28
ai gruppi di appartenenza) e dello spazio esterno (istituzioni, cultura ospitante) per i migranti, la trasmissione transgenerazionale (come e che cosa si trasmette nel rapporto
genitori/figli), il ruolo e il valore della lingua dei genitori
per i giovani di seconda generazione.
E anche in questo caso occorre avere il coraggio di porre domande evidenti: cosa significa prima generazione?
È facile collegare l’appellativo all’atteggiamento generale
di considerare il migrante senza una vita, una storia, un
contesto, prima del suo arrivo in Italia. Una specie di improvviso qui e ora senza passato, una sorta di tabula rasa,
perché il resto è ignoto…, un altro modo per sottolineare
lo strappo tra il prima e il dopo.
È importante inoltre partire dai processi di filiazione (essere figlio dei propri genitori, essere iscritto a una discendenza, in base a elementi consci e inconsci) e di affiliazione
o meglio affiliazioni (i giovani di seconda generazione non
scelgono un gruppo: devono mescolare, fare le proprie affiliazioni, definire i propri desideri e aspirazioni di somiglianza; gli aspetti dell’appartenenza, dell’identità e della
creatività).
È proprio nella dinamica filiazione/affiliazioni che avviene
la costruzione della propria identità e nei bambini figli di
migranti ciò avviene attraverso un continuo passaggio dal
singolare al plurale e la capacità di integrare il concetto
di molteplicità. I bambini hanno bisogno di fare continui
passaggi tra dentro (rapporti tra genitori e figli, fratelli e
sorelle, maschi e femmine) e fuori (nel contesto Paese/accoglienza), dove il dentro è dentro alla famiglia: la lingua,
i rituali, l’educazione, le spiegazioni, il cibo, le relazioni famigliari, mentre il fuori è fuori dalla famiglia, la lingua del
paese di arrivo, la scuola, il gruppo amicale, l’educazione,
il cibo, i dottori, gli psicologi, gli ospedali, il modo di vedere il mondo, il razzismo.
Nelle situazioni transculturali la trasmissione della propria
filiazione dai genitori ai figli avviene senza il contesto del
gruppo. Inoltre viene trasmesso anche l’eventuale trauma
della migrazione e di eventi ad essa collegati: i bambini devono elaborare gli effetti che la migrazione ha avuto sui
genitori. Per questo motivo, ci indica Moro, è importante
lavorare sul racconto.
La situazione transculturale rappresenta in realtà anche un
elemento di creatività e di maggior resilienza, ma diversi
studi indicano con evidenza come essa diventi un fattore
di rischio per i bambini e le loro famiglie. È a partire da
questo “maggiore rischio” che tutti gli operatori, non solo
della salute mentale, ma anche della scuola o dei servizi sociali devono iniziare a porsi degli interrogativi ripensando
non solo la pratica quotidiana, ma anche il sistema teorico
di riferimento che la guida.
Dobbiamo domandarci se la nostra cultura dà sufficiente
spazio alla cultura di chi ci sta di fronte, essere consapevoli
che nello scambio tra culture avviene una trasformazione
costante, che la cultura è un sistema sempre dinamico che
cambia con gli incroci intergenerazionali.
Dobbiamo riconoscere che la domanda “da dove vengo” è
il primo punto che tutti affrontiamo e che nella migrazione
è una domanda costante.
Dobbiamo considerare gli effetti della migrazione negli individui e nei gruppi: negli individui dobbiamo considerare
la storia precedente alla migrazione, e tra gli effetti spesso
troviamo la violenza, i traumi, le depressioni, l’ansietà. Nei
gruppi gli effetti della migrazione sono spesso la mancan-
za di supporto e legami, la mancanza di valori, linguaggi,
religione. Inoltre dobbiamo considerare nella genitorialità
la solitudine e il fatto che esistono altre modalità di essere
genitori, altri modi di amare e di soffrire.
“La migrazione è un atto individuale a valenza collettiva”.
L’elemento collettivo dà luogo a trasformazioni anche di tipo
religioso e di modi di fare. Nulla è quindi dato una volta per
tutte: l’ambito in cui operiamo è dinamico, in trasformazione continua. Non ci sono certezze e ricette pre-costituite.
Sono i figli delle famiglie che migrano che più degli altri
bambini invitano noi operatori dei servizi a decentrarsi,
a mettere in discussione le nostre pratiche e a riadattarle:
anche se non c’è una psicopatologia specifica nel figlio dei
migranti, vi è una differenza nelle modalità di accesso e
nei risultati delle strategie che attiviamo. «Questi bambini sono costretti a gestire diversi registri, diversi mondi,
talvolta diverse lingue. Il figlio di migranti, come tutti i
bambini ma con una nitidezza maggiore che deriva dalla condizione di separazione tra l’interno della famiglia e
l’esterno, si costruisce nel punto d’incrocio tra i due processi: un processo di filiazione “sono il figlio di…, la figlia
di…” e un processo di affiliazione “appartengo a questo
o quel gruppo”, generalmente secondo uno schema di
appartenenze multiple che può modificarsi nel tempo. E
questi due processi, per armonizzarsi, devono sostenersi
a vicenda, mondo interno e mondo esterno». (Moro 2007)
Per questo motivo occorre creare legami tra le diverse
affiliazioni, occorre occuparsi ad esempio di entrambe le
lingue che appartengono al bambino, quella di origine e
quella ospitante, e anche del passaggio da una all’altra.
Roberto Beneduce ha aperto il suo intervento esplicitando
sin dal principio la forte e inevitabile connessione tra le attività rivolte agli immigrati e la dimensione politica: «trattare gli immigrati è di per sé un atto politico. Il bambino il
cui nome non viene accettato all’anagrafe è una questione
politica». Si rivolge quindi agli operatori invitandoli a riflettere sul proprio ruolo in riferimento all’attuale contesto
socio-politico, caratterizzato da una sorta di “privatizzazione dello stato” e parallelamente di crescente arbitrarietà.
Occorre quindi rigettare qualsiasi etichetta del buonismo e
operare nei luoghi di lavoro ciascuno con le proprie competenze in maniera efficace con una forte attenzione al pluralismo della realtà.
Quest’ultimo, sottolinea Beneduce, non è solo una questione con gli immigrati poiché il pluralismo delle appartenenze accomuna tutti. Si tratta dell’essere sospesi tra due
mondi o tra più mondi.
Allora è necessario contestualizzare le pratiche, le tecniche, il lavoro che si fa. Leggere, analizzare e riconoscere il
sociale, l’economico, il culturale, la politica (ad esempio in
relazione ai diritti di cittadinanza) nel lavoro che facciamo
con i migranti.
Le diseguaglianze sociali e l’esclusione sociale entrano anche nella relazione tra operatore e utente/paziente tanto che
non può essere presente alcuna forma di riconoscenza da
parte di quest’ultimo poiché si trova in una posizione di dipendenza, e la riconoscenza può avere luogo solo tra pari.
Nel lavoro con i migranti non si può eludere la specificità
dei percorsi di costruzione dell’identità.
È necessario attrezzarsi per operare quotidianamente e con
ciascun utente una “antropologia del sottosuolo”: di ciò
che non si vede.
Non bisogna perdere l’attenzione al globale, perché questo
ha effetti sul locale e sul nostro modo di erogare i servizi,
di adottare tecniche o stili di cura o determinate risposte ai
bisogni. Ad esempio è importante riconoscere che attualmente in Africa stiamo assistendo a processi di de-filiazione e dis-affiliazione. «Siamo davanti ad una massa enorme
di individui soli». Allora, dice Benduce, «la semiotica clinica deve essere anche politica. C’è un rapporto strettissimo
tra sofferenza, attività degli operatori e contesto politico. I
permessi di soggiorno sono violenza e arbitrarietà.»
È necessario riconoscere il culturale che sta nella psichiatria, ma soprattutto avere la consapevolezza che «culturale
non è sempre nell’altro»: anche le nostre stesse pratiche di
«diagnosi e cura» si realizzano all’interno di una specifica cornice, che va vista e riconosciuta nelle sue specificità,
punti di forza e limiti.
Se partiamo dal fatto che non ci sono specificità etnopatologiche nella popolazione immigrata, come anche i dati
presentati dal Dipartimento di Salute mentale di Bologna
mettono in evidenza, dobbiamo domandarci se la semiotica che abbiamo adottato è adeguata. Cosa è culturale
e cosa no? Nell’incontro con i migranti assistiamo a una
nuova modalità delle figure del dono e dello scambio, del
dentro e del fuori. A volte l’economico va riconosciuto in
ciò che noi chiamiamo culturale. La nostra attenzione deve
essere portata alla specificità della risposta.
“Guarire” cosa significa? Curare le memorie? Incontrare
chi è portatore di diversità cosa comporta?
Non dobbiamo mai dimenticare che “ci definiamo a partire da ciò che non siamo”.
La grande occasione che l’immigrazione ci offre è ripensare il nostro sistema dei servizi non più secondo un modello strutturato, dato una volta per tutte, valido allo stesso
modo per tutte le persone che vi accedono, impersonale e
“burocratico”, astratto.
I migranti ci obbligano ad «ascoltare la singolarità, ad accettare di moltiplicare i riferimenti di lettura di un fatto e
a cercare di co-costruire con l’altro una lettura possibile, la
sua, attualizzata nella relazione, ci portano a vedere l’altro
come un simile differente».
I migranti ci obbligano ad alzare lo sguardo dal piccolo
contesto locale e nazionale e a riconoscere le interdipendenze dei fatti, siano essi politici, economici, sociali e la
loro ricaduta sul nostro incontro quotidiano con l’altro.
Come mi ha sussurrato dal suo banco dietro di me un’assistente sociale: “ci si sente meno soli”. Forse proprio di
questo, anche di questo abbiamo bisogno anche noi che
lavoriamo in questo settore: di sentirci meno soli, di sentire
il sostegno politico, istituzionale, sociale e anche di sentire
il sostegno del pensiero, il sostegno delle idee che permettano di pensare alle nostre azioni come dotate di senso,
iscritte in un disegno complessivo con i suoi obbiettivi, i
contenuti, le metodologie di intervento, gli strumenti per
verificarne gli effetti.
Certo, è forte anche la tentazione di reclamare da questi momenti di incontro anche un maggior livello di operatività,
indicazioni e guida per operare nel quotidiano. Ma probabilmente sono altri i luoghi e le modalità per trasferire riflessioni e prospettive generali nello specifico degli interventi.
E allora è questo il nostro auspicio: che sempre più sia possibile rinnovare e rinforzare questo circolo virtuoso di riflessione e prassi, di considerazioni generali e enunciazione
di principi e attivazione di risorse; che sempre più i livelli
politico, istituzionale, organizzativo e operativo possano
incontrarsi, convergere e integrarsi.
Vorremmo concludere prendendo a prestito le parole di
un’altra grande esperta del settore Cecilia Edelstein, psicologa, terapeuta familiare e sistemica, etnopsicologa e terapeuta transculturale, fondatrice di Shinui - Centro di consulenza sulla relazione (vedi box a p. 46) e Direttrice della
Scuola triennale di counseling sistemico pluralista di Bergamo): «L’immigrazione ha effetti enormi sulla persona, il
cambiamento è insito nel passaggio, dopo la migrazione la
persona non è più la stessa. Allo stesso modo la società che
accoglie l’immigrato cambia, anch’essa non è più la stessa. Nessun incontro è unidirezionale, siamo nel campo dei
processi e i processi di integrazione partono dall’incontro
personale. È quindi nell’ambito relazionale che si svolge il
processo, qui le emozioni si mettono in gioco. Lo scambio
emotivo coinvolge anche negli operatori la parte umana al
di là del ruolo e quindi l’utilizzo del sé relazionale nella
relazione d’aiuto. Vengono così coinvolti i diversi livelli del
sé. Portare se stessi nella relazione d’aiuto è importantissimo e come farlo è un arte. Questo saper essere va completato con il sapere e il saper fare in una congiunzione di
elementi volti alla co-costruzione delle risposte di cura. Il
disagio è universale, la manifestazione è culturale e individuale. L’attenzione degli operatori deve essere posta nel
non confondere il disagio con la patologia.»
Silvia Festi, collaboratrice della Cooperativa Lai-momo, si
occupa da anni di migrazioni e di progetti in favore delle
popolazioni migranti
Paolo Ballarin è psicologo psicoterapeuta esperto in tematiche interculturali, lavora come libero professionista a
Bologna, collabora con la Cooperativa Lai-momo, con enti
e pubbliche amministrazioni
BIBLIOGRAFIA
M. Benasayag, G. Schmit (2003), L’epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, Milano, 2004
C. Edelstein, Psicodiagnosi, salute mentale e immigrazione,
in AA.VV., La parola e la cura, vol.1, 2004, pp. 45-48
N. Losi, Vite altrove, Feltrinelli, Milano 2000
M.R. Moro (2007), Maternità e Amore, Frassinelli. Torino
2008
M.R. Moro, Bambini di qui venuti da altrove, Franco Angeli, Milano 2005
O
n the 10th of October 2008, in the University of
Bologna, the department of Mental Health held
a convention on the topic of people coming from other
cultures. The convention, “Dalla formazione degli
operatori alla presa in cura di bambini, adolescenti e
adulti di altre culture”, highlighte that in order to take
care of immigrant citizens it is necessary to have good
knowledge of the phenomenon of immigration. In this
context, the work needs to happen on different levels:
health, psychological, sociological, anthropological,
social, political, theoretical and operational.
29
AeM 64 nov. 08
ESPERIENZE
Le service de psychopathologie
de l’enfant et de l’adolescent
de l’Hôpital Avicenne:
les métissages au service des
soins psychiques
par Marie Rose Moro
Quelques mots d’histoire
C’est en 1978 que le Pr Serge Lebovici, pédopsychiatre
et psychanalyste, a créé le service de psychopathologie de
l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital Avicenne pour développer la psychopathologie du bébé en partenariat avec en
particulier la Protection Maternelle et Infantile, approche
nouvelle en France. Serge Lebovici a rapidement compris
la nécessité d’accueillir de manière adaptée les parents
d’où qu’ils viennent et quelle que soit leur langue et les
représentations qui les habitent. En 1983, il est remplacé
par le Pr Philippe Mazet qui continue à développer l’étude
des interactions mères-bébés en particulier entre les mères déprimées et leurs enfants. En 2000, le Pr Marie Rose
Moro, ethnopsychiatre et psychanalyste, prendra en charge ce service en continuant à développer l’étude sur les
interactions parents-bébés dans la tradition première de ce
service. Cependant elle va développer les études transculturelles. De même dans l’accueil et la prise en charge des
familles migrantes et leurs enfants.
Les structures aujourd’hui
Aujourd’hui, le service s’est diversifié avec une préoccupation d’accueil de toutes les familles en particulier celles qui
sont le plus en difficultés sur le plan culturel pour mettre
la psychothérapie au service de tous.
30
- La consultation transculturelle.
Plus de vingt langues sont parlées tous les ans dans cette
consultation qui se fait avec un groupe de psychothérapeutes polyglottes et cosmopolites. Des traducteurs participent
aussi à ce dispositif spécifique qui permet d’expérimenter
des manières de faire qui ensuite sont mises au service de
l’ensemble du service, bébés, enfants, adolescents.
- La consultation parents-bébés.
- La consultation de pédopsychiatrie.
- Le Centre référent langage, pour tous les enfants qui présentent des troubles du langage.
- La Maison des adolescents d’Avicenne (Casita), qui accueille et soignent les adolescents et leurs parents.
- La prise en charge des addictions (Le centre Boucebci et
l’ECIMUD).
- La Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP 93)
pour tous les traumas collectifs.
- Les urgences psychiatriques.
- La psychiatrie de liaison.
Et aussi, des enseignements universitaires et aux professionnels dans le domaine des soins aux bébés, des adolescents et de la clinique transculturelle. Enfin, une équipe
de recherche en clinique transculturelle.
BIBLIOGRAPHIE
Un film: J’ai rêvé d’une grande étendue d’eau. Réalisatrice:
Laurence Petit-Jouvet,
Abacaris Films ([email protected]), Producteur:
Arnaud de Mezamat
Un livre: M.R. Moro et coll., Avicenne, l’andalouse. Devenir psychothérapeute en situation transculturelle, La Pensée
sauvage, Grenoble 2004
Marie Rose Moro est Professeur de Psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent, Université de Paris 13, Chef de service au
Centre Hospitalier Universitaire Avicenne (Bobigny, France), AP-HP. Dirige la revue transculturelle L’autre et le Centre de Recherche en clinique transculturelle de Paris 13
© aiep – 10 juin 2005 - www.clinique-transculturelle.org
DOSSIER
La salute delle persone in viaggio
di Rabih Chattat
A
ffrontare un viaggio migratorio è un’operazione
complessa e richiede, paradossalmente, la disponibilità di risorse che nella realtà sono assenti. In conseguenza di ciò il migrante si trova esposto a un numero significativo di eventi definibili come “stressanti” che hanno
un impatto significativo sulla possibile relazione tra la “provenienza” e lo stato di salute attuale. In questo contributo si
cercherà di delineare in maniera sintetica tre punti importanti al riguardo. Nella prima parte si adotterà una visione
d’insieme del rapporto tra la provenienza e lo stato attuale
elencando tutti i fattori che entrano in gioco e il loro contributo; la seconda parte prenderà in considerazione la prima
fase della migrazione, quella fase di transizione tra i “due
mondi” e la specificità di questa condizione rispetto ad altre fasi del viaggio; l’ultima parte tenderà, in relazione alla
prima fase migratoria, a gettare uno sguardo sull’esperienza di una categoria speciale di migranti, quelli non assistiti
dal servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento
all’esperienza di un ambulatorio che svolge una funzione di
cerniera al riguardo. Prima di addentrarci nella descrizione
è importante sottolineare che non verrà fatto un riferimento
puntuale alla bibliografia utilizzata ma verranno citati alla
fine dell’articolo alcuni testi o articoli utilizzati come fonte
di dati a cui i lettori possono fare riferimento.
Dalla partenza all’oggi
Il tema della salute delle persone in viaggio può essere
analizzato seguendo una prospettiva di tipo trasversale,
collocando su di una linea retta ad un estremo il punto di
partenza (provenienza in termini di appartenenza originaria) e all’altro estremo lo stato attuale di salute (benessere
e malessere) in un dato momento nella nuova realtà (nuova
appartenenza); si può procedere quindi con il collocare,
lungo questa linea, tutti quei fattori che, avendo un certo
impatto, giocano un ruolo nel modulare l’esito (la salute/
malattia della persona interessata). In quest’ottica si potrebbero considerare tre ordini di fattori: uno di tipo biologico/genetico, uno di tipo socio-culturale e un altro relativo alla condizione socioeconomica. Il primo esercita la sua
influenza sia direttamente che indirettamente; la relazione
diretta si può evidenziare prendendo in considerazione le
suscettibilità di alcuni gruppi di popolazione per alcune
malattie (ad esempio talassemia e Mediterraneo), mentre
quella indiretta diventa evidente se si considera che l’avvio
del viaggio della persona è l’esito di una selezione basata, in
particolare nella prima generazione di migranti, principalmente sulla “salute” e sulla forza fisica intese come risorsa
per compiere il viaggio. Estendendo questo concetto, la
provenienza incide anche come elemento che può favorire
la discriminazione; a questo riguardo sono ormai all’ordine
del giorno micro e macro episodi che segnalano l’accentuazione del rischio per chi possiede lineamenti o colore della
pelle diversi. A parte il rischio fisico diretto, tale discriminazione incide sulle possibilità di accesso e di fruizione dei
servizi addetti alla salute; la discriminazione incide anche
sulla disponibilità di alloggio e sulle condizioni lavorative
oltre a essere essa stessa una fonte di stress e di disagio.
Per cui sarebbe opportuno considerare la discriminazione,
In cerca di
accoglienzaVia Marsala,
Roma 2006.
Foto di Sarah
Klingeberg
31
AeM 64 nov. 08
Partita
a calcio,
Roma 2007.
Foto di Sarah
Klingeberg
32
non solo nel più ampio aspetto politico-sociale, ma anche
nelle sue ricadute sulle normali condizioni di vita quotidiana; in alcune situazioni essa è fonte di hassles (le piccole
seccature quotidiane che hanno impatto significativo sulla
salute quanto gli eventi stressanti significativi).
Accanto alla dimensione “etnica” in senso stretto il secondo
ordine di fattori fa riferimento agli elementi di ordine sociale e culturale; oltre alle differenze culturali che hanno il loro
impatto sui comportamenti, sugli stili di vita, sulle rappresentazioni della salute e della malattia e sui linguaggi delle
patologie (elementi ampiamente descritti dall’antropologia
e dall’etno-medicina) in questa sede preme soprattutto mettere l’accento su alcune componenti, forse di ordine minore,
ma importanti nella loro influenza sullo stato di benessere.
Il primo di questi è la lingua, in particolare nelle prime fasi
della migrazione oppure quando non si creano le condizioni per un apprendimento adeguato; potrebbe sembrare banale ma la conoscenza della lingua (italiana in questo caso)
è un elemento importante di facilitazione della partecipazione e dell’accesso ai servizi e al miglioramento delle condizioni di lavoro oltre a essere un elemento fondamentale
nell’interazione; d’altro canto alcune condizioni sociali di
isolamento e ristretta interazione riducono ulteriormente
le possibilità di acquisire le abilità linguistiche necessarie.
Nella pratica quotidiana si osserva frequentemente l’importanza di tale dimensione e come essa può essere fonte
di equivoci e di discriminazioni basate sostanzialmente su
problematiche di ordine comunicativo.
Il secondo fattore socioculturale interessa il tema della “partenza”; partire significa anche separarsi, distaccarsi, allontanarsi, abbandonare un luogo, uno spazio ma anche delle
persone significative; certo, vi sono alcune determinanti
(primariamente di ordine economico), in particolare quella
di diventare la fonte di sostentamento degli altri rimasti.
La dimensione e l’impatto di questa “separazione” finalizzata tendono a manifestare il loro effetto nel tempo in
base alla legge “fisica” della risposta allo stress, secondo la
quale all’inizio si mobilitano tutte le risorse per affrontare un determinato evento; questa mobilitazione permette
l’acceso a energie utili la cui disponibilità temporale è però
limitata, per cui se non avviene un processo di integrazione
(recupero) delle energie utilizzate si rischia di procedere
progressivamente verso uno stato di esaurimento, cioè di
sofferenza e di disagio e in alcuni casi di malattia; a proposito di malattia fisica occorre considerare il rapporto
tra cultura e linguaggio somatico in quanto il corpo (e il
simbolo) in molte realtà è uno strumento molto più adatto
a comunicare il proprio stato di malessere di quanto non
possa essere la parola.
Questa fase di possibile esaurimento avviene spesso a distanza di 2-4 anni dal momento di arrivo e esprime la distanza
temporale massima tollerabile per una separazione. In questo processo di bisogno-necessità, di cui verrà illustrato un
esempio in seguito, la separazione può essere ricomposta, se
le condizioni lo permettono, attraverso un contatto diretto
con il luogo e le persone che sono state abbandonate; questo
può avvenire sia tramite la ricongiunzione sia tramite il rientro temporaneo o definitivo. Questa fase di ricomposizione
ha un impatto anche sulla personalità delle persone e sul
loro senso di identità e di ruolo; una signora, ad esempio,
dopo tre anni di assenza dal paese di origine dove aveva lasciato il suo bambino ancora piccolo in custodia alla madre,
doveva il suo stato di ansia e di timore all’esito di un possibile incontro con il figlio, adducendo preoccupazioni sul reciproco riconoscimento e sulle capacità di riprendere il ruolo
di madre. È proprio durante questa fase che si osservano
fenomeni di “ritorno” quasi “integralista” alle origini oppure di rinuncia altrettanto sostanziale. Sarebbe opportuno
osservare che, dopo un certo periodo, questa dimensione di
separazione e distacco diventa la condizione stessa del migrante, che avverte l’indebolimento dei legami con la realtà
di origine e la difficoltà di sostituirli con nuovi legami significativi; questo lo porta ad essere particolarmente esposto a
situazioni di sofferenza e disagio oppure di chiusura e isolamento. Questi elementi possono essere considerati anch’essi
fonti di stress psicosociale e avere quindi un impatto anche
sulla salute fisica della persona.
Il terzo ordine di fattori, quello relativo allo status socioeconomico, fa riferimento ad aspetti inerenti il tipo di lavoro svolto, le mansioni, l’accesso e la disponibilità di risorse
(retribuzione e potere di acquisito), di informazioni adeguate e di reti sociali.
Tutti questi fattori, sebbene in maniera diversificata, possono essere fonti di stress psicosociale, condizionare l’accesso ai servizi, oppure interferire con la possibilità di acquisire comportamenti e stili di vita salutogeni ecc.
La transizione tra “due mondi”
Da quanto esposto sopra emerge chiaramente la complessità del modello che cerca di porre in relazione migrazione
e salute; inoltre il processo di migrazione è lungo e coinvolge più di una generazione per cui si cercherà, come proposto all’inizio, di mettere ancora più in evidenza gli elementi
connessi alla prima fase della “immigrazione” e il ruolo
degli elementi connessi alla “emigrazione” nel determinare
lo stato di benessere della persona in viaggio. Questa scelta
è dettata anche dall’esperienza sul campo, a contatto con
migranti arrivati da poco (in un arco di circa tre anni) e in
condizioni particolari, cioè non assistibili normalmente dal
servizio sanitario nazionale. La prima tappa del viaggio, in
particolare per quanto concerne la realtà italiana, è spesso
connotata da una condizione di estrema “precarietà” in
termini legali; i numeri diffusi dalle diverse agenzie oppure emersi in occasione delle cosiddette “regolarizzazioni”
sono degli indicatori importanti della dimensione della
tendenza a trattare la questione solo nel suo aspetto di “sicurezza” e di “ordine pubblico” omettendo tutti gli altri
aspetti correlati quali: la forza della “povertà” che spinge
ad allontanarsi dalla propria terra e dai propri affetti; l’assorbimento da parte di un mercato del lavoro flessibile che
cerca di risparmiare non solo per trarre vantaggio da certe
forme di sfruttamento ma anche per l’inadeguatezza delle
sue risorse in rapporto ai bisogni impellenti degli immigrati; la mancanza di percorsi chiari e guidati che possono regolare l’ingresso; la sproporzione tra un mercato della domanda alto e una disponibilità di posti “regolari” bassa.
Tutti questi elementi, insieme alle loro reali conseguenze,
contribuiscono a creare una categoria di persone piena di
doveri ma alla quale manca del tutto qualsiasi forma di diritto, di tutela e di riconoscimento. L’unico “diritto” che
viene riconosciuto a queste persone è quello delle “cure
urgenti e essenziali”, che rappresenta una traduzione discutibile del dettato costituzionale che afferma il diritto
alla salute delle persone presenti sul territorio italiano. Si
crea quindi in questo ambito una significativa compressione delle possibilità di riuscita per una persona che intraprende il suo viaggio con lo scopo di fornire un supporto
economico a quelli che restano e il viaggio dall’inizio si
presenta carico di incognite e di pericoli.
Già la traversata del deserto per entrare nell’“Europa senza
frontiere” non è scevra da costrizioni e pericoli; alcuni riescono ad ottenere il visto turistico (che costa molto) ma altri
devono affidarsi ai “corrieri”, con tutti i rischi e i costi del
caso, per approdare in una realtà nella quale sono a rischio
continuo di essere “espulsi”, rinchiusi e comunque considerati (quando ciò accade) solo come un problema di ordine.
Nel frattempo, sulla base della nostra esperienza, molti di
loro svolgono il loro lavoro nelle case delle persone anziane
assistendole oppure badando alla casa. La loro condizione,
oltre a comportare una fragilità estrema di negoziazione,
per cui gli orari di lavoro possono diventare continui (il
luogo del lavoro diventa una prigione ma anche un rifugio
data la condizione di presenza), determina l’assenza o la
riduzione di relazioni sociali e interpersonali, esasperando
la distanza e il distacco dalle persone significative che può
durare in media 2-3 anni e il contatto continuo con la sofferenza dell’altro; tutto con lo scopo di sostenere la sopravvivenza e di garantire il futuro a coloro che sono stati lasciati
nel paese di origine. Questa descrizione è esemplificativa di
molte delle condizioni che si riscontrano nell’ambulatorio
della nostra associazione dove diverse persone si rivolgono
ai nostri volontari chiedendo cura, ascolto, sollievo ma anche legittimazione e riconoscimento.
Migrazione e salute: l’esperienza di Sokos
La richiesta di cura a SOKOS riguarda nella maggiore parte dei casi problematiche di salute che sono la conseguenza delle condizioni di vita e di lavoro affrontate in Italia;
raramente abbiamo riscontrato ciò che viene chiamato
“patologia da importazione”, cara come categoria in quanto veicolo di suggestioni esotiche oltre che affascinanti.
Le malattie che riscontriamo sono, in ordine di maggiore frequenza, a carico dell’apparato muscolo-scheletrico,
dell’apparato digerente, dell’apparato respiratorio e le
problematiche algiche (cefalea in particolare) seguite da
quelle di tipo neurologico e psicopatologico; ciò conferma l’origine situazionale della problematica e il ruolo delle
condizioni “socio-economiche” oltre che “socio-culturali”
nel determinismo delle condizioni di salute. In una ricerca
svolta all’interno della nostra Associazione, dal titolo “La
cura delle donne che curano”, sostenuta da Coop Adriatica attraverso l’iniziativa “C’entro anch’io”, le badanti intervistate hanno riferito di percepire come dannosi per il
loro benessere globale i ritmi di lavoro continui (24 ore su
24 per almeno 6 giorni a settimana), la pressione psicologica della relazione assistenziale, la fatica fisica del lavoro
che viene svolto, l’alterazione del ritmo sonno-veglia dovuto alle richieste notturne di assistenza; tutti questi elementi, insieme ad altri ancora, sono considerati come causa di
molti dei disturbi presentati.
Una considerazione a parte merita la richiesta di visite di
tipo ginecologiche in quanto esprimono l’esigenza di tutela
e di prevenzione che le donne, indipendentemente dalla
loro provenienza, cercano di mantenere e/o di riprendere;
ciò può essere letto come una ricerca di continuità e di protezione di fronte a un’esistenza non solo precaria ma anche
minacciata; si può affermare che le donne, attraverso un
processo di normalizzazione, cercano di ridurre l’impatto
di una condizione di sospensione. Nello stesso ordine di fattori può essere collocata l’assistenza pediatrica svolta dalla
nostra associazione a favore di genitori e dei loro bambini,
anch’essi influenzati dalla condizione dei genitori.
Oltre alla cura svolta con le visite, gli approfondimenti di
diagnosi e le terapie del caso, non va trascurata l’importanza dell’ascolto; in effetti rivolgersi a SOKOS rappresenta
una delle poche “giustificate” assenze dal lavoro e offre la
possibilità di raccontare qualcosa a qualcuno; dato il limitato spazio fisico e temporale utile allo sviluppo di relazioni, l’occasione di una visita diventa importante in quanto
rappresenta un’opportunità anche se limitata e contenuta.
In effetti i colleghi che svolgono l’attività di ambulatorio
sono concordi nel segnalare la necessità di andare “oltre”
la visita e di costruire le condizioni per dare “più tempo”
alla visita, esprimendo in questo modo il valore relazionale
del lavoro che viene svolto e l’importanza della dimensione
dell’attenzione e dell’ascolto, percepiti come bisogno proprio ma che in realtà possono essere considerati il riflesso
della richiesta dell’altro. In base a quanto esposto si potrebbe affermare che il servizio offerto da SOKOS svolge
diverse funzioni, non solo di ordine “sanitario” ma più articolato e permette di rispondere a diversi bisogni.
A questo punto potrebbe essere utile estrapolare alcuni
aspetti dedotti da una serie di colloqui svolti con un’assistente domiciliare che si è rivolta a SOKOS per un problema di cefalea e che è stata successivamente indirizzata
verso degli incontri di supporto al fine di mettere a fuoco
i fattori di tipo psicosociale che possono avere giocato un
33
AeM 64 nov. 08
34
qualche ruolo nello sviluppo della sintomatologia. Il primo
punto da considerare è l’estrema prudenza con la quale la
signora ha affrontato i primi incontri; ciò può essere letto
come necessità, da parte della persona, di essere rassicurata in merito al tipo di lavoro che verrà svolto e all’utilità
e alla ricaduta che ciò può avere per lei. Ciò ha portato
la persona a riportare le difficoltà incontrate nel lavoro di
assistenza che sta svolgendo, difficoltà descritte nei termini
di orari, di fatica fisica ma anche di tipo relazionale, sottolineando la sua percezione di “non esistenza” al di fuori del suo ruolo di aiuto; il concetto di “non esistenza” fa
riferimento al vissuto di non essere considerata da parte
della persona assistita nei propri bisogni e nelle proprie
esigenze; dormire quando l’altro dorme, mangiare ciò che
l’altro propone o permette, usare gli spazi concessi in una
condizione in cui il luogo di lavoro è anche la casa della
signora: sono tutti elementi che restringono lo spazio di
una presenza («non vedo l’ora di avere una stanza per me
anche se non ha la luce»). A questa significativa impossibilità di disporre del tempo, dello spazio e della quotidianità
veniva attribuita una quota significativa del disagio e delle
difficoltà vissute. Con il proseguire degli incontri, accanto
alle difficoltà della quotidianità, sono emersi aspetti correlati al rapporto con la realtà di provenienza, in quanto la
signora ha lasciato nel suo paese un figlio piccolo accudito
dalla madre e dal padre di lei; il racconto al riguardo ha
fatto emergere un altro aspetto della sua sofferenza, legato
al suo ruolo di madre “distante”, alla quale viene richiesto
da parte del figlio di indicare una data di rientro che lei
non riesce a mantenere; questo a causa della condizione di
sospensione in cui vive in attesa di una potenziale, futura
e ipotetica regolarità oppure di un rientro dopo avere assicurato il proprio futuro, quello dei genitori e quello del
figlio. Come si può intuire, questo rapporto con i familiari
assenti è sotto certi aspetti lacerante per la sovrapposizione
tra le cause e le soluzioni della propria sofferenza. A ciò si
aggiunge il rapporto con i genitori che sollecitano la figlia a
“resistere” all’estero ma nello stesso momento le chiedono
risorse per completare alcuni progetti (migliorare la casa o
ingrandirla). Sembra quindi una situazione bloccata e senza via di uscita; le uniche alternative possono essere rinunciare al progetto migratorio e rientrare nel paese di origine
oppure sperare in una regolarizzazione che permetta un
movimento libero in grado di favorire il ricongiungimento
con i familiari o quantomeno la ricomposizione periodica
delle relazioni.
Da quanto descritto si evidenzia l’alto prezzo che pagano
queste persone, esponendosi continuamente al rischio (minaccia) di vedere distrutto o interrotto il loro progetto; a
ciò si può attribuire la loro prudenza relazionale, il loro
timore di esporsi ma anche il bisogno di raccontare la propria esperienza a qualcuno che sia disponibile ad ascoltare
le rotture relazionali che devono affrontare. Per il momento alla signora dell’esempio citato non rimane che cercare
di “corrompere” il figlio inviando, con i corrieri che fanno
la spola, molti regali e oggetti nella speranza di colmare la
distanza, sostenere i propri genitori non solo per la loro
sussistenza ma anche per i propri progetti; per affrontare tutto ciò non rimane che rimandare di mese in mese
la soluzione, nella speranza che succeda qualcosa. Questa
“quasi illusione” riesce a sostenere il loro sforzo finché il
dolore della distanza non supera certi limiti; a quel punto
non rimane altro che rientrare.
In conclusione è opportuno richiamare l’attenzione sull’effetto della migrazione in sé e sul diverso impatto sulla
salute, a seconda delle fasi e delle condizioni in cui viene
affrontata. Inoltre il viaggio delle persone che migrano è
carico di elementi che possono avere un effetto sulla loro
condizione di salute e di benessere in generale, per cui si
potrebbe sottolineare l’importanza di una attenta valutazione della complessità del rapporto tra migrazione e
salute, sia nella sua dimensione trasversale (aggregazione
temporanea di diversi fattori) sia nella sua dimensione verticale (successione di elementi che condizionano la salute),
al fine di costruire delle risposte adeguate ai bisogni espressi e attuali, senza trasformare una dinamica complessa in
una schematizzazione facile da comprendere ma difficile
da applicare nella pratica.
Rabih Chattat è Professore associato di Psicologia Clinica presso l’Università di Bologna e Responsabile Ricerca e
Aggiornamento presso il SOKOS, associazione per l’assistenza a emarginati e immigrati di Bologna
www.sokos.it
BIBLIOGRAFIA
E. Baken, A. Bazzocchi, N. Bertozzi, C. Celeste, R. Chattat,
V. D’Augello, L. Marchetti, M. Palazzi, E. Prati, C. Reali,
C. Ranieri, F. Righi, E. Sukaj, P. Vitali, La salute maternoinfantile degli stranieri e l’accesso ai servizi. Analisi qualiquantitativa nel territorio cesenate, in «Quaderni acp», vol.
14, n. 2, 2007, pp. 56-60
R. Chattat, La lunga transizione dei migranti, in «Animazione sociale», n. 2, 2007, pp. 27-34
A.M. Kamperman, I.H. Komproe, J.T.V.M. de Jong, Migrant mental health: a model for indicators of mental health
and health care consumption, in «Health Psychology», n.
26, vol. 1, 2007, pp. 96-104
N. Leduc, M. Proulx, Patterns of health services utilization
by recent immigrants, in «Journal of immigrant health»,
vol. 1, n. 6, 2004, pp. 15-27
A. Sayad, La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato
alle sofferenze dell’immigrato, Raffaello Cortina Editore,
Milano 2002
H.P. Uniken Venema, H.F.L. Garretsen, P.J. Van der Maas,
Health of migrants and health policy, the Nederlands as an
example, in «Social Science and Medicine», n. 6, vol. 41,
1995, pp. 809-818
I
n this article the author highlights the relationship
between health and immigration, in reference to the
concepts of a transversal viewpoint (which involves
biological-genetic, cultural, social and economic
factors) and a vertical viewpoint (psychological stress).
In this framework the association SOKOS gives
medical and psychological support to immigrants
living precariously; these activities have their
foundation in the belief that social, cultural and
economic conditions have a big influence on the
health of immigrants.
Fondazione europea
per la Genetica
di Serena Paterlini
L
a Fondazione europea per la Genetica è una ONLUS creata nel 1995 da un gruppo di ricercatori già
coinvolti nello sviluppo di attività legate alla European School of Genetic Medicine, scuola nata nel 1988 per
iniziativa dei professori Victor A. McKusick e Giovanni
Romeo, e considerata fonte scientifica e ideologica della
fondazione. Sin dalla sua nascita, l’obiettivo primario della fondazione è la promozione scientifica e professionale
di giovani genetisti europei con particolare attenzione alle
applicazioni nel campo della medicina preventiva. I corsi
della European School of Genetic Medicine, gestiti dalla
fondazione, offrono a giovani scienziati provenienti da tutto il mondo la possibilità di acquisire nuove competenze
in un contesto multiculturale e di grande spessore scientifico. Sin dal 2002, con l’assegnazione da parte della Commissione europea di fondi nell’ambito del progetto EUMEDIS, la fondazione, mettendo a disposizione il proprio
bagaglio culturale-scientifico e la sua expertise, ha creato
un ampio network (laboratori, ospedali, centri di ricerca,
dipartimenti universitari) nell’area Mediterranea del mondo e, al contempo, ha dato il via a un progetto triennale di
formazione a distanza rivolto a medici e ricercatori mediorientali specializzati in genetica medica, impossibilitati per
varie ragioni a partecipare a dei corsi organizzati in Italia.
Di fatto, la peculiarità di questi corsi denominati “ibridi”
consiste nella possibilità di poter seguire via internet da
un laboratorio, da un centro di ricerca, dal dipartimento
di un ospedale (remote training centres) un corso che è
realizzato presso uno dei due centri di formazione (main
training centres) di cui la fondazione dispone (il Centro
universitario euromediterraneo sito a Ronzano (Bologna),
e il Centro universitario sito a Bertinoro di Romagna). La
denominazione “ibrido” è strettamente legata alla natura
stessa del corso, un mélange perfetto tra formazione frontale e e-learning. Di fatto, i corsisti di un corso ibrido, pur
non essendo fisicamente in Italia, possono, grazie ad un
semplice collegamento internet, partecipare alle sessioni
didattiche previste dal corso residenziale, interagire online con i docenti per eventuali chiarimenti e approfondimenti durante la “questions and answers session” prevista
alla fine di ogni sessione mattutina, e allo stesso tempo
prendere parte ai laboratori pratici che il direttore del
RTC, ha organizzato in loco.
Dal 2004, dunque, la fondazione ha attivato una vera e
propria rete di remote training centres in varie aree del
Mediteranneo e del Mediorente (Tunisia, Iran, Egitto, Marocco, Algeria, Slovenia, Spagna, ecc.) e la partecipazione
media ad ogni corso ibrido è di 3 RTC e più di 70 studenti.
La scelta della fondazione di creare partenariati con l’area
mediterranea e dei Paesi ACP nasce dalla volontà di incoraggiare, attraverso il dialogo scientifico, l’analisi delle implicazioni sociali, etiche e legali legate alle scoperte genetiche. La creazione di un network di RTC dislocati in vari
Paesi mediterranei offre la possibilità a moltissimi ricercatori e soprattutto ricercatrici, di usufruire di corsi altamente professionalizzanti e utili nella loro attività di ricerca.
La fondazione ha inoltre in attivo, accanto ai partenariati
legati all’Educazione allo Sviluppo, una serie di progetti
di cooperazione internazionale finanziati dall’Unione europea e dal Ministero degli affari esteri, volti a rafforzare
la comunità euromediterranea dei ricercatori nell’ambito
della ricerca clinica e molecolare rivolta alla talassemia e
alle emoglobinopatie correlate e alla oncogenetica. Grazie
ai progetti avviati e al network legato ai corsi ibridi, più di
800 studenti e ricercatori di vari Paesi mediterranei hanno potuto accedere a una formazione elevata e specifica,
senza dover abbandonare il proprio Paese continuando
a fare ricerca. La Fondazione europea per la Genetica ha
dunque fondato sul dialogo interculturale scientifico la sua
specificità, operando non solo nell’ambito dell’educazione
frontale e in quella a distanza e nella progettualità internazionale, ma anche attraverso la realizzazione di eventi
destinati a un pubblico non solo di formazione scientifica.
Il public under standing è di fatto uno dei nuovi fronti di
azione della Fondazione; attraverso l’organizzazione di festival, dibattiti, conferenze concernenti le malattie genetiche, si cerca un contatto con la cittadinanza. L’importanza
di tali iniziative è senza dubbio legata alla necessità di sensibilizzare i non addetti ai lavori, di renderli partecipi delle
scoperte scientifiche, di rendere fruibile e accessibile una
materia complessa e articolata, di creare un ponte concreto
tra scienza e società, tra cittadinanza e ricerca.
ESPERIENZE
13 anni di ricerca scientifica,
formazione e cooperazione internazionale
35
AeM 64 nov. 08
DOSSIER
Una sfida per il futuro
36
l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle
popolazioni Migranti e per il contrasto delle
malattie della Povertà
Sintesi della presentazione ufficiale di Aldo Morrone e Ottavio Latini a cura della redazione
L
a visione particolare del mondo e la percezione di
salute e della malattia sono definite dalla cultura,
dalla scienza e dalla conoscenza. Il singolo interpreta la propria situazione nelle forme basate sulle conoscenze
della propria cultura, trasmessa e derivante dalla vita di
tutti i giorni, con riti e riti e modi differenti. Da questa
conoscenza, ogni gruppo sviluppa ciò che sembra essere
più utile per il proprio benessere e lo trasforma in tradizione. Le diverse classificazioni sono fatte secondo conoscenze diverse e l’unione della medicina complementare
e di quella convenzionale produce situazioni complesse.
Oggi, abbiamo l’affascinante compito di leggere e sviluppare queste conoscenze, per il nostro futuro e quello dei
nostri bambini.
Nei prossimi 25-30 anni, la popolazione del nostro pianeta crescerà enormemente. Secondo la maggior parte delle
stime, la popolazione mondiale aumenterà di più di 2,7
miliardi di persone, pari a quasi il 50 per cento della popolazione attuale.
Entro 25-30 anni, la produzione alimentare mondiale
dovrà raddoppiare, con energia e produzione industriale
da triplicare. Nei Paesi in via di sviluppo, queste risorse
dovranno essere quadruplicate per adeguarsi all’aumento
della popolazione. Secondo le tendenze attuali, questo sviluppo economico condurrà a un ulteriore degrado ambientale e delle risorse: con un progressivo aumento dell’inquinamento dell’atmosfera, e il conseguente deterioramento
dello strato di ozono e l’intensificazione dell’effetto serra.
Aumenteranno inquinamento dell’acqua, disboscamento,
impoverimento del terreno e perdita della biodiversità.
In questo quadro, i rischi di danno alla salute aumenteranno drammaticamente, in particolare nei paesi tropicali
e in quelli in via di sviluppo. Le malattie, particolarmente
quelle correlate alla distruzione dell’ambiente, si trasmetteranno più facilmente in una popolazione di più di 8,5
miliardi, fra cui più di 7 miliardi vivranno nelle zone meno
sviluppate del mondo.
Che cosa si può fare di fronte a queste prospettive?
Lo squilibrio fra i paesi sviluppati e quelli così chiamati “in
via di sviluppo” può essere visto a tutti i livelli, compresi
quelli sanitari e scientifici. A livello internazionale, l’unica
alternativa possibile è offerta dallo lo sviluppo sostenibile.
L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) già aveva
cominciato, a metà degli anni Settanta, la campagna “l’anno 2000, salute per tutti”. Avendo superato tale data, l’impossibilità di realizzare gli obiettivi inizialmente definiti,
malgrado l’impegno delle organizzazioni internazionali,
è stata provata. Sarà necessario introdurre miglioramenti
culturali e scientifici se realmente vogliamo universalmente
“la salute per tutti”.
Il Sistema sanitario nazionale e l’immigrazione in Italia
Il Sistema sanitario nazionale (SSN) italiano è stato istituito nel 1978 (legge n. 833 23 dicembre, 1978) per garantire
l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini senza distinzioni di
sesso, residenza, età, reddito e lavoro. È fondato su due
principi di universalità (tutti i cittadini sono uguali e hanno
gli stessi diritti) e di accessibilità. Dall’inizio degli anni Novanta il SSN ha subito un processo della decentralizzazione, conferendo una progressiva maggior autonomia alle regioni. Di conseguenza, attualmente il SSN funziona su un
livello centrale e uno regionale, con diverse responsabilità.
A livello centrale lo Stato ha la responsabilità di assicurare
il diritto alla salute a tutti i cittadini attraverso un sistema
di garanzie costituzionali e attraverso la fornitura dei Livelli essenziali di assistenza (LEA). A livello regionale, le
regioni hanno la responsabilità diretta sul loro territorio di
rendere possibili gli obiettivi di salute del paese. Le regioni
hanno competenza esclusiva nell’applicazione, nella regolazione e nell’organizzazione dei servizi e delle attività, tese
alla salvaguardia della sanità pubblica. L’accesso al SSN per
gli stranieri è regolato dal Decreto legislativo del il 25 luglio 1998 - Testo Unico sull’Immigrazione, così come dalle
modifiche relative, quali il Decreto presidenziale 394/1999
di DPR 334/04 e di DPR 394/88. La circolare 5 del Ministero della Salute completa la riforma e l’aggiornamento
delle regole permettendo l’accesso normale ai servizi preventivi, curativi e rieducativi nazionali del sistema sanitario da parte dei cittadini stranieri, presenti regolarmente
o irregolarmente in Italia. Il DPR 334/04 art. 42 del Testo
Unico sull’Immigrazione specifica che il SSN è garantito
nel caso in cui il permesso di soggiorno sia estinto ma in
fase di rinnovo, prima dell’introduzione di tale modifica il
migrante con il permesso di soggiorno scaduto non aveva
più diritto al SSN.
In particolare, gli articoli 34 e 35 sottolineano che tutti gli
stranieri iscritti e non al SSN hanno il diritto alla salute.
- Articolo 34: “Assistenza sanitaria per gli stranieri iscritti
al SSN”. Gli stranieri hanno l’obbligo di registrarsi al SSN
con la conseguenza di avere parità di trattamento e gli stessi diritti e funzioni di qualunque altro cittadino italiano.
- Articolo 35: “Assistenza sanitaria per gli stranieri non
iscritti al SSN” che vivono sul territorio nazionale ma che
non sono in regola con le leggi relative all’entrata e alla
residenza legale, possono usufruire del trattamento urgente in ospedale o di tutti i trattamenti urgenti di base,
comprendenti anche le lunghe degenze in ospedale per
malattie o lesioni accidentali o come applicazione di protocolli di medicina preventiva volti a salvaguardare la salute
dell’individuo e della collettività.
Secondo la legislazione attuale, dunque, tutti gli italiani e
gli immigrati regolari possono avere libero accesso ai servizi forniti dal SSN, qualunque sia la loro situazione economica. Un contributo di spesa può essere chiesto per l’elargizione di determinati servizi e farmaci. Gli immigranti
illegalmente presenti sul territorio nazionale possono ottenere l’assistenza medica da un centro del SSN, se vengono
identificati e forniti di un codice STP (Straniero Temporaneamente Presente). Secondo la norma vigente, uno straniero privo di documento di identificazione deve fornire
soltanto il suo nome, la data di nascita e la nazionalità per
ricevere un numero STP. Il documento STP permette, in
questo modo, il libero accesso ai servizi e alle medicine essenziali quando il paziente si reca a un centro del SSN. Il
documento STP deve essere rinnovato ogni sei mesi.
INMP. Persone migranti e impoverite al centro: una rete
nazionale per assistenza, ricerca e formazione
Le persone migranti e impoverite sono i protagonisti, troppo spesso trascurati dalle Istituzioni, a cui vuole rivolgersi
l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle
popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della
Povertà (INMP). Esso eredita l’esperienza e rappresenta
il consolidamento dell’attività della Struttura complessa
di Medicina preventiva delle Migrazioni, del Turismo e di
Dermatologia tropicale dell’Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano, operante dal 1985 nel quartiere
Trastevere a Roma, ma affonda le sue radici nel lontano
1725, quando papa Benedetto XIII fondò un ospedale, per
accogliere e curare i malati di Roma e i pellegrini che giungevano nella città da tutta Europa, specialmente i poveri
e gli esclusi affetti da malattie della pelle, in particolare la
lebbra e la scabbia.
In linea con l’ispirazione originaria, e in risposta a concreti principi etici, è iniziata negli anni Ottanta un’attività di
accoglienza e cure gratuite dedicate alle persone più deboli ed emarginate, italiani e immigrati, a rischio di essere
escluse dall’accesso alle cure sanitarie a causa della povertà, dell’ignoranza, o a causa di problemi con la legge. Oltre
alla specifica attività clinico-scientifico-epidemiologica,
l’opera professionale è stata offerta, con un approccio rispettoso e accogliente, avvalendosi della preziosa esperienza di mediatori linguistico-culturali.
Il percorso formale per la costituzione dell’INMP parte dall’adozione di un protocollo d’intesa, il 7 settembre
2006, fra il Ministero della Salute, la Regione Lazio, la Regione Puglia, la Regione Sicilia, e gli Istituti Fisioterapici
Ospitalieri per la costituzione del “Centro di Riferimento
nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni migranti e il Contrasto delle Malattie della Povertà”,
che dava mandato al prof. Aldo Morrone, Direttore della struttura di Medicina Preventiva delle Migrazioni, del
Turismo e di Dermatologia Tropicale dell’IRCCS Istituto
dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano di Roma,
di promuovere e avviare tutte le procedure necessarie alla
realizzazione del Centro.
L’INMP si propone di costruire in breve tempo una rete
L’INMP è articolato in:
Una sede nazionale a Roma, in via di San Gallicano
25/a (www.inmp.it)
Tre Centri Regionali, riconosciuti con provvedimento
del Ministero della Salute:
- Regione Lazio, la Struttura di Medicina Preventiva
delle Migrazioni, del Turismo e di Dermatologia Tropicale dell’IRCCS Istituto Dermosifilopatico Santa
Maria e San Gallicano di Roma;
- Regione Puglia, parte dell’Azienda Ospedaliera Civile “Tatarella “ di Cerignola (FG);
- Regione Sicilia, parte dell’Azienda Ospedaliera San
Giovanni di Dio di Agrigento.
nazionale, sviluppando un rapporto di collaborazione con
altri sistemi sanitari regionali interessati a promuovere la
salute delle popolazioni migranti presenti sul loro territorio e a contrastare l’insorgenza delle malattie correlate alla
povertà, che affliggono le persone a rischio di emarginazione sociale.
Le strutture socio-sanitarie regionali dovranno lavorare
in stretta collaborazione con i servizi territoriali, le ASL,
i centri di ricerca scientifica e le associazioni del terzo
settore e dovranno venire incontro alle esigenze sanitarie
degli operatori del turismo, dei missionari, dei viaggiatori
da e per i Paesi tropicali, fornendo visite specialistiche e
informazioni sanitarie aggiornate per la prevenzione delle malattie più comuni delle regioni tropicali, le patologie
della povertà, le persone a rischio di esclusione sociale e
gli immigrati.
In questi ambiti, dovrà essere perseguita l’eccellenza nella
prevenzione, la diagnosi, l’assistenza, la ricerca e la formazione riguardo alle malattie prevalenti nelle popolazioni
target dell’azione dell’istituto, in un’ottica di inclusione e
di integrazione.
Altro obiettivo è colmare il gap di formazione specialistica
degli operatori socio-sanitari che vengono a contatto con
la popolazione migrante finalizzata all’approccio interculturale, nella tutela della salute degli immigrati, richiedenti
asilo, vittime della tratta, senza fissa dimora e nomadi, e
per il contrasto delle patologie della povertà, individuando
modelli di intervento per il corretto e tempestivo accesso ai
servizi sanitari regionali, con rispetto delle diverse identità
culturali, con accreditamento ECM. Si tratta di costruire
un intervento di sostegno formativo che si avvalga del contributo di esperti nel settore della medicina delle migrazioni e del contrasto alle patologie della povertà, al fine di
costruire con gli operatori socio-sanitari locali un percorso
di educazione, prevenzione, diagnosi e cura adattato a un
contesto multiculturale.
È infatti necessario definire un percorso per la ricostruzione della storia clinica di persone in condizioni di criticità,
dei possibili interventi a breve e medio periodo, avvalendosi anche del contributo di staff multiculturali in cui inserire mediatori linguistico-culturali.
Tali figure professionali devono essere formate ad hoc al
fine di poter interagire positivamente con gli operatori sanitari e le strutture sanitarie locali. Inoltre occorre curare la
formazione degli operatori socio-sanitari locali nel ricono-
37
AeM 64 nov. 08
scimento delle condizioni delle persone vittime di tortura,
che possono richiedere lo status di rifugiati, utilizzando una
adeguata metodologia di raccolta dei dati anamnestici.
Lo scopo fondamentale dell’INMP per i prossimi anni sarà
inquadrare in un’esperienza interdisciplinare, che non risponda solo ai bisogni, ma sia capace di anticiparli in questi tre obiettivi: ricerca clinica, formazione, ricerca.
1. Ricerca clinica e promozione della salute - L’attività di
ricerca clinica dell’INMP è strettamente connessa e integrata con l’attività di assistenza svolta dai Centri Regionali
di Riferimento.
- Interventi di promozione, diagnosi precoce, cura e follow up dei pazienti migranti, richiedenti asilo, vittime della
tratta, senza fissa dimora e nomadi per le patologie dermatologiche tropicali, le principali malattie sessualmente
trasmissibili, le patologie polmonari, gastroenterologiche,
dismetaboliche, urologiche, odontoiatriche, oculistiche e
oncologiche con visite preventive nelle diverse specialità.
- Varo di uno specifico programma di prevenzione del
cervico-carcinoma, vista l’accertata correlazione fra alcuni
ceppi del virus HPV e il cancro della cervice uterina.
- Esecuzione previo consenso informato della sierologia
per HIV e MST e delle analisi ematologiche per le anemie
carenziali.
- Inserimento temporaneo nel SSR degli stranieri non in
regola mediante l’attribuzione di un codice STP e percorso
guidato per gli stranieri ascrivibili al SSR. Ma anche sostegno psicologico, antropologico e di educazione sanitaria
con rispetto delle diverse culture nei confronti di migranti,
richiedenti asilo, ecc.
2. Formazione - Nel concreto, l’INMP si avvarrà del contributo di esperti nel settore della medicina delle migrazioni
e del contrasto alle patologie della povertà, al fine di costruire con gli operatori socio-sanitari locali un percorso
di educazione, prevenzione, diagnosi e cura, adattato a un
contesto multiculturale.
Punto centrale del modello di intervento sanitario proposto dall’INMP è definire un percorso per la ricostruzione
della storia sanitaria di queste persone, delle loro condizioni di criticità, dei possibili interventi a breve e medio periodo, avvalendosi anche del contributo di staff multiculturali, con l’inserimento di figure specifiche, quali i mediatori
linguistico-culturali.
- Corso internazionale di medicina transculturale, consistente in 6 seminari di un giorno e con cadenza mensile.
Medici, ricercatori, antropologi, sociologi, rappresentanti
di amministrazioni pubbliche, scuola, volontariato, enti
locali, associazioni italiane e straniere, si confrontano su
percorsi di ricerca e di formazione nell’ambito della promozione della salute e dell’integrazione sociale.
- Attivazione di uno staff multidisciplinare e interculturale per la realizzazione dell’attività di accoglienza, orientamento, educazione sanitaria e il sostegno durante l’iter
diagnostico-terapeutico. Nella sede nazionale dell’Istituto
sono previsti 25 mediatori linguistico-culturali impegnati
a rotazione nel corso dell’anno; si procederà alla progettazione del percorso formativo dello staff di mediazione
anche presso le sedi regionali di Sicilia e Puglia.
38
3. Ricerca - Terzo settore di eccellenza dell’Istituto è quello della ricerca. In quest’ambito, spicca la collaborazione
avviata con l’OMS – in particolare con l’Ufficio europeo
per gli Investimenti per la Salute e lo Sviluppo, con sede a
Venezia – focalizzata sul tema “salute e povertà”.
Sono, inoltre, già attivi progetti come la promozione di una
linea di ricerca multicentrica con l’International centre for
migration and Health/OMS di Ginevra sul diabete delle
popolazioni migranti in Europa, una piattaforma congiunta con il Centro nazionale AIDS (Istituto superiore di sanità), specificamente dedicata ad attività di prevenzione,
assistenza, sperimentazione a elevata tecnologia nella lotta
contro le principali malattie della povertà (AIDS, tubercolosi e malaria) secondo un approccio multidisciplinare che
coniuga scienze biomediche e scienze sociali in un contesto
multietnico e multiculturale.
Inoltre, con Italian Dermatological Centre, fondato e gestito dall’Istituto internazionale di Scienze mediche antropologiche e Sociali, (IISMAS), è stata realizzata una convenzione per il supporto scientifico e formativo nel settore
della dermatologia delle popolazioni mobili e delle malattie infettive e diffusive.
Le attività in questo campo dovrebbero prevedere: sperimentazione e validazione di una serie di strumenti sistematici di riconoscimento, monitoraggio e valutazione dei bisogni di salute delle comunità di migranti e di popolazioni
a rischio di povertà. Sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali per la tutela e l’assistenza delle comunità e
delle fasce fragili della popolazione italiana, con l’obiettivo
di favorire la tempestività nel ricorso ai servizi e la compatibilità con l’identità culturale di tali comunità.
Tra i progetti di ricerca attivati dall’INMP sono inoltre
presenti l’osservazione epidemiologica per rilevare la tipologia e la frequenza della patologia riscontrabile (sia quella
più comune, che quella di rara osservazione), i principali
fattori condizionanti le manifestazioni patologiche e lo sviluppo di un’attività di cooperazione scientifica nazionale
e internazionale, di consulenza clinica, sperimentale e di
cooperazione formativa, che si attivi tramite una rete di riferimento con centri specializzati.
Infine è in corso la realizzazione di pubblicazioni scientifiche che raccolgano i risultati dell’attività di ricerca e li
mettano a disposizione della comunità scientifica.
T
he INMP (National Institute for Health Migration
and Poverty) works in a multi-cultural context.
Since 1985, through the help of linguistic-cultural
mediators, the INMP has supported and offered
medical open-source care for people in financial need
and immigrants. Through its regional “office” the
INMP has three main goals for the future: 1) clinical
(scientific) research and the promotion of health; 2)
training (professional); 3) scientific research.
Chi cura la salute dei cittadini stranieri?
di Giovanna Dallari, Tommaso Paganelli, Pirchia Schildkraut
Se voi avete il diritto di dividere il mondo in
italiani e stranieri allora io reclamo il diritto
di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato,
privilegiati e oppressori dall’altro.
Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri
(Don Lorenzo Milani)
L
a rappresentazione dello stato di salute della popolazione straniera presente in un Paese deve prendere
le mosse dall’analisi e dalla valutazione delle oggettive condizioni socio-ambientali che la caratterizzano e descrivere poi il rapporto fra essa e il sistema socio-sanitario.
In letteratura numerose ricerche evidenziano come le disparità di salute rappresentino una costante della nostra
società. Indagare il peso dello svantaggio sociale sulla salute degli immigrati è utile per comprendere gli effetti del disagio sullo stato di salute di tutte le popolazioni che vivono
in una condizione di precarietà socio-economica.
Studiare la condizione di queste persone, diverse da noi
ma anche fra loro, e i fattori che la determinano, significa
porsi nell’ottica di possibili cambiamenti da introdurre nel
sistema, per renderlo più accogliente e capace di rispondere
adeguatamente alle nuove sfide poste da ciascun fruitore.
La presenza dei nuovi venuti va considerata infatti come
un’opportunità per riflettere sui contenuti, i metodi e le
modalità organizzative abitualmente utilizzati per rispondere ai bisogni di tutti i “clienti” vecchi e nuovi; porta
inoltre a ripensare le strategie di igiene e prevenzione pubblica, i programmi di educazione alla salute, le strategie
vaccinali, i controlli sanitari alle frontiere e nei luoghi di
aggregazione sociale. Troppo presto, forse, i Paesi occidentali hanno distolto l’attenzione dalle malattie della povertà,
considerandole debellate, e ora, con altrettanta facilità, si
tende a imputare ai migranti la colpa della loro recrudescenza, generando allarmismo, il diffondersi della “paura
dell’untore” atteggiamenti neo-razzisti.
Si parla di “Sindrome di Salgari” per indicare quell’erronea
propensione dei clinici a diagnosticare, di fronte a un paziente straniero, patologie inusuali, tropicali, esotiche e mai
viste prima. A questa fa da contraltare la “Sindrome da General Hospital”, che si riferisce invece alle fantasie che talvolta i pazienti stranieri hanno riguardo alle presunte qualità
miracolistiche dell’ipertecnologica medicina occidentale.
La medicina transculturale, invece, si pone l’obiettivo di
realizzare interventi efficaci in un contesto che tenga con-
to, nella relazione operatore sanitario-paziente, dei diversi
substrati culturali presenti.
I lavoratori immigrati sono generalmente occupati nei
cosiddetti lavori “delle 5 P”: pesanti, pericolosi, precari,
poco pagati, penalizzati socialmente; svolgono attività per
le quali non possiedono un bagaglio professionale, assai
diverse dai mestieri praticati in precedenza, quasi sempre
non coerenti con i titoli di studio acquisiti; sviluppano la
loro esperienza direttamente sul campo: tutto ciò spesso
avviene a scapito della salute.
Un ulteriore fattore di rischio è costituito dal lavoro stagionale: le aziende agricole del Sud e del Nord-Est tendono
ormai ad utilizzare esclusivamente stranieri, perlopiù in
condizione di irregolarità giuridica, i quali, al Sud in particolare, vengono sottopagati, costretti a vivere nei campi
dove lavorano, in condizioni disumane.
Corrono maggiori rischi per la salute le “assistenti famigliari” e non vanno dimenticate le vittime di tratta, persone
“quasi invisibili” a tutti i servizi, oggetto di un racket transnazionale di esseri umani, il cui stato di salute si deteriora
velocemente e coinvolge la cittadinanza tutta.
I servizi socio-sanitari pubblici devono dunque confrontarsi con un quadro estremamente complesso, sia sul piano
giuridico-amministrativo (diritto/accesso ai servizi), sia su
quello sanitario e sociale (diagnosi e cura/accessibilità) e
adottare un nuovo approccio, onde evitare di creare disparità a genesi istituzionale, che si vanno a sommare alle
tradizionali disuguaglianze di salute.
Le norme sull’assistenza sanitaria per gli stranieri
Il D. L. 25 luglio 1998, n. 286 (artt. 34, 35, 36), il relativo
Regolamento d’attuazione, DPR del 31 agosto 1999, n. 394
(artt. 42, 43 e 44) e la Circolare n. 5 del 24 marzo 2000,
pur assicurando tutela e accesso di immigrati regolari e
non ai servizi esistenti, peccano di frammentarietà e disorganicità, fondandosi su una filosofia improntata ad una
visione globalmente negativa del fenomeno, identificando
l’immigrato come mera forza lavoro. I decreti flusso degli
ultimi anni, lungi dall’essere strumenti funzionali ad un
auspicabile processo di costituzione di una società armonicamente ibrida, hanno causato un aumento di irregolarità
e di nuovi ingressi di lavoratori “in nero”, mentre la mancanza del permesso di soggiorno, l’attesa del rinnovo o di
ricongiungimento famigliare, spesso rilasciati già scaduti,
determinano una sorta di “precarietà giuridica” che ha ri-
DOSSIER
Attualità e prospettive per l’inclusione
dei cittadini stranieri nei servizi socio-sanitari
39
AeM 64 nov. 08
Castel
Sant’Angelo,
Roma 2007.
Foto di Sarah
Klingeberg
40
percussioni profonde su vari ambiti della vita delle persone
straniere, inclusi l’accesso al lavoro e alla salute. Le date
di rilascio, infatti, possono interferire con il rinnovo del
contratto di lavoro o dell’iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale, con conseguente perdita del proprio medico di
Medicina generale, producendo effetti diretti sulla salute
della persona, in termini di ansia e insicurezza, ma anche
ostacolando l’accesso ai servizi, la continuità assistenziale
e quindi l’effettiva autotutela della salute. Fermo restando
che a tutti gli stranieri presenti sul nostro territorio sono
garantiti i ricoveri urgenti, si distinguono gli stranieri regolarmente presenti dagli stranieri privi di titolo di soggiorno (Straniero temporaneamente presente - STP). Le
criticità nell’accesso ai servizi dei neocomunitari (rumeni,
bulgari) sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle degli utenti extracomunitari; anzi, il recente cambiamento
del loro status giuridico ha paradossalmente determinato
alcune difficoltà interpretative che li hanno penalizzati,
come nel caso della Bulgaria e della Romania. La cittadinanza italiana è fondata sul principio dello jus sanguinis e
può essere concessa ai nati in Italia dopo il compimento
del diciottesimo anno, nel caso ricorrano i requisiti. Ciò
ha riflessi diretti sulla salute dei minori, che usufruiscono
del Servizio sanitario solo in quanto “figli di lavoratori,
pensionati o disoccupati” e, a 18 anni, possono restare in
Italia solo se lavorano o studiano. I minori stranieri non
accompagnati hanno diritto di ricevere protezione, assistenza e prestazioni sanitarie, di essere iscritti a scuola, di
non essere espulsi, di ottenere un permesso di soggiorno.
Infine anche il complicato iter per il riconoscimento dei
titoli di studio, che limita fortemente la mobilità sociale, e
l’impossibilità di partecipare attivamente alla vita politica
locale attraverso il voto alle elezioni amministrative, costituiscono altrettanti fattori di disagio, che favoriscono una
perdita di salute.
La salute dei migranti: alcun dati
Le persone che giungono nel nostro paese sono, in misura
importante, già selezionate dalla famiglia e dalla comunità nel paese di origine per le loro caratteristiche positive.
Si tratta perlopiù di persone giovani, determinate, dotate
di capacità organizzative e di adattamento, preparate ad
affrontare anche situazioni di forte disagio, in possesso
dunque di un rilevante patrimonio di salute sia sul piano
strettamente fisico, che su quello psichico; questo fenomeno prende il nome di “effetto migrante sano”.
Non va tuttavia sottovalutata l’importanza del “bagaglio
di malattia” che gli immigrati portano con sé; ogni intervento sanitario infatti, sia esso di carattere individuale
che collettivo, non può prescindere dalla conoscenza, e
conseguente valutazione, di una storia clinica e culturale,
che costituisce un altro importante determinante di salute.
Le patologie endemiche; le condizioni socio-sanitarie e lo
stato vaccinale dei paesi di provenienza; le concezioni, sia
collettive che individuali, relative alla salute e alla sua salvaguardia; l’offerta, spesso assai diversa, di servizi sanitari
e il conseguente rapporto che le persone sono use ad avere
con essi, connotato da sentimenti di subalternità piuttosto
che da fiduciosa richiesta di un servizio dovuto, gli esiti di eventuali interventi rituali invalidanti, vissuti come
identitari, considerati invece in Occidente in maniera assai
critica e negativa costituiscono un importante ambito da
indagare e valutare prima di mettere in campo azioni sulla
salute collettiva o individuale.1 Altro dato recentemente
condiviso è l’arrivo di persone affette da lebbra in fase florida (si tratta perlopiù di emigrati italiani che rientrano
da paesi del Sud America), che non viene diagnosticata,
perché ormai scomparsa e quindi non più studiata dai medici nel nostro paese, così come non viene considerato il
fatto che giungono persone dalla Nigeria dove è diffusa
la poliomielite, ma non altrettanto la vaccinazione, e per-
tanto questi potrebbero essere serbatoi di virus da strada,
potenzialmente infettanti.
Studi recenti dimostrano come, dopo un intervallo di benessere che va da 3 a 6 mesi, il patrimonio di salute venga
rapidamente dilapidato a causa delle inadeguate condizioni socio-lavorative.
Il viaggio e il primo insediamento avvengono, quasi sempre, in estrema scarsità di risorse e tutele e determinano a
volte l’insorgenza di quadri patologici più o meno gravi.
I più comuni sono le malattie respiratorie, quali bronchiti ricorrenti, asma e broncopolmoniti, dovute al dormire
spesso all’aperto; le malattie infettive e parassitarie, quali
scabbia e diarrea; le patologie dell’apparato osteo-articolare, dovute a lavori pesanti e mancanza di un letto per dormire e infine patologie più subdole e gravi come la TBC,
nei soggetti geneticamente predisposti.
Nell’ambito lavorativo, i motivi culturali, la spinta economica e la volontà di compiacere colleghi e datore di lavoro portano la gran parte degli stranieri a sottovalutare e
non applicare i dispositivi per la sicurezza. L’irregolarità
di presenza poi, costringe al lavoro nero e corrisponde a
una invisibilità per i servizi di formazione, di controllo e di
prevenzione e porta spesso anche a un mancato accesso ai
servizi sanitari in caso di infortuni.
Tutte le condizioni suesposte concorrono a determinare le
capacità di valutazione della propria condizione reale di
salute, la consapevolezza del diritto ad essa attestato dalle
normative, ma soprattutto le aspettative e la reale attitudine
a tutelare la propria salute come unico bene e patrimonio.
Solo da qualche anno si sono raccolti elementi utili a descrivere il profilo di salute della popolazione immigrata in
Italia; i primi dati, molto simili a livello nazionale e delle
diverse realtà indagate, hanno evidenziato una forte tendenza a sviluppare affezioni conseguenti a regimi e stili di
vita poco salutari.
Analizzando i dati riguardanti gli accessi degli immigrati
ai servizi sanitari, emerge una forte richiesta di cure per
affezioni acute, ma una scarsa adesione agli interventi di
base, alla prevenzione e alle cure a lungo termine. Si rileva
ovunque un ricorso ai servizi di emergenza-urgenza per patologie non gravi – comportamento comune anche a molti
italiani – anche perché sono servizi più conosciuti rispetto
ai servizi territoriali; questi ultimi comprendono sia la medicina di base, sia i servizi consultoriali che, soprattutto
in città, sono in molti casi difficilmente accessibili per la
scarsa compatibilità in termini di orario di apertura.
Da studi recenti effettuati in Emilia-Romagna, emerge
come siano le donne immigrate ad aderire meno ai vari
programmi di prevenzione proposti dalle AUSL – mammografie o PAP-test per la prevenzione dei tumori della
sfera femminile – ai quali aderisce il 50-60% delle donne
Italiane e solo il 30-35% delle donne immigrate, percentuale questa sicuramente ancor più bassa, se si considerano
le donne presenti ma non residenti e perciò non conosciute
dai servizi; risulta specificamente esclusa da questo tipo di
interventi una popolazione particolarmente a rischio per
l’età: la grande coorte delle assistenti famigliari, sia regolari
che irregolari.
Gli studi sulla applicazione dei diritti di tutela della maternità evidenziano come siano le donne precarie immigrate,
impiegate in lavori stagionali e pesanti, ad essere meno tutelate, fino a dovere scegliere fra la dimissione volontaria dal
lavoro e la interruzione volontaria della gravidanza. Stanno
fra l’altro emergendo anche questioni relativamente inedite, quali il ricorso ripetuto all’IVG (interruzione volontaria
di gravidanza)2 e la violenza intra-familiare – da intendersi
sia in termini di abuso vero e proprio, che di impedimento
alla realizzazione di sé al di fuori della famiglia.
Nell’anno 2004 a Bologna, tra le prime venti cause di dimissione dai reparti ospedalieri il 35,3% faceva riferimento all’evento nascita e alla salute riproduttiva della donna.
Al primo posto si trovavano le interruzioni di gravidanza
(15%), episodi legati al parto fisiologico (10%) e al parto con taglio cesareo (3%); seguivano, al quarto posto, le
patologie legate alla salute mentale. Ad Arezzo il 54% delle straniere si ricovera in ostetricia e ginecologia, contro
il 15% delle italiane. Al secondo posto nella domanda si
posiziona la chirurgia generale con il 13% di ricoveri per le
straniere e il 18% per le italiane. Confrontando i primi 20
DRG,3 riferiti ai ricoveri di minori, le malattie da raffreddamento (polmonite semplice e pleurite, bronchite e asma)
si trovano al secondo e terzo posto nei ricoveri di minori
provenienti da Paesi in via di sviluppo, che sono invece
solo al nono e decimo posto per gli italiani; i neonati a termine con affezioni maggiori e quelli con affezioni significative si trovano tra i primi sei DRG se stranieri, mentre sono
al tredicesimo e sedicesimo posto se autoctoni; le malattie
dell’apparato digerente, caratteristiche della popolazione
immigrata, occupano il primo posto tra i ricoveri dei minori stranieri e il secondo tra quelli degli italiani.
È ben dimostrata la tendenza a sviluppare obesità e ipertensione delle minoranze etniche e degli immigrati,4 con
un conseguente alto tributo di malattie cardiovascolari, in
contrasto con la bassa prevalenza al paese di origine. Queste patologie sono talmente estese, che si possono spiegare
per tutte le provenienze con il cambiamento nel regime
alimentare che avviene con la migrazione e con l’adozione
di stili di vita poco salutari all’arrivo, oltre che ai diversi
fattori di discriminazione socio-culturali.5
In uno studio di recente pubblicazione (Dallari, Gualdi
et al. 2008), condotto fra i membri di varie comunità di
immigrati presenti nei comuni di Bologna e Palermo, si è
valutato il rapporto fra obesità e esposizione al rischio di
affezioni cardiovascolari, riscontrando che le percentuali
di sovrappeso/obesità sono simili a quelle della popolazione italiana6 per i maschi, ma più alte nelle donne straniere
(43,2% vs 45,8% maschi; 59,1% vs 33,6% femmine); le
varie nazionalità presentano prevalenze e profili diversi e,
in ogni caso, tutti i gruppi hanno una prevalenza – e quindi
un rischio – più alta che nel paese nativo. Kossovari e Rom
presentano la maggiore prevalenza e il maggior rischio e
anche la popolazione senegalese mostra un brusco aumento dell’incidenza di obesità nelle donne, che si spiega anche
per la valenza positiva attribuita al sovrappeso, simbolo di
prosperità economica.
Per quanto riguarda poi le malattie croniche, che necessitano di un’assistenza e di un follow-up continuo e accurato,
come ad esempio asma e diabete, è stata dimostrata una
maggiore gravità dei quadri sintomatologici, nonché una
ridotta percezione e un minor controllo della malattia da
parte del paziente immigrato. I programmi di gestione della malattia o di riabilitazione, che tentano di accentuare la
sicurezza e il senso di responsabilità personale nei pazienti
che si occupano della propria malattia, potrebbero risultare importanti nella riduzione del rischio di morte.
Nel caso dell’asma è documentato un aumento del rischio
41
AeM 64 nov. 08
42
di mortalità nei soggetti adulti, che sono affetti dalle forme asmatiche più onerose. I pazienti afroamericani vanno
incontro ad esiti peggiori; non è accertato se per via di un
minor accesso all’assistenza o per ragioni genetiche (risposta insufficiente ai farmaci).
Molti ceppi sono più a rischio dei caucasici di sviluppare
diabete e pertanto grande attenzione va posta nel monitorare la possibile insorgenza di alterazioni glicemiche. La
malattia diabetica è di difficile controllo per motivi culturali, religiosi e, persino, organizzativi; benché le cure siano
gratuite indipendentemente dalla regolarità di presenza in
Italia, è difficile ottenere la compliance dei pazienti al calendario dei controlli e al rigore per la dieta, spesso incongrua
anche per motivi religiosi.7 Inoltre molte attività lavorative
subalterne impediscono un accurato controllo della glicemia e l’assunzione di una razione alimentare congruente
con i valori glicemici accertati al momento del pasto, nel
caso del diabete insulino-dipendente.
Con l’obiettivo di fare rete per far scomparire la circoncisione8 clandestina e le mutilazioni genitali femminili in
Italia, è stato siglato nel 2008 un protocollo d’intesa tra
il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e la Federazione italiana medici pediatri (FIMP) che
definisce i punti chiave di un network per la protezione
dei bambini da questo rischio emergente, che sarà anche
uno strumento per conoscere un fenomeno ad oggi poco
tracciabile.
Numerose leggi e direttive obbligano i datori di lavoro
a fornire informazioni, formazione e mezzi adeguati agli
standard di sicurezza sui luoghi di lavoro, ma la realtà delle
morti bianche dimostra come sia ancora un processo formale, soprattutto per i lavoratori “in nero”, che devono anche sottrarsi ai controlli, seppur talvolta più convenzionali
che formativi, che le aziende sanitarie mettono in essere e
all’azione educativa del Responsabile della sicurezza.
Il 9,8 % degli infortuni denunciati all’INAIL riguarda lavoratori stranieri, benché siano il 3,4% della forza-lavoro:
un rischio triplo rispetto agli italiani. Ogni giorno si verificano tre morti sul lavoro: 1200 l’anno; ogni due giorni avviene un caso di infortunio mortale fra i cittadini stranieri.
I decessi nel 2007 sono stati 174, con una crescita del 4%
rispetto al 2006. Tra i più colpiti romeni (41), marocchini
(23 morti), e albanesi (18). Questi dati non considerano
una quota di sommerso non valutabile relativa ai lavoratori “in nero” e agli irregolari, agli incidenti sul lavoro che
vengono passati sotto silenzio o, se gravi, denunciati come
infortuni domestici al Pronto Soccorso, per evitare problemi al datore di lavoro.
La migrazione non aumenta di per sé il rischio di sviluppare
disturbi mentali, sono piuttosto le circostanze e le condizioni di vita che creano un contesto favorente l’insorgenza di
tali disturbi; sono stati descritti invece diversi fattori esogeni di “fragilizzazione” della salute mentale nei migranti. Se
la maggioranza di essi supera le difficoltà incontrate grazie
alla forte motivazione del “progetto migratorio”, una parte
non trascurabile va incontro a disturbi psichici.
La letteratura scientifica internazionale riporta che i migranti, sia nelle prime che nelle seconde generazioni,
presentano un rischio di disturbi mentali da 3 a 5 volte
più elevato rispetto ai nativi.9 Sta inoltre emergendo una
nuova area di dipendenze patologiche da considerare con
attenzione, soprattutto tra le assistenti familiari e le seconde generazioni.
Servizi generali e dedicati
Nel nostro Paese vige un sistema di salute pubblico e
universalistico, deputato ad assicurare le cure necessarie
a tutti i cittadini residenti e presenti sul suolo nazionale;
per gli immigrati l’accesso ai servizi, anche dove essi sono
disponibili, è reso complesso, se non impossibile, da pastoie burocratiche e muri invalicabili di incomprensione
linguistica e culturale.
Il volontariato da sempre rappresenta la cartina di tornasole dei fenomeni emergenti e si pone come primo intercettatore e interlocutore delle esigenze delle popolazioni deboli.
Numerose esperienze italiane riguardano l’apertura di ambulatori per stranieri irregolarmente presenti: alcuni gestiti
da organizzazioni di volontariato – eventualmente convenzionati con le ASL – altri direttamente dalle aziende USL,
strutture completamente indipendenti e autofinanziate.
La prima risposta del sistema politico e dei servizi sanitari
pubblici è stata la creazione di “Servizi dedicati”, realizzati principalmente in ambito materno-infantile, i quali
ben presto si sono dotati di strumenti di supporto, quali
interpretariato, mediazione linguistica e culturale, hanno
prodotto molti strumenti informativi cartacei e strutturato
programmi di formazione per diversi target.
Sono stati creati ad esempio il Numero Verde 80663366,
che risponde in sei lingue su problemi socio sanitari da
diverse postazioni all’interno dell’Azienda USL di Bologna; si sono raccolti e pubblicati sul sito della medesima
USL esperienze, strumenti informativi, progetti e fonti di
finanziamento, addirittura moduli e altro materiale utile
al miglioramento dei servizi. Si sono inoltre sperimentate
modalità di formazione e comunicazione interculturale utili per cambiare l’approccio dei professionisti nei confronti
dei nuovi cittadini e il reengeneering dei servizi.
Da anni il settore manageriale dei servizi sanitari sta cercando di mettere a punto strumenti organizzativi idonei a
rispondere in maniera univoca e esaustiva ai bisogni di una
popolazione così eterogenea, riconducendo questa popolazione all’interno del sistema dei servizi generali.
Nel caso specifico dell’AUSL di Bologna si è rivelata vincente la creazione di una Unità operativa semplice, cui è stato affidato il compito di promuovere, favorire, supportare,
coordinare e verificare tutto il processo di cambiamento.
Questa scelta ha determinato l’opportunità di lavorare in
rete aziendale interprofessionale prima e interistituzionale
poi. Si sono così realizzati diversi progetti di ricerca/intervento sulla salute piuttosto estesi, che hanno fatto sedere al
tavolo della progettazione diversi interlocutori (professionisti e dirigenti di Comune, ULS, Volontariato, Università,
Provincia, ecc.) con condivisione di obiettivi, programmi e
risorse, a partire dalle fasi iniziali.
È proprio il lavoro in rete la strategia principale che consente di avere una visione olistica del fenomeno e delle
persone, mettere in atto attività veramente rispondenti ai
bisogni, dare una risposta basata sulla condivisione delle informazioni, delle risorse e dei know-how. I professionisti di
ciascuna istituzione mantengono il compito di lavorare su
parti o ambiti peculiari, ma, al contempo, hanno l’opportunità di avere una visione su tutti gli aspetti e le sfaccettature
del fenomeno, di individuare e colmare lacune nelle aree
di competenza, come pure le sovrapposizioni, di ottenere
infine finanziamenti e riconoscimenti dalla comunità scientifica e dai ministeri preposti. In questo modo si possono
raggiungere risultati riguardanti il percorso nel suo insie-
Castel
Sant’Angelo,
Roma 2007.
Foto di Sarah
Klingeberg
43
AeM 64 nov. 08
me: dallo studio e analisi dei determinanti, alla promozione
della salute, alla diagnosi, alla cura e riabilitazione.
44
Comprensione reciproca e comunicazione con i pazienti
Nella relazione medico-paziente la comprensione da parte
dei pazienti stranieri è sovente ostacolata da motivi linguistici, culturali, di concezione della salute e di priorità, ma
anche dalle scarse competenze dei professionisti, sia dal
punto di vista linguistico, che nell’approccio relazionale.
Gli strumenti per facilitare questi momenti e l’accesso ai
servizi socio-sanitari generali si sono spesso rivelati scarsamente efficaci. Si tratta perlopiù di materiale informativo cartaceo non tarato sul target – che invece legge attentamente la pubblicità sui mezzi pubblici e sui giornali
gratuiti – e di interventi di semplice interpretariato, spesso
denominati “di mediazione interculturale”.
Per comunicare, comprendere e incoraggiare l’attiva partecipazione del paziente nel processo decisionale sul trattamento da impostare, è importante assumere un atteggiamento non giudicante e esplorare con alcune domande le
opinioni del paziente, solo allora il medico può fornire informazioni esaustive sulla malattia in questione e le opzioni
terapeutiche disponibili, aiutando il paziente a confrontare
i suoi valori e le sue preferenze con le opzioni disponibili.
Comportamento questo peraltro assolutamente utile anche
nei confronti dei pazienti nativi.10
Nell’ambito delle politiche locali di integrazione sociale
dei migranti i mediatori interculturali esercitano la funzione di “ponte” tra diverse culture contribuendo a garantire pari opportunità e la non discriminazione.11 Si tratta,
secondo la definizione formulata dal Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro (CNEL), di un «agente attivo
nel processo di integrazione» che si pone «fra gli stranieri
e le istituzioni, i servizi pubblici e le strutture private, senza sostituirsi né agli uni né alle altre, per favorire invece il
raccordo fra soggetti di culture diverse».12
Il mediatore interculturale è un operatore sociale che facilita la comunicazione tra individuo, famiglia e comunità,
favorendo la rimozione delle barriere culturali e linguistiche, la valorizzazione della cultura di appartenenza, la
cultura dell’accoglienza, l’integrazione socio-economica, la
fruizione dei diritti e l’osservanza dei doveri.
Il mediatore opera presso istituzioni e organismi pubblici e privati, collaborando con gli operatori dei medesimi,
affiancandoli nello svolgimento delle loro attività per individuare i bisogni dell’utente, negoziare le prestazioni,
collaborare alla formazione di professionisti e utenti e partecipare alla programmazione, progettazione, realizzazione
e valutazione degli interventi.
La varietà dei contesti in cui opera e dei compiti richiedono
spiccate doti personali ed elevate competenze professionali
(con eventuali specializzazioni attinenti allo specifico ambito di lavoro): sono essenziali un’adeguata conoscenza della
lingua italiana, della lingua madre e dei codici culturali del
gruppo di riferimento, come pure il possesso di capacità
comunicative, di relazione e di gestione dei conflitti.
Le disposizioni sanitarie fanno riferimento al ruolo dei mediatori sia ai fini dell’educazione e prevenzione sanitaria,
sia nell’ambito della loro formazione.15 Ad oggi non è ancora possibile accedere ad un servizio di mediazione “certificato” per la mancanza del riconoscimento della figura
professionale del mediatore/della mediatrice interculturale
a livello nazionale.
Conclusioni
Le disuguaglianze sociali nella salute sono dimostrate, e
sono altamente costose per gli individui e per la società tutta; l’immigrazione spinge la società a ripensare se stessa, il
proprio sistema di servizi e il proprio network di relazioni
con vantaggi per la cittadinanza tutta; i servizi socio-sanitari e del volontariato, che si trovano in prima linea, sono gli
antesignani di questo processo.
La salute non migliora con l’apertura di servizi dedicati, ma
piuttosto attraverso un approccio empatico, di accoglienza
verso ciascun paziente, e la formazione dei professionisti; i
quali affianchino ad una competenza professionale rinnovata una visione di insieme, acquisita operando all’interno
di una rete interprofessionale e interistituzionale. Attori
della rete devono essere tutti gli stakeholder: gli enti pubblici locali, le associazioni di volontariato e, soprattutto, i
rappresentanti e i portavoce delle popolazioni target.
La partecipazione dei cittadini alla progettazione sanitaria deve essere allargata agli stranieri, per creare le condizioni affinché le comunità abbiano in sé la conoscenza,
le risorse e il potenziale organizzativo e di leadership per
realizzare un cambiamento. La logica di costruzione del
Piano per la Salute deve essere ricondotta al processo di
sviluppo della “comunità competente”, secondo il quale,
dietro alle dimensioni di “contesto e cultura”, è sottesa una
visione del territorio come comunità di condivisione della
salute nell’accezione di “bene comune relazionale” e cioè
un fenomeno emergente da un’azione collettiva intesa non
come somma di individui, ma delle loro interazioni.
L’impegno che si prospetta ora al sistema sanitario, che si
richiama ai valori propalati dall’Organizzazione mondiale
della sanità come sistema di “Ospedale e Servizi Sanitari
promotori di salute”, è quello di interrompere questa spirale per invertire le tendenze attuali.
Giovanna Vittoria Dallari, già medico responsabile del
Progetto salute migranti e indigenti dell’Azienda USL di
Bologna e coordinatrice del gruppo Ospedale interculturale dell’Emilia-Romagna, membro della SIMM (Società
italiana di medicina delle migrazioni), di UCODEP e di
ELFO HEALTH-LAB. È docente al Master di I livello
transculturale-multietnico, nel campo della salute del sociale e del welfare presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
della Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Tommaso Paganelli, sociologo, è laureato in scienze politiche e ha conseguito un Master universitario di II livello
relativo al diritto d’immigrazione e alla comunicazione interculturale
Pirchia Schildkraut, medico-chirurgo, esperta di medicina
delle migrazioni opera presso l’Ambulatorio Biavati di Bologna per l’assistenza medica a stranieri irregolari
BIBLIOGRAFIA
M. Affronti, D. Carrillo, G.V. Dallari (a cura di), Modelli
sperimentali per combattere le disuguaglianze nell’accesso ai
servizi sanitari, Medical Books, Palermo 2005
F. Balsamo, Famiglie di migranti. Trasformazioni dei ruoli e
mediazione culturale, Carocci, Roma 2003
F. Bracci, G. Cardamone (a cura di), Presenze, Migranti e
accesso ai servizi socio-sanitari, FrancoAngeli, Milano 2005
G. Ceccatelli Gurrieri, Mediare culture. Nuove professioni
tra comunicazione e intervento, Carocci, Roma 2003
C. Conti, G. Sgritta (a cura di), Immigrazione e politiche
socio-sanitarie. La salute degli altri, in «Salute e Società»,
n. 2, 2004, pp. 13-19
F. Carchedi, G. Mottura, E. Pugliese (a cura di), Il lavoro
servile e le nuove schiavitù Franco Angeli, Milano 2003
G.V. Dallari, L. Luatti, et al., (a cura di), L’immigrazione
straniera in provincia di Arezzo, Rapporto 2003 e 2005,
Ucodep, Arezzo 2008
G.V. Dallari, D. Previti, S. Ricci, Interprete o mediatore culturale? Le aspettative di un servizio sanitario italiano, in M.
Russo, G. Mack (a cura di), Interpretazione di trattativa.
La Mediazione linguistico-culturale nel contesto formativo e
professionale, Hoepli, Milano 2005
G.V. Dallari, D. Previti, S. Ricci, La comunicazione come
strumento per l’equità di accesso: la comunicazione interculturale, in AA.VV., La comunicazione nella strategia di Governo del Distretto, Atti del convegno Venezia 1-2 ottobre
2004, Quaderni CARD 4, Iniziative Sanitarie, Roma 2005
G.V. Dallari, S. Ricci, D. Previti, E. Di Felice, Immigrati in
provincia di Bologna: i numeri e le tendenze (2005). Parte
terza: la sanità. Dossier Generale, n. 6, Osservatorio delle
Immigrazioni della Provincia di Bologna
W.P. Frisbie, C. Youngtae, R.A. Hummer, Immigration and
the health of Asian and Pacific Islander adults in Unite States, in «American Journal of Epidemiology», n. 153, 2001,
pp. 372-380
S. Gallus, P. Colombo, V. Scarpino, P. Zuccaro, E. Negri,
G. Apolone, C. La Vecchia, Overweight and obesity in Italian adults 2004, and an overview of trend, in «Eur J Clin
Nutr.», n. 60, 2006, pp. 1174-9.
S. Geraci, M. Mazzetti, L’incontro con il paziente immigrato in V. De Micco (a cura di), Le Culture della Salute.
Immigrazione e sanità: un approccio transculturale, Liguori,
Napoli 2002
A. Gusmeroli, L. Ortensi, N. Pasini, L’integrazione sanitaria
degli immigrati tra accesso e utilizzo dei servizi e l’emergere di
nuove problematiche, in G.C. Blangiardo (a cura di), INAIL,
Col vento dell’est. Lavoratrici e infortuni, in Dati INAIL
sull’andamento degli infortuni sul lavoro, n. 4, aprile 2005
R. Jace, La necessità di servizi più adeguati ai bisogni degli
stranieri, in AA.VV., Salute interculturale, salute per tutti,
Atti del convegno organizzato dall’associazione Aprile di
Bologna, Aprile Quaderno n. 2, ottobre 2005
M. Lisoni, M.T. Sensale, E.D. Ruffino, Stranieri e salute, dal
conflitto alla gestione di un problema quotidiano, in «ASIAgenzia Sanitaria Italiana», n. 7, 17.02.2002, pp. 25-28
J. Mato, L’importanza della mediazione sociosanitaria all’interno del progetto Sperimentazione interregionale per combattere le diseguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari, materiale del convegno “Fatti e saperi sulla salute dei migranti
a Palermo e a Bologna”, 4-5 marzo 2005, Bologna 2005
P. Mladovsky, Migration and health in EU health system, in
«Euro Observer», winter, vol. 9, n. 4, 2007
A. Morrone, Problematiche sanitarie in una società multiculturale, in V. De Micco, (a cura di), Le Culture della Salute, Liguori, Napoli 2002
N. Pasini, M. Picozzi (a cura di), Salute e immigrazione. Un
modello teorico pratico per le aziende sanitarie, FrancoAngeli, Milano 2005
F. Pittau, A. Spagnolo (a cura di), Immigrati e rischio infortunistica in Italia, IIMS, Roma 2003
T. Seppilli, Le nuove immigrazioni e i problemi di strategia
dei servizi sanitari europei: un quadro introduttivo, in «Salute e Società», n. 2, 2004, pp. 35-48
A.K. Kurian, K.M. Cardarelli, Racial and ethnic differences
in cardiovascular disease risk factors: a systematic review, in
«Ethnicity and disease», n. 17, 2007, pp. 143-52
A. Spinelli, M.Grandolfo, et al., L’interruzione volontaria
di gravidanza tra le donne straniere in Italia, Istituto Superiore di Sanità, Rapporti ISTISAN 06/17 ISSN 1123-3117
A.J. Thomas, L.E. Elberly, G.D. Smith, J.D. Neaton, J.
Stamler, Race/ethnicity, income, major risk factors, and
cardiovascular disease mortality, in «American Journal of
Public Health», n. 95, 2005, pp. 1417-23
www.mastertransculturale.unimore.it - Università di Modena e Reggio-Emilia, Facoltà di Medicina e Chirurgia –
Master di I livello transculturale – multietnico, nel campo
della salute del sociale e del welfare
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-easilo/2008/settembre/manuale-normativa-2.html. Manuale sui principali elementi della normativa su immigrazione,
asilo e cittadinanza con elementi e riferimenti linkati - versione aggiornata al 31 agosto 2008
NOTE
1 - Una recente analisi effettuata dal Centro di malattie sessualmente
trasmesse, presso il Policlinico Umberto I di Roma, evidenzia che,
in seguito ad una regressione pressoché totale della sifilide in Italia,
si è fortemente ridotta la reperibilità della penicillina a dosaggio per
adulti; il forte aumento dei casi di sifilide fra le persone provenienti
dall’Europa dell’Est, ove tale affezione è ancora endemica, pone seri
problemi organizzativi per il suo trattamento.
2 - Nel 2004 su 4.682 IVG effettuate presso i presidi sanitari di Bologna, il 71,7% erano a carico di italiane, il 28,3% di straniere (di
cui il 27,4% da donne provenienti da PVS). Per quanto riguarda le
provenienze da PVS: Europa dell’Est: Romania (21,8%), Marocco
(12,6%), Moldavia (8,6%), Cina (6,8%), Albania (4,9%), Ucraina
(4,7%). I dati trovano riscontro con quelli relativi ai recenti flussi migratori che fanno registrare un incremento delle presenze di donne
provenienti dall’Est Europa che diventano ancora più evidenti se si
confrontano con il 2002 a ridosso della regolarizzazione.
3 - Diagnosis Relate Groups: si tratta di un sistema di classificazione dei ricoveri che fa riferimento al costo di produzione, che viene
definito a livello nazionale e consente di effettuare conteggi a livello
interaziendale e interregionale.
4 - Kurian and Cardarelli, 2007.
5 - Frisbie et al. 2001; è inoltre dimostrata la tendenza a consumare
cibi poco salutari (es. Coca Cola, merendine, ecc.) che divengono
una sorta di status simbol particolarmente economico e vengono falsamente percepiti come indicatori di integrazione.
6 - Gallus et al. 2006.
7 - Il corano non prescrive l’osservanza delle regole del Ramadan per
le donne gravide, ma molte di loro ritengono importante la stretta
osservanza o temono il giudizio negativo dei famigliari e si espongono al coma ipoglicemico per il prolungato digiuno.
8 - L’accordo prevede un monitoraggio attraverso una adeguata informazione nei punti nascita, negli ambulatori dei pediatri e in ogni
altra struttura interessata e si accompagna a campagne di comunicazione e counselling alle famiglie che sono orientate all’intervento.
I pediatri di famiglia e i pediatri dei pronto soccorso esporranno
un poster che fornisca alle persone interessate informazioni circa le
corrette procedure chirurgiche e le indicazioni delle strutture del
servizio sanitario a cui rivolgersi.
9 - Le indagini condotte in Italia dalla Caritas e da Medici senza Frontiere mostrano come anche queste problematiche di salute siano lega-
45
AeM 64 nov. 08
te alla fragilità sociale, allo scadente status socio-economico e al basso
livello di integrazione nella società di accoglienza. In aumento sono i
casi di disagio mentale connesso alle difficoltà e agli insuccessi della
migrazione, alla solitudine, alla nostalgia di casa; nel breve e medio
periodo si rivelano anche casi di persone con “traumi da sbarco”.
10 - Numerosi studi indicano infatti con chiarezza che i medici dovrebbero aumentare le loro capacità di riconoscimento dei propri
stereotipi inconsci anche nei riguardi dei pazienti autoctoni. Alcune
strategie possono essere utilizzate per ridurre l’impatto di questi “errori di giudizio”: è compito fondamentale degli operatori riconoscere e fare proprie le modalità di comunicazione dei loro assistiti per
evitare che essi si sentano “interrogati” o offesi, fino a contrapporre
un atteggiamento di chiusura nei confronti del medico.
11 - “Mediatore culturale”, “mediatore linguistico-culturale”, “mediatore di madrelingua”, “tecnico esperto in mediazione”…: la varietà delle definizioni, la frammentazione e disomogeneità delle diverse
proposte di profilo formulate da Enti territoriali e Enti locali per
la stessa figura professionale. La dizione “mediatore interculturale”
risponde maggiormente al profilo personale e professionale affermatosi in questi ultimi anni, che sottolinea la via italiana all’integrazione
che - ai diversi livelli educativo, lavorativo, giuridico-amministrativo
e a quello socio-sanitario si è progressivamente definita nella prospettiva interculturale, ovvero nella promozione del dialogo e del
confronto tra le diverse culture, secondo le indicazioni formulate
dall’UNESCO sin dal 1980 (UNESCO, Introduction aux études interculturelles, Paris 1980).
12 - CNEL, Organismo Nazionale di Coordinamento per le politiche di integrazione sociale degli stranieri, Gruppo di lavoro “Politi-
che per la mediazione culturale. Formazione e impiego dei mediatori
culturali”, 03.04.2000, www.portalecnel.it.
13 - il Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario, Conferenza unificata Ministero della sanità - Regioni - Aziende
Sanitarie locali, al punto 7.2, contiene indicazioni alle Regioni in merito alla formazione dei mediatori e al loro utilizzo al fine di superare
le difficoltà nei rapporti con i detenuti provenienti da paesi stranieri.
Centro Frantz Fanon
Centro di consulenza
sulla relazione Associazione Shinui
ESPERIENZE
a cura di Silvia Festi
46
T
he majority of people who reach our country
pursue a precise migratory project. It is a healthy
and somewhat selecte population who immigrate,
but the quality of their health rapidly declines.
Health problems frequently derive from a complex
interaction of factors (legal barriers, social and cultural
inequality...). Clinical problems are more frequently
the outcome of social difficulties; they are not due to
lack of health-care services but to cultural and social
barriers, denying access to existing facilities. In order
to study the health status of immigrants we must
start by studying the medical reality of the countries
they come from and their individual migratory route,
avoiding the temptation to consider immigrants as
“plague carriers” and bearers of “new diseases”.
Il Centro Frantz Fanon con sedi a Torino, accoglie utenti
immigrati, rifugiati, vittime di tortura, nomadi e richiedenti asilo che, in ragione di motivi di disagio psicologico, esprimono una domanda di ascolto, di counselling o
di psicoterapia. Un lavoro intensivo è stato condotto nel
corso degli anni con donne vittime della tratta, bambini
immigrati e adolescenti stranieri non accompagnati e con
richiedenti asilo e rifugiati vittime di violenza o tortura.
In molti casi, in alternativa ad una presa in carico diretta
dell’utente e/o della famiglia, si è privilegiato un intervento
di collaborazione e di supervisione con le équipe curanti.
Al Centro possono rivolgersi migranti indipendentemente
dalla residenza o dal permesso di soggiorno.
Le attività cliniche si ispirano a un approccio etnopsichiatrico che ha tratto molti dei suoi presupposti dall’esperienza del Centre Devereux Parigi e, grazie a incontri con altri
centri e gruppi di lavoro (Centre Minkowska di Parigi e
Ospedale di Bobigny, Naga-Har di Milano), ha elaborato
modelli di lavoro e di ricerca autonomi.
Il Centro di consulenza sulla relazione – Associazione Shinui con sede a Bergamo offre interventi di psicoterapia
e counseling, mediazione familiare, terapie interculturali
a individui (adulti e adolescenti), coppie (coppie miste
e non), famiglie (migranti e non, adottive e affidatarie).
Particolare attenzione è dedicata alle variabili culturali
del disagio psichico, agli aspetti psicologici dei processi
migratori, alle relazioni transgenerazionali, alla mediazione, all’integrazione. Il centro svolge inoltre attività di
ricerca, progetti psicosociali sul territorio, supervisione e
consulenze a professionisti ed équipe di lavoro, seminari e
convegni con esperti di fama nazionale e internazionale.
Inoltre realizza attività di formazione (Scuola di counseling sistemico pluralista di Bergamo, perfezionamento in
counseling interculturale, corso di mediazione familiare,
percorsi formativi e seminari anche in altre sedi su temi
quali: relazione, comunicazione, conflitti, famiglia, affido,
adozioni, intercultura, narrazioni, autobiografia).
Il Centro intende offrire un modello pluralista considerando e intrecciando i diversi approcci delle scuole sistemiche: milanese (Boscolo, Cecchin), strutturale (Minuchin),
narrativo (postmoderno) e comunicativo-umanista (Satir).
Centro Frantz Fanon presso ASL 2 di Torino via Vassalli
Eandi 18 - 10138 Torino e via Monginevro 130 - 10141
Torino (tel. 01170954214 – www.associazionefanon.org)
Centro di consulenza sulla relazione – Associazione Shinui via Divisione Tridentina, 5 – 24121 Bergamo (tel.
035241039 – www.shinui.it)
di Tatiana Di Federico e Marco Minarelli
DOSSIER
La salute delle donne migranti:
un viaggio tra diversi mondi e modi
culturali di cura del corpo
P
arlare della salute dei migranti pone la questione
fondamentale della salute delle migranti, in quanto da sempre e in ogni società le donne hanno la
funzione naturale di dare alla luce i nuovi membri e la funzione sociale di curare i corpi, attraverso pratiche e saperi
tramandati di generazione in generazione.
La natura sociale della cura del corpo, intesa in senso olistico come benessere interno e esterno, e dei saperi che ad
essa sottendono pongono in primo luogo la necessità di
analizzare da un punto di vista antropologico i concetti di
cultura, corpo e cura del corpo.
Cultura - Edward B. Taylor definì la cultura un insieme
complesso che include le conoscenze, le credenze, l’arte,
la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e
abitudine acquisita dall’uomo in quanto membro della società. Tale definizione è rimasta per anni un punto di riferimento, ma oggi ormai è messa in crisi dalla globalizzazione che impone un nuovo concetto di cultura, intesa come
relazione e stratificazione di significati. La cultura diventa
un percorso in continua trasformazione e ciò provoca un
indebolimento dell’autorevolezza e dell’importanza degli
antropologi nell’affrontare tale concetto (Parodi da Passano 2006).
Corpo - Il corpo è ciò che permette all’uomo di essere un
soggetto costruito sulle relazioni e sui simboli. Ciascuna
cultura ha costruito un sapere specifico del corpo. Malgrado la base biologica uguale possiamo ipotizzare tanti corpi
quante sono le culture: esiste una pluralità di corpi proprio
perché esiste una pluralità di culture che se ne occupano,
ognuna a modo proprio (Destro 2001).
Le Breton (1999) afferma che l’esistenza dell’uomo è corporale e il trattamento sociale e culturale di cui esso è fatto
oggetto, le sue immagini e i suoi valori ci parlano sia della
persona che delle variazioni che la sua definizione e i suoi
modi d’esistenza conoscono passando da una struttura sociale all’altra.
Cura del corpo come sistema culturale - Tra le conoscenze
tipiche di ciascuna cultura vi sono anche quelle riguardanti
la cura del corpo, intesa qui in un senso olistico, ovvero
non solo dal punto di vista medico, ma di un equilibrio
tra benessere esterno e interno. Un ramo dell’antropolo-
gia, definito antropologia medica, si avvale degli apporti
dell’antropologia sociale, culturale, biologica e linguistica
per comprendere meglio i fattori che influenzano la salute
e il benessere, l’esperienza e la diffusione della malattia, la
prevenzione e il trattamento della malattia, i processi di
guarigione, le relazioni sociali di gestione della terapia e
l’importanza culturale e l’uso di sistemi medici pluralistici.
L’antropologia medica considera i sistemi medici dei sistemi culturali, in cui la conoscenza e le politiche scientifiche
sono socialmente costruite.
Nella società multietnica, in cui ogni giorno ciascuno di noi
si confronta e agisce, la prassi medica deve tener conto, più
di ogni altro periodo storico, di tali visioni antropologiche di
cultura, corpo e cura del corpo, in quanto si relaziona con
comportamenti culturali diversi da quelli locali e che condizionano i vissuti di una parte in costante crescita della popolazione italiana. Attualmente nel nostro paese sono presenti
circa 3.400.000 migranti; calcolando gli irregolari è presumibile che si raggiungano (e forse si superino) i 4 milioni.
La distribuzione geografica di questa popolazione coincide
abbastanza fedelmente con la geografia dello sviluppo economico: 55% al nord; 30% al centro e solo il 15% al sud.
Di questi nuovi cittadini circa la metà è rappresentata da
Kohl o kajal,
prodotto
per il trucco
degli occhi,
tipico dei
paesi africani
e asiatici.
Foto di
Tatiana Di
Federico
47
AeM 64 nov. 08
donne in prevalenza in giovane età e tradizionalmente portate a una prolificità che costituisce un elemento nuovo e
rilevante per il nostro paese.
Questo ha fatto sì che da alcuni anni sia diventato positivo
il saldo tra nascite e morti e ciò, unito a un altrettanto positivo saldo migratorio, ha permesso la ripresa dell’incremento della popolazione che ora sfiora i 60 milioni.
La società italiana è multietnica (sono infatti più di 150 i
paesi da cui giungono i nuovi connazionali) e multiculturale (di seconda e ormai terza generazione), con le seguenti
caratteristiche che ne derivano:
“etereogenicità” dei paesi e delle culture di provenienza;
“dinamicità”: se negli ultimi dieci anni i migranti sono nel
complesso raddoppiati i minori sono aumentati di ben dieci volte;
“strutturalità”: quella migrante è una popolazione che si
sta stabilizzando. Prevalgono infatti i coniugati sui non coniugati (e ciò è indice di “progetti di vita”) e, proporzionalmente, i matrimoni misti: una delle conseguenze è il già
ricordato saldo positivo delle nascite.
Di particolare significato in questo scenario, e elemento
imprescindibile nel determinarlo, è stato il progressivo aumento della quota attribuibile alle donne che, come ricordato, sono ormai numericamente alla pari con gli uomini
e tra un po’ probabilmente li supereranno. Il ricongiungimento famigliare non è l’unica ragione di tale fenomeno,
perché particolari aspetti di impiego lavorativo giocano un
ruolo fondamentale: ad esempio la progressiva prevalenza
degli anziani nella nostra società si è tradotta in un continuo aumento delle necessità assistenziali e in un sempre
più imponente ricorso alle badanti, 5 su 6 delle quali sono
attualmente straniere.
Gli aspetti più significativi della cura
del corpo femminile migrante
A una tale complessità culturale il sistema sanitario è tenuto ad adeguarsi dando risposte articolate, che tengano
conto delle diverse provenienze dei e delle pazienti, e non
generiche; in particolare meritano attenzione gli aspetti di
frequente pregiudizio che si ritrovano nel vissuto e nelle condizioni delle donne e dei loro bambini quali quelli
riferibili alla procreazione, al controllo della fertilità e al
disagio mentale.
48
La gestazione, il parto, la nascita
Numericamente le bimbe e i bimbi nati da genitori di provenienza straniera superano il 10% del totale dei nati. Si
tratta quindi di un numero tutt’altro che esiguo e tuttavia
ancora oggi l’evento “nascita” in questi casi è caratterizzato da un’elevata esposizione a malattie e conseguenze legate alla gravidanza e al parto e dovute a una serie di fattori
spesso interdipendenti:
- marginalità sociale della famiglia e disagio della donna
che risente della mancanza del fattore di protezione costituito dalla rete parentale del Paese d’origine;
- frequente giovane età e/o multiparità della madre;
- compromissioni cliniche quali anemia (per incongrua
alimentazione) o infezione dell’apparato genito-urinario
(spesso per mutilazioni materne);
- ridotto accesso ai servizi durante la gravidanza (una recente indagine nella Regione Lazio ha evidenziato l’alta
percentuale di straniere incinte in cui la prima visita avveniva dopo la 12a settimana di gravidanza).
Ne risultano percentuali elevate di nati pre-termine e con
basso peso neo-natale, prevalenza aumentata di nati con
asfissia neo-natale, elevati tassi di mortalità alla nascita e di
mortalità neo-natale precoce, nonché maggiori complicanze nel post-partum a carico della puerpera.
Anche se negli ultimi tempi tali conseguenze sembrano avviarsi, almeno in alcune regioni, a un progressivo ridimensionamento, i dati generali rimangono tuttora preoccupanti e richiedono ulteriori e più appropriati provvedimenti.
Interruzione volontaria della gravidanza
In controtendenza rispetto a quanto si osserva in generale
nella popolazione femminile del nostro paese (in pratica
un calo del 40% dal 1982 al 2004) il ricorso alla IVG (interruzione volontaria di gravidanza) è in crescita tra le migranti raggiungendo ormai un 33-35% del totale; di pari
passo la pluri-abortività (ossia gli aborti ripetuti) si situa
per le donne migranti al 35% contro il 22% della popolazione in generale.
Dalle non poche indagini svolte al riguardo è emerso che
tra le prime cause comportanti il ricorso alla IVG vi sono
problemi economici e l’aver già raggiunto il numero ottimale di figli. Pertanto risulta molto chiaramente come
l’aborto sia considerato l’ultima ratio come conseguenza
del fallimento dei metodi adottati per evitare gravidanze
indesiderate e quindi dipenda della scarsa conoscenza dei
mezzi per programmare la pianificazione famigliare.
A questo riguardo occorre tenere presente le seguenti realtà:
- nel determinare le scelte, o non scelte, di controllo della fertilità sono fondamentali le abitudini riproduttive del
paese d’origine (mentre accade che praticamente in tutte
le nazionalità la pillola predomini quale mezzo contraccettivo – seguono profilattico e spirale – nelle donne dell’est
prevale ancora il coito interrotto);
- la conoscenza dei metodi contraccettivi è, in generale,
scarsa e superficiale e ciò ne comporta un uso poco frequente e spesso errato;
- è gravemente carente la conoscenza della legge che disciplina in materia di controllo delle nascite (e sui diritti di cui
la coppia gode al riguardo) e delle strutture in cui questa si
esplica attraverso il lavoro degli operatori (circa 1/3 delle
donne non conosce la regolamentazione sulla IVG).
Questi rilievi, ampiamente documentati e verificabili, rischiano di essere di ben poca utilità se ad essi non faranno
seguito opportuni provvedimenti, non particolarmente impegnativi ma in cui tutti credano:
- diffondendo la consapevolezza nelle coppie provenienti
da altri paesi della possibilità di programmare la pianificazione famigliare facendo conoscere leggi e strutture (consultori famigliari in primo luogo);
- utilizzando gli “spazi giovani” per una continua attività di
informazione e educazione ad una sessualità responsabile;
- proponendo consulenza con specialisti a chi si rivolge al
consultorio con richieste specifiche, ma anche a chi si presenti con richieste generiche;
- offrendo colloqui con équipe specificatamente qualificate in occasione della richiesta di certificazione, e in particolare sui metodi anticoncezionali usati in caso di aborto
ripetuto.
Il disagio psicologico
Benché considerati diffusi, disagio e depressione sono dif-
ficilmente valutabili nella realtà perché di difficile espressione sottendendo sia sofferenze personali, sia critiche più
o meno aperte alla società di accoglienza.
Eradicazione, perdita della rete amicale e parentale, senso
di solitudine e di inadeguatezza, difficoltà di comunicazione attraverso il linguaggio che aggrava la difficoltà ad
intendersi non solo semanticamente con l’altro, povertà e
marginalità sociale sono condizioni riconosciute quali cause del disagio mentale, più o meno comuni a tutti coloro
che intraprendono un progetto migratorio. Le più pesantemente colpite sono soprattutto le donne che hanno conosciuto terribili esperienze di violenza e costrizione, ma
anche chi, come le rifugiate politiche, non trova, a differenza di quanto accade in occasione dei ricongiungimenti famigliari, una già avviata forma di convivenza con la società
di accoglienza e deve intraprendere un viaggio nel viaggio,
spesso senza compagni e riferimenti certi, ma con davanti
a sé un precario progetto di vita.
Non sfugge al problema nemmeno chi gode di un lavoro
se questo è per sua natura mentalmente usurante: in particolare disagio e depressione sembrano avere una incidenza
ragguardevole tra le badanti, categoria tra le più benemerite per le famiglie italiane alla quale non si presta probabilmente la dovuta attenzione.
Nel complesso il capitolo che riguarda la salute psichica
della persona immigrata, di fondamentale importanza non
solo per il singolo ma per la società intera e campo di applicazione dell’Etnopsichiatria, appare in una fase di impostazione metodologica ancora in cerca di una definizione
più completa.
Sperimentare l’ascolto per conoscere altri
sistemi culturali di cura dei corpi
Una buona pratica per iniziare la conoscenza di altri sistemi culturali è indubbiamente l’ascolto e la costruzione di
relazioni, ovvero il porsi in una condizione di scambio con
“l’altra”, ascoltandola e lasciandosi attraversare dall’alterità, sospendendo il giudizio e il pre-giuduzio. Solo in tal
modo è possibile avviare uno scambio e un confronto conoscitivo sui saperi e sulle usanze che caratterizzano altre
culture e modi di agire.
Un esperimento in tale prospettiva è stato compiuto in un
comune della Provincia di Bologna, Crevalcore, appartenente al distretto socio-sanitario definito “Pianura Ovest”
e composto da altri cinque comuni (Anzola dell’Emilia,
Calderara di Reno, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese). L’iniziativa ha fatto parte
del progetto denominato “Intercultura ad Ovest”, realizzato dalla Cooperativa Lai-momo e consistente in una
serie di azioni integrate volte a facilitare la costruzione di
relazioni positive tra popolazione autoctona e popolazione migrante presente nei territori del Distretto “Pianura
Ovest” e a migliorare l’accesso ai servizi e alle risorse presenti da parte dei cittadini migranti.
Tra le azioni svolte, alcune sono state declinate unicamente
al femminile, con l’obiettivo di coinvolgere donne migranti e native in attività di gruppo che da un lato hanno favorito l’espressione e la valorizzazione della propria identità
e della cultura di appartenenza in una logica dialettica e
di confronto reciproco, e dall’altro hanno gettato le basi o
rafforzato le metodologie di un agire insieme verso obiettivi comuni.
A Crevalcore un gruppo di circa 30 donne migranti, coor-
dinato da un’operatrice italiana e da una mediatrice marocchina, è stato attivato un laboratorio di auto-narrazione
sulla cura del corpo, svoltosi in 7 incontri della durata di
due ore ciascuno. Il laboratorio è stato uno spazio di incontro e ascolto vissuto da donne di diverse provenienze:
Marocco, Tunisia, Pakistan, Moldavia e Sudan. Al suo interno le partecipanti hanno avuto l’opportunità, attraverso
la narrazione, di riappropriarsi della propria storia personale, diventandone protagoniste, e contemporaneamente
di condividerla e intrecciarla con le altre. I temi trattati
riguardavano la cura del corpo in senso molto generale,
dai rimedi popolari per curare influenze e disturbi lievi
dell’apparato respiratorio, ai metodi di cura e di bellezza
collettivi in occasione di eventi importanti come la nascita
e il matrimonio.
Il primo elemento emerso dai racconti delle donne marocchine, tunisine, sudanesi e moldave è l’importanza
centrale della rete di relazioni amicali e parentali intessuta
attorno ai corpi sociali, una rete capace di aver cura e contemporaneamente di insegnare e tramandare le pratiche
di cura. La presenza di una comunità allargata che non
solo agisce sui corpi, per il loro benessere e la loro preparazione in momenti speciali, ma si tramanda come eredità
genealogica nelle relazioni tra donne, è la differenza più
evidente rispetto alla dimensione individuale della nostra
società e alla spersonalizzazione dell’esperienza di cura
in strutture come gli ospedali o centri per i trattamenti
estetici. Si pensi ad esempio a ciò che rappresenta l’hammam (bagno turco) nei paesi musulmani, ovvero il luogo
tradizionale dell’intimità, della purificazione del corpo e
delle confidenze femminili, il luogo di condivisione della cura di sé (Trevisani 2006). L’hammam è qualcosa di
molto diverso dai luoghi di bellezza europei e occidentali,
è prima di tutto un luogo dove si celebra la sacralità del
corpo e uno spazio delle possibilità di condivisione, che
permette alla donna di vivere con altre passaggi emotivamente impegnativi e le offre aiuto e sostegno insostituibili
(Trevisani 2006).
Il secondo elemento è il legame molto stretto e il profondo
rispetto per il mondo naturale, del quale le donne hanno
dimostrato nei loro racconti una conoscenza approfondita
delle sue proprietà e delle possibilità di usare erbe, fiori
e alimenti come rimedi ai più diversi problemi. L’hennè,
il latte di mucca, i fiori, l’olio di hargan, il miele, lo zucchero sono gli ingredienti delle “ricette” per la cura del
corpo narrate dalle donne durante il laboratorio. Come
afferma Ivana Trevisani (2006) soprattutto per le donne
islamiche il primo luogo in cui si trovano gli ingredienti
base per i loro prodotti è la cucina. I prodotti per trattare
il corpo, in vita e nella morte, e per trattare gli spazi che
i corpi abitano sono preparati naturali e tradizionali, ma
sapientemente combinati e mescolati con una conoscenza
empirica che ha caratteristiche di scientificità.
Iniziare dalla narrazione e dall’ascolto è una buona pratica
per costruire ponti tra mondi culturali diversi, ponendosi
nei confronti dell’altra con curiosità e voglia di capire i
suoi sistemi di pensiero e di organizzazione della realtà
che la circonda.
Conclusioni
La società in cui viviamo evolve assumendo sempre più
le caratteristiche di una società multietnica, assecondando
dinamiche, da sempre esistite, che fanno sì che le popola-
49
AeM 64 nov. 08
zioni si spostino dal luogo originario in un “altrove” in cui
trovare condizioni di vita migliori; obbedendo, in definitiva, ai versi di un celebre nostro conterraneo, Giovanni
Pascoli, che, più o meno un secolo fa, cantava da buon
romagnolo inurbatosi a Bologna «or la mia patria è là dove
si vive».
La presenza di migranti rappresenta, al momento, più del
6% della popolazione totale in Italia e è destinata a salire; forse è una presenza ormai irrinunciabile per la nostra
economia, anche se oggetto di pulsioni, spesso alimentate
ad arte, irrazionalmente ostili.
La componente femminile è ormai numerosissima; soprattutto su di essa occorre fare affidamento per sviluppare
una convivenza civile, rispettosa delle diversità e unita
nelle affinità, considerando le prime opportunità per un
reciproco arricchimento, e le seconde conferma di una dignità comune; soprattutto attraverso di essa si può cogliere il già ricordato carattere strutturale dell’immigrazione
nel nostro paese.
Purtroppo l’attuale legislazione non prende nella debita
considerazione questo aspetto perché considera la precarietà dell’immigrato “istituzionale”; l’acquisizione della
cittadinanza rimane infatti un percorso ostico e accidentato, che crea una precarietà “voluta” che interessa la ricerca
di un alloggio stabile, la tutela sul lavoro, l’accesso ai servizi e si accompagna a povertà e emarginazione sociale.
A patire maggiormente questa condizione sono prevalentemente le donne, e sulle donne che vengono da altri paesi
deve esercitarsi, per l’ambito di competenza prevalentemente, ma non solo in quello, l’attività degli operatori sanitari e degli amministratori delle risorse.
Si è già accennato a qualche intervento raccomandabile
par favorire una serena pianificazione famigliare; più in
generale si possono individuare i seguenti snodi problematici e ricorrenti che possono definirsi prioritari e sui
quali sarebbe bene concentrare i propri sforzi:
- accoglienza e facilitazione dell’accesso ai servizi: occorre
formare tutti gli operatori, non solo quelli di specifiche
strutture, ma tutti coloro che possono venire in contatto,
come interfaccia di servizi pubblici, con le persone migranti su come dare informazioni esaurienti su diritti e
doveri previsti dalla attuale legislazione e sulla strada più
semplice per ottenere l’assistenza necessaria, anche decrittando se occorre le richieste formulate;
- mediazione linguistica e culturale: costituisce una risorsa
fondamentale a cui, per ovvi motivi, è quasi impossibile
rinunciare ma nello stesso tempo è un atteggiamento di
apertura e di disponibilità all’incontro che dovrebbe appartenere a tutti perché tutti siamo chiamati a mediare tra
principi identitari e innovazioni, tra conosciuto e conoscibile, tra radicamenti e nuove appartenenze;
- capacità d’ascolto: è un certo modo di ascoltare che provoca il narrare di sé, delle proprie vicende e dei sentimenti
che quelle vicende hanno generato e se c’è dolore nel raccontarsi l’ascolto è già una prima riparazione, dare voce è
già rafforzamento della dignità dell’altro che trova in chi lo
ascolta un forse inaspettato compagno di strada.
Forse dovrebbero essere le donne migranti a parlare più
spesso e più a lungo di sé e della loro salute: quando accadrà apprenderemo quello che numeri e tabelle, pur utilissime, non sono in grado di dirci e verrà anche a noi voglia
di parlare.
50
Marco Minarelli è Medico pediatra e responsabile del Consultorio famigliare del Comune di San Giovanni in Persiceto – Distretto Pianura Ovest della Provincia di Bologna
Tatiana Di Federico è esperta di genere e lavora come progettista, coordinatrice e operatrice in progetti interculturali presso la Cooperativa Lai-momo
BIBLIOGRAFIA
A. Destro, Complessità dei mondi culturali, Patron Editore,
Bologna 2001
A. Destro, Donne e microcosmi culturali, Patron Editore,
Bologna 1997
A. Morrone, L’altra faccia di Gaia: salute, migrazione e ambiente tra Nord e Sud del pianeta, Armando Editore, Roma
1999
A. Morrone e P. Vulpiani, Corpi e simboli: immigrazione,
sessualità e mutilazioni genitali femminili in Europa, Armando Editore, Roma 2004
A. Morrone, F. Alichino, G. Di Cristofaro Longo, Cultura,
salute, immigrazione: una analisi interculturale, Armando
Editore, Roma 1995
G. Parodi da Passano, Cultura-esperienza e cultura-conoscenza, in S. Federici, A. Marchesini Reggiani, Interculture
map Piemonte e Liguria, Lai-momo, Sasso Marconi (BO)
2007
G. Devereux, Saggi di Etnopsichiatria generale, Armando
Editore, Roma 2007
I. Trevisani, Il velo e lo specchio. Pratiche di bellezza come
forme di resistenza agli integralismi, Baldini e Castoldi Dalai 2006
J-L. Amselle, Connessioni. Antropologia dell’universalità
delle culture, Bollati – Boringhieri editore, Torino 2001
L. Attenasio, La cura degli altri. Seminari di etnopsichiatria,
Armando Editore, Roma 2005
L. Attenasio, Fuori norma: la diversità come valore e sapere,
Armando Editore, Roma 2001
R. El Khayat, Il mio maestro Georges Devereux, Armando
Editore, Roma 2008
U. Fabietti, Storia dell’antropologia, Zanichelli, Bologna
2001
I
n these last few years Italian society has became
multi-ethnic and multicultural; therefore it is
beginning to pay particular attention to the health of
immigrants, particularly to women, because in several
cultures the care of body and of children are mainly
associate with women. In this framework it becomes
necessary to create adequate relationships between
different cultural systems on the basis of reciprocal
listening and understanding.
Tubercolosi e immigrazione
N
el 2006 sono stati stimati dall’OMS a livello mondiale 9.2 milioni di nuovi casi di tubercolosi (TB)
(139 per 100 000 abitanti), inclusi 4.1 milioni di
nuovi casi con espettorato positivo (44% del totale) e oltre 700.000 casi di TB in persone co-infettate con il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV) (8% del totale).
L’83% del totale delle notifiche proviene dall’Africa, SudEst Asiatico e regioni del Pacifico Occidentale. Nel 2006,
sono stati inoltre stimati quasi mezzo milione di casi di tubercolosi multiresistente (resistenza contemporanea a isoniazide e rifampicina -TB-MDR), di cui 23.353 notificati,
più di metà dei quali dalla Regione Europea.
La tubercolosi tra gli immigrati nell’Europa occidentale
Nell’Europa occidentale l’incidenza della TB è in riduzione, seppur lentamente, e la malattia è oggi legata ad alcuni
fattori di rischio specifici, tra i quali è ben documentato
il ruolo dei flussi migratori (fig. 1). L’esempio dell’Italia è
paradigmatico: dal 1999 al 2006, i casi di TB registrati in
“cittadini non italiani” nel nostro Paese sono infatti passati dal 22% del 1999 al 46,2% del 2006 (Ministero della
Salute 2008) (fig. 2, p. 52). Nell’ultimo quinquennio il valore medio dell’incidenza della TB in persone straniere si
attesta intorno a 70 nuovi casi per 100.000 persone-anno,
sostanzialmente superiore a quello medio nazionale (7.5
casi per 100,000). Malgrado l’aumento del numero dei casi
di TB tra gli immigrati (dovuto al parallelo incremento nel
numero totale degli immigrati in Italia), vi è una sostanziale
stabilità dell’incidenza in questa popolazione. Si osservano
fluttuazioni annuali presumibilmente legate all’imprecisione nella stima dei denominatori (fig. 3, p. 52); tali fluttuazioni, peraltro, si attenuano quando ai denominatori viene
aggiunta la quota stimata di immigrati irregolari.
È importante sottolineare che, nello stesso periodo, non vi
è alcun segnale di ripresa della tubercolosi nella popolazione generale: l’incidenza di tubercolosi in Italia è in progressiva lentissima diminuzione (da 9,1 casi per 100.000
abitanti nel 1995 a 7,5 casi per 100.000 abitanti nel 2006)
per effetto del progressivo trend in diminuzione (-33%) tra
i soggetti italiani (Ministero della salute 2008).
Gli immigrati in Italia provengono generalmente da Paesi
in cui l’incidenza tubercolare è molto superiore a quella
DOSSIER
di Alberto Matteelli, Issa El-Hamad, Mario C. Raviglione
Figura 1
Proporzione
di casi di TB
in persone
straniere
in Europa
(fonte: Eurosurveillance)
51
AeM 64 nov. 08
italiana (tab. 1, p. 53). Tra i Paesi di provenienza degli immigrati in Italia quelli con una incidenza più elevata di TB
sono le Filippine (287/100.000) e il Senegal (270/100.000).
Otto tra i paesi di provenienza degli immigrati hanno
un’incidenza di TB più elevata di 100 casi per 100.000
abitanti (valore oltre al quale un Paese o un gruppo di
popolazione viene convenzionalmente considerato ad alto
rischio di TB); inoltre, in questi stessi paesi è talvolta molto
aumentata la frequenza di casi di TB sostenuta da ceppi
multiresistenti pari per esempio al 19,4% e 16% rispettivamente in Moldavia e Ucraina.
Caratteristiche cliniche della tubercolosi negli immigrati
Figura 2
Numero di
casi di TB
in immigrati
e in italiani,
1999-2006
Figura 3
Incidenza
di TB nella
popolazione
immigrata,
1999-2005.
Fonte:
Ministero
della salute
52
I casi di tubercolosi in cittadini stranieri si concentrano
nelle classi di età giovani e adulte. Nella fascia di età 15-24
anni e 25-34 anni più del 70% dei casi di TB nel 2006 era
in persone immigrate da altri Paesi, mentre gli immigrati
rappresentano una quota quasi inesistente dei casi di TB
tra gli ultra-sessantacinquenni.
Mentre nella letteratura scientifica il rischio maggiore di
sviluppare la tubercolosi si verifica durante i primi due anni
dalla data di immigrazione (CDC 1998), in Italia nel periodo 1999-2004 solo il 12% e 32% circa dei casi di TB in soggetti stranieri si è manifestato entro il primo anno di arrivo
e tra il primo e il secondo anno di arrivo rispettivamente.
A livello clinico, non vi è evidenza che le caratteristiche della TB negli immigrati siano differenti da quelle in soggetti
autoctoni. La sola differenza documentata è una maggior
prevalenza di resistenze primarie all’isoniazide (Migliori
2002). L’impatto sul successo terapeutico della monoresistenza all’isoniazide è marginale. Ben diverse sarebbero le
conseguenze di un incremento del rischio di forme multi
resistenti: tale fenomeno, di cui vi è qualche evidenza in
Germania (Eker 2008), non è stato documentato in Italia.
Non vi è altresì alcuna evidenza di una associazione tra TB
e co-infezione con il virus HIV in soggetti immigrati. In effetti, la probabilità di co-infezione con HIV è quattro volte
maggiore in soggetti italiani con TB rispetto agli stranieri
(De Iaco 2005).
Controllo della tubercolosi in soggetti immigrati:
diagnosi e cura dei casi sintomatici.
Le strategie di controllo della tubercolosi non differiscono negli immigrati rispetto alla popolazione autoctona: la
diagnosi precoce e la terapia efficace dei malati ne rappresentano l’elemento centrale. Oltre a garantire il beneficio
individuale, il trattamento dei malati interrompe la circolazione del micobattere nella collettività dopo circa 3-4
settimane dall’inizio della terapia e previene il rischio di
selezione di ceppi resistenti ai farmaci antitubercolari. Le
linee guida italiane sulla lotta alla TB aderiscono a questo
principio, stabilendo, per quanto concerne gli immigrati,
«l’esigenza di garantire la diagnosi tempestiva, il trattamento efficace e la ricerca dei contatti dei casi, in quanto
questi interventi rappresentano, anche tra gli immigrati, le
misure più efficaci a contrastare la diffusione della tubercolosi» (Ministero della Salute 1998).
La strategia globale promossa dall’OMS, sia nella prima
versione, emessa nel 1994 (WHO 1994), che nella sua ampia revisione del 2006 (WHO 2006), garantisce un ruolo
centrale al trattamento a breve termine (regime di 6 mesi)
con terapia standardizzata direttamente supervisionata almeno nella fase iniziale. L’acronimo DOT (Directly observe treatment) identifica una serie di interventi attraverso i
quali i servizi sanitari o gli agenti comunitari supportano il
paziente durante il periodo di trattamento con l’obiettivo
comune del completamento della terapia stessa. L’assunzione supervisionata della terapia è uno di questi strumenti, con il ruolo di supervisore che può essere affidato
a membri del servizio sanitario, ovvero a personale non
sanitario, secondo ragioni di convenienza.
L’adozione di misure di trattamento supervisionato è di
importanza cruciale in paesi a risorse basse o intermedie.
Nei paesi a risorse avanzate, in cui la TB non rappresenta
un problema prioritario e i tassi di completamento della terapia sono comunque elevati, queste misure sono a
volte impiegate meno rigidamente. Ad esempio le linee
guida statunitensi del 2005 (CDC 2005) e le linee guida
britanniche del NICE del 2006 (NICE 2006) raccomandano l’adozione della DOT solo in particolari gruppi di
pazienti, soprattutto se presentano fattori di rischio di non
adesione al trattamento.
In Italia lo smantellamento dei servizi dedicati al controllo
della tubercolosi, innescato dalla riduzione dell’incidenza
della malattia, ha privato la salute pubblica degli strumenti per l’attuazione della terapia supervisionata nella maggior parte dei casi.
L’obiettivo dichiarato dei programmi di controllo della
TB è il trattamento con successo di almeno l’85% dei casi
di tubercolosi polmonare escreato positivi (WHO 1991)
identificati e l’identificazione di un minimo del 70% dei
casi stimati. Questi obbiettivi sono stati introdotti poiché
a questi livelli di identificazione e di guarigione il processo di riduzione dell’incidenza accelera. Il documento Stop
Paese
N° immigrati
residenti
in Italia
Incidenza stimata di casi di
TBC/100.000§
Prevalenza di
HIV (%) nei
casi di TBC§
Stima % di TB-MDR sul totale
dei casi di TBC (LC 95%)^
Nuovi casi
Ri-trattamenti
Albania
375.947
19
-
1,5 (0,3-10)
10
Romania
342.200
128
0.3
2,8 (1,8-4,2)
11
Marocco
343.228
93
0.4
0,5 (0,2-1,1)
12
Cina
144.885
99
0.3
5,0 (4,6-5,5)
26
Ucraina
120.070
106
5.8
16,0 (13,7-18,4)
44
Filippine
101.337
287
0.1
4,0 (2,9-5,5)
21
Tunisia
88.932
25
0.2
2,7 (0,4-15)
36
Polonia
72.457
25
0.4
0,3 (0,1-0,6)
8.2
India
69.504
168
1.2
2,8 (2,3-3,4)
17
Ecuador
68.880
128
1.1
4,9 (3,5-6,6)
24
Perù
66.506
162
2
5,3 (4,3-6,4)
24
Egitto
65.667
24
0.1
2,2 (1,2-3,7)
38
Serbia e
Montenegro
64.411
32
0.7
0,4 (0,1-0,9)
4.1
Senegal
59.857
270
2.7
2,1 (0,7-4,9)
17
Sri Lanka
56.745
60
0.2
0,2 (0-1)
0.0
Moldavia
55.803
141
0.4
19,4 (16,7-22,3)
51
Tabella 1
Incidenza di
tubercolosi
nei 16
Paesi con
la frequenza
più elevata
(in ordine
discendente)
di immigrati
in Italia
§ WHO TB global report 2008
^ WHO 4th Report antimicrobial resistance, 2008 (Annex 8)
alla TB in Italia, approvato dalla Commissione Salute nel
maggio 2007 (Ministero della Salute 2007), ha definito
come obiettivo dei programmi di controllo, per quanto concerne il trattamento, il trattamento con successo
dell’85% dei casi in persone con meno di 65 anni di età,
e, globalmente, non più dell’8% di persone in trattamento
perse al follow-up.
Vi sono dati, tuttavia aneddotici, che indicano che i tassi di
completamento della terapia antitubercolare siano inferiori negli immigrati rispetto agli italiani. Presso il più grande
centro antitubercolare di Milano nel periodo 1999-2003
avevano abbandonato il trattamento antitubercolare il
10% degli italiani, l’8.8% degli stranieri con regolare permesso di soggiorno, e il 22.4% degli stranieri irregolari
(Luigi Codecasa, comunicazione personale). Questi dati
suggeriscono che almeno per alcune frange della popolazione immigrata vi sia la necessità di adottare specifici
programmi per il supporto dell’aderenza al trattamento
antitubercolare.
Aspetti legali della cura degli immigrati
in Italia e in Europa
Tra i fattori che condizionano una maggiore suscettibilità
degli immigrati alla TB vi è la capacità di accoglienza della
società nel Paese ospite, condizionata e in parte anche condizionante lo status giuridico, e il grado di accessibilità e
fruibilità dei servizi socio-assistenziali.
L’elemento giuridico-normativo passa attraverso il riconoscimento del diritto all’assistenza socio-sanitaria. Lo spirito del legislatore è improntato a regole e modalità di equità
e universalità.
Dal punto di vista sanitario il diritto all’accesso trova giustificazioni tanto nei vantaggi che offre alle strategie di sanità
pubblica, quanto negli obblighi deontologici della professione sanitaria (FNOMCeO 2007). L’offerta di servizi socio-sanitari alle persone straniere, indipendentemente dalla
regolarità del permesso di residenza, promuove il benessere di tutti e può facilitare l’integrazione e la partecipazione
dei migranti all’interno dei Paesi ospitanti promuovendo
53
AeM 64 nov. 08
l’inclusione e la comprensione, contribuendo alla coesione,
aumentando lo sviluppo (Consiglio d’Europa 2007).
In quest’ottica l’Assemblea del Parlamento europeo, con
la risoluzione n. 1059 del 2006, ha esortato a «eliminare
qualunque obbligo riservato al personale sanitario (...) di
fare rapporto ai poteri pubblici della presenza di immigrati irregolari» (Assemblea del Parlamento europeo 2007) e
l’Italia ha ratificato la risoluzione fin dal 1995 con una specifica normativa di tutela (Decreto Legge n. b489 del 1995,
alcune ordinanze ministeriali, poi consolidatesi nel Decreto Legislativo n. 286 del 1998 e in altre norme collegate).
Accesso alla diagnosi e alla cura della TB
L’elemento della “permeabilità” dei servizi è determinante
per garantire percorsi di tutela sanitaria specifici nell’ambito di una più generale funzione di contrasto alle diseguaglianze da parte dei Servizi per la Salute Pubblica.
Gli interventi per ridurre le barriere di accesso e favorire
la fruibilità dei percorsi assistenziali, di prevenzione e di
cura, si articolano attorno a due strategie. Il primo elemento è costituito dall’informazione sui diritti (e doveri) e sui
percorsi assistenziali per le popolazioni immigrate. Tale
processo prevede il coinvolgimento, la responsabilizzazione e il protagonismo delle comunità di immigrati (intese
come organizzazioni, singoli leader, associazioni specifiche, mediatori organizzati ecc.), fino a che esse stesse non
ne diventino i principali promotori e attori. L’organizzazione istituzionale, in collaborazione con l’associazionismo
e il terzo settore, deve favorire e supportare tale processo
fornendo competenze, conoscenze, mezzi e strumenti, in
una logica di forte integrazione con le competenze comunitarie e tradizionali.
Il secondo elemento è rappresentato dalla sensibilizzazione dell’intero servizio sanitario al problema dell’accesso ai
servizi per gli immigrati. Tale processo prevede varie azioni
che vanno dalla formazione degli operatori, al lavoro multidisciplinare, al lavoro di rete intra-aziendale, interistituzionale e con l’associazionismo (autoctono e di immigrati),
al modellamento dei servizi in chiave transculturale (accesso equo e leggibile per tutti) e interculturale (attenzione
specifica per alcuni contesti linguistici e culturali).
Uno studio sull’entità e le cause del ritardo diagnostico in
casi di TB condotto in Emilia-Romagna fornisce importanti
spunti di riflessione (Gagliotti 2006). Innanzitutto il ritardo
diagnostico, sulla popolazione totale di malati di TB, risulta
di circa 3 mesi, inaccettabilmente elevato e potenziale causa
della persistente circolazione del micobattere nella popolazione. Il ritardo è risultato di entità simile in italiani e stranieri. Tuttavia, mentre negli italiani il ritardo è imputabile
quasi interamente al basso tasso di sospetto della malattia
nel personale sanitario, tra gli immigrati il fattore predominante è la tardiva consultazione dei servizi sanitari, a testimonianza dell’esistenza, nel mondo reale, del problema
della fruibilità dei servizi per le persone straniere.
54
Programmi di screening per la malattia tubercolare
Sotto il termine di screening si raggruppano le attività svolte a identificare i casi di malattia tubercolare in persone con
sintomi minimi o assenti, anticipando l’afferenza ai servizi
sanitari e quindi la diagnosi. Programmi di screening per
i soggetti italiani sono limitati ai soggetti a contatto di pazienti con TB contagiosa. Tuttavia, l’elevata incidenza di
TB tra gli immigrati rende questa popolazione potenziale
target per interventi di screening allargati.
Nel 2004 sono stati pubblicati i risultati di una indagine
condotta a livello europeo sui programmi di screening esistenti nei diversi paesi, che ha coinvolto 26 dei 51 paesi europei (Coker 2004). Emerge come nella maggior parte dei
casi lo screening venga effettuato al momento dell’ingresso
nel paese e prevalentemente su rifugiati e richiedenti asilo.
I pochi paesi che conducono programmi di screening anche di immigrati diversi dai rifugiati, in genere li svolgono
attraverso servizi di comunità e non al momento dell’ingresso nel paese. Per lo screening viene utilizzato prevalentemente l’esame radiografico del torace; in bambini e
adolescenti (anche se la soglia di età è molto variabile da
paese a paese) e nelle donne in gravidanza viene eseguito il
test cutaneo alla tubercolina secondo Mantoux.
Le linee guida italiane (Ministero della Salute 1998) propongono di «eseguire lo screening con esame radiologico
e test di Mantoux: a) nelle persone provenienti da paesi ad
alta endemia tubercolare (incidenza di tubercolosi stimata dall’OMS > 100 casi/100.000) recentemente immigrati
(meno di due anni), il più presto possibile dopo l’ingresso
in Italia (operativamente utile sfruttare l’occasione del rilascio del permesso di soggiorno); b) nelle persone provenienti da paesi ad alta endemia che, successivamente ai
primi due anni, permangono per condizioni di vita e socioeconomiche ad alto rischio per la tubercolosi.». Le linee
guida promuovono inoltre lo screening in tutte le occasioni di contatto con le strutture sanitarie, quali, ad esempio,
l’accesso alle strutture ambulatoriali, il ricovero ospedaliero, il rilascio di certificazioni sanitarie.
Poiché non è stato contestualmente creato alcun sistema
informativo per la registrazione delle attività di screening
realmente effettuate, non sono disponibili dati per stimare
l’entità delle attività di screening della malattia tubercolare
attuate in Italia negli ultimi anni su soggetti immigrati.
Sono stati identificati 14 studi pubblicati negli ultimi 10
anni in paesi europei, mirati a valutare la resa (yield: numero di casi di tubercolosi diagnosticati/numero di persone
sottoposte a screening) di programmi di screening mirati
a diagnosticare tempestivamente la malattia tubercolare o
l’infezione tubercolare latente. Gli studi condotti in paesi
che eseguono programmi di screening all’ingresso, sono
stati indirizzati prevalentemente ai rifugiati, ma sono stati
inclusi anche immigrati che non richiedono asilo politico.
La media dello yield per TB attiva nei 9 studi che riportano questa informazione è pari a 272,3 casi per 100.000
abitanti (range 100-555 casi per 100.000 abitanti). Se si
aggiungono anche gli esiti fibrotici di TB (3 studi) lo yield
è mediamente pari a 618 casi per 100.000 abitanti (range
218-1189 casi).
Diagnosi e trattamento dell’infezione tubercolare latente
Le basi patogenetiche che giustificano gli alti tassi di incidenza della tubercolosi negli immigrati sono sostanzialmente due: da una parte l’incremento della probabilità di
progressione da infezione a malattia tubercolare per fattori
legati al processo migratorio, dall’altra una maggiore circolazione di M.tuberculosis, nelle comunità di immigrati nel
paese ospite. L’importanza relativa dei due fattori non è
nota. Mentre la diagnosi precoce e terapia efficace dei casi
sintomatici è una strategia adeguata per limitare la diffusione di M.tuberculosis, la prevenzione della progressione
da infezione a malattia tubercolare richiede una strategia
per la diagnosi e trattamento dell’infezione tubercolare latente. A interventi di quest’ultimo genere si attribuisce di
norma importanza molto limitata, tuttavia in determinate
popolazioni ad elevato rischio – quali ad esempio i soggetti
con co-infezione da HIV – ne è universalmente riconosciuta la rilevanza.
Le linee guida italiane (Ministero della Salute 1998) stabiliscono che è «opportuno lo screening periodico annuale dei
cutinegativi e uno screening della malattia nei cutipositivi,
che non si sono sottoposti a chemioterapia preventiva o
non hanno completato il ciclo previsto». Tuttavia, non specificano direttamente che la diagnosi di infezione tubercolare latente è giustificata soltanto se inserita nell’ambito
di un programma di trattamento dei soggetti identificati.
Anche in questo caso, la mancanza di un sistema informativo dedicato preclude l’esistenza di dati sul numero delle
persone immigrate sottoposte a screening per infezione
tubercolare latente e sulla proporzione dei soggetti infetti
per cui sia stato iniziato e completato lo screening.
Nel complesso, il limite più importante per l’esecuzione dei
programmi di screening all’ingresso e di follow-up successivo, è rappresentato dalla bassa copertura. In parte, perché
spesso selettivamente indirizzata a particolari categorie di
immigrati (ad esempio rifugiati) o perché per definizione
alcune categorie di immigrati non sono identificabili all’ingresso nel paese (immigrati illegali), in parte perché per
problemi organizzativi non si riesce a raggiungere tutta la
popolazione bersaglio.
La diagosi e cura dell’infezione tubercolare latente ha tuttavia ulteriori limiti, rappresentati da una parte dalle difficoltà di completamento delle pratiche di screening e dall’altra
dai bassi tassi di completamento dei regimi di trattamento
dell’infezione tubercolare latente. Sul versante dello screening vi è ampio range nel tasso di completamento, tra
il 33% e l’80% (El-Hamad 2001, Carvalho 2004); i tassi
possono essere migliorati quando vengano attuate attività
di supporto tra le quali, ad esempio, l’offerta del test nella
lingua di appartenenza dello straniero (Carvalho 2004).
In uno studio condotto in Italia su immigrati clandestini, il
tasso di completamento di un regime di terapia dell’infezione tubercolare latente con isoniazide 300 mg (o 5 mg/kg)
assunta quotidianamente per 6 mesi non superava il 40%;
nello stesso studio, la supervisione attuata presso il centro
di cura di un regime bisettimanale di isoniazide addirittura riduceva i tassi di completamento al di sotto del 10%
(Matteelli 2000). Uno studio successivo ha dimostrato che,
nella stessa categoria di soggetti, i tassi di completamento
potevano essere incrementati fino al 50% per mezzo della
Immagine
tratta dal
fumetto Luís
Figo and
the World
tuberculosis
cup di Rod
Espinosa,
vincitore del
concorso
promosso
dall’Organizzazione
mondiale
della sanità
in collaborazione con
Luís Figo
55
AeM 64 nov. 08
supervisione al domicilio del paziente e l’impiego di regimi
brevi (rifampicina e pirazinamide per 2 mesi) (Anna Cristina Carvalho, comunicazione personale).
Costo-efficacia degli interventi negli immigrati
Sono stati identificati tre studi di costo-efficacia di programmi di screening della malattia o dell’infezione tubercolare, tutti condotti in Canada.
Dasgupta nel 2005 ha pubblicato una revisione degli articoli pubblicati prima del 2003 che dimostra che il costo
totale per caso di TB attiva diagnosticato è pari a 12.407 $
per il TST, 9.898 $ per la radiografia del torace, da 6.757 $
a 17.284 $ per la coltura (1 coltura o 3 colture) e conclude:
«gli attuali programmi di screening con esame radiografico del torace hanno uno scarso impatto e non sono costoefficaci. L’esecuzione dello screening con l’esame diretto
dell’espettorato aumenterebbe il costo-efficacia solo marginalmente. In paesi a bassa incidenza, lo screening degli
immigrati all’ingresso ha un impatto limitato e non è costoefficace» (Dasgupta 2005).
Un secondo studio di Dasgupta del 2000 conclude nuovamente che lo screening degli immigrati al momento della
richiesta del permesso di soggiorno e i programmi di sorveglianza successivi sono poco costo-efficaci, soprattutto per
problemi di natura organizzativa.
Schwartzmann nel 2000 confrontava il rapporto costoefficacia di programmi di screening all’ingresso basati
sull’esame radiografico del torace (per la ricerca della malattia attiva) con quelli basati su test tubercolinico (per la
ricerca dell’infezione tubercolare) (Schwartzmann 2000).
In tre coorti simulate di immigrati di 20 anni di età (diversa prevalenza di LTBI e di infezioni HIV), seguite per 20
anni, rispetto all’assenza di screening, lo screening radiografico previene il 4,3% dei casi di TB attiva attesi nella
coorte a maggior rischio (LTBI 50% e HIV 10%) e 8%
nella coorte a rischio più basso (LTBI 5%, HIV 1%). Lo
screening con TST riduce ulteriormente l’incidenza attesa
dell’8% e 4% rispettivamente. Il costo dello screening radiografico è di 3943 $ per caso prevenuto nella coorte più
a rischio e 236.494 $ in quella a rischio più basso. Il costo
del TST è 32.601 $ per caso prevenuto nella coorte più a
rischio e 68.799 $ in quella a rischio più basso. Gli autori
così concludono: «Nei giovani immigrati da paesi ad alto
rischio, lo screening radiografico è relativamente poco costoso, mentre lo screening con test tubercolinico è molto
più costoso».
56
Conclusioni
Un programma che si prefigga una riduzione della morbilità tubercolare nella popolazione immigrata in un paese a sviluppo avanzato come l’Italia non può prescindere
dall’ampliamento della fruibilità dei servizi sanitari e sociali. Ne è prerequisito il diritto legale all’accesso ai servizi
sanitari che deve essere assicurata a tutti gli immigrati indipendentemente dal possesso di permesso di soggiorno e
senza alcun obbligo di segnalazione all’autorità di polizia.
L’informazione esaustiva della popolazione sui diritti/
doveri e sui percorsi sanitari deve essere considerata una
priorità d’intervento. La progettazione, possibilmente concertata tra i vari “attori” sanitari e sociali, istituzionali e non
(servizi di programmazione, servizi territoriali, associazionismo e terzo settore), dovrebbe prevedere il coinvolgimento diretto e partecipato degli immigrati – associazioni,
leader o gruppi di aggregazione religiosi o politici, singoli
interessati, mediatori. La garanzia di accessibilità ai servizi richiede necessariamente anche interventi di riorientamento del sistema sanitario. Vi è necessità di interventi per
migliorare il coordinamento dei diversi ambiti assistenziali
ospedalieri e territoriali, per formare gli operatori sanitari
ad un approccio transculturale, per ridefinire i percorsi assistenziali in modo da tener conto dei bisogni specifici della popolazione immigrata (apertura pomeridiana o serale,
servizi decentrati, ecc.), per valorizzare il ruolo del medico
di medicina generale e del pediatra di libera scelta, nella
presa in carico di immigrati.
L’elemento essenziale di ogni intervento per il controllo della tubercolosi è rappresentato dalla diagnosi e trattamento
dei casi di malattia. I responsabili delle politiche sociali e
sanitarie dovrebbero considerare il case-holding come una
misura centrale di salute pubblica. Per assicurare una elevata adesione al trattamento, è essenziale, laddove necessario,
che i servizi sociali contribuiscano alla presa in carico dei
pazienti con TB, anche prevedendo, in fase di trattamento,
forme di accoglienza e accompagnamento sociale.
Per il miglioramento del case-holding appare essenziale che
i centri per il trattamento della tubercolosi in persone immigrate si avvalgano di servizi di traduzione e soprattutto
di mediazione culturale. L’aderenza al trattamento deve avvalersi del counseling e consegna di materiale informativo
nella lingua adeguata, della chiara definizione e compartecipazione iniziale del piano terapeutico, della semplificazione della terapia attraverso l’uso delle associazioni di
farmaci e della consegna diretta gratuita dei farmaci.
In particolari gruppi di pazienti (scarsa aderenza in precedente trattamento, soggetti senza fissa dimora, tubercolosi
multiresistente) oppure qualora non siano stati efficaci gli
interventi sopra elencati, è raccomandata la terapia direttamente osservata e attuata, ove possibile, a domicilio del
paziente o comunque in luoghi facilmente accessibili dal
paziente. La promozione e l’offerta di una diagnosi precoce di malattia tubercolare dovrebbe essere affidata in primo luogo ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Per ogni nuova persona iscritta proveniente da
un paese ad alto rischio (incidenza stimata dall’OMS >100
casi/100.000) queste figure sanitarie dovrebbero garantire
l’informazione sanitaria, raccogliere l’anamnesi tubercolare, indagare sulla eventuale presenza di sintomi suggestivi
di tubercolosi e se presenti proporre una radiografia del
torace. Le raccomandazioni sopra riportate valgono anche
per tutti gli operatori che lavorano in centri di assistenza sanitaria dedicati agli immigrati anche irregolari e che
visitano persone immigrate recentemente da paesi ad alto
rischio (>100 casi/100.000).
Lo screening e trattamento dell’infezione tubercolare latente è raccomandato per i bambini immigrati. La vaccinazione con BCG può essere proposta a bambini di età
inferiore a 5 anni appartenenti ad una comunità ad elevato
rischio di TB.
A priorità inferiore, ma comunque consigliato laddove le
condizioni lo rendano fattibile, è lo screening dell’infezione tubercolare latente e la terapia dell’infezione tubercolare latente in soggetti provenienti da paesi a incidenza di
tubercolosi >100/100,000 e residenti in Italia da <5 anni,
oppure provenienti dalle stesse aree e che vivono in condizioni socio-sanitarie di emarginazione indipendentemente
dall’epoca di soggiorno.
Alberto Matteelli e Issa El-Hamad lavorano presso l’Istituto Malattie Infettive e tropicali dell’Università degli studi
di Brescia
Mario C. Raviglione, lavora presso lo STOP TB Department dello World Health Organisation, di Ginevra
BIBLIOGRAFIA
American Thoracic Society, Controlling TB in the Unite
States. Recommendations from the American Thoracic Society, in «MMWR», n. 54 (RR 12), 2005, CDC and the Infectious Diseases Society of America
Assemblea del Parlamento europeo, Dichiarazione di Bratislava sulla salute, i diritti umani e le migrazioni, 8a Conferenza dei Ministri Europei della Salute
A.C.C. Carvalho, N. Saleri, I. El Hamad, S. Tedoldi, S. Capone, M.C. Pezzoli, M. Zaccaria, C. Pizzoccolo, C. Scarcella, A. Matteelli, Completion of screening for latent tuberculosis infection among immigrants, In «Epidemiology and
infection», vol. 133, n. 1, 2005, pp. 179-185
Centers for Diseases Prevention and Control, Recommendations for prevention and control of tuberculosis among
foreign-born persons, in «MMWR», n. 47 (RR 16), 1998,
pp. 2-29
R.J. Coker, A. Bell, R. Pitman, A. Hayward, J. Watson,
Screening programmes for tuberculosis in new entrance
across Europe, in «The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease», n. 8 (8), pp. 1022-1026, 2004
K. Dasgupta, et al., Comparison of cost-effectiveness of tuberculosis screening of close contacts and foreign-born populations, in «American Journal of Respiratory and Critical
Care Medicine», vol. 162, n. 6, 2000, pp. 2079-2086
K. Dasgupta, D. Menzies, Cost-effectiveness of tuberculosis control strategies among immigrants and refugees, in
«European Respiratory Journal», vol. 25, n. 6, 2005, pp.
1107-16
G. De Iaco, A. Matteelli, A. Pini, A.C.C. Carvalho, M.
Manfrin, N. Saleri, S. Capone, S. Caligaris, F. Castelli, G.
Carosi, Tasso di mortalità legato alla tubercolosi (TB) in pazienti con infezione da HIV (HIV+) in Italia, XIX Convegno Nazionale AIDS e Sindromi Correlate, Vibo Valentia,
21-23 ottobre 2005
I. El-Hamad, C. Casalini, A. Matteelli, S. Casari, M. Bugiani, M. Caputo, E. Bombana, C. Scolari, R. Moioli, C.
Scarcella, G. Carosi, Screening for tuberculosis and latent
tuberculosis infection among undocumente immigrants at
an unspecialise health service unit, in «The International
Journal of Tuberculosis and Lung Disease», vol. 5, n. 8,
2001, pp. 712-716
B. Eker, J. Ortmann, G.B. Migliori, et al., Multidrug- and
extensively-drug resistant tuberculosis: a TBNET survey in
Germany, in «Emerging Infectious Diseases», in corso di
stampa, 2008
FNOMCeO, Manifesto di Padova sul multiculturalismo in
medicina e sanità, FNOMCeO, 2007
C. Gagliotti, D. Resi, M.L. Moro, Delay in the treatment of
pulmonary TB in a changing demographic scenario, in «The
International Journal of Tuberculosis and Lung Disease»,
n. 10, 2006, pp. 305-309
A. Matteelli, C. Casalini, M.C. Raviglione, I. El-Hamad, C.
Scolari, E. Bombana, M. Bugiani, M. Caputo, C. Scarcella,
G.P. Carosi, Supervise preventive therapy for latent tuberculosis infection in illegal immigrants in Italy, in «Ameri-
can Journal of Respiratory and Critical Care Medicine», n.
162, 2000; pp. 53-1655
G.B. Migliori, L. Fattorini, P. Vaccarino, G. Besozzi, C.
Saltini, G. Orefici, E. Iona, A. Matteelli, F. Fiorentini, L.R.
Codecasa, L. Casali, A. Cassone; SMIRA (Italian Multicentre Study on Resistance to Anti-tuberculosis drugs) Study
Group, Prevalence of resistance to anti-tuberculosis drugs:
results of the 1998/99 national survey in Italy, in «The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease», n.
6, 2002, pp. 32-8
Ministero della Salute, Linee Guida per il controllo della
malattia tubercolare, su proposta del Ministro della Sanità,
ai sensi dell’art. 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Ministero della Salute, Documento Stop alla TB in Italia
2007 http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pagineAree_831_listaFile_item Name_0_file.pdf
Ministero della Salute - DG della Prevenzione Sanitaria –
Ufficio V – Malattie Infettive e Profilassi Internazionale
2008
NICE, Tuberculosis. Clinical diagnosis and management of
tuberculosis, and measures for its prevention and control,
2006
Presidenza del Consiglio d’Europa, Conclusioni e Raccomandazioni della Conferenza Europea “Health and Migration in the UE. Better Health for all in an inclusive society”,
Lisbona, 27 e 28 settembre 2007
K. Schwartzman, D. Menzies, Tuberculosis screening of
immigrants to low-prevalence countries. A cost-effectiveness
analysis, in «American Journal of Respiratory and Critical
Care Medicine», 2000 Mar;161(3 Pt 1), pp. 780-789
World Health Organisation, The stop TB strategy, Building on and enhancing DOTS to meet the TB-relate
millennium development goals, Report n. WHO/
HTM/STB/2006.37, Geneva 2006
World Health Organisation, WHO Tuberculosis Programme: framework for effective tuberculosis control, Report n.
WHO/TB/94.179
World Health Organisation, The global plan to stop TB
2006-2015, Available at: http://www.stoptb.org/globalplan/plan_main.asp Accesse 10 October 2008
P
eople born abroad represent a disproportionately
high percentage of tuberculosis (TB) cases in
Europe. They account for almost half of the total
TB burden in Italy; however, the incidence of TB in
immigrants is stable and that in Italian citizens has
been slowly decreasing over the last few years. Specific
strategies are neede to reduce the burden of the disease
in the immigrant population, including granting legal
access to equitable and culturally sensitive health
services. Early diagnosis and effective treatment of
infectious cases is the basis of any TB strategy: people
born abroad may require additional specific services
to ensure they follow the treatment and programmes
for diagnosis, and to ensure treatment of latent TB
infection.
57
AeM 64 nov. 08
ESPERIENZE
Alimentazione
e immigrazione:
problemi aperti
di Nicola Villanova
D
58
al 1980 l’Italia si è trasformata in Paese di immigrazione, con problemi di integrazione culturale: oggi
si contano nel nostro paese 190 nazionalità diverse,
con 80 lingue e 18 religioni. Alcune tradizioni alimentari
dei paesi d’origine possono comportare problemi sanitari
significativi, in particolare nei bambini immigrati: lo svezzamento più tardivo e l’allattamento al seno esclusivo fino
a oltre il 1° anno; l’assunzione precoce e protratta di latte
senza integrazione con frutta, verdure e carne possono favorire situazioni carenziali, quali il ritardo di crescita, il rachitismo, l’anemia ferropriva, ecc. Il rischio di questi stati
disnutrizionali appare correlato a un’immigrazione recente
della famiglia e allo stato di povertà che spesso si accompagna alle fasi iniziali dell’esperienza migratoria.
Un’indagine ha rilevato un’elevata frequenza di bambini
immigrati con malattia celiaca: il rischio di sviluppare questa malattia non è da correlare alle diversità tipologiche,
ma alle abitudini alimentari che sono state acquisite a seguito del fenomeno migratorio.
A partire dalla 2° e 3° infanzia la scolarità favorisce una
più facile integrazione degli immigrati con gli stili di vita
del mondo occidentale, tra cui anche le usanze alimentari.
Queste sono frequentemente caratterizzate da un’esagerata assunzione di zuccheri a rapido assorbimento, di proteine animali e di grassi saturi con conseguente maggior
rischio nell’età adulta di stati morbosi tipici della civiltà
moderna: malattie cardiovascolari, obesità, ipertensione,
diabete. Una delle prossime sfide sarà quella di evitare, per
mezzo di corretti interventi di educazione alimentare, che i
ragazzi immigrati assumano gli stessi comportamenti dietetici errati dei loro coetanei italiani. Un possibile traguardo
ulteriore potrà essere quello di far conoscere qualche vantaggio proprio dello stile alimentare degli immigrati.
Tra le popolazioni islamiche adulte, la tradizione alimentare più seguita è il divieto di assumere carne suina e l’ob-
bligo di consumare carne purificata secondo un rituale
religioso ben codificato. Questa procedura è obbligatoria
anche tra gli ebrei, che parlano di carne kasher, cioè idonea. I musulmani inoltre non possono assumere alcolici e
durante il mese lunare di digiuno (Ramadan), non possono
assumere cibo e bevande se non dopo il tramonto. Per chi
pratica l’induismo la vacca è sacra e quindi non commestibile perché connessa alla dottrina della trasfigurazione;
altri indiani sono vegetariani, perché secondo la loro religione tutti gli esseri viventi, compresi gli animali, debbono
essere rispettati.
L’Italia è ormai divenuta una nazione multietnica e multiculturale. Ciò comporta problemi anche nell’alimentazione,
perché questa è differente in ogni cultura. Per non trovarci
spiazzati, dobbiamo imparare a conoscerle. Per altro, le popolazioni immigrate tendono ad acquisire le abitudini alimentari del mondo occidentale, con i possibili rischi sanitari che queste comportano (allergie e intolleranze alimentari,
malattie dismetaboliche, proprie dei Paesi industrializzati).
Uno dei problemi emergenti relativi alla immigrazione è
quindi quello dell’alimentazione infantile e degli stati morbosi a essa correlati. Potrà essere di grande utilità una sana
pedagogia alimentare, unitamente all’implementazione di
un rigoroso protocollo di attività fisica.
In questa ottica si pongono gli studi volti a verificare la prevalenza di obesità e soprappeso, particolarmente nella popolazione infantile. Il Centro Salute “G.C. Croce” di Sasso
Marconi ha attivato recentemente un’analisi dello stato nutrizionale dei bambini in alcune classi di IV elementare nel
territorio della montagna bolognese, unitamente ad un protocollo di implementazione dell’attività fisica per contrastare il fenomeno dell’obesità. È una sfida nuova di fronte ad
una popolazione che cambia, alla forte immigrazione presente in queste aree e ad abitudini alimentari ben diverse da
quelle alle quali erano abituati i nostri genitori.
Note a margine del sessantesimo anniversario della
Dichiarazione universale dei diritti umani
di Elisa Pelizzari
Un importante anniversario
Il 10 dicembre 1948 l’Assemblea generale delle Nazioni
Unite approva e proclama la Dichiarazione universale dei
diritti umani. Si celebra dunque quest’anno il sessantesimo
anniversario di tale solenne delibera, nella quale, all’art. 2,
leggiamo: «Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso,
di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere...» e, all’art. 21: «Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia
attraverso rappresentanti liberamente scelti».
Che ne è di tali impegnative affermazioni rispetto agli stati africani? Inevitabile, qui, è il riferimento alla maggiore
organizzazione su scala continentale: l’Unione africana
(UA), creata nel 2002, e volta a sostituire l’Organizzazione
dell’unione africana (OUA). Ne sono membri tutti i Paesi
del continente, ad eccezione del Marocco. In effetti, fra
gli scopi dell’UA vi è la promozione della democrazia, dei
diritti umani e dello sviluppo. Nel suo atto costitutivo, al
punto E, notiamo un preciso riferimento alla Carta delle
Nazioni e alla Dichiarazione universale dei diritti umani,
mentre, al punto H, si garantisce la protezione delle prerogative sancite dalla Carta africana dei diritti umani e dei
popoli.
Almeno sul piano formale, l’importanza e il valore inalienabile dei diritti umani vengono dunque riconosciuti dalla
pressoché totalità dei governi africani. Differente la prospettiva su un piano reale.
Risulta però impossibile, se non si vuole correre il rischio di
sottoporre all’attenzione dei lettori solo qualche dato generico e superficiale, tracciare, in poche righe, il quadro della
situazione dei diritti umani in ogni Stato del continente. Per
verificare in cosa si traduca l’applicazione (o il non rispetto)
SITUAZIONI
La crisi somala e la partecipazione delle
donne alla ricostruzione dello Stato
Magdy El
Shafee Wa’il Saad,
That’s mine,
pubblicata
in Africa
Comics
2005-2006,
Lai-momo
2006
59
AeM 64 nov. 08
dei principi sopra enunciati, preferiamo – nel presente articolo – optare per una riflessione di ambito più ristretto e
riguardante un caso di sicura attualità: quello della Somalia.
In maniera ancora più specifica, tenteremo di offrire una
descrizione dei “diritti al femminile” in tale nazione, terra
da tanti additata quale drammatico caso di faile state.
60
Un caso di studio: la Somalia
Nonostante la lunga crisi e la cruenta guerra intestina ancora in corso, un inedito modello di ricomposizione del
tessuto collettivo sembra germinare in Somalia. Protagonista del processo è la Somali Women’s Agenda (SWA),
piattaforma di riflessione e d’azione sul futuro assetto del
paese, nata nel 2007 e formata da donne, molte delle quali
leader di associazioni di volontariato, attive in loco o nella diaspora. Il lavoro e gli obiettivi della SWA sono stati
esposti in un seminario internazionale, tenutosi a Torino
nel maggio 2008, promosso dalla Provincia e da varie organizzazioni (IIDA, ACSP, SDW, Zonafranca, SCI, IXème
Ciel). Un’ulteriore conferenza ha avuto luogo a Nairobi
nel luglio 2008, e ha rappresentato un passo decisivo per
quanto concerne l’inclusione delle donne somale nel percorso di decision making a tutti i livelli della società locale.
Ne sono stati organizzatori le ONG COSPE e IIDA, sostenute da UNIFEM, DFID e Commissione europea.
Per comprendere da dove emerga la necessità delle donne
di levare la voce in difesa dei loro diritti e di quelli della
società civile in generale, è opportuno ripercorrere alcuni
momenti della lunga crisi somala.
Dopo la fuga del dittatore Siad Barre, il paese piomba in
un tunnel di violenza e terrore che, seppure attraverso fasi
alterne, rimane senza soluzione. I primi scontri nella capitale, senza governo dal 1991, hanno per protagonisti i
signori della guerra, con le loro milizie a base clanica, ciascuno alla ricerca di un’impossibile supremazia. L’emergenza umanitaria da loro generata induce le Nazioni Unite ad organizzare due missioni, Unosom I e Unosom II
(1992-1995), tristemente fallite. Le difficoltà che si susseguono favoriscono il rapido smembrasi del paese, un tempo citato quale esempio di omogeneità etnica e culturale in
Africa. Si assiste così alle scissioni unilaterali delle regioni
del Somaliland (1991) e del Puntland (1997-98).
Una fase diversa sembra aprirsi con la salita al potere delle
corti islamiche, nei territori centrali e a Mogadiscio, dal
luglio 2006; i movimenti religiosi tentano di ristabilire ordine e sicurezza appoggiandosi alla sharia. Ma il loro predominio è contestato dal governo federale di transizione
(GFT), istituzione sorta da una serie di conferenze di pace
tenutesi all’estero, a Gibuti (2000) e a Nairobi (2004) in
particolare. Per appoggiare tale struttura, che pretende di
superare le barriere fra i clan, intervengono le truppe etiopi, le quali – nel dicembre del 2006 – finiscono per occupare militarmente Mogadiscio, col tacito assenso degli Stati
Uniti (inquieti di fronte al possibile rafforzarsi, nel Corno
d’Africa, di un regime musulmano, etichettato come radicale, e all’emergere di una fantomatica base per terroristi
vicini ad Al-Qaida).
La resistenza armata (muqawamada) all’invasione straniera
non tarda ad organizzarsi, anche perché, tradizionalmente,
il governo di Addis Abeba è percepito come una minaccia
per l’integrità territoriale somala; scaramucce lungo i confini – nell’Ogaden soprattutto – hanno in effetti scandito
l’esistenza dei vari regimi nei due paesi.
Di fronte alle violenze che sconvolgono Mogadiscio, nel
febbraio 2007, le Nazioni Unite autorizzano l’Unione africana ad inviare forze d’interposizione.
Gli scontri non cessano: in un paese in pieno caos e alla
fame, le armi circolano in abbondanza. È questo l’ambito
in cui si profila un fragile patto fra le varie forze contrarie
alla presenza etiope. Ne sono artefici alcuni partiti autonomisti d’oltre frontiera invisi al presidente Meles Zenawi,
l’Eritrea (che gioca la carta del sostegno militare e logistico
alla neonata alleanza per la liberazione della Somalia), gli
ex signori della guerra (appartenenti alla confederazione
clanica degli hawiye), il COSIC o consiglio delle corti islamiche. Quest’ultimo si articola in correnti, ciascuna delle
quali guidata da personaggi carismatici; fra i segmenti più
conosciuti, possiamo citare, da un lato, quello di Aden
Xashi Cayrow Sheikh Muktar e del suo portavoce Robo
Abu Mansur, entrambi a capo del movimento clandestino
Shabab, dall’altro lato, il gruppo di Sheikh Hassan Dahir
Aweys, l’ex dirigente del partito radicale At-Itihad AlIslaami, assassinato nel 2008 e sostituito da Sheikh Sharif
Sheikh Ahmed.
I soprusi dell’esercito etiope e dei soldati somali agli ordini
del GFT – che ha come presidente ad interim Abdullahi
Yusuf Ahme e primo ministro (dimissionario) Ali Mohame Gedi – spingono la gente alla fuga in massa, sia con
spostamenti nel paese, sia con l’emigrazione al di fuori dei
confini nazionali. Si parla di 1 milione di rifugiati interni,
accampati alla meno peggio sotto gli alberi e quasi privi di
aiuto dalle agenzie internazionali, impossibilitate ad operare a causa dell’insicurezza diffusa. La migrazione verso il
Kenya è poi pesantemente frenata dal governo di Nairobi,
che accoglie ufficialmente già 180.000 rifugiati e non ne
vuole altri, mentre quella via mare, diretta alle coste dello Yemen, avviene in condizioni di enorme pericolo per i
profughi, e senza reali prospettive d’inserimento per loro
nel luogo di arrivo.
Il fardello della guerra sulle spalle delle donne
Il peso dell’emergenza umanitaria di cui è vittima la popolazione ricade, in gran parte, sulle spalle delle donne;
sono queste, come vogliono i costumi autoctoni, a essere
incaricate del mantenimento della famiglia. Nonostante
la guerra civile, continuano perciò a gestire un’economia
informale, volta alla mera sopravvivenza, dedicandosi alla
coltivazione (laddove l’attività agricola è ancora possibile),
al piccolo commercio e all’esercizio di micro-imprese. Un
importante aiuto è poi fornito dai parenti installati da anni
all’estero, che non cessano di spedire denaro e beni di consumo.
Le vedove o le mogli separate di mariti che combattono devono provvedere alla cura dei figli e rischiano di continuo
di essere oggetto di stupri e aggressioni. Ne è un esempio
il caso di Zamzan Abdinoor (AFRICA.COM, sett. 2007).
Data in sposa ad un miliziano del centro portuale di Kisimayo, Zamzam rimane vedova, in seguito a uno scontro
tra fazioni. Uno zio le trova un secondo marito, anche lui
membro di un gruppo armato, poi ucciso in un agguato.
La giovane, con bambini piccoli e incinta, si ritrova abbandonata a se stessa e priva di mezzi per sopravvivere. Nel
tentativo di scampare alla guerra civile, nei primi mesi del
2007, oltrepassa la frontiera e si sistema nel campo profughi allestito nella cittadina kenyana di Garissa. Qui lavora
ancora oggi in un baracchino dove prepara il tè, vende ge-
neri di prima necessità e foglie di khat (sostanza allucinogena da consumare masticandola, molto apprezzata nella
regione). Il suo destino ricorda quello di tante somale, cedute dalle famiglie più povere ai miliziani, magari contro la
loro volontà, e poi costrette a vagare da un luogo all’altro
per sfuggire agli scontri.
All’impegno femminile sul fronte domestico e lavorativo, non corrisponde purtroppo una presa di posizione
in campo politico. Le numerose (e, non di rado, inutili o
pretestuose) conferenze per la pacificazione della Somalia emarginano le donne, relegandole in secondo piano.
Interpretazioni scorrette, ma di comodo, della religione
musulmana, fanno sì che la componente femminile della
società sia esclusa dall’arena pubblica, per venire adibita
solamente a compiti domestici. Insomma, al momento di
decidere, a molti non pare importante implicare le donne:
d’altronde, queste, dovrebbero sentirsi già rappresentate
dai leader dei clan (patrilineari) di appartenenza...
A ciò la Somali Women’s Agenda ha deciso di porre un
freno, lottando per assicurare alle donne pari opportunità
di accesso e piena partecipazione alle strutture di potere.
Certo, l’entità del conflitto in corso non lascia grande spazio al dibattito, mentre l’assenza d’istituzioni politiche stabili (e legittimamente elette) rende impossibile la messa in
opera di un piano strategico efficace. Malgrado questo, la
SWA ha già raggiunto uno scopo fondamentale: mettere
insieme donne di regioni e di etnie differenti, esponenti
di 16 associazioni femminili, per dare vita a quanto è stato
chiamato, forse con una certa ironia, il “sesto clan”.
Alla consueta distinzione fra le confederazioni claniche (tol)
discendenti dal mitico antenato capostipite Samaale (dir,
hawiye, darood) o da Sab (digil e raxanweyn), così come
ai raggruppamenti più eterogenei formati dalle minoranze
etniche (bantu e khoisan, rispettivamente chiamate in somalo jareer e boon), le donne hanno voluto contrapporre
una loro esclusiva realtà rappresentativa che non guarda al
passato, ma si rapporta alle necessità del presente, il “sesto
clan” appunto.
Il “sesto clan”
Col proposito di chiarire il significato del suo impegno
politico, in Somalia come nella diaspora, il 12 e il 13 maggio scorsi la SWA ha accolto l’invito delle autorità e delle
associazioni torinesi a riunirsi, per un seminario di studi,
nel capoluogo del Piemonte. Il programma delle due giornate è stato inserito in un ciclo d’incontri sui diritti delle
donne nel mondo, realizzato dal Museo diffuso della resistenza, a sessant’anni dalla Dichiarazione universale dei
diritti umani.
Relatrici e relatori si sono alternati per offrire un contributo, a partire dalle specifiche competenze, sul tema della ricostruzione della società somala. Figure istituzionali, quali
l’assessore alle Pari opportunità e alle relazioni internazionali della Provincia di Torino, Aurora Tesio, o il ministro
del governo federale somalo di transizione, Mohame Ibrahim Xabsade, hanno ascoltato intellettuali da anni in esilio,
come Mohame Aden Sheikh, universitari, quali l’antropologo Alberto Antoniotto e, soprattutto, esponenti delle
associazioni femminili: Hibo Yassin (COSPE), Mariam
Yassin (IIDA), Hawa Ugas (WAMO), Sahra Omar Mallim
(ALLA MAGAN). Hanno poi preso la parola varie rappresentanti della diaspora in Europa, fra cui Jawahir Cumar e
Batulo Essak, che lavorano per portare avanti progetti di
cooperazione sociosanitaria nel paese d’origine. Nuradin
Dirie, consigliere speciale del responsabile UNICEF per la
Somalia, ha quindi spiegato come incide sulle generazioni
più giovani il perdurare dell’emergenza e la mancanza di
strutture educative adeguate.
L’analisi del quadro politico ha sottolineato il valore storico della pastoral democracy, tipica della realtà nomade prima del colonialismo e ha condotto a interrogarsi sul senso,
oggigiorno, di un’identità costruita unicamente sui legami
agnatici. Quanto al ruolo delle donne, si è ricordato come,
da un punto di vista formale, i loro diritti siano stati riconosciuti già dagli anni ’60, all’indomani cioè dell’indipendenza nazionale, senza però che venissero tradotte nella
pratica quotidiana le norme sull’uguaglianza. Il problema
di fondo rimane quello della formazione e dell’istruzione,
non solo in ambito scolastico, bensì in campo sociopolitico: il dialogo, il rispetto reciproco e la costruzione di una
cultura di riconciliazione esigono la partecipazione di tutti
i cittadini, uomini e donne in prima linea, insieme.
Proprio le questioni della good governance sono al centro
di progetti di cooperazione fra l’Italia e la Somalia, rivolti
al sesso femminile. La collaborazione fra le ong COSPE
e IIDA (sigla che in somalo significa “ragazza nata in un
giorno di festa”) scommette sul potenziamento (empowerment) della società civile, attraverso il riconoscimento del
contributo delle donne, le più disponibili a muoversi per la
pace e a sormontare le faziosità.
I tradizionali spazi decisionali, gestiti dagli anziani delle
comunità, vengono troppo spesso strumentalizzati: un soprannome attribuito ai membri maschili di tali consigli lo
conferma in modo sarcastico. L’espressione fadhi ku dirir
(coloro che rimangono seduti a sorseggiare il tè, discutendo di guerra, ma facendo combattere gli altri) designa ormai i “saggi” dei villaggi e dei quartieri, i quali sembrano
trovare nel mantenimento dello status quo la sola ragione
d’essere del loro potere. A quando la svolta radicale?
Elisa Pelizzari è dottore di ricerca in antropologia e etnologia all’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di
Parigi; specialista del Corno d’Africa, lavora attualmente
come responsabile della casa editrice L’Harmattan Italia
T
he Universal Declaration of Human Rights (10th
December 1948) established, at least formally, the
importance and value of human life by stating its most
important rights. But what value and effectiveness do
these principles have in Africa? This article analyses
the case of post-civil war Somalia, where women have
tried to “reform” their country through the Somali
Women’s Agenda (SWA), an organization aiming to
involve women in the decision making process of the
local community.
61
AeM 64 nov. 08
MUSEI
READ-ME. Musei etnografici e diaspora
Museo Luigi Pigorini, Roma, 5-7 giugno 2008
di Anna Maria Pecci
Mathilde
Monnier, en
collaboration
avec Karim
Zeriahen,
Dans tes
cheveux,
2007, installation vidéo,
10 min. 59
sec.
© Musée
du quai
Branly/Marc
Coudrais
62
N
elle giornate del 5, 6 e 7 giugno il Museo nazionale
preistorico etnografico (MNEP) “Luigi Pigorini”
di Roma ha ospitato la prima di una serie di iniziative organizzate nell’ambito del progetto READ-ME
(Réseau européen des associations de diasporas et musées
ethnographiques) a cui l’istituzione italiana prende parte
insieme a tre dei più importanti musei etnografici europei:
il Musée Royal de l’Afrique Centrale di Tervuren (Bruxelles), l’Etnografiska Museet di Stoccolma e il Musée du quai
Branly di Parigi.
Il progetto si inserisce in quel processo di ripensamento
delle poetiche e politiche della rappresentazione museale
(Karp e Lavine 1995) che sta recentemente coinvolgendo
alcune delle principali istituzioni museali europee, dopo
essere stato avviato e promosso, già negli anni ’80 e ’90 del
Novecento, in quei Paesi anglosassoni e francofoni (ricordiamo in particolare gli Stati Uniti, l’Australia e il Canada) dove maggiori sono state le rivendicazioni dei diritti
di rappresentazione e autorappresentazione culturale da
parte delle minoranze o “comunità” etniche depositarie del
sapere e del saper fare insiti nelle testimonianze materiali e
immateriali “altre” – ovvero “loro” – conservate nei musei.
READ-ME intende principalmente ridefinire e promuovere il rapporto tra i musei etnografici che vi prendono parte
e le culture della diaspora che reclamano nuova visibilità
sociale in un’ottica di inclusione culturale e di cittadinanza
attiva. A tal fine, risulta di cruciale importanza l’elaborazione partecipata (o collaborativa) di una nuova visione museologica e museografica che assuma i patrimoni e i musei
come terreno di connessione e di confronto interculturale
su cui elaborare e sperimentare attività di valorizzazione e
riappropriazione identitarie.
Il progetto, per quanto riguarda la restituzione pubblica dei
lavori interistituzionali, è strutturato in un ciclo di atelier
scientifici caratterizzati dalla presenza congiunta di referenti museali e rappresentanti delle associazioni o comunità delle diaspore dei Paesi partecipanti. Ogni evento intende costituire un’occasione di dibattito e riflessione per/tra
antropologi, etnologi, sociologi, storici dell’arte, museologi, museografi e studenti, ponendo al centro del confronto
non soltanto il tema della diaspora ma anche quello della
maschera che, essendo presente in tutte le culture, è intesa
come “oggetto museale transculturale” e mezzo per incentivare il dialogo tra le diverse comunità diasporiche. Ogni
atelier prefigura inoltre l’esercizio e l’espressione di uno
sguardo critico da parte dei rappresentanti delle diaspore
tanto nei confronti dei musei e delle loro strategie rappresentative quanto dei rapporti tra i Paesi europei e le ex
colonie in una prospettiva postcoloniale.
L’atelier di Roma, dal titolo “Museo e diaspora. Maschere
e identità plurali”, è stato articolato in tre giornate tematiche – Il Museo etnografico, la maschera, le diaspore; Io,
l’altro, la maschera; Scritture della diaspora e maschere
dell’identità – a cui hanno preso parte, in qualità di relatori, i referenti del MNEP “L. Pigorini”, i rappresentanti
di alcune associazioni e comunità delle diaspore presenti a
Roma (tra cui AssoCina, Federazione della diaspora africana di Roma e del Lazio, ATM onlus, Comunità della diaspora peruviana), antropologi culturali e museali, docenti
di lingue e letterature straniere, giornalisti e artisti “migranti”, di prima e seconda generazione. Tra il pubblico
erano presenti diversi “addetti ai lavori” e studenti, oltre
ai referenti dei musei europei e ai rappresentanti delle diaspore provenienti dal Belgio e dalla Svezia. Da segnalare la
significativa assenza dei rappresentanti delle associazioni
delle diaspore in Francia.
I lavori hanno ruotato attorno al tema della maschera, intesa in senso sia metaforico che materiale; una scelta che,
come illustrato nel programma, raddoppiando le possibilità di riflessione, ha inteso evitare il rischio di «limitare il campo di interesse alla maschera in quanto oggetto
etnografico connotato da specifiche valenze culturali» e
innescare conseguenti «meccanismi di esclusione» per cui
«le comunità coinvolte avrebbero potuto non riconoscere nell’oggetto-maschera un elemento rappresentativo del
proprio patrimonio culturale». A partire da tali premesse,
e con il contributo dei rappresentanti delle associazioni
delle diaspore, la maschera è stata assunta come «dispositivo simbolico polisemantico e inclusivo, un metadiscorso
sui processi di costruzione dell’identità in contesti di immigrazione». Gli interventi hanno pertanto proposto diverse
chiavi di lettura, prevalentemente antropologiche, del “mascheramento” e della trasformazione delle identità in contesti di adattamento e di integrazione culturale, illustrando
molteplici declinazioni del tema a partire da resoconti di
fieldworks condotti nella prospettiva di un’antropologia
“rimpatriata” (Marcus e Fischer 1998; Clifford 1993) e dislocata tra il percorso diasporico e musealizzante della maschera Jurupari conservata al MNEP “L. Pigorini”, le comunità diasporiche presenti al centro e ai margini di Roma
e le produzioni artistiche dei giovani migranti di seconda
generazione, per citare soltanto qualcuno dei casi discussi.
Nel corso delle tre giornate la dialettica tra musei e culture
delle diaspore è stata vivace e costruttivamente “tesa”, nel
senso che la riflessione sui concetti in uso (identità, etnicità, maschera, diaspora, patrimonio) e sulle modalità di rappresentazione delle culture (in particolare il metodo etnografico di ricerca sul campo, quale incontro “asimmetrico”
con l’altro; il linguaggio museografico o “vetrinizzazione”;
la scrittura dell’altro) è stata oggetto di un confronto e di
un dibattito avviati, in maniera critica, dai rappresentanti
delle comunità delle diaspore, in particolare dai belgi che
in più occasioni hanno sollecitato gli antropologi presenti
a ripensare ancora, “qui e ora”, alcuni degli strumenti in
dotazione con la loro “cassetta degli attrezzi”.
Non è possibile sintetizzare qui il programma degli interventi – numerosi, molto diversi tra loro per contenuti e
approcci disciplinari, e particolarmente densi di significati
– ma appare opportuno riassumere il senso dell’iniziativa
parafrasando uno dei sottotitoli secondo il quale “il museo
etnografico esce dai depositi” e getta la maschera, ovvero
apre le porte a uno sguardo esterno che, in quanto diasporico, può risultare anche estraniato e gli disvela parte (siamo
soltanto agli inizi…) dei dispositivi discorsivi che, tradotti
in linguaggio museografico, hanno storicamente “camuffato” le identità tangibili e intangibili degli oggetti altri, occultando i processi culturali di etichettamento e definizione
a cui sono stati sottoposti. Come sostiene James Clifford,
«tutti i siti di raccolta cominciano ad assomigliare a posti
d’incontro e passaggio. Visti in questo modo, gli oggetti attualmente nei grandi musei sono viaggiatori, attraversatori: alcuni fortemente “diasporici” con forti legami altrove,
ancora molto significativi. (…) Questa riconsiderazione di
collezioni e esposizioni come processi storici incompiuti di
viaggio, di attraversamento e riattraversamento, modifica
le concezioni di patrimonio e pubblico» (Clifford 1999, p.
264). READ-ME, con modalità finalmente collaborative,
ne sta prospettando alcune. READ-ME proseguirà con altre tre iniziative in programma:
- un atelier e un festival del film antropologico presso l’Etnografiska Museet di Stoccolma (ottobre 2008);
- un Colloquio internazionale sul tema della diaspora al
Musée du quai Branly di Parigi (marzo 2009);
- una mostra sulle maschere contemporanee africane e sui
rispettivi rituali al Musée Royal de l’Afrique Centrale di
Tervuren (maggio 2009).
Anna Maria Pecci, antropologa museale, svolge attività di
ricerca, consulenza e collaborazione nell’ambito della progettazione culturale applicata a musei e patrimoni
BIBLIOGRAFIA
J. Clifford, I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura
e arte nel secolo XX, Bollati Boringhieri, Torino 1993
J. Clifford, Strade. Viaggio e traduzione alla fine del secolo
XX, Bollati Boringhieri, Torino 1999
G.E. Marcus, M.M. J. Fischer, Antropologia come critica
culturale, Meltemi, Roma 1998
I. Karp, S. D Lavine (a cura di), Culture in mostra. Poetiche e
politiche dell’allestimento museale, CLUEB, Bologna 1995
F
rom the 5th to the 7th of June the Museo nazionale
preistorico etnografico (MNEP) “Luigi Pigorini”
in Rome hosted the first conference of the project
“READ-ME” (Réseau européen des associations de
diaspora et musées ethnographiques).
Participating in the project are some of the most
important European ethnographic museums (Musée
Royal de l’Afrique Centrale of Tervuren, Brussels,
Etnografiska Museet of Stockholm, Musée du quai
Branly of Paris). “READ-ME” aims at redefining and
facilitating the links between ethnographic museums
and cultures of the diaspora.
63
AeM 64 nov. 08
Femmes dans les arts d’Afrique
MUSEI
Musée Dapper, Paris,
10 ottobre 2008 - 12 luglio 2009
64
di Francesca Fattori
F
igure centrali delle società tribali africane, fondate
spesso su un sistema matrilineare, le donne sono le
protagoniste assolute della grande mostra temporanea inaugurata dal Musée Dapper – la cui fondazione
opera da oltre vent’anni per promuovere le arti africane –
per celebrare il ruolo riservato alla figura femminile nella
rappresentazione scultorea africana.
Ciò che colpisce in questa esposizione, curata da Christiane Falgayrette Leveau, oltre alla grande quantità di opere
esposte (circa centocinquanta, provenienti da diverse importanti collezioni museali e private, europee e africane),
è l’estrema varietà delle forme artistiche e dei supporti e
materiali utilizzati.
In funzione dell’uso privato o pubblico, quotidiano o ritosacrale degli oggetti, il corpo femminile è sublimato nel
legno, nell’avorio o nei metalli preziosi, e interviene nei
riti di iniziazione, sepoltura, protezione o risoluzione dei
conflitti... I tratti del corpo femminile possono essere – secondo l’epoca o la localizzazione geografica – geometricamente e grossolanamente abbozzati o esaltati nelle forme
piene della fertilità, simboleggianti il ruolo della donna
come nutrice della famiglia e del mondo, ma infondono
in ogni caso un’impressione di equilibrio atemporale e di
grande modernità plastica.
Comune denominatore alla grande diversità di forme e
usi, la celebrazione dei cicli e dei momenti forti della vita,
del passaggio dall’infanzia all’adolescenza e all’età adulta,
dove è la maternità, più visibile dell’evento del parto, ad
essere esaltata.
Dall’Antico Egitto ai regni e gruppi dell’Africa occidentale ed equatoriale (Repubblica Democratica del Congo,
Costa d’Avorio, Burkina Faso, Mali, Camerun, Nigeria,
Egitto, Gabon, Tanzania, Ghana), non si tratta unicamente di esplorare l’estetica della rappresentazione del corpo
femminile, ma anche il ruolo rivestito dalle donne nella
vita sociale, politica, economica e religiosa delle rispettive
comunità.
La prima impressione è quella di una grande ambivalenza,
in una sorta di presenza/assenza che vede la donna come
figura predominante e fondamentale all’interno della cerchia familiare – dotata del ruolo fondamentale di trasmissione della memoria e dei valori – ma, al tempo stesso,
apparentemente più defilata nella sfera politica e rituale
delle comunità africane. Un’impressione confermata dalla pratica: la rappresentazione della figura femminile è
principalmente affare degli uomini del gruppo, artefici e
destinatari degli oggetti scolpiti a effige femminile, come
la straordinaria “maschera da ventre” di legno, indossata
dagli officianti per riprodurre in particolari rituali le fattezze del corpo trasformato dalla gravidanza.
Ciò che risalta maggiormente è la celebrazione del ruolo di
moglie e di madre, custode e garante dell’ordine della famiglia, cellula primordiale del gruppo e dell’intero cosmo.
Gli oggetti esposti hanno valenza di ricompensa, come
preziosi cucchiai di legno scolpiti che premiano presso
alcune popolazioni della Costa d’Avorio le arti culinarie
femminili, e vengono utilizzati per trasmettere specifici
messaggi educativi alle giovani generazioni e in particolare alle giovani donne. Ogni tappa della vita femminle
è presente, dall’adolescenza alla gravidanza, magnificata
come segno di fertilità dell’intera comunità e della terra.
Le maschere di legno e le statue corrispondono all’ideale di bellezza e sensualità dei diversi gruppi e epoche,
e testimoniano delle esperienze vissute dalle donne nella
propria corporeità, come le scarificazioni rituali o le pratiche invasive e violente delle mutilazioni sessuali, segno di
iniziazione e di passaggio all’età adulta. Il rapporto di coppia è egualmente presente, e la donna è spesso presentata
come controparte di un essere maschile, nella maggior
parte dei casi divino. La statuaria funeraria – che richiama
le reminiscenze delle lezioni di storia sull’Antico Egitto –
celebra “coppie eterne” che simboleggiano la perennità
della struttura familiare e la perfetta complementarità delle figure maschile e femminile.
La celebrazione del ruolo “privato” e della sfera intima
della donna non deve trarre in inganno sull’apparente relegazione a tali funzioni, e la mostra rivela abilmente la
celebrazione artistica riservata al ruolo politico e sacrale
rivestito dalla donna in specifici contesti.
Maternità rima infatti con regalità, come illustrano le maschere e i copricapi destinati a trasmettere alla comunità
l’esempio di madri-regine illustri. Costante di numerose
culture sparse per il mondo, il gruppo scultoreo della donna con il bambino fornisce nelle arti africane un’immagine
YAKA /
SUKU,
Statuette,
République
Démocratique
du Congo,
Bois et
pigments,
H: 32 cm.
Musée royal
de l’Afrique
centrale,
Tervuren.
Photo
Jean-Marc
Vandyck,
© MRAC
Tervuren
65
AeM 64 nov. 08
Angèle
Etoundi
Essamba,
Série
«Noirs»,
Les
Amazones,
2002.
Photographie
argentique
noir et blanc.
© Angèle
Etoundi
Essamba
ideale tendente verso il mondo sovrannaturale. Iniziate
alle pratiche rituali e terapeutiche in alcune comunità,
come in Mali, le donne hanno l’occasione di partecipare
direttamente alle cerimonie, prerogativa usualmente riservata agli uomini.
Considerata un nodo fondamentale nella relazione al divino e all’aldilà, la donna è quindi presente anche quando
la sua presenza è proibita fisicamente, grazie a statue e
oggetti che, riproducendone le forme, ne attestano l’importanza primordiale all’interno delle dinamiche sociali e
religiose.
In apertura all’esposizione, spazio dedicato per antonomasia alle opere di giovani artisti originari dell’Africa o
della diaspora africana, il Musée Dapper propone le immagini dell’artista camerunese Angèle Etoundi Essamba.
Nelle sue fotografie di grande formato, un uso sapiente
del bianco e nero e di alcuni dosati colori permette di sottolineare i volumi dei corpi femminili e l’intensità degli
sguardi, nella potenza evocatrice di una femminilità che è
incarnata nei diversi volti dell’Africa, dal Maghreb al sud
del Sahara.
Mostrando corpi “esaltati, tormentati, in rivolta, finalmente liberati”, il ritratto femminile è utilizzato per interrogare le appartenenze multiculturali e il ruolo che la
società africana riconosce alla donna, immortalata nelle
diverse tappe della vita. Anche in questo caso, il medium
utilizzato e le figure rappresentate contribuiscono a unire
modernità e tradizione, concretezza e misticismo, dando
vita a uno spazio senza tempo nel quale la donna si vede
riconosciuta nel ruolo di protagonista e regina.
Una ricca programmazione culturale (proiezioni cinematografiche e conferenze) completa la mostra, esplorando
l’evoluzione contemporanea della rappresentazione femminile nelle forme artistiche africane e toccando temi controversi e attuali come il ruolo della donna nella migrazione o nei conflitti.
F
emmes dans les arts d’Afrique, held at the Dapper
Museum (Musée Dapper), is dedicated, as the
title suggests, to African women.
Women in African art are represented through various
mediums such as clay and wood sculptures that show
the different stages in a woman’s life: childhood,
adolescence, adulthood and mainly motherhood.
The exhibition highlights the private and public
aspects of women and their political function in
society. In particular in the works of the African artist
Angle Etoundi Essamba he reinforces this concept
by showing women that embody the many faces of
Africa.
I “luoghi comuni”
dell’intercultura
C
ultura, culture, multicultura, intercultura, pluralismo culturale, dialogo interculturale, identità sono
alcune espressioni ricorrenti di un vasto dibattito
che negli ultimi anni attraversa le discipline e la società;
un dibattito caratterizzato da eccessi e retoriche, semplificazioni e distorsioni, parzialità e interessi, confusioni. Il
termine “interculturale”, assieme a “multiculturale”, è divenuto una sorta di chiave universale buona per qualsiasi
evento che coinvolga in modo più o meno determinante
individui o aspetti di cultura diversa. Tutto oggi pare interculturale, e si fregia di tale attributo o di uno dei tanti
lemmi derivanti da questa matrice lessicale, con il rischio
di svuotare e banalizzare un’idea e una pratica con profonde implicazioni politiche, pedagogiche, etiche.
Vista da lontano l’interculturalità sembra dunque evocare
grandi consensi. Molti si pregiano di interpretarla correttamente e di praticarla con coerenza. Il panorama si complica se lo sguardo si avvicina. L’interculturalità esaltata e
protetta – e la sua versione transitiva, il dialogo interculturale – è soltanto la propria, con i propri parametri interpretativi, con le proprie ideologie, sottomessa alla propria
paternità. Ma un conto è consentire al principio astratto,
un conto è misurarsi sul concreto. Un maestro dell’interculturalità come Raimond Panikkar (2002) ha affermato
coraggiosamente che «l’apertura all’interculturalità è veramente sovversiva. Ci destabilizza, contesta convinzioni
profondamente radicate che diamo per scontate, perché
mai messe in discussione. Ci dice che la nostra visione del
mondo, quindi il nostro stesso mondo, non è l’unico». Che
sia così, a dircelo, è la prospettiva storica. Il dialogo interculturale (e quello interreligioso di cui è parte integrante)
non appartiene alla prassi comune delle relazioni internazionali, né a quelle più feriali e tuttavia non meno importanti dei rapporti quotidiani tra persone appartenenti a
culture e a religioni diverse. Intanto perché le esperienze
storiche prevalenti, nelle relazioni tra gli stati e tra i popoli,
non sono state e non sono di dialogo, di riconoscimento
reciproco, ma piuttosto di dominio se non addirittura di
sopraffazione. L’altro, il diverso, nella cultura storica più
diffusa che poi si è affermata come mentalità prevalente,
va tenuto sotto controllo, va dominato o quanto meno
messo in condizioni di non turbare l’ordine costituito, di
non mettere in discussione gli atteggiamenti condivisi dalla
maggioranza omogenea.
Un quadro sintetico sul dialogo interculturale deve quindi
partire da questi due poli: da un lato l’apparente pressoché
generale successo dell’idea, e dall’altro il sotterraneo pro-
blematico scontro di visioni, interpretazioni e interessi in
cui si fabbrica il senso quotidiano del dialogo interculturale nel mondo globalizzato. Va dunque compreso leggendo
le grandi proclamazioni e le facili convergenze alla luce dei
reali termini problematici.
Le matrici dell’intercultura
Che cos’è dunque “intercultura”? In quale contesto ha
luogo? Qual è la prospettiva di un processo interculturale?
Per rispondere a queste domande si possono sommariamente individuare alcuni assi a partire da altrettanti semplicistici luoghi comuni.
L’interculturalità non insiste sulle “culture”, ma è attenta
alla relazioni tra le persone.
L’idea che le culture siano identità rigide e univoche, non
multiple, e che i loro confini siano difficilmente modificabili, è ormai minoritaria negli studi e nel dibattito scientifico, ma non ancora nel più diffuso senso comune. È su
quest’idea che affondano le loro radici le visioni di tipo differenzialista, che possono andare da un multiculturalismo
tollerante, ma poco incline allo scambio culturale, fino a
vere e proprie forme di “neorazzismo culturale”, cioè fondato sulla diversità delle culture. È questo, per esempio, lo
scenario che potrebbe dar vita a quello che è stato chiamato “scontro di civiltà”.
La ricerca antropologica ha mostrato tuttavia che la questione è molto più complessa. Le culture non sono organiche e chiuse, ma passano attraverso processi di trasformazione e di adattamento. Le contraddizioni interne,
mosse dalle dinamiche sociali, inducono cambiamenti; e
il contatto con altre culture può influenzare l’evoluzione
in un certo modo, piuttosto che in un altro, può attivare
meccanismi di apertura e cambiamento, oppure meccanismi difensivi di rafforzamento identitario. In ogni caso le
culture non orientano in maniera deterministica il contatto
tra gli individui. Cultura e identità sono quindi concetti
“in divenire”, non dati una volta per tutte, continuamente aggiornabili e permeabili ad influenze “esterne”. Sono
costituzionalmente entità relazionali. Ciò non significa che
non sia essenziale cercare di capire chi si è, a cosa si crede,
come si vuole vivere; significa non accontentarsi di etichette preconfezionate e affrontare la propria esistenza consapevoli di essere sempre “in ricerca”.
Pertanto, quando utilizziamo la parola cultura in un contesto di interculturalità, osserva giustamente Marco Aime
(2004), non è corretto parlare di culture che si incontrano,
INTERCULTURA
di Lorenzo Luatti
67
AeM 64 nov. 08
ma di persone che veicolano una certa cultura e che si incontrano. L’intercultura insiste, non sui due poli – “le culture” – che sono in gioco e sulle supposte differenze degli
altri, ma sul prefisso inter, sullo spazio che sta nel mezzo,
che si colloca nel territorio dell’incontro e delle possibilità
di interazione.
Ciò nonostante la reificazione delle culture (e delle identità)
continua ad essere una tentazione molto diffusa nelle pratiche quotidiane (e in quelle scolastiche), sostanzialmente
perché le idee semplici e semplicistiche sono più popolari delle idee complesse. Un’intercultura intenta a scoprire
le culture e a cercare di afferrarle ignora questo rischio,
non accorgendosi peraltro che compie un tentativo vano.
L’obiettivo dell’approccio interculturale è dunque imparare come svolgere l’incontro e non imparare la cultura
dell’altro. Una nuova prospettiva del dialogo richiede una
comprensione interculturale che permetta di cogliere l’altro
come singolo e allo stesso tempo, come inserito nel gruppo,
libero – se lo desidera – dalla sua prigione culturale. Una
simile visione dinamica e non reificata delle culture assume
un relativismo moderato come base per cercare il difficile
equilibrio tra rispetto delle specificità e affermazione dei
principi universali (Santerini 2003). Su questo “pericolo”
insiste il documento di indirizzo ministeriale dell’ottobre
2007 sulla “via italiana” alla scuola interculturale, il quale
pone l’accento su una formazione (iniziale) degli insegnanti
che adotta un approccio multidisciplinare: antropologico,
pedagogico-didattico, sociologico, psicologico e artistico.
Lo sguardo antropologico è espressione di un curriculum
formativo che si nutre di sano “relativismo”, ovvero antidogmatismo, apertura, autocritica, disponibilità al dialogo,
capacità di uscire da sé, di disporsi all’alterità, di cogliere i
propri confini anche come limiti, di non giudicare a priori. Occorre portare questo sguardo, questa grande lezione
dell’antropologia culturale nell’intercultura, nella scuola
plurale: formare e educare ad una mente multiculturale, ad
una forma mentis interculturale, versatile, aperta all’ascolto e all’incontro, complessa, dialogica, al plurale in grado
di esprimere nuove forme culturali più fluide e composite
(Anolli 2006, p. 164; Cambi 2006).
68
L’intercultura non è un’esclusiva del
fenomeno migratorio
Da quando significativi flussi migratori hanno sempre più
interessato l’Italia, cambiando il paesaggio delle città e della società, abbiamo iniziato a definirci multiculturali. A ben
vedere, più che parlare di pluralismo culturale come un
aspetto nuovo che interessa l’Italia è più indicato parlare
di una sua maggiore visibilità e articolazione. Il pluralismo
culturale, come quello religioso, da sempre caratterizza
ogni società nel mondo, non c’è nulla di nuovo in questo.
Per cui, come è stato opportunamente osservato, «il multiculturalismo è un assunto che si basa quantomeno su un
doppio errore: che un individuo sia per così dire completamente o ampiamente sovradeterminato da una cultura,
e che le nostre società fossero (o che le società in generale
possano mai essere) monoculturali prima dell’arrivo dei
migranti» (Zoletto 2000). Semmai la presenza degli immigrati ci ha costretto a prendere atto di un pluralismo culturale interno, così come ad esempio la presenza dell’islam
ci ha costretto a prendere atto di un pluralismo religioso
preesistente alle migrazioni internazionali. L’Italia si scopre plurale e questo non è senza conseguenze.
Oggi, in questa fase, parlare di intercultura spinge a calare questo concetto ben dentro il contesto migratorio. Per
molti l’intercultura è semplicemente delegata all’incontro
tra persone provenienti da contesti geografico-statuali diversi. Del resto l’educazione interculturale, soprattutto in
Italia, è nata sotto la spinta del fenomeno dell’immigrazione. Difficile negarlo. A favorire questo “equivoco” hanno
contribuito numerosi documenti statali di indirizzo (del
Ministero della Pubblica Istruzione e del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione usciti dal 1989 in poi) che
hanno unito i due temi, intercultura e inserimento degli
alunni stranieri. Tuttavia il procedere congiunto e talvolta
confuso dei due termini può considerarsi, come è stato osservato, un punto di forza italiano, in quanto «l’orizzonte
interculturale ha contribuito, almeno in parte, a dare senso
alle pratiche quotidiane per l’integrazione e queste sono
state, a loro volta, collocate al centro di un progetto più
ampio e inclusivo» (Favaro 2007, p. 25)
Nondimeno il metodo interculturale considera la molteplicità degli stili, dei modelli, degli atteggiamenti, delle
sfumature che le componenti della società esprimono in
modo differenziato. Differenziato per classe, per genere,
per generazione, per appartenenza geografica, per appartenenza urbana o rurale, per potere contrattuale, per
letture del presente e concezioni sul futuro. L’intercultura
può fare emergere le dinamiche delle relazioni fra diverse
soggettività che interpretano i propri modelli di appartenenza in modo differenziato secondo le loro esperienze.
Fornisce abilità, conoscenze, atteggiamenti necessari a risolvere i conflitti, a lavorare in una società plurale, ad analizzare i propri valori culturali, promuovendo la tolleranza,
il rispetto e la comprensione reciproca, l’apertura verso gli
altri. Dunque, intercultura non solo a scuola e nel mondo
dell’educazione, ma sfida professionale e umana da vivere
e rendere pratica quotidiana nei luoghi di vita e di prossimità, nei servizi per tutti, nei territori comuni, nei modi e
tempi dell’abitare insieme (Favaro 2001). Sul piano pratico, significa passare da una concezione “compensativa”
e specialistica riservata agli stranieri, ad una concezione
ordinaria e pervasiva. Occorre assumere e praticare l’interculturalità come normalità e, come viene spesso ripetuto,
sfondo integratore.
L’intercultura non è mai rinuncia, censura,
negazione, impoverimento
L’impulso all’interculturalità non deve far paura perché
questa prospettiva non comporta mai una perdita di aspetti identitari importanti, in quanto la conoscenza non deve
mai significare necessariamente né adesione né condivisione di ciò che viene conosciuto. E è importante segnalare
che dove nascono conflitti, fortemente mediatizzati e dibattuti, sono spesso gli stessi autoctoni ad innescarli, erigendosi a difensori della “diversità”, come nel caso della
questione della presenza del crocefisso o del presepe in
classe. Esempi, questi ultimi, di infauste iniziative di singoli insegnanti italiani, del tutto ignari che il pluralismo e
l’intercultura non funzionano per sottrazione, ma semmai
per addizione e per sintesi.
Non c’è intercultura senza dialogo,
non c’è dialogo che non sia interculturale
I due termini, per quanto sempre più abusati, presentano
un’evidente correlazione. Nella sua accezione l’intercultu-
ralità è un concetto che si lega a quello di dialogo, pace,
convivenza possibile e si contrappone ad altri concetti
come scontro di civiltà, integralismo, guerre etniche, razzismo e xenofobia etc. Il dialogo è interculturale o non è.
Affinché esso sia fecondo e autentico occorrono tuttavia
alcune condizioni preliminari: la centralità dell’alterità e
della relazione, che comportano come portati ineliminabili
la disposizione interiore all’accoglienza della differenza, la
reciprocità, l’interiorizzazione della proprio non-assolutezza e della non indiscutibilità delle proprie istanze, dando
luogo a atteggiamenti di accoglienza, empatia, apertura,
tolleranza, rispetto. Il dialogo quindi prevede una sana posizione di relativismo e laicità, che passa attraverso il riconoscimento di valori fondamentali, quali il pluralismo, la
libertà e la democrazia, condizione propedeutica per la costruzione di un dialogo interculturale. Elementi costitutivi
e strutturali sono l’intenzionalità, il prefisso inter- di intercultura, l’empatia, il decentramento, la transitività cognitiva e una intrinseca politicità. In questo senso, concordiamo con Franco Cambi quando considera l’intercultura una
“sfida” della pedagogia odierna: «L’unione dei principi del
pluralismo, della differenza e del dialogo viene a produrre
così una frontiera avanzata del pedagogico, che è anche
una frontiera in movimento e che costituisce l’elemento
chiave della sfida dell’intercultura, anche in pedagogia”»
(Cambi 2001).
La dimensione politica del dialogo interculturale
Come si è detto la cultura è plurale in quanto presenta
molteplici voci e non è una neanche nel singolo individuo
(multiculturale lui stesso). E’ multiculturale nel senso che
contiene in sé diversi frammenti provenienti da altri contesti. Ma è altresì interculturale perché questi frammenti
fanno sì che individui appartenenti agli stessi contesti possano agire secondo diverse modalità. La multiculturalità è
un dato di fatto, è l’insieme delle parti che compongono il
mosaico; intercultura è il metodo per prendere coscienza
di tale multiculturalità. Le relazioni per loro natura sono
dialogiche e ogni relazione dialettica presume una serie di
aggiustamenti. L’interagire produce compromessi perché
la relazione significa anche la ricerca di un’accettazione
reciproca. Allora diviene interessante capire come avvengono questi aggiustamenti o questi compromessi, come
avviene questa ricerca dell’accettazione reciproca, vale a
dire in modo negoziato, conflittuale, dialettico. Avviene
con grande difficoltà quando le soggettività interagiscono
all’interno di una relazione asimmetrica. E di fatto, l’intercultura non può trascurare che i rapporti avvengono
spesso in forma asimmetrica tra i soggetti della relazione.
In questo senso, l’intercultura è espressione di rapporti di
potere e il carattere politico diventa parte del dialogo interculturale nel suo essere necessariamente dialogo tra persone che si incontrano e si mettono in discussione. Si pensi
ad esempio ai rapporti tra immigrati e società di approdo,
dove i primi occupano una posizione in netto svantaggio e
hanno minori possibilità di incidere nella relazione stessa.
La retorica dell’interculturalità basata sulla valorizzazione
delle differenze, che parte dall’idea che ci sono culture che
entrano in contatto, non è sostenibile all’interno di un sistema concreto di relazioni asimmetriche. Ma è anche un
approccio complessivo e trasversale ad ogni aspetto della
società, dalle relazioni interpersonali agli assetti di potere.
Laboratorio
di
espressione
artistica.
Calderara di
Reno giugno
2008. Foto di
Gail Pomare
69
AeM 64 nov. 08
Vincent
Rioux,
Aubervilliers
vu d’un vèlo,
“Aubervilliers,
portraits
sensibles”,
agosto 2008
© Michel
Pichon
Dal dialogo proclamato al dialogo praticato
Per un corretto dialogo interculturale occorrerà dunque
evitare letture ideologiche e metafisiche dell’altro. In primo luogo bisognerà riconoscere che a dialogare non sono
entità astratte (le culture), ma uomini e donne con storie,
vissuti, sofferenze, speranze proprie, peculiari e irripetibili.
Creare e favorire occasioni di incontro in luoghi e spazi
che favoriscano il contatto effettivo, l’ascolto reciproco, la
narrazione altrui, ma anche valorizzare esperienze e testimonianze vissute in un dialogo fecondo possono aiutare
senz’altro il percorso. Così partire dagli elementi che ci
accomunano piuttosto che da quelli che ci dividono è una
buona indicazione di metodo.
Il dialogo interculturale non è un’attività riservata agli
specialisti, ma coinvolge tutti, e tutti sono chiamati a praticarlo. Ognuno ne è protagonista e non può limitarsi a
ricoprire il semplice ruolo di teorizzatore. Certo è che per
una reciproca conoscenza ci vuole del tempo. Il cammino
potrà rivelarsi complesso e accidentato. Occorrono umiltà
e mitezza nell’affrontare il dialogo interculturale: l’umiltà
di chi sa che non ha mai tutta la verità e la mitezza di chi
cerca di capire quanto di positivo c’è negli altri prima di
condannare senza appello quello che ancora ci divide. E,
se è vero che la chiarezza evita tristi malintesi, va fatto uno
sforzo per spiegarsi meglio, raccontarsi reciprocamente,
per conoscere e evitare la paura dell’ignoto, per conoscersi
e stupirsi con piacere del valore altrui, per unire l’impegno
e contribuire ad una coesistenza, oltre che pacifica, anche
produttiva di benessere e umanità.
70
Lorenzo Luatti è ricercatore dei processi migratori e delle
relazioni interculturali. Collabora con il Centro di Documentazione Città di Arezzo e con la Ong Ucodep. È assegnista di ricerca presso l’Università di Firenze. Tra le sue
recenti pubblicazioni: Atlante della mediazione linguistico
culturale (FrancoAngeli, 2006), La città plurale. Trasformazioni urbane e servizi interculturali (EMI, 2006), Voci
migranti nella letteratura italiana per ragazzi, in «Scritture
migranti. Rivista di scambi interculturali», n. 1/2007
BIBLIOGRAFIA
M. Aime, Eccessi di culture, Einaudi, Torino 2004
L. Anolli, La mente multiculturale, Laterza, Roma-Bari
2006
F. Cambi, Incontro e dialogo. Prospettive della pedagogia
interculturale, Carocci, Roma 2006
F. Cambi, Intercultura: fondamenti pedagogici, Carocci,
Roma 2001
D. Demetrio, G. Favaro, Didattica interculturale, FrancoAngeli, Milano 2002
G. Favaro, L. Luatti, L’intercultura dalla A alla Z, FrancoAngeli, Milano 2004
G. Favaro, La “via italiana” all’integrazione interculturale,
in «Animazione sociale», n. 5, 2007, pp. 21-32
R. Panikkar, Pace e interculturalità, Jaca Book, Milano
2002
F. Pinto Minerva, L’intercultura, Laterza, Roma-Bari 2002
M. Santerini, Intercultura, La Scuola, Brescia 2003
G. Sartori, Pluralismo, multiculturalismo e estranei, Rizzoli, Milano 2000
D. Zoletto, Gli equivoci del multiculturalismo, in «Aut
Aut», n. 312, 2000
D. Zoletto, Straniero in classe. Una pedagogia dell’ospitalità, Cortina, Milano 2007
Interacció 2008: politiche locali
per l’intercultura
di Sandra Federici
I
ntellettuali di spicco impegnati in poetiche legate al
dialogo interculturale, come lo scrittore spagnolo residente tra Parigi e Marrakech Juan Goytisolo, lo scrittore e animatore teatrale polacco Krzysztof Czyzewski, e lo
studioso di teatro Dragan Klaic, originario di Belgrado e
attivo ad Amsterdam, sono stati convocati dalla Provincia
di Barcellona per l’edizione 2008 di Interacció. Dal 29 al
31 ottobre più di 500 funzionari pubblici e assessori delle
istituzioni della Catalogna ma anche del resto della Spagna
hanno partecipato a questa iniziativa biennale di aggiornamento e dibattito sulle politiche interculturali locali che
si tiene dal 1984. Quest’anno era organizzata negli spazi
del CERC (Centre d’Estudis i Recursos Culturales) e del
CCBAI (Centre de cultura contemporània de Barcelona).
Accanto agli artisti, erano presenti studiosi delle politiche
interculturali messe in campo nelle città europee, come
Bhikhu Parek, professore di teoria politica alla London
School of Economics e Alfons Martinell, direttore della
cattedra UNESCO per le Politiche culturali e la Cooperazione dell’Università di Girona.
Multi, inter, intra: ogni giorno si tenevano sessioni di presentazioni di progetti e esperienze culturali messe in campo nei comuni e dalle associazioni, nell’ambito delle quali
Africa e Mediterraneo è stata invitata a presentare il progetto di ricerca Interculture Map, realizzato nel 2005-2006
per creare una mappatura delle buone pratiche europee
suddivisa in cinque settori di intervento: Arti, Educazione,
Qualità della vita, Media, Università.
Scopo dell’iniziativa di Barcellona era riaprire il dibattito
sulla diversità e l’interculturalità, nella convinzione che la
nuova dimensione del fenomeno richiede una risposta dalle
autorità locali, per le quali è tempo di costruire un quadro
teorico e pratico che permetta di confrontare la creazione di politiche interculturali a partire dal settore culturale
degli enti pubblici. In un approccio che, trovandoci nella
regione che ha fortemente difeso la propria identità catalana nell’ambito nazionale e europeo, non riguarda solo gli
immigrati ma anche gli autoctoni.
E il dibattito nelle diverse sessioni, soprattutto quelle più
informali e ristrette dei progetti, costantemente documen-
INTERCULTURA
Barcellona 28-31 ottobre 2008
Momenti di
dialogo a
Interacció
2008,
Barcellona
© L’ Altrange
71
AeM 64 nov. 08
Momenti di
dialogo a
Interacció
2008,
Barcellona
© L’ Altrange
72
tate dalle specialissime inquadrature fotografiche
dell’artista spagnolo L’Altrange, ha fatto emergere
come sia ormai grande l’esperienza e l’impegno da
parte delle autorità locali, che sono state le prime
ad affrontare nella pratica il bisogno di integrazione
espresso dalle piccole società territoriali che sempre
più andavano modificandosi. Nelle discussioni è
emerso spesso un forte bisogno da parte dei funzionari di migliorare le proprie performance nella
organizzazione di eventi culturali e sociali e il senso
di frustrazione per quando, nonostante l’impegno
la partecipazione del pubblico, e in particolare dei
migranti, è scarsa.
Guy Saëz, direttore di ricerca a Grenoble, ha ripercorso l’evoluzione del modello francese di cultura
moderna, a partire dalla prima fase in cui la cultura
è stata chiamata a essere protagonista delle tappe
della costruzione nazionale, ad assicurare il prestigio della Francia all’estero e la coerenza della sua
immagine. Poi c’è stata la fase della mondializzazione delle industrie culturali, evento scioccante per
l’enormità e diversità dell’offerta da parte di queste
industrie. Infine, si è arrivati alla sfida del pluralismo
territoriale, con la crescita del “locale”, della sensibilità al patrimonio e alla memoria regionali, con le
città che sono diventati i luoghi per eccellenza della
gestione della differenza, creando reti tra territori e
stimolando la partecipazione dal basso.
Franco Bianchini, professore di Politica e pianificazione culturale alla Leeds University, ha raccontato
gli elementi strutturali delle nuove città interculturali, nelle quali sono ormai cambiati i linguaggi e le
immagini, e dove sono necessarie nuove professionalità, come il cultural cartographer, l’intercultural
mediator e il cultural planner.
Molto interessante la relazione di Ali MoussaIye, Direttore della sezione dialogo interculturale
dell’UNESCO, che ha tracciato la storia di come
questa istituzione ha affrontato questo concetto.
È partito dalla fase delle lotte per l’indipendenza
(1950-1970), quando all’UNESCO si doveva soprattutto rompere la gerarchia tra le “razze” e favorire
l’apporto di ogni popolo alla cultura mondiale (da
qui i progetti della Storia dell’Africa, dell’America
Latina, ecc.)
Ha proseguito con il periodo dagli anni ’80 al 2000,
con la fine della divisione in due del mondo e un
grande lavoro dell’UNESCO per fare comprendere le radici comuni delle diverse culture e per proteggere il patrimonio dell’umanità. E negli anni ’90
sono stati lanciati grandi progetti come “La route de
l’esclave”. Poi, l’11 settembre 2001, che ha portato
a esaltare i tratti distintivi delle culture in generalizzazioni pericolose. Si è allora voluto evidenziare che
nessuna cultura può esistere da sola, ma tutte si definiscono nel confronto reciproco, e il dialogo culturale non è conoscenza dell’Altro ma soprattutto
costruzione di una relazione. E il prodotto principale di questo periodo è stata la Dichiarazione sulla diversià culturale, per promuovere un pluralismo che
deve necessariamente accompagnare la democrazia.
Viaggio in Burkina Faso
L’esperienza della cultura africana con Sala 1 Viaggi si confronta con una nuova sfida: quella di visitare un Paese fuori
dal comune, il Burkina Faso (ex-Alto Volta), il cui nome
significa “terra degli uomini d’onore”. Sarà l’occasione per
assistere all’incontro culturale più importante per il cinema africano, la biennale FESPACO.
Creata nel 1969, questa manifestazione di rilievo internazionale anima la capitale Ouagadougou (Ouaga) di mille
iniziative.
Partner nell’organizzazione del viaggio è FITIL, un’associazione onlus italiana, che da anni porta avanti progetti
a Ouagadougou. Tramite FITIL si potranno incontrare
artisti e registi, assistere alle proiezioni dei film e visitare
luoghi interessanti nella capitale.
Il programma prevede una visita al villaggio di Sakouli (4
marzo), dove opera FITIL.
A Ouagadougou, invece, si potrà partecipare ai festeggiamenti dell’apertura del Festival, oltre a visitare il Museo
Nazionale, la Grande Mosquée, il quartiere di Paspanga,
con i suoi bar e cabaret rinomati per la musica, uno dei
maggiori vanti del Burkina, e il Grande Mercato, uno dei
più importanti dell’Africa Occidentale e che attualmente
è in fase di ristrutturazione, dopo l’incendio che lo colpì
qualche anno fa. Ovviamente da programma è prevista una
tappa al quartiere “in” di Ouagadougou, caratteristico per
le sue ville e per i suoi incontri di moda e di arte, soprattutto durante il FESPACO.
Una giornata sarà dedicata a una visita nel cuore della terra
dei Gourounsi, a Tiébélé (5 marzo), città che vanta una
mirabile architettura, arricchita da complesse decorazioni
pittoriche.
Durante gli ultimi giorni del viaggio (6 e 7 marzo) ci si sposterà nel Sud-Ovest per visitare Bobo-Dioulasso (e le zone
vicine di Dafra e Banfa), seconda città più importante del
Burkina Faso, il cui contesto geografico è particolarmente
ricco di vegetazione e di bellezze naturali: dalle cascate alle
stupefacenti formazioni rocciose. Il ritorno a Ouagadougou per gli ultimi appuntamenti e per lo shopping prima di
ripartire per l’Italia è previsto per l’8 marzo.
Per la musica sono previsti parecchi appuntamenti serali.
Ouagadougou ospita persone provenienti da tutti gli angoli del Paese e questo fa sì che ci sia un forte métissage
culturale, che emerge anche dall’offerta musicale.
Questo viaggio promette un’esperienza unica in un paese
poco conosciuto, con una cultura lontana dalla nostra, importante e affascinante.
Per info e pernottamenti: Mary Angela Schroth
Sala 1, tel. 06-7008601; [email protected]
EVENTI
in occasione della Biennale del CInema africano
“Fespaco” a Ouagadougou
Sala 1 Viaggi in collaborazione
con Nuove Esperienze e FITIL onlus,
27 febbraio – 8 marzo 2009
Timpous
(Burkina
Faso),
Senza titolo,
pubblicata
in Africa
Comics
2005-2006,
Lai-momo
2006
73
AeM 64 nov. 08
Aubervilliers, portraits sensibles
6 settembre 2008,
Aubervilliers, Villa Mais d’Ici
Una macchina fotografica per raccontare la città e un gruppo di persone intenzionate ad andare oltre gli stereotipi.
Questi i due ingredienti principali di Aubervilliers, portraits sensibles, un laboratorio di fotografia, ideato e organizzato da Afriphoto (www.afriphoto.com), progetto di
Africultures, che da tempo si muove verso la promozione
di fotografi di origine africana, perché possano esprimere
liberamente la loro creatività, facendosi conoscere.
Come ci suggerisce lo stesso titolo il luogo d’azione è Aubervilliers, periferia di Parigi, alla fine della linea 7 della
metropolitana, a un passo dalla cintura che delimita il centro urbano parigino, aldilà della linea che segna il confine
con la banlieue. Le banlieue sono solitamente identificate
attraverso immagini stereotipate che focalizzano l’attenzione unicamente sulla violenza, sulla problematicità, sul
degrado. La parola banlieue, composta da “ban”(bando)
e “lieue” (luogo) contiene in sé una connotazione negativa
che in realtà è essa stessa frutto di un’etimologia contrastante, giocata sul significato di “ban”: se nel Medioevo
esso indicava la giurisdizione, l’autorità del Signore, a partire dal XVI secolo la parola “ban” ha assunto il significato di esilio, e dunque come conseguenza la banlieue è
diventata da luogo di giurisdizione del Signore a spazio di
esclusione, fuori dal bando.
Aubervilliers, portraits sensibles è un progetto partito proprio dall’idea di lavorare con gli abitanti di uno di questi
luoghi liminali perché nella loro quotidianità immortalassero immagini aldilà degli stereotipi, offrendo la loro rapPagina a
fianco:
Michel
Pichon,
Mboka
Bisenso
(“I paesi in
movimento”
in lingua
Lingala),
“Aubervilliers,
portraits
sensibles”,
agosto 2008
© Michel
Pichon
74
presentazione “sensibile” della vita della loro città. Lungi
dalle intenzioni degli organizzatori quella di voler negare
tutte le difficoltà che possono sussistere in una realtà periferica, dall’alta percentuale di disoccupazione, alle questioni legate allo stato di abbandono da parte delle politiche municipali. Tutto questo purtroppo esiste e persiste.
L’obiettivo del laboratorio è stato, invece, quello di spostare per un momento i riflettori.
Il progetto si è svolto durante le ultime tre settimane di
agosto: sette giorni di formazione, nove partecipanti di età
diverse, quasi tutti alle prime armi, nove macchine fotografiche tra Reflex, digitali e usa e getta. La preparazione di base sulle tecniche della fotografia è stata affidata a
Harandane Dicko, fotografo maliano, assistente tecnico al
CFP di Bamako (Cadre de promotion pour la Formation
en Photographie) in residenza a Parigi all’interno di un
progetto di Cultures France.
Una volta acquisite le competenze basilari, ognuno degli
aspiranti fotografi ha identificato il soggetto del proprio reportage e ha delineato i punti su cui intendeva concentrare
il proprio lavoro di indagine “sensibile”.
Ultimata anche questa fase, i partecipanti si sono gettati
nelle strade di Aubervilliers, dilettandosi in scatti a volti,
architetture, spazi, oggetti, colori e animali.
Le foto scattate venivano poi puntualmente discusse insieme in classe insieme a Harandane Dicko e alla responsabile
di Afriphoto, Marian Nur Goni: attraverso il confronto venivano messi in luce i punti forti e quelli deboli, i dettagli
da conservare e quelli da scartare, da un punto di visto sia
tecnico che contenutistico.
Al termine dei sette incontri ognuno di loro è stato in grado di realizzare un montaggio delle immagini, con musiche
e parole scelte in modo da rafforzare il messaggio alla base
del loro lavoro.
Il risultato: 9 diaporama che affrontano diversi temi attraverso altrettanti diversi approcci. C’è chi si è concentrato
sulla vitalità di Aubervilliers ritraendo i volti della gente
per strada, chi ha privilegiato i colori dei mercati e dei negozi “afro-francesi”, chi ha immortalato le architetture più
svariate, chi si è concentrato sui movimenti della gente attorno a un incrocio di 2 strade, in una visione bergsoniana
dell’esistenza.
Stando ai commenti degli organizzatori dell’evento il punto saliente dell’esperienza è stato il valore umano dell’esperienza, tanto per la partecipazione attiva e coinvolgente degli aspiranti fotografi, tanto per l’impatto che ha avuto sul
pubblico e sull’amministrazione locale di Aubervilliers.
Realizzato in partenariato con Ethnoart, Achromatik e la
Villa Mais d’Ici, con il sostegno di Via le monde e della
Préfecture de la Seine-Saint-Denis il progetto Aubervilliers, portraits sensibles ha restituito la parola, anzi l’obiettivo, a chi la realtà della periferia la vive ogni giorno, con
le sue difficoltà, ma anche con tutti i suoi aspetti positivi
e umani.
Elisabetta Degli Esposti Merli
75
AeM 64 nov. 08
LIBRI
76
V.Y. Mudimbe,
Cheminements.
Carnets de Berlin
(Avril-Juin 1999),
Humanitas, Québec
2006, pp. 223
Voici un livre qui, pour plus d’une
raison, ne manquera d’intéresser ceux
qui suivent le déploiement de l’œuvre
et de la pensée de V.Y. Mudimbe. En
effet, Cheminements. Carnets de Berlin a d’abord ceci de particulier: c’est
le troisième livre écrit en français depuis l’établissement de V.Y. Mudimbe
aux États-Unis, le premier étant Shaba
deux. Les carnets de Mère Marie-Gertrude (1989) et le deuxième, son autobiographie intellectuelle, Les corps glorieux des mots et des êtres (1994). On
peut ainsi noter que les trois ouvrages
francophones de la période américaine de Mudimbe exploitent, chacun à
sa manière, le principe du carnet ou
du journal personnel, lequel traverse,
de part en part, l’œuvre de l’écrivain
et penseur congolais. On le retrouve,
en effet, au cœur de l’écriture de Entre les eaux (1973), de L’écart (1979)
et, dans une moindre mesure du Bel
immonde (1976), sans oublier Carnets
d’Amérique (1976). La permanence
de ce fil témoigne du fait que l’œuvre
de V.Y. Mudimbe est sous-tendue par
une quête jamais achevée, toujours
recommencée: la quête de l’être qui
semble avoir trouvé dans la littérature, mieux encore, dans l’écriture, son
lieu par excellence d’épreuve ou d’approfondissement. L’écriture, dont le
propre est d’être une traversée dévorante et jubilante des cultures et des
territoires, est véritablement ici le lieu
d’attache tant désiré – celui où l’on
fait racine, où l’on met pousses, où
l’on creuse ses tombes, ses visages, ses
origines, ses légendes, ses angoisses
et ses déchirements intérieurs, pour
s’ouvrir à tous les courants culturels
du monde, c’est-à-dire à l’universel.
Car, comme il l’écrit dans L’Autre face
du Royaume, «l’universalité ne peut
exister qu’à partir d’une expérience
critique et permanente d’une authenticité singulière » (1973, p. 136). Cette
dynamique était déjà annoncée dans
Réflexions sur la vie quotidienne où
Mudimbe écrit:
«J’ai voulu naguère m’établir dans
la grâce de la pensée et, depuis lors,
m’enroule dans une fascination permanente dont l’insanité essentielle
est la prétention à tout démontrer, à
tout comprendre en déstructurant, à
tout ramener au tribunal de l’esprit.
Mais les banalités comme les mystères les plus profonds de la vie sont
des énigmes. De s’y appesantir ne les
change pas, peut-être en éclaire-t-on
la complexité!» (1971, p. 5)
Éclairer la complexité des situations
apparemment les plus simples, les
plus banales de la vie quotidienne,
ces situations à travers lesquelles l’être
humain se révèle à soi-même à la fois
comme liberté et comme produit d’un
temps, d’une époque donnée, c’està-dire comme produit-producteur
de son époque, telle est justement la
tâche à laquelle s’atèle Mudimbe dans
ses carnets berlinois dont le ton, le
style alerte et l’érudition ne sont pas
sans rappeler les Carnets d’Amérique
(1975).
L’autre intérêt de Cheminements. Carnets de Berlin réside dans le fait qu’il
nous fait entrer dans la fabrique mudimbienne des idées pour prendre la
mesure de la patience, de l’ascèse et de
la solitude nécessaires au jaillissement
de la parole ou du discours. Pour parodier un titre de Martin Heidegger,
je dirai que Cheminements. Carnets
de Berlin nous donne à suivre, en
certaines de ses modulations, l’acheminement mudimbien vers la parole
ou le discours public. On voit en effet
comment, dans la solitude qui est ici
figure de l’écart, le philosophe prépare ses conférences ou ses séminaires
sur des thèmes aussi divers que Les
règles de perfection de saint Benoît de
Nursie, Saint Bernard de Clairvaux et
Saint Ignace de Loyola (pp. 24-25),
«les conflits d’interprétation dans un
monde interculturaliste » (pp. 67-69),
sur le paradoxe des études subalternes
en leur générosité politique et contradictions logiques (pp. 190-195), ou
encore, sur les paradoxes de la globalisation économique et technologique
(pp. 215-216).
Bref, en ce livre à la fois dense et léger se révèle la manière dont la pensée
mudimbienne se nourrit de la lecture
du monde comme texte soumis à notre jugement et responsabilité, et de
l’étonnement face à l’apparente banalité du quotidien, pour s’élever dans les
cimes de la méditation la plus pointue
sur le destin de l’homme et le devenir
du monde, mettant au grand jour des
liens inattendus entre des univers de
pensée apparemment inconciliables.
Ainsi ce passage, caractéristique du
style de pensée de V.Y. Mudimbe, où
le philosophe allemand Martin Heidegger semble tendre la main à Saint
Benoît:
«Avant de m’arrêter, une note sur
mon état mental: malgré l’exigence de mon attention soutenue pour
cette lecture [de In Shadow of Hegel:
Complementarity, history, and the
unconscious d’Arkady Plotnitsky],
impression d’avoir vécu et compris
enfin un point de Heidegger : la
pensée attente. Elle est négation de
toute irruption. En fait, elle n’attend
rien. Me dire, ce soir et peut-être le
reste de ma vie, je n’attends rien, absolument rien. La négation absolue.
Saint Benoît l’avait comprise, avant
le philosophe allemand. Heureux,
cependant, d’en vivre en mon cheminement. Quels aigles, ces hommes!
Voilà, je les confonds : Benedetto et
Heidegger. Qui l’aurait cru?» (2006,
p. 79)
Ainsi va ce livre, ouvrant ici et là des
chemins qui, tout en évoquant, peutêtre ironiquement, les Howledge heideggeriens, font aussi penser à la belle
métaphore cartésienne du voyageur
égaré dans une forêt, celle des livres et
des idées, mais aussi celle d’un monde où l’hybris démoniaque nous fait
ériger des murs des séparations culturelles, linguistiques, raciales, entre des
humains qui sont pourtant, en ce qui
constitue leur humanité, fondamentalement solidaires. Ce qui s’impose
à ce voyageur, c’est le cheminement,
la patience ou l’endurance dans le
questionnement de soi et du monde,
et dans la recherche des liens ou des
ponts entre les choses, les êtres, les
mondes, les cultures et les races; la
tentative en somme de reconfigurer le
monde dans son interculturalité.
Dans l’impossibilité de faire un résumé
de ce livre, qui est véritablement une
bibliothèque où de multiples entrées
renvoient à tous les savoirs marginaux
et institués, et offrent au lecteur la
possibilité d’un cheminement personnel, je peux, au moins, attirer l’attention sur une leçon qui s’en dégage,
avec des résonances insidieusement
politiques en notre monde où sévit
l’évidence banale de la tragédie des
frontières. Cette leçon profondément
LIBRI
humaniste s’exprime en une phrase
qui clôt une conversation de l’auteur
avec deux intellectuels de Brazzaville
sur les frontières coloniales: «Il n’y a
pas de frontière qui vaille une vie humaine, quelle qu’elle soit» (p. 167). Et
en une autre phrase qu’on peut lire
comme un complément, Mudimbe
ajoute: «Réussir en histoire, pour le
bien ou pour le mal, semble toujours
avoir eu une constante, un préalable:
“manger” les frontières» (p. 171). De
là une conviction qui pourrait laisser
d’aucuns pantois: «Conviction: que
comme entité politique, le Congo se
désintègre demain me laisse, au total,
relativement froid, si son éclatement
est condition d’une constitution progressive d’un plus grand ensemble.»
Et il ajoute:
«On a ri du rêve de Cheikh Anta
Diop pour la création d’un État
fédéral en Afrique. L’on avait tort. Il
n’avait peut-être pas un bon sens de
mesure en beaucoup de choses, mais
on ne peut lui dénier un sens aigu,
une saine vision pour un avenir plus
raisonnable, en tout cas plus viable pour les républiques d’Afrique
noire. Ouvrir, donc, les frontières à
une libre circulation des biens et des
personnes; vouloir une cité nouvelle,
démocratique, et surtout plus fraternelle.» (p. 170)
Dans ce même registre de remise en
question des frontières, Mudimbe
montre «l’incohérence des adjectifs
des classifications raciales et ethniques» aux États-Unis et dénonce ce
qu’ils «disent à propos de la culture
et de la société américaine» (p. 120),
à savoir son incapacité d’assumer sa
diversité et de se défaire des «préconceptions, préjugés et intolérances des
chapelles» qui favorisent ce que certains, incapables de voir les liens entre
les peuples et les cultures, on a appelé
«le choc des cultures».
C’est en fin de compte la vision d’un
monde sans frontière, un monde dans
lequel le sujet pourrait se dire citoyen du monde, c’est-à-dire irréductible ni à une race ou une nation, ni
même à une classe, que réfléchissent
son écriture et sa pensée transversale,
en constant exil des repères de la raison grammairienne ou classificatrice
héritée des Lumières. En effet, Cheminements, Carnets de Berlin crée un
univers où la lecture comme figure de
l’activité intellectuelle consiste à établir des liens, à chercher des lieux de
jonction entre des réalités apparemment sans rapport comme le capitalisme et le multiculturalisme. N’est-ce
pas en ce sens même que Mudimbe
peut s’approprier les vers de Chavez:
«Los que están mirando (leyendo) /
(…) Nos dicen el camino [ceux qui regardent (lisent)/ indiquent le chemin]
(p. 129), celui d’un monde plus vivable, plus fraternel. Ou encore ce court
poème de Gina Valdés suggérant que
les frontières ne devraient jamais avoir
le dernier mot:
Freddy
Tsimba, Elles
viennent de
loin, Dak’art
2008 Afrique:
mirroir?
Photo by
Iside Ceroni
Somos una gente
Hay tantisimas fronteras
Que dividen a la gente,
Pero por cada frontera
Existe también un puente (p. 123)
Nous sommes un peuple
Il y a tant de frontières
Qui divisent le peuple
Mais pour chaque frontière
Il y a un pont.
Somme toute, en ce livre dense et léger,
se réfléchit l’état de notre monde avec
ses blessures et ses absurdités (le nazi-
77
AeM 64 nov. 08
sme, l’esclavage, le racisme, les guerres), ses craintes, mais aussi ses espoirs
et ses promesses. C’est l’ouvrage d’un
homme profondément à l’écoute de
son époque et des mouvements intellectuels, culturels et spirituels qui la
constituent, et essayant d’en éclairer la
complexité par la lecture/écriture et la
méditation. En fait une manière toute
personnelle de répondre à la question
kantienne: Comment s’orienter dans
la pensée?, ou, sous sa reformulation
heideggerienne: Qu’appelle-t-on penser? Dans notre monde d’aujourd’hui,
semble-t-il nous dire, penser c’est
moins classifier, hiérarchiser, séparer
en enfermant les êtres et choses dans
des catégories réductrices, que jeter
des ponts entre l’Afrique, l’Amérique,
l’Asie et l’Europe. Après la chute du
Mur de Berlin, qu’il faut éviter de
déplacer en l’érigeant ailleurs (entre
l’Occident et l’Afrique, par exemple),
notre survie dépend, comme le suggère Edward Said à la fin de Culture
et impérialisme, de la conscience des
liaisons entre les choses.
Kasereka Kavwahirehi
Université d’Ottawa
Bibliographie
V.Y. Mudimbe, Réflexions sur la vie
quotidienne, Mont Noir, Kinshasa
1971
V.Y. Mudimbe, Entre les eaux, Présence Africaine, Paris 1973
V.Y. Mudimbe, L’Autre face du Royaume. Une introduction à la critique
des langages en folie, L’Âge d’homme,
Lausanne 1973
V.Y. Mudimbe, Carnets d’Amérique,
Saint-Germain-des-Prés, Paris 1976
V.Y. Mudimbe, Le bel immonde, Présence africaine, Paris 1976
V.Y. Mudimbe, L’écart, Présence africaine, Paris 1979
V.Y. Mudimbe, Les corps glorieux des
mots et des êtres. Esquisse d’un jardin
africain à la bénédictine, Humanitas/
Présence africaine, Montréal/Paris
1994
José Eduardo Agualusa,
Il venditore di passati,
LaNuovaFrontiera,
Roma 2008
pp. 137, euro 15,00
78
Quante persone dal passato tormentato o infangato da vicende oscure
vorrebbero mettere tutto nel dimenticatoio per poter riscrivere la propria
storia? Certo una soluzione potrebbe
essere quella di fuggire in un altro Paese per ricominciare da capo, ma cosa
raccontare a chi pone domande su ciò
che si è stati?
Il rimedio ce lo propone José Eduardo
Agualusa. Nel suo romanzo Il venditore di passati avere un passato nuovo di
zecca è molto facile: basta incontrare
Felix Ventura, un uomo che ha fatto
dell’invenzione del passato un mestiere. «Assicuri ai suoi figli un passato
migliore», dice in tono accattivante il
suo biglietto da visita, una frase che
attira nella casa di questo particolare
genealogista numerosi personaggi alla
ricerca di un nuovo albero genealogico dal quale trarre una nuova linfa
vitale. Ventura offre ai suoi avventori
passati strepitosi, sensazionali, costellati di antenati nella maggior parte dei
casi illustri.
Con una scrittura fluida e arricchita
da sprizzi di humor sottile Agualusa
ci fa riflettere sul concetto di passato
sotto diversi punti di vista, attraverso
diversi personaggi di un Angola contemporanea. In primis attraverso il
tema della reincarnazione, fenomeno
che nel passaggio da una vita all’altra
lascia ricordi e reminescenze velate,
anche se si tratta di una transazione da
un’esistenza umana a una animale.
Il passato poi viene rappresentato
come un qualcosa che porta con sé
conti da regolare, situazioni mai chiarite e che, lasciate in sospeso, incombono sulla quotidianità dell’esistenza.
Messo sotto un’altra luce ancora, il
passato poi veste i panni della consolazione, di una sorta di rifugio fatto di
momenti che alleviano le ansie quotidiane: questo aspetto però non sempre si attiene alla realtà, ma è il frutto
della trasposizione di ciò che è stato
detto e raccontato da altri. In questo
modo diventa ricordo pur non essendo mai stato vissuto, ma non per questo risulta meno efficace il suo effetto
su un animo in cerca di conforto.
E da questo spunto Agualusa sviluppa
il concetto di passato come invenzione, che può diventare realtà, se chi se
ne impossessa ci crede così tanto da
farlo diventare vero.
Autore di numerosi romanzi molto
amati dal pubblico di lingua portoghese, Josè Eduardo Agualusa è giornalista e editore. Nato in Angola, oggi
vive tra il Portogallo, il Brasile e la sua
terra natale.
Il venditore di passati di recente ha
vinto l’Independent Foreign Fiction
prize, un importante premio che viene assegnato ogni anno al migliore
romanzo straniero pubblicato in Inghilterra.
Elisabetta Degli Esposti Merli
Fabrizio Gatti,
Bilal. Il mio viaggio da
infiltrato nel mercato
dei nuovi schiavi,
Rizzoli, RCS Libri
Milano 2007,
pp. 504, euro 18,50
Il rischio che il clima di tensione alimentato dalla preoccupazione per
quella che a livello mediatico viene
definita “emergenza immigrazione”
scateni reazioni preoccupanti diventa
ogni giorno più reale.
E è per questa ragione che si fa strada
la necessità di confrontarsi, di capire,
di riflettere, perché il processo che
porta a elaborare idee al limite della
xenofobia si nutre di emozioni e pregiudizi che si insinuano con pericolosa
facilità tra le pieghe delle insicurezze
della società moderna.
Fortuna vuole che esistano diverse
persone che nel quotidiano si battono
per far circolare informazioni che si
basano su un’analisi dello stato delle
cose che va oltre l’istituzionalità. Tra
questi il giornalista e inviato del settimanale «L’Espresso» Fabrizio Gatti,
conosciuto per aver fatto numerose
indagini “sotto copertura”.
Bilal. Il mio viaggio da infiltrato nel
mercato dei nuovi schiavi concentra in
poco più di 500 pagine il frutto delle
indagini che il giornalista ha affrontato, con la ferma intenzione di scoprire
cosa avviene lungo l’iter che migliaia
di individui percorrono dal continente
africano fino alle coste italiane. Ha seguito i “candidati all’immigrazione”,
questi nuovi schiavi di una tratta che è
gestita da una intricata e corrotta rete
di mediatori, contrabbandieri, forze
dell’ordine, trafficanti ed esercito. Ma
non solo: la sua indagine si è spinta oltre all’arrivo in Europa, proseguendo
fino ai luoghi di lavoro in cui i nuovi
immigrati vengono reclutati e denunciando una serie di situazioni in cui il
rispetto dei minimi diritti umani è un
optional.
Un viaggio dall’interno, raccontato
con quell’agghiacciante schiettezza che
può scaturire solo da chi quell’esperienza l’ha provata in prima persona,
anche se sotto mentite spoglie. Gatti,
partendo dal Senegal, è arrivato fino
in Libia, attraversando con i migranti
il deserto del Niger su camion carichi
al limite del sostenibile e subendo con
loro controlli e violenze da parte di polizia e militari. Il reporter inizia il suo
viaggio come semplice turista italiano
intenzionato ad affrontare il deserto,
all’avventura, su rotte e con mezzi che
nessuna agenzia di viaggio metterebbe
mai nel proprio pacchetto.
Bloccato sul confine con la Libia (le
cose che avrebbe visto sarebbero state
troppo scomode per il governo del colonnello Gheddafi) e non potendo da
lì imbarcarsi per l’Italia, Gatti si è fatto
ripescare a pochi metri dalle coste di
Lampedusa. E da qui prende via la se-
conda parte della testimonianza: il corpo tratto in salvo assume le generalità
di Bilal, clandestino di origine curda.
Bilal è uno degli immigrati che riescono a superare il calvario della traversata, per i quali tuttavia le sofferenze e
le ingiustizie non conoscono ancora
tregua. Prima i Centri di permanenza
temporanea, luoghi di detenzione al
di fuori del diritto e di ogni concezione di umanità e, poi risparmiati dal
rimpatrio, attraverso un foglio di via,
ecco che al di fuori del CPT li aspetta
la clandestinità e il lavoro in nero, nei
cantieri o nei campi.
Una condizione che difficilmente
si può chiamare vita: costretti a nascondersi, ad accettare condizioni di
lavoro lontano anni luce da ciò che si
definisce diritto del lavoratore e costantemente in bilico tra l’espulsione
e la permanenza sul territorio.
Attraverso gli occhi di Gatti/Bilal,
attraverso i racconti delle persone
che incontra lungo il viaggio ci viene
dipinta una situazione che va oltre le
informazioni dei notiziari. Ci svela
trame politiche e giochi di potere che
tanto in Africa quanto in Italia continuano ad alimentare i processi di immigrazione clandestina.
Il libro è stato insignito del Premio letterario Tiziano Terzani, proprio per la
sua propensione a far riflettere il lettore aldilà di quali siano le sue opinioni
riguardo all’immigrazione e oltre l’attribuzione di colpe e responsabilità.
Non si può trovare una soluzione al
dramma dell’immigrazione clandestina, nemmeno dopo aver letto un libro
del genere. Ma se non altro si può attribuire a Bilal il merito di suscitare il
dibattito e la discussione.
Elisabetta Degli Esposti Merli
Pedro F. Miguel,
Muxima,
Sintesi epistemologica
di filosofia africana,
Edizioni Associate,
Roma 2002,
pp. 143, euro 12
“C’è uno scultore africano che si diverte a fare delle marionette in cui il
nero viene rappresentato con le orecchie grandi e la bocca piccola, mentre
il bianco appare con la bocca grande e
le orecchie piccole…”.
Sono parole dell’autore di questo libro
e il senso delle quali ci viene raccontato anche da Karen Blixen nel suo romanzo autobiografico La mia Africa,
così: «Si è perduta l’arte dell’ascoltare
in Europa. Gli africani la posseggono
ancora perché non sanno leggere. Appena principi a dire: - un tale camminava nella pianura e incontrò un altro
-, subito pendono dalle tue labbra, subito la loro fantasia insegue con slancio la pista sconosciuta dei due uomini sulla pianura. Ma i bianchi non
son più capaci di prestare orecchio a
un racconto, nemmeno se sentono che
è loro dovere. Divengono irrequieti,
si ricordano di mille incombenze da
sbrigare proprio in quel momento. Le
stesse persone, invece, son capaci (…)
di trascorrere tutta la sera immersi nella lettura di un qualsiasi pezzo di carta
stampata (…) È l’abitudine di cogliere
le cose solo con gli occhi».
Dunque l’Africa ascolta. Volentieri.
Questo è a mio avviso il contesto o
il sottofondo in cui si muove Miguel
in Muxima. Un utile strumento che
ci guida nella lettura di questo libro
è l’espressione Mwa lemba che significa: (andare) verso il Dio della vita. In
particolare è la preposizione Mwa che
dobbiamo portare con noi per leggere
Muxima. Mwa che significa “verso”, è
usata per indicare l’andare verso qualcosa di già conosciuto, con il quale si
ha già una relazione.
Continuando a riempire la nostra cassetta degli attrezzi, Miguel ci obbliga
a metterci anche la parola “frugare”,
toccare a tastoni nel buio. Dico ci obbliga perché è un termine ricorrente
nel suo libro. E poi ancora il termine
79
AeM 64 nov. 08
80
“passare”, nel senso di muoversi verso
la Parola Madre. E per finire con gli
strumenti è bene leggere Muxima con
un attenzione particolare alla struttura
della lingua, quella di Miguel è il Bantu Kimbundu. Il linguaggio infatti è,
proprio per la sua struttura, rivelatore del pensiero. Per fare solo qualche
esempio: per dire “io mentre taglio la
legna”, il Bantu Kimbundu utilizza
due volte il soggetto, la prima volta
per indicarne l’esistenza, la seconda
volta, la sua modificazione e diluizione nell’azione; il nostro “io ho una
casa” nelle lingue bantu diventa “io
sto con una casa” e dunque anche la
casa sta con me, espressione che evoca
“l’Essere che sta là”, il quale mette in
rapporto l’essere della casa con il mio
essere. In altre parole è la stessa struttura della lingua che ci porge insieme
il significato e un pensiero, cioè un
modo di intendere le cose della vita.
Una filosofia, dunque.
Pochi strumenti per ascoltare il racconto che Miguel ci propone di quella
che secondo lui è filosofia a tutti gli
effetti. Una narrazione che diventa
anche confronto, in certi punti serrato, con alcuni concetti fondamentali
della filosofia occidentale. Ricorrente è il riferimento al principio di non
contraddizione nella sua formulazione
aristotelica, e alla filosofia hegeliana di
cui viene sottolineato il forte astrattismo, un astrattismo che per Miguel
diventa una specie di sguardo malato
sul mondo perché la realtà anziché
essere ascoltata è in ultima analisi
raccolta nelle sue contraddizioni attraverso la verità del concetto, l’unico
elemento qualificato per raggiungere
la verità: è il razionale a essere reale. In questa visione non ascoltare il
mondo fa tutt’uno con l’impossibilità
di incontrarlo, almeno secondo il pensiero bantu. Certamente dentro queste
maglie esso non riesce ad entrare, e se
la Filosofia ha necessariamente questa
struttura allora il frugare, il passare e
il rispondere all’appello di gla, che è
il principio di continua creazione, diventano tutt’al più materiale etnologico o antropologico. Ma Miguel non si
arrende e in modo determinato porta
avanti l’idea che Muxima sia il cuore
del filosofare. Questo termine che
ricorda il lev biblico, lo traduciamo
con cuore. Cuore inteso come mente,
come luogo dove risiedono i pensieri e
le percezioni, dove vengono elaborate
domande, risposte, riflessioni e decisioni. È il cuore di cui ci ha parlato lo
stesso Agostino, africano pure lui.
Dunque una filosofia che mettendo al
centro l’ascolto e il simbolo, in qualche misura “giudica” l’astrazione e
il principio di non contraddizione.
Non per bandire la ragione da questo frugare l’arcano, ma per ridarle il
suo compito, che anche per Miguel è
quello di partire non da se stessa ma
dalla realtà, e della realtà mettere in
luce alcune delle infinite sfaccettature,
consapevole che il suo dire è sempre e
solo una preziosa ma piccola scoperta
della Verità.
Miguel non ci nasconde una sua profonda convinzione, e cioè che l’Occidente abbia profondamente bisogno
di questo sguardo sul mondo, di questo pensare che mettendosi in ascolto
della realtà, dunque anche della realtà
economica e politica, con più difficoltà
volge lo sguardo da un’altra parte.
Certo è una provocazione forte e dunque da raccogliere, ma alla quale verrebbe già quasi voglia di rispondere
che questo approccio alla realtà non
ci è completamente estraneo, che forse addirittura Kant con la Critica della
ragion pura, quando afferma che il noumeno è un concetto problematico e un
concetto limite e che tale concetto è necessario per limitare la validità oggettiva della conoscenza sensibile, in qualche misura era su una strada simile.
Sara Belotti
Jean-Philippe Stassen
Deogratias, racconto a
fumetti dal Ruanda,
Stampa Alternativa
Nuovi Equilibri,
Pavona 2005,
pp. 78, euro 12,00
Jean Philippe Stassen, autore belga
di spiccata sensibilità narrativa, nella
sua vita ha viaggiato molto e l’Africa
l’ha conosciuta con la lucidità di un
fotoreporter, munito, al contempo, di
uno sguardo radicalmente intimista.
Deogratias può considerarsi il risultato
di entrambi gli approcci narrativi: fra
il documentario e il diario personale,
questa graphic novel è ambientata in
Ruanda, subito prima e subito dopo
il genocidio del 1994 e narra la storia
di Deogratias, un ragazzino hutu che
si innamora di una ragazza tutsi. Una
vicenda d’amore adolescenziale, una
storia di guerra, una pagina di storia
africana che ha visto sparire più di
800.000 persone nel giro di un centinaio di giorni, lasciandone altre in
balia di un totale nonsense esistenziale
consumato nella quotidianità. Deogratias da questa guerra esce pazzo, privato di ogni forza in grado di liberarlo
dalla rete dei sensi di colpa e atrocità
che il conflitto etnico ha creato attorno alla sua persona e alla sua terra.
Creatura ormai al limite tra l’umano
e il bestiale, nella sua mente i ricordi
si susseguono veloci e ci raccontano
di una vita fatta di affetti e curiosità,
ma anche di profonde contraddizioni,
tali da preannunciare la catastrofe del
genocidio. La presenza disarmante
dell’istituto ecclesiastico, più che mai
influente e corrotto, la prostituzione
come unico mezzo di sopravvivenza,
la stonata curiosità del mondo occidentale, e la sua violenza, agìta più o
meno consapevolmente. E ancora, il
razzismo; radicato “da lontano”, entrato nelle scuole, insegnato e subìto.
L’interagire complicato con l’altro sesso, l’identità difficile da trovare e da
perdere. Il passato di Deogratias che
lo accompagna in flashback, la rottura
estrema che il genocidio porta nella
sua vita, fino all’ultimo viaggio autodistruttivo in nome di una vendetta
inutile, si mescolano in questo fumetto bellissimo e buio. Come buia e
marcata è la scenografia del paesaggio
magico e allo stesso modo inquietante,
che fa da sfondo a un disegno di uomini deformati, quasi eccessivi, di cui
i contorni tendono paradossalmente
a sfumare in un’oscurità totalizzante.
Sembrano emergere solo gli occhi,
spesso sconvolti. E il cielo, quando è
giorno, e le stelle.
Giulia Frattini