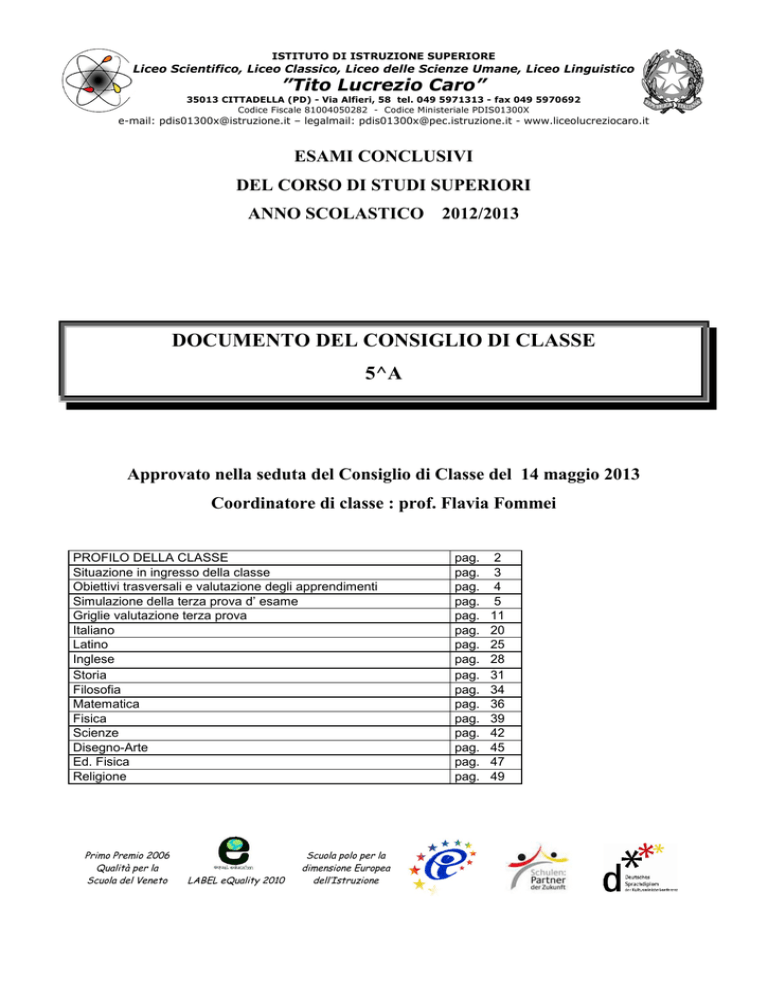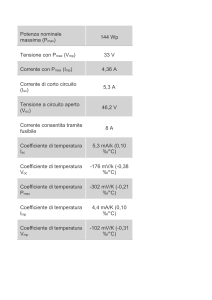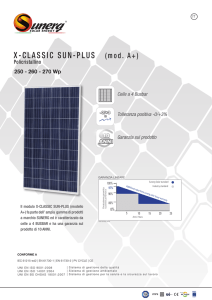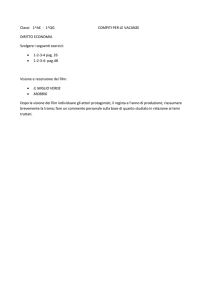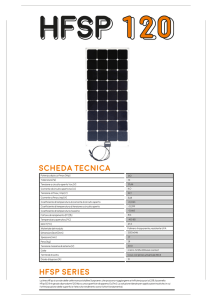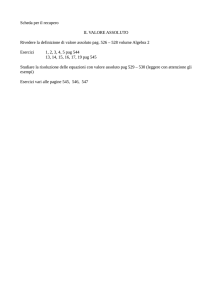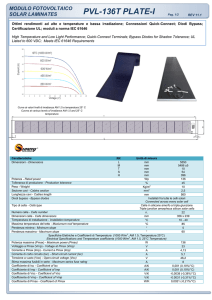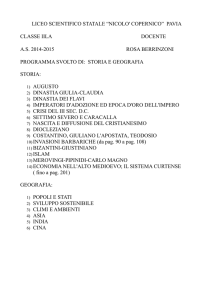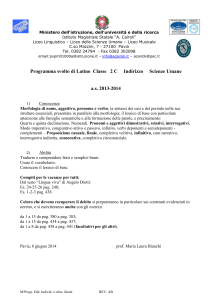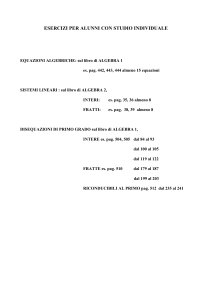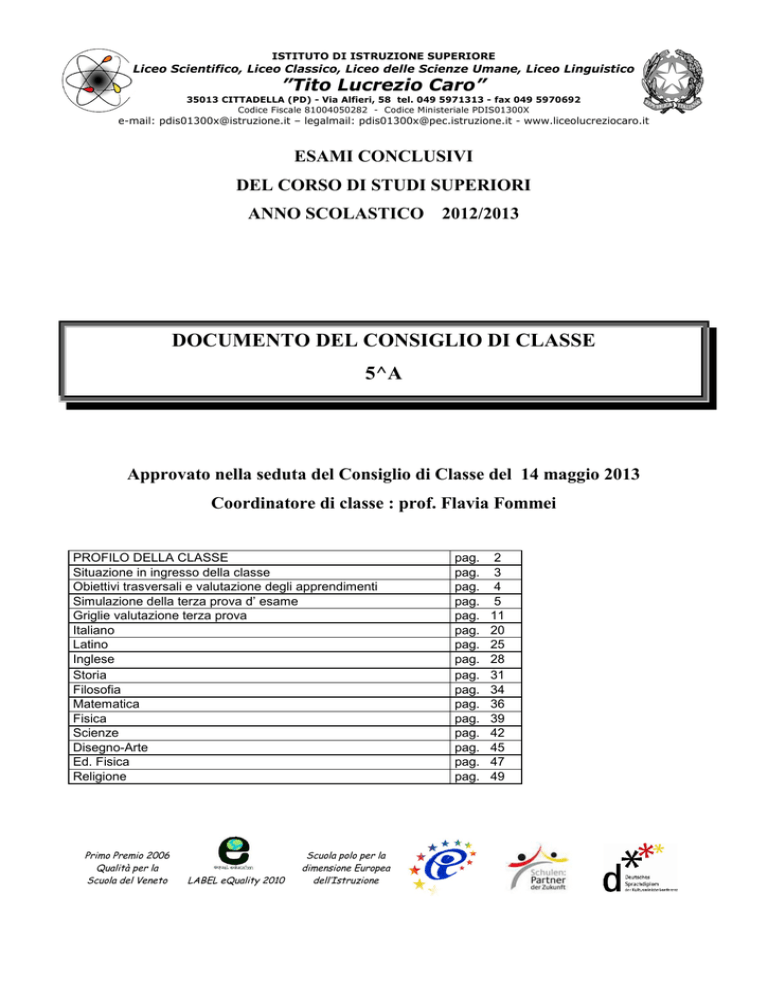
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Liceo Scientifico, Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Linguistico
”Tito Lucrezio Caro”
35013 CITTADELLA (PD) - Via Alfieri, 58 tel. 049 5971313 - fax 049 5970692
Codice Fiscale 81004050282 - Codice Ministeriale PDIS01300X
e-mail: [email protected] – legalmail: [email protected] - www.liceolucreziocaro.it
ESAMI CONCLUSIVI
DEL CORSO DI STUDI SUPERIORI
ANNO SCOLASTICO 2012/2013
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5^A
Approvato nella seduta del Consiglio di Classe del 14 maggio 2013
Coordinatore di classe : prof. Flavia Fommei
PROFILO DELLA CLASSE
Situazione in ingresso della classe
Obiettivi trasversali e valutazione degli apprendimenti
Simulazione della terza prova d’ esame
Griglie valutazione terza prova
Italiano
Latino
Inglese
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze
Disegno-Arte
Ed. Fisica
Religione
Primo Premio 2006
Qualità per la
Scuola del Veneto
LABEL eQuality 2010
Scuola polo per la
dimensione Europea
dell’Istruzione
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
2
3
4
5
11
20
25
28
31
34
36
39
42
45
47
49
PROFILO DELLA CLASSE
1.1Elenco materie e docenti
MATERIA
DOCENTE
ITALIANO – LATINO
Flavia Fommei
LINGUA LETTERATURA INGLESE
Lisa Milardo
STORIA – FILOSOFIA
Nicoletta Mazzilli
MATEMATICA – FISICA
Regina Bortignon
SCIENZE CHIMICA GEOGRAFIA
Armando Campana
DISEGNO STORIA DELL’ARTE
Mario Tuscano
EDUCAZIONE FISICA
Ugo Pasinato
RELIGIONE
Vincenzo Lasorsa
1.2
Elenco alunni
(
femmine 11, maschi 14) Totale 25
alunni
1
Aliu Enxhi
14
Lucietto Giulia
2
Battistella Francesco
15
Marcato Michele
3
Benetello Leonardo
16
Maretti Nicola
4
Berlanda Stefano
17
Pavan Giovanni
5
Bernabè Riccardo
18
Pellanda Massimiliano
6
Boscolo Carolina
19
Pitton Giulia
7
Bressan Angela
20
Pivato Giulia
8
Casale Alessandro
21
Rebeschini Erica
9
Casale Massimo
22
Sandonà Daniele
10
Dalla Libera Andrea
23
Scalco Angela
11
De Franceschi Anna
24
Sgarbossa Bianca
12
De Davide Nicola
25
Sgarbossa Elena
13
Formentin Andrea
1.3
Rappresentanti di classe studenti: Rebeschini Erica , Scalco Angela
Rappresentanti di classe genitori: Gardin Lia Vittoria
1.4
Storia della classe
CONTINUITA’ DIDATTICA
3^
LETTERE
Fommei Flavia
LINGUA E LETTERATURA INGLESE Vitturelli Daniela
STORIA – FILOSOFIA
MATEMATICA – FISICA
Mazzilli Nicoletta
Bortignon Regina
4^
Fommei Flavia
Busatto Elena (sostituita
da Iemmolo e Scapolo)
Mazzilli Nicoletta
Bortignon Regina
SCIENZE CHIMICA GEOGRAFIA
Marcon Cristina
Marcon Cristina
DISEGNO STORIA DELL’ARTE
Orlando Giuseppe Caltanella Tiziana
Mario Tuscano
EDUCAZIONE FISICA
Pasinato Ugo
Pasinato Ugo
Pasinato Ugo
RELIGIONE
Lasorsa Vincenzo
Lasorsa Vincenzo
Lasorsa Vincenzo
2
5^
Fommei Flavia
Milardo Lisa
Campana Armando
Mazzilli Nicoletta
Bortignon Regina
Alunni
iscritti
Terza
Quarta
27
28
Iscritti da
altra classe o
ripetenti
1
1
Quinta
25
0
1.5
Promossi
a giugno
18
18
Non promossi
a giugno
0
1 (ritiratosi )
Alunni con
sospensione di
giudizio
9
9
Promossi
in seconda
sessione
9
9 ( di cui 1
iscrittosi ad
altra
classe,1 ad
altra
scuola)
Commento riassuntivo
La classe ha evidenziato, fin dalla classe terza, una sostanziale disparità tra gli elementi maschili, intuitivi e
generalmente piuttosto vivaci dal punto di vista intellettivo , ma propensi, almeno all’inizio, ad affrontare le
diverse discipline con un impegno non sempre costante, e le studentesse, nel complesso, più diligenti e
disciplinate.
L’impegno degli insegnanti è stato volto, fin da subito, a favorire la presa di coscienza delle diverse potenzialità e
a far sì che modelli di riferimento diventassero gli studenti positivi tanto per il comportamento che per i risultati
conseguiti.
A riguardo, va sottolineato che la classe ha collaborato in maniera progressivamente più significativa, tanto che,
fin dalla classe quarta, è stato possibile rilevare un clima di maggiore collaborazione, certamente proficuo tanto
per gli studenti più dotati, che hanno potuto far emergere al meglio le loro capacità, quanto per i più fragili che
hanno potuto beneficiare di un clima di maggiore serenità e collaborazione reciproca.
Si può pertanto affermare che il livello di preparazione nelle diverse discipline sia complessivamente più che
sufficiente, con punte di eccellenza .
2
SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE
Risultati dello scrutinio finale della classe 4^ (alunni promossi)
Materia
Alunni promossi Alunni promossi Alunni promossi Alunni promossi di cui alunni con
con 6
con 7
con 8
con 9/10
sospensione
giudizio
Italiano
16
8
2
Latino
16
5
4
Inglese
4
5
9
9
Storia
4
10
9
4
Filosofia
13
9
3
2
Matematica
12
4
2
2
7
Fisica
14
6
4
2
1
Scienze
13
9
2
3
Disegno-Arte
1
12
13
2
Educazione
2
8
12
5
Fisica
3
1
2
del
3
INIZIATIVE COMPLEMENTARI E/O INTEGRATIVE
A) Attività a cui ha partecipato tutta la classe nel corso di quest’anno scolastico:
visite d’istruzione a Madrid;
visione dello spettacolo teatrale “ Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello;
conferenza promossa dall’A.I.R.C sulla prevenzione dei tumori;
partecipazione alle Olimpiadi di Fisica ( L’alunno Casale Massimo si è qualificato per la fase provinciale);
corso di Matematica in preparazione alla seconda prova d’esame;
mostra sulla scuola fascista in occasione della giornata della memoria;
conferenza da parte dell’associazione AVIS a proposito della donazione del sangue;
incontro con l’associazione AIDO
B) Attività a cui ha partecipato parte della classe
Conseguimento nel quarto anno del “First certificate” ;
Attività di orientamento in uscita: giornate dell’orientamento presso l’Università di Padova e altri Atenei;
corso di logica ALPHATEST 12;
corso di preparazione ai test universitari tenuto dal prof . Campana;
Attività di educazione alla salute ( gli studenti hanno avuto la possibilità di incontrare un andrologo);
partecipazione al “Festival della scienza” di Genova;
ciclo di conferenze del progetto “Ripensare i saperi” in quarta:
Incontri sulla Bioetica;
progetto Comenius EUPLAY;
donazione del sangue da parte di alcuni studenti a seguito dell’incontro con l’associazione Avis
Progetto di alternanza scuola-lavoro: azione a) Bilancio di competenze per studenti del quinto anno con il Dott. Angelo
Boccato
Progetto di alternanza scuola- lavoro(rete Liceo “Cornaro”): azione2) “communication skills”, ovvero come redigere un
approfondimento e parlare in pubblico
OBIETTIVI TRASVERSALI
obiettivi educativi
q motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel prepararsi all’Esame di
Stato
q capacità di instaurare efficaci rapporti interpersonali in ambito sociale e lavorativo
q consapevolezza delle proprie aspirazioni e attitudini al fine dell’inserimento nel mondo del
lavoro o per il proseguimento degli studi
obiettivi didattici
q potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi
q riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline, allo scopo di raggiungere
l’unitarietà dei saperi
q approfondire la connessione tra cultura umanistica e sviluppo dei metodi critici e di
conoscenza propri della cultura scientifica
q fare propria una flessibilità mentale da tradurre sia nella capacità di affrontare nuovi
problemi che nella capacità di sapersi rapportare alla realtà in cui si opera
4
5 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
5.1
Criteri adottati
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento al POF e per quelli specifici relativi ad ogni disciplina si
rimanda ai criteri approvati dai singoli dipartimenti e alle relazioni finali dei docenti.
5.2
Numero di verifiche effettuate nell'anno scolastico e tipologie di prove
Materia
Interrogazioni
(n.
medio
Compiti
scritti Compiti
per (tema, analisi del (problemi,
studente)
testo,
saggio esercizi)
scritti Prova
casi strutturata/
semistrutturata
breve ecc)
o pratica
1
Simulazione
delle
d’esame
Italiano
4
5
Latino
4
5
1
Inglese
4
3
3
Storia
2
1
2
Filosofia
2
1
1
Matematica
1
5
1
Fisica
2
1
2
3
1
Scienze
3
3
2
Disegno-Arte
3
2
2
Ed. Fisica
Religione
6
7.1
prove
6
2
SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D'ESAME
La struttura della prova
Sono qui di seguito riportati i criteri generali per lo svolgimento delle simulazioni di terza prova scritta :
•
Numero di simulazioni per l'intero anno scolastico :
•
Periodi di effettuazione: Novembre, Febbraio e Aprile
•
Durata della prova: 3 ore
•
Numero di materie: 4 discipline
•
Tipologia dei quesiti: tipologia B, a risposta aperta ( Lunghezza indicativa 8-10 righe per risposta)
•
Modalità: tre quesiti per materia
•
Strumenti utilizzabili: dizionari mono e bilingue in Inglese, calcolatrice non programmabile
6.2
Prove effettuate
1DATA: Tipologia B 27-11-2012, 4 materie con tre quesiti ciascuna Fisica, Inglese, Filosofia, Storia dell’arte
2DATA: Tipologia B 23-2-2013, 4 materie con tre quesiti ciascuna Latino, Inglese, Storia e Scienze
3DATA: Tipologia B 23-4-2013, 4 materie con tre quesiti ciascuna Inglese, Storia , Storia dell’arte e Scienze.
5
6.3
Valutazione delle prove
Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie allegate.
Le simulazioni della terza prova sono state valutate in quindicesimi e sono state assunte dalle singole discipline
come uno degli elementi di valutazione quadrimestrale.
La valutazione complessiva della prova è stata ricavata dalla media dei voti dei 12 quesiti, con arrotondamento
al numero intero (es. 11.50 - 12.49 arrotondati a 12).
6.4
Risultati delle simulazioni
(Medie in quindicesimi)
<10
10-11
12-13
14-15
6
12
6
1
Seconda simulazione* 7
9
6
1
Terza Simulazione*
11
12
0
Prima simulazione
0
*due studenti assenti
Medie delle singole discipline nelle simulazioni (in quindicesimi)
Prima simulazione:
Media in quindicesimi
FILOSOFIA
10.24
FISICA
10.2
STORIA DELL’ARTE
12.72
INGLESE
9.32
Seconda simulazione:
Media in quindicesimi
LATINO
9.2
INGLESE
9.8
STORIA
11.17
SCIENZE
9.83
Terza simulazione
Media in quindicesimi
Inglese
Scienze
10.1
9.61
Storia dell’arte
13.6
Storia
11.82
6
Elenco allegati:
1
2
3
Copie delle simulazioni di terza prova d'esame somministrate;
Griglie di valutazione adoperate;
Relazioni e programmi svolti delle varie discipline.
Allegato 1: Testi terze prove
PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA:
Prova di Fisica
1) Definisci la forza elettrica tra due cariche puntiformi e il campo elettrico generato da una carica puntiforme e
descrivine le principali proprietà. Determina inoltre analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale e
campo elettrico e campo gravitazionale.
Calcola infine il rapporto tra forza elettrica e forza gravitazionale di due sfere di massa unitaria e carica unitaria poste a
1 m di distanza.
2) Definisci il flusso del campo elettrico. Enuncia il teorema di Gauss e utilizzalo per determinare modulo, direzione e
verso del campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica.
3) Definisci l’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico ed esprimi la relazione con il lavoro della forza
elettrica.
È possibile dedurre il campo elettrico dal potenziale?
Se V è il potenziale elettrico generato da una carica puntiforme su una superficie equipotenziale, quanto vale il
potenziale V1 a una distanza tre volte maggiore dalla carica?
INGLESE
Carry out the following assignments using 10 lines. You may use your dictionaries if you wish.
1. Illustrate the main features of the Romantic Poetry
2. Briefly analyse the poem London by W. Blake
3. Compare the poems London by W. Blake and Composed upon Westminster Bridge by W.
Wordsworth
London by William Blake
I wander through each chartered street,
Near where the chartered Thames does flow,
And mark in every face I meet,
Marks of weakness, marks of woe.
In every cry of every man,
In every infant's cry of fear,
In every voice, in every ban,
The mind-forged manacles I hear:
How the chimney-sweeper's cry
Every blackening church appals,
And the hapless soldier's sigh
Runs in blood down palace-walls.
But most, through midnight streets I hear
How the youthful harlot's curse
Blasts the new-born infant's tear,
And blights with plagues the marriage-hearse
7
Composed upon Westminster Bridge by W. Wordsworth
Earth has not anything to show more fair:
Dull would he be of soul who could pass by
A sight so touching in its majesty:
This City now doth, like a garment, wear
The beauty of the morning; silent, bare,
Ships, towers, domes, theatres, and temple lie
Open unto the fields, and to the sky;
All bright and glittering in the smokeless air.
Never did sun more beautifully steep
In his first splendour, valley, rock, or hill;
Ne'er saw I, never felt, a calm so deep!
The river glideth at his own sweet will:
Dear God! the very houses seem asleep;
And all that mighty heart is lying still!
Composed upon Westminster Bridge by W. Wordsworth
Earth has not anything to show more fair:
Dull would he be of soul who could pass by
A sight so touching in its majesty:
This City now doth, like a garment, wear
The beauty of the morning; silent, bare,
Ships, towers, domes, theatres, and temple lie
Open unto the fields, and to the sky;
All bright and glittering in the smokeless air.
Never did sun more beautifully steep
In his first splendour, valley, rock, or hill;
Ne'er saw I, never felt, a calm so deep!
The river glideth at his own sweet will:
Dear God! the very houses seem asleep;
And all that mighty heart is lying still!
STORIA DELL’ARTE
ANALIZZA LE TRE IMMAGINI PROPOSTE, INDICANDO:
TITOLO, AUTORE, PERIODO, TECNICA, MOVIMENTO ARTISTICO.
8
Prova di Filosofia
Domande:
1) Spiega per quali motivazioni l’etica kantiana rappresenta un’etica deontologica, formale e delle
intenzioni.
2) Cosa garantisce nella riflessione kantiana alla fisica di costituirsi come scienza
3) Spiega qual è la funzione che Kant assegna all’Io Penso.
SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA:
LATINO
1) Il “labirinto” come chiave di lettura della vicenda del Satyricon
2) Il sesso e l’ansia della morte: perché questi due temi hanno tanta importanza nel Satyricon?
3) Delinea la pluralità di generi letterari diversi che confluiscono nel Satyricon
INGLESE
Carry out the following assignments using 10 lines. You may use your dictionaries if you wish.
1. Contextualize and comment the following lines:
Ah, happy, happy boughs! That cannot shed
Your leaves, nor ever bid the spring adieu;
And, happy melodist, unwearied,
For ever piping songs for ever new;
More happy love! More happy, happy love!
For ever warm and still to be enjoyed,
For ever panting, and for ever young;
All breathing human passion far above,
That leaves a heart high-sorrowful and cloyed
A burning forehead, and a parching tongue.
2. Define the most important characteristics of the Early Victorian Novelists as opposed to Late Victorian
writers
3. Summarise the plot of Jane Eyre by C. Brontë and underline the elements that are autobiographic in
the novel
QUESITI di SCIENZE
1.
Il modello dell’interno del Sole e del suo “funzionamento” sono rappresentativi di molte stelle.
Spiegare: in quale zona del diagramma H-R si trovano le stelle simili al Sole, quanto rimarranno in
questa fase e perché, cosa determina il passaggio alla fase successiva.
2. Dopo aver esposto qual è l’idea di base della teoria dell’universo stazionario, spiegare quali dati
sperimentali hanno portato al suo abbandono negli anni ’60.
3.
Quali sono le metodologie, i campi di applicazione e i limiti dei metodi usati per determinare le
distanze in astronomia.
9
STORIA
Domande:
1) Durante il primo conflitto mondiale quando e per quali motivazioni gli Stati Uniti entrano in guerra?
2) Quali furono le motivazioni che spinsero Giovanni Giolitti ad intraprendere la politica imperialistica
e quali furono gli esiti dell’impresa coloniale giolittiana?
3) Spiega quali furono, nella Germania del nuovo corso, le scelte compiute da Guglielmo II che
contribuirono alla scoppio della prima guerra mondiale?
TERZA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA:
INGLESE
1. After briefly outlining the main features of the Dramartic Monologue, compare and contrast the
characters of Ulysses and Telemachus in the Dramatic Monologue Ulysses by A.L. Tennyson
2. Briefly outline how Victorian (early-mid-late) writers expressed their critical attitude towards the
society in which they lived
3. Analyse the theme of DOUBLE in the novel “The Picture of Dorian Gray”
Scienze
1. Spiegate quale relazione esiste tra distribuzione geografica dei vulcani e il tipo di attività vulcanica e
di monte vulcanico.
2. Le facies sedimentarie sono correlate al tipo di roccia sedimentaria. Giustificate, con esempi, questa
affermazione nel caso delle facies continentali.
3. Solitamente si parla di “dualismo delle rocce magmatiche”, spiegate i motivi di questa affermazione.
STORIA
Domande:
1) Spiega quando e per quali motivazioni si diffuse in Italia il mito della vittoria mutilata?
2) A partire da quale anno Mussolini introduce le leggi fascistissime e quali furono le loro
conseguenze?
3) Spiega per quali motivazioni il biennio rosso ha favorito l’ascesa del movimento fascista?
4)
STORIA DELL’ARTE
ANALIZZA LE IMMAGINI E DESCRIVI: L' AUTORE, IL PERIODO STORICO, IL
MOVIMENTO ARTISTICO.
10
Griglie di valutazione utilizzate
VALUTAZIONE TERZA PROVA d’ESAME
ALLEGATO
Indicatori
Descrittori
Punti
Punteggio assegnato
Quesito
1
Completezza e
pertinenza delle
conoscenze dei
contenuti
Capacità di
elaborazione e
sintesi
Coerenza
argomentativa
Scorretta, lacunose e non
pertinente
Parziale e approssimativa
1
Essenziale
3
Chiara e abbastanza approfondita
4
Approfondita e completa
5
Disarticolata e totalmente carente
1
Generica e poco efficace
2
Chiara e corretta
3
Organica e significativa
4
Contradditoria e disorganica
1
Schematica, ma coerente
2
Rigorosa e organica
3
Impreciso e non appropriato
1
Quesito
2
Quesito
3
2
Correttezza
formale ed uso
di un linguaggio
specifico
Semplice, ma corretto e
appropriato
Esposizione chiara e lineare con
utilizzo di un lessico pertinente
Punteggio totale dei quesiti (min 1 / max 15)
2
3
(si ottiene sommando per ciascun quesito i punti assegnati ai quattro indicatori)
(1-3 mancanza di contenuti per una valutazione valida)
Per la lingua straniera il punto 4 può essere sostituito da:
Completamente scorretta e
incomprensibile
Padronanza della lingua
(correttezza
Esposizione talvolta scorretta,
grammaticale,
ma comprensibile, lessico
ortografica e lessicale) e semplice e ripetitivo
competenze espositive
Esposizione fluida, corretta
formale e lessico pertinente
1
2
3
Livello di sufficienza
Indicatori
Completezza e pertinenza delle
conoscenze dei contenuti
Capacità di elaborazione e sintesi
Coerenza argomentativa
Correttezza formale ed uso di un
linguaggio specifico
Descrittori
Essenziale
Punteggio assegnato al
quesito
3
Chiara e corretta
3
Schematica, ma coerente
2
Semplice, ma corretto e
appropriato
Totale punti:
2
11
10
SCHEDA DI VALUTAZIONE QUESITI TERZA PROVA
(tipologia B)
LINGUA STRANIERA
Indicatori
Completezza e
pertinenza delle
conoscenze dei
contenuti
Capacità di
elaborazione e
sintesi
Coerenza
argomentativa
Padronanza della
lingua (correttezza
grammaticale/
ortografica e
proprietà lessicale)
Descrittori
Punti
Scorretta/lacunosa/non pertinente
1
Essenziale
2
Approfondita/esauriente
3
Disarticolata e totalmente carente
1
Generica e poco efficace
2
Chiara e corretta
3
Organica e significativa
4
Contradditoria e disorganica
1
Schematica, ma coerente
2
Rigorosa e organica
3
Incomprensibile
1
Scorretta e inappropriata
2
Non particolarmente corretta e
appropriata, ma ben comprensibile
Sostanzialmente corretta e
appropriata
Linguaggio ricco e appropriato,
esposizione fluida
3
Punteggio assegnato
Quesito
1
Quesito
2
Quesito
3
Quesito 1
Quesito 2
Quesito 3
4
5
Punteggio totale dei singoli quesiti (min 1 / max 15)
(ottenuto sommando per ciascun quesito i punti assegnati ai quattro indicatori)
(totale 1-3 dove manca sostanza per una valutazione valida)
Livello di sufficienza
Indicatori
Completezza e pertinenza
delle conoscenze dei contenuti
Capacità di elaborazione e
sintesi
Coerenza argomentativa
Padronanza della lingua
Descrittori
Essenziale
Punteggio assegnato al
quesito
2
Chiara e corretta
3
Schematica, ma coerente
2
Non particolarmente corretta e
appropriata, ma ben comprensibile
Totale punti:
3
12
10
GRIGLIA DI LATINO
Comprensione
del brano
Punt.
parz
Correttezza
morfologica
Punt.
Gravi e
diffusi errori
di morfologia
1-4
Gravi errori
di morfologia
5-7
parz
Non è stato
compreso il
significato del
brano
1-7
Il brano è stato
compreso in
modo molto
parziale
8-10
Il brano è stato
compreso in
modo parziale
1112
Errori di
morfologia
9-10
Sono stati colti
gli elementi
essenziali del
brano
1314
Qualche
errore di
morfologia
9-10
E’ stato colto il
significato
globale del
brano
1519
Lievi errori di
morfologia
11
E’ stato colto il
significato del
brano
2022
Morfologia
generalmente
corretta
12
Il senso del
brano è stato
compreso nelle
sue articolazioni
2324
Morfologia
quasi
corretta
Il senso del
brano è stato
compreso in
maniera
puntuale e
precisa
2530
Morfologia
corretta
PUNTEGGIO TOTALE IN 100:
Correttezza
sintattica
Punt.
parz
Pertinenza
lessicale
Punt.
Rielaborazione
Punt.
Punt.
parz
formale
parz
Tot.
Gravi errori
lessicali
1-8
1-4
£30
Scelta
impropria
dei
significati di
parole
chiave
9
Gravi e
diffusi errori
di sintassi
1-7
Gravi errori
di sintassi
8-9
Errori di
sintassi
1012
Scelta
impropria di
alcuni
termini
Qualche
errore di
sintassi
1314
Lievi errori di
sintassi
Periodi
gravemente
scorretti e
incoerenti
Grav. Insuff.
Periodi scorretti
e incoerenti
5
1012
Periodi scorretti
6
Incertezza
nelle scelte
lessicali
1314
Traduzione
corretta ma
stentata
7
1518
Incertezza
nelle scelte
lessicali
1517
Traduzione
corretta ma
stentata
7
Sintassi
generalmente
corretta
1920
Uso di un
lessico
generico
18
Traduzione
scorrevole
8
1314
Sintassi quasi
corretta
2124
Uso di un
lessico
appropriato
19
Resa efficace
9
15
Sintassi
corretta
25
Uso di un
lessico
appropriato
ed elegante
20
_______
13
31-40
Insuff.
41-50
Non Suff.
51-60
Quasi
Suff./Suff.
61-70
Più che Suff.
71-80
Discreto/Buono
81-90
Buono
Resa efficace ed
elegante
10
91-100
Eccellente
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – ITALIANO
TRIENNIO
Correttezza
linguistica e
coerenza testuale
TIPOLOGIA “A” - ANALISI TESTUALE
Comprensione
complessiva del
testo
Pertinenza
rispetto alla
richiesta (analisi)
Contestualizzazione
Approfondimento
Giudizio
Voto
in
decimi
Voto in
quindicesimi
Confusa, priva di
senso compiuto
Mancata
comprensione della
richiesta
Gravi e numerosi
errori, gravi errori
lessicali e mancanza
di progressione
Mancante
Negativi
1-3
1-5
Contraddittoria
Corrispondenza
sporadica,
fraintendimenti,
omissioni
Presenza di errori,
punteggiatura e
lessico incerti,
progressione confusa
Collegamenti intrainter-testuali stentati e
non giustificati
Gravemente
insufficiente
4
6-8
Parziale o molto
approssimativa,
non ricostruisce il
senso essenziale
Corrispondenza
limitata e
disorganica
Errori sporadici,
linguaggio generico,
progressione poco
chiara
Collegamenti sporadici
e superficiali
Insufficiente
5
9
Limitata al senso
centrale
Corrispondenza
limitata, ma
coerente
Progressione chiara,
anche se semplice,
errori occasionali
Esposizione
schematica, ma
corretta nei
collegamenti
Sufficiente
6
10
Essenziale, ma
con elementi di
specificazione
correlati
Adesione precisa,
omissioni e
fraintendimenti
poco rilevanti
Progressione chiara,
sintassi corretta
Esposizione
schematica con un
ampliamento
significativo
Discreto
6,5-7
11
Inferenze
denotano
autonomia nel
metodo d’analisi
Adesione precisa
Morfosintassi sicura
Esposizione autonoma
Più che
7-7,5
12
Frequenti
inferenze
denotano
autonomia nel
metodo d’analisi
Adesione precisa e,
in parte,
approfondita
Morfosintassi sicura,
articolazione e lessico
precisi
Esposizione
autonoma, elaborata
criticamente
Buono
8
13
Ampia, precisa,
svela il senso
profondo con
inferenze
interessanti
Adesione precisa e
approfondita di
tutte le richieste
Discorso articolato e
strutturato, lessico
specifico e stile
personale
Contestualizzazione
ampia che giustifica le
interpretazioni
personali
ottimo
9/10
14-15
discreto
14
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – ITALIANO
Aderenza al
problema
TRIENNIO
TIPOLOGIA “B” – SAGGIO BREVE
Comprensione
dei documenti
dati, utilizzo
dei documenti
integrativi
Correttezza
linguistica e coerenza
alla forma testuale
prescelta:
destinatario, contesto
comunicativo,
registro linguistico,
scopo
Rielaborazione
Giudizio
Voto in
decimi
Voto in
quindicesimi
Mancata
focalizzazione
del problema
Assente
Gravi e numerosi errori,
scelte lessicali
incongruenti, mancata
progressione
Mancanza di
elementi
significativi
Negativo
1-3
1-5
Corrispondenza
sporadica / tesi
non chiara
Approssimativa
con
fraintendimenti e
omissioni
Errori, uso della forma
contraddittorio,
progressione confusa
Idee superficiali,
collegamenti
stentati
Gravemente
insufficiente
4
6-8
Corrispondenza
limitata e
disorganica /
tesi esplicitata
in modo
confuso
Parziale, manca
la ricostruzione
del quadro
essenziale
Errori sporadici; lessico,
destinatario e scopo
generici; progressione
non chiara
Collegamenti
sporadici, idee
non significative
Insufficiente
5
9
Corrispondenza
limitata ma
coerente / tesi
chiara
Approssimazioni
e omissioni n on
toccano i temi
essenziali
Tipologia e progressione
chiare, errori occasionali
Esposizione
schematica di
almeno un
elemento
significativo
Sufficiente
6
10
Adesione
coerente alle
principali
articolazioni /
tesi e
argomentazioni
chiaramente
esplicitate
Limitata
all’essenziale, ma
con conoscenze e
documenti
integrativi
Tipologia e progressione
articolate, sintassi
corretta
Esposizione
schematica con
qualche
ampliamento
significativo
Discreto
6,5-7
11
Adesione
sicura alla
traccia e alle
sue
articolazioni
Sicura, ben
integrata con un
quadro di
riferimento
Morfosintassi corretta,
tipologia e progressioni
fluide
Esposizione
problematica
con sviluppo di
idee ed elementi
significativi
Più che
discreto
7-7,5
12
Adesione
sicura e, in
parte,
approfondita
Precisa,
articolata,
giustificata dalle
conoscenze
personali
Morfosintassi sicura,
tipologia adatta
all’articolazione
Scelta autonoma
degli elementi
significativi,
problematizzazio
ne
Buono
8
13
Adesione
sicura e, in
gran parte,
approfondita
Precisa, acuta,
integrata in
un’organizzazione
concettuale
Realizzazione efficace,
padronanza di lessico e
sintassi
Ricerca di
significati nello
sviluppo criticoproblematico
Più che buono
9
14
Adesione
precisa e
approfondita a
tutte le
richieste della
traccia
Accompagnata
da sicuri quadri
di riferimento
Testo piacevole ed
efficace, stile creativo
Integra
problematicame
nte;
documentazione
e conoscenze
personali
Ottimo
10
15
15
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – ITALIANO
Pertinenza alla
traccia
Conoscenza dei
contenuti
TRIENNIO
Correttezza
linguistica e
coerenza
testuale
Rielaborazione
TIPOLOGIA “C” – TEMA STORICO
Giudizio
Voto in decimi
Voto in
quindicesimi
Negativo
1-3
1-5
Mancata
comprensione
della richiesta
Scarsa o assente
Gravi e numerosi
errori morfologici,
lessicali e di
progressione
Mancano i
collegamenti
Corrispondenza
sporadica alla
traccia
Approssimativa,
confusa su date,
avvenimenti e
concetti chiave
Errori morfologici,
lessico incerto,
progressione
confusa
Collegamenti
stentati e non
giustificati
Gravemente
insufficiente
4
6-8
Corrispondenza
limitata e
disorganica
Parziale, confusa;
quadro
cronologico e
culturale
incompleto
Alcuni errori,
lessico generico,
progressione non
chiara
Collegamenti
sporadici e
superficiali
Insufficiente
5
9
Corrispondenza
limitata ma
coerente
Approssimazioni e
omissioni non
toccano i temi
essenziali
Tipologia e
progressione
chiare, errori
occasionali
Esposizione
schematica di
almeno un
elemento
significativo
Sufficiente
6
10
Adesione coerente
alle principali
articolazioni
Limitata
all’essenziale, con
alcuni elementi
correlati
esattamente
Articolazione
essenziale,
sintassi semplice
ma corretta
Esposizione
schematica con
qualche
ampliamento
significativo
Discreto
6,5-7
11
Adesione sicura
alla traccia e alle
sue articolazioni
Essenziale,
avvenimenti
inseriti in un
chiaro quadro di
riferimento
Morfosintassi
corretta, lessico
specifico,
articolazione
fluida
Esposizione con
spunti
argomentativi,
inferenze e
collegamenti
Più che discreto
7-7,5
12
Adesione sicura e,
in alcune
articolazioni,
approfondita
Con riferimenti
precisi, articolati e
giustificati
Morfosintassi
corretta, lessico
specifico,
articolazione
fluida
Esposizione
autonoma,
elaborata
criticamente
Buono
8
13
Adesione sicura e
approfondita alla
maggioranza delle
articolazioni
Con date, nomi e
teorie in
un’organizzazione
che sa valorizzarle
Articolazione
fluida, sintassi e
lessico specifico
precisi
Sviluppo critico
argomentativo
della
contestualizzazion
e
Più che buono
9
14
Adesione precisa
e approfondita a
tutte le richieste
della traccia
Ampia,
personale,e
precisa di nozioni,
fonti e
interpretazioni
Discorso articolato
e strutturato,
lessico specifico e
stile personale
Contestualizzazion
e ampia che
giustifica le
interpretazioni
personali
Ottimo
10
15
16
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – ITALIANO
Pertinenza alla
traccia
Conoscenza dei
contenuti
TRIENNIO
Correttezza
linguistica e
coerenza
testuale
Rielaborazione
TIPOLOGIA “D” – TEMA DI ATTUALITÀ
Giudizio
Voto in decimi
Voto in
quindicesimi
Negativo
1-3
1-5
Mancata
comprensione
della richiesta
Scarsa o assente
Gravi e numerosi
errori morfologici,
lessicali e di
progressione
Mancano i
collegamenti
Corrispondenza
sporadica alla
traccia
Approssimativa,
confusa su
concetti chiave
Errori morfologici,
lessico incerto,
progressione
confusa
Collegamenti
stentati e non
giustificati
Gravemente
insufficiente
4
6-8
Corrispondenza
limitata e
disorganica
Parziale, confusa;
quadro culturale
incompleto
Alcuni errori, uso
di un lessico
generico,
progressione non
chiara
Collegamenti
sporadici e
superficiali
Insufficiente
5
9
Corrispondenza
limitata, ma
coerente
Con lacune che
non toccano i temi
essenziali
Progressione
chiara, anche se
semplice, errori
occasionali
Esposizione
schematica ma
corretta nei
collegamenti
Sufficiente
6
10
Adesione coerente
con la traccia e le
sue articolazioni
Limitata
all’essenziale,con
alcuni elementi
correlati
esattamente
Articolazione
essenziale,
sintassi semplice
ma corretta
Esposizione
schematica con
qualche
ampliamento
significativo
Discreto
6,5-7
11
Adesione sicura
alla traccia e alle
sue articolazioni
Essenziale,
avvenimenti
inseriti in un
chiaro quadro di
riferimento
Morfosintassi
corretta, lessico
specifico,
articolazione
fluida
Esposizione con
spunti
argomentativi,
inferenze e
collegamenti
Più che discreto
7-7,5
12
Adesione precisa
e, in alcune
articolazioni,
approfondita
Riferimenti precisi,
articolati e
giustificati
Morfosintassi
corretta, lessico
specifico,
articolazione
fluida
Esposizione
autonoma,
elaborata
criticamente
Buono
8
13
Adesione sicura e
approfondita alla
maggioranza delle
articolazioni
Teorie in
un’organizzazione
efficace
Articolazione
fluida, sintassi e
lessico specifico
precisi
Sviluppo critico
argomentativo
della
contestualizzazion
e
Più che buono
9
14
Adesione precisa
e approfondita a
tutte le richieste
della traccia
Ampia, personale
e precisa di
nozioni, fonti e
interpretazioni
Discorso articolato
e strutturato,
lessico specifico e
stile personale
Contestualizzazion
e ampia che
giustifica le
interpretazioni
personali
Ottimo
10
15
17
CRITERI DI CORREZIONE E VALUTAZIONE
DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
Nella assegnazione del punteggio di ogni prova si propone di seguire i seguenti criteri:
A: numero di problemi e quesiti da valutare, punteggio massimo, punteggio di sufficienza
a1. viene considerata la risoluzione di un solo problema e del numero di quesiti indicato dalla consegna (di solito
cinque)
a2. ad una prova costituita dalla risoluzione completa di un problema e di un numero di quesiti pari a quello indicato
dalla consegna viene assegnato il voto massimo.
a3. ad una prova costituita dalla risoluzione completa e corretta di un problema o di un numero di quesiti pari a
quello indicato dalla consegna o di un problema risolto parzialmente e di un numero di quesiti risolti parzialmente
in modo tale da totalizzare un punteggio equivalente al 50% del punteggio massimo ottenibile viene assegnato un
voto pari a 10/15.
a4. la determinazione del punteggio complessivo dell’elaborato si ottiene in base alle modalità previste al punto C
B.
Elementi di cui tenere conto nell'assegnazione del punteggio:
1. CONOSCENZE
Conoscenze disciplinari specifiche , conoscenza di principi, teorie, concetti, termini, regole,
procedure, metodi e tecniche.
2. CAPACITA’ LOGICHE ED ARGOMENTATIVE :
Organizzazione e utilizzazione di conoscenze e abilità per analizzare, scomporre, elaborare.
Proprietà di linguaggio, comunicazione e commento della soluzione puntuali e logicamente
rigorosi. Scelta di procedure ottimali e non standard.
3. CORRETTEZZA E CHIAREZZA DEGLI SVOLGIMENTI
Correttezza nei calcoli, nell’applicazione di tecniche , coerenza delle procedure e correttezza e
precisione nell’esecuzione delle rappresentazioni geometriche e dei grafici.
4. COMPLETEZZA
Problema risolto in tutte le sue parti e risposte complete ai quesiti affrontati.adeguatezza alle
richieste della risoluzione e qualità delle rappresentazioni grafiche di dati del problema o dei
quesiti.
C Determinazione del punteggio grezzo.
La griglia prevede, per ciascun descrittore, l’attribuzione di un “punteggio” minore o uguale ad un
valore massimo dipendente dalle tracce assegnate e fissato a livello nazionale . La griglia
completata con l’indicazione dei punteggi massimi sarà disponibile su www. matmedia
il pomeriggio della seconda prova scritta .
Si otterranno dalla risoluzione del problema e dei quesiti non superiore a quello indicato dalla
consegna, un punteggio complessivo compreso fra 1 e 150, da cui si otterrà il voto definitivo,
utilizzando la tabella di conversione allegata alla griglia.
18
ESAME DI STATO 2013 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
SCRITTA - COMMISSIONE _______________
CANDIDATO ________________________________________________ CLASSE _________
VOTO _____/15
Problemi
(Valore
massimo
attribuibile
75/150 per
ognuno)
CIITERI PER LA VALUTAZIONE
1
2
Quesiti
(Valore massimo attribuibile 75/150 = 15x5)
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
P.T
.
Q1
0
1. CONOSCENZE
Conoscenza di principi, teorie, concetti,
termini, regole, procedure, metodi e
tecniche
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤ pmax ≤ pmax pmax pmax pmax pmax pmax pmax pmax pmax pmax pmax
2. CAPACITA’ LOGICHE ED
ARGOMENTATIVE
Organizzazione e utilizzazione di
conoscenze e abilità per analizzare,
scomporre, elaborare. Proprietà di
linguaggio, comunicazione e commento
della soluzione puntuali e logicamente
rigorosi. Scelta di procedure ottimali e
non standard.
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤ pmax ≤ pmax pmax pmax pmax pmax pmax pmax pmax pmax pmax pmax
3. CORRETTEZZA E CHIAREZZA
DEGLI SVOLGIMENTI
Correttezza nei calcoli, nell’applicazione
di tecniche e procedure. Correttezza e
precisione nell’esecuzione delle
rappresentazioni geometriche e dei
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
grafici.
≤ pmax ≤ pmax pmax pmax pmax pmax pmax pmax pmax pmax pmax pmax
4. COMPLETEZZA
Problema risolto in tutte le sue parti e
risposte complete ai quesiti affrontati.
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤ pmax ≤ pmax pmax pmax pmax pmax pmax pmax pmax pmax pmax pmax
Totali
TABELLA DI CONVERSIONE DAL PUNTEGGIO GREZZO AL VOTO IN QUINDICESIMI
Puntegg
io
Voto
0-3
4-10
11-18
19-26
27-34
35-43
44-53
54-63
64-74
75-85
86-97
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Firme della Commissione:
19
98109
12
110123
13
124137
14
138150
15
RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI DELLE VARIE DISCIPLINE:
RELAZIONE FINALE Materia: Italiano
Docente Flavia Fommei
Classe V A
A.S.: 2012-2013
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, nella quale ho insegnato nel corso del triennio, ha
manifestato nel complesso un apprezzabile impegno. Le lezioni si
sono svolte in un clima di collaborazione e interesse; un discreto
numero di alunni ha offerto contributi significativi.
Il livello raggiunto è complessivamente più che sufficiente, con
punte di eccellenza. Gli elementi in difficoltà sono riusciti a
raggiungere nell’ultimo periodo un livello di conoscenza decoroso.
COMPETENZE
a) Saper contestualizzare un testo
b) Riconoscere le caratteristiche strutturali e
linguistiche di un testo
c) Saper analizzare gli elementi metrici e
stilistici, riconoscere le principali figure
retoriche, individuare i campi semantici
(parole chiave, temi)
d) Acquisire il senso storico dell’evolversi
della lingua e della cultura
LINGUISTICHE a) Utilizzare un linguaggio adeguato ed
esprimere i diversi contenuti appresi
b) Produrre testi di diversa tipologia, facendo
in modo che abbiano completezza, coerenza
e coesione
LETTERARIE
CAPACITA’
a) Formulare un linguaggio adeguato ed esprimere i diversi
contenuti appresi
b) Produrre testi di diversa tipologia, facendo in modo che
abbiano completezza, coerenza e coesione
c) Collocare il singolo autore o movimento in rapporto con
quanto lo ha preceduto e individuare gli aspetti che lo
legano con gli sviluppi successivi
d) Analizzare, sintetizzare e confrontare testi, autori e
movimenti
e) Rielaborare criticamente e autonomamente il materiale
letterario
f) Istituire collegamenti in prospettiva interdisciplinare
CONOSCENZE
a) Conoscere i contenuti specifici delle correnti letterarie
affrontate
b) Conoscere le opere letterarie previste nel corso dell’anno
c) Conoscere caratteristiche tipologiche e strutture formali delle
opere letterarie
d) Conoscere le principali vicende biografiche degli autori
trattati, le linee evolutive del pensiero e della produzione
e) Conoscere il contesto storico e culturale degli autori trattati
20
VALUTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI
Si può affermare che gli obbiettivi prefissati siano stati
raggiunti nella quasi totalità degli alunni, seppure a diversi
livelli e in relazione a un diverso impegno profuso nello studio
personale, alla diversa partecipazione al dialogo educativo, al
differente coinvolgimento negli argomenti trattati.
CRITERI METODOLOGICI
Lo studio della letteratura è stato proposto partendo da una
introduzione
generale
sul
contesto
storico-culturale
caratterizzante ogni movimento letterario, per arrivare poi ad
una conoscenza più ravvicinata delle tematiche e degli autori
attraverso la lettura commentata di testi significativi.
Il contributo degli alunni è stato sempre un elemento
imprescindibile, dapprima sotto la guida dell’insegnante per
arrivare poi ad interpretazioni autonome da parte dei ragazzi.
Sono stati previsti inoltre momenti di discussione in cui gli
alunni hanno avuto modo di esprimere le loro riflessioni , per
una sempre più completa e critica acquisizione dei contenuti.
Sono stati offerti spunti per stimolare il confronto,
l’attualizzazione e la personalizzazione delle tematiche e delle
problematiche offerte, con l’appoggio di strumenti bibliografici
idonei ad approfondire gli argomenti. Laddove possibile, si è
cercato di istituire un collegamento interdisciplinare con le
materie che hanno maggiore collegamento con la letteratura
italiana ( in particolare Storia , Filosofia, Storia dell’Arte,
Inglese).
MATERIALI DIDATTICI
R. Bruscagli, G, Tellini, “ Letteratura e storia”,4,5,6 Sansoni
G. Tornotti , “La mente innamorata” Bruno Mondadori
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state effettuate tre prove scritte e due o più verifiche orali nel
primo quadrimestre; tre prove scritte e due o più orali nel secondo.
Nel secondo quadrimestre è stata effettuata una verifica scritta sulla
Divina commedia di Dante
Per quanto riguarda i compiti scritti ( per cui i ragazzi hanno avuto a
disposizione tre ore ciascuno, fatta eccezione per la simulazione
finale di cinque ore) sono state proposte le prove previste dagli esami
di stato .
Le verifiche orali hanno permesso di sondare l’acquisizione dei
contenuti e il grado di rielaborazione critica, nonché la capacità di
espressione e di commento autonomo ai testi.
VALUTAZIONE
> I criteri per lo scritto sono stati i seguenti:
- correttezza formale, proprietà lessicali
- pertinenza rispetto al titolo
21
- organicità e ordine di svolgimento
- originalità dell’impostazione
- capacità critica
> per l’orale
- correttezza terminologica
- completezza
- scioltezza espositiva
- capacità di rielaborazione personale
- capacità di istituire collegamenti in maniera
autonoma
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
ARGOMENTO
SINTETICO
L’ETA’
NAPOLEONICA:
STRUTTURE
POLITICHE E
SOCIALI.
NEOCLASSICISMO E
PREROMANTICISMO
IL ROMANTICISMO
IN EUROPA ED IN
ITALIA: IDEOLOGIE,
STRUTTURE
POLITICHE E
CONTESTO SOCIALE
SVILUPPO ANALITICO
TEMPI E
DATA
ü Settembre,
Ugo Foscolo: la fusione tra arte e vita: Ultime lettere di
Ottobre
Jacopo Ortis, “Al lettore”, “L’incontro con Parini” , dai ü 12 lezioni
Sonetti “Alla sera”; “A Zacinto”; “In morte del fratello
Giovanni”; Dei Sepolcri; Dalle Grazie : “Il velo delle
grazie”
Caratteri generali (contraddittorietà della concezione ü Ottobre,
romantica ed il prevalere dell’importanza data al
Novembre,
sentimento),
la
nuova
figura
dell’intellettuale
Dicembre e
(inconciliabilità tra artista e società), importanza del
28 lezioni
genio individuale, movimenti romantici che si
diffondono in Europa, il valora dell’arte, i concetti di
sublime e senhsuch.
Dibattito tra classicisti e romantici
F. schiller: da Sulla poesia ingenua e sentimentale : I
moderni rimpiangono la natura
F. Schlegel : da Dialogo sulla poesia : Fare una nuova
poesia
W. Wordsworth : da Ballate liriche. Prefazione : La
poesia è lo spontaneo traboccare di forti sentimenti
Madame De Stäel.: da Sulla maniera e l’utilità delle
traduzioni
Giovanni Berchet: da Lettera semiseria: La poesia
popolare.
Romanticismo italiano: caratteristiche generali analogie e
differenze con il romanticismo europeo:
Alessandro Manzoni: la biografia e la poetica ; da
Lettre a M. Chauvet: Poesia e storia. Dall’Epistolario. A
Claude fauriel : La funzione civile della letteratura. Da
Sul Romanticismo : L’utile per scopo, il vero per soggetto
e l’interessante per mezzo. Dagli Inni sacri: “La
Pentecoste”. Dalle Odi: “Il cinque Maggio”.
Dall’Adelchi: “ Coro dell’atto terzo”,“Coro dell’atto IV”
. I promessi sposi.
Giacomo Leopardi: poetica e pensiero, teoria del
22
piacere, passaggio dal pessimismo storico al pessimismo
cosmico, Lettura e analisi di alcuni brani tratti dallo
Zibaldone di pensieri: “ Un desiderio infinito e
irrealizzabile: la teoria del piacere”, “ il vago e
l’indefinito: le rimembranze della fanciullezza”, “ Ogni
giardino è quasi un vasto ospitale”,” L’immaginazione: la
teoria della doppia visione”, Dai Canti: “Alla Luna”, “L’
infinito” , “A Silvia”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il
sabato del villaggio”, “Il passero solitario”, ”Canto
notturno di un pastore errante dell’ Asia”, “La ginestra”.
Dalle Operette Morali: “Dialogo della natura e di un
Islandese”.
ETA’ POSTUNITARIA:
STRUTTURE
POLITICHE E
SOCIALI. LA
SCAPIGLIATURA:
POSIZIONE
SOCIALE, PENSIERO
E RUOLO DEGLI
INTELLETTUALI
NATURALISMO
FRANCESE E
VERISMO
ITALIANO: I TRATTI
FONDAMENTALI
DELLE DUE
CORRENTI E LORO
ANALOGIE E
DIFFERENZE
IL DECADENTISMO :
I TEMI E LA VISIONE
DEL MONDO
E. Praga: “Preludio”
A. Boito: “Lezione di anatomia”
I. U. Tarchetti: “ Memento”
G. Carducci: la vita, le opere, l’evoluzione poetica, lo
scudiero dei classici e il poeta ribelle, il classicismo
moderno della maturità, La metrica barbara. Da Rime
nuove Il comune rustico; Pianto antico;da Odi barbare:
Nevicata
Gennaio
8 lezioni
Poetiche del Naturalismo francese e del Verismo italiano ü Febbraio –
Giovanni Verga: il periodo pre-verista. La svolta con la
Marzo
novella “Nedda”. Da Vita dei campi: . “Rosso Malpelo”. ü 10 lezioni
I Malavoglia (temi fondamentali, lingua e analisi): Il
quadro teorico: la prefazione ai Malavoglia, Buona e
brava gente di mare, La morte di Bastianazzo, Qui non
posso starci; Da Novelle rusticane :”La roba“, da Mastro
Don Gesualdo: La giornata di Gesualdo, A un tratto
s’irrigidì e si chetò del tutto.
La poetica decadente. L’estetismo. Il simbolismo.
ü Marzo,
Aprile
C. Baudelaire, da I fiori del male :L’albatro,
Gabriele D’Annunzio: la vita, la poetica, l’estetismo. Da Il ü 20 lezioni
Piacere: L’attesa dell’amante, Il ritratto di Andrea Sperelli ;.I
romanzi del super uomo. Da Le vergini delle rocce: Il
programma politico del superuomo”. Da Alcione. “La sera
fiesolana”, “La pioggia nel pineto”; dal Notturno: I sogni del
malato
Giovanni Pascoli: la vita, le soluzioni formali e la
poetica. Da Myricae: “Lavandare”, “Novembre”, “Il
tuono”, “L’assiuolo”, “ X agosto”.Da Canti di
Castelvecchio: , “Il gelsomino notturno”. Da Il fanciullino
: Il fanciullino
Italo Svevo: la poetica. Da Una vita:L’inizio di Una vita,
Ci sono del tutto ignote le cause del suicidio: la morte
antieroica dell’inetto. Da Senilità : Erano tutti ricordi della
propria colpa: la conclusione . Da La coscienza di Zeno ,
Zeno e il dottor S., L’ultima sigaretta, La morte di mio
padre, La conclusione
Luigi Pirandello: la visione del mondo. Da L’umorismo:
“Il sentimento del contrario”. I romanzi: “Il fu Mattia
Pascal” (L’opera nel percorso poetico dell’autore, trama e
23
struttura, temi, lo stile): Cambio treno, cambio vita, La
conclusione; , Da Uno, nessuno e centomila: Non
conoscevo bene neppure il mio corpo.
FUTURISMO:
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto tecnico della ü Maggio
IDEOLOGIE, FORME letteratura futurista
ü 2 lezioni
E TENDENZE
LETTERARIE
L’ ERMETISMO:
Giuseppe Ungaretti: le linee fondamentali della poetica. ü MaggioREALTA’ POLITICO- Da L’ allegria: “I fiumi”, “Veglia”, “Soldati”, “
Giugno
SOCIALE E LA
Mattina”,” San Martino del Carso”
ü 10 lezioni
NUOVA POETICA Eugenio Montale: la visione del mondo e la tecnica del (in parte ancora
correlativo oggettivo. Da Ossi di seppia: “ I limoni” da svolgere)
“Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e
assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”
DANTE
Divina Commedia: Paradiso canti I-III-VI-VIII-IX- ü Settembre, Marzo
XI-XII-XV-XVII-XXXI
ü 20 lezioni
Totale ore di
lezione
svolte:
120
24
RELAZIONE FINALE
Docente: FLAVIA FOMMEI
Materia: Latino
Classe: VA
A.S.: 2012-2013
* * *
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, in cui ho insegnato la materia a partire dalla classe terza, ha
generalmente dato prova di un adeguato senso di responsabilità, consentendo di
svolgere un lavoro proficuo. Gli obbiettivi fissati in sede di programmazione
sono stati generalmente raggiunti, pur con una notevole diversità di livello,
proporzionale all’impegno profuso dagli alunni e alle singole predisposizioni.
Difficoltà sono state incontrate da alcuni studenti nell’interpretazione corretta
del testo latino, ma, nel corso di quest’ultimo anno, tutti sono comunque riusciti
a raggiungere un adeguato livello di preparazione, soprattutto per quanto
riguarda le conoscenze letterarie.
COMPETENZE
GRAMMATICALI
LETTERARIE
Saper leggere individuando gli elementi legati alle
strutture morfologico-sintattiche
Saper contestualizzare i vari autori, saper analizzare,
sintetizzare e confrontare testi, autori e periodi,
individuando elementi che esprimono la civiltà e la
cultura latina.
CAPACITA’
g) saper riconoscere usi, costumi e tradizioni del mondo latino attraverso
la lettura delle opere caratterizzanti un determinato periodo letterario
h) saper riconoscere motivi e spunti di attualizzazione e confronto tra
autori ed opere del passato e del presente, per sottolineare i momenti di
continuità tra cultura latina e cultura italiana
CONOSCENZE
a) perfezionamento della conoscenza della lingua latina mediante consolidamento delle
strutture morfo-sintattiche;
b) conoscenza della storia della letteratura latina dall’età di Augusto ad Apuleio nei suoi autori
più significativi, inquadrati nell’ambito storico culturale in cui si esprimono.
METODOLOGIE
Nella prima parte dell’anno si è proposto agli alunni un lavoro di
traduzione su testi latini non troppo lontani dalle loro conoscenze
storiche e culturali.
Si è dato particolare peso, nella traduzione, alla resa italiana, perché gli
alunni fossero consapevoli delle scelte lessicali e sintattiche del singolo
autore. Per quanto riguarda lo studio letterario, intensificatosi nel corso
del secondo quadrimestre, si sono stimolati gli alunni a continui
collegamenti e confronti con le età precedenti, in maniera tale da cogliere
le linee di continuità rintracciabili e i cambiamenti intervenuti nella
scelta dei generi letterari, dei gusti, delle tendenze e delle idee.
Costante è stato lo sforzo di legare i fatti storici con i fenomeni letterari,
per comprendere come la cultura s’intrecci strettamente con la storia.
Lezioni frontali, discussioni di approfondimento e verifiche orali hanno
costituito momenti di riflessione e di approfondimento su tali aspetti .
MATERIALI DIDATTICI
E. Malspina, P. Pagliani, R. Alosi, A. Buonopane, R. Ampio, A. Balbo
“Antico Presente”, Petrini, 2,3
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state effettuate due prove scritte di due ore ciascuna ( traduzioni ) e
due verifiche orali nel primo quadrimestre, rispettivamente tre e due nel
25
secondo. Nel corso dell’anno sono state effettuate inoltre due prove
strutturate di letteratura
VALUTAZIONE
Per lo scritto si è tenuto conto:
8 della comprensione del messaggio;
8 della correttezza morfologica, sintattica, lessicale;
8 della scioltezza della traduzione (primo quadrimestre)
8 della capacità di sintesi, di collegamento e di confronto dei
fenomeni letterari (secondo quadrimestre)
Per l’orale si è tenuto conto:
8 della correttezza e della completezza;
8 della scioltezza espositiva;
8 della capacità di rielaborazione personale;
della capacità di operare collegamenti interdisciplinari.
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER
ARGOMENTO
SVILUPPO ANALITICO
SINTETICO
LA STORIOGRAFIA Tito Livio: una vita dedicata all’impegno letterario. Ab
DURANTE L’ETA’
urbe condita libri. L’interpretazione della storia. Tecnica
AUGUSTEA
narrativa, stile e lingua. Da “Ab urbe condita”: il grande
nemico di Roma, il ritratto di Annibale (XXI, IV); la
tragica fine di Lucrezia (I, 58); l’esordio della repubblica:
la fine della tirannia (II, 1); la disfatta di Canne: la prima
fase della battaglia (XXII, 47)
L’ELEGIA
Ovidio: notizie biografiche. Le opere elegiache ed
erotico-didascaliche. Ovidio poeta epico. I “Tristia” e le
“Epistulae ex Ponto”. Lingua e stile.
Da “Amores”: Il catalogo è questo! (Am. II, 4, 9-48; A rs
Am. II, 641-648, 657-662); da “Metamorfosi”: Apollo e
Dafne (Met. I, 502-566)
SENECA
La militia vitae, una vasta e molteplice produzione,
dialoghi e trattati, le lettere a Lucilio, lo stile moderno
“del moralista”, l’ Apokolokyntosis, le tragedie.
Da “De brevitate vitae” (1-3, 10, 2, 5-6).
Epistulae morales ad Lucilium: 9.8-12 “La vera nobiltà”
(in traduzione), 44, “Schiavi e padroni” 47; l’osservazione
scientifica: da” Naturales quaestiones”, III, praef, (5-18).
PETRONIO
1. La questione dell'autore del Satyricon; 2. Contenuto
dell'opera; 3. La questione del genere letterario; 4.
Struttura del romanzo e strategie narrative; 5. Il mondo
del Satyricon: il realismo petroniano.
Dal Satyricon: un esempio di lingua parlata: “Il discorso
di Ermerote” 37; “La tomba di Trimalchione”(71, 5-12),
“Il lupo mannaro” 61, 6-9, “La matrona di Efeso”, 111112.
L’EPICA
Lucano: una vita tra poesia e politica,il Bellum civile o
Pharsalia: struttura e contenuto, la nuova epica di Lucano,
i personaggi del Bellum civile, la visione pessimistica, lo
stile.
Il Bellum civile: I, 129-157 “Pompeo e Cesare”;I, 129-157
“Un orrendo rito magico”; VI, 668-706, 716, 725; “La
piana di Farsalo dopo la battaglia”. VII, 785-824; “Le
nozze di Catone” (II, 326-391)
LA POESIA
NELL'ETA' GIULIOCLAUDIA
Fedro e la favola: gli umili alla ribalta letteraria, l’opera,
il mondo di Fedro. Fabulae “Il lupo e l’agnello” (I,1)
Il corvo e le penne del pavone (I,3) , Il lupo e il cane (III,
7) La volpe e l’uva (IV, 3)
La poesia satirica: Persio: un giovane moralista, caratteri
della, forma e stile. Dalle Satire: “Sei tu che sei in gioco”:
l’inetto “giovin signore” /III, 1-34)
26
TEMPI E DATA
Settembre
9 ore
Ottobre
4ore
Ottobre- Novembre
Dicembre
25 ore
Gennaio- Febbraio
10 ore
Febbraio
7 ore
Febbraio
3 ore
Aprile
5 ore
-
LA CULTURA
NELL’ETA’ DEI
FLAVI E DI
TRAIANO
Quintiliano. Notizie biografiche. L'Institutio oratoria. De
causis corruptae eloquentiae. Lo stile.
Da Institutio oratoria:, “Il professore ideale” II, 2, 4-13, I
primi insegnamenti I, 1, 26-27, 30-31, 34-36; Lo stile
corruttore di Seneca X,1,125-131; Contro le punizioni
corporali I, 3, 14-17; Retorica e filosofia I, praef.. I, 9-11.
Marziale e la poesia epigrammatica: origini e sviluppi
dell’epigramma. La vita e le opere. La poetica.
Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica
compositiva. I temi: il filone comico-realistico; forma e
lingua. Da Epigrammata: “Una galleria di maschere”
(denti veri o denti finti) V, 43, “Fabulla e le sua amiche”
VIII, 79, “La vedova nera” IX, 15, “Basta che non
parli!”XI,102, “Il corteggiatore interessato” I, 10, “Capelli
dipinti” VI, 57; Un Marziale diverso: L’Epigramma per la
morte della piccola Erotion V, 34; La quiete mortale della
vita in provincia (XII, 18)
La satira di Giovenale: La vita. La poetica dell’indignatio
Aspetti delle satire. Lingua e stile.
Sermones: Indignatio ed ira nel manifesto poetico di
Giovenale I, 1, 20-30, 73-80, 147-171; Giovenale e gli
immigrati stranieri III, 58-80; una galleria di ritratti
femminili VI, 114-131, 434-456, 475-495.
Tacito. La vita e la carriera politica; 2. L'Agricola; 3. La
Germania; il Dialogo de oratoribus; 4. Le Historiae e gli
Annales; La concezione e la prassi storiografica di Tacito;
la lingua e lo stile tacitiani.
Da Agricola : finalmente si torna a vivere (3); Fremiti di
ribellione (15-16, 1-2); Un buon governatore (19-21). Da
“Germania”: identikit dei germani (4); i boni mores dei
germani (17); i Germani: una minaccia fatale per l’impero
(37). Da “Historiae”. Parlare di tutti senza amore e senza
odio (I)
L’ETA DI ADRIANO Apuleio. La vita. Il De Magia. Le Metamorfosi ovvero
E DEGLI ANTONINI L’asino d’oro; “Amore e Psiche” da Metamorphoseon
IV,28-31; V, 1-2, 22-24; VI, 9-11; 23-24.
Marzo
9 ore
Aprile
3 ore
Aprile
2 ore
Maggio6 ore
Totale ore svolte 84
27
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO
2012/2013
Docente: Milardo Lisa
Materia: Inglese
Classe: 5A
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE:
alla fine dell’ anno scolastico gli alunni sanno:
§
CONOSCERE GLI ARGOMENTI DI LETTERATURA TRATTATI NEL CORSO DELL’ANNO;
§
UTILIZZARE LA LINGUA NELL’ESPRESSIONE ORALE E SCRITTA IN MODO ABBASTANZA CORRETTO;
§
ANALIZZARE UN TESTO LETTERARIO (POESIA, PROSA, TEATRO) IN TUTTE LE SUE COMPONENTI.
COMPETENZE:
§
competenze linguistico-comunicative: nel corso dell’anno l’alunno ha sviluppato le proprie competenze
comunicative nella LS, con l’attivazione e l’affinamento delle capacità espressive, interpretative, di
interazione e di riflessione sulla lingua e su testi letterari e non, più o meno complessi;
§
competenza metacognitiva: l’alunno è stato spronato, in accordo con le altre discipline , ad affinare e
migliorare il proprio metodo di studio per poter perseguire gli obiettivi proposti con profitto
CAPACITÀ:
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
§
sapersi esprimere in LS oralmente su argomenti di attualità e di letteratura con discreta intonazione e
pronuncia, con correttezza grammaticale, con discreta padronanza lessicale;
§
sapere comprendere nel suo significato globale e nel dettaglio la lingua parlata da altri a normale
velocità di conversazione;
§
saper produrre testi scritti di media lunghezza, di argomento letterario e non, con correttezza
grammaticale, con buona padronanza lessicale;
§
sapere esprimere le proprie opinioni in modo chiaro e comprensibile, con una certa correttezza formale e
con buona padronanza lessicale;
§
sapere comprendere, analizzare ed interpretare sotto la guida dell’insegnante, testi in LS di carattere
letterario;
§
in riferimento alla letteratura: sapere comprendere, analizzare ed interpretare i testi letterari proposti in
classe; saper contestualizzare un’opera all’interno del suo periodo storico e letterario; sapere mettere a
confronto opere diverse di stessi autori e di autori diversi; sapere riconoscere le caratteristiche distintive
dei “macrogeneri” letterari, (Poetry,Drama and Fiction).
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:
Modulo / U.D.
Letteratura
Ripasso The Augustan Age, the Rise of the Novel;
Ripasso The Augustan novelists:
D. Defoe, Robinson Crusoe;
J. Swift, Gulliver’s travels;
S. Richardson, Pamela or the virtue rewarded;
H. Fielding, Tom Jones;
L. Sterne, the anti-novel
Periodo /ore
2h
Settembre - Ottobre
The Romantic Age:
historical, social and literary background
2h
The Gothic Fiction: main features
3h
28
Frankenstein or the Modern Prometheus by M. Shelley
Lettura del testo The monster comes to life, pag. 341
The novel of manners: main features
Pride and Prejudice by J. Austen
Lettura capitolo 1 del romanzo, pag. 331
Visione del film Pride and Prejudice
5h
William Blake, p. 281
main features of Songs of Innocence and Songs of Experience;
London, pag. 287.
2h
The Romantic Poetry:
3h
William Wordsworth: A certain colours of imagination, pag. 291;
Composed upon Westminster Bridge, pag. 293;
Confronto tra London by W. Blake e Composed upon Westminster Bridge
by W. Wordsworth.
1h
Lingua
Unit 12: Staying healthy: relative clauses
Unit 13: Animal kingdom: third conditional, if only, wish
Unit 15: Fiesta!: the passive
6h
Samuel Taylor Coleridge: The Rhyme of the Ancient Mariner;
Lettura della prima parte della ballata pag. 301.
2h
George Gordon Byron: the Byronic hero, (main features)
2h
Percy B. Shelley: England in 1819, (testo in fotocopia)
3h
John Keats: Ode on a Grecian Urn, pag. 321.
4h
Novembre - Dicembre
Confronto tra London by W. Blake, Composed upon Westminster Bridge
by W. Wordsworth e England 1819 by P.B. Shelley.
1h
The Victorian Age:
historical, social and literary background
3h
The Early Victorian novels:
Charles Dickens, Oliver Twist, pag. 26
Lettura del brano a pag. 29-30
2h
Gennaio - Febbraio
The Mid- Victorian novels:
Charlotte Brontë, Jane Eyre, pag. 36
Lettura dei brani a pag. 37-41
3h
Jean Rhys, The Wide Sargasso Sea,
(main features of the novel, fotocopia)
3h
The Late Victorians:
Thomas Hardy, Tess f the d’Urbervilles, pag. 49
Lettura del brano a pag. 52-54
5h
Aestheticism:
The precursors of the Aesthertic movement (W.Peter, Dante Gabriel
Rossetti, J. Ruskin: materiali in fotocopia)
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, pag. 64
Lettura della Preface
Lettura e analisi di un testo in fotocopia
Marzo - Maggio
7h
29
Victorian Poetry:
Alfred, Lord Tennyson, pag. 83
Ulysses, pag. 84
3h
The Twentieth Century (part 1):
Historical, social and literary background
the psychological novel
the stream of consciousness fiction
the Interior Monologue
3h
Joseph Conrad, Heart of Darkness, pag.158
Lettura del testo a pag. 162
3h
James Joyce, Dubliners, pag. 174
The Dead, pag. 181
Lettura della parte finale della short story
4h
Virginia Woolf, pag. 189
A room of one’s own, (fotocopia)
Lettura e analisi di un estratto in fotocopia: Judith Shakespeare
4h
Ore di verifica (scritte e orali): tutte le ore restanti sono state dedicare
alla somministrazione di verifiche scritte e orali
Ore di progetto
2h
Ore svolte nella settimana di recupero e approfondimento
4h
GLI ARGOMENTI IN PROGRAMMA SARANNO OGGETTO DI SPIEGAZIONE FINO AL GIORNO
18/05/2013. DOPO TALE
DATA LE LEZIONI IN CLASSE SARANNO DEDICATE AL RIPASSO DI TUTTI GLI AUTORI SVOLTI.
METODI
Le lezioni hanno alternato momenti di lezione frontale in cui l’insegnante ha introdotto degli argomenti utili
ed indispensabili per la comprensione dei lavori che gli studenti hanno svolto, a momenti di interazione,
confronto e riflessione tra studenti e tra studenti ed insegnante.
Gli argomenti sono stati presentati in collaborazione tra gli studenti, che sono stati invitati dall’insegnante, in
particolare nel secondo quadrimestre, a introdurre periodi letterari ed autori ai compagni, avendo quindi un
ruolo attivo non solo nel momento della verifica ma anche in quello della spiegazione.
MATERIALI DIDATTICI, MEZZI E SPAZI
Il libro di testo:
LETTERATURA:
Medaglia C., Young B. A., With Rhymes and Reason 1-2, Loescher Ed.
LINGUA
Brook-Hart G., Complete First Certificate, Cambridge Ed.
Per migliorare la didattica l’insegnante si è avvalsa dell’uso di fotocopie, di materiale aggiuntivo, di lucidi,
video, dizionario monolingue e bilingue.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le verifiche si sono sempre svolte in classe; due prove scritte nel primo quadrimestre e quattro nel secondo
quadrimestre. Le prove orali sono state almeno due per quadrimestre.
Le prove di verifica scritte sono stati svolti in forma di questionari a domande aperte sugli gli argomenti
trattati in classe.
Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle Linee Generali della didattica della disciplina che si trovano nel
POF dell’Istituto che sono state concordate tra tutti i docenti della disciplina.
30
Docente: Prof.ssa Mazzilli Nicoletta
Materia: storia
Classe: 5A
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE:
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono:
§
L’ evoluzione e lo sviluppo dei fatti storici nella loro successione cronologica della storia italiana ed
europea dalla seconda metà dell’Ottocento fino alla fine della prima metà del 1900.
COMPETENZE:
Alla fine dell’ anno scolastico gli alunni sanno:
§
riferire in modo chiaro e coerente fatti, eventi e processi;
§
cogliere la complessità del fatto storico oggetto di studio, evitando le interpretazioni semplicistiche e
unilaterali superando una visione frammentaria della storia;
§
Individuare cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici, distinguendo tra le diverse tipologie
(naturali, umane, politiche, economiche, socio-culturali…)
CAPACITÀ:
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
§
operare collegamenti fra le conoscenze in chiave sincronica;
§
applicare processi di analisi e sintesi rispetto ai contenuti;
§
elaborare una prospettiva critica tra passato e presente.
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:
Modulo / U.D. / Percorso formativo / Approfondimento
L’Europa nella seconda metà del XIX.
Il processo di unificazione tedesco e il II Reich. Bismarck: la Kulturkampf
e leggi antisocialiste, politica estera alla ricerca di un equilibrio europeo.Il
processo di unificazione italiana: politica cavouriana, II guerra
d’Indipendenza, la spedizione dei mille. I governi della destra storica:
problemi politici, economici culturali connessi alla formazione dello stato
unitario. La III guerra d’Indipendenza, la questione romana e leggi delle
guarentigie. La sinistra storica: la questione sociale e meridionale, il
trasformismo di Agostino Depretis e i governi di Francesco Crispi.
Periodo /ore
Settembre-Novembre
(18 ore)
Approfondimenti:
Una radiografia dell’Italia nel 1861. (fornite fotocopie tratte dal manuale “Chiaro
Scuro” voll.2)
La seconda rivoluzione industriale e la grande depressione di
fine secolo.
Evoluzione scientifica, tecnologica ed economica. Impatto sociale dello
sviluppo tecnico-scientifico. Trasformazioni interne del sistema
capitalistico: nascita del capitalismo finanziario, internazionalizzazione
dell’economia, ottimizzazione dei cicli produttivi e il taylorismo. Grande
depressione di fine secolo e svolta protezionistica. Sviluppo dei movimenti
socialisti di fine secolo: rivendicazioni operaie e la seconda internazionale.
L’ Europa a cavallo tra due secoli.
L’età giolittiana: trasformazioni politiche, economiche e sociali. La
Germania di Guglielmo II. Linee generali dell’imperialismo. (consegnate
fotocopie). I nazionalismi di fine secolo. La situazione internazionale alla
31
Novembre-Dicembre
(8 ore)
Gennaio
(4 ore)
vigilia del conflitto: suddivisione dell’Europa in due blocchi.
Approfondimenti:
La grande migrazione nell’età giolittiana (fornite fotocopie tratte dal manuale
“ la Storia e identità” voll.3).
La prima guerra mondiale e le rivoluzione russe.
La prima guerra mondiale: cause del conflitto, il piano Schieffen. La
guerra di logoramento: tattiche belliche, tecnologia militare e impatto
sociale delle nuove armi di distruzione di massa. Intervento italiano: patto
di Londra, divisione tra interventisti e neutralisti. La situazione sui fronti
nel 1916 e la Strafexpedition. Il 1917: il ritiro della Russia ed intervento
statunitense. 1918: cause politiche e sociali della caduta degli imperi
centrali. I trattati di pace e la nascita della Società delle Nazioni.
Gennaio-Febbraio
(12 ore)
Situazione dell’ Impero Russo nei primi del 1900 e la rivoluzione del 1905.
Menscevichi e Bolscevichi. Progetto politico di Lenin: le Tesi Aprile. La
Rivoluzione di Febbraio e di Ottobre.
Il dopoguerra in Italia e in Europa.
Problemi politici ed economici dell’Italia e dell’Europa nel dopoguerra.
Vittoria mutilata e reggenza del Carnaro. Il biennio rosso in Italia.
Cambiamenti delle forze politiche in Italia: l’ultimo governo di Giovanni
Giolitti, nascita del partito popolare di don Luigi Sturzo, dei fasci di
combattimento e situazione delle sinistre. L’avvento del fascismo: dal
fascismo agrario alla Marcia su Roma. Il primo governo di Mussolini, la
Legge Acerbo, il Delitto Matteotti, le leggi fascistissime.
Politica
economica fascista negli anni venti e trenta. Il totalitarismo fascista: dalla
creazione dell’Ovra all’istituzione del ministero per la cultura popolare.
Connubio tra fascismo e chiesa: i patti lateranensi.
Febbraio-Marzo
(13 ore)
Approfondimenti:
Il programma dei fasci di combattimento (fornite fotocopie tratte dal manuale “ la
Storia dei mille anni” voll.3).
La Russia Staliniana.
Guerra civile tra armata e armata rossa. Internazionale comunista.
Politica economica dal comunismo di guerra alla Nep. La creazione del
URSS. Il totalitarismo di Stalin: obiettivi della politica staliniana dal 1928, i
piani quinquennali e la statalizzazione dell’economia. La strage dei kulaki,
i gulag e sistemi repressivi del regime staliniano.
Lo Stato Nazista.
Il dopoguerra in Germania: dal governo di Ebert al piano Dawes. Ricerca
di un equilibrio in Europa: gli accordi di Locarno
Il totalitarismo nazista: il programma dell’NSDAP e l’ideologia
nazionalsocialista. L’ascesa al potere di Hitler dal putsch di Monaco alla
formazione del III Reich. Antisemitismo: dalle leggi di Norimberga alla
soluzione finale. Strumenti di formazione e di controllo del consenso:
dall’istituzione delle SA/SS alla formazione del ministero per la
propaganda.
Aprile
(9 ore)
Approfondimenti:
W. Hofer, Hitler e l’Educazione dei giovani. (fornite fotocopie tratte dal manuale
“Dentro la Storia” voll.3)
La seconda guerra mondiale
Politica estera dello Stato Nazista e Fascista. Cause della seconda guerra
mondiale. Situazione sui fronti nel biennio 1939-1940: la repubblica di
Vichy e i governi collaborazionisti. Intervento italiano, operazione Leone
Marino. Operazione Barbarossa e intervento statunitense.
Maggio
(5 ore)
Crollo del fascismo, la Repubblica di Salò. Resistenza in Europa e in Italia.
La resa delle potenze dell’Asse. Il bombardamento di Hiroschima e
Nagasaki. I trattati di Pace.
Dal 15 maggio in poi
32
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico
Nel conteggio complessivo del monte ore annuale, aggiornate al 12 maggio 2012, sono state
inserite le ore effettive di lezione svolte, le ore dedicate alle verifiche orali e scritte.
68
Inoltre sono state dedicate alcune ore nel primo mese di scuola al recupero per sommi capi del programma
dell’anno precedente. Tale parte, che comprende l’arco temporale che si estende dal Congresso di Vienna
fino ai moti del quarantotto in Italia, non è stato volontariamente inserito nel programma che sarà oggetto
d’esame.
2. METODI
La metodologia si è articolata in lezioni frontali e dialogate, articolate nella presentazione della
complessità dei fenomeni storici, finalizzate ad offrire un percorso di lettura e analisi storica non
deterministica. Nella trattazione degli argomenti, inoltre, e’ stata dato maggiore rilievo più che alla
tematizzazione delle biografie dei grandi attori della storia, al chiarimento delle dinamiche sociali,
economiche, storiche che hanno condotto alla loro ascesa.
3. MATERIALI DIDATTICI, MEZZI E SPAZI
Libro di testo: Giardina, Sabatucci, Vidotto, Nuovi profili storici del 1900 a oggi, Laterza (vol.3). Per la
trattazione degli argomenti trattati nella prima parte dell’anno e’ stato utilizzato: Giardina, Sabatucci
Nuovi profili storici del 1650 al 1900, Laterza (vol.3).
4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Nel corso dell’anno sono state svolte due simulazioni di terza prova, due verifiche orali e due verifiche
semistrutturate.
33
Docente: Prof.ssa Mazzilli Nicoletta
Materia: filosofia
Classe: 5A
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE:
§
Acquisizione dei contenuti essenziali e dei problemi fondamentali propri della filosofia di fine ottocento e
novecento.
§
Il lessico e le categorie fondamentali della tradizione filosofica con particolare riferimento alla filosofia
contemporanea.
COMPETENZE:
Alla fine dell’ anno scolastico gli alunni sanno:
§
Comunicare in modo chiaro i contenuti appresi sia in forma orale che in forma scritta;
§
Supportare le proprie affermazioni con argomentazioni razionali;
CAPACITÀ:
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
§
Confrontare e contestualizzare le diverse risposte date dai filosofi allo stesso problema;
§
Ricostruire il pensiero di un autore a partire da un determinato aspetto, realizzando opportuni
collegamenti;
§
applicare processi di analisi e sintesi rispetto ai contenuti
5. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:
Modulo / U.D. / Percorso formativo / Approfondimento
Periodo /ore
Il criticismo Kantiano:
La rivoluzione copernicana di Kant; le facoltà conoscitive, i principi a
priori, la distinzione tra noumeno e fenomeno. La critica della Ragion
Pura:fondazione del sapere scientifico. Estetica trascendentale: statuto
della sensibilità e le forme a priori di spazio e tempo; Analitica
trascendentale: statuto dell’intelletto, funzione delle categorie, deduzione
trascendentale e l’Io penso kantiano. Dialettica trascendentale: critica alla
metafisica tradizionale, idee trascendentali.
Critica della Ragion Pratica: il problema morale in Kant, massime,
imperativo ipotetico e categorico. Formalismo ed intenzionalità dell’etica
kantiana. I postulati della ragione pratica.
Settembre-Novembre
(21 ore)
Romanticismo e Idealismo tedesco.
Romanticismo tedesco: caratteristiche generali.
Hegel:i capisaldi del sistema hegeliano e la dialettica. Enciclopedia delle
scienze filosofiche: cenni alla logica hegeliana, filosofia della natura,
filosofia dello spirito soggettivo, oggettivo e assoluto.
Dicembre - Febbraio
Romanticismo (2 ore)
Hegel (12 ore)
Marx:
Critica a Feuerbach. Caratteristiche della società borghese e alienazione
economica. Il Capitale: il lavoro quale merce, plus-lavoro e plus-valore,
cause e conseguenze della caduta tendenziale del saggio del profitto,
crollo della società capitalistica. Il materialismo storico.
Marzo
(6 ore)
Schopenhauer:
Opposizione al realismo hegeliano. Ripresa del kantismo e dualismo tra
volontà e rappresentazione. Il corpo e la metafisica della volontà. Le vie
Marzo
(5 ore)
34
di liberazione dal dolore: arte, morale della compassione ed ascesi. Critica
all’ottimismo storico e sociale.
Il positivismo:
Caratteristiche generali del positivismo. Comte: concezione della scienza,
filosofia della storia e legge dei tre stadi. La classificazione delle scienze. I
compiti della filosofia. La sociologia e l’umanità come Grande- Essere.
Nietzsche:
La Nascita della Tragedia. Socrate e l’esaltazione del concetto. La
considerazione della Storia. Critica alla morale e alla religione. La morte di
Dio, il nichilismo attivo e passivo. L’Uber-Mensch e la volontà di potenza.
Freud e la rivoluzione psicoanalitica:
La psicoanalisi quale nuova chiave interpretativa dell’uomo, la scoperta
dell’inconscio, il determinismo psichico e il tema della responsabilità nella
psicoanalisi. La rimozione, funzione del sogno e leggi di costruzione della
scena onirica. Prima e seconda topica. Il disagio della civiltà e il concetto
di Eros e Thanatos.
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico
Aprile
(5 ore)
Aprile
(5 ore)
Dal 15 maggio in poi
60
Nel conteggio complessivo del monte ore annuale, aggiornate al 8 maggio 2012, sono state inserite le
ore effettive di lezione svolte, le ore dedicate alle verifiche orali e scritte
METODI
Le lezioni sono state prevalentemente frontali, sia per sopperire ad alcune difficoltà palesate nel
confronto autonomo con il manuale, sia per dare continuità la metodologia didattica scelta dai docenti
dei precedenti anni; nonostante questo, comunque, si è cercato di coinvolgere il più possibile gli
studenti, stimolando e valorizzando domande ed approcci personali agli argomenti trattati.
MATERIALI DIDATTICI, MEZZI E SPAZI
Libro di testo: Abbagnano-Fornero, Itinerari di Filosofia, protagonisti, testi, temi e laboratori, Paravia
vol.2a, 2b Laterza (vol.3). Per la trattazione di alcuni argomenti sono state consegnate fotocopie tratte
dal testo “Comunicazione Filosofica” di Domenico Massaro e consigliata la consultazione del sito
dell’Istituto Italiano di Studi filosofici (saggi per la scuola curato da Antonio Gargano).
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Nel corso dell’anno sono state svolte una simulazioni di terza prova, due verifiche orali e due verifiche
semistrutturate.
35
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2012/13
Docente: Bortignon Regina
Materia: Matematica Classe: 5^A
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
COMPETENZE:
Alla fine dell’ anno scolastico gli alunni sanno:
§
RICONOSCERE E UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELL’ANALISI INFINITESIMALE IN DIVERSI CONTESTI
§
ESPRIMERE LE RELAZIONI TRA DIVERSI FENOMENI MEDIANTE FUNZIONI MATEMATICHE
§
UTILIZZARE MODELLI MATEMATICI PER LO STUDIO DI DIVERSI FENOMENI
§
UTILIZZARE IN MODO CRITICO E CONSAPEVOLE GLI STRUMENTI MATEMATICI ACQUISITI
§
§
§
ESPORRE CON UN LINGUAGGIO PRECISO LE INFORMAZIONI ACQUISITE E ANALIZZARE CRITICAMENTE I RISULTATI
RAGGIUNTI
RICONOSCERE ANALOGIE IN CONTESTI PROBLEMATICI DIVERSI, INDIVIDUANDO ADEGUATE STRATEGIE RISOLUTIVE
EVIDENZIARE LO STRETTO LEGAME TRA LO SVILUPPO DEL PENSIERO MATEMATICO E IL CONTESTO STORICO,
SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
ABILITÀ:
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
§
INDIVIDUARE IL DOMINIO DI UNA FUNZIONE, RICONOSCERE LE PROPRIETÀ DI CUI ESSA GODE, STUDIARNE
L’ANDAMENTO
§
RAPPRESENTARE GRAFICAMENTE UNA FUNZIONE
§
UTILIZZARE LE ABILITÀ DI CALCOLO PER LO STUDIO DI UNA FUNZIONE
§
RICONOSCERE LE FIGURE NELLO SPAZIO
§
CALCOLARE AREE E VOLUMI
§
APPLICARE I TEOREMI DELL’ANALISI A SITUAZIONI PROBLEMATICHE
§
RISOLVERE PROBLEMI CON DIVERSE PROCEDURE DI CALCOLO PER INDIVIDUARE QUELLA PIÙ SINTETICA E ADEGUATA
ALLA SITUAZIONE
CONOSCENZE:
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono:
§
IL CONCETTO DI FUNZIONE REALE DI VARIABILE REALE E DI SUCCESSIONE
§
LA CLASSIFICAZIONE E LE PROPRIETÀ DELLE FUNZIONI
§
LA DEFINIZIONE DI LIMITE DI UNA FUNZIONE E I TEOREMI RELATIVI
§
LA DEFINIZIONE DI DERIVATA DI UNA FUNZIONE, IL SUO SIGNIFICATO GEOMETRICO, I TEOREMI RELATIVI E LE REGOLE
DI DERIVAZIONE
§
IL CONCETTO DI MASSIMO E MINIMO, DI PUNTO CRITICO E DI FLESSO PER UNA FUNZIONE
§
IL SIGNIFICATO DI ASINTOTO DI UNA FUNZIONE
§
IL CONCETTO DI INTEGRALE INDEFINITO E DEFINITO E I METODI DI INTEGRAZIONE
§
I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE
§
LE PROPRIETÀ DELLE FIGURE NELLO SPAZIO
§
IL CALCOLO DI AREE E VOLUMI DI SOLIDI PARTICOLARI
§
SEMPLICI ELEMENTI DI CALCOLO COMBINATORIO
36
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:
UNITᾺ DIDATTICA
Periodo /ore
1- Nozioni di topologia su R. Funzioni in R.
Il campo dei numeri reali. Insiemi di numeri reali. Relazioni tra punto
e insieme. Estremo superiore e inferiore di un insieme di numeri reali.
Funzioni reali di una variabile reale. Classificazione delle funzioni.
Rappresentazione di una funzione. Proprietà specifiche di alcune
funzioni. Grafici notevoli di funzioni elementari. Trasformazioni
elementari del grafico di funzioni. Funzione composta.
Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione. Funzioni
inverse. Funzioni goniometriche inverse.
Settembre – ottobre
18 ore
2- Limiti.
Limite finito e infinito di una funzione in un punto. Limite destro e
limite sinistro di una funzione in un punto. Limite finito e infinito di
una funzione all’infinito. Teoremi fondamentali sui limiti. Infinitesimi.
Operazioni sui limiti. Forme indeterminate o di indecisione.
Progressioni aritmetiche e geometriche. Successioni. Successioni
convergenti, divergenti, indeterminate. Proprietà delle successioni.
Ottobre – dicembre
18 ore
3- Funzioni continue.
Definizione. Continuità delle funzioni elementari. Funzioni continue in
un intervallo chiuso e limitato. Continuità delle funzioni composte.
Continuità delle funzioni inverse. Limiti fondamentali. Limiti notevoli.
Infinitesimi. Punti di discontinuità di una funzione. Asintoti. Primo
approccio al grafico di una funzione.
4- Derivate delle funzioni di una variabile.
Introduzione al concetto di derivata. Derivata di una funzione in un
punto. Calcolo della derivata in un punto. Continuità e derivabilità.
Significato geometrico della derivata. Funzione derivata. Derivata di
alcune funzioni elementari. Teoremi sulle derivate. Derivata di una
funzione composta. Derivata logaritmica. Derivata delle funzioni
inverse. Derivate di ordine superiore. Applicazioni delle derivate.
Dicembre – gennaio
12 ore
Gennaio – marzo
11 ore
5- Teoremi fondamentali del calcolo differenziale in R.
Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange o del valor medio.
Conseguenze del teorema di Lagrange. Teorema di Cauchy o degli
incrementi finiti. Teorema di de L’Hospital. Altre forme di indecisione.
Differenziale e suo significato geometrico.
6- Estremi. Studio di una funzione.
Massimi e minimi relativi. Studio degli estremi relativi con la derivata
37
Marzo – aprile
11 ore
Aprile
12 ore
prima. Studio degli estremi relativi con le derivate successive.
Massimi e minimi assoluti. Problemi di massimo e di minimo.
Concavità e punti di flesso. Punti di una curva a tangente verticale.
Studio di una funzione.
7- Integrali.
Integrale definito
Problema delle aree. Area del trapezoide. Integrale definito. Proprietà
dell’integrale definito e teorema della media. Funzioni primitive.
Funzione integrale: teorema di Torricelli - Barrow e formula di
Newton - Leibiniz.
Integrale indefinito
Integrale indefinito di una funzione continua. Integrali indefiniti
immediati. Proprietà dell’integrale indefinito. Integrazione per
sostituzione, per scomposizione e per parti.
Applicazioni dell’integrale definito
Calcolo di aree. Area della superficie limitata da due curve. Volume di
un solido di rotazione. Arco di
linea. Superficie di rotazione.
Estensione del concetto di integrale
Integrale generalizzato per funzioni illimitate. Integrale generalizzato
su intervalli illimitati.
Aprile – maggio
10 ore
Argomenti previsti dopo il 13 maggio: studio di alcuni elementi di
calcolo combinatorio e studio dei solidi notevoli.
Maggio
5 ore
Ore effettivamente svolte dal docente fino al 13 maggio
92
Ore di lezione impiegate in attività progettuali
5
Ore di lezione dal 13 maggio alla fine dell’anno scolastico
8
2. METODI (Lezione frontale, gruppi di lavoro processi individualizzati, attività di recupero - sostegno e integrazione….)
§
LEZIONE FRONTALE
§
§
ESERCITAZIONE GUIDATA
ESERCITAZIONE INDIVIDUALE
§
§
CORREZIONE DEGLI ESERCIZI ASSEGNATI COME MOMENTO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
UTILIZZO DELL’ERRORE COME STRATEGIA DI APPRENDIMENTO
3. MATERIALI DIDATTICI, MEZZI E SPAZI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, biblioteca,
tecnologie audiovisive e/o multimediali...):
§
TESTI IN ADOZIONE:
“ ARCHITETTURE DI MATEMATICA” VOL.3: ANALISI INFINITESIMALE
- CASA EDITRICE: CEDAM
“MODULI DI LINEAMENTI DI MATEMATICA” VOL. E: GEOMETRIA EUCLIDEA NELLO SPAZIO
AUTORI: N. DODERO – P. BARONCINI – R. MANFREDI – CASA EDITRICE: GHISETTI & CORVI
§ APPUNTI DELL’INSEGNANTE E FOTOCOPIE
AUTORE: M. SCOVENNA
4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare (prove scritte, verifiche orali, test aggettivi come
previsti dalla terza prova, prove grafiche, prove di laboratorio…)
§
§
§
PROVE SCRITTE
PROVE ORALI
SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA D’ESAME: 16 MAGGIO. DURATA: 5 ORE.
SONO STATE EFFETTUATE 6 PROVE SCRITTE E ALMENO 1 PROVA ORALE PER TUTTI GLI STUDENTI
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove scritte effettuate.
38
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO
2012/13
Docente: Bortignon Regina
Materia: Fisica
Classe: 5^A
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
COMPETENZE:
Alla fine dell’ anno scolastico gli alunni sanno:
§
OSSERVARE E IDENTIFICARE LE DIVERSE TIPOLOGIE DI FENOMENI
§
FORMULARE IPOTESI ESPLICATIVE UTILIZZANDO MODELLI, ANALOGIE E LEGGI
§
FORMALIZZARE UN PROBLEMA DI FISICA E APPLICARE GLI STRUMENTI MATEMATICI E DISCIPLINARI RILEVANTI PER LA SUA
SOLUZIONE
§
UTILIZZARE IL LINGUAGGIO FISICO ADEGUATO ALLA SITUAZIONE E AL CONTESTO
§
COMPRENDERE E VALUTARE LE SCELTE SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE CHE INTERESSANO LA SOCIETÀ IN CUI VIVONO
ABILITÀ:
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
§
INDIVIDUARE I NODI CONCETTUALI DEGLI ARGOMENTI SVOLTI
§
INDIVIDUARE ANALOGIE E DIFFERENZE TRA FENOMENI FISICI DIVERSI
§
COSTRUIRE MODELLI MATEMATICI DI SITUAZIONI FISICHE PROBLEMATICHE
§
RICONOSCERE I LIMITI E LE APPROSSIMAZIONI DI UN MODELLO FISICO
§
RISOLVERE PROBLEMI E DISCUTERNE I RISULTATI DAL PUNTO DI VISTA FISICO
§
RICONOSCERE I LEGAMI DELLA FISICA CON LE ALTRE DISCIPLINE
CONOSCENZE:
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono:
§
LE LEGGI FONDAMENTALI DEI FENOMENI ELETTRICI E MAGNETICI
§
I CAMPI ELETTRICO E MAGNETICO E I RELATIVI MODELLI FISICI
§
LE EQUAZIONI DI
MAXWELL COME SINTESI DELL’ELETTROMAGNETISMO
5. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:
UNITᾺ DIDATTICA
Periodo /ore
1 - La carica elettrica e la legge di Coulomb
Elettrizzazione per strofinio. Conduttori e isolanti. Definizione operativa
della carica elettrica. La legge di Coulomb. L’esperimento di Coulomb. La
forza di Coulomb nella materia. L’elettrizzazione per induzione.
Settembre
3 ore
39
2 - Il campo elettrico
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le
linee del campo elettrico. Il flusso del campo vettoriale attraverso una
superficie. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss.
Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica.
Altri campi elettrici con particolari simmetrie.
3 - Il potenziale elettrico
L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. Le superfici
equipotenziali. La deduzione del campo elettrico dal potenziale. La
circuitazione del campo elettrostatico.
4 - Il modello atomico
L’esperienza di Rutherford. L’esperimento di Millikan. Il modello di Bohr.
L’energia di legame di un elettrone in un atomo di idrogeno.
5 - Fenomeni di elettrostatica
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Il
campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio. Il problema
generale dell’elettrostatica: il teorema di Coulomb. La capacità di un
conduttore. Il condensatore. Condensatori in serie e in parallelo.
L’energia immagazzinata in un condensatore.
6 - La corrente elettrica continua
L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti
elettrici. La prima legge di Ohm. I resistori in serie e in parallelo. Le leggi
di Kirchhoff. La trasformazione dell’energia elettrica. La forza
elettromotrice.
7 – La corrente elettrica nei metalli
I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm. La dipendenza della
resistività dalla temperatura. Carica e scarica di un condensatore.
L’estrazione degli elettroni da un metallo. L’effetto Volta. L’effetto
termoelettrico.
8 – La corrente elettrica nei liquidi e nei gas.
Le soluzioni elettrolitiche. L’elettrolisi. Le leggi di Faraday per l’elettrolisi.
La conducibilità nei gas.
9 – Fenomeni magnetici fondamentali
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e
correnti. Forze tra correnti. L’intensità del campo magnetico. La forza
magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo
percorso da corrente. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide.
Il motore elettrico.
10 – Il campo magnetico
La forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica. Il moto di una carica in
40
Ottobre
7 ore
Ottobre – novembre
5 ore
Novembre
4 ore
Novembre
6 ore
Dicembre - gennaio
8 ore
Gennaio
8 ore
Febbraio - Marzo
6 ore
Marzo – aprile
9 ore
Aprile
8 ore
un campo magnetico uniforme. Il flusso del campo magnetico. La
circuitazione del campo magnetico. Le proprietà magnetiche dei materiali.
Il ciclo di isteresi magnetica.
11 – L’induzione elettromagnetica
La corrente indotta. La legge di Faraday- Neumann. La legge di Lentz.
L’autoinduzione e la mutua induzione. Energia e densità di energia del
campo magnetico.
Maggio
3 ore
Argomenti previsti dopo il 13 maggio:
12 – Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche.
Il campo elettrico indotto. Il termine mancante. Le onde
elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico.
Ore previste: 5
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico
Rimangono da svolgere 9 ore, 5 delle quali si prevede di utilizzarle per completare il
programma, le rimanenti per ripassare gli argomenti svolti.
Durante l’anno 6 ore di lezioni sono state impiegate per consentire lo svolgimento di attività
progettuali.
Il numero ridotto di ore svolte non hanno consentito lo svolgimento dell’unità didattica: la
relatività.
67
2. METODI
§
LEZIONE FRONTALE
§
ESERCITAZIONE GUIDATA
§
CORREZIONE DELLE ESERCITAZIONI A CASA COME MOMENTO DI VERIFICA DELLA CAPACITÀ APPLICATIVA
§
UTILIZZO DELL’ERRORE COME STRATEGIA DI APPRENDIMENTO
3. MATERIALI DIDATTICI, MEZZI E SPAZI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, biblioteca,
tecnologie audiovisive e/o multimediali...):
§
TESTO IN ADOZIONE: “LA FISICA DI AMALDI: ELETTROMAGNETISMO – FISICA MODERNA”
AUTORE: UGO AMALDI CASA EDITRICE: ZANICHELLI
▪
SUSSIDI AUDIOVISIVI
4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare (prove scritte, verifiche orali, test aggettivi come
previsti dalla terza prova, prove grafiche, prove di laboratorio…)
§
QUESITI A RISPOSTA BREVE
§
RISOLUZIONE DI PROBLEMI
§
PROVE ORALI
Sono state svolte 3 prove scritte di Fisica, una simulazione di terza prova e almeno una verifica orale.
A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove di verifica effettuate.
41
RELAZIONE SUL PROGRAMMA DI SCIENZE
Docente prof. Armando Campana
Ore di lezione effettuate
55 su 66. In realtà il monte ore è stato inferiore a causa
dell'impegno del docente come vicario del preside in riunioni e gestione della scuola.
Il programma ha previsto lo svolgimento di 2 argomenti fondamentali: astronomia e geologia.
OBIETTIVI CONSEGUITI
Conoscenze:
ú forma e dimensioni della Terra
ú la rotazione terrestre
ú la rivoluzione terrestre
ú moti millenari della Terra
ú caratteri fisici della Luna e movimenti lunari
ú geomorfologia lunare e origine della Luna
ú strutture solari
ú caratteristiche generali di pianeti, asteroidi e comete
ú caratteristiche ed evoluzione delle stelle
ú struttura ed evoluzione del cosmo
ú minerali e rocce
ú rocce magmatiche e strutture vulcaniche
ú rocce sedimentarie e ambienti di sedimentazione
ú metamorfismo e rocce metamorfiche
ú pieghe e faglie
ú fenomeni sismici e interno della Terra
ú caratteri fisici della Terra
ú crosta oceanica e crosta continentale
ú teorie orogenetiche
ú fondali oceanici
Comprensione
ú discutere le tappe della rappresentazione della superficie terrestre
ú saper interpretare prove e conseguenze della rotazione terrestre
ú saper interpretare prove e conseguenze della rivoluzione terrestre
ú riconoscere le conseguenze climatiche dei moti millenari della Terra
ú interpretare fasi lunari ed eclissi in relazione ai moti lunari
ú interpretare origine e funzionamento del Sole
ú saper interpretare e differenziare le caratteristiche dei corpi del sistema solare, anche in
relazione all'origine del sistema solare
ú comprendere le condizioni fisiche di formazione e di evoluzione di una stella
ú discutere le varie ipotesi su struttura ed evoluzione del cosmo
ú interpretare le condizioni di formazione dei diversi tipi di roccia magmatiche
ú interpretare la distribuzione e le caratteristiche dei vulcani
ú interpretare le condizioni di formazione di rocce sedimentarie e magmatiche
ú comprendere i metodi di studio delle strutture geologiche
ú riconoscere gli elementi di interpretazione di evoluzione del paesaggio geologico
ú interpretare il fenomeno sismico
ú spiegare le proprietà fisiche della Terra
ú riconoscere le caratteristiche della crosta oceanica e di quella continentale
ú spiegare la teoria della tettonica delle placche
ú collegare in modo sistematico e coerente i fenomeni sismici, vulcanici, orogenetici con le
strutture litosferiche e il modello globale della tettonica a placche
Capacità
ú capacità di esporre le conoscenze in modo completo e rigoroso
42
ú
ú
ú
ú
ú
capacità di valutazione complessiva dei fenomeni, capacità di sintesi e di sviluppare gli
opportuni collegamenti
capacità di approfondimento, sfruttando conoscenze propedeutiche di fisica, chimica,
geografia generale
mettere in relazione spazio-temporale il pianeta Terra con il resto dell'Universo
osservare e descrivere fenomeni celesti disponibili dall'esperienza diretta
capacità di svolgere approfondimenti autonomi nell'ambito delle Scienze della Terra
sfruttando conoscenze propedeutiche di fisica, chimica, geografia generale
METODOLOGIA e TEMPI
Il metodo adottato è stato essenzialmente la lezione frontale e lo strumento di lavoro il libro di
testo (nel quadro riassuntivo del programma sono specificate le parti svolte).
Nel quadro riassuntivo del programma sono indicate le ore di lezione effettivamente svolte nei
singoli moduli.
STRUMENTI E CRITERI DELLA VALUTAZIONE
Gli strumenti e i criteri di valutazione hanno fatto riferimento alle decisioni assunte a livello di
dipartimento e presenti nel P.O.F.
Le valutazioni sono state sia di tipo orale che scritto ed hanno interessato 15 lezioni. In ogni
quadrimestre sono state effettuate 1 o 2 interrogazioni per alunno, 1 o 2 test scritti, 2
simulazioni di Terza Prova.
La valutazione ha accertato il raggiungimento degli obiettivi generali e il possesso delle
conoscenze e delle abilità disciplinari.
Il raggiungimento della sufficienza è corrisposto al possesso di conoscenze essenziali,
rielaborazione accettabile ma a volte poco precisa, esposizione coerente anche se con qualche
imprecisione.
Le valutazioni scritte erano composte da due parti: una parte (42 punti) prevedeva risposte
brevi a domande aperte, l'altra parte (48 punti) era composta da domande chiuse (vero-falso,
a scelta), la sufficienza corrispondeva a 50 punti.
43
PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI
SVOLTO DALLA CLASSE V^ sez. A a.s. 2012-2013
ARGOMENTO
GENERALE
Introduzione
all’astronomia
SVILUPPO ANALITICO
·
·
TEMPI
la sfera celeste, moto diurno, moto annuo
teoria tolemaica e teoria copernicana, Galilei,
Keplero
forma e dimensioni della Terra, reticolo geografico
moti apparenti di Sole, stelle e pianeti
3 lez.
Settembre
movimenti della terra: prove e conseguenze di
rotazione e rivoluzione. Le stagioni. Moti millenari
misura del tempo. Determinazione delle coordinate
8 lez.
Ottobre /
novembre
·
·
la Luna: caratteri fisici, movimenti, fasi lunari ed
eclissi, geomorfologia e origine, le maree
classificazione e descrizione dei pianeti, le comete
formazione del Sole, origine del sistema solare
6 lez.
Novembre /
dicembre
Le stelle
·
·
·
·
·
radiazione elettromagnetica e metodi di indagine
caratteristiche e proprietà delle stelle
diagramma H-R
evoluzione stellare
formazione degli elementi
6 lez.
Gennaio
Cosmologia
·
gli oggetti del cosmo: stelle, nebulose, quasar,
galassie
origine e storia dell'universo
·
·
Il pianeta Terra
·
·
I corpi del sistema
solare
·
·
Geologia descrittiva
·
·
·
·
·
Geofisica
·
·
·
·
·
·
·
3 lez.
Gennaio /
febbraio
classificazione di rocce e minerali
rocce ignee, origine dei magmi
i vulcani (struttura, eruzioni, attività,
distribuzione)
rocce sedimentarie, ambienti sedimentazione e
stratigrafia
tipi di metamorfismo e rocce metamorfiche
la tettonica: pieghe e faglie
i terremoti: origine, misura, distribuzione
modello dell’interno della Terra e strutture
litosferiche
calore interno e magnetismo
teorie orogenetiche
fondali oceanici
tettonica delle placche
7 lez
Febbraio /
marzo
7 lez.
Aprile - maggio
Testo
Lupia Palmieri - Parotto IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE – Zanichelli 2008
Cap. 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 14.4.2 – 16.7.1
44
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2012/2013
ALLEGATO 10
Docente: Tuscano Mario
Materia: disegno e storia dell'arte Classe: A025
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini
di:
CONOSCENZE:
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono:
le principali correnti artistiche della pittura, architettura e scultura dal periodo Rococò fino ai giorni nostri;
•
il linguaggio specifico della materia;
COMPETENZE:
Alla fine dell’ anno scolastico gli alunni sanno:
§
rapportare le conoscenze acquisite nell’ambito della storia dell’arte a quelle delle altre discipline;
§
utilizzare le competenze acquisite per l'interpretazione del mondo della comunicazione per immagini, con senso
critico;
§
leggere un'opera d'arte in tutti i suoi aspetti tecnici, formali e contenutistici;
CAPACITÀ:
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
§
§
comprendere i concetti di: linea, forma, volume, composizione, spazio, colore, luce nelle opere d'arte;
§
analizzare un'immagine e collocarla nel contesto storico, sociale, ed economico;
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:
Modulo / U.D. / Percorso formativo / Approfondimento
Luigi Vanvitelli
* Filippo Juvarra: palazzina di caccia Stupinigi
Johann Balthasar Neuman la residenza di Wuerzburg
Giambattista Tiepolo: gli affreschi della residenza Di
Wuerzburg e di villa Valmarana;
Rosalba Carriera: ritratto di Anna Katharina Orzelska;
Canaletto: Il bacino di San Marco il giorno dell'ascenzione;
William Hogarth: la mattina;
*Giuseppe Jappelli: il Caffè Pedrocchi di Padova;
Antonio Canova: Dedalo e Icaro, monumento funebre a Clemente XIV, Amore e
Psiche, danzatrice con le mani sui fianchi;
Jacques Luis David: la morte di Marat, giuramento degli orazi;
Periodo /ore
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Goya: la famiglia di Carlo IV, la fucilazione, Saturno che divora uno dei suoi
figli;
Gaspar David Friedrich: Abbazia nel querceto, Viandante sul mare;
William Turner : Esequie in mare;
45
1
1
1
1
Jean Auguste Ingres: Bagnante di Valpicon;
Thèodore Gèricault : la zattera della Medusa;
Eugène Delacroix : la liberta guida il popolo;
Gustave Coubert : Funerale a Ornans
Monet : impressione levar del sole, la cattedrale di Roue; Manet la colazione
sull'erba; Renoir : il moulin de la Galette; Edgard Degas : la lezione di ballo; *
Georges Seurat: una domenica pomeriggio all'isola della grande Jatte; *Paul
Signac : Colazione;
Paol Gauguin: la visione dopo il sermone
Vincent Van Gogh : i mangiatori di patate, autoritratto, notte stellata;
* Touluse Lautrec : Moulin Rouge;
Paul Cezanne : la montagna di Sainte-Victoire
Edvard Munch: il grido;
* Giovanni Fattori : i soldati;
* Telemaco Signorini : la toeletta del mattino;
* Giovanni Segantini : le due madri;
* Giuseppe Pellizza da Volpedo : il quarto stato;
Art Nouveau : Van De Velde (scrivania);
* Victor Hortha : casa Solay;
* Gino Coppedè : palazzi degli Ambasciatori;
Antonio Gaudì : casa Mila, Sagrada Familia;
* Ludwing Kichner : Pote sul Reno;
* Matisse : la danza;
De chirico : il grande Metafisico;
Mirò : disco rosso all'inseguimento dell'allodola;
Picasso : Guernica;
Wasilj Kandinskj : paesaggio a Murnau, composizione astratta;
Umberto Boccioni : la città che sale, autoritratto;
Salvador Dalì : la giraffa in fiamme;
Amedeo Modigliani : Zingara con bambino;
Bauhaus : Walter Cropius;
Giuseppe Terragni: Casa del Fascio;
Frank Lloyd Wright : casa Kaufman (una casa sulla cascata);
Le Courbusier : Villa Savoye
* Pollock, *Burri, * Vedova
* Alberto Giacometti
* Henry Moore; * Lucio Fontana; * Andy Warhol;
Renzo Piano e richard Rogers : centro nazionale d'arte e di cultura Pompidou (
Beaubourg )
* Mario Botta : museum of Modern Art San Fracisco
Frank Owen Gehry : museo Guggenheim di Bilbao
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
N.B: gli artisti con * saranno trattati successivamente alla firma della presente relazione.
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico
57
•
METODI (Lezione frontale, gruppi di lavoro)
•
MATERIALI DIDATTICI, MEZZI E SPAZI : Testo adottato, tecnologie audiovisive e/o multimediali utilizzate in classe o
nell'aula video.
•
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE:: verifiche orali, due simulazioni scritte della terza prova di
esame.
46
Relazione Finale del Docente
Gli allievi:
ANNO SCOLASTICO
Docente: Pasinato Ugo
Materia: educazione fisica
2012/2013
Classe: 5°
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE:
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono:
Principali gesti tecnici relativi alle discipline sportive affrontate, dei fondamentali individuali e dei regolamenti
essenziali dei giochi sportivi (Pallavolo, Pallacanestro,Calcetto, badminton).
Terminologia specifica relativa alla disciplina.
Conoscenza delle tecniche generali di alcune specialità dell’atletica leggera.
Sistemi di allenamento più comuni (circuit-training, percorsi misti ) e regolamenti esenziali dell’atletica leggera.
Contenuti essenziali di ginnastica artistica. Conoscenza degli elementi fondamentali alimentazione.
Elementi si traumatologia.
COMPETENZE:
Alla fine dell’ anno scolastico gli alunni sanno effettuare:
Applicazione dei fondamentali gesti tecnici in contesti e situazioni di gioco.
Assunzione di ruoli congeniali alle proprie attitudini.
Arbitraggio e compiti di organizzazione nelle partite o nei giochi strutturati.
Applicazione significative correlazioni fra contenuti teorici e contenuti pratici..
Rielaborazione dei vari contenuti proposti.
CAPACITÀ:
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni hanno la capacità di:
Comprensione di testi riferiti al regolamento, all’allenamento, alle varie tecniche sportive, espressive, alla salute
dinamica.
Applicazione globale di compiti /situazioni /tecniche motorie, sportive, espressive.
Percezione analisi dei dati dell’esperienza vissuta.
Organizzazione delle informazioni al fine di produrre semplici sequenze o progetti motori, sportivi, espressivi
individuali e collettivi.
6. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:
OBIETTIVI
CONTENUTI
Corsa aerobica e anaerobica
alattacida; es. respiratori, resp.
costale e diaframmatica. Es. a
Potenziamento fisiologico carico naturale, es. di opposizione e
resistenza.
Esercizi di equilibrio in situazioni
dinamiche e complesse di volo.
Elementi di ginnastica artistica;
progressioni semplici a corpo libero
Rielaborazione degli
e ai grandi attrezzi
schemi motori di base
Autogestione di gruppi di lavoro.
Applicazione di schemi di gara e
Consolidamento del
carattere sviluppo socialità assunzione di ruoli. Giuria e
arbitraggio
e senso civico
Esercizi propedeutici e specifici
Conoscenza e pratica delle degli sport più praticati. Tecnica
essenziale specifica delle varie
attività sportive
discipline di atletica leggera
Informazioni attività cardio
respiratoria e fonti energetiche
Informazioni
fondamentali sulla tutela nella attività fisica. Contr.
muscolare
della salute
47
STRUMENTI
TEMPI
Spazi aperti e chiusi.
Pista di atletica.
Percorsi misti.
Cronometro
I° e II° quadrimestre
Grandi attrezzi.
I° e II° quadrimestre
Piccoli attrezzi.
Materassini.
Tappetini
Over
Esecuzione di tattiche
I° e II° quadrimestre
essenziali nello sport di
squadra
Giochi sportivi.
Riadattamento attività di
squadra con regole
predeterminate
Palloni.
I° e II° quadrimestre
Campi di gioco.
Attrezzi specifici
dell’atletica.
Libro di testo.
4 ore
Applicazioni pratiche
7.
METODI (Lezione frontale, gruppi di lavoro processi individualizzati, attività di recupero - sostegno e
integrazione….)
Metodo globale e analitico del movimento e del gesto atletico specifico.
Articolazione flessibile delle varie unità didattiche con lezione frontale, lavori di gruppo e autogestione di gruppi di
lavoro, insegnamento individualizzato. Esercitazioni teorico-pratiche.
Attività “in situazione” basata sulla continua indagine e sull’ individuazione e autonoma correzione dell’errore.
Caratteristiche metodologiche essenziali in educazione fisica:
§
Valorizzazione dell’intelligenza motoria come risorsa, meritevole di essere coltivata e rispettata in tutti i soggetti
§
Stimolazione della creatività attraverso un uso divergente delle categorie del pensiero e degli schemi interpretativi
dati
§
Accorto dosaggio di procedimenti: dall’esercizio propedeutico all’esecuzione finale del gesto tecnico.
§
Un uso discreto della spiegazione, che non anticipa l’intero percorso, ma pone l’allievo in condizione di
superare eventuali situazioni di difficoltà.
8.
MATERIALI DIDATTICI, MEZZI E SPAZI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, biblioteca,
tecnologie audiovisive e/o multimediali...):
Mezzi e strumenti di lavoro
§
Piccoli e grandi attrezzi, attrezzi di riporto
§
Spazi :Palestra, pista di atletica
,
9.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare (prove scritte, verifiche orali, test aggettivi come
previsti dalla terza prova, prove grafiche, prove di laboratorio…)
Osservazione e misurazione in relazione alla situazione di partenza, ai risultati intermedi e finali per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati. Osservazione e misurazione delle esercitazioni pratiche “in itinere” al fine di progettare le
varie fasi dell’organizzazione dell’attività, dei percorsi operativi e metodologici da adottare. Prove pratiche.
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA SVOLTO a.s. 2012/2013
Del Prof Pasinato Ugo
di Ed. Fisica della classe
5^A
Esercizi di tonicità muscolare e strechmg.
Corsa aerobica e anaerobica, esercizi respiratori.
Esercizi a carico naturale; esercizi con pesi max 1/6 del peso corporeo.
Esercizi con piccoli attrezzi. Esercizi ai grandi attrezzi.
Percorsi misti e circuiti allenanti.
Esercizi a tempo e ritmo, esercizi di abilità e destrezza.
Giochi Sportivi: Pallavolo, basket, badminton conoscenza di schemi semplici, elementi di tecnica e tattica di gioco.
Gesti tecnici di Atletica Leggera: corsa veloce, ostacoli, salto in alto, salto in lungo, getto del peso, staffetta.
Autogestione di gruppi di lavoro.
48
Relazione Finale del Docente
ANNO SCOLASTICO
2012/2013
Docente: Lasorsa Vincenzo
Materia: Religione
Classe: 5^A
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
COMPETENZE:
Alla fine dell’ anno scolastico gli alunni sanno:
· interrogarsi sulla loro identità umana, religiosa e spirituale
· riconoscere l’incidenza del Cristianesimo nel corso della storia, in dialogo con altre religioni e sistemi di
significato
· confrontarsi con la visione cristiana del mondo, in modo da elaborare una posizione personale libera e
responsabile
ABILITÀ:
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
· giustificare e sostenere le proprie scelte
· riconoscere l’importanza del Concilio Vaticano II
· interpretare la presenza della religione nella società contemporanea
CONOSCENZE:
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono:
·
·
l’identità della religione cattolica nei suoi documenti ufficiali
il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo
10. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:
Modulo / U.D. / Percorso formativo / Approfondimento
Periodo /ore
Il Concilio Vaticano II: la libertà religiosa e il dialogo con le altre religioni.
6
Il Concilio Vaticano II: il problema della guerra.
1
Il Concilio vaticano II: i laici nella Chiesa.
4
La dottrina sociale della Chiesa: il senso del lavoro e i diritti dei lavoratori.
6
La dottrina sociale della Chiesa: i rapporti tra Chiesa e Stato e tra fede e
politica secondo il pensiero cattolico e secondo un’ideologia totalitaria (il
nazionalsocialismo).
3
La Chiesa cattolica nel XX secolo: giudizi, dibattiti e calunnie sul
comportamento di Pio XII durante la seconda guerra mondiale.
5
La cultura religiosa nella formazione permanente dopo il liceo.
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico
49
1 (prevista dopo il 15
maggio)
26
11. METODI (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero - sostegno e
integrazione….)
Ogni lezione si svolgerà attraverso una o più delle seguenti attività: conversazione guidata; spiegazione
dell’insegnante; analisi e discussione di testi o audiovisivi; ricerca e discussione di articoli di giornali o riviste;
esposizione di lavori personali o di gruppo; analisi guidata di testi biblici.
12. MATERIALI DIDATTICI, MEZZI E SPAZI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, biblioteca,
tecnologie audiovisive e/o multimediali...):
§
Libro di testo: G. Marinoni – C. Cassinotti, La domanda dell’uomo, Marietti Scuola
Cartelloni, audiovisivi, articoli di giornale o riviste, testi biblici corredati da schede di lavoro.
Aula di classe
§
Aula Video
§
§
13. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare (prove scritte, verifiche orali, test aggettivi come
previsti dalla terza prova, prove grafiche, prove di laboratorio…)
Il conseguimento degli obiettivi è stato verificato attraverso gli interventi spontanei degli studenti, le
domande di ripasso da parte dell’insegnante, l’esposizione dei lavori di gruppo.
La valutazione, inoltre, ha tenuto conto di: attenzione e interesse; partecipazione attiva; impegno e
costanza.
50
IL PRESENTE DOCUMENTO DI PAG. 51 E' STATO
PREDISPOSTO E DEFINITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE
5^ A NELLA SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2013
COORDINATORE DI CLASSE prof.ssa. Flavia Fommei
CONSIGLIO DI CLASSE
MATERIA
DOCENTE
ITALIANO – LATINO
LINGUA LETTERATURA INGLESE
STORIA – FILOSOFIA
MATEMATICA – FISICA
SCIENZE CHIMICA GEOGRAFIA
DISEGNO STORIA DELL’ARTE
EDUCAZIONE FISICA
RELIGIONE
FLAVIA FOMMEI
MILARDO LISA
MAZZILLI NICOLETTA
BORTIGNON REGINA
CAMPANA ARMANDO
TUSCANO MARIO
PASINATO UGO
LASORSA VINCENZO
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE
REBESCHINI ERICA
SCALCO ANGELA
FIRME
FIRMA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FIORENZA MARCONATO
51