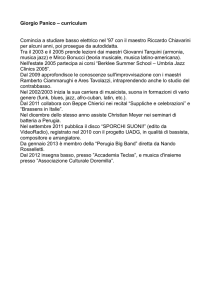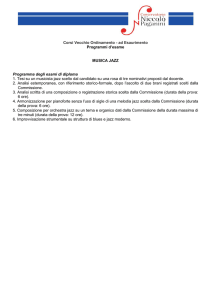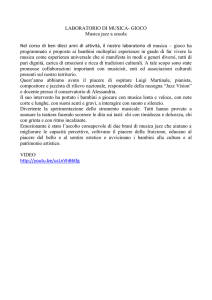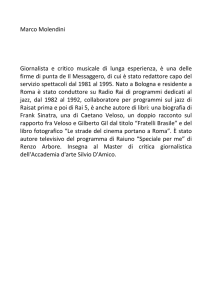SI SCRIVE MUSICA, SI LEGGE PASSIONE
DI E NRICO C OGNO
Parliamo di musica, in particolare di jazz e di musica d’autore, ma anche di
creatività, di come nasce un’idea musicale, di come il jazz può influenzare la
scrittura, oltre ad avere influenzato, dai primi del 900, quasi tutta la musica
attuale e l’arte in senso generale, con particolari riferimenti alla letteratura e
alla pittura.
Ricordate l’incipit di Il giro del giorno in ottanta mondi di Julio Cortàzar?
“Una sera in cui Lester Young riempiva di fumo e pioggia la melodia di Three
Little Words, sentii più che mai cosa rende tali i grandi del jazz: quella
invenzione che rimane fedele al tema mentre lo combatte, lo trasforma e li
irida….. un andirivieni di pezzi di stelle, di anagrammi e palindromi”.
Ricordate, ancora, Henri Matisse e la sua opera JAZZ, pubblicata nel 1947
dall’editore Terrier? Quelle venti tavole dagli accesi cromatismi (come era
logico attendersi dal caposcuola dei Fauves) che cercavano,
nell’improvvisazione con la quale Matisse sempre produceva le sue opere (prive
di prospettiva ma cariche di umanità, di senso del ritmo e di colore) di cogliere
l’attimo creativo con forbici, colla, ispirazione e passione, nei suoi gauches
decoupè.
E ricordate, più recentemente, la geniale opera di uno dei nostri autori musicali
più creativi, Paolo Conte, che in Ratmataz ha fuso mirabilmente jazz e arte
visiva?
Da quasi cinquanta anni porto avanti, con le debite differenze rispetto a questi
maestri, una ricerca che analizzi l’intrecciarsi della musica con le parole e la
stimolazione che queste sanno dare alla musica. Ho un’idea fissa: indagare su
cosa genera questo intreccio dell’idea con l’arte, in particolare per cercare di
capire come nasce un’idea, sapere cosa fa sorgere l’esatto attimo creativo.
Anche un personaggio di Alessandro Baricco cercava sempre, per tutta la vita,
di capire dove finiva il mare.
Un'altra mia idea fissa è cercare di dare swing alla scrittura.
Nel 1971 pubblicai per Cappelli Editore “Jazz Inchiesta Italia”, un testo che
cercava di “scrivere in modo jazz”. Qualcuno colse questa intenzione.
Francesco Forti su Spettacolo scrisse: “Non è facile resistere all’intensa
suggestione che emana dal libro per come è stato montato e per la sua scrittura
rapida e swingante”. Perfetta sintesi di quello che avevo cercato di fare.
Nell’introduzione cercavo di spiegare questo approccio:
Feeling: tocco, sensibilità, sentimento.
E’ scritto sui dizionari, ma la gente del jazz non usa tradurlo.
Dice: il jazz è feeling (o è swing, è blues) come chiave di un codice che sconfina
in campi semantici che un dizionario non riporta. Parlando (o scrivendo) di jazz, è
importante far rivivere un tratto spontaneo, non mediato, che proceda sul piano
dell’emotività più pura (pulsazione, fremito, mixage di sentimenti tra il lirico e il
disincantato), un modo di rendere jazz le parole, di usare un segno in sintonia
con i problemi degli uomini che del feeling ne hanno fatto un modo di vivere.
Il jazz è compromissione e comprensione: per parlarne serve compromettersi con
chi lo produce e capirne il perché. Le biografie da sole non servono a questo.
Per sensibilizzare anche il fruitore meno attento serve scoprire la seconda parte di
ogni musicista. Si sa qualcosa sempre e soltanto della prima, quella che va dallo
strumento in avanti, mentre dell’altra (quella che tira fuori dall’ oggetto le note, le
idee, i suoni della rabbia, dell’amore, la poesia, la vita) l’uomo, insomma, la
gente, l’uomo, lo conosce sempre troppo poco o troppo tardi.
Il jazz in Italia, ha avuto molti giudici e pochi testimoni.
Ora che serve affermarlo (a fianco dei fenomeni della cultura ufficiale) come
musica di poesia e non di consumo, serve, paradossalmente, la tecnica del
consumo, non quella della poesia: una inchiesta rivolta a scoprire l’ambiente e la
problematica di chi produce il jazz, di chi lo giudica e di chi lo ascolta. Il tutto
impregnato di feeling, fatto con discorsi grintosi, diretti a stimolare oltre che a
informare.
Negli anni ’70 una storia (in senso tradizionale) del jazz soddisferebbe chi infila i
libri sugli scafali con amore feticistico e lascerebbe insensibili quelli che, di una
musica viscerale come il jazz, vogliono un documento che ne analizzi la sfera
sociale ed umana. Vivere il jazz al di fuori di questo contesto significherebbe
esaminarlo spogliato della sua caratteristica più importante.
Così l’uomo del sassofono sarà del fianco del vigile urbano, il critico di fronte alla
fioraia, lo studente con il programmatore RAI: un collage che tenderà a creare un
habitat in cui le testimonianze (non i giudizi) cercheranno di distinguere i buoni
poeti dai buoni artigiani, sul piano dello stimolo emozionale.
Nel jazz la saggistica, caricata di feeling (denominatore comune per questo
dialogo) può sconfinare e fondersi con la narrativa, può vivere di ricordi e da
questi, operando per sintesi, trasformarsi in ricerca.
Non potrebbe, trattandosi di jazz, non essere racconto di vita.
In altra parte del sito si può rileggere l’intero testo (Jazz Inchiesta Italia 1971)
tenendo però conto di due indicazioni: la prima è che il libro è stato scritto
nell’estate del 1970 e che oggi pertanto mostra tutte le incompletezze
derivanti da ciò. E’ solo una testimonianza sullo spaccato di quel periodo, visto
che il testo è introvabile e forse a qualcuno potrebbe far piacere rileggerlo o
leggerlo per la prima volta.
La seconda è che manca delle immagini, fondamentali, mi pare, per dare quello
swing che il testo intendeva avere e che nella versione originale, ancorché in
bianco e nero e su carta povera, invece includeva.
La passione per la musica e per le parole
L’ho succhiata nel latte, la passione per le parole, per la musica e per l’arte in
una Torino del dopoguerra: macerie, fame, ma anche l’allegria di chi dalla
guerra era uscito vivo. Cantavamo sempre, in casa. Mio padre, che si era
formato artisticamente a Parigi, era un bravissimo pittore e appassionato
melomane. Mia madre era nata nei pressi di Buenos Aires, cantava, suonava la
chitarra e dipingeva anche lei; si era poi trasferita in Inghilterra, per arrivare in
Italia verso i trent’anni. Così le milonghe, le arie verdiane, le ballate celtiche,
le ceramiche d’arte e la pittura mi sono entrate nel sangue, mischiate come un
frullato di dolce follia.
L’ambiente era creativo, anche se il fatto che in famiglia fossero tutti dotati di
una grande abilità nel disegno, fuorché me, mi spinse verso un’espressività
basata sulle parole, parlate e scritte.
Sono sempre stato attratto dalle parole. Mio padre, a volte, se le inventava,
quando quelle del dizionario erano inadeguate: nel nostro lessico familiare, ad
esempio, bastava che mio padre, rientrando in casa e volendo dire “Questa sera
mangiamo in fretta, poi andiamo al cinema” usava una sola parola, inventata e
quasi magica: “Tringhesvai”. E, tutti felici, capivamo perfettamente.
Mia madre, per via della sua lunga presenza in Inghilterra, aggiungeva alle
parole inventate da mio padre i suoi termini italo-ispano-anglosassoni.
Qualche volta i miei amici avevano difficoltà a capirmi: solo dopo molti anni mi
resi conto che, certe parole che usavo, non esistevano in italiano, anche se
erano più efficaci di quelle previste dallo Zingarelli.
Alla sera, la radio alternava radiodrammi a musiche dal mondo: mi piaceva il
suono delle chitarre, nel folklore internazionale, i quartetti vocali, il suono del
trombone, i gospel, la musica country. Il jazz lo scoprii qualche anno più tardi.
Così mi nutrivo del Trio Los Calaveras, del Golden Gate Quartet, di Les Paul e le
sue 100 chitarre, delle arie d’opera, delle orchestre italiane dell’epoca: Cinico
Angelini, Pippo Barzizza, la stupenda band di Ferrari. E c’era poi il Discobolo, la
hit parade di quel tempo.
Scoprii il jazz nel 1954, quando acquistai una antologia discografica per
corrispondenza: vi era di tutto, in quel disco, da Sidney Bechet a Louis
Armsgrong, da Benny Goodman a Charlie Parker, da Chet Baker a Dave Brubeck.
Fu un vantaggio, perché, da quel momento in poi, mi piacque ogni genere di
jazz, senza cadere nel tormentone dell’epoca che usava distinguere, con una
sorta di definizione demenziale, tra jazz caldo e jazz freddo.
Un Natale ricevetti in regalo una chitarra e passai giorni interi a cercar di
cavare un suono che non fosse solo un Mi basso ostinato, con il quale
accompagnavo tutto: tanto, sosteneva un mio amico, prima o poi i giri armonici
“passavano di lì”.
La cosa migliorò quando mia sorella decise di prendere delle lezioni di chitarra
e il mio compito di bravo fratello era accompagnarla tutte le volte dal maestro,
perché all’epoca, a Torino, le ragazze per bene non andavano da sole da un
giovane musicista, per di più in un borgo periferico: insomma, il fratellino
sempre dietro, tipo “Io Mammeta e tu”. Mi annoiavo da morire. Il maestro mi
fece una proposta: con poche lire in più avrebbe insegnato anche a me. Un
affare, almeno mi sarei annoiato di meno.
Così studiai solfeggio e armonia (cosa che in realtà apprezzai solo in seguito) e
una volta scoperto che la musica e la chitarra non erano poi così difficili,
dilagai.
Aggiunsi l’uso del banjio tenore a sei corde, più agevole per me del classico
quattro corde. Amavo esplorare più le parti armoniche che quelle melodiche. Mi
nutrivo di Tiny Grimes, Django Reinhardt, Bib Bill Broonzy e vari bluesmen.
Poi, attratto dai suoni pastosi del trombone a coulisse (divertenti nel dixieland
e adattissimi anche a stili più moderni) comprai per duemila lire un vecchio Orsi
al Balòn, pagavo le lezioni ad uno squattrinato allievo del conservatorio di
Torino sotto forma di due pacchetti di Giubek, mi vennero due labbra gonfie
come un canotto (non avevo idea che esistesse il sistema no-pressure: al
conservatorio all’epoca il bocchino si schiacciava sino a far sgorgare il sangue) e
incrinai definitivamente il rapporto con i vicini che pensavano che avessimo una
mucca in casa, tanti erano i muggiti che producevo all’inizio con quel coso
metallico.
Poi, non pago, tentai di fare del jazz con il corno francese (anche quello
acquistato di seconda mano da un amico) ma smisi subito, essendo uno
strumento troppo ostico per il be-bop. Però eseguivo il Tannhauser niente male.
Nel frattempo, colpito da Stan Kenton e Woody Herman, iniziai a comporre dei
brani che arrangiavo a 16 voci: solo che non trovai mai tanti amici in grado di
leggere la musica per eseguirli, per cui non ho mai saputo se facessero davvero
pena come ora temo.
Infine, incominciai a muovere i primi passi come giornalista specializzato in
quella che veniva definitiva musica extra-colta, facendo incetta di articoli
firmati (anche se pagati quasi niente) per poter prendere la tessera da
pubblicista, che ottenni poi qualche anno dopo.
I gruppi musicali dell’epoca
Avevo attivato diversi combos: un quintetto con due tromboni, stile Jay & Kay,
qualche gruppo in stile swing-era, con il giovane Paolo Dutto al clarinetto e io
alla chitarra, più una ritmica raccogliticcia con il classico bassista-finto (era un
imbianchino che faceva boom-boom a corde libere, del tutto indipendenti dalla
tonalità del brano) e un batterista che oggi fa il carrozziere, di cui non ricordo
il nome, ma so che lo chiamavamo Cucciolo. Poi avevo qualche formazione in
stile east coast con un organico molto elastico: dipendeva da quanti amici
erano disposti a venire alle prove. Alcuni compagni d’avventura (non li cito per
tenerezza) erano talmente “squadrati” che, una volta esposto il tema che
leggevano rigidamente, non riuscivano a capire quando, finite le
improvvisazioni, dovevano riprendere il chorus finale: ricorrevo quindi a degli
espedienti strani, tipo battere il palmo della mano sul bocchino del trombone
quattro battute prima della ripresa, oppure facendo dello scat urlando Minus
four, three, two, one…
Uno di questi musicisti-da-ridere era il mio giovane portalettere (che mi sentiva
suonare quando mi portava la corrispondenza) e che, quando mio padre un
Natale gli volle dare la mancia, come un tempo si usava alla consegna del
Calendario del Portalettere, si schernì dicendo..”No, no, mi basterebbe solo
poter suonare con suo figlio…”.
L’altro era l’idraulico di casa, anche lui appassionato suonatore di sax tenore
che aveva imparato a suonare nella banda del paese. Non tutti erano così
semplici: alcuni, per la verità, erano già bravi. Mi ricordo tra questi Enrico
Rava, che aveva appena abbandonato il trombone a coulisse (strumento con il
quale aveva iniziato, per pochissimo tempo, a suonare nei gruppi dixieland) per
passare alla tromba, sulla quale stava impostando il metodo no-pressure,
imitando alla meglio Miles Davis, con interminabili cascate di note per
nascondere una tecnica allora molto rozza. Adesso Enrico, diventato
giustamente una grande star del jazz, confessa, nel suo interessantissimo libro
“Note necessarie”, che impiegò molti anni a disfarsi di quel vizio e ci riuscì solo
quando, sentendolo suonare, Joao Gilberto gli disse: “Sei bravo, ma fai troppe
note inutili. Suona solo le note necessarie”.
Veniva spesso anche Gianni Negro (e poiché, da chitarrista, non avevo in casa
un pianoforte, Gianni suonava la fisarmonica alla Gorni Kramer) e nei concerti
esterni qualche volta ci raggiungeva Paolo Conte. Quando al piano c’era Ennio
Vitanza (un innamorato di Monk che all’epoca aveva vinto un concorso nelle
ferrovie come Capo Stazione Aggiunto alla stazione di Porta Nuova e che poi si
trasferì a Milano a fare il cronista sportivo in Rai), Paolo passava al vibrafono,
sul quale è sempre stato molto bravo. Sempre come vibrafonista, Paolo Conte e
il fratello Giorgio alla batteria, diversi anni dopo, nel 1962, incisero per la RCA
Victor un extended play dal titolo “The Italian Way to Swing” sotto il nome,
americanizzato, di Paul Conte Quartet.
E’ un disco purtroppo introvabile.
Il rapporto jazz-canzoni
Va ricordato che negli anni 50, in mezzo a poche canzoni interessanti, vi era
molta robaccia. I cantautori (termine creato alcuni anni dopo) non esistevano
ancora in Italia: si doveva ascoltare Georges Brassens per sentire qualcosa di
serio. Chi componeva la musica, tranne pochissimi casi, non la eseguiva e
soprattutto non scriveva i testi.
Per questo c’erano i “parolieri”. Per scrivere una canzone si mettevano quindi
insieme un gruppo di persone, a volte con qualche nome in più al solo scopo di
poter depositare il pezzo alla SIAE, che rilasciava il titolo di autore solo dopo
esami che all’epoca erano piuttosto complessi.
A quel tempo, in genere, chi suonava jazz non amava la musica leggera: si
atteggiava, aveva un po’ la puzza sotto al naso e cercava di stare alla larga
dalle canzoni. Ricordo un amico che per far colpo sulle ragazze diceva di “fare
be-bop” e siccome loro non sapevano cosa fosse ma non osavano chiederlo, lui
riusciva ad ottenere un alone di mistero e rimorchiava facilmente. In realtà
suonava da schifo.
Paolo Conte, senza dirlo a nessuno di noi, si divertiva, con suo fratello Giorgio
(altro bravissimo autore che meriterebbe molta più notorietà in Italia) a
scrivere canzoni che proponeva ai gruppi e ai cantanti di successo dell’epoca.
Molti di questi brani sono adesso dei successi mondiali: si pensi a "La coppia più
bella del mondo" e "Azzurro" per Adriano Cementano, "Insieme a te non ci sto
più" per Caterina Caselli, "Tripoli '69" per Patty Pravo, "Messico e nuvole" per
Enzo Jannacci, "Genova per noi" e "Onda su onda" per Bruno Lauzi, ecc. .
Solo in un secondo tempo, come Paolo ha affermato in una recente intervista,
incominciò a tenere nel cassetto le sue composizioni senza offrirle più a
nessuno, perché, sono parole sue, dette con la consueta e inimitabile sintesi:
“L’interpretazione di un brano da parte di un cantante di successo è un onore
quanto una profanazione”.
Anni dopo decise quindi di cantare le sue canzoni in prima persona. Direi che
“Sotto le stelle del jazz” è la perfetta descrizione di quella epoca - tanto cara
anche al regista-clarinettista Pupi Avati - dove tutte le ragazze si chiamavano
Marisa, il jazz a loro non piaceva perché “non si capisce il motivo”, i ragazzi
avevano le cravatte sbagliate e giravano i preziosi 78 giri sui grammofoni a
manovella, cercando di ballare con le più belle: il ballo era l’unico modo in cui
all’epoca si poteva stare vicino, a volte molto vicino, ad una ragazza.
Il meritato successo internazionale di Paolo Conte, e in parte anche quello di
Giorgio Conte, è oggi sotto gli occhi di tutti.
Un episodio curioso a proposito di Paolo Conte accadde a Roma: da molti anni
non ci vedevamo, dopo che lui si era laureato in legge e curava lo studio
professionale del padre ad Asti. Io vivevo ormai da tempo a Roma e mi
occupavo, collateralmente, di critica jazz, come poi vedremo. Non avevo
ricollegato che un certo P.Conte, autore di diverse canzoni di successo, era il
mio mitico pianista-vibrafonista di quando eravamo ragazzi: può sembrare
strano ma davvero non avevo ricollegato i nomi. Una sera, durante un concerto
di Art Farmer al Music Inn, vidi un elegante signorotto baffuto, sornione, che
sembrava aspettare da me un cenno di riconoscimento: dopo molti anni le
persone cambiano e non mi resi conto di chi fosse quel gentiluomo con l’aria da
gattone. Solo quando, con accento piemontese, mi rimproverò dicendo “Oh,
basta là, ma non si salutano neanche più gli amici…” mi resi conto, dalla voce e
dallo sguardo, che era Paolo Conte. Aveva appena inciso il suo primo LP per la
RCA, solo piano e voce, e, obbligato dalla casa discografica, lo stava
presentando in giro per l’Italia, con grande ritrosia perché detestava cantare in
pubblico. M’invitò ad andarlo ad ascoltare in un piccolissimo locale di via
Garibaldi, il Folk Rosso (da non confondere con il ben più importante
Folkstudio) un locale, scomparso pochi anni dopo, che era letteralmente una
topaia: penso che le poltrone fossero state raccattate nelle discariche, quelle
abbandonate dai cittadini. Bisognava stare attenti a non prendersi il tetano, ma
Paolo fu una rivelazione. Allora nessuno conosceva la sua musica surreale,
cosicchè Bartali, La giarrettiera Rosa, La Topolino Amaranto, Wanda e le storie
del Caffè Mocambo mi colpirono molto. Per altro, lui allora non cantava mai le
sue Onda su Onda, Una giornata al mare, Azzurro e i successi che altri avevano
lanciato. Era realmente un nuovo modo, geniale, di interpretare delle canzoni.
Di tanto in tanto accompagnava il canto con swinganti boogy woogy o afferrava
il suo kazoo (che a New Orleans era lo strumento dei negretti poveri) per fare la
linea melodica nella ripresa del refrain. Ne scrissi su Il Tempo una recensione
entusiasta. E la cosa finì lì, per almeno un anno e mezzo.
La sua affermazione avvenne per gradi: lenta ma inesorabile, sino al grande
successo,
soprattutto all’estero. Quando lo rividi al suo secondo concerto a Roma già
c’era una folla ad ascoltarlo. Nel camerino, dopo le spettacolo, mi confessò che
il mio articolo aveva finalmente convinto sua madre (quattro colonne su un
quotidiano della capitale avevano impressionato favorevolmente quella gentile
signora di provincia, a quanto pare) che dopo anni di disapprovazione della
mania di quei due figli a perdere tempo con la musica, aveva ammesso le loro
ragioni nel non dedicarsi solo all’attività legale. E poiché questo riconoscimento
la madre glielo confessò poco prima della sua morte, Paolo ne fu molto toccato
e me lo confessò con commozione.
Il successo di Paolo Conte, all’estero, partì dalla Francia: il critico musicale del
Figarò seguì la sua tournèe italiana sommergendo i francesi di elogi su questo
avvocato poeta che cantava in modo sghembo storie di gente che invecchiava
triste nei tinelli marron. Siccome il critico del Figarò era un giovane free lance
pagato a borderò (cioè per ogni pezzo che scriveva) era costretto a scrivere un
sacco di articoli per pagarsi le spese del viaggio in Italia. Così la Francia su
sommersa di articoli su Conte, tanto che lo chiamarono a Parigi e Paolo si
chiese come i francesi avrebbero potuto capire i racconti di uno che vive in
mezzo alla campagna, dove il sole è un lampo giallo al parabrise. Avrebbero
capito soltanto parabrise. Cercò allora di tradurre in francese le sue canzoni:
incominciò da “La ricostruzione del Mocambo” e quando cercò di tradurre la
frase “tinello marron”, si arrese, capì che era un’impresa impossibile, decise di
non tradurre nulla, di cantare tutto in italiano e si preparò al fiasco più totale.
Fu un’apoteosi, invece, e il commento (assolutamente geniale) di Paolo Conte
fu:
“Ancora una volta i francesi sono stati vittime della loro presunzione di capire
sempre tutto”.
Sempre sulla linea del rapporto jazz-arte, Paolo Conte ha prodotto nel 2000
un progetto che sognava da venti anni: "Razmataz", un’opera musicale che
narra della Parigi degli anni ’20. E’ la fusione dei suoi due amori, il jazz e l’arte
visiva.
Conte vede nella Parigi degli anni Venti il punto d'incontro e di fermento
culturale di tutte le avanguardie del ventesimo secolo. La storia, che nello
specifico narra l'incontro tra la vecchia Europa e la nuova musica nera, è stata
illustrata da 1800 suoi disegni e trasformata in un'opera video su DVD,
accompagnata da musica e dialoghi. L'album contiene stralci di musica
d'atmosfera del passato oltre ad una serie di canzoni in un'interessante
carrellata di stili in francese, italiano e inglese, e riflette le eccitanti
innovazioni e fusioni di questo incrocio culturale della Parigi degli anni Venti.
Tutti i musicisti amano il jazz?
A proposito del rapporto jazz-musica leggera, è curioso notare che alcuni
artisti, che in seguito raggiunsero grande notorietà nel campo della canzone e
in altri settori della cultura, avessero con il jazz un rapporto molto
diversificato: alcuni d’amore, altri di totale disinteresse.
Un rapporto d’amore è stato certamente quello di Fred Buscagione, Bruno
Martino,
Armando Trovajoli, Ugo Calise, Nicola Arigliano, Renzo Arbore, Lucio Dalla,
Piergiorgio Farina, Tullio De Piscopo, poi, più tardi, Pino Daniele, Sergio
Cammariere e tanti altri.
In cima alla lista, per la verità, andrebbero messi Luigi Tenco e Bruno Lauzi
che, negli anni 50, il primo al clarinetto e il secondo al banjo, formarono la
Jelly Roll Morton Boys Band a Genova, con Danilo Degipo alla batteria e Alfred
Gerard alla chitarra.
Molto più recentemente, un altro notevole cantautore, Gianmaria Testa,
appassionato di jazz, è stato chiamato ad inaugurare l'edizione 2002 di Umbria
Jazz, il maggior evento legato al genere in Italia. A proposito di Umbria Jazz, ho
già prima citato il bravissimo Pupi Avati, celebre regista che condivide com’è
noto con l’altro grande cineasta, Woody Allen, la passione per il clarinetto. A
proposito di questa passione comune per il clarinetto, ricordo che molti anni
dopo Alberto Alberti e Carlo Pagnotta si fecero venire la voglia di riunire ad
Umbria Jazz (la loro creatura che tanto successo ha portato alla cultura e al
turismo umbro) alcune celebrità per una magic riunion di clarinettisti, da far
esibire in gruppo con una sezione ritmica: Woody Allen, Hengel Gualdi, Pupi
Avati, Lucio Dalla e Renzo Arbore. Ero presente al concerto, al quale dette
forfait (ma c’era da giurarlo) soltanto Woody Allen.
Pupi Avati, dietro le quinte (che poi non erano davvero delle quinte, perché il
concerto si teneva sulla piazza maggiore di Perugia, en plain air, era
terrorizzato:
“Ma perché cavolo ho accettato una simile follia, non suono da anni, sarà una
catastrofe”. Invece andò benissimo. Suonarono tutti splendidamente, con molto
swing e sembravano un gruppo vero che suonasse insieme da anni.
Pochi conoscono la storia di un ventenne, certo Ferdinando da tutti chiamato
Nando, che aveva scoperto, nella portineria di Piazza Cavour a Torino dove
abitava con la madre, un pacco di dischi di jazz a settantotto giri dimenticati
dall’inquilino precedente. Se li era imparati a memoria sul vecchio grammofono
a manovella e quando conobbe lo scatenato fisarmonicista e trombettista
Renato Germonio, tra i due nacque un’amicizia immediata. Germonio, con
maggiori possibilità economiche, noleggiò subito un contrabbasso per Nando,
che aveva frequentato per sei mesi il corso di violino al Conservatorio Giuseppe
Verdi, facendosi poi buttare fuori per il suo carattere focoso. Le corde erano
più spesse, la tastiera molto più grande, ma grosso modo Nando seppe
arrangiarsi a suonare quel violone enorme. Nacque così il primo duo jazzistico
torinese, fisarmonica e contrabbasso, che per ore swingavano sulle note di The
Sheik of Araby, la loro sigla musicale: il giovanotto era Ferdinando Buscaglione,
che poi cambiò il suo nome popolare di Nando in quello di Fred, con cui divenne
a tutti noto.
Invece non aveva un buon rapporto con il jazz Lucio Battisti, che dall’età di 18
anni era il chitarrista del gruppo I Campioni, nel quale si era fatto le ossa Tony
Dall’ara, un gruppo reso celebre dal loro successo Tintarella di Luna, ripreso
poi da Mina. Ricordano i colleghi che una volta Battisti venne condotto a forza
ad ascoltare al Lirico di Milano il gruppo di Charlie Mingus e per tutto il tempo
sbuffò: “Ma che palle, annammo via, ma che è ‘sta robba”
Anche rifacendosi alle origini del jazz, il rapporto tra questo linguaggio e la
musica leggera, in particolare proprio al genere “song”, è molto più stretto di
quanto solitamente si pensi. Una infinità di jazzmen hanno dedicato moltissimi
album alla rivisitazione in chiave jazzistica di canzoni di tutti i tipi, i cosiddetti
“standard”
Lo standard altro non è che un song, una canzone, in origine spesso presente
nelle commedie musicali. Il legame tra standard e jazz i indissolubile: si pensi a
tutte le registrazioni dei vocalist e singers vari, da Billie Holiday a Ella
Fitzgerald, da Sarah Vaughan a Mel Tormè, da Louis Armstrong a Bestie Smith.
Gli standard
Una cosa che colpisce sempre chi pratica poco l’ambiente del jazz è il fatto
che i musicisti, quando si incontrano per la prima volta, riescono a suonare
insieme senza difficoltà, senza leggere spartiti, senza aver mai provato prima.
Questo che sembra, agli occhi dei profani, un piccolo miracolo, è per jazzmen
una normalità, basata sulla conoscenza dei cosiddetti “standard”, quei brani
evergreen che si suonano da sempre. Conoscere gli standard è fondamentale,
diversamente non sarebbe possibile nessuna attività senza settimane di prove e
di studio specifico del repertorio. Si ritiene che i brani di comune conoscenza
nel mondo jazzistico siano almeno un migliaio.
Questo è la lista dei 100 standard, redatta da Nino De Rose, che si devono
tassativamente conoscere per fare del jazz, oltre al più tradizionale di tutti: un
giro di blues di 12 battute, in Sibemolle.
Titolo
Autore
1) Ain't Misbehavin'
Fats Waller
2) AII Blues
Miles Davis
3) AII The Things You Are
Jerome Kern
4) AII Of You
Cole Porter
5) Ad Infinitum
Carla Bley
6) Autumn Leaves
Joseph Kosma
7) BeautifuI Love
Victor Young
8) Black Orpheus
Luiz Bonfà
9) Blue Bossa
Kenny Dorham
10) Blusette
Toots Thielmans
11) Body And Soul
John Green
12) Bye Bye Blackbird
Ray Anderson
13) Cantaloupe Island
Herbie Hancock
14) Cherokee
Ray Noble
15) Corcovado
A.C. Jobim
16) Days Of Wine And Roses
Henry mancini
17) Doxy
Sonny Rollins
18) ExactIy Like You
Jimmy McHugh
19) Fly MeToThe Moon
Burt Howard
20) Foggy Day
George Gerswin
21) Footprints
Wayne Shorter
22) Four
Miles Davis
23) Georgia On My Mind
Hoagy Carmichael
24) Giant Steps
John Coltrane
25) Goodbye Pork Pie Hat
Charlie Mingus
26) Have You Met Miss Jones
Richard Rogers
27) Here's That Rainy Day
Jimmy van Heusen
28) How Deep Is The Ocean
Irvin Berlin
29) How High The Moon
Morgan Lewis
30) How insensitive
A.C. Jobim
31) It Don't Mean A Thing
Duke Ellington
32) I Fall In Love Too Easily
Jule Styne
33) I Got Rhythm
George Gershwin
34) I Love You
Cole Porter
35) I Remember You
Victor Schertzinger
36) l'II Remember April
Raye De Paul
37) If I Should Lose You
Ralph Rainger
38) Impressions / So What Davis
J. Coltrane/Miles Davis
39) In A Mellow Tone
Duke Ellington
40) In A Sentimental Mood
Duke Ellington
41) In Walked Bud (Blue Skies)
Thelonious Monk
42) In Your Own Sweet Way
Dave Brubeck
43) Jucy Luicy/ Confirmation
H. Silver/Charlie Parker
44) Just Friends
Klemmer/Lewis
45) Lady Be Good
George Gershwin
46) Lady Bird
Tedd Dameron
47) Laura
David Raskin
48) Like Someone In Love
Jimmy van Hausen
49) Lover Man
Ram ramirez
50) Left Alone
Mal Waldron
51) LuIlaby Of BirdIand
George Shearing
52) Maiden Voyage
Herbie Hancock
53) Man I Love
George Gershwin
54) Memories Of You
Eubie Blake
55) Milestones (modale)
Miles Davis
56) Minority
Gigi Gryce
57) Misty
Errol Garner
58) Moments' Notice
Kohn Coltrane
59) My Favorite Things
Richard Rogers
60) My Funny Valentine
Richard Rogers
61) My Romance
Richard Rogers
62) Naima
John Coltrane
63) Nardis
Miles Davis
64) Night And Day
Cole Porter
65) Night In Tunisia
Dizzy Gillespie
66) On Green Dolphin Street
Bronislau Caper
67) On The Sunny Side
Jimmy McHugh
68) One Note Samba
A.C. Jobim
69) Out of Nowhere
John Green
70) Over The Rainbow
Harold Arlen
71) Recordame
Joe Henderson
72) Round Midnight
Thelonious Monk
73) Ruby, My Dear
Thelonious Monk
74) Satin Doll
Duke Ellington
75) Serenade To A Cuckoo
Roland Kirk
76) Shadow Of Your Smile
Johnny Mandel
77) Softly As In A Morning
Sigmund Romberg
78) Solar
Miles Davis
79) Someday My Prince will Come
Frank Churchill
80) Sophisticated Lady
Duke Ellington
81) Soul Eyes
Mal Waldron
82) Speak Low
Kurt Weil
83) St. Thomas
Sonny Rollins
84) Star Eyes
Raye DePaul
85) Stella By Starlight
Victor Young
86) Summer Night
Harry Warren
87) Summertime
George Gershwin
88) Take Five
Paul Desmond
89) Take The "A" Train
Billy Strayhorn
90) Tenderly
Walter Gross
91) There’ll Never Be Another You
Harry Warren
92) Waltz For Debbie
Bill Evans
93) What Is This Things Called Love
Cole Porter
94) Whisper Not
Benny Golson
95) Windows
Chick Corea
96) Woody ‘n’ You
Dizzy Gillespie
97) Yardbird Suite
Charlie Parker
98) Yesterday
Jerome Kern
99) You Don't Know What Love Is
Raye - DePaul
100) You Stepped Out Of A Dream
N.H. Brown
Per questo, parallelamente all’amore per il jazz, ho sempre maturato un
parallelo interesse per la canzone d’autore, diretta discendente della canzone
popolare.
Come nasce una canzone
Probabilmente una canzone nasce nello stesso modo in cui nasce un brano di
jazz. Non credo vi sia molta differenza, in termini di processo di genesi
creativa, tra comporre Night in Tunisia oppure Estate. La differenza tra i brani
strumentali e le canzoni è solo data dalla presenza del testo. Quando poi il jazz
attinge dal genere song, qualunque canzone diventa uno standard jazzistico.
Dice Lucio Dalla che “Guardando la vita nasce una canzone” e ricorda che,
incontrando a Bologna una prostituta e chiacchierando con lei del più e del
meno, si sentì chiedere, per prima cosa: “Ma lo sai che domani arriva Sartre?”
Commenta Dalla: “Io ci rimasi di sasso, e l’indomani composi Disperato Erotico
Stomp”.
Lui si dice solo “narratore di fatti di vita”.
Quando nel 1982 il discografico Vincenzo Micocci (che si autodefinisce
l’inventore del termine cantautore, anche se la versione è da altri contestata)
con Tullio De Mauro organizzò il corso Mestiere della Musica, invitando come
docenti il fior fiore degli autori musicali, Venditti, Battiato, Morricone e altri,
Lucio Dalla tenne una lezione proprio su come nasce una canzone, facendo
distribuire agli studenti una fotocopia in cui c’era scritto: “Cari allievi, le mie
canzoni più belle le avete scritte voi, senza saperlo. Quanta gente canta, se sa
cantare, ma quanta canta anche se non sa farlo.
Perché uno canta? Se è felice? Se ha qualcosa da dire? O se soffre e se gli piace
soffrire, o se ha fantasia e non ama il “normale” delle cose. Forse si canta da
sempre perché cantare è come raccontare, stare vicino alle cose, a un passo dal
mondo.
Anch’io canto a un passo dal mondo, scrivo canzoni e ricevo nastrini e cassette
a milioni. La gente mi manda le sue parole, non vuole solo autografi o foto
firmate, non mi chiede chi amo, ma se amo, mi chiede a cosa penso quando
scrivo una canzone e dov’era questa canzone prima di essere scritta, su quali
spiagge o cimiteri volava prima di essere inventata, in quali occhi a mandorla di
strega o in quali mani di porco o di fata era avanti di essere scovata. Io ho
cominciato così: in piedi su di un tavolo, sotto ad un neon, nella cucina di casa.
Oggi mi sveglio la notte con questo sogno sempre in mente e mi butto anni e
anni avanti, sbaraglio gli occhi sulla canzone che scriverò domani, un sogno
difficile da raccontare, più facile da suonare.
Quanta gente sarà seduta davanti a me ad aspettare qualcosa di speciale su un
argomento che mi sembra del tutto normale? Mi crederanno quando dirò che
ogni fatto ha un suo suono, che questa notte a casa mia ho già visto le loro
facce, so già chi sono, che potrei parlare duecento ore in fila e non stancarmi
mai o stare zitto a contare sino a duemila e dirti tutto quello che dirai? Chissà
se crederanno che ognuno è mago, è carta da canzone, è padrone di due
tasche, che la gioia è come la disperazione, che tutte le note stanno
tranquillamente in una mano sola, che anche i muli possono cantare in un coro
e, soprattutto, che le mie canzoni più belle le hanno scritte loro?”
A volte gli autori svelano cosa ha generato il “momento magico”, ma in molti
casi rimane un mistero. Alcuni spunti sembrano essere comuni, come nel caso
dell’ispirazione più diffusa al mondo, l’amore, ma questa non è certo l’unica
fonte di creatività.
In un testo del compianto Giorgio Lo Cascio, “Diventare Cantautori” (Lato Side
Editore), vengono riportate le otto tipologie che, nello studio della metrica
classica, servono a classificare i generi testuali. Naturalmente questa
classificazione vale prevalentemente per i brani classici, ma con una piccola
forzatura può essere adattata anche alle canzoni:
Il Carme (potrebbe essere il caso di Eppure soffia di Pierangelo Bertoli);
L’Epicinio (per celebrare o auspicare una vittoria: El pueblo unido jamas serà
vencido);
L’Epitalamio (composizione per la celebrazione di un matrimonio, che in parte
è presente nel testo dello strano sposalizio narrato in Alice di Francesco De
Gregori oppure in Marcia Nuziale di Brassens tradotta da De Andrè e cantata da
Gino Paoli);
L’Epicedio (per le occasioni funebri e i funerali: ad esempio La Ballata del
Pinelli);
L’Elegia (un narrazione triste, potrebbe essere esemplificata con Santa Lucia di
De Gregori o La storia di Marinella di De Andrè);
L’Idillio (un tema bucolico, come un Mazzo di fiori di Roversi-Dalla);
Il Sermone (componimento satirico, come l’Ultimo Mohicano di Gianfranco
Manfredi)
L’Epistola (una composizione in forma di lettera, come l’Anno che verrà di
Lucio Dalla o Rosso colore di Bertoli);
L’Epigramma (una comunicazione pungente e ironica, di quattro/cinque versi al
massimo, come le canzoni-bonsai di Enzino Iachetti).
Indagando su cosa ha generato l’idea-base di una serie di canzoni, ho
individuato una lunga serie di spunti, in parte rientranti in questo elenco, in
parte no, più che altro allo scopo di coinvolgere il lettore nel completare la
lista.
Sono chiaramente nati da
Un testo letterario:
Dormono sulla collina, Un matto, Un giudice, Un blasfemo, Un malato di cuore,
Un medico, Un chimico, Un ottico, Il suonatore Jones, di Fabrizio De Andrè e
Giuseppe Bentivoglio, tutte liberamente tratte dall’antologia di Spoon River di
E.L.Masters
Un fatto di cronaca:
1) La Donna Cannone di Francesco De Gregori, ispirata da un fatto realmente
accaduto: un circo equestre era entrato in crisi a seguito della fuga d’amore
della sua massima attrazione, una donna che tutte le sere veniva sparata da un
cannone. Era accaduto che una sera, dopo lo sparo, la donna era sparita, non
nel cielo, ma con il suo amante.
2) Una Storia Sbagliata di Fabrizio De Andrè, commissionatagli dalla RAI per la
sigla di una trasmissione ispirata all’omicidio di Pier Paolo Pasolini.
Un rapimento:
Hotel Supramonte, ispirata a Fabrizio De Andrè dalla sua drammatica avventura
in Sardegna ed allo strascico che ebbe nei suoi rapporti con la compagna Dori
Ghezzi, rapita assieme a lui.
Una donna:
Margherita di Luberti e Cocciante; ma anche Laura, Maria, Suzanne, Dolly,
Nenè, Anita, Emanuela, Gloria, Liu, Dolcenera,Titti, Sally, Linda, Isolina,
Elena, Alice, Maruzzella, più quasi tutto il calendario di nomi femminili, ma
non Francesca, perché sappiamo che secondo Lucio, Non è Francesca.
La dedica ad una città:
Roma capoccia, Ma se ghe pensu (Genova), Malaga, Addio Lugano bella,Ciao
Turin, Rimini, Genova per noi, Napule è, e migliaia di altre località.
La dedica ad un luogo:
Creuza de ma, Luci a San Siro, Motel, Porta Portese, Via del Campo, Il mare,
Chiesetta alpina, La collina, Via della povertà, Via della Croce, ecc.
La luna:
Verde luna, Luna rossa, Guarda che luna, Luna marinara, Pallida luna, Luna tu,
Acqua dalla luna, più almeno il 20% delle ispirazioni delle canzoni
Le stagioni:
Estate, April in Paris, Maledetta primavera, Inverno, Il mare d’inverno,
Autumn in New York, ecc.
Una data:
1950 di Amedeo Minghi, 29 settembre di Lucio Battisti, 4/3/1943 di Lucio Dalla
e Paola Pallottino.
Un periodo:
I migliori anni della nostra vita di Renato Zero, A very good year interpretata
sia da Franck Sinatra sia da Ray Charles.
Una rosa:
La rosa sfogliata di Vinicio De Morales, metafora dell’amore in disfacimento;
Rose Rosse, Yellow roses of Texas e molti altri esempi.
Se la rosa è rossa, ovviamente, è simbolo d’amore, ma spesso, di qualunque
colore sia, è una metafora dell’intimità femminile.
Celebrità del passato:
Bartali di Paolo Conte, Nuvolari e Caruso di Lucio Dalla, Girardengo (Vai
campione) di cui è autore il fratello di Francesco De Gregori, Carlo Martello di
De Andrè, più tante altre.
La nascita di un figlio:
Avrai, di Claudio Baglioni.
Una storia strana:
Aguaplano di Paolo Conte (un pianoforte a coda in fondo al mare, sul fiume di
Gennaio che è poi Rio de Janeiro, che mai si saprà come e perché sia finito lì);
I sogni:
Nel blu dipinto di blu e centinaia d’evocazioni che apparirebbero troppo
assurde se non fossero giustificate dal fatto di essere state provocate da una
fantasia notturna;
Una sbronza:
Amico fragile di De Andrè, scritta in garage sotto l’effetto del vino dopo una
furiosa serata nei salotti bene della Sardegna degli anni 70.
L’amicizia:
Ci vorrebbe un amico di Venditti, Una donna per amico di Riccardo Cocciante,
L’arcobaleno, dedica musicale di Giulio Rapetti a Lucio Battisti dopo una sua
visione notturna; Amico di Renato Zero.
Una cadenza ritmica:
Zoccoletti, quelli che, per intenderci, nella tormentone che cantava Claudio
Villa, ogni mattina davano il buon giorno a Nina; Scalinatella longa, dove il
passo del somaro segna il ritmo della bella canzone di Roberto Murolo.
Un manifesto politico:
Contessa, di Paolo Pietrangeli, La locomotiva di Francesco Guccini, ecc.
Oggetti e cose:
Sassi, Foglie morte, Abatjour (o l’illuminazione di una celebre casa
d’appuntamenti di Buenos Aires in A Media luz, il celebre tango che descrive le
stanze piene di velluti, tutti in penombra, che sorgevano al celebre indirizzo di
un lupanare dell’epoca, “Corriente 648”, riportato nel testo, dove ora esiste
soltanto più uno squallido garage).
I fenomeni atmosferici:
Il vento, Solo, sole, sole, Cantando sotto la pioggia, O sole mio, Nebbia,
Tramonto, Quando calienta el sol, Alba tragica, ecc.
Una parte del corpo:
Bocca di rosa, Le tue mani, Lisa dagli occhi blu, Ma le gambe…
Strumenti musicali:
La fisarmonica di Stradella, Chitarra romana, Suona balalaika, Il piano
elettrico, ecc.
Le attività professionali:
Il pianista di piano-bar, Boscaiolo, Vecchio lampionaio, Ma dove vanno i
marinai, Lupo di mare, Il pescatore, ecc.
Un aneddoto:
Lo scrutatore non votante di Samuele Bersani. L’autore confessa di aver scritto
di getto la canzone dopo l’incontro con un amico che gli aveva confessato di
non votare alle elezioni. Solo che lo stesso amico era stato visto da Samuele nel
ruolo di scrutatore alle elezioni precedenti, donde una serie di ossimori e di
nonsense deliziosi che danno vita a questo testo di Bersani.
Ho lasciato per ultimo il tema principe, l’amore. Dice Giulio Rapetti (Mogol) che
se gli amori non producessero tormenti, nel sorgere, nello svolgimento e nella
fine del sentimento, probabilmente non ci sarebbe nulla da scrivere.
Ecco una infinitesima parte delle canzoni ispirate a
L’amore nelle sue varianti.
- la nascita del sentimento:
La costruzione di un amore, di Ivano Fossati; Mi sono innamorato di te di Luigi
Tenco;
Che cosa c’è di Gino Paoli (più centinaia di altri esempi)
- un madrigale:
La Cura, di Franco Battiato, che riesce ad essere intrisa d’amore senza mai
nominarlo; (anche qui gli esempi sono infiniti, molte spesso sotto forma di nomi
femminili, quasi mai maschili);
Un amore ritrovato:
Valsinha di Chico Buarque De Hollanda
- l’abbandono:
Quando finisce un amore di Luberti e Cocciante, Ne me quitte pas di Jacques
Breil; L’amore conta di luciano Ligabue, Cantando con le lacrime agli occhi,
Viale d’autunno
- il suicidio per amore:
La ballata del Michè, Marinella di Fabrizio De Andrè, Alfonsina, cantata da
Mercedes Sosa, e tante altre canzoni ispirate a suicidi per un amore finito.
Più il 70% della produzione canzonettistica di tutto il mondo ispirato all’amore.
IL JAZZ NELLA TORINO DEGLI ANNI 50
Il disegno musicale più ambizioso a Torino negli anni dal 1955 al 1958, almeno
per quanto riguardava il jazz californiano, era guidato da Piero Brovarone, un
geniale commesso di dischi che anni dopo si sarebbe trasferito negli USA,
laureandosi brillantemente in fisica nucleare, diventando poi un docente di
informatica dopo anni di brillante attività alla NASA. Brovarone suonava (e
ancora suona, negli USA) con grande tecnica, una infinità di strumenti, sempre
da autodidatta: tromba, chitarra, flauto, pianoforte. Scriveva anche sofisticati
arrangiamenti. Ero presente quando arrivò un pacco delle Messaggerie Musicali
contenente un flauto-traverso che Brovarone aveva acquistato per
corrispondenza. Aprì il pacco, montò i due pezzi dello strumento e, senza aver
mai saputo come s’imboccasse un flauto, suono un’aria di Bach in modo
perfetto. Faceva quasi rabbia. Aveva l’orecchio assoluto e improvvisava in
modo magistrale in qualunque tonalità. Dopo un periodo come commesso da
Gariazzo (un negozio di dischi a fianco del teatro Alfieri che importava i primi
LP dagli USA e che rappresentava il centro di raccolta per gli appassionati
torinesi di jazz moderno) Piero (noto come Pedro) aprì un proprio negozio in via
XX Settembre nel quale io, in attesa di partire per il servizio militare, lavoravo
pretestuosamente come assistente: il vero scopo era ascoltare jazz tutto il
giorno e incontrare i vari Franco Mondini, Enrico Rava, Cesare Fiorio, Giampaolo
Belgrano, Raul Marietti, Bruno Bonsignore, Ennio Vitanza, Piero Delsedime (un
emulo di Gerry Mulligan al sax baritono, poi diventato un brillante docente
universitario) e tanti altri della ganga dei “modernisti”.
Vi erano poi altri bravi musicisti, in particolare pianisti: Mario Rusca, ad
esempio, e un certo Peter Angela, che tutti oggi conoscono con il suo nome
anagrafico di Piero. Ma amavamo alla follia un dolcissimo ragazzo dalla parlata
romana, Maurizio Lama, che si era trasferito a Torino quando il padre assunse in
quella città l’incarico di Provveditore agli Studi. Maurizio, che accompagnava
splendidamente al piano Enrico Rava, morì pochi anni dopo in un incidente
stradale sull’Autostrada dei Fiori.
Hot jazz e cool jazz
Ho già accennato al tormentone dell’epoca che divideva il jazz tra hot e cool.
In quegli anni, e forse oggi farà impressione ai giovani jazzisti sentirlo dire, gli
ambienti del jazz si dividevano in due fazioni distinte, che a volte finivano
anche in rissa: il termine jazz caldo e jazz freddo lo usavano solo gli estranei
alla cerchia jazzistica, di solito signore-bene che volevano apparire informate,
ed a noi faceva ribrezzo.
I termini usati erano “tradizionale” e “moderno”.
C’erano quindi i “tradizionalisti”, che ascoltavano o suonavano solo dixieland,
blues e revival, e i “modernisti”, come noi, che seguivano solo quello che
andava dal bebop in poi. I primi accettavano anche la swing era, ma si
fermavano lì. Per loro Dizzy Gillespie, Charlie Parker, per non parlare di tutto il
jazz bianco (Stan Kenton, Woodhy Hermann, l’intera East Cost) era musicaccia
incomprensibile. Noi chiamavamo gli altri “cavernicoli”. Alcuni dei
“modernisti”, almeno io ero tra questi, non facevano però troppe distinzioni tra
le epoche.
Oltre al primo disco che mi fece scoprire il jazz, di cui ho già detto, ce ne fu un
secondo importante nella mia formazione iniziale: un’altra antologia, questa
volta dell’East Coast, grazie alla quale m’innamorai di Gerry Mulligan, Chet
Baker, Shally Manne, ecc. Ma via via ascoltai tutto il jazz, dalle origini a quei
giorni, cioè a metà degli anni ‘50. Una profonda emozione la provai al mio
primo concerto, al teatro Nuovo di Torino nel 1956, quando ascoltai per la
prima volta dal vivo il quartetto di Gerry Mulligan, che da pochi mesi si era
separato da Chet Baker. Alla tromba quella volta c’era Joe Eardly. L’emozione
fu pari a quelle che ricevetti nell’ascoltare, molti anni dopo, in distinti
concerti, due giganti: Louis Armstrong e Duke Ellington.
Il centro di tutte le attività di jazz tradizionale (e solo qualche volta di jazz
moderno, che in quel locale era piuttosto malvisto) era il Sangip Club, al
Valentino, dove aveva sede il Circolo Torinese del Jazz (del quale qualche
tempo dopo venni nominato segretario) frequentato da uno stuolo di ex alunni
del San Giuseppe, il fior fiore della Torino-bene dell’epoca che si formava dai
guesuiti.
Nella cantina, dove vi era anche un sala-prove, erano attive diverse formazioni
di jazz tradizionale e di swing e, solo in un secondo tempo, di jazz moderno.
Era lì che avvenivano gli scontri, qualche volta fisici, tra gli appassionati dei
due generi. Mi ricordo che una volta uno dei “cavernicoli” sbattè il coperchio
del piano sulle mani di un pianista che stava eseguendo un pezzo di Lennie
Tristano e per poco non gli spezzò le dita.
Stanchi di essere vessati da questi personaggi intransigenti, decidemmo di fare
una colletta tra noi e affittare una cantina. Il più attivo in questa operazione,
oltre me, fu Enrico Rava. Andammo a parlare con il segretario della Camera del
Lavoro di Torino il quale ci affittò per poche lire al mese uno scantinato
enorme, pieno di topi e scarafaggi.
Comprai presso una cartiera decine di rotoli di cartone ondulato che servirono a
tappezzare le pareti ed insonorizzare il locale, aiutati anche da una raccolta di
contenitori per uova che i negozianti buttavano via. Poi colorammo tutto con
tinte che obbligavano a suonare con gli occhiali da sole per non essere accecati,
tanto erano vivaci. Ma fu un successo. Avevamo una sala prove solo per il “jazz
moderno”. Quando il segretario della Camera del Lavoro scese per vedere cosa
Rava ed io stavamo combinando fu talmente sorpreso da nostro zelo che ci fece
omaggio di tre mesi d’affitto. Con quella somma pagammo la derattizzazione e
suonammo finalmente senza i topi. Che tempi, gente, da non credere. Era in
quel cantinone enorme che Enrico Rava studiò seriamente l’imboccatura della
tromba.
La band più importante era guidata da uno molto bravo nel ragtime, Ettore
Zeppegno, che poi si trasferì a Roma alla direzione artistica della RCA.
Spiccavano nella banda Gigi Cavicchioli al sax basso e Alex Cameron Curry alla
cornetta in Do.
Altri gruppi erano animati dal clarinettista Bepi Cancan, poi trasferitosi a Milano
per lavorare nell’editoria.
Ricordo un cantante negro che per poche lire cantava gli standard americani
per qualunque formazione, Al Tanner, sempre sbronzo, che viveva di rendita
(aveva sbancato il Casinò di Venezia in una serata fortunata) bevendo pinte di
bourbon al bar di fronte a Porta Nuova.
Ad un livello, sempre amatoriale, ma decisamente eccellente, era molto attivo
il gruppo Jazz at Kansas City con Renato Germonio, Sergio Farinelli, Emilio
Siccardi e Dick Mazzanti, che alternava il trombone al piano, nel quale
eccelleva nello stile boogy woogy. L’avvocato Siccardi era un vero principe del
foro, talmente appassionato di Lester Young che ne imitava, oltre il fraseggio e
la sonorità sul sax tenore, anche l’abbigliamento (girava sempre con un
cappello piatto a tesa tonda) e, quando la band raggiungeva dei momenti caldi,
suonava piegando il sax tenore di lato, come il suo idolo. Siccardi e Mozzanti,
oltre che amicissimi, erano anche cognati, perché avevano sposate due sorelle
appassionate di jazz.
Nelle grandi occasioni venivano al club anche dei musicisti che, sebbene fossero
quasi coetanei, sembravano molto più vecchi di noi, talmente erano bravi:
Gianni Basso, Oscar Valdambrini, Dino Piana, Sergio Fanni e Carlo Sola.
Era sempre presente anche Sergio Ramella che anni dopo sarebbe passato dal
ruolo di appassionato ascoltatore a quello di organizzatore di eventi jazzistici.
Di tanto in tanto avvenivano dei gemellaggi e degli scambi culturali con altri
circoli del jazz sparsi per l’Italia: tra questi i più attivi erano il circolo di
Bologna, dove imperava Ruggero Stiassi, quello di Genova, animato da Lucio
Capobianco, quello di Roma (dove la Roman News Orleans Jazz Band
spadroneggiava, animando quella che poi venne chiamata la Dolce Vita) e
Perugia, dove si era trasferito da Genova Adriano Mazzoletti, che poi lasciò
Perugia per Roma e andò alla Rai, diventando, negli anni seguenti, con Nicolosi,
Biamonte, Rosa e Rotondo uno dei programmatori di jazz più attivi. A
Mazzoletti si devono inoltre i più significativi studi sul jazz italiano, sui quali
ritorneremo più avanti.
Si tenevano settimanalmente, in questi circoli, delle audizioni guidate, a tema.
Noi al San Gip a Torino avevamo una rigorosa programmazione mensile e non
era raro che fossero presenti molte decine di appassionati. La sala era sempre
piena se era in programma del jazz tradizionale, ma una sera, per l’improvvisa
assenza di un conferenziere su Bix Beiderbecke, lo sostituii io con un
programma sul post be bop.
Siccome i “cavernicoli”, di fatto, altro tipo di jazz che non fosse il loro non lo
ascoltavano quasi mai, si trovarono spiazzati nel dover ammettere che le cose
che stavano ascoltando erano eccellenti. Così a poco a poco i gruppi smisero di
lottare tra loro. Anche se, non solo gli appassionati, ma anche alcuni critici
ufficiali non riuscirono mai ad accettare le nuove tendenze.
All’inizio del mio periodo di segretariato del circolo, forse anche grazie al fatto
che le mie audizioni avevano (non è immodestia, solo cronaca) il più elevato
numero di ascoltatori, venni invitato a tenere una conferenza fuori dal circolo,
in un teatro, un vero, enorme teatro. L’annuncio era apparso su La Stampa
cosicché molte centinaia di persone, attratte dal tema e dal fatto che
l’audizione fosse gratuita, riempirono la sala. Ricordo vividamente due cose: la
prima, che quando vidi più di mille persone in sala mi trasformai in uno zombie
dalla paura. Se mi avessero detto che, anni dopo, sarei diventato un docente di
tecniche per la comunicazione efficace in pubblico, sarei morto dalle risate. La
seconda, che il direttore del teatro, che non mi conosceva ma aveva
trionfalmente annunciato “Tra poco sarà qui il noto conferenziere Enrico
Cogno”, vedendo un giovane spaventato che si era presentato con lo stesso
cognome, pensò che si trattasse del figlio del conferenziere mandato ad
annunciare il ritardo del padre.
“Tuo padre quando arriva?” mi chiese nervoso.
“Mio padre non viene”.
“Come non viene?”
“Ma non si occupa di queste cose… Guardi che Enrico Cogno sono io.”
“Tuuuuuuu?” E lo sgomento si dipinse sul suo volto.
In realtà andò tutto benissimo.
Poi per me quel periodo d’oro finì con la partenza per il servizio militare. Ero
nella 46°Aerobrigata a Pisa dove ascoltavo alla radio la Coppa del Jazz, che
quel anno venne vinta dal Quintetto di Lucca, guidato da Giovanni Tommaso e
Antonello Vannucchi.
Dopo fu tutto diverso.
Smisi di suonare quasi completamente, ma con due figlie piccole e un lavoro
che mi obbligava a molti viaggi, non mi pesò troppo il distacco dall’ambiente
jazzistico.
La civiltà della fame
Me lo ricordo bene, quando si viveva nella civiltà della fame, o se
vogliamo dirla alla Enzo Spaltro, nella società della scarsità. La
comunicazione, al confronto di oggi, quasi non esisteva e non ce
ne accorgevamo neppure. Pochi amici con il telefono, pochissimi
con il televisore, alcuni con la Vespa, solo i figli di papà con
l’auto. Si parlava, si camminava, si ascoltava musica. Lontani anni
luce dal diluvio informativo di oggi, dai cellulari che trillano come
cicale in ogni luogo, che mandano messaggi cifrati: T.V.M.B. io di
+ xkè 6 bella.
Era meglio, era peggio? Era diverso. Certo, più scomodo, molto
più silenzioso, più raccolto, meno sguaiato. Se confronto la
comunicazione degli anni di guerra, con le notizie sullo sbarco
degli alleati captati di nascosto da Radio Londra, con i quattro
colpi di tamburo che riprendevano l’inizio della Quinta di
Beethoven (un ritmo cupo che metteva i brividi, soprattutto se
passavano nei pressi delle pattuglie tedesche che avrebbero
fucilato chiunque fosse stato trovato all’ascolto) e lo paragono con
le immagini delle Twin Towers che crollano in diretta, le emozioni
sono identicamente forti, mentre i due sistemi di comunicazione
sono chiaramente all’opposto.
Le immagini, in radio, erano quelle della fantasia, in TV, quelle
della realtà.
Ma non sempre la fantasia perde, nel confronto.
Ma lo strumento di comunicazione che in quel giorno, quel
maledetto storico e trasformante 11 settembre, ha dimostrato di
aver perso, è stato Internet: almeno in quelle ore, chi poteva ha
spento il computer ed ha acceso la televisione, al limite, la radio.
Poi si è attaccato al cellulare per dirlo agli altri, sperando di
arrivare per primo, quasi godendo dell’essere per primo
messaggero di una catastrofe.
Ma Internet rimane lo strumento principe per creare un net work
mondiale, come la sigla WWW, Wordls Wide Web, indica. Non a
caso, nel 2006, il protagonista scelto per la mitica copertina del
Times è stato uno specchio, per indicare che i protagonisti del
mondo siamo noi, collegati nella rete mondiale.
Negli anni in cui ascoltavo Radio Londra di nascosto non sapevo
quale fosse la differenza tra informazione e comunicazione. Non
mi era chiaro che si comunica sempre e che se anche si cerca di
non comunicare, si comunica lo stesso. Non sapevo che invece non
sempre si fa informazione, perché se non si informa,
l’informazione davvero non c’è.
La memoria
Allora non sapevo che la memoria fosse così importante. La usavo,
in quei tempi, solo come tecnica di studio, e quello era l’uso che
consideravo serio, in alternativa all’uso gioioso, per ricordare cose
gradevoli, per rivivere dei momenti belli. Non conoscevo la
distinzione tra memoria a lungo termine, quella di tipo
emozionale, eterna, e la memoria labile, quella che usavo per
leggere dei testi mal scritti da recitare in esami sgradevoli. La
memoria l’avevo ridotta a strumento utile per ottenere un voto di
sufficienza, non sapevo nulla dell’emisfero sinistro e di quello
destro del cervello, non sapevo che gli ermeneuti greci e i docenti
della Roma antica sapevano giocare con la memoria come Cirano
con le parole, sapevano trarne il massimo profitto, visto che
scrivere, all’epoca, era poco agevole e che tanti erano gli
analfabeti.
Ho incominciato a capire che cosa volesse dire saper fare davvero
comunicazione quando, nella mia prima visita romana, mi imbattei
nelle lastre di marmo di via dei Fori Imperiali che mi mostravano,
tavola dopo tavola, il successivo espandersi dell’impero.
Pensateci: senza Internet, senza fax, senza telefono, senza
giornali, senza radio, senza TV, il sistema di comunicazione degli
antichi romani teneva saldamente collegato quasi tutto il mondo.
Era più lento, ma doveva funzionare perfettamente, visti i
risultati. Credo che il fattore determinante fosse la capacità,
certo maggiore di quella attuale, di memorizzare.
Non per nulla noi, mammiferi umani di lentissima crescita,
impieghiamo ben 25 anni per giungere ad una relativa maturità e
ne trascorriamo altrettanti a dormire: assommando, nella vita
media di un individuo, le ore di sonno a quelle del tempo che gli
occorre per diventare psicologicamente maturo, ogni persona
impiega 50 anni, quindi ben oltre la metà della sua vita media. Di
quello che gli resta, una grande parte, soprattutto verso la fine, la
passa a ricordare.
Il tempo dedicato al lavoro sta rapidamente decrescendo: dice
l’evoluzione storica del rapporto vita/lavoro che i nostri avi
vivevano in media 300.000 ore e ne lavoravano 200.000, noi ne
viviamo 700.000 di cui ne trascorriamo 150.000 a lavorare, mentre
i nostri nipoti, che vivranno 850.000 ore, ne dedicheranno soltanto
120.000 ore al lavoro.
Non abbiamo più bisogno di usare la memoria per ricordare cose
che una banca dati può custodire meglio della nostra materia
grigia; dobbiamo invece incominciare ad usare la memoria come
macchina della metafora, come generatore di nuovi sistemi di
relazione. Italo Calvino ricordava, nelle “Lezioni Americane”, che
il silenzio, lo spazio, l’autonomia, l’amicizia, la convivialità, la
bellezza sono una rete di connessioni tra i fatti, tra le persone, tra
le cose del mondo, che già sono e sempre più saranno la vera
ricchezza del terzo millennio. Come ottenere questo? Se non
fossimo in grado di usare così bene la memoria, ci consola
Nietzsche: “Il vantaggio della cattiva memoria e che si gode
parecchie volte delle stesse cose per la prima volta”.
LA ROMA MUSICALE DEGLI ANNI 60
Quando arrivai a Roma, invece, la musica mi mancava. Dirigevo il servizio
comunicazioni di una multinazionale americana e, dal tardo pomeriggio in poi,
avevo del tempo libero. Ripresi a collaborare con Musica Jazz e con qualche
periodico che ospitava delle rubriche musicali. Poi venni invitato da Angiolillo a
tenere per il quotidiano Il Tempo la rubrica del jazz, visto che la nuova
direzione di Gianni Letta dava molto spazio alla cultura. Questo fece scattare
anche delle collaborazioni con la Rai, che poi proseguirono, in vari modi, per
quasi venti anni, particolarmente con Adriano Mazzoletti e Paolo Padula.
Collaboravo anche con le prime radio romane, che allora si chiamavano “radiolibere”. In particolare una, Radio GBR, trasmetteva da uno sgabuzzino
dell’Hotel Hilton (che si trova in cima a Monte Mario) e irradiava un segnale di
buona potenza: mi lasciava un sacco di spazio, ero libero (vorrei vedere, era
una radio-libera) di trasmettere cosa volevo, non come in Rai dove tutto
passava attraverso cento controlli. Tenevo una rubrica che chiamai “My
favorites” nella quale trasmettevo, dato il titolo, i brani che amavo di più. Il
proprietario era un simpatico ed esplosivo commerciante di elettrodomestici,
per cui venivo pagato in natura, nel senso che mi dava lavatrici e frigoriferi e
non denaro. Molte volte facevo venire in diretta (tutto era in diretta, fare le
differite costava di più e non c’erano quattrini) dei musicisti per intervistarli e
andavamo avanti ore a parlare di jazz.
Insomma, mi venni a trovare nella condizione di avere spazi nei quali operare
ed una serie di contatti con un sacco di musicisti, l’ideale per raccogliere con
facilità del materiale.
Mi venne l’idea di fare una ricerca (il mio primo lavoro era stato quello di
ricercatore), in particolare una doppia indagine, dapprima sul jazz italiano e
poi su quello europeo, che non godevano di grande spazio né in Rai, né sui
giornali.
Poi, parlando con l’editore Cappelli di Bologna, con il quale ero in contatto,
pensai di riversare i risultati dell’indagine in due libri, il primo, che venne
realizzato nel 1971, JAZZ INCHIESTA ITALIA e il secondo, che avrebbe dovuto
intitolarsi JAZZ INCHIESTA EUROPA, che invece rimase lettera morta perché
l’editore incominciò a vivere momenti difficili.
In quel periodo collaboravano con il mio servizio aziendale due personaggi,
Ennio Tamburi (un art director molto creativo, un vero artista, nipote nel
grande Orfeo Tamburi) e Umberto Santucci (fratello del trombettista Cicci
Santucci). Umberto, tra le tante cose che faceva, allora era prevalentemente
un fotografo. Con loro decisi di dare al libro un montaggio che, grazie alla mole
di fotografie che avevo fatto produrre a Santucci, potesse, alternandosi alle
parole, dare un certo ritmo alla stesura del tutto: l’intenzione era quello di fare
un testo “che avesse swing”.
La copertina avrebbe dovuto essere una tromba riempita di spaghetti, a
significare un certo intasamento tipico della cultura medio-borghese italiana di
quel periodo: in realtà venne reperito solo un vecchio bombardino a Porta
Portese e al posto degli spaghetti vennero infilati nello strumento dei bucatini
all’amatriciana, semplicemente perché quel giorno in casa del fotografo quello
era il piatto servito a pranzo.
C OME VENNE ACCOLTO IL LIBRO
Al testo vennero dedicate molte recensioni, tra le quali una, lunghissima e
lusinghiera, a cura di Walter Mauro, che occupò interamente le due pagine
centrali de La Fiera Letteraria, della quale ho perso il ritaglio.
La cartolina promozionale a suo tempo realizzata in appoggio al lancio del
libro
Ecco una sintesi delle altre recensioni, riportate non per immodestia ma come
puro atto di cronaca :
Musica Jazz: “Cogno ha descritto il suo libro come una jam session. Il risultato
è che si legge di corsa, con divertimento e anche con utilità, considerato che
alla fine ci si fa effettivamente un’idea precisa del mondo del jazz italiano,
degli umori e delle idee che vi circolano”.
Franco Fayenz: “Un volume agile che descrive e fornisce prove con notevole
incisità. Il libro è scritto molto bene, con vivacità, con anticonformismo e con
una libertà di schemi che riesce a riflettere nelle parole lo spirito del jazz.”
Fabrizio Zampa su Il Messaggero: “Un ritratto discordante ma vivo, costruito
con le caratteristiche di un servizio giornalistico.”
Maurizio Costanzo (con Dina Luce in Buon Pomeriggio) RadioRAI: “Un libro
molto bello, un abecedario utilissimo per chi vuole accostarsi al jazz, adatto
soprattutto per i giovani e con una caratteristica indispensabile in questo senso:
costa poco”.
Giuseppe Gatt: “Testimone e non giudice. In questa impostazione metodologica
sta il grosso merito del libro di Cogno; l’aver cioè rinunciato alla presa di
posizione cattedratica e l’aver scelto una forma di coinvolgimento globale che
colloca il libro in linea con il più vivo ed attuale spirito della critica d’oggi”
Arrigo Polillo su Il Giorno: “Sin dalla copertina è emblematicamente indicato lo
spirito spregiudicato (ma solo apparentemente divertito) con il quale l’autore
ha avvicinato la materia. Ognuno degli intervistati spara sul bersaglio preferito,
talvolta senza rifuggire dai colpi bassi”.
Renzo Nissim in “E via discorrendo..RadioRAI”: “Il libro è eccellente, con una
veste grafica avvincente ed un suo stile imprevisto, molto ritmico”.
Tonino Scaroni su Il Tempo: “E’ un libro che tocca i tre aspetti del mondo
jazzistico: chi fa, chi giudica e chi ascolta il jazz in Italia, in modo
assolutamente nuovo ed interessante”.
Walter Mauro su Il Dramma: Sul filo dell’indagine giornalistica il libro di Cogno
si presenta come quanto di più completo e pertinente ci si potesse aspettare”.
Pietro Violante su Il Giornale di Sicilia: “I jazzmen italiani vengono fuori con
verità (qui il merito di Cogno) colti in una confusa e affannosa ricerca
d’identità”.
Dario Salvatori su Ciao 2001: “Enrico Cogno ha risolto molto brillantemente il
problema di un libro nuovo ed attuale sul jazz italiano: un libro che costituirà
per tutti gli appassionati una piacevole sorpresa”.
Roberto Capasso su Il Paese Sera: “Un’inchiesta coraggiosa, una serie di
interviste che hanno il pregio di essere montate in maniera assai valida, si da
facilitare la lettura”.
E. G. Mattia su Momento Sera: “Una trattazione giovane, ricca di notizie, una
registrazione fedele delle arringhe in difesa del jazz, raccolte in un documento
che non si perderà nel mucchio della stampa periodica”.
Giorgio Martinelli su Il resto del Carlino: “Un quadro fitto di cose e personaggi,
con molte pregevoli illustrazioni nel testo”.
Il Secolo XIX: “Lontano da ogni cerebralità questo libro si propone di capire e
informare. Gli interventi di Cogno sono spesso maliziosamente provocatori e
pongono con franchezza sul tappeto certe questioni imbarazzanti: un vivace
campione di stimolante polemica culturale”.
Gianni Capitani su L’Avanti: “Un buon libro, con un montaggio agile, favorito
da un racconto fotografico e da una impaginazione di grande interesse”.
Albert Rodriguez in Per voi giovani: “Presenta l’immagine del jazz italiano
nella sua dimensione quotidiana, evitando le definizioni universalistiche e lo fa
mediante una proposta metodologica molto corretta.”
Francesco Forti su Spettacolo: “Una mano, quella di Cogno, di regista oltre
che di scrittore. Non è facile resistere all’intensa suggestione che emana dal
libro per come è stato montato e per la sua scrittura rapida e swingante”.
Ma una recensione che mi ha colpito, della quale non conosco l’autore, l’ho
trovata di recente navigando in Internet in un sito internazionale di vendite
editoriali, che dice: “Jazz Inchiesta Italia è un libro ormai introvabile sul jazz
italiano degli anni '70. Tra le righe riesce a parlare dell'Italia di quegli anni e di
alcune idee che attraverso la musica si stavano affermando. L'ho trovato su una
bancarella a Roma Ostiense e ne ho comprato 2 copie. E’ uno di quei libri a
margine del mondo editoriale e quindi bellissimo e appassionato.“
Vennero tirate ben 25.000 copie del libro (una vera esagerazione, dato il
numero abituale della tiratura di opere del genere) che dopo qualche tempo
riempirono i vari remainder d’Italia.
I PERSONAGGI DELL ’ EPOCA
Il problema che mi si pose subito, non appena ebbi deciso di scrivere
l’inchiesta, fu quali personaggi inserire e quali escludere dal testo, anche in
base alla ridotta bibliografia esistente: all’epoca, sul jazz italiano, le due opere
di riferimento erano la discografia curata da Pippo Barazzetta, edita nel 1960
(Giuseppe Barazzetta, JAZZ INCISO IN ITALIA, Messagerie Musicali, Milano,
1960) e un libro-disco di Adriano Mazzoletti, una vera chicca, dal titolo 40 ANNI
DI JAZZ IN ITALIA, che riuniva in due LP una splendida selezione di brani storici
dei musicisti italiani più significativi, corredata da un album fotografico. La
bella copertina era opera del graphic designer romano Sergio Salaroli.
Soltanto diversi anni dopo, nel 1982, Mazzoletti editò per Laterza un altro
testo, la prima edizione de “Il jazz in Italia” che, pur essendo un libro
corposo, per altro presentava solo una parte delle sue ricerche. Una più recente
edizione di questo testo, divisa in due volumi (il primo dei quali si estende dalle
origini agli anni Trenta), presenta invece il materiale nella sua completezza e si
spinge fino agli anni Settanta.
E’ un panorama completo del jazz in Italia dal 1902 agli anni Trenta, un testo
nel quale si sfatano molte vecchie idee sul rapporto tra jazz e società italiana.
Afferma Adriano Fazzoletti che “all'inizio il jazz in Italia è stata una musica di
imitazione del modello americano. I musicisti che affrontarono per primi questa
musica negli anni Venti erano quasi tutti diplomati, molto preparati e in più
possedevano la capacità di capire e assimilare il nuovo linguaggio, anche se
conoscevano soprattutto un jazz più leggero, da ballo. A partire dal 1932
appaiono degli straordinari musicisti con una forte personalità che, se fossero
vissuti altrove, oggi sarebbero considerati dei grandi. Il periodo più significativo
va dal 1935 all’avvento del bebop: il periodo swing ha prodotto grandi musicisti
di assoluto valore, primo fra tutti il fisarmonicista Gorni Kramer, il trombettista
Nino Impallomeni, il sassofonista Piero Rizza, il pianista Romeo Alvaro.”
Chi mettere, chi levare da quel testo?
Ricordo, mentre preparavo Jazz Inchiesta Italia, che nell’intervistare Giorgio
Gaslini ricevetti da lui l’incitamento a “separare la gramigna dal grano”, che
fuori di metafora voleva dire “scegli tu chi mettere nel libro, ma non mettere
tutti”. Optai per una soluzione che mi sembrava corretta a livello editoriale:
dare più spazio (foto e intervista) ai jazzmen maggiori e citare soltanto gli altri,
senza però escludere qualcuno volontariamente. Poi, di fatto, qualche
dimenticanza mi avrà fatto cadere in qualche gaffes.
Alcuni di quei personaggi minori sono svaniti come meteore nel giro di pochi
anni. Altri, già piuttosto anziani all’epoca, si sono ritirati o sono deceduti. Altri
sono tuttora in splendida forma e al centro dell’attuale panorama del jazz.
Invece molti dei big attuali, all’epoca erano poco più che bambini e ovviamente
non potevano comparire come: per citarne alcune per tutti, Massimo Urbani,
Paolo Fresu e Stefano Bollani.
Come sappiamo il primo dei tre non è riuscito ad uscire dal tunnel e, purtroppo,
possiamo solo ricordarlo con grande affetto.
L A PREFAZIONE DI M ASSIMO M ILA
Una annotazione va fatta per la prefazione al testo, a cura di Massimo Mila, un
grande teorico musicale che era piuttosto defilato rispetto al jazz. Confesso che
mi serviva il nome di un saggista super partes che non irritasse nessuno dei
colleghi della critica: non avrei potuto chiedere la prefazione, che so, ad Arrigo
Polillo piuttosto che a Franco Fajenz senza sollevare gelosie e ripercussioni
negative. Invece, sia Polillo, sia Fajenz, con altri critici musicali come Franco
Pecori, Umberto Santucci, Alberto Rodriguez, Giancarlo Roncaglia (gli ultimi
due deceduti in questi ultimi anni) intervennero per altro all’interno del libro, o
sotto forma di intervista o di contributo scritto. Così, chiesi a Mila
l’autorizzazione a pubblicare un suo scritto sul jazz sotto forma di prefazione e
lui, gentilissimo, accondiscese senza problemi. Eccola riprodotta:
Prefazione
Il jazz moderno è diventato un fenomeno complesso e multiforme, chi si dirama
in varie articolazioni e che non teme all’occorrenza di accostarsi alla
ricercatezza dell’arte moderna. Soltanto la presenza di qualche glorioso
superstite può restituire ancora nella sua autenticità quel senso univoco di
robusta ispirazione popolare che, più di quaranta anni fa, aveva attirato sul
jazz l’interesse e la simpatia di quasi tutte le forze vive della musica
contemporanea. Oggi anche il jazz percorre vie difficili, non meno difficili di
quelle degli indirizzi più avanzati della odierna musica d’avanguardia. Ed è
giusto che sia così: probabilmente sarebbe un errore volerlo mantenere a forza,
come se fosse imbalsamato, su quelle posizioni di semplicità popolare di cui
solo Armstrong e gli artisti della sua epoca conservano il segreto. Ma anche il
jazz di oggi comprova la propria positività precisamente attraverso l’evoluzione
che subisce: proprio perché alle
sue origini c’erano la verità e la forza dell’ispirazione popolare, il jazz si
dimostra capace di sopravvivere e di seguire un proprio destino artistico, che
magari lo allontana dalle posizioni originarie. Ma non si vive senza trasformarsi,
e anche chi è rimasto sentimentalmente attaccato alla nostalgia del jazz della
sua giovinezza, anche chi ha perduto il contatto con la molteplicità degli
sviluppi più recenti, così prolifici di nuove formule e nuovi stili, se fa tanto di
accostarvisi, non tarda a riconoscere in questi sviluppi le conseguenze
inevitabili dell’antico ceppo.
E’ ancora l’antico incendio che alimenta le nuove fiamme, o fiammelle che
siano, e anche nelle sue recentissime formulazioni il jazz resta tuttora una
manifestazione genuina della musica del nostro tempo: senza avere spento
l’originario impulso popolare, ne documenta le possibilità di affinamento e di
evoluzione stilistica in accordo con il volgere dei tempi: basterebbe questo per
fare del jazz un capitolo insostituibile nella musica moderna.
Massimo Mila
Molti amici non ci sono più
Nel ripensare a quel periodo a distanza di tanti anni risulta evidente che per
molte persone la vita è troppo breve. La lista delle persone che nel frattempo
sono decedute è lunga. Solo per citarne alcuni: Massimo Urbani, Alberto
Rodriguez, Giancarlo Roncaglia, Dick Mazzanti, Sergio Battistelli, Umberto
Cesàri, Oscar Valdambrini, Marcello Melis, Romano Mussolini, Giancarlo Cesaroni
(il patron del mitico Folkstudio) ed i due anfitrioni della serata nella quale Jazz
Inchiesta Italia venne presentato, Pepito e Picchi Pignatelli. Scelsi infatti per
l’occasione il loro mitico Music Inn, che era il tempio del jazz a Roma. Pepito e
Picchi, dieci anni dopo, uscirono drammaticamente dalla scena del jazz: dopo
la morte del principe-batterista per alcolismo, Picchi non resistette al dolore e
poco tempo dopo si tolse la vita.
Ma quella serata di presentazione, affidata a Renzo Arbore, fu molto vivace e
allegra. Era presente uno stuolo di colleghi giornalisti e musicisti, animati da
Dario Salvatori, Fabrizio Zampa, Marco Molendini e tanti altri. Alla fine ne
venne fuori, ovviamente, una jam session.
A proposito di amici scomparsi, mette conto riportare qui un avvenimento che
seguì immediatamente la pubblicazione del libro relativo a Umberto Cesari. Il
grande pianista era stato da me descritto con stima e affetto, ma senza
un’intervista diretta. Sapevo, da quanto si diceva in giro, che era stato il
migliore pianista italiano in assoluto, ma che da anni viveva in casa, senza
uscire mai. Una storia che aveva, del tutto casualmente, delle attinenze con
quanto scrisse molti anni dopo Alessandro Baricco in Novecento, un testo nato
per il teatro che poi diventò un film (“La leggenda del pianista sull’oceano”) nel
quale si narra la storia di un pianista abbandonato in fasce dalla madre
emigrante su di una nave dalla quale non scenderà mai. In entrambe le storie di
tratta di splendidi pianisti che vivevano isolati.
BIBLIOGRAFIA JAZZ
Kitty Grime - “Jazz at Ronnie Scott’s” , Robert Hale – London, 1979.
Max Gordon - “Live at The Viliage Vanguard “, St. Martin Press -New York 1980.
Linda DahI -“Stormy Weather” - Quartet Books - London 1984
Robert Reisner “Bird: The Legend Of Charlie Parker”, Quartet Books - London
1962.
Sally Placksin - “American women in Jazz”, Wideview Books - U.S.R. 1982.
Hildred Roach - “Black American Music”, Crescendo – Boston 1973.
Kitty Grime - “Jazz Voices”, Quartet Books - London 1983.
Art & Laurie Pepper - “Straight Life”, Schirmer Books -N.Y. 1979.
Gaetano Liguori - Guido Michelone - “Una Storia Del Jazz” C. Marinotti - Milano
1999.
New Groue Dictionarg Of Jazz - McMillan 1994.
Gian Carlo Roncaglia - “Italia Jazz Oggi”, De Rubeis – Anzio 1990
Charles Mingus -“Beneath The Underdog”, Penguin – London 1975.
Barry Vlanov -“Manuale Del Jazz”, Feltrinelli, Milano 1959.
Mario Pasi -“George Gershwin”, Guanda - Parma 1958.
Gunther Schuller -“II Jazz Classico”, Mondadori - Milano 1979.
Keith Jarrett -“II Mio Desiderio Feroce”, Socrates – Roma 1994.
Livio Cerri -“Discussioni Sul Jazz”, Collector - Cosenza 1995.
Autori vari -“Jazz Guitarists”, Guitar Player - California 1973.
AMI -“Catalogo Solisti & Gruppi”, Raggiaschi - Siena 1993.
Antonio Orlando -“Guida alla Musica Jazz”, Gammalibri - Milano 1978.
Enrico Cogno -“Jazz Inchiesta Italia”, Cappelli - Bologna 1971,
Billy Taylor -“Jazz Piano: A History”, W.C.B. Publ. - lowa 1982.
Miles Davis - Quincy Troupe -“Miles”, Rizzoli - Milano 1998.
J.C. Thomas -“ Chasin’ The Trane”, Elm Tree Books – London 1975.
Bruce Crowther & Mike Pinfold -“The Jazz Singers”, Blandford Press - London
1986.
Autori vari: “Russian Jazz: New Identity”, Quartet Books -London 1985.
Leslie Gourse -“Louis’ Children”, Quill - N.Y. 1984.
Laurent De Wilde -“Thelonious Monk Himself”, Minimum Fax - Roma 1996.
Paola Boncompagni -“Lady Day”, Nuovi Equilibri - Roma 1990.
Arnold Shaw -“Sinatra”, Longanesi - Milano 1970.
Paul Olivier -“Bessie Smith”, Ricordi - Milano 1961.
Arrigo Zoli -“Franco D’Andrea”, Azi – Roma
Banny Green - “Blame It On My Youth”, Panther - London 1969
Andrè Hodeir - “Uomini e Problemi del Jazz”, Longanesi “ Milano 1958
Bill Cole - “John Coltrane”, Schirmerbooks - New York 1978
lan Carr - “Miles Davis”, Arcana Ed. - Milano 1982
Ed Kirkeby - “Ain’t Misbehavin’ “, DaCapo Press - N.Y. 1966
H.Hawes-D.Asher - “Raise Up Off Me”, C,M & G - N.Y. 1972
Vladimiro Lupi - “Vocal Groups”, S.A.T.E. - Ferrara 1986
Livio Cerri - “Mezzo Secolo di J,”, Nistri-Lischi - Pisa 1981
Len Lyons - “Jazz Pianists”, DaCapo Press - N.Y. 1983
Whitney Balliett - “American Singers”, Oxford Press - N.Y. 1979
Franco Fayenz - “Jazz & Jazz” Laterza - Bari 1981
Adriano Mazzoletti - “II Jazz in Italia”, Laterza - Bari 1986
Luciano Federighi - “Cantare il Jazz”, Laterza - Bari 1986
Andrè Hodeir - “The WorIds Of Jazz”, Grove Press - N.Y. 1972
Gene Lees - “Singers And The Song”, Oxford Press - N.Y. 1987
A.B. Spellman - “Black Music: Four Liues”, Schocken - N.Y- 1986
Frank Kofsky - “Black Nationalism And The Revolution In Music”, Pathfinder
Press - N.Y. 1970
Whitney Balliet - “new York Notes”, DaCapo - N.Y. 1972
Duke Ellington - “Autobiografia”, Emme Ed. - Trento 1981
Joachim Berendt - “The Jazz Book”, Paladin - Great Britain 1976
Luciano Federighi “Le Grandi Voci della Musica Americana” Oscar Mondadori Milano 1997
S.B. Charters - L.Kunstadt - “Jazz”, DoubleDay &C. - N.Y. 1962
Louis Armstrong - “Satchmo”, Garzanti - Milano 1970
LeRoi Jones - “II Popolo del Blues”, Einaudi - Torino 1968
Enrico Pieranunzi - “Bill Evans” Nuovi Equilibri - Roma 1994
lan Carr - “Keith Jarrett” Arcana - Milano 1992
Giancarlo Roncaglia - “Una Storia del Jazz” Marsilio - Venezia 1982
Arrigo Polillo - “Jazz” Oscar Mondadorì - Milano 1976
Arrigo Zolì - “Storia del J. Moderno Italiano” Azi - Roma 1983
Livio Cerri - “Jazz in Microsolco” Nistri Lischi - Pisa 1963
Longstreet-Dauer-Carpitella - “Dizionario del Jazz” II Saggiatore Mondadori Verona 1960
Eric J. Hobsbawm - Storia Sociale del J.” Editori Riuniti - Roma 1982
David Meeker - “Jazz In The Movies” Talisman - London 1981
Alec Wilder - “American Popular Song” Oxford - N.Y. 1975
Antonio Lodettì - “Jazz & Jazzmen” Kaos - Milano 1992
Feather-Gitler - “Jazz in The Seventies” Quartet - London 1978
Joachim & Ernst Berendt - “Fotostoria del Jazz” Garzanti-Milano 1979
Jimmy Lyons - “Dizzy, Duke, The Count and Me” Living Book San Francisco 1978
Brian Case - Stan Britt - “Enciclopedia illustrata del Jazz” Idea Libri - Milano
1981