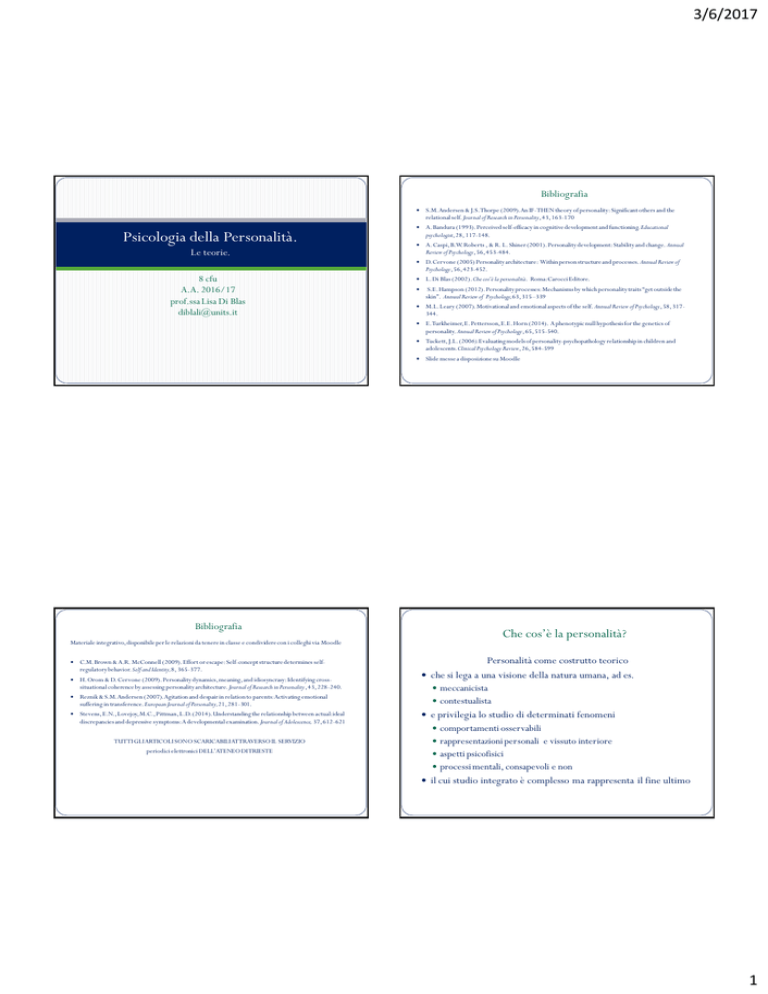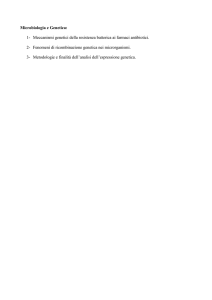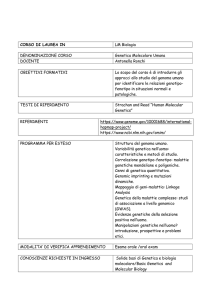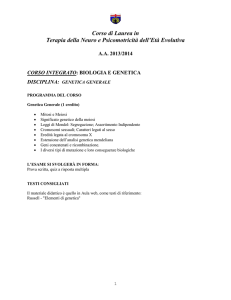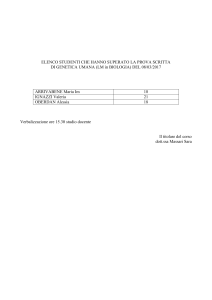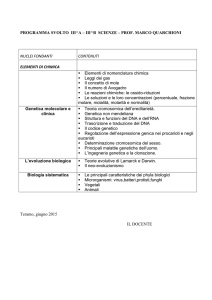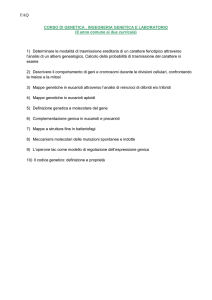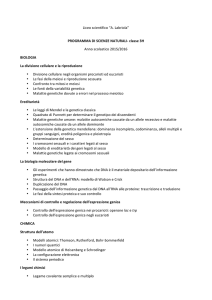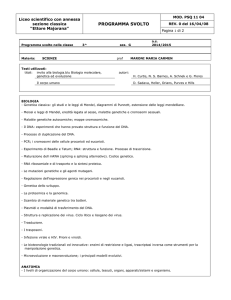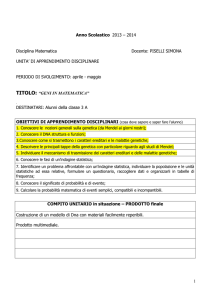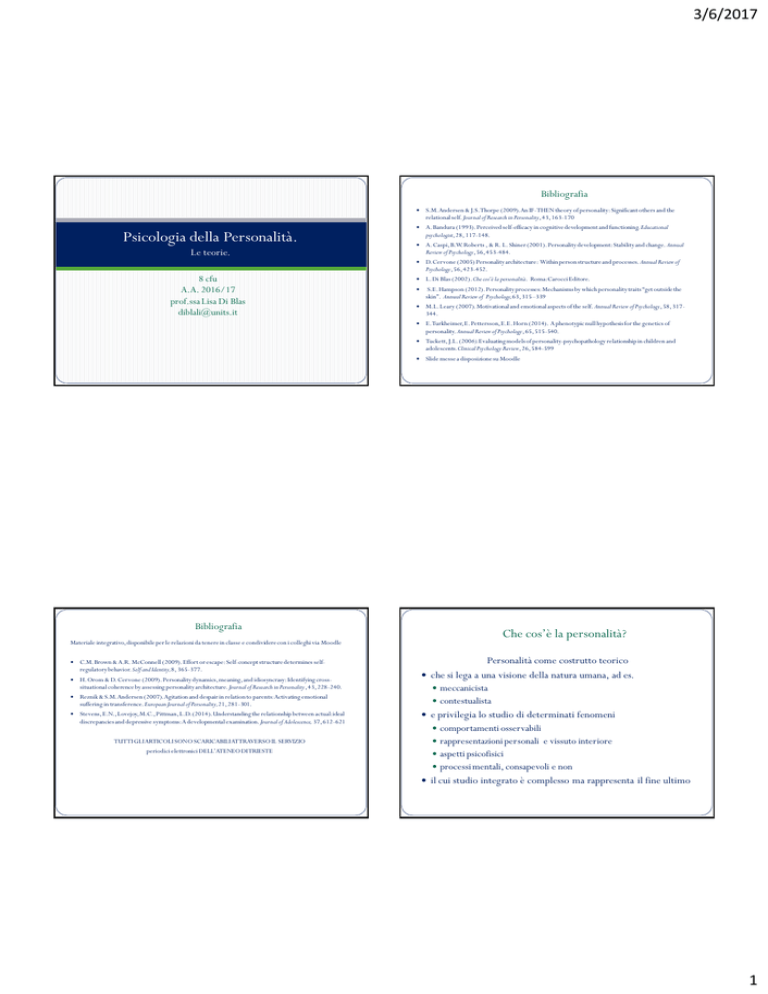
3/6/2017
Bibliografia
Psicologia della Personalità.
Le teorie.
8 cfu
A.A. 2016/17
prof.ssa Lisa Di Blas
[email protected]
S.M. Andersen & J.S. Thorpe (2009). An IF-THEN theory of personality: Significant others and the
relational self. Journal of Research in Personality, 43, 163-170
A. Bandura (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational
psychologist, 28, 117-148.
A. Caspi, B.W. Roberts , & R. L. Shiner (2001). Personality development: Stability and change. Annual
Review of Psychology, 56, 453-484.
D. Cervone (2005) Personality architecture: Within person structure and processes. Annual Review of
Psychology, 56, 423-452.
L. Di Blas (2002). Che cos’è la personalità. Roma:Carocci Editore.
S.E. Hampson (2012). Personality processes: Mechanisms by which personality traits “get outside the
skin”. Annuul Review of Psychology, 63, 315–339
M.L. Leary (2007). Motivational and emotional aspects of the self. Annual Review of Psychology, 58, 317344.
E. Turkheimer, E. Pettersson, E.E. Horn (2014). A phenotypic null hypothesis for the genetics of
personality. Annual Review of Psychology, 65, 515-540.
Tuckett, J.L. (2006).Evaluating models of personality-psychopathology relationship in children and
adolescents.Clinical Psychology Review, 26, 584-599
Slide messe a disposizione su Moodle
Bibliografia
Che cos’è la personalità?
Materiale integrativo, disponibile per le relazioni da tenere in classe e condividere con i colleghi via Moodle
C.M. Brown & A.R. McConnell (2009). Effort or escape: Self-concept structure determines selfregulatory behavior. Self and Identity, 8, 365-377.
H. Orom & D. Cervone (2009). Personality dynamics, meaning, and idiosyncrasy: Identifying crosssituational coherence by assessing personality architecture. Journal of Research in Personality, 43, 228-240.
Reznik & S.M. Andersen (2007). Agitation and despair in relation to parents: Activating emotional
suffering in transference. European Journal of Personality, 21, 281-301.
Stevens, E.N., Lovejoy, M.C., Pittman, L.D. (2014). Understanding the relationship between actual:ideal
discrepancies and depressive symptoms: A developmental examination. Journal of Adolescence, 37, 612-621
TUTTI GLI ARTICOLI SONO SCARICABILI ATTRAVERSO IL SERVIZIO
periodici elettronici DELL’ATENEO DI TRIESTE
Personalità come costrutto teorico
che si lega a una visione della natura umana, ad es.
meccanicista
contestualista
e privilegia lo studio di determinati fenomeni
comportamenti osservabili
rappresentazioni personali e vissuto interiore
aspetti psicofisici
processi mentali, consapevoli e non
il cui studio integrato è complesso ma rappresenta il fine ultimo
1
3/6/2017
Che cos’è la personalità?
Elementi dominanti nello studio della personalità
tendenze di base o tratti o disposizioni
condizioni ambientali
rappresentazioni di sé, degli altri, del mondo
caratteristiche adattive: competenze acquisite, atteggiamenti,
valori, obiettivi, stili interpersonali e ruoli sociali
biografia, narrato e storia di sé
concetto di coerenza (consistency)
Che cos’è la personalità?
Questioni dominanti e trasversali alle teorie della personalità
ruolo della genetica
ruolo dell’ambiente
aspetti stabili o strutture e aspetti dinamici o processi
intra-personali
inter-personali
ruolo del tempo
stabilità e cambiamento
passato, presente e futuro
leggi generali e leggi idiografiche
Teorie dei tratti o disposizionali
Le teorie dei tratti o delle disposizioni
Modelli tassonomici o di classificazione dei tratti disposizionali
Il costrutto di personalità si articola
intorno a queste idee principali:
la personalità è definita come un insieme di tratti o disposizioni
i tratti si manifestano direttamente attraverso i nostri comportamenti,
cognizioni, emozioni
hanno una base biologica
sono relativamente coerenti e stabili attraverso
i contesti
il tempo
si privilegiano gli aspetti stabili o strutturali della personalità
si privilegiano leggi generali per descrivere e spiegare la
personalità
2
3/6/2017
Teorie dei tratti:
le costanti comportamentali
Teorie dei tratti e teorie disposizionali
Lo studio delle disposizioni viene affrontato sul piano
Tratti come predisposizioni a manifestare alcuni comportamenti,
(cognizioni ed emozioni) in modo più regolare di altri:
il comportamento dipende dai tratti
descrittivo
sviluppo
temperamento e personalità
continuità nel tempo
TRATTO (elemento latente)
esplicativo
genetica
COMPORTAMENTO
biologia
ambiente
effetti additivi e interazione tra genetica e ambiente
TRATTO
COGNIZIONE/AFFETTI
Teorie dei tratti: la classificazione delle
costanti comportamentali
Tratti come categorie sovraordinate di un sistema che organizza
comportamenti (cognizioni, affetti) osservabili: le tassonomie
Obiettivo
classificazione sistematica delle differenze individuali
indagando come in generale ci si comporta, si sente, … al di là del contesto e
del tempo
Metodi
COMPORTAMENTO
Teorie dei tratti: la classificazione delle
costanti comportamentali
Tratti come costrutti psicologici e categorie sovraordinate di un sistema
che organizza comportamenti (cognizioni, affetti) osservabili: le
tassonomie
Estroversione
ottimismo
energia
Benevolenza
altruismo
ubbidienza
Coscienziosità
ordine
perseveran
za
Stabilità Emotiva
ansia
sicurezza
Immaginazione
creatività
curiosità
osservazione, questionari, produzione libera, …
self- report, peer report, TR, …
Tecniche di analisi
validazione psicometrica
riduzione dei dati via ACP e AFC (validazione interna)
correlati esterni e sperimentali (validazione esterna)
3
3/6/2017
Teorie dei tratti: la classificazione delle
costanti comportamentali
Teorie dei tratti: costanti comportamentali
Attraverso le tecniche di riduzione dei dati si organizzano comportamenti, emozioni,
cognizioni in categorie più generali che svelano così le differenze individuali più
rilevanti mediante un approccio BETWEEN PEOPLE
ACP: relazione di indicazione
AFC: relazione di dipendenza
L
L
X
Ancora un esempio: Tassonomia e validazione dei Problemi esternalizzanti e
Problemi internalizzanti secondo il modello ASEBA (fonte D’Orlando et al, 2010)
Teorie dei tratti: le costanti comportamentali
… al contempo pertanto il comportamento rivela i tratti
TRATTO (elemento latente)
COMPORTAMENTO
biologia
TRATTO
COGNIZIONE/AFFETTI
COMPORTAMENTO
Y
Teorie “deboli” o descrittive dei dati,
la componente classifica e riassume,
senza obiettivi esplicativi
X
Y
Teorie “forti” dei tratti che assumono una
disposizione latente,
che descrive e spiega i correlati (coerenze)
comportamentali
Teorie dei tratti: categorie temperamentali e della personalità
TEMPERAMENTO
“… quei fenomeni che caratterizzano la natura emozionale di un
individuo e che includono la sua suscettibilità alla stimolazione
sensoriale, la qualità del suo stato umorale prevalente, nonché le
fluttuazioni e l’intensità del suo stato umorale; questi fenomeni
vengono considerati come dipendenti da elementi costituzionali e
dunque in origine ampiamente ereditari” (Allport, 1937)
PERSONALITÀ
Si riferisce in modo più inclusivo alle tendenze relativamente stabili
e coerenti che le persone hanno di comportarsi, pensare e sentire
Distinguiamo, per entrambe i costrutti, tra modelli
bottom up: puramente esplorativi e descrittivi
top down: biologici che utilizzano espliciti criteri di definizione e
selezioni delle disposizioni di base
4
3/6/2017
Teorie dei tratti: categorie temperamentali
Teorie dei tratti: categorie temperamentali
Elementi di accordo
Basi biologiche
Stabilità temporale: Il substrato temperamentale rimane costante, si
Legame diretto temperamento-comportamento solo nella prima
modificano le sue espressioni comportamentali
infanzia oppure in condizioni ambientali nuove
Forte componente affettiva
Elementi di disaccordo
Quali e quante dimensioni
Peso dell’ereditarietà
Centralità dell’emozionalità
Teorie dei tratti:
categorie temperamentali e della personalità nell’infanzia
Big Five: Hierachical Personality Inventory for Children (bottom up)
approccio bottom-up, descrittivo, non assume basi biologiche:
Estroversione (Ottimismo, Espressività, Timidezza, Energia)
Benevolenza (Egocentrismo, Altruismo, Ubbidienza, Dominanza, Irritabilità)
Coscienziosità (Ordine, Concentrazione, Perseveranza, Motivazione alla
riuscita)
Stabilità emotiva (Ansia, Sicurezza)
Immaginazione (Creatività, Intelletto, Curiosità)
Thomas e Chess (bottom up)
Progetto NYLS
base biologica, non
necessariamente genetica
il come o stile del comportamento
in 9 categorie
1. ritmicità delle funzioni
biologiche
2. livello di attività
3. approccio / evitamento
4. qualità predominante umore
5. soglia sensorio-percettiva
6. adattabilità
7. intensità reazioni (emotive)
8. distraibilità
9. perseveranza
9 categorie ridotte poi a 4-7, tra
cui:
Inibizione sociale
Emozionalità negativa
Adattabilità
Attività
Perseveranza
Teorie dei tratti: categorie temperamentali
Rothbart (top down)
Le differenze comportamentali dipendono da differenze di natura biologica, a
base genetica ed ereditaria, riconducibili a
Reattività intesa proprio come risposta biologica di attivazione ed
eccitabilità che coinvolge il sistema endocrino, neurovegetativo e
nervoso centrale
Auto-regolazione intesa come funzione di regolazione mediante
approccio, ritiro, inibizione, attacco e attenzione
Le differenze biologiche generano differenze legate a 3 macro-sistemi, ciascuno
dei quali rappresenta differenze costituzionali nei livelli di reattività
(affettiva e comportamentale) e di modulazione della reattività:
Reattività negativa, reattività positiva, sistema attentivo
5
3/6/2017
Teorie dei tratti:
categorie temperamentali
Teorie dei tratti: categorie temperamentali
Rothbart:
Reattività negativa o Sistema dell’ansia (BIS), la cui attivazione genera stati
affettivi negativi, inibizione del comportamento, sensibilità alle minacce
Reattività positiva o Sistema d’approccio (BAS), la cui attivazione genera
affetto positivo, approccio all’ambiente e alle novità, sensibilità alle
ricompense
Sistema attentivo o effortful control (volontarietà del controllo) che coinvolge
controllo inibitorio (sopprimere risposte inappropriate), direzione e
mantenimento dell’attenzione, sensibilità a stimoli a bassa intensità
Buss e Plomin (top down)
base biologica, si all’ereditarietà
metodo dei gemelli
modello EASI: Emozionalità (negativa), Attività, Socievolezza, Impulsività
Teorie dei tratti: le categorie della personalità
Molti modelli, tra questi BF (bottom up) e PEN (top-down)
Big Five psicolessicali e il modello a 5 fattori (FFM)
ipotesi di sedimentazione
primi studi anni ’40 ma fiorisce anni ‘80/’90
liste di aggettivi classificati in macro-categorie
denominate poi Big Five (BF)
e in parallelo si afferma il Five Factor Model (FFM—che diventa anche modello
esplicativo secondo Costa e McCrae)
BF e FFM sono ancora modelli dominanti
correlati esterni
continuità attraverso il tempo (cfr tassonomie temperamentali)
basi biologiche
seppure complessa la questione della loro tenuta trans-culturale
Per un sistema tassonomico unitario nell’infanzia (R. Shiner)
Estroversione e Affettività positiva
Inibizione sociale (verso il nuovo)
Timidezza (verso il conosciuto)
Socievolezza
Dominanza
Energia-Livelli di attività
Nevroticismo e Affettività negativa
Irritabilità e rabbia
Categorie concettualmente legate
attraverso le fasce d’età sono un
pre-requisito per lo studio della
continuità delle differenze
individuali nel tempo
Ansia e Paura
Coscienziosità e Constraint
Attenzione e persistenza nel compito (vs. impulsività cognitiva)
Controllo inibitorio (vs. impulsività comportamentale)
Motivazione alla riuscita
Amabilità
Antagonismo e Aggressività
Prosocialità (empatia e altruismo)
Teorie dei tratti: categorie della personalità
Il modello sperimentale di H. Eysenck
cfr visione critica di un approccio correlazionale come quello
del modello a 5 fattori (“costellazioni di parole”)
necessario lo sviluppo di una teoria causale e di un metodo
d’indagine ipotetico-deduttivo
che prevede come la personalità debba essere studiata
tenendo conto di
fattori causali
tratti fenotipici
conseguenze comportamentali
approccio etic-imposed (FFM)
approccio emic per dimensioni psicolessicali
6
3/6/2017
Teorie dei tratti: la personalità
IL MODELLOSPERIMENTALE DI
H. EYSENCK
fattori causali
deteminanti genetiche
strutture fisiologiche
tratti fenotipici
modello PEN
conseguenze comportamentali,
rilevabili in
contesti sociali
laboratorio
Genotipo:
il livello di una qualità
individuale così come
risulterebbe unicamente
determinata dal nostro DNA
Fenotipo:
una combinazione di
genetica
ambiente
strumento di
osservazione/misurazione
Teorie dei tratti: la personalità
Eysenck: La teoria dell’attivazione differenziale
le persone hanno diversi livelli di attività corticale
vi è una relazione tra attività corticale e
Estroversione/Introversione
estroversi livelli minori
introversi livelli maggiori
questa è una correlazione !
per affermare che l’Estroversione ha basi biologiche è necessario
trovare che vi sono precise conseguenze comportamentali:
per innalzare i loro livelli di attività della corteccia gli estroversi
cercano stimolazioni vs. gli introversi
Teorie dei tratti o disposizionali
Le teorie dei tratti o delle disposizioni
Meccanismi, Tempo e Ambiente
Il costrutto di personalità si articola
intorno a queste idee principali:
la personalità è definita come un insieme di tratti o disposizioni
i tratti si manifestano direttamente attraverso i nostri comportamenti,
cognizioni, emozioni sistemi tassonomici
hanno una base biologica
sono relativamente coerenti e stabili attraverso
i contesti quale il ruolo dell’ambiente? Temi trasversali!
il tempo quali forme di continuità? Temi trasversali!
si privilegiano gli aspetti stabili o strutturali della personalità, lo
studio dei tratti, ma crescente attenzione verso modelli dinamici
si privilegiano leggi generali per descrivere e spiegare la
personalità quali i meccanismi? Temi trasversali!
7
3/6/2017
Teorie dei tratti: I meccanismi
Come agiscono i tratti ? (Hampson, 2012)
Teorie dei tratti: I meccanismi
Come agiscono i tratti ? (Hampson, 2012)
STIMATORE
TRATTO
OUTCOME
ASSOCIAZIONE
DIRETTA
il nevroticismo si associa a molti outcome anche oggettivi:
•bassa auto-stima
•maggiori livelli di problemi psicosomatici
•relazioni interpersonali meno soddisfacenti
•maggiori problemi cardiovascolari
•minore longevita’
Vi è dunque un supporto empirico a favore del costrutto di Nevroticismo
OUTCOME
MODERATORE
TRATTO
•Studi sperimentali mostrano che il NEVROTICISMO
modera l’impatto delle discrepanze di sé sugli stati depressivi, più intenso
se maggiore Nevroticismo
• Studi a misure ripetute in tempi brevi (dynamic modelling)
mostrano che il nevroticismo modera l’intensità delle reazioni emotive (rabbia)
agli eventi percepti come ingiusti, associazione più intensa
Teorie dei tratti: I meccanismi
Come agiscono i tratti ? (Hampson, 2012)
TRATTO
OUTCOME
Teorie dei tratti: I meccanismi
Come agiscono i tratti ? (Hampson, 2012)
ASSOCIAZIONE
MODERATA
MODERATORE
Studi sperimentali mostrano che l’associazione tra Nevroticismo e
violenza verso il partner è
• più intensa in condizioni di maggiore stress
•meno intensa se sono maggiori le abilità di tipo problem-solving
TRATTO
OUTCOME
ASSOCIAZIONE
MEDIATA
MEDIATORE
La relazione tra Nevroticismo e distress è mediata da
• maggiore percezione di eventi stressanti (processo di selezione)
• reazione agli eventi stressanti (processo di reazione)
8
3/6/2017
Teorie dei tratti: coerenza comportamentale e
coerenza della personalità cross-situazionale (il ruolo del contesto)
coerenza come invarianza negli ordini di
teorie disposizionali
p1
p2
50
25
s1 s2 s3 s4 s5
situazioni
aggressività
75
rango (r) attraverso i contesti
si esprime come elevazione del
punteggio o profilo
aggregazione tiene sotto controllo
l’errore di misurazione e la variabilità
cross-situazionale casuale (noise) e
permette di far emergere le
differenze individuali globali
C = P +A
Persona (disposizioni) e ambiente: relazioni e meccanismi di reciproca influenza
Persona (disposizioni) e ambiente:
relazioni e meccanismi di reciproca influenza
intreccio statico
persona può
stimolare reazioni ambientali (elicitazione)
reagire alle stimolazioni ambientali (reazione)
agire sull’ambiente attraverso (azione)
la selezione
NB La relazione tra P e A coinvolge
la costruzione
non solo disposizioni personali, ma
ovvero l’ambiente può
anche processi cognitivi affettivi e motivazionali
stimolare reazioni individuali
reagire a stimoli/azioni individuali
agire sulla persona attraverso
la selezione
la costruzione
Persona (disposizioni) e ambiente: relazioni e meccanismi di reciproca influenza
Elicitazione
le qualità disposizionali elicitano risposte ambientali:
i bambini con elevata impulsività comportamentale possono elicitare risposte
ambientali quali
nei pari: rifiuto, in part. verso gli ineffective aggressors (= scarso controllo della
loro aggressività + rifiuto delle regole)
negli adulti stili comportamentali ostili, negativi verso b: di scarso controllo,
punitivi, incoerenti nell’uso della punizione / premio
le qualità ambientali elicitano risposte personali
stili genitoriali coercitivi o di scarso controllo contribuiscono a sviluppo di c.
disadattivi
rifiuto dei pari contribuisce a sviluppo c. disadattivi
Elevata impulsività comportamentale combinata con stili genitoriali coercitivi
aumenta probabilità di insorgenza di problemi di tipo esternalizzante (P x A)
Reazione
dalle qualità disposizionali (P) possono dipendere le reazioni agli stimoli
ambiantali
b. impulsivi non rispondono alla punizione
b. inibiti rispondono alla punizione
L’ambiente rinforza positivamente o negativamente (reazione dell’ambiente
alla persona) qualità personali
si rinforza l’ansia di un b. verso il nuovo allontanandolo prontamente da nuovi
contesti che lo agitano
in ambienti degradati, pressioni sociali in direzioni disadattive: atteggiamenti positivi
verso modelli devianti
Tendenza all’inibizione combinata con stili genitoriali punitivi aumenta il
rischio di sviluppare problemi di tipo internalizzante (P x A)
9
3/6/2017
Persona (disposizioni) e ambiente: rlazioni e meccanismi di reciproca influenza
Selezione
dalle qualità disposizionali dipendono le caratteristiche dell’ambiente scelto
b. / adol aggressivi tendono a legarsi a pari difficili
adulto sceglie ambiente lavorativo, partner, amici
l’ambiente seleziona p. compatibile e respinge p. incompatibile
pari adattivi respingono bambini aggressivi (ma anche particolarm timidi)
pari accolgono b/i parim difficili
Ragazzi con probl comportamentali ricercano pari simili,
se accolti aumenta probabilità di creare spirale a rischio (P x A)
Persona (disposizioni) e ambiente: relazioni e meccanismi di reciproca influenza
Costruzione
dalle qualità disposizionali dipendono rappresentazioni dell’ambiente
b. aggressivi tendono a interpretare come ostili azioni e intenzioni altrui
b. esternalizzanti tendono a sovrastimare proprie competenze sociali
dalle rappresentazioni altrui dipendono le rappresentazioni personali
l’adulto trasmette al b. ciò che è bene/male (attraverso il dialogo quotidiano)
l’altro trasmette al b. chi è e quanto vale (genitori, pari)
l’altro trasmette teorie sul mondo (es. t. intelligenza)
Tendenze all’aggressività combinate con rappresentazioni altrui del mondo
come ostile mantengono e aumentano livelli di aggressività personale (P x A)
Lo studio della continuità dei tratti disposizionali
L’approccio è quantitativo e indaga diverse forme di continuità
psicometrica attraverso il tempo, tra le quali
1.
Continuità differenziale o gerarchica:
2.
Continuità assoluta:
stabilità degli ordini di rango (test-retest)
andamento dei livelli medi nel tempo (studi trasversali e studi
longitudinali)
gap maturazionali
3.
Continuità individuale
Continuità differenziale
verifica la stabilità degli ordini di rango
e si misura mediante coefficiente di correlazione
(test-retest)
Qual è la relazione tra età e stabilità dei tratti?
A quale età si osserva il picco della stabilità?
Qual è il livello di questo picco? Sufficientemente elevato per dire che
non si cambia più?
stabilità di una singola variabile a livello individuale (RCI)
10
3/6/2017
Continuità differenziale
Roberts e DelVecchio, 2000: meta-analisi di 152 studi longitudinali con oltre
3000 correlazioni test-retest (min = 1 anno, max = 53 anni, media = 6,7 con sd = 7,5),
età da 6 settimane a 73 anni; categorie BF e 5 fattori di Martin e Presley (1994)
Continuità assoluta
verifica la stabilità dei livelli medi di una caratteristica individuale
e si indaga mediante studi trasversali e studi longitudinali
Quale l’andamento dei livelli medi?
Vi è un picco vs un livello minimo ? A quale età?
Vi sono gap maturazionali?
Continuità assoluta: self-esteem
Continuità individuale
verifica la stabilità del livello
di una caratteristica
individuale nel singolo
individuo attraverso il tempo
e indaga se vi sia variazione o
cambiamento affidabile da un
tempo all’altro
11
3/6/2017
Determinanti ambientali del comportamento
Il contributo dell’ambiente
Teorie comportamentiste: L’apprendimento per associazione
Teorie sull’impatto del contesto ambientale:
Il comportamento
dipende largamente da fattori esterni alla persona
viene appreso
può essere spiegato attraverso meccanismi di condizionamento e
rinforzo
I modelli che legano Persona P all’Ambiente variano attraverso le
diverse teorie della personalità, tra queste
Il comportamentismo radicale e il condizionamento pavloviano
comportamentismo radicale: C = f A
interazionismo: P x A
genetica comportamentale
teorie cognitivo-sociali: P x A
Il comportamentismo radicale e il condizionamento pavloviano
Il condizionamento pavloviano
Watson attacca il metodo introspettivo, siamo agli inizi del ‘900
soggetto e oggetto di osservazione devono essere nettamente
separati
oggetto di studio può essere solo ciò che è direttamente
osservabile, ciò che è manifesto
comportamento come unità complessa, ma scomponibile in unità
semplici, caratterizzate da
frequenza e recenza
C = f frequenza e recenza
e spiegabile in termini di condizionamento pavloviano ( “classico”)
equazione fondamentale: R = f S (ovvero C = f A )
si possono distinguere
stimoli incondizionati (S INC)
stimoli condizionati (S CON) è uno stimolo inizialmente neutrale, arbitrario
e si possono distinguere
R incondizionate: RINC = f SINC
R condizionate: RCON è la risposta appresa mediante
condizionamento allo stimolo inizialmente neutrale
L’associazione costante di uno Sneutro ad uno SINC genera infine la stessa
risposta prodotta dallo SINC alla sola presenza, però, dello Sneutro; così
Sneutro diventa SCON e la risposta a questo RCON
12
3/6/2017
Il comportamentismo radicale e il condizionamento pavloviano
Il condizionamento classico: esempi
cane di Pavlov, dove la salivazione (RINC) al cibo (SINC) diventa RCON al
suono del campanello (stimolo neutrale che diviene SCON)
L’approccio è di tipo associazionista:
l’efficacia dello SCON dipende dal suo appaiamento con lo SINC
SCON deve precedere lo SINC, anche di pochi millisecondi
e l’apprendimento è rivelato dalla comparsa di una nuova risposta allo
SCON, la RCON che dimostra cambiamento
Teorie disposizionali: P C
Comportamentismo radicale: A C (non c’è posto per P)
Il comportamentismo radicale e il condizionamento pavloviano
Le nevrosi: ancora Pavolov
• ancora sul cane: l’esperimento con cerchi (stimolo neutarle riforzato) ed elissi
(stimoli neutrali non rinforzati) e la progressiva difficoltà a discriminare tra cerchi
ed elissi, modificando progressivamente la forma dei cerchi in elissi, determina
reazioni nevrotiche nel cane
• l’esperimento sul piccolo Albert condotto da Watson: reazione emotiva
condizionata
Terapia associata al condizionamento classico:
la desensibilizzazione sistematica di Wolpe
Si inibiscono le reazioni fobiche e ansiose attraverso il contro-condizionamento,
per fasi
rilassamento muscolare profondo
gerarchia di stimoli ansiogeni
intervento terapeutico: associazione rilassamento a stimoli ansiogeni
Il comportamentismo radicale e il condizionamento pavloviano
Processi associati al condizionamento classico:
generalizzazione: una RCON ad uno SCON viene associata anche ad altri SCON simili
processo che porta ad una coerenza comportamentale rispetto a stimoli simili;
discriminazione: se l’associazione Sneutrale /SINC si verifica per certi stimoli
ma non per altri che non sono seguito da SINC, una RCON si verifica solo in
funzione Sneutrali condizionati processo che conduce ad una specificità delle R CON
a stimoli simili;
estinzione: se lo SCON è presentato ripetutam senza essere seguito almeno
occasionalm da SINC, l’associazione si indebolisce progressivam, sino a
estinguersi del tutto;
differimento della gratificazione: a un aumento nell’intervallo di tempo tra
SCON e SINC progressivamente corrisponde un’estensione anche della RCON,
fino a essere osservata proprio poco prima che lo SINC sia presentato
Ancora sul condizionamento pavloviano secondo la
prospettiva funzionale
Il condizionamento pavloviano rimane un meccanismo basilare di
apprendimento
Le teorie funzionaliste mettono in evidenza come però in setting ecologici i
meccanismi di apprendimento possano funzionare in modo in parte diverso:
lo SCON deve essere naturalmente legato allo SINC, proprietà diverse dello
stesso oggetto (es. sapore e odore del cibo)
potenziamento dell’effetto di 2 SCON simultaneam presenti insieme allo SINC
(es., gusto e odore di cibo avariato)
apprendimento più rapido se maggiore rilevanza ecologica dello SCON (es.
suono del serpente a sonagli)
in termini adattivi, le RCON sono funzionali solo nel grado in cui facilitano un
organismo nella sua interazione con lo SINC
comportamento sessuale o di difesa del territorio
tolleranza condizionata all’assunzione di droghe
13
3/6/2017
Il comportamentismo secondo Skinner: il condizionamento operante
Del comportamentismo classico rimane centrale
l’idea del controllo (dall’esterno: A C)
il principio dell’associazione
ma non tutto è spiegabile con il condizionamento classico:
non vi sono solo RINC e RCON
ma anche comportamenti spontanei o operanti
condizionamento operante: un comportamento spontaneo (non elicitato da uno stimolo
ambientale specifico) è seguito da un evento nell’ambiente che funge da rinforzo; si
osserva come tale comportamento inizialm spontaneo diventi progressivamente più
frequente
in questo caso, l’ordine stimolo-comportamento appare invertito rispetto al
condizionamento classico
vs. meccanismo dell’estinzione operante: un comportamento spontaneo o piuttosto già
appreso non è seguito da rinforzo e progressivamente diventa meno frequente, fino a
cessare
Il controllo avviene attraverso la manipolazione dei rinforzi;
Vi è condizionamento operante se vi è CAMBIAMENTO
Skinner e la tecnica del modellaggio
Il condizionamento operante: shaping
ovvero come modificare il comportamento
analisi funzionale come tecnica di analisi delle covariazioni tra S e R
attraverso l’osservazione sistematica del comportamento
per estinguere comportamenti problematici
e rafforzare comportamenti desiderati
shaping
approssimazione graduale
esecuzione del comportamento
rinforzo positivo
estinzione operante
Il comportamentismo secondo Skinner: il condizionamento operante
Lo Skinner box:
associazione tra frequenza di un comportamento e tipo di programma
di rinforzo (time-based schedule vs response-based schedule)
apprendimento per successive approssimazioni
Il condizionamento operante: premi e punizioni
rafforzatore positivo: ciò che rende più forte il comportamento cui si
associa—può variare da individuo a individuo
sequenzialità del rinforzo:
rinforzo continuo
rinforzo parziale
rinforzo accidentale
rafforzatore negativo
rimozione rafforzatore positivo
stimoli aversivi
le punizioni sono efficaci?
Il comportamentismo secondo Skinner: e la personalità?
non trova posto il concetto di struttura della personalità
il comportamento è dettato dalle condizioni ambientali
non occorre ipotizzare / inferire strutture sottese o latenti
coerenza comportamentale
dipende dal contesto
meccanismi di generalizzazione / discriminazione
la liberà scelta e volontà sono un’illusione
I meccanismi di apprendimento individuati dall’approccio
comportamentista rimangono meccanismi basilari, anche per quel che
riguarda lo sviluppo delle differenze individuali
14
3/6/2017
Oltre il comportamentismo:
L’apprendimento sociale e l’introduzione della persona
L’ apprendimento tramite osservazione: modeling
l’esperimento di Bandura e Mischel (1965) sull’differimento della gratificazione
Pretest (selezionati b/i con % maggiore di scelte estreme tra 14 coppie di premi)
Fase sperimentale
Post test
L’apprendimento sociale: l’introduzione della persona
Apprendimento vicario e condizionamento operante
osservare per apprendere, ma senza diretta esperienza o pratica
rinforzo: non sono più necessari
progressiva approssimazione
esperienza diretta rinforzata
ripetuti rinforzi
può bastare una singola osservazione, anche per apprendere
1 mese dopo
comportamenti complessi
apprendimento ≠ prestazione
generalizzazione degli effetti nel tempo e attraverso stimoli e contesti
processi simbolici e cognitivi sono elementi essenziali per comprendere
e spiegare l’apprendimento: è la P a legare stimolo e conseguenze
qui ed ora: si re-interpretano i risultati osservati con il piccolo Albert
attraverso il tempo (anticipo esiti attesi )
attraverso i contesti
Oltre il comportamentismo:
come definire l’ambiente?
L’ambiente
può essere definito in modo
• OGGETTIVO:contesti definiti e accettati in modo consensuale
• “tassonomie” di ambienti oggettivi: rituali, divertimento, sport, conflitto
interpersonale
• SOGGETTIVO: contesti definiti e percepiti anche affettivamente in
modo individuale
offre RISORSE
esercita PRESSIONI
agisce sulla persona attraverso diversi meccanismi
può essere potente tanto da rappresentare “environtype”
Ambiente oggettivo: possibili variabili
(Evans, 2006)
Diversi studi mostrano come lo sviluppo
• cognitivo (capacità attentive, prestazioni in matematica o nella lettura)
• comportamentale ed emotivo caratterizzato p.es. da iperattività, aggressività
siano legati a variabili ambientali oggettive:
• inquinamento (es. esposizione prenatale a inquinamento da piombo), anche
acustico
• sovraffollamento
• qualità del quartiere, del vicinato
Condizioni economiche e sociali svantaggiate
minore accesso a cure mediche (mortalità infantile, problemi di crescita i
cui effetti permangono nel tempo)
minori stimolazioni cognitive (maggior abbandono scolastico)
minori aspettative di riuscita scolastica
maggiore stress, maggiore parenting negativo
esposizione a modelli devianti
15
3/6/2017
Ambiente oggettivo: possibili modelli persona e SE (Conger e Donnellan, 2007)
Modello diretto ambiente persona
modelli mediati
modello dello stress famigliare
Condizioni
economiche
Pressione
economica
Stress a
livello
famigliare
Il contributo della genetica comportamentale
Parenting
Difficolta
comportam
ed emotive
bambino
Conflitti
famigliari
modello dell’investimento famigliare
SES
Investimento
sui figli
Difficoltà
comportam ed
emotive figli
Teorie dei tratti: basi genetiche
Basi genetiche del comportamento: un’introduzione
Se le differenze individuali di base dipendono da disposizioni, allora è
necessario trovare conferma che i tratti hanno una base biologica, in
particolare genetica
Genetica comportamentale cerca di comprendere fino a che punto il
genotipo determina le differenze nel fenotipo
genetica quantitativa
genetica molecolare
Genetica e ambiente agiscono sull’individuo, non si può considerare
l’una senza l’altro
Lo studio della genetica comportamentale contribuisce alla
concettualizzazione dell‘ambiente e alla comprensione del suo ruolo
sullo sviluppo delle differenze individuali
… ovvero
i GENI sono quegli elementi che determinano le caratteristiche
manifeste (codificando sequenze di aminoacidi e generando specifici enzimi
e proteine)
i geni possono avere forme alternative dette ALLELI o fattori
che hanno la capacità di controllare un carattere FENOTIPICO
(ALLELOMORFISMO)
un allele può essere dominante o recessivo (cfr legge della
dominanza)
una combinazione di alleli è detta GENOTIPO
16
3/6/2017
Basi genetiche del comportamento: un’introduzione
i geni sono collocati in luoghi o LOCI specifici all’interno di un
cromosoma che a sua volta è collocato nel nucleo di una cellula
l’uomo è un organismo DIPLOIDE per cui ogni cromosoma è
presente in doppia coppia
nell’uomo vi sono 23 coppie di cromosomi omologhi
ogni coppia di cromosomi omologhi contiene le stesse
informazioni genetiche, cioé dettano in ogni punto lo stesso
carattere, ma non necessariam lo stesso allele
da un gene con 2 alleli possono derivare 3 genotipi (PP, Pp, pp)
se 2 cromosomi omologhi hanno 2 alleli identici, allora l’organismo è omozigote
per quel carattere (es. PP omozigote dominante vs pp omozigote recessivo)
Basi genetiche del comportamento: un’introduzione
Un esempio: la malattia di Huntington
Basi genetiche del comportamento: un’introduzione
G. Mendel e 3 leggi fondamentali
Legge della segregazione o della disgiunzione
• 2 elementi determinano una caratteristica individuale manifesta
• in un individuo, i 2 elementi si separano durante la riproduzione
• ciascun individuo eredita un elemento paterno e uno materno
Legge della dominanza
• un elemento può essere dominante o recessivo
• se si combinano un elemento dominante e uno recessivo, il carattere
manifesto dipenderà da quello veicolato dall’elemento dominante
Legge dell’assortimento indipendente
• ciascun elemento viene ereditato indipendentemente dall’altro (uno
dalla madre, uno dal padre)
Basi genetiche del comportamento: un’introduzione
Un altro esempio: la fenilchetonuria o PKU, una malattia recessiva
malattia degenerativa ereditaria che si manifesta per lo più tra 40-50
malattia degenerativa ereditaria, si manifesta nella primissima infanzia,
anni, con disturbi del movimento, cognitivi e comportamentali
responsabile è un gene specifico (localizzato sul cromosoma 4), con
allele dominante e genotipo Hh (eterozigote dominante)
responsabile è un gene specifico (localizzato sul cromosoma 12), con
Hh
Si può dimostrare
che la frequenza
rimane inalterata per
la generazione
successiva
allele recessivo e genotipo pp (omozigote recessivo)
hh
Pp
H
h
h
h
Hh
Hh
hh
hh
50% affetti
determinando importanti ritardi nello sviluppo
50% sani
Pp
P
p
PP
Pp
25% sani
P
50% portatori
Pp
p
pp
25% affetti
75% stesso fenotipo
17
3/6/2017
Basi genetiche del comportamento: un’introduzione
Basi genetiche del comportamento: un’introduzione
Indipendenza dell’assortimento: un esempio
i tratti complessi: le qualità individuali , siano discrete (colore degli
Aa
Bb
AB
Ab
occhi) siano continue (intelligenza), spesso dipendono non da un
singolo gene, ma da più geni tratti POLIGENICI
Aa
BB
aB
AB
ab
AA
BB
AA
BB
Aa
BB
AA
Bb
AA
Bb
Aa
Bb
Aa
BB
Aa
BB
aa
BB
Aa
Bb
Aa
Bb
aa
Bb
Aa
BB
Aa
Bb
aa
BB
aa
Bb
AB
aB
aB
16 combinazioni possibili
6 genotipi
se allele A e B dominanti,
allora 2 fenotipi (dove A e B
dominanti risultano nel
75% dei casi)
Basi genetiche del comportamento: un’introduzione
Figli
50%
Gemello
fraterno /
fratelli
50%
In generale, i dati empirici mostrano che
il rischio di schizofrenia e i livelli di
correlazione tra profili del QI aumentano
in base al grado di parentela
Genitore
50%
Zii
25%
target
Genello
identico
100%
Figli
50%
Nipoti
25%
Come lavorare su dimensioni continue?
Si applicano ancora le leggi di Mendel?
Due esempi:
Schizofrenia: il rischio di schizofrenia è del 48% per gemelli identici,
17% per gemelli frateni, 9% per i fratelli e genitori/figli, 4% per nipoti
(nonni/nipote, zii/nipote)
QI: il coeff di correlazione tra punteggi al QI è pari a .85 per gemelli
identici, .60 per gemelli fraterni, . 45 per i fratelli e genitori/figli, .15
tra cugini
Basi genetiche del comportamento: un’introduzione
le leggi di Mendel si applicano anche a tratti poligenici
in particolare, se operano con EFFETTI ADDITIVI, per cui
non sono completamente dominanti o recessivi, ma operano
contribuendo ciascuno al fenotipo,
allora si può dimostrare facilmente come
da 1 gene con 2 alleli 3 genotipi e 2 fenotipi
da 2 geni con 2 alleli 9 genotipi e 5 fenotipi
da 3 geni con 2 alleli 27 genotipi e 7 fenotipi
vale a dire, all’aumentare del numero di geni che
contribuiscono al tratto, ci si approssima a una distribuzione
normale dei fenotipi
18
3/6/2017
Basi genetiche del comportamento: genetica comportamentale
Alla base della genetica quantitativa vi è l’idea che i tratti quantitativi
dipendono da tratti poligenici
Benchè la maggior similitudine fenotipica di tratti poligenici si associ al
crescere del legame di parentela (within family), di per sé tale legame non
prova la base genetica del tratto, poiché la somiglianza potrebbe dipendere
dalla condivisione ambientale
Per questo, la genetica quantitativa tiene conto non solo della variabilità
genetica ma anche di quella ambientale, in particolare stima il grado in
cui le differenze individuali dipendano da differenze genetiche e da
differenze ambientali
Basi genetiche del comportamento: genetica quantitativa
La genetica quantitativa: la scomposizione delle fonti di variabilità
variabilità within family : i livelli di somiglianza fenotipica tra membri
di una famiglia possono dipendere da genetica e ambiente
varianza fenotipica P = G + E
G = variabilità genetica o grado in cui le differenze a base genetica si associano
alle differenze fenotipiche
E = variabilità ambientale (unica e condivisa)
La genetica molecolare stima specifici geni e profili genetici che sottendono
manifestazioni fenotipiche delle differenze individuali
Basi genetiche del comportamento: genetica quantitativa
POSSIBILI METODI DI STIMA DELL’IMPATTO DELLA GENETICA
metodo dei gemelli
MZ condividono 100% patrimonio genetico (r = 1.0) vs DZ condividono
parte del patrimonio genetico (50%)
se differenze fenotipiche sono unicamente attribuibili a G, allora la
correlazione attesa è r = 1.0 per MZ e r = 0.5 per DZ (es. peso e altezza)
ovvero la differenza nell’intensità della correlazione dovrebbe dipendere da
base genetica
MZ cresciuti assieme vs DZ cresciuti assieme (G + E condiv)
MZ cresciuti separatam vs DZ cresciuti separatam (G)
adozioni
fratelli naturali ma cresciuti separatamente (r attesa= 0.5 ) (G)
genitori naturali e figli dati in adozione (r attesa= 0.5) (G)
genitori/figli naturali e vissuti assieme vs genitori naturali e figli dati in
adozione (G)
Basi genetiche del comportamento: I risultati
Risultati
Legami di parentela
Estroversione
Nevroticismo
MZ cresciuti assieme
.51
.46
DZ cresciuti assieme
.18
.20
MZ cresciuti separat
.38
.38
DZ cresciuti separat
.05
.23
Genitori naturali e figli
.16
.13
Genitori adottivi e figli
.01
.05
Fratelli naturali cresciuti
assieme
.20
.09
Fratelli adottivi
-.07
.11
(Lohelin, 1992)
Impatto degli effetti di
contrasto e di assimilazione sui
dati MZ e DZ
19
3/6/2017
Basi genetiche del comportamento: I risultati
Basi genetiche del comportamento: genetica quantitativa
POSSIBILI METODI DI STIMA DELL’IMPATTO dell’AMBIENTE
CONDIVISO
Metodo dei gemelli
I risultati
gemelli identici cresciuti assieme (G + Acon) vs separatamente (G)
adozioni
fratelli adottivi (Acon)
genitori e figli adottivi (Acon)
POSSIBILI METODI DI STIMA DELL’IMPATTO dell’AMBIENTE
NON CONDIVISO
Metodo dei gemelli
gemelli identici cresciuti assieme (grado di dissimilitudine)
(Plomin & Caspi, 1999)
Genetica quantitativa: l’impatto dell’ambiente non condiviso
Non shared environment is generally the way environment works in behavioral sciences (Plomin)
Un esempio empirico: progetto NEAD (Nonshared Environment and Adolescent Development, Reiss et
al, 2000)
Basi genetiche del comportamento: l’indice di ereditarietà
Indice di ereditarietà (H) come proporzione della varianza fenotipica
attribuibile alle differenze genetiche tra gli individui
coinvolge 720 famiglie, con 2 figli
include dati osservativi e questionariali
risultati
dati
Report Figli
Report genitori
Dati osservativi
r
Parenting
.25
Relazione tra fratelli
.40
Parenting
.70
Relazione tra fratelli
.80
Figlio genitore
.20
Genitore figlio
.30
ci sono correlati comportamentali delle diverse percezioni dell’amb famigliare? SI,
negative parenting (punteggi residui da legame con fratello) si lega a comport antisociali e
depressione
Alcuni caveat fondamentali per interpretare l’indice di ereditarietà
(Plomin et al. 2008):
l’ereditarietà si stima in base a dati correlazionali: la significatività
statistica rivela se la genetica conta e la grandezza dell’effetto
stima quanto conta (logica di base: se un tratto fosse di origine del tutto
genetica, r tra fratelli cresciuti assieme sarebbe comunque non superiore a .50 e
pertanto il valore di r osservato viene raddoppiato ovvero la differenza nell’intensità
della correlazione tra MZ e DZ viene raddoppiata)
H stima differenze individuali WITHIN family, non BETWEEN
people differenze mediam osservate tra gruppi di individui appartenenti a popolazioni
diverse possono dipendere interamente da condizioni ambientali (es. QI)
20
3/6/2017
Basi genetiche del comportamento: l’indice di ereditarietà
Indice di ereditarietà (H) come proporzione della varianza fenotipica attribuibile alle differenze
genetiche tra gli individui
i dati riguardano la popolazione non il singolo individuo
Basi genetiche del comportamento: la genetica
agisce attraverso l’ambiente
La genetica può agire attraverso l’ambiente (non condiviso)
la PKU colpisce 1 su 10.000, perciò ha scarso impatto sulla variabilità abilità cognitive sulla
popolazione, mentre impatto fortissimo sul singolo
Genetica personalità ambiente
se H = .90 non significa che per il singolo il 90% della sua qualità fenotipica dipende da G e
il resto da A, ma che la variabilità tra le persone per quella caratteristica dipende
largamente dalla genetica
il 99.9% del DNA non varia da individuo a individuo: mutazioni anche minime avrebbero
un impatto dirompente
per il singolo contano sempre G + A
H si riferisce a quanto si osserva, non ad un potenziale che dipende da
G +A
e nemmeno a ciò che dovremmo osservare non implica
Esperienze correlate a profili genetici (the nature of nurture):
Le persone costruiscono il loro ambiente parzialmente in base a
propensioni genetiche
Esperienze e profili genetici interagiscono:
Alcune esperienze favoriscono alcune propensioni
determinismo, ma un fattore di rischio che da solo non determina
un comportamento manifesto
Teorie dei tratti: basi genetiche
Ancora sulla genetica quantitativa: Interazione tra genetica e ambiente
Genetica molecolare
Genetica molecolare
identificare specifici geni associati alle differenze comportamentali
relazioni dirette
relazioni dirette tra specifici polimorfismi genetici e comportamenti:
gene recettore D4 spiega parte della variabilità nelle differenze individuali
nel tratto Ricerca di Novità
gene trasportatore della serotonina 5-HTT spiega parte della variabilità nelle
differenze individuali nei livelli di Nevroticismo
la quota di varianza spiegata è sempre molto contenutta
interazioni tra specifici polimorfismi genetici e comportamenti,
interazioni tra specifici polimorfismi genetici e ambiente (cfr parte 2)
dove la caratteristicha genetica può fungere da
fattore protettivo rispetto all’impatto dell’ambiente sullo sviluppo di
caratteristiche di personalità non adattive
ovvero è l’ambiente a fungere da fattore protettivo rispetto allo
sviluppo di comportamenti disadattivi legati a specifici profili genetici
21
3/6/2017
Ancora sulla genetica quantitativa: Interazione tra genetica e ambiente
Ancora sulla genetica quantitativa: Interazione tra genetica e ambiente
Genetica molecolare
Genetica molecolare
ATTACCAMENTO
MATERNO
GENE: 5HTTLPR
ESPERIENZE
STRESSANTI
GENE:
GABRA6
DEPRESSIONE
Se omozigote per l’allele L vs. omozigote per l’allele S o eterozigote S/L,
allora maggior efficienza nella regolazione della serotonina e funge da fattore
protettivo rispetto allo sviluppo della depressione
REATTIVITA’
FISIOLOGICA AD
EVENTI STERSSANTI
Se l’attaccamento materno è di tipo insicuro vs. sicuro, allora chi si caratterizza
per un profilo con gabra6 omozigote per l’allele S mostra maggiore
reattività fisiologica ad eventi stressanti,
in altre parole, attaccamento sicuro può fungere da fattore protettivo rispetto
ad elevati livelli di reattività in condizioni ambientali stressanti
22