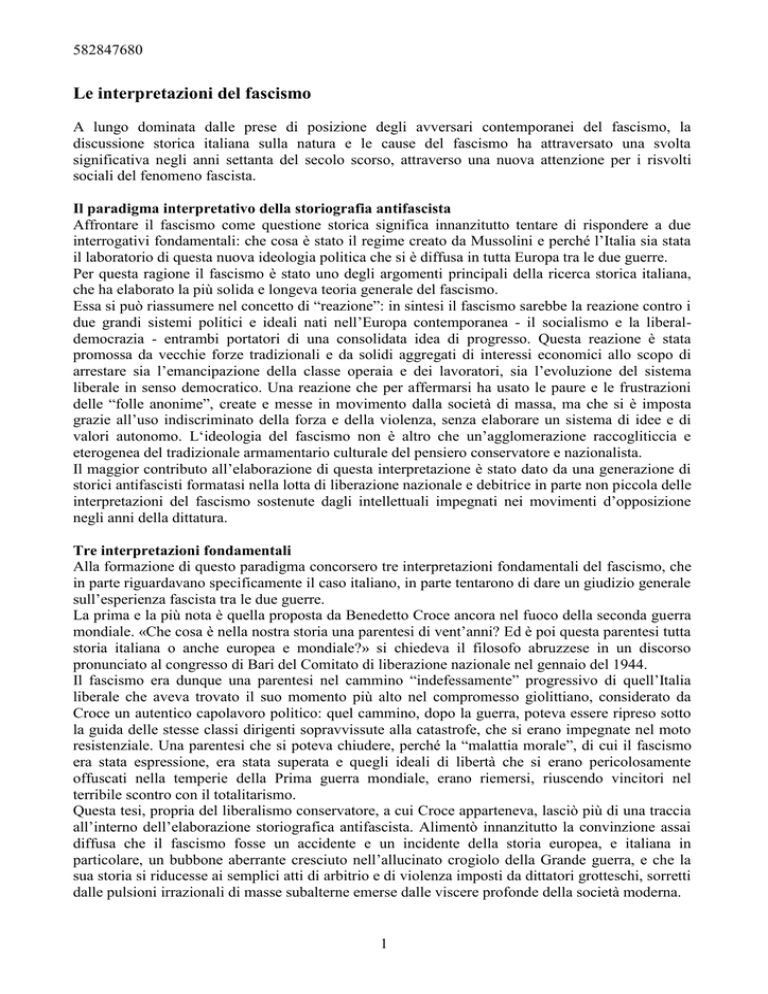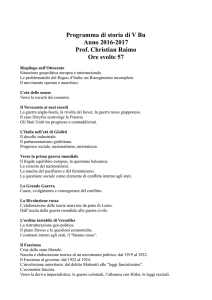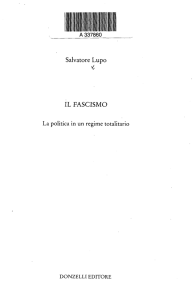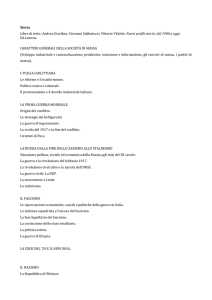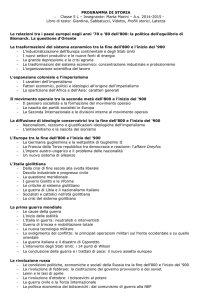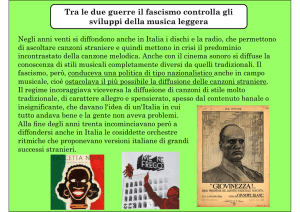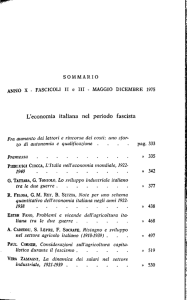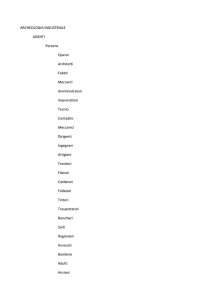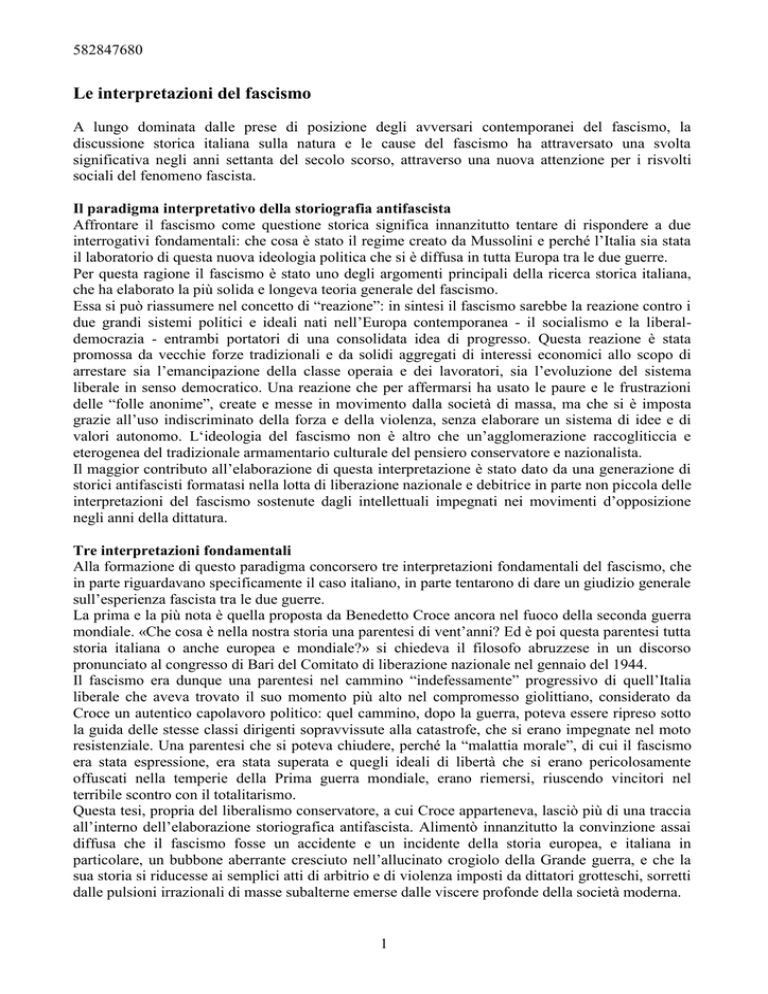
582847680
Le interpretazioni del fascismo
A lungo dominata dalle prese di posizione degli avversari contemporanei del fascismo, la
discussione storica italiana sulla natura e le cause del fascismo ha attraversato una svolta
significativa negli anni settanta del secolo scorso, attraverso una nuova attenzione per i risvolti
sociali del fenomeno fascista.
Il paradigma interpretativo della storiografia antifascista
Affrontare il fascismo come questione storica significa innanzitutto tentare di rispondere a due
interrogativi fondamentali: che cosa è stato il regime creato da Mussolini e perché l’Italia sia stata
il laboratorio di questa nuova ideologia politica che si è diffusa in tutta Europa tra le due guerre.
Per questa ragione il fascismo è stato uno degli argomenti principali della ricerca storica italiana,
che ha elaborato la più solida e longeva teoria generale del fascismo.
Essa si può riassumere nel concetto di “reazione”: in sintesi il fascismo sarebbe la reazione contro i
due grandi sistemi politici e ideali nati nell’Europa contemporanea - il socialismo e la liberaldemocrazia - entrambi portatori di una consolidata idea di progresso. Questa reazione è stata
promossa da vecchie forze tradizionali e da solidi aggregati di interessi economici allo scopo di
arrestare sia l’emancipazione della classe operaia e dei lavoratori, sia l’evoluzione del sistema
liberale in senso democratico. Una reazione che per affermarsi ha usato le paure e le frustrazioni
delle “folle anonime”, create e messe in movimento dalla società di massa, ma che si è imposta
grazie all’uso indiscriminato della forza e della violenza, senza elaborare un sistema di idee e di
valori autonomo. L‘ideologia del fascismo non è altro che un’agglomerazione raccogliticcia e
eterogenea del tradizionale armamentario culturale del pensiero conservatore e nazionalista.
Il maggior contributo all’elaborazione di questa interpretazione è stato dato da una generazione di
storici antifascisti formatasi nella lotta di liberazione nazionale e debitrice in parte non piccola delle
interpretazioni del fascismo sostenute dagli intellettuali impegnati nei movimenti d’opposizione
negli anni della dittatura.
Tre interpretazioni fondamentali
Alla formazione di questo paradigma concorsero tre interpretazioni fondamentali del fascismo, che
in parte riguardavano specificamente il caso italiano, in parte tentarono di dare un giudizio generale
sull’esperienza fascista tra le due guerre.
La prima e la più nota è quella proposta da Benedetto Croce ancora nel fuoco della seconda guerra
mondiale. «Che cosa è nella nostra storia una parentesi di vent’anni? Ed è poi questa parentesi tutta
storia italiana o anche europea e mondiale?» si chiedeva il filosofo abruzzese in un discorso
pronunciato al congresso di Bari del Comitato di liberazione nazionale nel gennaio del 1944.
Il fascismo era dunque una parentesi nel cammino “indefessamente” progressivo di quell’Italia
liberale che aveva trovato il suo momento più alto nel compromesso giolittiano, considerato da
Croce un autentico capolavoro politico: quel cammino, dopo la guerra, poteva essere ripreso sotto
la guida delle stesse classi dirigenti sopravvissute alla catastrofe, che si erano impegnate nel moto
resistenziale. Una parentesi che si poteva chiudere, perché la “malattia morale”, di cui il fascismo
era stata espressione, era stata superata e quegli ideali di libertà che si erano pericolosamente
offuscati nella temperie della Prima guerra mondiale, erano riemersi, riuscendo vincitori nel
terribile scontro con il totalitarismo.
Questa tesi, propria del liberalismo conservatore, a cui Croce apparteneva, lasciò più di una traccia
all’interno dell’elaborazione storiografica antifascista. Alimentò innanzitutto la convinzione assai
diffusa che il fascismo fosse un accidente e un incidente della storia europea, e italiana in
particolare, un bubbone aberrante cresciuto nell’allucinato crogiolo della Grande guerra, e che la
sua storia si riducesse ai semplici atti di arbitrio e di violenza imposti da dittatori grotteschi, sorretti
dalle pulsioni irrazionali di masse subalterne emerse dalle viscere profonde della società moderna.
1
582847680
In questa chiave il fascismo era, appunto, una semplice “reazione” al liberalismo e al socialismo,
priva di qualunque dimensione teorica e culturale. Il filosofo Norberto Bobbio, che più di ogni altro
rappresenta la tradizione dell’antifascismo laico e democratico, nel suo ormai classico Profilo
ideologico del Novecento negò l’esistenza di una cultura fascista, cioè un corpus dottrinario dotato
di una sua intima coerenza e di una sua originalità, in grado di collocare il fascismo tra i sistemi del
pensiero politico novecentesco.
All’interpretazione liberal-conservatrice si è contrapposta quella liberal-radicale, che può essere
sintetizzata nella famosa formula elaborata dall’intellettuale torinese Piero Gobetti, nell’immediato
dopoguerra del “fascismo come autobiografia della nazione”. Questa tesi elaborata dal giovane
direttore della rivista “Rivoluzione liberale”, metteva l’accento sulla continuità tra Italia fascista e
Italia liberale e manifestava un rifiuto, per così dire preventivo, nei confronti della concezione
crociana del fascismo come “parentesi”.
In quest’ottica, la dittatura di Mussolini era l’esito di una rivoluzione liberale mancata ed
espressione di un paese arretrato e incolto, che non ha mai conosciuto istituzioni politiche
effettivamente democratiche, ma ha subito un sistema di governo nel quale si sono combinati
paternalismo, clientelismo, trasformismo e autoritarismo.
Il fascismo si configurava dunque come un “disvelamento” delle contraddizioni e delle aporie della
storia nazionale, che doveva essere collocato lungo una linea di continuità soprattutto con
quell’Italia liberale che non aveva saputo opporsi alla dittatura e che ne era stata poi travolta.
Anche in questo caso il fascismo è però una “reazione”: la reazione della “vecchia Italia”, che non
ha esitato a scegliere la tirannide, facendo leva su quel “vizio storico” del paese, pur di impedire
l’affermazione delle aspirazioni e dei valori dell’“altra Italia”, quella democratica e
modernizzatrice.
Da queste considerazioni ha preso corpo soprattutto tra gli intellettuali antifascisti aderenti negli
anni trenta al movimento Giustizia e libertà – dallo storico Gaetano Salvemini, ai fratelli Carlo e
Nello Rosselli, fondatori del movimento, a Silvio Trentin – una interpretazione del fascismo nella
quale l’accento principale è stato posto sul ruolo fondamentale svolto dalle tradizionali burocrazie
pubbliche nel favorire prima l’affermazione e successivamente la stabilizzazione del regime. Il
fascismo è espressione di una inedita alleanza tra ceti proprietari e grandi apparati burocratici, le
cui élite formavano l’oligarchia nelle cui mani era racchiuso il potere reale. Il fascismo poggiava
dunque su apparati di potere ereditati dalla vecchia Italia liberale che si riconobbero e sostennero il
progetto reazionario di cui era portatore, perché animati da una cultura reazionaria e da spinte
autoritarie: un elemento di continuità tra l’Italia pre-fascista e quella della dittatura, che sarebbe
proseguito anche in quella post-fascista.
La terza interpretazione è quella elaborata dalla tradizione marxista che ha letto il fascismo come
reazione di classe. Questa tesi trovò la sua sintesi più nota nella ormai classica definizione del
fascismo elaborata da Georgi Dimitrov, segretario del Comitato esecutivo della Terza
internazionale, secondo la quale i regimi creati da Mussolini e da Hitler rappresentavano la
«dittatura terroristica aperta degli elementi più reazionari, più sciovinisti, e più imperialisti del
capitale finanziario».
Anche lo studio più attento e articolato sul fascismo elaborato dalla cultura politica comunista negli
anni trenta - il famoso Corso sugli avversari scritto da Palmiro Togliatti nel suo esilio sovietico e
pubblicato solo nel 1970 con il titolo di Lezioni sul fascismo, nel quale il segretario del Pcd’I
elaborò la famosa definizione del fascismo come “regime reazionario di massa “ - restava
intimamente convinto che il fascismo fosse il volto del capitalismo nell’epoca dell’imperialismo.
Questa interpretazione fu sostenuta da una nuova generazione di storici marxisti i cui lavori
scientifici uscirono tra gli anni cinquanta e settanta del secolo scorso. Come scrisse lo storico
tedesco Reinhard Kuhln nel 1973 «I movimenti fascisti rappresentano, dal punto di vista della loro
funzione oggettiva, la forma moderna camuffata di vesti popolari, della controrivoluzione
borghese-capitalistica, e cioè quella forza politica che era in grado di fornire al capitalismo, nelle
nuove condizioni dell’epoca, una nuova base di massa per il caso di una crisi grave».
2
582847680
Il fascismo come rivoluzione
Proprio alla metà degli anni settanta le ricerche di Renzo De Felice e di Emilio Gentile su
Mussolini e l’ideologia del fascismo, da un lato, e, dall’altro, la diffusione dei saggi su temi
analoghi dello storico americano George Mosse e del francese Zeev Sternell, usciti quasi
simultaneamente alla pubblicazione delle ricerche di un sociologo italiano, Gino Germani, sui
rapporti tra autoritarismo e modernizzazione in Europa e in America latina, contribuirono a mettere
in discussione i fondamenti stessi del “paradigma antifascista”, avviando una nuova stagione di
ricerche e riaprendo il dibattito storiografico sul fascismo.
Nella sua Intervista sul fascismo del 1974 De Felice, proprio sulla scorta di una attenta lettura degli
studi di Mosse sulla “nazionalizzazione delle masse” nella Germania hitleriana esplicitava una
nuova proposta interpretativa imperniata su due cardini concettuali fondamentali.
Il primo consisteva nel rivendicare una forte distinzione tra fascismo-movimento e fascismoregime. Al primo venivano attribuiti i caratteri di un fenomeno rivoluzionario promosso dalla
piccola borghesia. Il fascismo era dunque una sorta di “rivoluzione dei ceti medi”, forte di una sua
autonomia ideale e politica, rispetto alla borghesia industriale e proprietaria, con cui quei gruppi
sociali hanno tentato di marcare una distanza e di aprire un vero e proprio conflitto per la direzione
politica del paese. Il fascismo non era stato soltanto una movimento di reazione al servizio di
consolidati interessi di classe, o una semplice superfetazione delle debolezze dell’identità italiana,
ma un fenomeno nuovo di mobilitazione delle “classi medie”, percorse da accentuati fenomeni di
massificazione e attraversare non solo da processi di proletarizzazione, ma anche di ascesa sociale.
A differenza della borghesia e del proletariato, queste ultime stavano progressivamente smarrendo
quelle già scarse connotazioni di classe ereditate dall’Ottocento, ed erano sospinte da processi
strutturali verso una collocazione sociale ambivalente nella quale il raggiungimento di forme di
status più elevate si combinava alla progressiva trasformazione in un coacervo indifferenziato di
“folle anonime”, che stava emergendo come una componente fondamentale della moderna società
industriale.
Le masse appaiono come un magma amorfo di “uomini senza qualità”, oscillante in permanenza tra
l’integrazione passiva e una mobilitazione che non riusciva ad essere intercettata dai partiti politici
formatisi nell’Ottocento attorno al grande scontro tra borghesia e proletariato.
Alla fine degli anni quaranta la filosofa tedesca Hanna Arendt colse con grande chiarezza il nesso
profondo che si era istiituto tra il processo di politicizzazione di questi strati sociali intermedi
massificati e l’affermazione del fascismo su scala europea.
I movimenti totalitari - scrisse - mira[rono] a organizzare le masse, non le classi, come i vecchi
partiti d’interessi degli stati nazionali del continente, e neppure i cittadini con opinioni e interessi
nei riguardi del disbrigo degli affari pubblici, come i partiti dei paesi anglosassoni. [...] Essi
reclutarono i loro membri da questa massa di gente manifestamente indifferente [...] ma che per
una ragione o per l’altra si sen[tivano] spinte all’organizzazione politica, pur non essendo tenute
insieme da un interesse comune e mancando di una specifica coscienza classista. [...] Il risultato fu
che in maggioranza [i movimenti totalitari] furono composti da persone che non erano mai
apparse prima sulla scena politica.
Il contributo della sociologia
Ma il contributo per molti aspetti più originale alla riflessione sul rapporto tra fascismo e ceti medi
per l’approccio metodologico e l’impianto teoriche lo sorregge, è stato offerto da Gino Germani, un
sociologo antifascista espatriato nel 1934 e ritornato in Italia nel secondo dopoguerra. In una serie
di studi di grande rilievo sul mutamento sociale e i processi di modernizzazione, pubblicati alla
metà degli anni settanta, inseriva la definizione dei quel rapporto all’interno di un modello di
spiegazione basato sul concetto di mobilitazione sociale.
3
582847680
La mobilitazione si verifica quando si rompono le forme consolidate di integrazione delle diverse
classi garantite dalla struttura sociale perchè nuovi gruppi sociali rivendicano una integrazione in
precedenza negata o aspirano a una nuova collocazione più funzionale ai loro interessi e alle loro
aspettative. Questo processo, nelle società industrializzate ad alto tasso di partecipazione politica, si
è tradotto storicamente in una dilatazione della conflittualità e in un accelerazione della mobilità
che hanno alterato l’intelaiatura normativa tradizionale e che ha implicato «una presa di possesso di
ruoli che precedentemente erano riservati ad altri settori» da parte dei nuovi gruppi sociali
emergenti e una dislocazione diversa per tutti gli altri gruppi sociali.
Questo fenomeno è appunto quello che Germani chiama “mobilitazione”: lo spostamento repentino
e traumatico di interi gruppi sociali rispetto alla loro tradizionale collocazione sociale che entrano
in movimento alla ricerca di un “nuovo ordine” in grado di garantire una nuova reintegrazione
soddisfacente.
Il fascismo, dunque è per Germani la forma politica della mobilitazione dei ceti medi che
inizialmente coesiste e confligge con movimenti e ideologie politiche che esprimono altri paralleli
processi di mobilitazione, primo fra tutti quello del proletariato industriale: la mobilitazione delle
classi medie innescata negli anni venti dal rifiuto della nuova dislocazione sociale entrava in
conflitto con quella della classe operaia e puntava decisamente a “smobilitarla” per ristabilire
quella gerarchia degli status sociali che era minacciata dalla ascesa delle “classi inferiori”.
Lungo questo crinale interpretativo, “reazione” e “rivoluzione” si sono dunque miscelate nella
concreta esperienza storica dei fascismi europei tra le due guerre, contribuendo però a generare
regimi che hanno assunto i connotati di una delle risposte possibili alle contraddizioni della società
moderna.
Germani dunque colloca il fascismo nella modernità, definendolo come una forma specifica
dell’autoritarismo moderno che ha attraversato tutto il XX secolo, muovendosi in una direzione
parallela a quella seguita da De Felice.
Il secondo cardine della proposta interpretativa defeliciana riguardava infatti la ridefinizione dei
rapporti tra fascismo e modernità, anch’esso strettamente connesso a una delle più feconde
intuizioni emerse dalla ricerca sociologica sul totalitarismo, cui appunto Germani aveva dato uno
dei contributi più significativi.
Secondo De Felice, il fascismo con i suoi nuovi miti politici intessuti di attivismo, di spiritualismo
antimaterialista, di fanatismo nazionalista e di esaltazione della forza, non rappresentava un ritorno
al passato, quanto piuttosto un’altra modalità di declinazione della modernità, del tutto imprevista,
fino alla fine del XIX secolo.
In questa chiave l’ideologia del fascismo non si configurava come inutile orpello posticcio e
strumentale di un movimento e di un regime asservito al grande capitale, ma rappresenta
l’orizzonte ideale all’interno del quale il nuovo soggetto sociale costituito dalle classi medie
definiva se stesso in alternativa alle altre classi e modellava la sua autorappresentazione.
Socialismo e liberalismo erano insieme respinti perchè espressione di una concezione materialistica
e conflittuale della storia e del mondo, a cui la piccola borghesia contrapponeva il mito della
nazione “astratta e trascendente”.
La nazione assumeva i caratteri di un luogo simbolico nel quale si sintetizzava la costituzione di
una società organica, nel quale la forza dello stato era in grado di superare, annullandoli, i due
elementi disgregatori prodotti dal capitalismo moderno e dal socialismo: la concorrenza e la lotta di
classe. Statalismo autarchico e corporativismo costituivano le coordinate attraverso le quali veniva
creata una società non conflittuale, pacificata, nella quale l’autonomia dei soggetti sociali era
trasfigurata nella rappresentanza istituzionalizzata degli interessi, sotto l’egida di uno stato “etico”,
depositario e promotore dei “fini superiori” della nazione: una nazione in armi, protesa ad
affermarsi come potenza nella lotta incessante tra i popoli e gli stati, che aveva avuto il suo atto di
nascita dell’esperienza della Grande guerra.
Questo “nuovo ordine” non aveva nulla a che vedere con la società tradizionale premoderna,
perchè assumeva come irreversibile la massificazione della società e si proponeva, attraverso una
4
582847680
sorta di nazionalizzazione autoritaria, di fornire una risposta originale a quella domanda di
integrazione sociale dei nuovi ceti sociali prodotti dall’industrializzazione e dalla modernizzazione,
che costituiva il problema cruciale del mondo contemporaneo e di cui pluralismo democratico e
modello sovietico costituivano le alternative.
In questo senso, tornando a Germani, il fascismo ha rappresentato una risposta alle sfide della
modernità: e negli anni trenta questa risposta, di fronte al collasso dell’economia capitalista nel
1929, e, prima, al fallimento della “rivoluzione europea” tentata dal comunismo bolscevico nel
dopoguerra, sembrò destinata al successo.
5