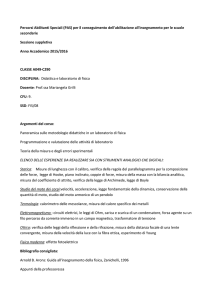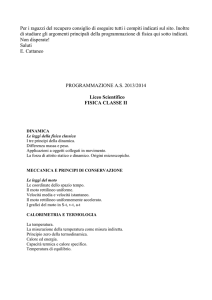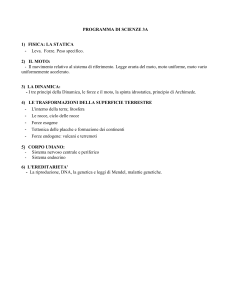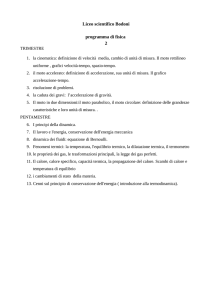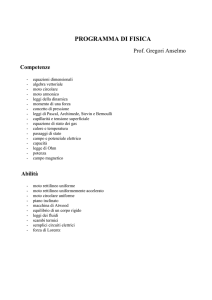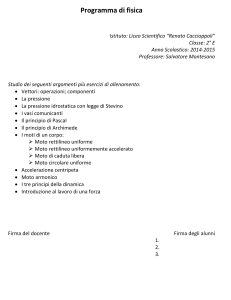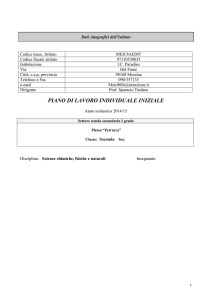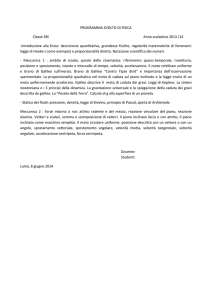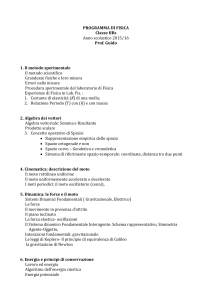Michele Camerota
LEZIONI DI STORIA DEL
PENSIERO SCIENTIFICO
6.
LA MECANICA TRA
CINQUECENTO E SEICENTO
LA SCIENZA DELLE MACCHINE
«Chiamo scienza meccanica quella disciplina da cui si possono ricavare le
cause e i principi di molte arti manuali. Queste arti sono comunemente, in
modo improprio, denominate anch’esse ‘meccaniche’, mentre dovrebbero
piuttosto dirsi arti basse, sellularie o banausiche. [...] E invero, pur
trattando di cose attinenti alla materia e al movimento – come i corpi
pesanti e leggeri in relazione alla velocità e alla tardità – la scienza
meccanica deve essere inclusa nel novero delle discipline matematiche,
poiché considera quegli oggetti secondo modalità matematiche. Per
quanto, infatti, gli strumenti meccanici e le stesse macchine vengano
concepiti in funzione di una qualche operazione pratica, tuttavia lo
studioso di meccanica, esaminandone esclusivamente le cause e i principi,
si sofferma e si concentra sulla sola contemplazione».
A. Piccolomini, In Mechanicas Quaestiones Aristotelis paraphrasis,
Roma, 1547, f. IIIr-v.
MATEMATICA E MECCANICA
Ben lungi dall’identificarsi con il patrimonio di cognizioni praticooperative degli artigiani e dei costruttori, la meccanica ha, per
Piccolomini, una dimensione genuinamente speculativa che la colloca a
buon diritto nell’ambito delle vere e proprie scientiae. In particolare, la
natura ‘scientifica’ (dimostrativa) è garantita dall’approccio matematico.
Al pari dell’ottica, dell’astronomia, della musica, la meccanica rientra,
infatti, nel genere delle scientiae mediae, ovvero di quelle branche
dottrinali che applicano dimostrazioni matematiche a soggetti di carattere
naturale. Come spiega lo stesso Piccolomini, «seppure tali discipline,
concernendo la materia, non possano essere qualificate come puramente
matematiche, tuttavia si debbono definire più convenientemente
matematiche che naturali» (ibid., f. IIv).
LE QUAESTIONES MECHANICAE
Attribuite ad Aristotele (ma più verosimilmente ascrivibili alla sua
scuola), le Quaestiones mechanicae vennero incluse nel secondo dei
cinque volumi del corpus aristotelico greco stampato da Aldo Manuzio tra
il 1495 e il 1498. Presto tradotte in latino, il loro esame si caratterizzò
come un momento centrale della riflessione scientifica del ’500 e del
primo ’600. Non a caso, allo scritto veniva riconosciuto il merito di aver
ricercato «in modo acuto e sintetico, le vere cause non solo di quasi tutte
le meravigliose macchine inventate finora, ma anche di quelle che lo
saranno in futuro» (A. Piccolomini, In Mechanicas Quaestiones
Aristotelis paraphrasis, f. Ivr;).
Le Quaestiones mechanicae sostengono con forza il carattere di scientia
media della meccanica. Secondo il trattato, i casi in cui – per citare la
traduzione italiana di Antonio Guarino – «le cose minori vincono le
maggiori, et quelle che havendo poco et moto et tempo muovono pesi
grandi», presentano aspetti «communi alle speculationi mathematiche et
alle naturali». L’occorrenza più emblematica in tal senso è quella della
leva, che con una «picciola forza» solleva «uno gran peso»
LE QUAESTIONES MECHANICAE:
LA SPIEGAZIONE DELLA BILANCIA
Secondo l’autore delle Quaestiones mechanicae, tutti i fenomeni
meccanici vanno riportati alla leva. Questa, a sua volta, è assimilata ad
una bilancia, i cui bracci, vincolati nel fulcro, si muovono descrivendo
archi di cerchio in direzioni contrarie. Assumendo che in tale bilancia i
bracci siano diseguali, avremo che l’estremità del segmento (braccio) più
corto, in quanto più vicino al centro, risulta più fortemente attratto da esso,
e, a causa di quel freno, si muove meno speditamente (cfr. Mech., 849a 619). All’opposto, l’estremità del più lungo si muoverà più velocemente
(sarà cioè in grado di tracciare un arco di cerchio più ampio in un tempo
dato). Ne consegue che «il punto più distante dal centro si muove più
velocemente, pur messo in movimento dalla stessa forza». (Mech., 849b
21-22). L’efficacia di un peso sulla bilancia (o il rendimento di una leva) è
allora tanto maggiore quanto più il punto di applicazione si allontana dal
fulcro.
QUAESTIONES MECHANICAE:
LA SPIEGAZIONE DELLA BILANCIA
Ecco come il principio fondamentale della meccanica aristotelica viene
illustrato da Alessandro Piccolomini in relazione al caso della leva:
«Poiché [...] quanto più una linea dista dal centro, tanto più velocemente e
facilmente si muove (descrivendo un cerchio più grande), risulta allora
necessario che, comunque esigua sia la forza (o il peso) applicata,
nondimeno, in virtù dell’aiuto della distanza, tale forza riesca a muovere
un peso più grande di lei. Il peso mosso si relaziona, infatti, a ciò che lo
muove nella misura inversa al rapporto tra le distanze; nella stessa misura,
cioè, con cui il movente supera il mosso, così la distanza dal centro di
quest’ultimo viene superata da quella del primo. In effetti, il peso mosso,
assunto come maggiore, per sua natura dovrebbe muovere di più che non
la piccola forza movente. Ma poiché questa forza si esercita lungo una
linea che dista maggiormente dal centro – e tale distanza non solo
compensa la sua debolezza, ma la aiuta a prevalere – non ci si deve
meravigliare se il peso maggiore mostrerà una minor efficacia. Pertanto,
tra due forze eguali, tanto più sarà efficace quella che si troverà ad essere
applicata ad una maggiore distanza dal fulcro, cioè dal centro». (In
Mechanicas Quaestiones Aristotelis paraphrasis, ff. XXIIIv – XXIVr).
QUAESTIONES MECHANICAE:
IL CONCETTO DI VELOCITA’
L’approccio proprio della trattazione sviluppata nelle Quaestiones
mechanicae ha una decisa valenza dinamica. L’equilibrio statico è, infatti,
il risultato di una condizione in cui i pesi liberi sono inversamente
proporzionali alle “velocità” (ossia agli archi di cerchio descritti dagli
estremi dei bracci cui sono fissati detti pesi).
L’analogia con il cerchio e la tesi della diversa velocità caratteristica dei
vari punti dei suoi raggi (bracci di un’ideale bilancia) serve, insieme ad
altre considerazioni anch’esse attinenti alle proprietà della figura circolare,
all’esame di 35 diverse questioni. Si va dall’analisi di alcune macchine
semplici (leva, bilancia, argano, puleggia, cuneo), a problemi legati alla
marineria (remo, timone, navigazione con venti non favorevoli), fino alla
resistenza dei materiali, al lancio con la fionda, e alla durata e cessazione
del moto. A queste si aggiungono delle quaestiones dedicate a temi più
teorici, di tipo geometrico, come il moto di cerchi concentrici e il rombo.
LA TRADIZIONE ARCHIMEDEA - 1
A differenza dell’approccio “dinamico”, di stampo aristotelico, le opere di
Archimede privilegiavano l’analisi delle determinazioni statiche. Ciò vuol
dire che, nella spiegazione del funzionamento della leva e della bilancia
(cui si riducevano tutte le altre macchine semplici), le condizioni di
equilibrio venivano sostanzialmente attribuite all’effetto combinato del
peso e della distanza dal fulcro del sistema meccanico.
Era questo il criterio utilizzato dallo stesso Archimede per formulare il
fondamentale teorema dell’equilibrio di una leva: «Le grandezze
commensurabili sono in equilibrio se sospese a distanze inversamente
proporzionali ai loro pesi» (Equilibrio dei piani, proposizione 6). Da tale
inversa proporzionalità tra pesi e distanze si desume immediatamente
l’eguaglianza dei prodotti dei pesi per le distanze, vale a dire
l’eguaglianza dei momenti statici.
LA TRADIZIONE ARCHIMEDEA - 2
A coloro che si ponevano sulla scia del matematico di Siracusa non
sfuggiva il vantaggio di sostituire la disorganica esposizione fornita dalle
Quaestiones mechanicae con il rigore proprio del modello archimedeo,
basato su un esatto apparato di assiomi, postulati e dimostrazioni.
Nondimeno, l’orientamento “dinamico” (pseudo)-aristotelico continuò a
godere di ampio credito nella seconda metà del Cinquecento e nei primi
decenni del Seicento.
NICCOLO’ TARTAGLIA
La Nova scientia di Tartaglia risponde alla domanda concernente il «modo
de mettere a segno un pezzo de artigliaria al più che può tirar» (cioè l’alzo
ideale di un obice per conseguire la massima gittata). Tartaglia stabilisce
che l’inclinazione ottimale di un cannone è di 45 gradi.
L’importanza dello scritto non sta tuttavia tanto e solo in questa
conclusione, quanto nell’originalità con cui approccia il tema del
movimento. Benché ispirata da problemi pratici, la Nova scientia mirava,
infatti, al rigore matematico, sia nella veste espositiva che negli esiti
concettuali e teorici. In tal senso, essa segna un distacco dalla tradizionale
considerazione “metafisica” delle quaestiones de motu, e concentra invece
l’attenzione sulle determinazioni geometriche dell’argomento.
NICCOLO’ TARTAGLIA:
IL MOTO DEI PROIETTILI
Tartaglia affronta l’esame della traiettoria dei proiettili, sostenendo che
essa risulta divisa in tre parti: una prima ascensionale rettilinea; una
seconda, intermedia, curva; e una finale di caduta verticale:«Ogni transito,
– recita il testo – over moto violente de’ corpi egualmente gravi, che sia
fuora della perpendicolar de l’orizonte, sempre sarà in parte retto e in
parte curvo, et la parte curva sarà parte d’una circonferentia di cerchio».
(Scientia nova, (1537), ed. Venezia 1550, f. 10v).
L’assunto sarebbe pienamente valido in sede teorica, ma in pratica, come
si avverte subito, nessun moto violento può incorporare tratti
perfettamente rettilinei a causa della «gravità», che continuamente «va
stimulando e tirando» il mobile verso il centro del mondo. La deviazione
indotta dal peso risulta, tuttavia, a giudizio di Tartaglia, assolutamente
trascurabile.
NICCOLO’ TARTAGLIA:
IL MOTO DEI PROIETTILI
A distanza di qualche anno, Niccolò Tartaglia rivide le proprie
convinzioni, e, forse, si convinse dell’errore fatto nella Nova scientia,
quando aveva stabilito che il moto naturale e quello violento non potevano
in alcun modo comporsi («Niun corpo egualmente grave può andare per
alcun spacio di tempo, over di luoco, di moto naturale et violente insieme
misto». Ibid., f. 7r). Nei Quesiti et inventioni diverse, sostenne infatti
l’idea di una traiettoria curva in tutti i punti. Richiamando quanto già
affermato nell’opera del 1537, egli specificava di aver fatto riferimento
alla tesi del carattere rettilineo di una parte della traiettoria al solo scopo di
«essere inteso dal volgo».
GIOVAN BATTISTA BENEDETTI
«Contro Aristotele e i filosofi tutti» si proclamava, fin dal titolo di una sua
opera (Demonstratio proportionum motuum localium contra Aristoteles et
omnes philosophos, Venezia, 1554), il veneziano Giovanni Battista
Benedetti: «Aristotele – scriveva – fu certamente uno straordinario
indagatore della natura. Tuttavia, non voglio asserire, come fanno alcuni
(che non hanno letto le sue opere o, se le hanno lette, non le hanno
comprese), che ogni parola di Aristotele ha il valore di una sentenza, e che
egli fu un dio della filosofia e non ha mai sbagliato in nulla. Se i poveracci
che lo hanno divinizzato conoscessero la differenza tra l’argomentazione
dimostrativa e il discorso basato sull’esperienza sensibile, non avrebbero
mai fatto quelle affermazioni». (Ibid., p. [20]).
La presa di distanza dalla fisica peripatetica è operata da Benedetti in
forza di un’esigenza di rigore dimostrativo di stampo matematico, che si
richiama direttamente all’esempio di Archimede. Così, tutta la sua
dinamica è costruita a partire dal modello dell’idrostatica archimedea.
BENEDETTI: IL MOTO DI CADUTA
In contrasto con la teoria aristotelica che considerava la velocità dei moti
naturali come proporzionale al peso assoluto dei corpi, Benedetti afferma
che essa è invece determinata dalla sperequazione tra il peso specifico del
mobile e quello del mezzo. Ciò implica che corpi della stessa materia,
anche se di differenti dimensioni, si muovono nello stesso mezzo (o nel
vuoto) con eguale velocità. Se, infatti, due corpi sono omogenei (della
stessa materia), essi hanno un identico peso specifico; e poiché nella
determinazione della velocità del moto ciò che conta è il confronto tra i
pesi di eguali volumi del mobile e del mezzo (cioè la comparazione tra
pesi specifici), ne consegue che mobili della stessa materia si muoveranno
appunto con eguale velocità perché identica sarà la differenza tra il loro
peso specifico e quello del mezzo.
È opportuno precisare che, nella dinamica di Benedetti, la velocità del
movimento è data dalla differenze tra i pesi specifici del mobile e del
mezzo e non – come voleva Aristotele – dal rapporto tra il peso assoluto
del corpo e la densità (resistenza) del mezzo.
BENEDETTI: L’IMPETUS
Opponendosi poi alla spiegazione aristotelica del moto violento, Benedetti
ricorre alla concezione (medievale) dell’impetus, che estende anche ai
corpi in moto di moto naturale per giustificarne il carattere accelerato:
«Ogni corpo grave, che si muova naturalmente o con violenza, riceve in sé
un’impressione (impressio) e un impeto (impetus) di moto, così che, pur
separato dalla forza motrice, continua a muoversi per un certo lasso di
tempo. Pertanto, se un corpo si muove di moto naturale aumenterà sempre
la sua velocità, poiché in esso l’impressio e l’impetus crescono di
continuo, dal momento che il corpo risulta costantemente a contatto con la
sua forza motrice [cioè con la gravità]». (Ibid., pp. 286-87).
La fisica di Benedetti, modellata sull’idrostatica di Archimede,
rappresentava, dunque, un notevole tentativo di fuoriuscita dal paradigma
aristotelico allora dominante. Di fatto, essa segnò la via su cui si sarebbe
posto il più coerentemente innovativo tra i philosophi naturales
dell’epoca: Galileo Galilei.
GALILEO: GLI SCRITTI DE MOTU
Una concezione assai simile a quella sostenuta da Benedetti si trova
esposta in alcuni lavori giovanili di Galileo noti come scritti De motu. Se e
come egli venne a contatto con l’opera di Benedetti è ancora un problema
aperto, per quanto, allo stato attuale, si tenda ad escludere la possibilità di
una influenza diretta.
In ogni caso, le tesi dei De motu galileiani prospettano anch’esse una
spiegazione del moto di stampo archimedeo, basata sul confronto tra il
peso specifico del mobile e quello del mezzo. Ciò conduce Galileo – come
già Benedetti – ad affermare che mobili della stessa materia, in un
medesimo mezzo, si muovono con eguale velocità, qualunque sia la loro
mole.
GALILEO: L’ESPERIMENTO DELLA TORRE
PENDENTE
È probabile che proprio per provare tale conclusione Galileo abbia
compiuto il semileggendario esperimento di lasciar cadere corpi dalla
sommità della Torre di Pisa. Secondo Vincenzo Viviani (1622-1703),
discepolo e primo biografo galileiano, la prova mirava, infatti, ad
accertare che «le velocità de’ mobili dell’istessa materia, disegualmente
gravi [cioè di differente peso assoluto], movendosi per un istesso mezzo,
non conservano altrimenti la proporzione delle gravità loro, assegnatagli
da Aristotele, anzi che si muovon tutti con pari velocità» (OG, XIX, p.
606).
I problemi veri per la concezione delineata nei De motu si presentano
tuttavia con la spiegazione del carattere accelerato del moto di caduta.
Poiché gli elementi determinanti (i pesi specifici del mobile e del mezzo)
non subiscono alcun mutamento durante il moto, risulta infatti impossibile
imputare loro la causa dell’accelerazione.
GALILEO: IL PROBLEMA DELL’ACCELERAZIONE
Allo scopo di risolvere tale difficoltà, Galileo postulò una causa
estrinseca, rappresentata da una forza, la virtus impressa, “preternaturale”
e “accidentale”, che agisce sui mobili contribuendo ad aumentarne la
velocità. La virtus impressa opera come un fattore perturbatore della
naturale tendenza dinamica del corpo:
«Diciamo che la forza impressa è un venir meno del peso (privationem
gravitatis) quando il mobile si muove verso l’alto; mentre nel caso di un
moto verso il basso è un venir meno della leggerezza (privationem
levitatis)». (OG, I, pp. 309-10).
Ora, nelle prime fasi della caduta, il corpo non viene mosso verso il basso
dall’intero suo peso, ma solo dalla parte eccedente la leggerezza indotta
(cioè la virtus impressa). E poiché tale eccedenza cresce in concomitanza
con l’indebolirsi della residua forza impressa, il corpo cade sempre più
veloce.
GALILEO: LA LEGGE DI CADUTA DEI GRAVI
Negli anni successivi al suo trasferimento a Padova (avvenuto nel 1592), Galileo
continuò a lavorare sul tema, cambiando tuttavia prospettiva. Ad interessarlo non
era più la giustificazione del fenomeno in termini causali, quanto la comprensione
delle proprietà e dei “sintomi” (come egli li chiama) del moto accelerato, ossia la
determinazione delle relazioni quantitative sussistenti tra gli spazi passati e i tempi
necessari a percorrerli. Una simile indagine otterrà un notevole risultato con la
scoperta della legge di caduta dei gravi (il caso paradigmatico di moto naturalmente
accelerato), esposta per la prima volta in una lettera a Paolo Sarpi del 16 ottobre
1604.
GALILEO: LA LETTERA A P. SARPI DEL 16 OTTOBRE
1604
«Ripensando circa le cose del moto, nelle quali, per dimostrare
li accidenti da me osservati, mi mancava principio totalmente
indubitabile da poter porlo per assioma, mi son ridotto ad una
proposizione la quale ha molto del naturale et dell’evidente; et
questa supposta, dimostro poi il resto, cioè gli spazzii passati
dal moto naturale esser in proporzione doppia dei tempi, et per
conseguenza gli spazii passati in tempi eguali esser come i
numeri impari ab unitate, et le altre cose. Et il principio è
questo: che il mobile naturale vadia crescendo di velocità con
quella proportione che si discosta dal principio del suo moto;
come, v. g., cadendo il grave dal termine a per la linea abcd,
suppongo che il grado di velocità che ha in c al grado di velocità
che hebbe in b esser come la distanza ca alla distanza ba, et così
conseguentemente in d haver grado di velocità maggiore che in
c secondo che la distanza da è maggiore della ca». OG, X, p.
115 (corsivo mio).
GALILEO: TEMPO E SPAZIO
Il documento appena citato esprime due fondamentali acquisizioni: 1) gli
spazi percorsi nella caduta sono proporzionali ai quadrati dei tempi; 2) di
conseguenza, gli spazi passati in tempi eguali si succedono come i numeri
dispari a partire dall’unità. Il fondamento di entrambi i risultati è
identificato nel “principio” per cui la velocità cresce al crescere della
distanza dal punto di inizio del movimento. L’assunto è tuttavia errato,
poiché, come lo stesso Galileo scoprirà ben presto, la velocità non aumenta
proporzionalmente allo spazio passato dalla quiete, bensì al tempo trascorso
dall’inizio del movimento.
Già in uno stralcio manoscritto, risalente forse al 1609, troviamo una
definizione del moto naturalmente accelerato basata sull’idea di
un’accelerazione proporzionale al tempo: «Chiamo moto uniformemente o
equabilmente accelerato, quel moto i cui momenti o gradi di velocità
aumentano, dall’abbandono della quiete, secondo l’incremento del tempo a
partire dal primo istante del movimento». (OG, II, p. 266).
La definizione verrà riproposta nelle pagine dei Discorsi e dimostrazioni
matematiche intorno a due nuove scienze (1638), l’ultima grande opera
galileiana.
GALILEO: L’INERZIA
Le acquisizioni concernenti il moto di caduta costituiscono una parte
importante del grande lascito intellettuale di Galileo. Va tuttavia segnalato
che la crucialità del contributo galileiano è soprattutto legata ad un
profondo ripensamento della stessa nozione di movimento e alla stretta
connessione che egli seppe istituire tra la dinamica e la cosmologia
copernicana.
Già nel 1613, Galileo affermava:
«rimossi tutti gl’impedimenti esterni, un grave nella superficie sferica e
concentrica alla Terra sarà indifferente alla quiete ed a i movimenti verso
qualunque parte dell’orizonte, ed in quello stato si conserverà nel qual una
volta sarà stato posto; cioè se sarà messo in stato di quiete, quello
conserverà, e se sarà posto in movimento, verbigrazia verso occidente,
nell’istesso si manterrà». (OG, V, p. 134).
Siamo qui di fronte ad una più compiuta esposizione di quel connotato
inerziale abbozzato (solo in termini cinematici) nei De motu e ne Le
mecaniche. Dietro questa formulazione si legge il decisivo abbandono
dell’immagine del moto propria della tradizione aristotelica.
GALILEO: IL MOTO COME STATO
Per Aristotele il movimento (anche quello locale) si configura nei termini di
un passaggio dall’essere in potenza all’essere in atto, cioè come un
processo attraverso il quale gli enti si “attualizzano”, realizzano cioè una
disposizione latente, in uno sviluppo che ha per fine il conseguimento di
una compiuta attualità. Nell’ambito della prospettiva galileiana, invece, il
moto viene equiparato ad uno stato, deprivato di qualunque determinazione
di natura teleologica, e, di fatto, reso indistinguibile dalla quiete («se sarà
messo in stato di quiete, quello conserverà, e se sarà posto in movimento,
[...] nell’istesso si manterrà», recita il passo poc’anzi citato).
GALILEO: IL MOTO DELLA TERRA È COME S’E’
NON FUSSE
«Rispetto alla Terra, alla torre e a noi, che tutti di conserva ci
moviamo, col moto diurno, insieme con la pietra, il moto diurno è
come se non fusse, resta insensibile, resta impercettibile, è senza
azione alcuna, e solo ci resta osservabile quel moto del quale noi
manchiamo, che è il venire a basso lambendo la torre». OG, VII, pp.
197 (corsivo mio).
Il movimento viene quindi riscontrato solo «nella relazione che hanno
essi mobili con altri che manchino di quel moto» (OG, VII, p. 142), il
che significa che esso è apprezzabile solo nel riferimento tra un mobile
ed un oggetto che non si muove.
GALILEO: LA RELATIVITA’
Concepire il moto nei termini di uno stato, è essenziale per poter affermare
quella relatività che fonda la possibilità stessa di una fisica “copernicana”,
ossia di una fisica della Terra in movimento. Nel Dialogo sopra i due
massimi sistemi, ribattendo all’argomento secondo cui, posto il moto
terrestre, un sasso lasciato cadere da una torre non atterrerebbe al piede
dell’edificio, Galileo argomenta:
«Rispetto alla Terra, alla torre e a noi, che tutti di conserva ci moviamo, col
moto diurno, insieme con la pietra, il moto diurno è come se non fusse,
resta insensibile, resta impercettibile, è senza azione alcuna, e solo ci resta
osservabile quel moto del quale noi manchiamo, che è il venire a basso
lambendo la torre». (OG, VII, p. 197).
In sostanza, un moto uniforme non esercita alcuna influenza sul
comportamento meccanico degli elementi che lo condividono. Il
movimento viene riscontrato solo «nella relazione che hanno essi mobili
con altri che manchino di quel moto» (ibid., p. 142), il che significa che è
apprezzabile solo nel riferimento tra un mobile ed un oggetto che non si
muove.
«Riserratevi con qualche amico nella maggiore stanza che sia sotto coverta di alcun gran navilio, e quivi
fate d’aver mosche, farfalle e simili animaletti volanti; siavi anco un gran vaso d’acqua, e dentrovi de’
pescetti; sospendasi anco in alto qualche secchiello, che a goccia a goccia vadia versando dell’acqua in un
altro vaso di angusta bocca, che sia posto a basso: e stando ferma la nave, osservate diligentemente come
quelli animaletti volanti con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza; i pesci si vedranno andar
notando indifferentemente per tutti i versi; le stille cadenti entreranno tutte nel vaso sottoposto; e voi,
gettando all’amico alcuna cosa, non piú gagliardamente la dovrete gettare verso quella parte che verso
questa, quando le lontananze sieno eguali; e saltando voi, come si dice, a piè giunti, eguali spazii passerete
verso tutte le parti. Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, benché niun dubbio ci sia che
mentre il vassello sta fermo non debbano succeder cosí, fate muover la nave con quanta si voglia velocità;
ché (pur che il moto sia uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi non riconoscerete una minima
mutazione in tutti li nominati effetti, né da alcuno di quelli potrete comprender se la nave cammina o pure
sta ferma: voi saltando passerete nel tavolato i medesimi spazii che prima, né, perché la nave si muova
velocissimamente, farete maggior salti verso la poppa che verso la prua, benché, nel tempo che voi state in
aria, il tavolato sottopostovi scorra verso la parte contraria al vostro salto; e gettando alcuna cosa al
compagno, non con piú forza bisognerà tirarla, per arrivarlo, se egli sarà verso la prua e voi verso poppa,
che se voi fuste situati per l’opposito; le gocciole cadranno come prima nel vaso inferiore, senza caderne
pur una verso poppa, benché, mentre la gocciola è per aria, la nave scorra molti palmi; i pesci nella lor
acqua non con piú fatica noteranno verso la precedente che verso la sussequente parte del vaso, ma con
pari agevolezza verranno al cibo posto su qualsivoglia luogo dell’orlo del vaso; e finalmente le farfalle e
le mosche continueranno i lor voli indifferentemente verso tutte le parti, né mai accaderà che si riduchino
verso la parete che riguarda la poppa, quasi che fussero stracche in tener dietro al veloce corso della nave,
dalla quale per lungo tempo, trattenendosi per aria, saranno state separate; [...] E di tutta questa
corrispondenza d’effetti ne è cagione l’esser il moto della nave comune a tutte le cose contenute in essa
ed all’aria ancora» OG, VII, pp. 212-13.