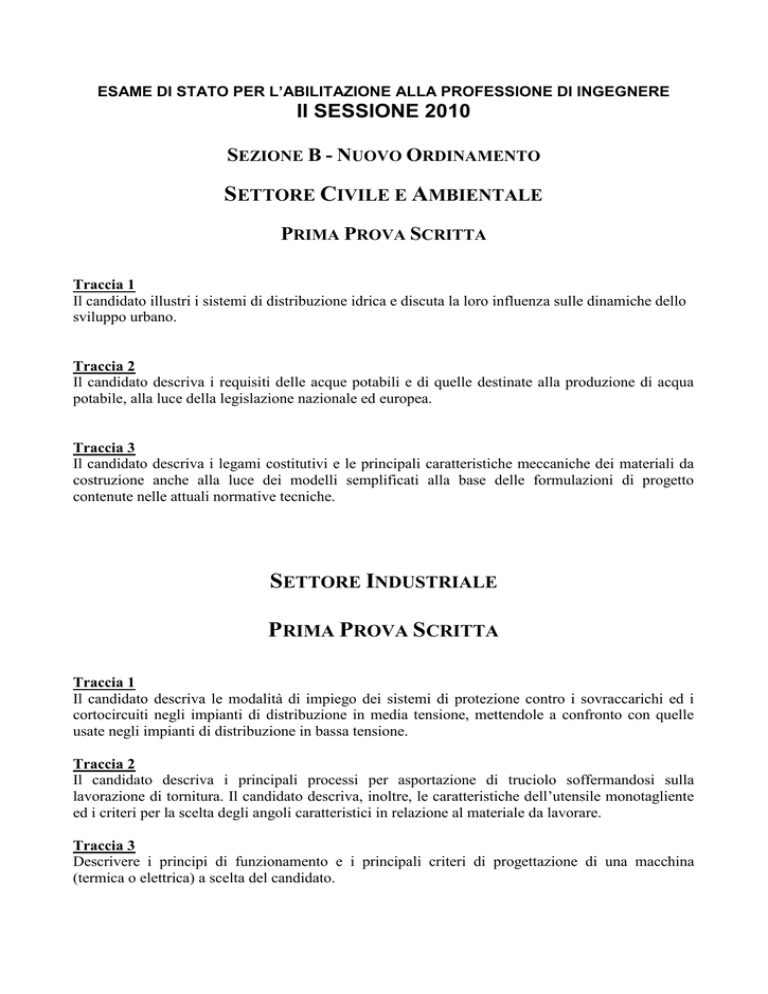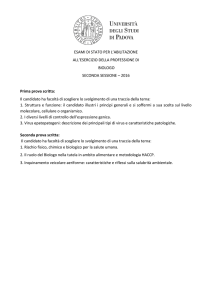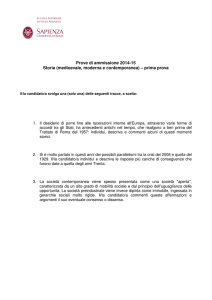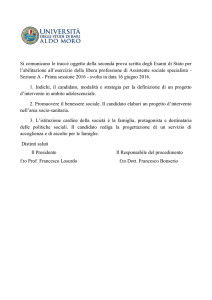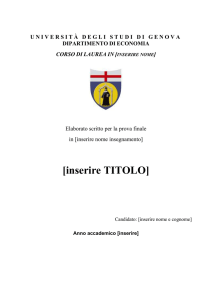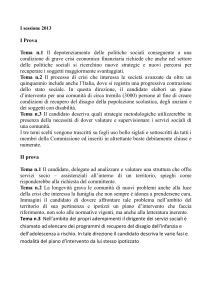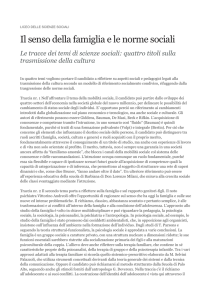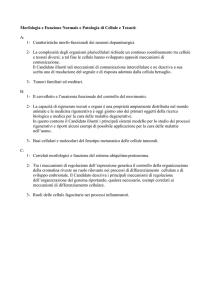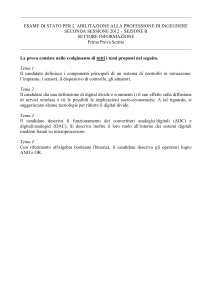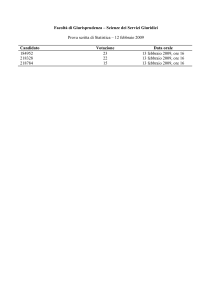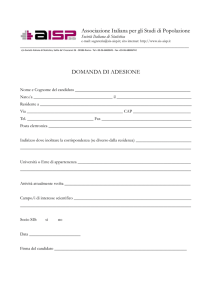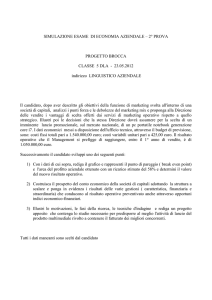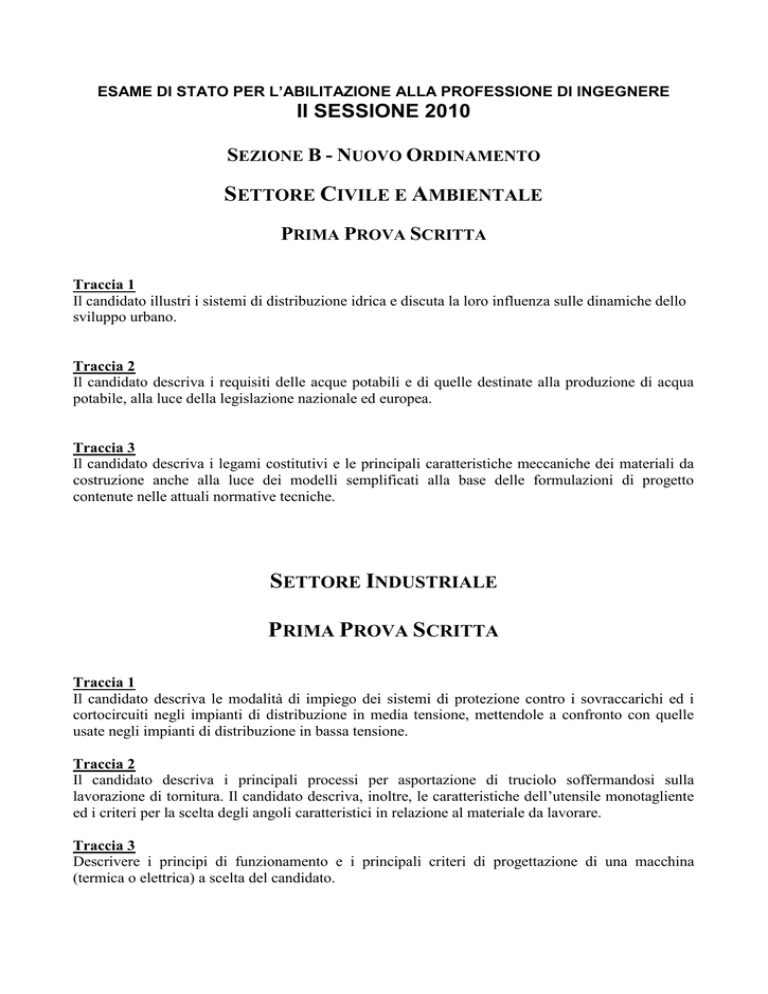
ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
II SESSIONE 2010
SEZIONE B - NUOVO ORDINAMENTO
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
PRIMA PROVA SCRITTA
Traccia 1
Il candidato illustri i sistemi di distribuzione idrica e discuta la loro influenza sulle dinamiche dello
sviluppo urbano.
Traccia 2
Il candidato descriva i requisiti delle acque potabili e di quelle destinate alla produzione di acqua
potabile, alla luce della legislazione nazionale ed europea.
Traccia 3
Il candidato descriva i legami costitutivi e le principali caratteristiche meccaniche dei materiali da
costruzione anche alla luce dei modelli semplificati alla base delle formulazioni di progetto
contenute nelle attuali normative tecniche.
SETTORE INDUSTRIALE
PRIMA PROVA SCRITTA
Traccia 1
Il candidato descriva le modalità di impiego dei sistemi di protezione contro i sovraccarichi ed i
cortocircuiti negli impianti di distribuzione in media tensione, mettendole a confronto con quelle
usate negli impianti di distribuzione in bassa tensione.
Traccia 2
Il candidato descriva i principali processi per asportazione di truciolo soffermandosi sulla
lavorazione di tornitura. Il candidato descriva, inoltre, le caratteristiche dell’utensile monotagliente
ed i criteri per la scelta degli angoli caratteristici in relazione al materiale da lavorare.
Traccia 3
Descrivere i principi di funzionamento e i principali criteri di progettazione di una macchina
(termica o elettrica) a scelta del candidato.
INGEGNERIA MECCANICA
SECONDA PROVA SCRITTA
Traccia 1
Il candidato illustri i principali metodi utilizzati per la regolazione della portate delle pompe
centrifughe mettendone in evidenza vantaggi e svantaggi.
Traccia 2
Il candidato descriva i principali criteri di usura per la determinazione della durata degli utensili da
taglio e le relazioni tra durata ed i principali parametri di processo. Il candidato descriva, inoltre, i
metodi per l’ottimizzazione di un processo di lavorazione per asportazione di truciolo.
Traccia 3
Il candidato descriva le possibili applicazioni delle fonti rinnovabili di energia nell’edilizia
residenziale popolare, evidenziando i possibili schemi impiantistici.
INGEGNERIA ELETTRICA
SECONDA PROVA SCRITTA
Traccia 1
Il candidato introduca il concetto di circuito magnetico e ne presenti il modello descrittivo, le sue
equazioni e le sue proprietà. Introduca inoltre il concetto di riluttanza magnetica e presenti la
descrizione di tali sistemi attraverso i modelli circuitali elettrici equivalenti. Con riferimento ad un
circuito magnetico scelto dal candidato, che contenga due avvolgimenti ed almeno un traferro, il
candidato illustri poi la procedura per valutarne i coefficienti di auto e mutua induzione.
Traccia 2
Il candidato descriva e confronti le tecniche e gli strumenti per la misurazione dello sfasamento tra
due segnali. Si evidenzino gli aspetti inerenti le scelte progettuali delle stazioni di misura.
Traccia 3
Il candidato descriva le grandezze 'portata' e 'energia termica specifica' di una linea in cavo,
indicando contestualmente per quali condizioni di funzionamento del sistema elettrico sono definite
ed illustrando le modalità con le quali si giunge alla loro definizione. Il candidato ne illustri infine
l'impiego.
INGEGNERIA CIVILE
SECONDA PROVA SCRITTA
Traccia 1
Il candidato illustri la metodologie e le considerazioni progettuali per un sistema di drenaggio
urbano di tipo separato.
Traccia 2
Si descrivano le metodologie sperimentali per la resistenza al taglio dei terreni a grana fina in
condizioni drenate e non drenate.
Traccia 3
Il candidato illustri i criteri generali per la verifica ed il progetto di sezioni di elementi in cemento
armato soggetti a flessione semplice o composta secondo l’approccio alle Tensioni Ammissibili e
allo Stato Limite Ultimo.
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E PER IL TERRITORIO
SECONDA PROVA SCRITTA
Traccia 1
Nell’ambito della pianificazione di “Area Vasta”, il Candidato illustri ed esemplifichi le linee guida
volte alle azioni per la tutela e la riqualificazione degli assetti idrogeologici del territorio,
differenziando gli aspetti strutturali e le possibili direttive programmatiche.
Traccia 2
Si descrivano le metodologie sperimentali per la resistenza al taglio dei terreni a grana fina in
condizioni drenate e non drenate.
Traccia 3
Il candidato illustri le procedure previste dalla legislazione vigente per la valutazione dell’impatto
ambientale derivante dalla realizzazione di un’opera sul territorio.
INGEGNERIA MECCANICA
QUARTA PROVA SCRITTA
Traccia 1
Il candidato effettui il dimensionamento di un impianto solare termico per la produzione di acqua
calda sanitaria che garantisca una copertura pari al 50% del fabbisogno annuo per una famiglia
composta da 4 persone. Si ipotizzi che il suddetto impianto debba essere installato su un tetto piano
in una località scelta dal candidato.
Traccia 2
Un albero di acciaio utilizzato in un riduttore ad ingranaggi cilindrici è soggetto ad una coppia
costante ed ad un momento flettente alterno simmetrico. La tensione dovuta al momento torcente
vale 80 MPa, mentre la flessione origina uno sforzo massimo di 60 MPa. Questi valori sono
nominali, non tengono cioè conto di uno spallamento (vedi figura).
Con D=36mm;
d=30 mm;
r=3mm.
Le superfici sono tutte lavorate di macchina utensile.
Caratteristiche del materiale: carico di rottura=700MPa; carico di snervamento=500 MPa
Durezza= 200 HB.
1. Valutare il coefficiente di sicurezza per una durata a fatica infinita
2. Valutare il numero di cicli di rottura se il momento flettente origina un carico di tensione di
100 MPa (invece che 60 MPa).
Traccia 3
Una Limatrice è una macchina utensile caratterizzata da un movimento rettilineo alternativo dello
slittone portautensili (Fig.1a), che è realizzato mediante un meccanismo a glifo oscillante, noto
come Guida di Fairbairn (Fig.1b).
Nelle ipotesi in cui la manovella motrice 2 ruoti in senso orario con n costante pari a 180 giri/min,
ricavare la velocità massima dello slittone portautensili, rispettivamente nella corsa di andata e di
ritorno, e le accelerazioni dello slittone portautensili in entrambe le posizioni di fine corsa.
A tal fine, si rilevino le dimensioni degli altri elementi partendo dalla conoscenza della lunghezza
della manovella a = 20 cm e ricavando la scala dal disegno di Fig.1b.
Si commentino i risultati ottenuti ponendo in evidenza le principali caratteristiche cinematiche della
Limatrice.
Fig.1 - Limatrice: a) vista complessiva della macchina utensile; b) schema cinematico.
INGEGNERIA ENERGETICA
QUARTA PROVA SCRITTA
Traccia 1
Il candidato effettui il dimensionamento di un impianto solare termico per la produzione di acqua
calda sanitaria che garantisca una copertura pari al 50% del fabbisogno annuo per una famiglia
composta da 4 persone. Si ipotizzi che il suddetto impianto debba essere installato su un tetto piano
in una località scelta dal candidato.
Traccia 2
Un impianto a ciclo combinato, con turbina a gas e turbina a vapore a valle, eroga
complessivamente una potenza di 200 MW.
L’impianto a gas, in circuito aperto, utilizza aria (cp = 1.005 kJ/kg K; k = 1.4) evolvente tra le
temperature minima e massima di 18 °C e 900 °C rispettivamente, con un rapporto di compressione
β = 9. I gas di scarico della turbina (cpg = 1.11 kJ/kg K; k = 1.33) vengono riportati a 900 °C nella
camera di combustione a monte del generatore di vapore a recupero ove entrano a tale temperatura e
lo abbandonano alla temperatura di 150 °C.
Il ciclo a vapore surriscaldato, a condensazione, evolve tra le pressione di 70 bar e di 0.05 bar ed è
caratterizzato da una temperatura massima T3 = 550 °C.
Determinare la portata di gas combusti disponibile e la portata di vapore prodotta, assumendo che il
combustibile impiegato nella camera di combustione suddetta sia caratterizzato da un potere
calorifico inferiore Hi = 43.000 kJ/kg.
Traccia 3
Si debba collegare in rete un impianto idroelettrico di piccola potenza. Il generatore sincrono trifase
abbia i seguenti dati di targa:
Potenza nominale
60 kVA
Frequenza nominale
50 Hz
Velocità nominale
1500 giri/min
Tensione nominale
1kV
cos nominale
0.84
Reattanza sincrona p.u.
0.8
Resistenza p.u.
0.01
La tensione della rete di potenza prevalente sia pari a 10kV.
Si progetti il convertitore elettronico per la connessione in rete, indicando lo schema elettrico, i
componenti elettronici di potenza scelti, gli algoritmi e gli schemi di controllo.
INGEGNERIA ELETTRICA
QUARTA PROVA SCRITTA
Traccia 1
Si consideri uno stabilimento alimentato a 20 kV con cabina di proprietà dell’utente. L’impianto elettrico
deve alimentare:
- un edificio adibito a uffici (potenza complessiva 15 kW) che dista 60 m dalla cabina;
- un’officina che dista 80 m dalla cabina con carichi di forza motrice (potenza complessiva 90 kW) e
impianto di illuminazione (potenza complessiva 9 kW);
- un impianto di illuminazione esterna (potenza complessiva 3 kW).
Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie:
a) disegni lo schema unifilare dell’intero impianto;
b) dimensioni le linee di alimentazione dei carichi;
c) disegni lo schema del quadro generale in cabina e ne dimensioni le principali apparecchiature.
Traccia 2
Un carico trifase di potenza 10MVA tensione nominale 400V con cos=0.9 rit. sia alimentato
tramite un trasformatore avente i seguenti dati di targa:
Tensione primaria nominale 10kV
Tensione secondaria a vuoto
450V
Potenza nominale
12MVA
Frequenza nominale
50 Hz
Potenza a vuoto percentuale
4.00%
Corrente a vuoto percentuale 2.00%
Tensione di corto circuito
percentuale
10.00%
Potenza di corto circuito
percentuale
4.00%
Si consideri che una variazione dei carichi intervenuta successivamente all'installazione del
trasformatore abbia portato la potenza assorbita pari a 15MVA con cos=0.8 rit. Si discutano le
diverse scelte possibili per alimentare i carichi, calcolando:
a) le correnti a carico nominale e al 50% del carico nella condizione di carico iniziale ( 10MVA con
cos=0.9 rit.)
b) le correnti erogate nella nuova configurazione al 30%, al 50% e al 100%del carico.
c) le cadute di tensione in tutte le condizioni considerate.
INGEGNERIA CIVILE
QUARTA PROVA SCRITTA
Traccia 1
Nelle seguenti tabelle sono forniti i dati relativi ad una prova edometrica effettuata su un campione
di argilla limosa prelevata in una formazione naturale alla profondità di 18 m dal piano campagna.
Nella formazione la falda è presente alla profondità di 3 metri dal piano campagna.
Il candidato determini:
a) le proprietà fisiche iniziali del campione (, d, e0, n, Sr)
b) la curva di compressibilità nel piano e – log’v
c) il coefficiente di compressibilità Cc
d) la curva rappresentativa di Eed in funzione di ’v
e) il rapporto di sovra consolidazione OCR
altezza
H0
(mm)
20.13
diametro
D
(mm)
50.43
tara anello
Ta
(g)
58.181
anello+provino umido
Ta+W u
(g)
tara pesafiltro
Tp
(g)
143.999
100.710
pesafiltro+anello+provino umido
Tp+Ta+W u
(g)
242.166
pesafiltro+anello+provino secco
Tp+Ta+W s
(g)
230.690
peso specifico
gs
(g/cm3)
2.73
tempo, t
(min)
cedimenti in fase di carico, w (mm)
(ore, min)
12.5
0
0.1
0.25
0.5
1
2
5
10
15
30
60
1.00
100
1.40
200
3.20
400
6.40
1440
24.00
peso applicato, Q (g)
carico, q (kPa)
6.000
5.995
5.980
5.975
5.970
5.970
5.970
5.970
5.975
5.985
6.010
6.030
6.075
6.120
6.185
248.0
12.18
25
50
100
200
400
6.190
6.170
6.170
6.170
6.170
6.165
6.160
6.160
6.160
6.155
6.150
6.150
6.150
6.150
6.150
495.0
24.32
6.150
6.115
6.110
6.110
6.105
6.100
6.090
6.085
6.080
6.070
6.060
6.055
6.000
5.990
5.990
1003.7
49.31
5.990
5.950
5.945
5.940
5.940
5.930
5.920
5.910
5.900
5.890
5.860
5.850
5.845
5.840
5.830
2000.4
98.27
5.830
5.770
5.755
5.750
5.740
5.725
5.705
5.690
5.675
5.650
5.630
5.615
5.605
5.555
5.510
3986.6
195.83
5.510
5.360
5.350
5.340
5.320
5.300
5.270
5.240
5.215
5.170
5.120
5.100
5.080
5.065
5.015
7986.9
392.34
tempo, t
(min)
5.015
4.870
4.850
4.840
4.830
4.810
4.775
4.750
4.720
4.675
4.640
4.620
4.600
4.590
4.570
15951.7
783.60
1600
2400
3200
4.570
4.410
4.390
4.375
4.345
4.310
4.240
4.160
4.105
3.990
3.870
3.810
3.750
3.720
3.695
31835.7
1563.87
3.695
3.630
3.620
3.610
3.600
3.580
3.535
3.500
3.470
3.405
3.340
3.295
3.250
3.220
3.200
47760.5
2346.15
3.200
3.165
3.155
3.150
3.145
3.130
3.110
3.080
3.065
3.020
2.980
2.940
2.900
2.870
2.825
63894.1
3138.69
cedimenti in fase di scarico, w (mm)
(ore, min)
0
0.1
0.25
0.5
1
2
5
10
15
30
60
1.00
100
1.40
200
3.20
400
6.40
1440
24.00
peso applicato, Q (g)
carico, q (kPa)
800
1600
400
100
2.835
2.860
2.860
2.865
2.870
2.870
2.885
2.895
2.895
2.900
2.905
2.905
2.910
2.910
2.910
31835.7
1563.87
2.920
2.950
2.960
2.965
2.975
2.990
3.015
3.040
3.060
3.100
3.150
3.180
3.205
3.215
3.225
7984.1
392.21
3.225
3.250
3.260
3.265
3.270
3.280
3.300
3.320
3.335
3.365
3.410
3.450
3.505
3.540
3.570
2000.4
98.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.80
Traccia 2
Con riferimento allo schema riportato in figura, il candidato esegua il calcolo del solaio
considerando la tipologia di solaio latero-cementizio gettato in opera e la destinazione d’uso di
civile abitazione. Si eseguano altresì gli elaborati grafici in opportuna scala.
Eventuali dati non inclusi nella traccia possono essere liberamente scelti dal candidato purché se ne
fornisca adeguata giustificazione.
1.00
4.00
4.00
1.50
Traccia 3
Data una strada extraurbana principale di tipo F1, il cui tracciato geometrico è riportato nella successiva
tabella, il candidato, in ottemperanza ai dettami riportati nelle “Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade (D.M. 5/11/2001)”, provveda a:
1) calcolare numericamente, verificare alla luce del D.M. 5/11/2001 e rappresentare graficamente il
diagramma di velocità;
2) si verifichi la necessità, alla luce del D.M. 5/11/2001, di inserire delle corsie di arrampicamento per
entrambi i sensi di marcia sapendo che il valore della Velocità Limite, Vlim in Km/h, su di una
livelletta di assegnata pendenza longitudinale è stimabile, per un veicolo commerciale tipo,
attraverso l’espressione:
Vlim 134.96 e-18.244(i mr )
3)
4)
5)
6)
dove i (in frazione) rappresenta la pendenza della livelletta ed mr il coefficiente di resistenza a
rotolamento pari a 0.035, e le curve di prestazione sono espresse attraverso le seguenti relazioni:
accelerazione: V ( s ) Vlim (1 e k s ) , decelerazione: V ( s ) Vlim (V0 Vlim )e k s
dove s rappresenta la progressiva in metri, V0 è la velocità massima iniziale delle curve di
prestazione pari a 90 Km/h, e k = 0.005. Si assuma una velocità all’inizio del tratto in esame del
veicolo pari a 73 Km/h.
assumendo le clotoidi di flesso simmetriche, effettuare le relative verifiche (contraccolpo,
sovrappendenza ed ottica) e calcolare i parametri rilevanti per la loro geometrizzazione;
effettuare le verifiche sugli altri elementi del tracciato (curve e rettifili);
calcolare numericamente e rappresentare il diagramma dei cigli;
calcolare il Livello di Servizio, secondo la procedura dell’ Highway Capacity Manual 2000,
assumendo un valore del Traffico Giornaliero Medio (mono-direzionale) pari a 2700 veicoli/giorno,
una percentuale di veicoli pesanti pari al 14 %, una ripartizione del traffico nelle due direzioni pari a
49/51, un terreno ondulato, una densità di 5 accessi per chilometro ed una percentuale di tracciato
con visibilità superiore a quella necessaria al sorpasso pari al 38 %.
N. progressivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Elemento
Rettifilo
Clotoide di transizione
Curva
Clotoide di flesso
Curva
Clotoide di flesso
Curva
Clotoide di transizione
Rettifilo
Sviluppo [m]
225
205
175
295
480
160
90
250
250
Raggio [m]
362
395
305
-
Pendenza [%]
3.9
3.9
3.9
-1.2
-1.2
1.1
1.1
0.5
0.5
Infine, sulla scorta dei dati di ingresso già riportati, si provveda a dimensionare una pavimentazione flessibile
con il metodo semi-probabilistico AASHTO Guide 1986, assumendo una vita utile di 20 anni, un tasso di
crescita annuo del traffico pari all’ 1.5 %, un valore del Modulo Resiliente del sottofondo pari a 42 MPa, un
valore di affidabilità pari all’85% , un valore del PSI finale pari a 2.5 ed uno spettro di traffico dei veicoli
pesanti riportato nella tabella seguente:
(N.B. gli assi ravvicinati sono da intendersi Tandem)
Peso degli assi [kN]
Tipo di veicolo
40
Autocarri medi e pesanti
80
100 100
Autocarri pesanti
60
Autotreni
60
100
100
100
80 80
80 80
Autoarticolati
40
50
80
Autobus
% sul traffico
Commerciale totale
16
34
30
15
5
Traccia 3
Il candidato progetti un sistema per la misura di una resistenza elettrica mediante la tecnica voltamperometrica.
Si considerino per la resistenza incognita i seguenti dati di targa:
d) resistenza nominale 10 Ω;
e) potenza nominale 2 W;
f) tensione di isolamento 150 V;
Dovranno essere evidenziati i seguenti aspetti:
a) scelta della strumentazione necessaria all’esecuzione della prova;
b) progettazione del circuito più idoneo motivandone le scelte;
Descrivere le possibili soluzioni progettuali (voltmetro a monte o a valle) valutando la
scelta rispetto alle caratteristiche della strumentazione e della resistenza incognita.
c) scelta della tensione di alimentazione del circuito di misura;
Valutare sia gli aspetti relativi al dimensionamento elettrico del sistema sia quelli
metrologici.
d) la valutazione dell’incertezza di misura associata alla resistenza misurata;
Per la configurazione circuitale scelta, riportare la trattazione matematica del calcolo
dell’incertezza di misura, evidenziando gli aspetti legati agli errori di consumo degli
strumenti.
Nello sviluppo del progetto si considerino, per l’amperometro ed il voltmetro scelti, le seguenti
caratteristiche relative alla resistenza interna.
g) Resistenza interna voltmetro: valore 10 MΩ; accuratezza percentuale 0,5 %.
h) Resistenza interna amperometro: valore 2 Ω; accuratezza percentuale 0,7 %
INGEGNERIA AMBIENTALE
QUARTA PROVA SCRITTA
Traccia 1
Nelle seguenti tabelle sono forniti i dati relativi ad una prova edometrica effettuata su un campione
di argilla limosa prelevata in una formazione naturale alla profondità di 18 m dal piano campagna.
Nella formazione la falda è presente alla profondità di 3 metri dal piano campagna.
Il candidato determini:
f) le proprietà fisiche iniziali del campione (, d, e0, n, Sr)
g) la curva di compressibilità nel piano e – log’v
h) il coefficiente di compressibilità Cc
i) la curva rappresentativa di Eed in funzione di ’v
j) il rapporto di sovra consolidazione OCR
altezza
H0
(mm)
20.13
diametro
D
(mm)
50.43
tara anello
Ta
(g)
58.181
anello+provino umido
Ta+W u
(g)
tara pesafiltro
Tp
(g)
143.999
100.710
pesafiltro+anello+provino umido
Tp+Ta+W u
(g)
242.166
pesafiltro+anello+provino secco
Tp+Ta+W s
(g)
230.690
peso specifico
gs
(g/cm3)
tempo, t
(min)
cedimenti in fase di carico, w (mm)
(ore, min)
12.5
0
0.1
0.25
0.5
1
2
5
10
15
30
60
1.00
100
1.40
200
3.20
400
6.40
1440
24.00
peso applicato, Q (g)
carico, q (kPa)
6.000
5.995
5.980
5.975
5.970
5.970
5.970
5.970
5.975
5.985
6.010
6.030
6.075
6.120
6.185
248.0
12.18
25
50
100
200
400
6.190
6.170
6.170
6.170
6.170
6.165
6.160
6.160
6.160
6.155
6.150
6.150
6.150
6.150
6.150
495.0
24.32
6.150
6.115
6.110
6.110
6.105
6.100
6.090
6.085
6.080
6.070
6.060
6.055
6.000
5.990
5.990
1003.7
49.31
5.990
5.950
5.945
5.940
5.940
5.930
5.920
5.910
5.900
5.890
5.860
5.850
5.845
5.840
5.830
2000.4
98.27
5.830
5.770
5.755
5.750
5.740
5.725
5.705
5.690
5.675
5.650
5.630
5.615
5.605
5.555
5.510
3986.6
195.83
5.510
5.360
5.350
5.340
5.320
5.300
5.270
5.240
5.215
5.170
5.120
5.100
5.080
5.065
5.015
7986.9
392.34
tempo, t
(min)
800
5.015
4.870
4.850
4.840
4.830
4.810
4.775
4.750
4.720
4.675
4.640
4.620
4.600
4.590
4.570
15951.7
783.60
1600
2400
3200
4.570
4.410
4.390
4.375
4.345
4.310
4.240
4.160
4.105
3.990
3.870
3.810
3.750
3.720
3.695
31835.7
1563.87
3.695
3.630
3.620
3.610
3.600
3.580
3.535
3.500
3.470
3.405
3.340
3.295
3.250
3.220
3.200
47760.5
2346.15
3.200
3.165
3.155
3.150
3.145
3.130
3.110
3.080
3.065
3.020
2.980
2.940
2.900
2.870
2.825
63894.1
3138.69
cedimenti in fase di scarico, w (mm)
(ore, min)
0
0.1
0.25
0.5
1
2
5
10
15
30
60
1.00
100
1.40
200
3.20
400
6.40
1440
24.00
peso applicato, Q (g)
carico, q (kPa)
2.73
1600
400
100
2.835
2.860
2.860
2.865
2.870
2.870
2.885
2.895
2.895
2.900
2.905
2.905
2.910
2.910
2.910
31835.7
1563.87
2.920
2.950
2.960
2.965
2.975
2.990
3.015
3.040
3.060
3.100
3.150
3.180
3.205
3.215
3.225
7984.1
392.21
3.225
3.250
3.260
3.265
3.270
3.280
3.300
3.320
3.335
3.365
3.410
3.450
3.505
3.540
3.570
2000.4
98.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Traccia 2
Con riferimento ad una utenza di 195.000 abitanti (dotazione idrica pari a 230 l/abgiorno) e una
risorsa idrica fluviale (categoria A3, D.Lgs. 152/06), il candidato definisca il ciclo di trattamento
per un impianto di potabilizzazione. Dimensioni, altresì, le singole fasi del ciclo di trattamento. Le
scelte progettuali siano volte a prevedere un impianto di trattamento versatile e contestualmente
contraddistinto da elevate performance.
Traccia 3
Il candidato mediante un'anali costi-benefici dimensioni la condotta di mandata e il gruppo di
pompaggio dell’impianto di sollevamento schematicamente illustrato in figura, caratterizzato da:
-
prevalenza geodetica HG = 25 m;
lunghezza della condotta premente L = 1200 m;
portata da sollevare Q = 80 l/s
HG
L
Per la progettazione si faccia riferimento ai costi indicati nel seguito:
Costi delle tubazioni (in acciaio bitumato senza saldatura), come da tabella seguente
DN
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
D esterno [mm] Spessore [mm] Costo [€/m]
48,3
2,6
11,10
60,3
2,9
11,59
76,1
2,9
14,52
88,9
3,2
17,08
114,3
4,0
28,43
139,7
4,5
34,71
168,3
4,5
50,14
219,1
5,6
79,06
273,0
6,3
110,23
323,9
7,1
167,26
355,6
7,1
177,33
406,4
8,0
203,31
457,2
8,0
238,94
508,0
8,8
290,24
609,6
10,0
406,26
- Costo di valvole e dispositivi: 15 % del costo della tubazione;
- Costo della centrale di sollevamento: 1500 €/kW di potenza installata;
- Costo dell’energia elettrica: 0,20 €/kWh
Per il gruppo di pompaggio si adottino pompe caratterizzate dalla curva caratteristica indicata in
tabella e dal rendimento ipotizzato costante e pari a h = 0.8:
33.3 38.3 50
58.3
Q [l/s] 25 30
32.5 24.5
H [m] 47 45.5 43.5 41
Infine, il candidato individui l’effettivo punto di funzionamento dell’impianto.