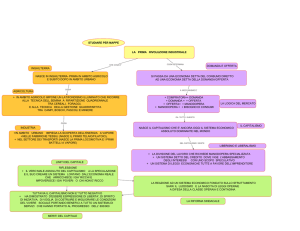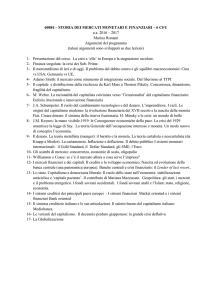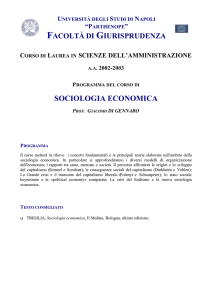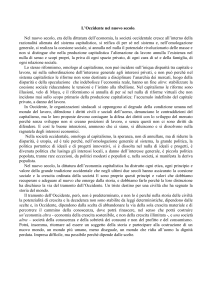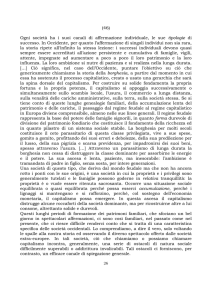Le ambivalenze del lavoro nell’orizzonte del
capitalismo cognitivo
di Federico Chicchi e Gigi Roggero
1. Sociologia e transizione verso il post-moderno
La ragione di fondo che ha sostenuto la realizzazione di questo volume è
rintracciabile nella convinzione che i rapporti tra le forze e le forme sociali
attraverso cui si promuove, organizza e governa la produzione del valore
siano oggi cambiate e vadano quindi profondamente ripensate. Diremmo di
più. Il quadro socio-economico che ha sostenuto lo sviluppo della società
capitalistica durante, più o meno, tutto il ventesimo secolo appare oggi
attraversato da una profonda crisi “strutturale”, che mina alla radice il
funzionamento e la legittimazione di quegli istituti sociali che durante la
società moderna e industriale avevano permesso la fondazione e quindi la
(relativa) stabilizzazione di uno specifico “regime di crescita”1. L’erosione,
la messa in discussione dei processi di riproduzione e sostenibilità della
società industriale hanno comportato di conseguenza, lo spiazzamento e la
perdita di efficacia interpretativa delle tipiche e fondative categorie
concettuali (culturali, economiche, sociali e giuridiche) del sapere moderno
(economia politica in primis). Rendendo particolarmente urgente la
domanda di elaborazione di nuovi paradigmi adatti alla comprensione della
transizione in atto.
La sociologia, per parte sua, ha in tal senso proficuamente contribuito, a
partire dalla fine degli anni ottanta, all’analisi di tali processi di
trasformazione e delle loro fenomenologie sociali più visibili. In proposito
e senza alcuna intenzione di esaurirne la variegata fecondità, crediamo
doveroso sottolineare qui l’importanza delle riflessioni dei cosiddetti
sociologi della modernità riflessiva (su tutti i lavori di Beck, Giddens,
Lash, Urry e Bauman) che hanno ripensato le categorie interpretative della
1 Nel senso attribuito al concetto dalla cosiddetta Scuola della regolazione francese (Cfr.
Aglietta, 2001 e Boyer, 2007).
1
modernità e fornito alcune stimolanti piste di indagine rispetto alla
emergenza sociale di una sua inedita configurazione2. Un prezioso
contributo alla definizione della transizione va inoltre attribuito all’indagine
del sociologo/geografo inglese David Harvey, che a partire da alcune
intuizioni della scuola regolazionista francese ha inteso sottolineare
l’affermarsi di un nuovo modello di accumulazione (e di nuove istituzioni
della regolazione) basato sulla flessibilità e capace, attraverso il
superamento delle rigidità fordiste, di rilanciare, al prezzo di ingenti costi
sociali, il funzionamento del sistema capitalistico. “C’è sempre il pericolo
di considerare il transitorio e l’effimero alla stregua di trasformazioni
fondamentali della vita politico-economica. Ma i contrasti tra le attuali
pratiche politico-economiche e quelle del periodo del boom postbellico
sono abbastanza marcati da rendere accettabile, per descrivere la storia
recente, l’ipotesi di un passaggio dal fordismo a ciò che potrebbe essere
chiamato regime “flessibile” di accumulazione” (Harvey, 1993, p. 155)3. È
sotto l’analisi concettuale dei processi di globalizzazione, inoltre, e più in
generale, che si è però sviluppato il più intenso dibattito sulle recenti
trasformazioni socio-economiche. Tale discussione, complessa e plurale, ha
certamente sedimentato e consegnato alla riflessione sociologica e
scientifica alcune chiavi interpretative di grande interesse4. In particolar
modo i temi che sono entrati a far parte della discussione teorica ed
empirica, e che sono ancora oggi per molti versi attuali, hanno inteso
chiarire: i processi di internazionalizzazione dei mercati e le loro
conseguenze sul lavoro e sull’economie nazionali, gli effetti di
ristrutturazione e re-engineering dell’impresa industriale e più in generale
delle strutture produttive, l’indebolimento progressivo delle capacità
regolative dello Stato nazione sull’economia e la crisi dei sistemi di
Welfare tradizionali. Rispetto a quest’ultimo tema e alla diffusione di
inedite condizioni di vulnerabilità sociale causate dalla crisi della cosiddetta
società salariale e dei dispositivi di protezione sociale ad essa
2 Vorremmo ricordare in proposito, per quanto riguarda l’Italia, anche il lavoro del
compianto sociologo riminese Alberto Melucci. Il lemma da lui utilizzato per definire la
transizione, e la sua radicalità, è stato quello del passaggio d’epoca (Melucci, 1994).
3 Non ci è qui possibile entrare con sufficiente profondità e dettaglio all’interno della
della proposta teorica di Harvey e di altri importanti teorici sul ‘rompicapo della
transizione’, le cui argomentazioni meriterebbero certamente ben altra presentazione. Ci
permettiamo, in proposito, di rimandare al primo capitolo del bel volume di Gigi Roggero
“La produzione del sapere vivo” (2009).
4 Per quanto riguarda specificatamente la sociologia economica sul tema della
globalizzazione e della complessità dei suoi processi, tutt’altro che lineari e progressivi va
certamente ricordata l’importanza dei contributi del cosiddetto approccio neo-isituzionalista
(Cfr. Rizza, 1999). Approccio cui farà ampio riferimento nelle sue opere lo stesso Manuel
Castells.
2
consustanziali, sono senz’altro da mettere in risalto i lavori di Robert Castel
(1995 e 2003). Lo studioso francese ha in particolare tematizzato, con
notevole perizia storiografica e acutezza interpretativa, il progressivo
processo di erosione della cittadinanza sociale e dei legami sociali moderni
immersi nel farsi incerto dello statuto del lavoro nel contesto socioeconomico contemporaneo.
Un’altro contributo di rilievo interno alla riflessione sociologica sulla
crisi del modello di produzione fordista è da attribuire al non comune, per
qualità e vastità, lavoro di analisi della cosiddetta società della rete,
proposto all’inizio degli anni novanta dal sociologo di origini catalane
Manuel Castells. L’opera di quest’ultimo ha avuto rispetto alla riflessione
generale sulla transizione un così stupefacente e significativo eco che non è
possibile non farne breve menzione. La sua proposta di definizione di un
nuovo paradigma, economico e organizzativo, l’informazionalismo - basato
sulla diffusione di una nuova “etica economica”, che echeggiando
Schumpeter, Castells definisce come cultura della distruzione creatrice pone al centro dell’analisi l’importanza crescente del governo e dello
sfruttamento economico dei flussi transnazionali di informazioni e
conoscenza5. Castells sottolinea, quindi, l’importanza crescente del sapere
nella definizione del nuovo paradigma economico post-fordista, paradigma
che, in virtù dello stretto rapporto con le nuove tecnologie della
comunicazione digitale porta, a seconda delle condizioni culturali ed
istituzionali vigenti in ogni singolo territorio, alla precisazione prima e
all’egemonia poi, di un inedito paradigma basato sulla diffusione della rete
come suo costante e principale principio operativo di organizzazione e
funzionamento. La sua analisi permette quindi alla difficoltosa e spesso
aporetica indagine sul post di fissare in positivo la rilevanza di alcune
specifiche (culturali, economiche e tecnologiche) coordinate definitorie. In
particolare è infatti nell’analisi di Castells che la rete come principio chiave
di ri-organizzazione della morfologia d’impresa e del lavoro, trova una
definitiva “consacrazione” sociologica e scientifica nell’analisi delle
trasformazioni del lavoro, dell’impresa e più in generale, della produzione
del valore.
Non è possibile infine non nominare l’importanza della proposta teorica
di Boltanski e Chiappello, che, alla fine degli anni novanta, hanno insistito,
attraverso il loro volume Le nouvel esprit du capitalisme (1999), non solo
5 Si chiede Castells (2008, p. 86): “Questo approccio shumpeteriano alla crescita
economica solleva un problema di rilevanza persino maggiore circa la struttura e la
dinamica dell’economia informazionale. Ovvero: cosa c’è di storicamente nuovo nella
nostra economia? Quale è la specificità rispetto ad altri sistemi economici, e in particolare
rispetto all’economia industriale?”.
3
sulla diffusione e centralità organizzativa del paradigma della rete (loro
parlano in merito di capitalismo connessionista o di città per progetti6) ma
anche sulla necessità di individuare nella metabolizzazione/traduzione
capitalistica delle rivendicazioni e critiche di stampo estetico e libertario
rivolte contro di esso (la cosiddetta critica d’artista) il motore stesso del
nuovo modello capitalistico post-industriale7. La rilevanza della loro
interpretazione risiede nel mostrare come anche elementi non
immediatamente interni alla organizzazione socio-economica capitalistica
siano decisivi nel determinare la dinamicità e la “rigenerazione” dello
stesso sistema. Come vedremo in seguito, tale questione, che riguarda
direttamente la qualità e la natura dei rapporti sociali di produzione,
risulterà centrale anche in alcune delle analisi sulla contemporanea
produzione della ricchezza proposte nei saggi del presente volume. Come
Castells, anche i due autori francesi, attraverso un approccio teorico e
metodologico però molto differente, basato sulla attenta analisi della
letteratura di fonte manageriale, indicano nella formazione di un nuovo
spirito del capitalismo (il richiamo a Max Weber è quindi anche qui
esplicito e fondante) e dunque nella generalizzazione di una inedita
“grammatica di giustizia” (articolata attraverso ordini normativi
convenzionali e specifiche prove di grandezza) che presiede e indirizza
l’organizzazione dei processi di estrazione del valore, il momento chiave
per comprendere l’attuale transizione capitalistica. “La grandezza della città
per progetti è adattabile e flessibile. Essa può ondeggiare da una situazione
all’altra molto differente adattandosi a quest’ultima. È polivalente, capace
di cambiare attività o strumento. È in tal modo impiegabile nell’universo
della impresa e perciò suscettibile di essere integrata in un nuovo progetto.
Chi è grande in questa città è così attivo e autonomo. Sa correre dei rischi
per annodare dei contratti sempre nuovi e ricchi di possibilità e reperire le
buone fonti d’informazioni al fine di evitare i legami ridondanti”
(Boltanski, 2002, p. 15). Un ulteriore pregio dell’opera di Boltanski e
Chiappello ci pare essere infine quello di collocare la loro proposta
interpretativa all’interno del quadro dinamico e conflittuale della società
capitalistica, cornice quest’ultima che ha, a nostro avviso in modo
6 La diffusione della rete crea i presupposti per la formazione di una nuova
organizzazione politica della produzione, una nuova città, per usare il lessico di Boltanski
che insieme a Thevenot all’inizio degli anni novanta avevano individuato sei modalità
differenti di gestire e organizzare l’efficacia della struttura normativa di uno spazio sociale
(Cfr. Boltanski e Thevenot, 1999).
7 Essa consiste in sintesi “nell’abbandonare il terreno delle prove istituzionali , in cui si
esprime la critica sociale, per mettersi all’ascolto delle nuove rivendicazioni che rientrano
piuttosto nel campo della critica d’artista”. (Boltanski, 2002, p. 17). Si veda in proposito
anche il contributo di Maurizio Lazzarato contenuto in questo volume.
4
improprio, progressivamente perso di rilevanza in gran parte della
pubblicistica della sociologia contemporanea.
Al di là dei contributi della riflessione sociologica nella interpretazione
della crisi della società industriale molte sono inoltre le proposte teoriche
che a partire da altri paradigmi disciplinari, in questi ultimi anni, hanno
prodotto sul tema approcci teorici di grandissimo spessore e rilevanza.
L’elenco sarebbe lungo e difficile da compilare in modo esaustivo, e non
compatibile con gli intenti di questa introduzione8. Quello che invece ci
pare utile sottolineare qui è che, a causa della complessità e profondità dei
cambiamenti in atto, per accedere a descrizioni euristicamente efficaci e
positive della transizione è diventata sempre più pressante ed evidente la
necessità di perseguire una seria e intensa contaminazione reciproca
(dunque senza alcun imperialismo o gerarchia disciplinare) delle diverse
prospettive interpretative in gioco. L’imperante e progressiva iperspecializzazione dei saperi ha infatti, spesso e volentieri, indebolito la
capacità delle singole scienze di costruire teorie “generali” dei processi in
atto, producendo tagli e parzialità (intra e inter disciplinari) sull’oggetto da
indagare (e in particolare sulla società capitalistica) fino alla grave
conseguenza di produrre il rischio dell’evanescenza della sua complessiva
ed unitaria rappresentazione cognitiva.
Questo volume si è posto, quindi, da un punto di vista metodologico, il
preciso obiettivo di interrogare (in modo transdisciplinare, dunque) la
disciplina socio-lavorista attraverso il confronto con alcune delle più
interessanti proposte interpretative sulla transizione provenienti da altre
discipline affini, che ci pare consegnino, come già rilevato, alla analisi più
generale della contemporaneità socio-economica, alcune piste di indagine
che non è più possibile tenere in residuale considerazione.
Per quanto riguarda specificatamente lo sfondo tematico all’interno del
quale presentiamo qui i diversi contributi raccolti, al di là della prima
richiamata urgenza che li connota e cioè quella di comprendere le nuove
modalità attraverso cui la produzione del valore oggi si attualizza nel lavoro
e nelle sue forme organizzative, è la necessità di articolare secondo
paradigmi innovativi che tengano conto delle effettive continuità e
discontinuità tra presente produttivo e passato industriale, e in particolare il
mutato e ambivalente rapporto di implicazione che il lavoro instaura oggi
con il “comando” capitalistico a porsi come questione rilevante.
Riportando, dunque, al centro della riflessione, il tema per lo più oggi
8 Solo per citarne alcune delle più significative, l’importante tradizione degli studi
cosiddetti post-coloniali, le riflessioni del post-operaismo italiano, in economia: la scuola
della regolazione francese, l’approccio della teoria delle convenzioni, e sul piano più
squisitamente filosofico il paradigma biopolitico. [Gigi.....]. Cfr. Roggero, 2009.
5
negletto, della tensione, del conflitto irriducibile, e delle contraddizioni tra
capitale e lavoro che il capitalismo deve continuamente governare e gestire
per generare una misura del valore che permetta la sostenibilità generale
dei suoi processi di accumulazione.
A questo proposito nella prima sezione della presente monografia,
intitolata “Quale analitica del valore nell’economia post-fordista?”
presentiamo una serie di contributi, a nostro parere di straordinario valore
teorico, che pongono, ciascuno in modo diverso, al centro della loro
disamina proprio tale questione.
Il saggio di Carlo Vercellone, che apre il volume, avanza la sua
riflessione all’interno dell’ipotesi del cosiddetto “capitalismo cognitivo”.
La tesi dell’autore, articolata in modo originale attraverso le principali
categorie interpretative marxiane, riguarda in estrema sintesi, la
formazione, sulle ceneri del paradigma della produzione di massa (della cui
crisi l’autore presenta una attenta e puntuale disamina genealogica), di un
nuovo sistema di accumulazione capitalistico, basato prevalentemente sullo
sfruttamento della conoscenza. In tale contesto, nella produzione della
ricchezza diverrebbe centrale la crescente autonomia del lavoro-vivo
cognitivo in rapporto alla “tradizionale” prevalenza del sapere accumulato
nelle macchine e nelle organizzazioni manageriali delle imprese. Secondo
Vercellone il capitalismo cognitivo è infatti, in primo luogo, caratterizzato
dalla definizione sociale di un inedito rapporto, “di una nuova fase storica”,
tra capitale e lavoro contrassegnata dalla crescente potenza produttiva di
una intellettualità diffusa che si genera prevalentemente al di fuori della
classica cornice capitalistica della fabbrica e che richiama direttamente in
causa il concetto marxiano di General Intellect. Afferma l’autore in
proposito: “Con il concetto di “capitalismo cognitivo” designiamo un
sistema di accumulazione nel quale il valore produttivo del lavoro
intellettuale e immateriale diviene dominante e dove la posta in gioco
centrale della valorizzazione del capitale e delle altre forme di proprietà
poggia direttamente sulla espropriazione “attraverso la rendita” del comune
e sulla trasformazione della conoscenza in una merce fittizia”. Avremo
modo di ritornare rapidamente in seguito su quest’ultima questione che
Vercellone definisce attraverso la formula del farsi rendita del profitto,
perché essa apre, al di là della aperta e stimolante questione teorica, una
prospettiva interpretativa che ci pare per certi versi estremamente feconda
ed efficace per leggere le più recenti fenomenologie della crisi finanziaria
del capitalismo contemporaneo (Cfr. Fumagalli e Mezzadra, a cura di,
2009).
Il prezioso e ricco di suggestioni teoriche contributo di Enzo Rullani si
pone per certi versi in continuità con quello di Carlo Vercellone. Ad
6
esempio quando identifica nella conoscenza la risorsa che nella modernità,
in modo più o meno esplicito a seconda dei paradigmi, è stato a
fondamento dello sviluppo economico e sociale. Le riflessioni di Rullani,
sulla scorta di una prospettiva teorica differente da quella di Vercellone (in
particolare le teorie della complessità e i modelli dell’evoluzionismo
biologico) concordano però con quest’ultimo nel verificare l’emergenza di
un nuovo paradigma capitalistico, quello che lui definisce come
capitalismo comunicativo, dove è centrale l’importanza delle infrastrutture
tecnologiche di natura comunicativa (Ict) e dove la produzione e la
misurazione del valore deve necessariamente adottare criteri diversi da
quelli tipicamente industriali e fordisti (Rullani, 2004). La proposta
analitica di Rullani permette di fare un importante passo avanti nella lettura
della transizione economica per tre principali ordini di motivi: a) mostra la
centralità delle risorse immateriali nella produzione del valore e identifica
le proprietà costitutive della risorsa conoscenza rispetto alla risorsa
produttiva materiale (la conoscenza non è una risorsa scarsa e non si
consuma con l’uso, la conoscenza ha costi di riproduzione che tendono a
zero); b) propone una innovativa analitica del valore dell’economia della
conoscenza basata: i. sulla misurazione della capacità del bene conoscenza
di produrre valore per l’esperienza soggettiva, ii. sul potenziale di
moltiplicabilità e ri-uso della risorsa conoscenza, e iii. sulla possibilità di
regolare e distribuire istituzionalmente il valore economico e sociale
prodotto all’interno della articolata filiera della cosiddetta fabbrica
dell’immateriale; c) evidenzia come i processi “normali” di produzione del
valore oggi non possano più essere ricompresi all’interno della classica
definizione di impresa. “Si tratta infatti, come abbiamo detto, di una
‘fabbrica diffusa’, che super ai confini proprietari delle singole imprese e si
distribuisce lungo la filiera dei molti operatori e delle molte funzioni”.
Quest’ultima considerazione pone, inoltre, un’altra fondamentale
questione: la difficile definizione dei confini (oggi sempre più porosi e
difficili da tracciare) tra lavoro e consumo (infatti per Rullani il
consumatore è certamente un attore, tutt’altro che passivo, della filiera
produttiva del capitalismo comunicativo). Ritorneremo più avanti
sull’argomento, anche richiamando le stimolanti considerazioni proposte
nel suo contributo da Vanni Codeluppi riguardo ai concetti di terzo lavoro e
di prosumer di Alvin Toffler, ci basti per ora qui mettere in evidenza come
su questa questione, non a caso, siano molti i contributi del volume che si
soffermano ad indagare le qualità emergenti di questo rapporto.
7
2. Biocapitalismo: norme e spazi del vivente messo al lavoro
Vi è da raccogliere e quindi precisare la grande rilevanza di un’altra
questione che emerge da alcuni dei saggi qui proposti. Essa riguarda il farsi
sempre più stretto e prossimo del rapporto tra vita e lavoro.
Lo scenario che delimita e al contempo caratterizza la prassi lavorativa
contemporanea è connesso, infatti, all’imporsi di una nuova fattispecie
normativa che si esercita, diremmo, al di là della sua tradizionale ed astratta
generalità. Nelle fabbriche sociali e diffuse del post-fordismo non si tratta
più di predisporre e disciplinare (subordinare) i soggetti produttivi
all’interno di rigidi e specifici ruoli funzionali cui corrisponde una ferrea
disciplina operativa (in questo caso infatti non vi sarebbe la possibilità di
sfruttare al meglio le sempre più rilevanti competenze cognitive ed emotive
dei lavoratori), ma piuttosto di formare e quindi controllare9 degli spazi di
“libertà” di azione produttiva all’interno dei quali le condotte soggettive
possano plasmarsi in conformità con le esigenze di continua e imperante
innovazione dei processi e dei prodotti. Sul piano dell’analisi del potere, si
tratta di riconoscere quella che possiamo definire come la svolta biopolitica
della società contemporanea, dove le relazioni di potere non sono più intese
nel senso della semplificante forma dicotomica sovrano-sudditi, o dentrofuori della legge; la norma biopolitica si presenta infatti come
“extragiuridica, eccezionale, flessibile, poiché la flessibilità e
l’imprevedibilità sono i caratteri dell’oggetto-vita cui si riferisce”
(Bazzicalupo 2006, p. 39). Tale potere non si esercita attraverso l’esercizio
di un comando “minaccioso” e “sovrano”, ma attraverso la “suadente” e
maternale proposta di percorsi di soggettivazione e potenziamento delle
proprie qualità personali al fine di sostenere la costruzione “orientata al
regime di verità” delle singole biografie professionali (empowerment). Il
potere biopolitico è in tal senso un potere “che produce un più di vita” e
non è costrittivo/disciplinare nel senso tradizionale del termine, è un potere
che governa la vita attraverso l’assoggettamento al sapere/potere
economico (bioeconomia) e attraverso la produzione di spazi di libertà
fittizia, all’interno dei quali stimolare la soggettività creativa e la
cooperazione sociale, spazi che però sono già piegati in una unica direzione
9 Il concetto di controllo si definisce in filosofia politica in contrasto con quello di
disciplina e rimanda implicitamente al lavoro (sulla “società del controllo”) di Gillez
Deleuze. Ma sono stimolanti in proposito anche alcune riflessioni dello psicoanalista
lacaniano francese J.-A. Miller (2006, p. 82 ): “Non si tratta dell’esercizio diretto ingiuntivo
del padrone, quanto piuttosto di indurre nei soggetti un’autocoercizione mentale”. Egli
definisce tale fenomeno come l’alleggerimento della padronanza.
8
prestabilita, quella indicata dal mercato e dai suoi autoreferenziali criteri di
efficienza10.
Serve la libertà del mercato del lavoro, ma occorre anche che vi siano dei lavoratori: che
siano abbastanza numerosi, sufficientemente competenti e qualificati, ma anche
politicamente disarmati, in modo che il mercato del lavoro non sia sottoposto a pressioni. Si
creano così le condizioni per dar vita ad una legislazione formidabile, per una formidabile
quantità di interventi di governo, a garanzia di quella produzione di libertà di cui si ha
appunto bisogno per governare (Foucault, 2005, p. 66-67).
Per osservare la stessa questione da una diversa prospettiva
interpretativa, ciò che appare divenire rilevante, con l’affermarsi del
cosiddetto capitalismo biopolitico, riguarda, in primo luogo,
l’indebolimento delle mediazioni (sociali e giuridiche) tra vita ed economia,
e di conseguenza, l’accentuarsi della prossimità dei dispositivi di governo
sulle condotte; dispositivi11 che possono essere facilmente riscontrati anche
all’interno dei nuovi rapporti organizzativi post-tayloristici. Con il concetto
di prossimità intendiamo quindi sottolineare la “cattura”12 all’interno della
pianificazione razionale e strategica della produzione flessibile, degli
aspetti intimi, privati, relazionali e comunicativi che prima non
partecipavano alla vita produttiva. L’immediata “messa a valore” del bios
(mente e corpo, vita e saperi personali) pone quindi le basi di una nuova
struttura di definizione della forma del lavoro nella società capitalistica
attuale. Questo processo di “approfondimento” della relazione produttiva
volto a comprendere al suo interno gli aspetti più intimi e privati della
persona, come detto, prefigura anche una nuova modalità di gestione del
potere organizzativo. È il tema che in filosofia politica è stato definito,
tramite il ricorso al lessico foucaultiano, come il passaggio dal governo alla
10
E’ comunque bene specificare che la diffusione dei dispositivi
biopolitici/governamentali non eliminano le tradizionali e coercitive (quando non violente)
forme di esercizio del potere (basti pensare in proposito alla attuale condizione sociale e
giuridica dei migranti), ma in un certo senso le integrano e affiancano in modo
complementare. Sul tema specifico della bioeconomia ci permettiamo invece di rimandare
ad un nostro precedente lavoro intitolato: “Bioeconomia: ambienti e forme della
mercificazione del vivente” in (Amendola, Bazzicalupo, Chicchi, Tucci, 2008).
11 L’analisi foucaultiana sulla biopolitica fa riferimento, in proposito, al cosiddetto
“potere pastorale”, inteso come modello di riferimento nella combinazione dei nuovi poteri
dispositivi. L’efficienza di questi ultimi starebbe proprio nella efficace connessione di
potestas e benevolentia tipica di tale istituto.
12 Il termine cattura viene qui utilizzato per sottolineare la incorporazione ex post delle
qualità valorizzanti i processi di produzione; queste ultime infatti tendono a formarsi e a
precisarsi in un rapporto di (naturalmente non assoluta ma relativa) esternalità rispetto alle
tipiche organizzazioni produttive capitalistiche.
9
governamentalità13, intesa quest’ultima come una pervasiva tecnica di
controllo delle condotte sociali che si differenzia dalle tradizionali azioni di
disciplina gerarchica dell’agire sociale e che si caratterizza, tra l’altro, per il
mettere a valore non solo gli aspetti meramente operativi e professionali del
fare sociale, ma ogni aspetto della vita umana (Cfr. Amendola,
Bazzicalupo, Chicchi, Tucci, 2008 e Marzocca, 2007).
Su questo specifico e importante tema si soffermano sia Vanni
Codeluppi che Andrea Fumagalli e Cristina Morini. In particolare nel loro
contributo Fumagalli e Morini approfondiscono, mirabilmente, il modo in
cui nel biocapitalismo il lavoro si presenta direttamente sotto la forma di
biolavoro e cioè “come summa delle facoltà vitali-cerebrali-fisiche degli
esseri umani”. Ancor più specificatamente di grande interesse è il modo
con cui gli autori mostrano come non siano solo gli aspetti cognitivi e
simbolici a caratterizzare il lavoro post-fordista ma come giochino un ruolo
altrettanto importante, gli aspetti emotivi e relazionali e di come questo sia
da collegare direttamente ai processi di femminilizzazione del lavoro. “Il
lavoro affettivo, emozionale, di cura, rappresenta insomma a nostro avviso
l’esempio più calzante di come, nella sfera biopolitica, la vita è destinata a
lavorare per la produzione e la produzione a lavorare per la vita”.
3. Capitalismo, reti e produzione di saperi
La tendenziale indistinzione tra rendita e profitto, ovvero il «divenire
rendita del profitto», è come abbiamo precedentemente accennato, una
delle linee interpretative attraverso cui Vercellone struttura l’ipotesi del
capitalismo cognitivo. Matteo Pasquinelli la conferma nell’indagine della
rete: l’algoritmo PageRank di Google è qui assunto come modello
esemplificativo di quello che viene definito un «parassita macchinico
dell’intelletto comune». Il problema non è più, allora, concentrarsi sul
motore di ricerca come apparato di sorveglianza e controllo: il modello del
Panopticon, particolarmente diffuso negli studi critici sui network, rischia
di essere fuorviante. Al centro dell’analisi è, anche in questo caso, la
produzione del valore in Internet, cioè come si fanno profitti e si accumula
13 Un’efficace e sintetica definizione di governamentalità si trova in Chignola (2006, p.
58): “Governamentalità è l’insieme delle istanze analitiche che adeguano l’esercizio del
potere sulla centralità dell’economia e non del diritto”. E ancora (Ivi, p. 61): “L’ambiente
sociale delle relazioni di mercato […] L’homo oeconomicus, che lo abita, è un “elemento
intangibile” per il potere; deve, letteralmente, essere lasciato fare. La sua, è un’azione libera
che consuma libertà e che libertà pertanto richiede gli venga continuamente assegnata e
garantita. Questa libertà è l’ “oggetto” della cura governamentale”.
10
capitale in uno spazio spesso ingenuamente considerato esterno al mondo
delle merci e del lavoro. L’algoritmo produce una gerarchia nella
produzione di conoscenza finalizzata a trasformarla in unità
quantitativamente misurabili, ovvero in valore di scambio. È in questo
processo che si situa l’arcano della fattura del plusvalore.
Da questo punto di vista, la rete è paradigmatica di ciò che, nella
letteratura sul capitalismo cognitivo, è identificato come un vero e proprio
rovesciamento rispetto all’organizzazione produttiva del capitalismo
industriale. Per sintetizzare: la cooperazione sociale ha raggiunto un livello
di autonomia tale da costringere il capitalismo cognitivo a rinunciare ad
organizzarla a monte, inseguendone invece i movimenti per “catturarla” a
valle. La creazione del valore avverrebbe perciò attraverso la captazione ex
post dell’autonoma potenza produttiva del lavoro vivo. Indipendentemente
dalla valutazione nel merito di tale ipotesi interpretativa, va precisato che
non vi è nessun giudizio morale nella definizione “parassitaria” del
capitalismo contemporaneo, quanto piuttosto l’urgenza di individuare le
nuove forme dell’accumulazione. In questo processo capovolto, per usare i
termini marxiani, la riduzione del lavoro vivo a lavoro astratto avviene
attraverso l’imposizione di unità di misura artificiali, atti a segmentare la
cooperazione sociale e ricondurre la «dismisura» al rapporto salariale.
Viene così imposta la vigenza della legge del valore laddove essa ha
cessato di essere valida: smarrito ogni rapporto con la quantificazione
dell’attività produttiva, diventa – sostengono i teorici del capitalismo
cognitivo – nuda misura dello sfruttamento, cioè legge del plusvalore.
Dunque, innervato dalla centralità dei rapporti di produzione e
dall’insistenza sui mutamenti della composizione di classe, dall’analisi
dello sfruttamento e del conflitto, il concetto di lavoro cognitivo si
allontana dalla categoria di knowledge worker e si separa in modo
definitivo da altre immagini prevalenti nella letteratura sociologica e non
solo, come quella di “classe creativa” (Florida, 2003). Il lavoro resta l’unica
fonte di creazione del plusvalore, ma è sono gli stessi confini del lavoro a
modificarsi. L’economia del brand, su cui si soffermano il saggio di Oscar
Marchisio, lo mostra con esemplare chiarezza. È allora necessario mettere
in discussione un consolidato luogo comune che ha accompagnato la
transizione “postfordista”, ossia la trasformazione del lavoratore in
consumatore, laddove è piuttosto all’opera il processo inverso. Si pensi –
oltre alla fenomenologia presentata da Vanni Codeluppi – alla figura
professionale del cool hunter, letteralmente il cacciatore di tendenze pagato
dalle aziende per individuare e “catturare” stili e forme di vita. Se negli
anni Venti Ford diceva “comprate una qualsiasi macchina purché sia una
Ford T nera”, sintetizzando la (peraltro irrealizzata) egemonia
11
dell’organizzazione imprenditoriale capitalistica sul ciclo della produzione
e del consumo, il cool hunter invece agisce a valle, per mettere a valore
quel «sapere comune» di cui parla lo stesso Codeluppi in quello che
definisce «biocapitalismo». Tuttavia, l’economia del brand non può essere
interpretata in termini esclusivamente parassitari, ma a sua volta funziona
attraverso processi di cooperazione, di cui i cacciatori di tendenze sono
appunto un segmento, finalizzati alla ricomposizione del comando ex post.
Se, mantenendo lo stesso angolo prospettico, ritorniamo al paradigma
della rete, la figura del prosumer – da vent’anni immagine dell’unificazione
tra produttore e consumatore – si spacca e si rovescia: è, a tutti gli effetti,
un lavoratore non retribuito. Lo ha capito bene Yochai Benkler (2007), su
cui si soffermano sia Pasquinelli sia Carlo Formenti, nella sua formulazione
di una «produzione orizzontale basata sui beni comuni». Osservando le
forme di innovazione e produzione «informazionale», dal peer-to-peer ai
social network, il giurista neoliberale esalta quelle caratteristiche dello
spazio di Internet – condivisione, centralità delle strategie non proprietarie,
eccedenza della cooperazione rispetto al mercato, orizzontalità – che
costituiscono il bagaglio dei movimenti open source e free software. Se
vari pensatori critici (Gorz, 2003) hanno inteso la produzione
“immateriale” nella chiave di un’economia dell’abbondanza e della
gratuità, destinata a condurre motu proprio verso forme di cooperazione,
scambio e consumo fondate sulla reciprocità e la messa in comune, per
Benkler questo è esclusivamente il punto di partenza. Lungi dall’essere in
contraddizione con il suo sviluppo, l’“economia dei beni comuni” è una
condizione di possibilità del capitalismo contemporaneo, tanto rischiosa
quanto necessaria. Anche da questo punto di vista, le nuove tecnologie – se
intese come prodotto e posta in palio dei rapporti sociali, non causa
oggettiva della trasformazione – segnano uno scarto rispetto al passato.
Indubbiamente, costituiscono uno dei vettori attraverso cui è passata la
tendenziale indistinzione tra tempi di vita e di lavoro: per i lavoratori
cognitivi, infatti, diventa sempre più difficile distinguere l’utilizzo delle
nuove tecnologie per il tempo di lavoro e per il tempo libero, per
l’occupazione e per il piacere (Ross, 2003). Ciò non configura, però, un
lineare sviluppo verso uno scenario post-capitalistico: disegna semmai il
nuovo terreno dell’accumulazione e del conflitto.
A questo livello, lo stesso sistema della proprietà intellettuale –
identificato come irrinunciabile pilastro delle strategie di appropriazione
capitalistica – rischia di diventare un ostacolo per processi di innovazione
che, poiché fondati su una cooperazione in buona misura autonoma, devono
oggi garantire un certo grado di libertà delle forze produttive. È allora una
sorta di “capitalismo senza proprietà” quella vagheggiata da Benkler e
12
molti altri teorici dell’“anarco-capitalismo”, che esemplificano nello
scontro tra Google e Microsoft la lotta tra nuova e vecchia economia. Le
imprese del Web 2.0, capeggiate dal gigante fondato da Page e Brin,
incarnano così quel modello di «produzione orizzontale basata sui beni
comuni» che non rappresenta certo un’alternativa al libero mercato, ma al
contrario uno straordinario meccanismo di valorizzazione per un
capitalismo che non riesce più a governare ex ante la cooperazione sociale.
Nella dissoluzione della classica dicotomia tra pubblico e privato, come
Pasquinelli mostra, pubblicità e finanziarizzazione sono i principali
dispositivi attraverso cui si alimentano i «rentier globali» dell’economia
digitale.
Su questa base interpretativa, saldamente ancorata nelle trasformazioni
produttive e del lavoro, si staglia la questione della crisi, che assume una
luce peculiare dall’angolo prospettico dell’ipotesi del capitalismo
cognitivo: la illustra Formenti, dialogandovi criticamente. La crisi
finanziaria, lungi dall’essere creata da degenerazioni speculative o bolle
incontrollate, è immediatamente crisi economica (Fumagalli e Mezzadra,
2009). Se negli schemi tradizionali finanziarizzazione e crisi intervengono
alla fine del ciclo, dopo l’espansione dell’economia reale legata
all’affermarsi di un modello produttivo, oggi la finanziarizzazione non solo
pervade l’intero ciclo economico, ma mette in discussione la stessa
categoria di ciclo, legata a periodi medio-lunghi. Nell’ultimo decennio,
invece, abbiamo assistito al succedersi di crisi economico-finanziarie di
portata mondiale in tempi talmente brevi (si pensi solo al crollo dei mercati
del sud-est asiatico nel ’97, a quello dell’indice Nasdaq e della new
economy nel 2000, alla crisi del sistema del debito e dei subprime a
cominciare dal 2007) da rendere estremamente difficoltoso ricostruire,
anche ex post, la dinamica ciclica. In un certo senso le nostre vite sono
interamente dentro al processo di finanziarizzazione: quando usiamo la
carta di credito o il bancomat, quando facciamo ricorso a mutui e debiti per
aver accesso a bisogni fondamentali (casa, formazione, mobilità, sanità),
quando una parte dei salari viene pagata in stock option, o le pensioni
diventano fondi di investimento. In questa luce la finanziarizzazione non
solo non si contrappone alla cosiddetta “economia reale”, ma è la forma
dell’economia capitalistica atta al comando e alla “cattura” del lavoro
cognitivo. La provocatoria formula scelta da alcuni circoli vicini a The
Economist, “comunismo del capitale”, è definita da alcuni teorici del
capitalismo cognitivo come la captazione del comune – ovvero ciò che è
prodotto dal lavoro vivo e dall’intelletto generale – nel segno della rendita,
intesa marxianamente come il potere di appropriazione di una parte
crescente dei valori creati dalla cooperazione sociale senza un intervento
13
diretto del capitale. La crisi, allora, lungi dall’essere confinata a una fase
discendente del ciclo e a preparare una nuova espansione, oppure al farsi
levatrice di una dinamica di crescita, non è più solo dato strutturale dello
sviluppo capitalistico, ma sembra diventare suo elemento permanente e
orizzonte insuperabile. Del resto, configurandosi come crisi del capitalismo
tout court, significa la fine del neoliberalismo, il che non significa che
siano finiti i suoi effetti, ma questi non riescono più a fare sistema.
È qui evidente, dunque, come le reti giochino un ruolo di primo piano
nelle trasformazioni del lavoro e del capitale. Non manca, del resto, una
ricca letteratura internazionale che ne ha esaminato l’importanza nel
passaggio dal “fordismo” al “postfordismo” (Castells, 2008; La Rosa,
2004). Tale ruolo, tuttavia, assume una peculiare declinazione nell’ipotesi
del capitalismo cognitivo: respingendo i rischi del “determinismo
tecnologico”, cioè dell’assunzione dei mutamenti produttivi come
inevitabile conseguenza delle innovazioni scientifiche e macchiniche, la
rete viene soggettivizzata. In altri termini, la produzione cooperativa dei
saperi e i rapporti sociali non sono il risultato bensì la trama dello sviluppo
tecnologico, nonché i suoi agenti di vivificazione e trasformazione
continua. Ma c’è di più: è necessario ripensare, si sostiene, il classico
rapporto tra capitale fisso e capitale variabile. Infatti, a differenza delle
conoscenze sottratte agli artigiani e agli operai nella fase del capitalismo
industriale e incorporate nelle macchine, oggi i saperi – nella misura in cui
diventano forza produttiva diretta e centrale, nonché mezzo di produzione –
non possono essere completamente trasferiti né alla macchina né
all’impresa. In altre parole, la conoscenza non viene ceduta completamente
e quindi interamente strappata al suo detentore, ma gli resta appiccicata
addosso. Le nuove tecnologie si basano infatti sulla produzione e gestione
dinamica di conoscenze, linguaggi e informazioni, che non possono essere
separati completamente dai soggetti della cooperazione sociale e
staticamente incapsulati nelle macchine, pena bloccare il processo stesso
dello sviluppo tecnologico. La separazione può così avvenire
esclusivamente su un piano formale e artificiale. Non è un caso che la
riduzione degli investimenti in capitale fisico e la diffusione delle macchine
telematiche sia per Benkler il primo dei tre elementi caratteristici della sua
auspicata economia dei commons – il secondo è la natura di bene comune
delle materie prime dell’economia dell’informazione, il terzo è la peculiare
forma modulare e cooperativa della produzione su Internet. Ed è indagando
la nuova qualità del rapporto tra capitale fisso e capitale variabile che
Christian Marazzi (2005) descrive l’emergenza di un «modello
antropogenetico», cioè basato sulla produzione dell’uomo attraverso
l’uomo, «in cui la possibilità della crescita endogena e cumulativa è data
14
soprattutto dallo sviluppo del settore educativo (investimento nel capitale
umano), del settore della sanità (evoluzione demografica, biotecnologie) e
di quello della cultura (innovazione, comunicazione e creatività)» (p. 109).
Nel modello antropogenetico, continua Marazzi, «la smaterializzazione del
capitale-fisso e dei prodotti-servizio ha quale suo corrispettivo concreto la
“messa al lavoro” delle facoltà umane […] che, interagendo con sistemi
produttivi automatizzati e informatizzati, sono direttamente produttive di
valore aggiunto. […] Nella nostra ipotesi, il corpo della forza-lavoro, oltre
a contenere la facoltà di lavoro, funge anche da contenitore delle funzioni
tipiche del capitale fisso, dei mezzi di produzione in quanto sedimentazione
di saperi codificati, conoscenze storicamente acquisite, grammatiche
produttive, esperienze, insomma lavoro passato» (p. 111).
Indipendentemente dalla completa obsolescenza o meno della
distinzione tra capitale fisso e lavoratore, possiamo sostenere che il
processo di cristallizzazione e oggettivazione del sapere nel sistema delle
macchine si articola in modo nuovo e peculiare: il lavoro/sapere morto ha
bisogno di essere vivificato con tempi estremamente più rapidi, da cui
sfugge continuamente un’eccedenza di sapere vivo e sociale (Roggero,
2009). Comunque, ci basti qui evidenziare il ruolo centrale della
produzione dei saperi nelle forme contemporanee del lavoro e
dell’accumulazione, efficacemente messo in evidenza dal saggio di Aihwa
Ong: è attraverso la conoscenza che si determinano le gerarchie all’interno
del mercato globale. Frantumatesi le illusioni delle dot.com e la retorica
degli “analisti di simboli”, come ben racconta Ong, il declassamento è
diventata la dura realtà del lavoro cognitivo. Tutto sommato, molte delle
nuove definizione dei produttori di conoscenza – si pensi ancora una volta
alla creative class – non sono altro che il tentativo di trovare un equivalente
funzionale del ruolo, sociale e politico prima ancora che economico, che in
passato svolgeva un ceto medio ora in fase di dissoluzione. La «guerra
globale dei talenti» di cui parla Florida (2006) disegna perciò uno scenario
in cui la centralità della cooperazione sociale e la sempre più stretta
interdipendenza globale della produzione deve essere continuamente
segmentata e divisa dallo scontro tra le elite nazionali per l’egemonia dei
mercati e la lotta intestina tra i lavoratori cognitivi per la loro
sopravvivenza.
Insieme a tali illusioni, è caduta anche l’idea che le mansioni ad alto
skill siano al riparo dall’esternalizzazione: soprattutto nella crisi si
moltiplicano i casi di imprese che optano per l’esternalizzazione di attività
ad alto contenuto cognitivo verso luoghi in cui possono trovare una
manodopera a basso costo. Allora, è attraverso la conoscenza che si
disegnano le nuove geografie della divisione del lavoro. Si prenda
15
l’esempio dell’iPhone: nel luglio del 2007, pochi giorni dopo le
impressionanti code di consumatori in fila nelle città americane per
comprare il gioiellino della Apple, The New York Times vi ha dedicato un
articolo per dimostrare come la sua produzione non sia riducibile alla
classica divisione di software e componentistica tra paesi del “primo” e del
“terzo mondo”. Le imprese di Taiwan giocano un ruolo fondamentale
nell’innovazione tecnologica, sono le mani (e i cervelli) silenziosi che
stanno dietro all’iPhone. D’altro canto, la parte di progettazione sviluppata
sul suolo americano si basa in buona misura sul lavoro dei “tecnomigranti”
indiani descritti da Ong: è il caso, esemplare in quanto affatto comune, di
Sajit, ingegnere indiano trasferitosi negli Stati Uniti attraverso un body
shop, sistema di intermediazione che alloca il lavoro a basso costo nei
mercati dell’hi-tech (Xiang, 2007). Approdato in California dopo aver
lavorato in un’azienda di software a Houston, Sajit – come molti suoi
connazionali – fa anche il taxista, strada temporanea per realizzare il
proprio “sogno americano”. Sogno di difficile realizzazione, per Sajit così
come per gli ingegneri bianchi della Silicon Valley colpiti da un vero e
proprio déclassement quando le loro imprese hanno deciso per
l’outsourcing a Bangalore, in India appunto.
Ad essere qui messa in discussione è quindi la tradizionale immagine
della divisione internazionale del lavoro, che affonda le proprie radici nei
principi dell’economia politica elaborati da Ricardo e nell’analisi smithiana
della ricchezza delle nazioni, per poi essere ricalcata sulla divisione
geografica tra zone “avanzate” ed “arretrate”. Già durante gli anni Novanta
Manuel Castells (2002), ipotizzando il passaggio alla società
«informazionale», evidenziava il problema: «La teoria della nuova
divisione internazionale del lavoro sottostante alle analisi degli impatti
differenziali di commercio e globalizzazione sulla forza lavoro, si affida a
un assunto che è messo in dubbio dall’osservazione empirica dei processi
produttivi nelle aree di nuova industrializzazione: vale a dire la persistenza
di un divario di produttività tra lavoratori e fabbriche nel Sud e nel Nord
del mondo. […] Più si approfondisce il processo di globalizzazione
economica, più si espande l’interpenetrazione delle reti di produzione e
gestione al di là dei confini, e più stretti divengono i collegamenti tra le
condizioni della forza lavoro nei diversi paesi, posti a livelli diversi di
retribuzione e tutela sociale, ma sempre meno distinti per competenze e
tecnologia» (pp. 275-276). Oggi nelle metropoli globali del capitalismo
contemporaneo sempre più è possibile osservare – con intensità e
gradazioni estremamente differenti – l’intero spettro delle forme
contemporanee della produzione e del lavoro. Non è questa la sede per
approfondire la validità euristica della categoria di “divisione cognitiva del
16
lavoro”. Sicuramente, se non si vuole riproporre immagini che ricalcano la
diffusa quanto dubbia idea di un “postfordismo occidentale” che si alimenta
di un “fordismo periferico”, è necessario che l’ipotesi del capitalismo
cognitivo cerchi le sue verifiche ed eventuali correzioni all’interno delle
coordinate spazio-temporali disegnate dai processi di unificazione del
mercato mondiale e di gerarchizzazione della forza lavoro transnazionale.
4. L’ipotesi cognitiva nella ricerca sul campo
I lavori di ricerca sul campo qui presentati – dando concretamente corpo
quell’indicazione metodologica di Marchisio orientata all’inchiesta che
costituisce il fondamento dello stile operaista e della produzione teorica
post-operaista – restituiscono proprio la dimensione globale dei processi
qui analizzati: come abbiamo visto, infatti, nel dissolversi della tradizionale
dialettica tra centro e periferia, qualsiasi ipotesi sulle trasformazioni del
capitalismo contemporaneo deve assumere il farsi uno del mondo.
Migrazioni e mobilità del lavoro si rivelano centrali, come mostra in modo
convincente Ong decostruendo gli ideali del maschio americano middle
class. E nelle nuove geografie spazio-temporali del capitale globale, ci
suggeriscono i saggi basati sul fieldwork, titoli di istruzione e confini,
ovvero scuole, università e stati, diventano innanzitutto dispositivi di
regolazione (perlopiù artificiale, potremmo dire seguendo la grammatica
dei teorici dell’ipotesi cognitiva) del valore di una forza lavoro
transnazionale e flessibile. Studiando il caso del «triangolo della ricerca»
del North Carolina, Anna Curcio – aprendo un campo di ricerca in parte
inedito nella letteratura socio-lavorista italiana – legge il passaggio dalle
fabbriche “fordiste” alle “fabbriche della conoscenza” alla luce della
produzione della razza. Perciò non solo la «linea del colore» non è separata
dai rapporti di produzione, ma al contrario è attraverso essa che si
modulano le linee del lavoro e dello sfruttamento. In altri termini, le
attitudini relazionali, linguistiche, affettive e cooperative della forza lavoro
contemporanea, descritte con precisione nei saggi di apertura del volume,
vengono qui gerarchizzate per mezzo della loro etnicizzazione: le
differenze, spesso evocate come fonte di trasformazione radicale, possono
quindi essere messe a valore nei circuiti dell’accumulazione capitalistica. In
questo quadro, il saggio di Curcio rileva come il management aziendale
vada di pari passo con il management della razza, in una scala che va dalla
whiteness alla blackness in cui si determinano i processi di inclusione
subordinata della forza lavoro latinos.
17
Dentro la globalizzazione, infatti, anche la dialettica tra dentro e fuori va
fecondamene ripensata: il saggio di Xiang Biao sulle migrazioni dalla Cina
verso Giappone, Corea del Sud e Signore, ossia in una macro-area centrale
per comprendere i mutamenti del capitale globale, non dipingono uno
scenario di esclusione, ma piuttosto di quella che potremmo chiamare
inclusione differenziale (Mezzadra, 2008). Si tratta di una logica che
unifica attraverso la segmentazione, connette frammentando, ricompone gli
spazi dividendo e gerarchizzando le figure del lavoro. Come già nel saggio
di Ong, anche Xiang mostra come la stessa definizione dello skill tende a
perdere valore descrittivo dell’attività svolta per assumere principalmente
una funzione di divisione, ovvero di controllo. Basti pensare – ritornando
all’esempio del circuito globale della produzione hi-tech – al già citato caso
dei body shop, dei “tecnomigranti” indiani e di Sajit: la loro definizione in
quanto lavoratore high skill o low skill non risponde tanto all’attività svolta
e alle capacità che possiede, quanto innanzitutto alle necessità di ricatto
delle imprese attraverso la politica dei visti. Anche la certificazione delle
competenze, dunque, funzionano come moltiplicazione dei confini salariali
e di segmentazione ed etnicizzazione della forza lavoro globale. La
formazione, ci suggerisce allora Xiang, diviene tecnologia di governo della
mobilità del lavoro, di inclusione differenziale appunto.
Ma i soggetti produttivi tendono continuamente a sfuggire alla
produzione di tali confini, anch’essi sempre più mobili e flessibili, per
mettere in tensione le nuove geografie del capitale globale. Così, se Xiang
descrive le nuove forme di governance transnazionale, Curcio e Andrew
Ross ne mostrano l’intima fragilità di fronte alla mobilità del lavoro vivo e
alle sue forme di resistenza. Il disimpegno della responsabilità aziendale nei
confronti dei lavoratori, su cui ci si è a lungo soffermati negli ultimi anni e
ancor più nell’avanzare della crisi nei termini di un deterioramento etico
(Gallino, 2005), cessa di essere un processo unilaterale: l’infedeltà del
lavoro vivo rispetto alle imprese – cioè lo sciogliersi dei vincoli di lealtà e
responsabilità che sono stati la base del compromesso fordista così come
dei processi di disciplinamento e interiorizzazione dell’etica del lavoro –
costituisce esattamente l’altra faccia della medaglia. La mobilità del
capitale globale si trova così, come in uno specchio, a fronteggiare un
lavoro vivo altrettanto mobile e globale (Ross, 2006): paradossalmente,
allora, il principale problema delle corporation transnazionali non è oggi
quello di aumentare la flessibilità della forza lavoro, ma di fidelizzarla.
Arriviamo qui, dunque, al nodo della precarietà, uno dei temi centrali
delle pratiche dei movimenti sociali in Italia e in Europa nell’ultimo
decennio: Ross tenta di tradurne i lessici al di fuori del vecchio continente,
mettendo correttamente in evidenza i problemi e il rischio che restino
18
confinati all’interno delle istanze di riconoscimento dei knowledge worker.
In questo quadro, comunque, la flessibilità emerge in tutta la sua
ambivalenza: affonda le proprie radici nella «rivolta contro il lavoro» prima
ancora che nelle tecnologie di governo capitalistiche, che semmai ne
rappresentano la risposta. È ciò che già avevano messo in evi,denza come
precedentemente sottolineato, sul finire degli anni Novanta Luc Boltanski
ed Ève Chiappello (1999), autori con cui proficuamente dialoga il saggio di
Lazzarato: in un voluminoso e accurato studio sulla letteratura del
management aziendale, hanno infatti mostrato come la categoria di
flessibilità ricorra in ugual misura negli anni Settanta e nel decennio loro
coevo, ma con un segno completamente rovesciato. Da minaccia al sistema
del lavoro salariato e alla stabilità delle gerarchie di potere, passata la
grande paura delle lotte, del sabotaggio e dell’assenteismo di massa, la
flessibilità è diventata per il management parola d’ordine obbligatoria e
ricetta salvifica delle politiche del lavoro. Nella metamorfosi semantica
descritta dai due sociologi francesi non vi è la semplice constatazione di
una generica possibilità di leggere lo stesso fenomeno da più punti di vista.
Emerge piuttosto la genealogia conflittuale del lavoro flessibile, all’interno
dello scontro tra pratiche di autonomia e processi di precarizzazione. Essa
ci permette di fare un passo oltre la semplice constatazione della
«modernità liquida» (Bauman, 2002), né d’altro canto si rappresenta solo
come un «Giano bifronte», attraversato da una linea progressiva che deve
liberarsi dai rischiosi contraccolpi della «modernità riflessiva» (Beck,
2000). È perciò necessario ripartire dalla genealogia del lavoro precario per
indagarne la sua nuova antropologia politica e le sue lotte contro i processi
di declassamento. Da questo punto di vista, la rete è anche forma
organizzativa delle nuove figure del lavoro. E se Formenti, come aveva già
fatto in precedenti lavori (Formenti, 2002), è critico rispetto
all’individuazione delle figure del conflitto e dell’organizzazione delle
lotte, a partire dall’attività di networking si possono costruire, secondo
Ross, quelle che lui chiama «coalizioni» tra differenti soggetti di classe.
Il problema, che assume carattere politico prima ancora che teorico,
rimane aperto: è la questione della produzione di soggettività dentro la
nuova composizione del lavoro vivo. Vari altri nodi e domande si
dischiudono a partire dall’ipotesi del capitalismo cognitivo e dai saggi qui
presentati. Come cambia, ad esempio, l’organizzazione di impresa laddove
muta radicalmente la classica formula trinitaria, cioè salario, profitto e
rendita, ovvero si sostiene che la creazione del plusvalore passi attraverso
la cattura della cooperazione sociale? Il concetto di ciclo produttivo ed
economico può ancora essere utilizzato, oppure in che modo deve essere
ridefinito alla luce della crisi globale? Come la «tendenza imperfetta alla
19
sussunzione reale» di cui parla Vercellone ci permette di leggere il
paradigma della cognitivizzazione al di fuori di una successione lineare e
progressiva di tempi e spazi dei modelli produttivi? È possibile ripensare il
welfare, tema su cui da tempo si confronta una parte importante della
letteratura sociologica (Paci, 2005; Castel, 2004), a partire dalle domande
poste dalle nuove figure del lavoro e dai movimenti che animano la
società? Infine, la questione del comune può qui uscire dall’evocazione per
diventare materia di inchiesta, connessa alle trasformazioni del lavoro e alla
sua qualità di auto-organizzazione, cioè alla capacità di costruire nuove
istituzioni dentro la crisi della governance contemporanea. Tali domande,
tra le molte che ancora si potrebbero porre, possono servire ad approfondire
la discussione attorno all’ipotesi del capitalismo cognitivo e, soprattutto,
alle questioni che esso solleva. Ad ogni buon conto, al di là di tale verifica
critica, nella misura in cui questo volume può contribuire a porre tali
interrogativi dentro la disciplina socio-lavorista, può dire di aver raggiunto
un importante obiettivo.
Bibliografia
Aglietta M. (2001), “Regolazione e crisi del capitalismo”, in Aglietta M., Lunghini
G., Sul capitalismo contemporaneo, Torino, Bollati Boringhieri.
Amendola A., Bazzicalupo L., Chicchi F., Tucci A., a cura di (2008), Biopolitica,
bioeconomia e processi di soggettivazione, Macerata, Quodlibet.
Bauman Z. (2002), Modernità liquida (2000), trad. it. Roma-Bari, Laterza.
Bazzicalupo L. (2006), Il governo delle vite. Biopolitica ed economia, Roma-Bari,
Laterza.
Beck U. (2000), La società del rischio. Verso una seconda modernità (1986), trad.
it. Roma, Carocci.
Boltanski L, Chiappello È. (1999), Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard.
Boltanski L. (2002), Una nuova componente dello spirito del capitalismo, in
Agalma n° 3, giugno 2002; pp. 9-21.
Boltanski L., Chiappello E. (1999), Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard.
Boltanski L., Thevenot L. (1991), De la justification: les économies de la grandeur, Paris, Gallimard.
Borghi V., Chicchi F. (2007), “Genealogie dell’employability. Appunti per una
sociologia economica del lavoro”, in Laville J-L., La Rosa M., a cura di, La
sociologia economica europea. Un percorso italo-francese, Milano, Franco
Angeli; pp. 115-130.
Boyer R. (2007), Fordismo e Postfordismo. Il pensiero regolazionista, Milano,
UBe.
Castel R. (2004), L’insicurezza sociale. Che significa essere protetti? (2003),
Torino, Einaudi.
Castel R., L’insicurezza sociale, Einaudi, Torino, 2004.
20
Castel R., Les Métamorphose de la question sociale. Une chronique du salariat,
Fayard, Paris, 1995.
Castells M. (2008), La nascita della società in rete (1996), trad. it. Milano,
Università Bocconi Editore.
Castells M. (2008), La nascita della società in rete, Milano, Egea.
Chiapello E. (1998), Artistes versus managers. Le management culturel face à la
critique d’artiste, Paris, Métailié.
Chicchi F. (2003), Lavoro e capitale simbolico, Milano, Franco Angeli.
Chignola S. (2006), “L’impossibile del sovrano. Governamentalità e liberismo in
Michel Foucault”, in Chignola S. (a cura di), Governare la vita, Verona, Ombre
Corte.
Codeluppi V. (2008), Il biocapitalismo. Lo sfruttamento integrale di corpi, cervelli
ed emozioni, Torino, Bollati Boringhieri.
Deleuze G. (2007), Che cos’è un dispositivo?, Napoli, Cronopio.
Florida R. (2003), L’ascesa della nuova classe creativa. Stile di vita, valori e
professioni (2002), trad. it. Milano, Mondadori.
Florida R. (2006), La classe creativa spicca il volo. La fuga dei cervelli: chi vince
e chi perde (2006), trad. it. Milano, Mondadori.
Foucault M. (2004), Sicurezza, territorio, popolazione, Milano, Feltrinelli.
Foucault M. (2005), Nascita della biopolitica, Milano, Feltrinelli.
Fumagalli A. (2007), Bioeconomia e capitalismo cognitivo. Verso un nuovo
paradigma di accumulazione, Roma, Carocci.
Fumagalli A., Mezzadra S., a cura di (2009), Crisi dell’economia globale. Mercati
finanziari, lotte sociali e nuovi scenari politici, Verona, ombre corte.
Gallino L. (2005), L’impresa irresponsabile, Torino, Einaudi.
Gorz A. (2003), L’immateriale. Conoscenza, valore e capitale (2003), trad. it.
Torino, Bollati Boringhieri.
Harvey D. (1993), La crisi della modernità, Milano, Il Saggiatore.
Kumar K. (2000), Le nuove teorie del mondo contemporaneo. Dalla società postindustriale alla società post-moderna, Torino, Einaudi.
La Rosa M., a cura di (2004), Il lavoro nella sociologia, Roma, Carocci.
Lianos M. (2005), Il nuovo controllo sociale, Avellino, Elio Sellino Editore.
Marazzi C. (2005), Capitalismo digitale e modello antropogenetico di produzione,
in Chicchi F., Laville J.-L., La Rosa M. e Marazzi C., a cura di, Reinventare il
lavoro, Roma, Sapere 2000.
Marazzi C. (2009), Finanza bruciata, Bellinzona, Casagrande.
Marzocca O. (2007), Perché il governo. Il laboratorio etico-politico di Foucault,
Roma, Manifestolibri.
Melucci A. (1994), Passaggio d’epoca, Milano, Feltrinelli.
Mezzadra S. (2008), La condizione postcoloniale: storia e politica nel presente
globale, Verona, Ombre Corte.
Miller J.-A. (2006), Pezzi staccati. Introduzione al Seminario XXIII “Il sinthomo”,
Roma, Astrolabio.
Paci M. (2005), Nuovi lavori, nuovo welfare. Sicurezza e libertà nella società
attiva, Bologna, Il Mulino.
Perniola M. (2002), Prova di forza o prova di grandezza? Considerazioni
sull’agalma, in Agalma n° 3, giugno 2002; pp. 62-79.
Rizza R. (1999), Istituzioni sociali e vita economica, Milano, Franco Angeli.
Roggero G. (2009), La produzione del sapere vivo, Verona, Ombre corte.
Roggero G. (2009), La produzione del sapere vivo. Crisi dell’università e
trasformazione del lavoro tra le due sponde dell’Atlantico, Verona, ombre corte.
21
Ross A. (2003), No-Collar: The Human Workplace and Its Hidden Costs, New
York: Basic Books.
Ross A. (2006), Fast Boat to China: Corporate Flight and the Consequences of
Free Trade: Lessons from Shangai, New York: Pantheon Books.
Rullani E. (2004), La fabbrica dell'immateriale. Produrre valore con la
conoscenza, Roma, Carocci.
Vercellone C., a cura di (2006), Capitalismo Cognitivo, Roma, Manifestolibri.
Xiang B. (2007), Global “Body Shopping”: An Indian Labor System in the Information Technology Industry, Princeton: Princeton University Press.
22