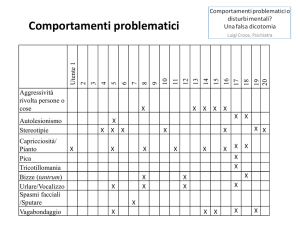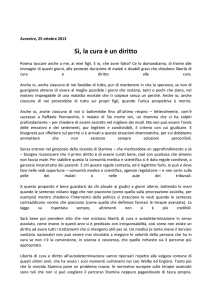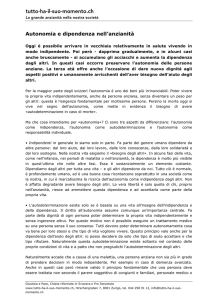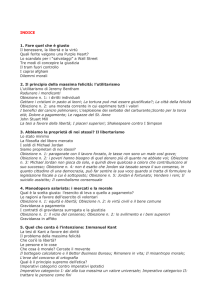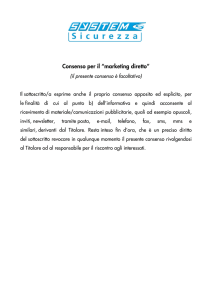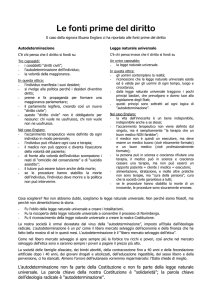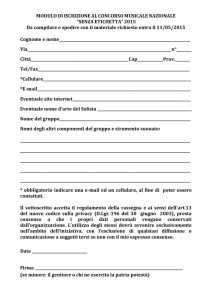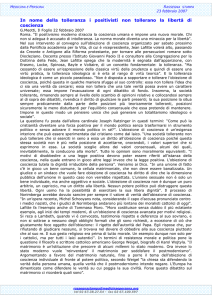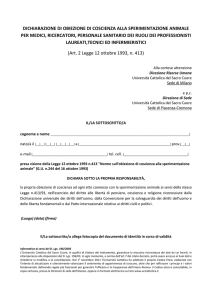Resoconto del Seminario interno “Per un diritto della dignità del morire”1
Università degli Studi di Bergamo - 12 settembre 2012
Presenti al Seminario: Marco Azzalini (diritto privato), Antonio Banfi (diritto romano), Carlo
Alberto Defanti (neurologo), Cristina Costantini (diritto privato comparato), Giuseppe Fornari
(filosofia analitica), Benedetta Manfredonia (diritto privato), Viviana Molaschi (diritto
amministrativo – diritto sanitario), Barbara Pezzini (diritto costituzionale), Roberto Pucella (diritto
privato), Persio Tincani (filosofia del diritto), Stefano Tomelleri (sociologia generale)
Massimo Foglia (dottorando diritto civile), Stefano Rossi (dottorando diritto costituzionale)
Daniela Barbierato (diritto privato), Ivo Lizzola (pedagogia sociale), Silvio Troilo (diritto
costituzionale) – assenti per impegni accademici
Il Seminario interno – interdipartimentale – è stato introdotto dalla prof.ssa Pezzini, che ha
sottolineato come la proposta-manifesto lanciata dal prof. Zatti (e di cui è stata con il prof. Defanti
tra i primi firmatari) abbia offerto uno stimolo prezioso per promuovere un’occasione di incontro e
discussione tra diversi colleghi che nell’ateneo bergamasco si sono nel corso del tempo ampiamente
interessati ai temi in oggetto, ciascuno nello specifico dei propri percorso disciplinari; le tematiche
che investono la fine della vita sono, infatti, necessariamente complesse, involgendo l’interesse e
rendendo indispensabile il contributo delle varie branche del diritto nell’ambito di un dialogo
virtuoso con altre discipline scientifiche (dalla medicina, alla sociologia alla filosofia).
Le modalità in cui si discute e si sperimenta la morte nella società odierna mettono difatti in gioco
diverse responsabilità, competenze e ruoli, che vengono ridefiniti nell’ambito di percorsi
interdisciplinari. In tale prospettiva dal confronto nasce un’occasione per realizzare un’opera
euristica volta a chiarire il significato (o almeno tentarvi) di concetti fondamentali nello
svolgimento di un discorso compiuto su tematiche così delicate, affrontando il problema di
scambiare “parole tra noi così diverse” (citando Zatti) e renderle reciprocamente intellegibili.
Successivamente è intervenuto il prof. Defanti che, nel ricordare la sua lunga esperienza di
neurologo, ha messo in luce come, nella pratica clinica, l’orgoglioso concetto di autodeterminazione
trovi difficoltà ad affermarsi nella sua versione ‘forte’ (ideale), scontrandosi con le debolezze e le
fragilità umane dei malati e degli stessi medici. Si dovrebbe quindi riconoscere una maggiore
appropriatezza e conformità al reale della versione ‘debole’ dello stesso principio, il che non
significa ridurre o limitare i diritti del paziente, ma convenire che spesso esso si esplica solo come
Il resoconto del seminario è stato redatto dal dott. Rossi che, pur tentando di riportare fedelmente il pensiero degli
interventori, si assume la responsabilità della sintesi di discorsi chiaramente più articolati e complessi.
1
semplice espressione di una scelta, che non presuppone la complessa costruzione di un vasto
patrimonio ideale.
Avendo seguito il percorso terapeutico di molti malati di Sla, Defanti ha sottolineato come le idee
del paziente riguardo agli interventi inerenti la sua salute evolvano e mutino con l’avanzare della
malattia. Ciò rende necessario approntare modalità e forme di espressione della loro volontà agili,
snelle e capaci di adattamento: se vi sono infatti persone che esprimono convinzioni incrollabili (di
libertà) di fronte alla malattia e alle limitazioni che ne derivano, ve ne sono altre che, in determinate
condizioni, tendono ad adattarsi al loro stato, accontentandosi di ciò che il corpo e la mente
consente loro di realizzare. Per cui si deve tener conto dei profili attinenti all’esperienza di ogni
singolo individuo, del suo contesto sociale, culturale e familiare.
Le disposizioni di fine vita (o meglio direttive anticipate) debbono essere vincolanti e, in sostanza,
già lo sono per i soggetti coscienti e competenti, la cui espressione di autodeterminazione (il cd.
dissenso terapeutico) deve essere rispettato. Ogni trattamento sanitario per essere legittimo
presuppone il valido consenso di chi vi si sottopone.
I problemi più gravi sorgono quando il paziente è in stato di incoscienza (temporanea o
permanente), in particolare in relazione al profilo dell’attualità delle direttive sanitarie che, specie in
occasione di percorsi di malattia prolungati (anche di decenni), potrebbero non essere più conformi
agli sviluppi della scienza medica e della tecnologia. Tuttavia, a tale ostacolo materiale, può essere
posto rimedio attraverso la delega e la nomina di un fiduciario, il cui ruolo sia quello di ricreare
quel dialogo – divenuto impossibile – tra paziente e medico, dando voce alle aspirazioni e alla
visione del mondo e della vita del primo.
Nella fisiologia dei casi, il percorso di affermazione dell’autodeterminazione dovrebbe svilupparsi
attraverso un dialogo franco e ragionato tra il medico curante (specie il medico di famiglia) e il
paziente, è nell’ambito di questo percorso che si potrebbe dar modo all’individuo di maturare, in
modo consapevole e informato, le proprie determinazioni.
Quindi è intervenuto il prof. Tincani, il quale riprendendo il filo del discorso di Defanti, ha posto
l’accento sulla drammaticità e sulle conseguenze perverse a cui si andrebbe incontro qualora ci si
‘arrendesse’ all’idea di una versione debole del principio di autodeterminazione. Se è pur vero che
esso di adatta alla condizione del singolo (alla sua fragilità culturale o sociale), tuttavia nel percorso
di definizione e chiarificazione dei concetti – specie qualora questi debbano costituire il nucleo del
tessuto normativo regolante la materia – si deve tendere a darne la visione più chiara e
l’interpretazione più rigida, in modo da evitarne l’espandersi di discrezionalità ed arbitrio
nell’applicazione. Definire malamente, in modo lasco, i concetti rilevanti in quest’ambito ne
comporta un’applicazione arbitraria. Così, ad esempio, la definizione che diamo della cura si riflette
sul concetto stesso di malattia e conseguentemente viene a delimitare o ampliare gli spazi stessi
della libertà di ognuno.
È seguito quindi l’intervento del prof. Pucella, il quale, discutendo con alcuni medici legali
padovani, che pur mostravano di avere un’idea chiara e moderna del problema delle scelte di fine
vita, ha notato come dai loro discorsi emergesse una radicata concezione di tipo organicistico della
salute e dell’opera del medico come garante della tutela del benessere organico della persona; il che,
nel contesto del fine vita, si traduce nella semplice protrazione della vita biologica a prescindere dal
contesto biografico in cui si inserisce. Si tratta di un profondo iato (o conflitto) conflitto culturale
che divide i medici dai giuristi, i quali, ispirati anche da una concezione costituzionalmente
orientata, danno per acquisita una nozione di salute come vissuto, ossia come paradigma complesso,
bilanciamento tra mente, spirito e corpo. È logico che, di fronte ad una nozione organicistica della
salute, l’autodeterminazione ne risulti lesa e sminuita, così come avvenuto in alcuni casi, anche
recenti, oggetto dell’attenzione della giurisprudenza.
Salute – come detto – non è solo benessere del corpo, ma anche possibilità di autodeterminarsi. Nel
contempo la protezione dell’autodeterminazione trova dei limiti e delle condizioni nella sua
esplicazione in sede civile o penale: così, ad esempio, in caso di esito fausto dell’intervento, pur in
violazione o in mancanza del consenso, c’è danno ? Sussistono i presupposti per integrare il reato ?
È seguito l’intervento della prof.ssa Pezzini, la quale ha posto in luce il rischio di ridurre il diritto
alla clinica giudiziaria, rischio che può essere scongiurato solo riaffermando il valore complesso del
diritto sociale alla salute come fattore del vissuto individuale e sociale. Far circolare attraverso il
dialogo interdisciplinare interpretazioni e concettualizzazioni che sono ormai acquisiti nel mondo
del diritto, da un lato, consente di definire con maggior sicurezza dimensioni e contesti altrimenti
lasciati alla mercè di parole sentite e utilizzate da ognuno in modo assai diverso, dall’altro, rende
effettiva l’opzione volta ad affermare un diritto prospettico, capace di adattarsi alla realtà, di
introiettare le acquisizioni provenienti dalle altre discipline, senza farsene fagocitare.
La burocratizzazione del consenso informato ridotto a consenso firmato, ad una serie di moduli,
pone i giuristi di fronte ai problemi di relazione che sussistono tra medico, struttura sanitaria e
paziente. In particolare il paziente deve prendere coscienza del suo nuovo ruolo, non più di passivo
fruitore delle prestazioni sanitarie, ma di attivo interprete, nel confronto con il medico, delle sue
esigenze di salute.
Con un breve intervento la prof.ssa Manfredonia ha ricordato come, già solo nei racconti dei suoi
nonni, emergesse una diversa visione e approccio al morire, un accadimento che veniva considerato
naturale e reso sociale attraverso determinate liturgie. In un periodo in cui i medici (specie quelli di
famiglia), un po’ tuttologi un po’ demiurghi, non si sottraevano al compito di consentire al malato,
specie quello anziano, di affrontare la morte con serenità e senza sofferenza. Nella realtà odierna, a
fronte dell’individualizzazione del rapporto sanitario, diviene più complesso definire i ruoli, gestire
le responsabilità e soprattutto assumersele, è quindi compito del diritto cercare di dare risposte
nuove a domande antiche.
Interveniva quindi il prof. Azzalini che sottolineava come la proposta lanciata dal prof. Zatti si situi
in un orizzonte ideale di grande spessore culturale rispetto alle miserie della politica e dei suoi
prodotti legislativi (ddl Calabrò), tuttavia per definire una disciplina in questo campo è necessario
chiarire alcune questioni: è indubbio che l’interesse rapsodico e strumentale della politica per questi
temi si manifesti solo nei momenti di crisi (caso Welby, Englaro) o per finalità biecamente
elettorali, ma ciò non consente di abbandonare la politica a sé stessa, essendo primario riaprire un
canale di dialogo, superare le differenze di linguaggio (che non vi sono solo tra medico e paziente)
per affrontare un problema che è prima di tutto di carattere culturale.
Un limite culturale, che nel campo del diritto civile, si manifesta per mezzo di quelle posizioni che
intendono affrontare il problema del fine vita attraverso le categorie del patrimoniale (l’utilizzo del
concetto di testamento biologico è paradigmatico), laddove invece sono in gioco diritti
personalissimi. Appare pertanto necessario adeguare o ripensare una serie di concetti giuridici,
come quello di atto giuridico che si può esprimere ed integrare anche attraverso il contegno auto
determinativo del paziente.
In tal senso categorie come consenso, azione e omissione (per dirne alcune) devono essere ripensate
in funzione del senso degli eventi, del contesto e degli sviluppi del sentire sociale e della stessa
innovazione tecnologica. In particolare un intervento normativo che voglia essere completo
dovrebbe affrontare la questione del binomio azione/omissione in relazione alla rifiutabilità di ogni
genere di trattamento (senza giochi semantici come avvenuto con la definizione di alimentazione
artificiale) per evitare il ripetersi di drammi come quelli affrontati dal dott. Riccio nel caso Welby.
Vi è poi una questione da definire con attenzione, ossia le modalità di nomina del fiduciario e la
limitazione dei suoi poteri nel caso di soggetto incapace (ma su questo si fa solo un accenno).
Più in generale le questioni sollevate non riguardano solo ed esclusivamente la tematica del fine
vita, ma investono ogni genere di trattamento (compreso quello relativo alla gestione dei dati
personali), nella misura in cui è necessario scongiurare che un intervento pervasivo di terzi possa
spogliare il soggetto dei suoi diritti.
È seguito l’intervento del prof. Tomelleri il quale, nell’ambito delle sue indagini empiriche svolte
nei reparti di terapia intensiva, ha riscontrato come, pur in mancanza di interventi normativi, si
siano definite strategie e prassi virtuose in grado di garantire la dignità del morire; tuttavia si tratta
di situazioni a macchia di leopardo che differiscono in funzione del fatto che i vuoti giuridici sono
compensati da pieni culturali; i problemi permangono invece ove vi sono vuoti culturali o conflitti
di valori, in questi casi appare necessario avere delle direttive chiare.
È sotto gli occhi di tutti che si assiste ad un fenomeno di medicalizzazione della vita che porta (in
quasi tutti i casi) a terminare la propria vita in ospedale, in particolare nei reparti di terapia
intensiva, in cui i medici si trovano a dover rispondere ad esigenze esistenziali, sociali, culturali e di
carattere burocratico (gestione degli spazi e dei tempi del fine vita) che creano un sovraccarico non
sostenibile. Si deve rilevare comunque come le prassi sanitarie non possano essere sostituite o
surrogate da disposizioni legislative, le quali eventualmente potrebbero definire il quadro di
sistema, ove queste potrebbero trovare collocazione e legittimazione.
Oltre al profilo organizzativo (essenziale in questo ambito), sono determinati: la formazione dei
medici che, nell’affrontare il fine vita, non possono limitarsi ad utilizzare il bagaglio delle loro
conoscenze cliniche e scientifiche, dovendo integrarle con strumenti forniti dalle analisi delle
scienze sociali e umanistiche. Forse un corso di letteratura, nelle facoltà di medicina o nei corsi di
specializzazione, consentirebbe ai medici di apprendere quella parole (non più così diverse) tali da
consentire loro di comunicare, con umanità, con il paziente. Altro punto è quello relativo alla
collegialità delle scelte; si rende indispensabile superare la visione medicocentrica, dando un ruolo
agli infermieri i quali sono i primi a farsi carico della persona, dei suoi bisogni e anche delle
aspettative e ansie dei familiari. In questo senso una collaborazione più stretta tra medici e
infermieri (quali testimoni privilegiati e primi ricettori di informazioni essenziali) renderebbe più
semplice il dialogo con il paziente, la definizione di quel percorso verso la fine della vita in
conformità con la volontà di quest’ultimo.
Un ultimo punto di cui si deve tener conto è il mutato ruolo delle famiglie e della loro struttura
interna (non più patriarcale, non più monolitica), il che, in mancanza di chiare direttive, rende
difficoltosa l’individuazione dei soggetti a cui riferirsi per condividere determinate scelte, per
ricostruire la storia del paziente.
Successivamente è intervenuta la prof.ssa Molaschi, che ha focalizzato il suo intervento sulla
dimensione organizzativa delle scelte di fine vita. Il problema è “dove” e “come” dare attuazione a
tali scelte. Emblematica e paradossale è stata l’odissea che ha visto coinvolta Eluana Englaro, il cui
padre non riusciva a trovare una struttura in cui procedere al distacco del sondino nasogastrico.
Le strutture sanitarie dovrebbero rispettare il diritto all’autodeterminazione terapeutica sia quando
questo implichi un dovere di cura “in positivo” (un dare prestazioni) sia quando questo comporti un
dovere di astensione, qualora il soggetto opti invece per negare il proprio consenso ai trattamenti (in
questo caso, però, sussiste pur sempre un dovere di accompagnamento e accudimento della persona
durante il periodo successivo alla sospensione del trattamento di sostegno vitale).
Il diritto del paziente di rifiutare determinati trattamenti c.d. salva vita può trovare un ostacolo alla
sua realizzazione nel diritto all’obiezione di coscienza (sulla cui natura di diritto inviolabile vi sono
diatribe in dottrina). Questo aspetto, che si correla all’organizzazione del personale, costituisce un
elemento di cui tener conto nel disciplinare la materia. L’esperienza applicativa della l. 194/1978 ci
fornisce un esempio plastico di come determinate questioni debbano essere affrontare per non
degenerare in patologie del sistema.
Per superare questi problemi, l’organizzazione deve divenire luogo di confronto delle diverse
visioni etiche al fine di rinvenire un punto di equilibrio che garantisca al contempo i diritti
individuali del paziente e l’esercizio dell’obiezione di coscienza del medico, la quale deve essere
“giuridicamente sostenibile” (v. il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica del luglio 2012) e
conseguentemente organizzativamente sostenibile. Nel regolamentare la materia del fine vita
sarebbe necessario tener conto anche di tali aspetti.
Facendo seguito a tali riflessioni è intervenuta la prof.ssa Pezzini che ritiene necessario porre in
discussione le fondamenta e la legittimità del cd. diritto all’obiezione di coscienza nell’ambito della
relazione terapeutica di cui il medico è parte integrante ed essenziale. La tutela costituzionale della
salute è volta infatti a garantire la relazione tra l’individuo e un soggetto portatore di specifiche
conoscenze (il medico) e il bene oggetto della relazione è un bene personalissimo del paziente, anzi
un diritto fondamentale della persona, che non è quindi oggettivabile né paragonabile a quello
oggetto di altre prestazioni professionali. In questa prospettiva il medico diviene strumento di
inveramento di un diritto costituzionalmente garantito (ossia quello all’autodeterminazione, al
dissenso terapeutico), il che deve necessariamente limitare lo spazio concesso all’espressione della
facoltà concessagli di esercitare l’obiezione di coscienza.
Un’obiezione al ragionamento suddetto è venuta dal prof. Pucella, il quale ha sottolineato come la
prestazione (positiva o astensiva) di tipo sanitario sia contrattualmente dovuta e fornita al paziente
dall’ente ospedaliero o dalla struttura di cura privata, il che comporta un onere a carico di queste
ultime volto a garantire l’attuazione del diritto del paziente, tutelando lo spazio per l’obiezione da
parte dei medici dipendenti.
Infine è intervenuto il prof. Fornari, il quale ha sottolineato che il suo contributo è strettamente
inerente alla sua formazione nell’ambito della filosofia analitica. Dopo aver ripercorso le strategie
elaborate nel mondo antico per semantizzare il lutto e l’evento morte, ne ha rilevato l’enorme
distanza rispetto a quelle proprie delle società contemporanee, notandone in alcuni casi la mancanza
ovvero un prospettiva afasica. Per quanto le strutture del vivere e del morire non abbiano più la
stessa efficacia di un tempo, Fornari ritiene che – nel prevedere una disciplina del fien vita – non si
debba incorrere nell’errore di adottare un metodo logico-deduttivo, facendo discendere dall’empireo
dei principi generali soluzioni che si potrebbero prospettare come troppo rigide e non adattabili alla
concretezza dell’umano e alle sue fragilità intrinseche. L’applicazione del meccanismo logico
deduttivo sconta la distanza e prescinde dal dato culturale e dal profilo assiologico che connota la
persona umana. Il formalismo, specie nell’ambito giuridico, potrebbe divenire fuorviante, laddove –
in questi ambiti – la percezione che deve prevalere è quella del particolare irripetibile, che si snoda
a partire dalla centralità esistenziale della persona. Si deve ripartire dalla verità esistenziale per
dettare le regole sul fine vita, rovesciando la piramide del ragionamento logico deduttivo; in questo
senso un contributo fattivo può venire dalla giurisprudenza, dai giudici comuni quali artefici di un
diritto di prossimità.
All’esito dell’incontro, la prof.ssa Pezzini, dopo aver rilevato i numerosi spunti di grande interesse
emersi nel corso della discussione, ha ricordato ai presenti l’incontro fissato per il 25-26 ottobre a
Trento. La data di un secondo – allo stato ancora eventuale – secondo appuntamento, prima del
convegno trentino, verrà comunicata a tutti via mail.