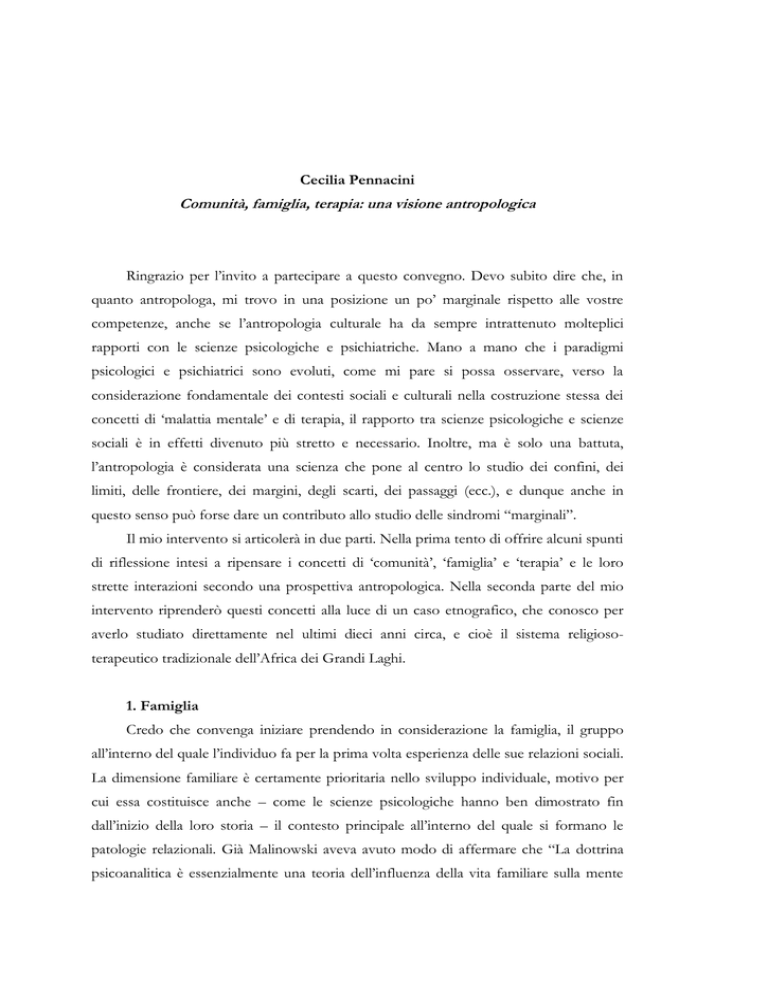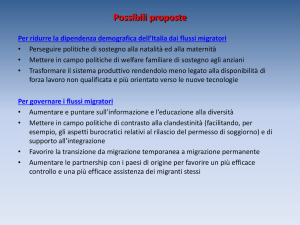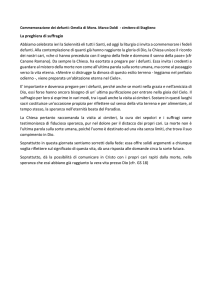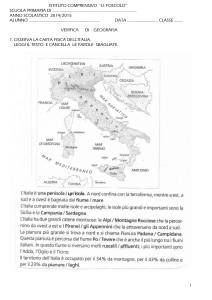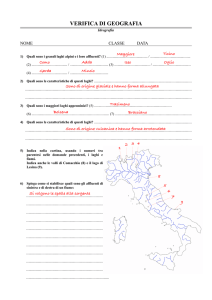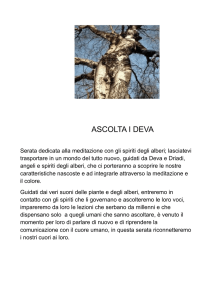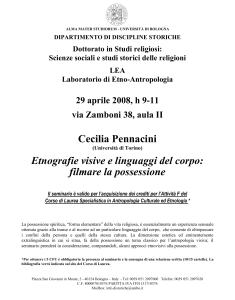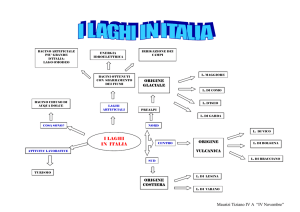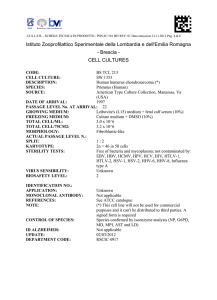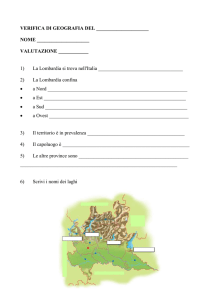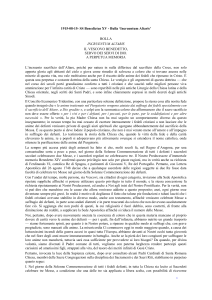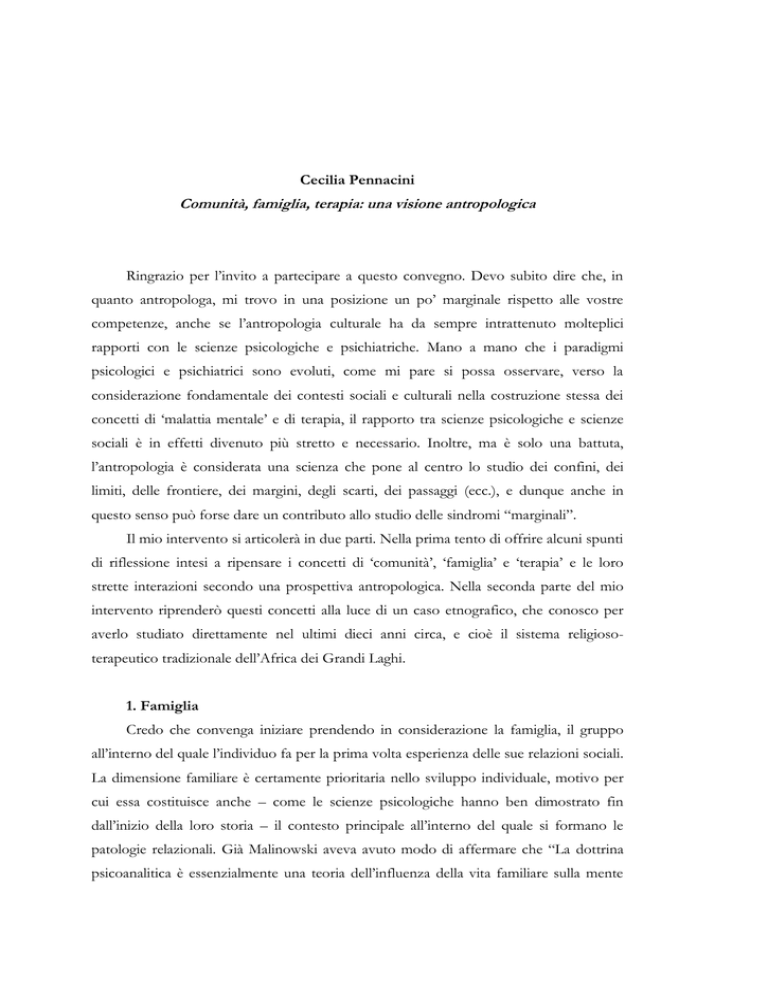
Cecilia Pennacini
Comunità, famiglia, terapia: una visione antropologica
Ringrazio per l’invito a partecipare a questo convegno. Devo subito dire che, in
quanto antropologa, mi trovo in una posizione un po’ marginale rispetto alle vostre
competenze, anche se l’antropologia culturale ha da sempre intrattenuto molteplici
rapporti con le scienze psicologiche e psichiatriche. Mano a mano che i paradigmi
psicologici e psichiatrici sono evoluti, come mi pare si possa osservare, verso la
considerazione fondamentale dei contesti sociali e culturali nella costruzione stessa dei
concetti di ‘malattia mentale’ e di terapia, il rapporto tra scienze psicologiche e scienze
sociali è in effetti divenuto più stretto e necessario. Inoltre, ma è solo una battuta,
l’antropologia è considerata una scienza che pone al centro lo studio dei confini, dei
limiti, delle frontiere, dei margini, degli scarti, dei passaggi (ecc.), e dunque anche in
questo senso può forse dare un contributo allo studio delle sindromi “marginali”.
Il mio intervento si articolerà in due parti. Nella prima tento di offrire alcuni spunti
di riflessione intesi a ripensare i concetti di ‘comunità’, ‘famiglia’ e ‘terapia’ e le loro
strette interazioni secondo una prospettiva antropologica. Nella seconda parte del mio
intervento riprenderò questi concetti alla luce di un caso etnografico, che conosco per
averlo studiato direttamente nel ultimi dieci anni circa, e cioè il sistema religiosoterapeutico tradizionale dell’Africa dei Grandi Laghi.
1. Famiglia
Credo che convenga iniziare prendendo in considerazione la famiglia, il gruppo
all’interno del quale l’individuo fa per la prima volta esperienza delle sue relazioni sociali.
La dimensione familiare è certamente prioritaria nello sviluppo individuale, motivo per
cui essa costituisce anche – come le scienze psicologiche hanno ben dimostrato fin
dall’inizio della loro storia – il contesto principale all’interno del quale si formano le
patologie relazionali. Già Malinowski aveva avuto modo di affermare che “La dottrina
psicoanalitica è essenzialmente una teoria dell’influenza della vita familiare sulla mente
umana”, 1927: 27); la psicoanalisi prende in considerazione però un tipo molto specifico
e nient’affatto universale di organizzazione sociale: la famiglia nucleare. L’intero
“dramma freudiano” (Malinowski 1927: 27) si svolge all’interno di questa specifica forma
socio-culturale. Uno sforzo di relativizzazione del concetto di famiglia in quanto parte
essenziale della struttura sociale può forse aiutarci a comprendere come determinate
sindromi potrebbero essersi originate all’interno di forme sociali specifiche.
Parlare di famiglia, da una prospettiva antropologica, significa affacciarsi su uno
scenario straordinariamente complesso e variegato, di fronte al quale è opportuno
domandarsi se esista davvero una famiglia universale o al contrario se le forme di
famiglia non siano così tante e sconcertanti nella loro diversità da mettere in dubbio la
definizione stessa di un concetto generale, con tutte le conseguenze teoriche ed
epistemologiche che si possono trarre da questa posizione.
Come sappiamo, il dibattito su cosa sia o su cosa debba essere una famiglia è oggi
estremamente attuale. Nonostante la tesi ampiamente diffusa (e riproposta anche dalla
costituzione italiana, all’art. 29) della famiglia come “società naturale fondata sul
matrimonio” - l’idea cioè che la famiglia umana (ma che tipo di famiglia?) esista in natura
e sia in qualche modo inscritta nei geni della specie - l’antropologia è oggi unanime nel
presentare invece la famiglia come un costrutto culturale. Non esistono (almeno per
l’antropologia) “famiglie naturali” ma solo modelli culturali di famiglie, estremamente
variabili nel tempo e nello spazio.
Una prima “relativizzazione” del concetto di famiglia rinvia all’opposizione
famiglia estesa – famiglia nucleare. In Occidente quando si parla di famiglia si pensa
immediatamente alla famiglia nucleare composta da due genitori di sesso opposto e dalla
loro prole. Se possiamo ammettere che questa famiglia nucleare rimane il caso più
diffuso nell’Occidente attuale, essa non costituisce invece la forma predominante se
prendiamo in considerazione una dimensione storica e geografica più vasta. In Europa la
famiglia nucleare si diffonde infatti piuttosto tardi, soprattutto in concomitanza con i
fenomeni di urbanizzazione che hanno accompagnato le rivoluzione industriale del
XVIII secolo, e fuori dal primo mondo essa è ancora oggi abbastanza rara. Comuni
invece sono diverse forme di estensione del gruppo domestico in senso orizzontale
(fratelli o sorelle che vivono insieme ai loro coniugi e alla prole) o verticale (matrimoni
patrilocali o matrilocali). Vi lascio immaginare le conseguenze psicologiche di una
situazione familiare dove i bambini fin dalla più tenera infanzia abbiano costantemente a
2
disposizione una molteplicità di figure di riferimento (nutrici, zie, zii, cugini, fratelli,
sorelle, vicini, nonni, prozii, ecc.) i quali scardinano la chiusura della relazione parentale a
favore di una molteplicità di modelli affettivi e identitari. In questa molteplicità, che
spesso è dato di vedere ad esempio nelle famiglie africane, i bambini sembrano in un
certo senso più liberi di scegliersi i propri riferimenti e i propri modelli, in un processo
che potremmo definire “auto-poietico”.
La questione delle relazioni familiari si complica poi ulteriormente se teniamo
conto delle diverse modalità di calcolo della discendenza e sugli effetti che queste scelte
culturali producono sulle relazioni tra le generazioni. Malinowski aveva già chiaramente
mostrato nel famoso volume del 1927 che la presunta universalità del complesso di
Edipo era messa in dubbio dalla diffusione di sistemi di discendenza matrilineari
all’interno dei quali l’autorità maschile non è rappresentata dal padre bensì dallo zio
materno, con tutte le conseguenze psicologiche che questo fatto può comportare. Più in
generale, molte culture incoraggiano una molteplicità di “care-givers”, spesso favorendo
addirittura l’adozione di bambini da parte di zii o altri parenti. E’ ciò che accade ad
esempio nell’isoletta polinesiana di Tikopia, studiata da Raymond Firth. Qui gli indigeni
affermano che “E’ male per un figlio aderire soltanto ai suoi genitori” ed è male che la
famiglia si isoli troppo rispetto al resto della società (cit. in Remotti 2007: 49). E’ positivo
invece spezzare quei legami che rischiano di diventare esclusivi, assorbenti e in qualche
modo anti-sociali. Il bambino deve essere socialmente svezzato al di fuori della famiglia
nucleare, in un contesto di cura più ampio e diversificato, anche semplicemente per
minimizzare i rischi di eventuali relazioni patogeniche.
Esistono dunque molti tipi di famiglia, dalle famiglie monoparentali o matrifocali,
sempre più diffuse in ogni parte del mondo, alle famiglie estese in senso orizzontale o
verticale, a matrimoni tra persone delle stesso sesso (diversi i casi classici, come il berdache
degli indiani delle pianure o il matrimonio tra donne dei Nuer) che prevedono anche
meccanismi che consentono la riproduzione e l’allevamento dei bambini, oppure
matrimoni tra persone con marcate differenze di età (ad es. donne adulte che sposano
lattanti), senza alcuna implicazione sessuale ma con importanti ricadute sociali e
patrimoniali. Ovviamente è importante in questo complesso e bizzarro scenario tener
conto del fatto che in molte delle società cui si è fatto cenno il matrimonio e la famiglia
sono istituzioni fondamentalmente sociali, che poco hanno a che vedere con l’esercizio
3
della sessualità. Tale sfera solo raramente è considerata di pertinenza della materia che
regola la vita matrimoniale e familiare.
2. Comunità
La dimensione della famiglia, fondamentale pur nelle sue differenze nella maggior
parte delle società, si inquadra nella dimensione dei più ampi rapporti sociali definiti da
ambiti economici, occupazionali, politici, di genere, di età, ecc., che nel loro insieme
vanno a comporre la struttura sociale. A questo livello, le scienze sociali hanno
individuato in generale due dimensioni diverse e complementari all’interno delle quali le
relazioni sociali extrafamiliari si dispiegano: la dimensione della comunità e quella della
società più vasta.
In particolare, il concetto di comunità ha avuto grande successo nelle scienze
umane, soprattutto in sociologia e in antropologia. Esso sembra rispondere all’esigenza
di definire e analizzare l’evoluzione dei gruppi sociali, che si muoverebbero dalla
dimensione ristretta della piccola comunità a quella della società più vasta. Il sociologo
tedesco Ferdinand Tönnies introduce a fine ottocento la dicotomia gemeinshaft (comunità)
e gesellshaft (società) per marcare appunto questo passaggio. Se la comunità era vista da
Tönnies come una dimensione sociale caratterizzata da rapporti faccia a faccia, relazioni
concrete vissute in un luogo fisico definito e abbastanza circoscritto (ad esempio un
villaggio), la società è invece una dimensione sociale complessa, fatta di relazioni molto
più ampie, anonime, impersonali, per lo più regolate da una struttura abbastanza rigida e
spesso gerarchica, conflittuale e competitiva. Tönnies inseriva le due dimensioni della
comunità e della società in una prospettiva evolutiva: man mano che i gruppi si
ingrandiscono e si sviluppano, essi abbandonano la vita di comunità per costruire
relazioni sociali sempre più complesse e spersonalizzate.
Nel corso del Novecento l’evoluzionismo culturale, all’interno del quale possiamo
situare questa teoria di Tönnies, verrà abbandonato lasciando il posto a un succedersi di
diverse teorie che rifiutano la prospettiva evolutiva. L’opposizione comunità/società
riemerge, in una prospettiva non più evoluzionistica ma piuttosto strutturalfunzionalistica, presso un autore che diverrà famoso per i suoi studi sul rituale: Victor
Turner. In un famoso volume dedicato appunto al processo rituale (1969), Turner
introduce il concetto di “communitas”, che mutua dai lavori del filosofo ebreo Martin
Buber. Per Turner “communitas” da un lato e società, o meglio struttura sociale,
4
dall’altra non sono due momenti di un’evoluzione storica del gruppo sociale, bensì due
dimensioni essenziali e compresenti in ogni società, strettamente collegate tra loro da un
rapporto di reciproca dipendenza dialettica.
Per Turner, infatti, ogni società si fonda su di una struttura di relazioni complesse,
gerarchiche e spesso competitive, all’interno della quale l’individuo è incardinato e in un
certo senso anche incastrato da forze coercitive; per quanto si possano prevedere talune
forme di mobilità e di creatività, a ciascuno viene in generale assegnato nella società un
ruolo preciso, determinato dal suo status, genere, età, ecc. Tuttavia, Turner mette in luce
come ogni struttura sociale, per poter sopravvivere e riprodursi nel tempo, deve potersi
rigenerare all’interno di un processo dinamico, descritto come una dialettica tra la
struttura e l’antistruttura. In altre parole, nessuna società può permettersi di vivere
costantemente in una dimensione strutturale. E’ sempre necessario prevedere momenti
antristrutturali che consentano alla struttura di rigenerarsi e di mutare e agli individui di
percepire i confini della struttura e il loro ruolo in essa. La ‘communitas’ rappresenta
precisamente questa dimensione anti-strutturale. Buber definisce la comunità: “Il non
essere più fianco a fianco (e si potrebbe aggiungere sopra e sotto) di una moltitudine di
persone, ma l’essere l’uno con l’altro. E questa moltitudine, pur muovendosi verso un
obiettivo, tuttavia sperimenta dappertutto un volgersi a, un dinamico star di fronte degli
altri, un fluire dall’Io al Tu” (Buber, 1961: 51, cit. in Turner 2001: 143). La comunità in
questo caso è la dimensione in cui si sviluppano rapporti di parità, fratellanza,
condivisione profonda e anche emotiva di esperienze sociali fondamentalmente antistrutturali. Come possiamo notare, la comunità in questa concezione si pone in un certo
senso agli antipodi della famiglia, la quale costituisce invece la cellula base della struttura
sociale.
Le comunità di cui ci occupiamo in questo convegno sono naturalmente qualcosa
di molto più specifico, trattandosi di comunità terapeutiche. Tuttavia mi pare si possa
cogliere in esse alcuni aspetti delle teorie cui ho fatto cenno: 1) le comunità terapeutiche
sono infatti ambiti sociali profondamente caratterizzati da rapporti in praesentia, vissuti,
concreti e dunque carichi di contenuti emotivi; 2) esse si contrappongono in certa misura
alla società più vasta dove vigono invece relazioni impersonali, strutturali e gerarchiche;
3) esse vengono proposte come alternativa almeno temporanea alla struttura familiare,
consentendo al paziente di fare esperienza di relazioni che sfuggono alla dimensione
5
strutturale e si dipanano invece in un’atmosfera maggiormente spontanea e antistrutturale.
Se la società più vasta mette l’accento dunque sulla struttura e sulle sue esigenze di
gerarchia e competitività, la comunità (anche quella terapeutica) valorizza invece una
condivisione di esperienze e di valori che, più che dividere le persone ponendole su piani
diversi, tenta di affratellarle e unirle. Ben inteso, le due dimensioni della società e della
comunità risultano entrambe necessarie e complementari e non si pongono mai in
alternativa l’una con l’altra. Ciascun individuo dovrebbe poter fare alternativamente
esperienza della dimensione strutturale e di quella comunitaria, che normalmente si
esprime nei momenti rituali. Le comunità terapeutiche, per quel poco che ho potuto
vedere, ripropongono la dimensioni delle relazioni vissute e concrete in alternativa
(almeno momentanea) alla più vasta struttura sociale. In questa dimensione, coloro che
per ragioni in questo caso patologiche devono essere momentaneamente allontanati dalla
società, hanno la possibilità qui di rigenerare la loro esperienza relazionale attraverso
rapporti di “fratellanza”. La dimensione antigerarchica e antistrutturale (nei limiti delle
possibilità di funzionamento di una struttura di tipo sanitario) mi pare siano valorizzate,
almeno nella comunità che ho potuto visitare. Questa dimensione dovrebbe, almeno in
linea teorica, favorire la ricostruzione di relazioni sociali strutturali.
3. Terapia
Società e culture hanno inventato diversi tipi di famiglia, predisposti a riprodurre la
struttura sociale attraverso l’esercizio del controllo della riproduzione biologica, per poi
forgiare la prole secondo uno specifico modello. In questo processo si costruiscono
letteralmente gli individui i quali vengono fin da subito proiettati, attraverso le relazioni
familiari, verso il modello sociale in vigore. La famiglia e le sue relazioni, che si tratti di
nucleare, estesa, monoparentale o altro, prepara l’individuo a una certa struttura sociale e
ai ruoli che vi dovrà ricoprire. Ovunque, tuttavia, questo complesso e delicato
meccanismo può entrare in crisi, dando luogo a patologie specifiche. Se la malattia
mentale si produce essenzialmente all’interno delle relazioni familiari, tale patologia non
può che essere strettamente dipendente nelle sue manifestazioni e nelle sue concezioni
dalla specifica forma di famiglia che la società si è data. Detto altrimenti, se la famiglia è
un costrutto socio-culturale lo sono anche le sue patologie.
6
Una delle domande che possiamo porci a questo punto riguarda le patologie
specifiche della società occidentale e del suo particolare tipo di famiglia: la sindrome
bordeline può essere considerata il prodotto specifico della famiglia nucleare, una forma
sociale inventata nelle città europee nei secoli XVIII e XIX, e delle sue disfunzioni? La
chiusura (che in taluni casi sembra la ricerca di una sorta di autosufficienza) della
relazione madre-figlio, che si attua talvolta all’interno di questo modello familiare, può
essere considerata un fatto antisociale e dunque potenzialmente pericoloso, nel
momento in cui la madre è portatrice a sua volta di traumi precedenti? Infine, la
relazione psico-terapeutica classica che si esplica nel rapporto a due paziente/terapeuta,
nel chiuso di una stanza, soggetta alle limitazioni temporali che vengono di consueto
imposte, non riproduce a sua volta tale chiusura e tale dipendenza?
L’ipotesi che sto tentando di formulare vorrebbe proporre una relazione stretta tra
modello di famiglia, patologia psichiatrica e risposta diagnostico-terapeutica. Questi tre
aspetti sono a mio parere strettamente connessi all’interno del medesimo orizzonte
culturale che li ha originati. La controprova potrebbe consistere nel prendere in
considerazione un contesto che presenti un diverso modello di famiglia e di conseguenza
patologie relazionali descritte, classificate e trattate secondo altri schemi interpretativi.
Tenterò dunque di presentarvi brevemente il caso del sistema terapeutico-religioso
utilizzato nell’Africa dei Grandi Laghi, che ho potuto studiare nel corso delle mie
ricerche sul campo.
4. Il sistema religioso-terapeutico dell’Africa dei Grandi Laghi
La regione dei Grandi Laghi africani, pur suddivisa in cinque stati nazionali e in
una ventina di società diverse (che parlano lingue differenti e presentano svariate forme
di organizzazione politica), presenta una notevole uniformità culturale, rilevabile in
particolare a livello della tradizione terapeutico-religiosa. In tutte le società interlacustri
viene infatti praticato un culto di possessione, denominato kubandwa nelle lingue locali,
all’interno del quale dei medium, posseduti da spiriti di eroi e sovrani che si ritiene
avessero un tempo vissuto nell’area, esercitano funzioni divinatorie e terapeutiche.
Accanto a queste figure maggiori, sono presenti altri specialisti magico-religiosi:
guaritori-indovini che apprendono tecniche magico-divinatorie da colleghi anziani (senza
tuttavia possedere il carisma che i medium ottengono in virtù della possessione spiritica),
erboristi specializzati nell’impiego della farmacopea, e infine stregoni che utilizzano la
7
magia nera a scopi malefici. Tali categorie di specialisti, soprattutto al giorno d’oggi
tendono a sovrapporsi le une all’interno di un’offerta terapeutica piuttosto flessibile.
Inoltre, accanto a queste figure tradizionali troviamo attualmente numerose figure di
guaritori religiosi, soprattutto pentecostali o musulmani, oltre che rappresentanti della
medicina e anche della psichiatria occidentale. L’offerta terapeutica è dunque vasta e
articolata; essa si fonda sulla compresenza di sistemi religiosi e terapeutici differenti.
Mi concentrerò sul sistema tradizionale, in quanto è quello che si discosta
maggiormente dal sistema europeo. Innanzitutto descriverò brevemente (e fin troppo
schematicamente) il modello di famiglia presente nei Grandi Laghi. Qui siamo in
presenza di una struttura di discendenza patrilineare, che dunque calcola i parenti solo
per via maschile (la madre e le relazioni uterine non danno luogo, almeno in linea
teorica, a rapporti di parentela). Il matrimonio è poliginico e virilocale, dunque un uomo
può sposare diverse donne, le quali vanno a vivere nel villaggio e sulla terra del clan del
marito, ciascuna dando luogo a una sua cellula matrifocale basata in una casa (un
“focolare”) dove la donna vive lavorando la sua porzione di campo con i suoi figli. Il
marito circola tra le mogli visitandole a turno. Il modello si è ovviamente modificato a
partire dall’evangelizzazione (circa il 65% della popolazione oggi è cristiana), e tuttavia
nonostante l’avversione dei missionari e del clero nei confronti della poliginia, essa è
ancora presente soprattutto nei contesti rurali, dove assolve anche a una funzione
economica.
La famiglia dei Grandi Laghi non è però descritta correttamente, almeno in termini
“emici”, se non si dà risalto alla presenza in essa dei defunti. La famiglia è infatti
concepita come un gruppo di discendenza di cui fanno parte con egual diritto i vivi e i
defunti. La morte comporta infatti la trasformazione di una persona in uno spirito, che
continua - in forme e gradi diversi a seconda del tempo intercorso dal momento della
morte - a vivere all’interno del nucleo domestico, dove per altro è stato sepolto. I defunti
sono vividamente percepiti come parte del gruppo domestico, protagonisti di offerte e
rituali miranti a pacificarli, poiché la loro presenza è sentita per lo più come minacciosa e
pericolosa. La famiglia è dunque estesa soprattutto nella dimensione verticale delle
generazioni che si susseguono, nonostante la morte.
Quali patologie mentali possono affliggere individui che crescono all’interno di
queste famiglie? La visione locale ci parla di una costellazione di disturbi ben codificata e
ricorrente nelle storie dei pazienti, che viene ricondotta a due ordini di spiegazioni-
8
classificazioni: la causa prima e principale dei disturbi mentali rimanda alla possessione
da parte degli spiriti. Si può trattare degli spiriti dei defunti della famiglia, gli antenati, che
vengono a vessare e infastidire un discendente che ha mancato nei loro confronti,
dimenticando le offerte e i rituali che dovrebbero tener viva la memoria del morto,
oppure di spiriti super-clanici divinizzati, la cui possessione prelude all’iniziazione al
rango di medium. Come si può vedere, la patologia è considerata anche il primo passo
nel percorso che conduce una persona a divenire medium e guaritore. Solo colui o colei
che ha fatto esperienza personale della malattia potrà infatti trasformarsi in mediatore e
terapeuta.
La seconda causa di disturbo rinvia invece alla stregoneria, cioè alla volontà di
qualcuno di danneggiare il paziente utilizzando tecniche e sostanze streganti, per cause
che vanno dall’invidia al rancore, e più in generale all’espressione del conflitto sociale.
Queste due condizioni (possessione e stregoneria) danno luogo a una costellazione di
disturbi mentali e sociali che rientrerebbero, in Occidente, in una diagnosi di tipo
psichiatrico. Si tratta tipicamente di una serie di sintomi che implicano una difficoltà a
mantenere le relazioni familiari all’interno del gruppo domestico. I pazienti descrivono
una storia clinica spesso abbastanza stereotipata, fatta di delirio, allucinazioni, incapacità
di comunicare, rifiuto a condividere il cibo nella dimensione familiare, successivo
abbandono del nucleo domestico, vagabondaggio nella foresta, sintomi che in generale
rinviano a un’interruzione delle relazioni familiari, non più sostenibili per il paziente.
Come si svolge la terapia? Il paziente viene normalmente portato dal medium
dopo un periodo prolungato di manifestazione dei sintomi. La famiglia estesa
accompagna il paziente (il coniuge se c’è, i genitori, spesso i nonni, a volte i vicini di
casa). Il medium procede a una consultazione collettiva, in cui di fronte a tutti i parenti
riuniti effettua una delle forme di divinazione in suo possesso, proponendo
un’interpretazione della malattia. Le cause vengono per lo più rinviate a una rottura nelle
relazioni con i parenti defunti. La cura consiste allora nell’effettuare per un certo periodo
una serie di rituali mirati ai defunti, fatti di offerte e gesti significativi, che risvegliano nel
paziente e nei suoi familiari il senso di appartenenza al gruppo esteso rigenerando le
relazioni familiari. Nel caso di disturbi gravi, che la famiglia non riesce a gestire al suo
interno, il paziente viene “internato” nella clinica del medium (che possiede sempre la
possibilità di ospitare il paziente e alcuni suoi parenti per un periodo anche prolungato)
insieme ad alcuni parenti stretti. In questo modo il medium accompagna i rituali familiari
9
riorganizzando le relazioni. In alcuni casi la patologia può essere curata soltanto tramite
un’iniziazione al rango di guaritore. Dopo tale iniziazione il paziente ottiene un nuovo
ruolo che lo porterà a vivere al di fuori della famiglia, il suo status viene modificato e
innalzato così ad una dimensione pubblica.
In questo sistema, la “pazzia” viene interpretata fondamentalmente come una
presenza spirituale aliena dentro al Sé: si tratta di spiriti ancestrali che vengono a
infastidire la persona che ha mancato nei loro confronti dimenticandosi di loro, oppure
di spiriti superclanici che per così dire estraggono la persona dal suo ambiente familiare
per farne un guaritore e un indovino. Nel primo caso è evidente come il sistema della
famiglia estesa produce le sue patologie nel momento in cui i vincoli ancestrali vengono
trascurati. La terapia consiste allora nel riorganizzare tali relazioni ricostruendo
l’immagine dei defunti. Nel secondo caso invece la società prevede la possibilità di una
vera e propria uscita dalla famiglia per quegli individui che non riescono ad integrarvisi.
In questo caso, invece di insistere sulla ricostituzione dei legami, si apre una strada
completamente diversa, quella della loro rescissione in vista dell’acquisizione di un
nuovo status, lo status del medium-guaritore. Questi individui hanno in un certo senso
abbandonato la loro famiglia dapprima durante la fase della malattia iniziatica, che
significativamente li portava fuori dall’ambiente domestico a vagabondare in solitudine
nella foresta, e successivamente, attraverso il rito iniziatico a entrare in una nuova
dimensione, quella del gruppo dei medium che si occupa non più del benessere della
propria famiglia ma di chiunque anche fuori dal clan richieda i suoi servigi.
La pazzia è dunque “creata” per così dire dagli spiriti, dagli spiriti familiari nel
primo caso, da quelli nazionali nel secondo. Essa non è mai concepita come un disturbo
organico, “naturale”, anche se organiche eventualmente possono essere le sue
manifestazioni. Anzi, persino patologie che chiaramente nel sistema medico occidentale
presenterebbero un’eziologia batterica o virale (addirittura l’AIDS), vengono il più delle
volte ricondotte a cause spirituali o alla stregoneria. Si tratta dunque di un sistema
medico che pone al centro la dimensione spirituale, la quale a sua volta rinvia alla
centralità delle relazioni familiari della famiglia estesa dei vivi e dei defunti e ai rischi
delle loro interruzioni. Nonostante tale centralità, tuttavia, non tutti sono costretti a
vivere all’interno di tali relazioni. Alcuni individui manifestano spesso fin dall’infanzia
una sintomatologia grave che viene ricondotta alla possessione degli spiriti non familiari.
A queste persone viene offerto un percorso alternativo: uscire definitivamente dalla
10
famiglia e entrare nella “comunità” dei medium, intraprendendo un percorso terapeutico
e iniziatico che in generale trasforma i sintomi in manifestazioni della positiva presenza
degli spiriti. Nella comunità dei medium non c’è famiglia e non c’è gerarchia. Ciascun
medium vive occupandosi dei suoi pazienti, in una dimensione considerata parallela a
quella della società normale e delle sue regole.
Per quel che ho potuto vedere, questi percorsi terapeutici hanno in generale
successo. Gli unici casi non trattabili che ho potuto osservare riguardavano persone che
la famiglia non aveva, per diversi motivi, voluto far iniziare al culto. In questo caso i
sintomi della malattia iniziatica, che normalmente si trasformano attraverso il rito di
iniziazione in tecniche divinatorie e terapeutiche, restavano allo stadio patologico,
cronicizzando per così dire il malato in una condizione di asocialità definitiva.
5. Conclusioni
Il sistema terapeutico dei Grandi Laghi è coerente con il modello famigliare che
queste società si sono date: esso insiste soprattutto su di una famiglia trans-generazionale
che comprende i vivi e i defunti, una struttura all’interno della quale ego si sente erede di
una lunga lista di parenti patrilineari la cui memoria risulta indispensabile nella
costruzione della propria identità. La pazzia nasce dal trascurare la memoria dei defunti;
la terapia interviene allora a ricostituire i legami rotti, un’operazione svolta
collettivamente dai parenti in vita, dal momento che la relazione con i defunti viene
coltivata collettivamente. Tuttavia, per quanto il sistema ponga al centro la famiglia
estesa in senso verticale, è previsto che alcuni individui possano fuoriuscire
completamente da questa rete. La pazzia severa che colpisce i futuri medium viene letta
come la manifestazione di una rottura insanabile con i parenti e il clan. In questo caso
un’alternativa alla famiglia viene offerta ai pazienti: entrare nella comunità dei medium,
una dimensione caratterizzata da forti elementi di anti-struttura. I medium sono infatti
persone in qualche modo marginali e trasgressive, esse vivono accanto alla struttura
sociale ma non vi partecipano completamente, a loro è consentito rovesciare e
trasgredire alcune regole fondamentali, tra loro non c’è gerarchia n’è organizzazione
sociale.
Le società dei Grandi Laghi hanno dunque immaginato due percorsi patologici e
terapeutici differenti per chi non si adatta “naturalmente” alla struttura familiare e
sociale: un primo percorso per coloro che, avendo manifestato disturbi a livello delle
11
relazioni familiari, possono essere risocializzati all’interno del nucleo domestico,
attraverso un consolidamento per così dire “artificiale” dei vincoli ancestrali; un secondo
percorso per coloro che invece devono rompere completamente con la famiglia e con la
società per entrare a vivere in una dimensione comunitaria e anti-strutturale, all’interno
della quale assumeranno il ruolo di mediatori e guaritori. Una scelta radicale, che
permette di recuperare individui altrimenti del tutto inutilizzabili nella società normale,
che vengono innalzati a uno status per molti versi superiore anche ai ruoli dell’autorità
politica, ma che rimane sempre parallelo e almeno in parte estraneo alla vita sociale.
Riferimenti bibliografici
Buber Martin, 1958, Il principio dialogico, Milano, Comunità.
Kernberg Otto, 1978, Sindromi marginali e narcisismo patologico, Torino, Bollati
Boringhieri (ed. orig. 1975, Borderline Condition and Pathological Narcissism, New York, Jason
Aronson).
Malinowski Bronislav, 2000, Sesso e repressione sessuale tra i selvaggi, Torino, Bollati
Boringhieri (ed. orig. 1927, Sex and Repression in Savage Society, Kegan Paul and Company,
London).
Obbo Christine, 1996, “Healing. Cultural Fundamentalism and Syncretism in
Buganda”, Africa (London), n. 66 (2), pp. 183-201.
Pennacini Cecilia, 1998, Kubandwa. La possessione spiritica nell’Africa dei Grandi Laghi,
Torino, Il Segnalibro.
Teuton Joanna, 2007, Bentall Richard, Dowrick Chris, “Conceptualizing Psycosis
in Uganda: The Perspective of Indigenous and Religious Healers”, Transcultural Psychiatry,
March 2007, pp. 79-113.
Remotti Francesco, 2005, “Comunità e società”, Terapia di Comunità. Rivista
Bimestrale di psicologia, Anno 5, n. 30, dice. 2005, www.terapiadicomunita.org
Turner Victor, 2001, Il processo rituale, Brescia, Morcelliana (ed. orig. 1969, The Ritual
Process. Structure and Anti-Structure, The Lewis Morgan Lecture 1966, New York, Aldine de
Gruyter).
Viazzo Pier Paolo e Remotti Francesco, 2007, “La famiglia: uno sguardo
antropologico” in Personal Manager. L’economia della vita quotidiana. Vol. 4, La Famiglia,
Università Bocconi Editore, pp. 2-65.
12