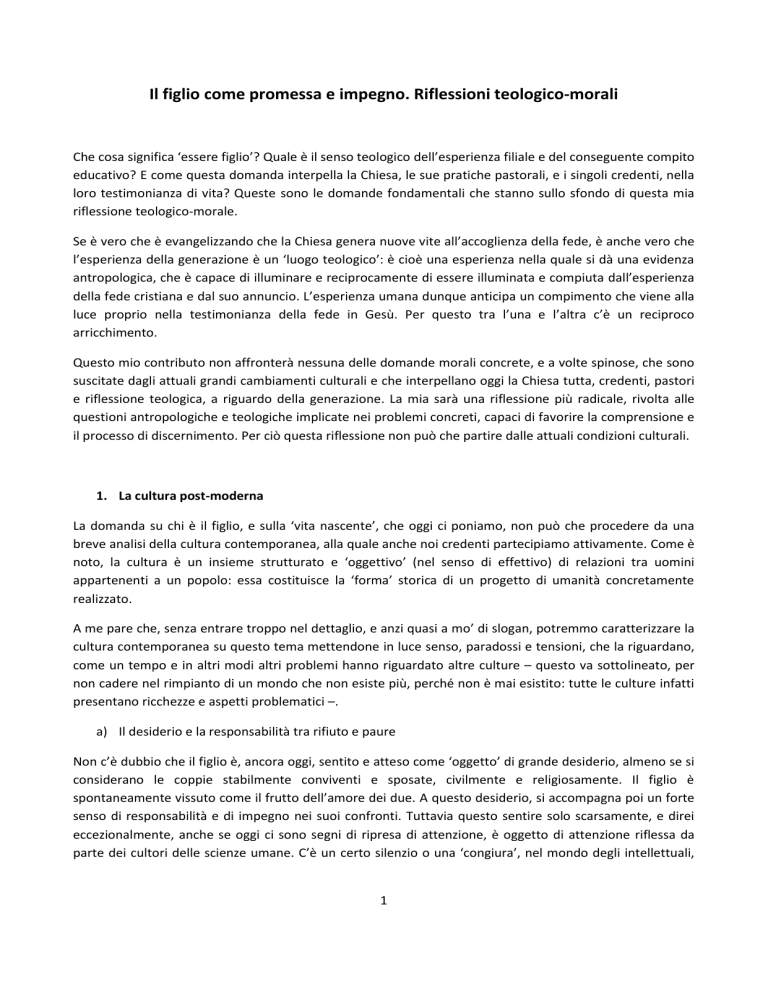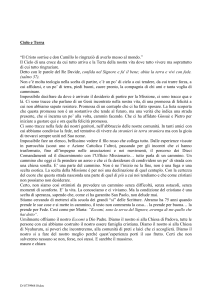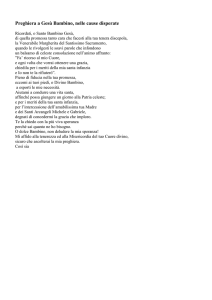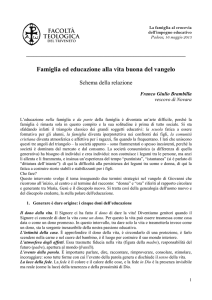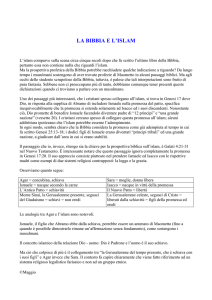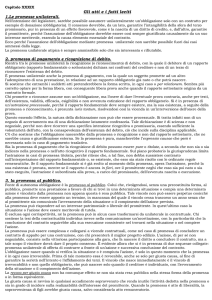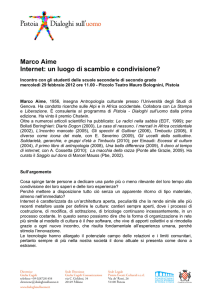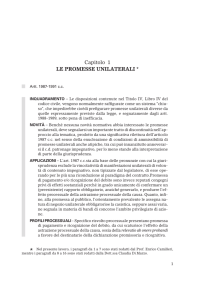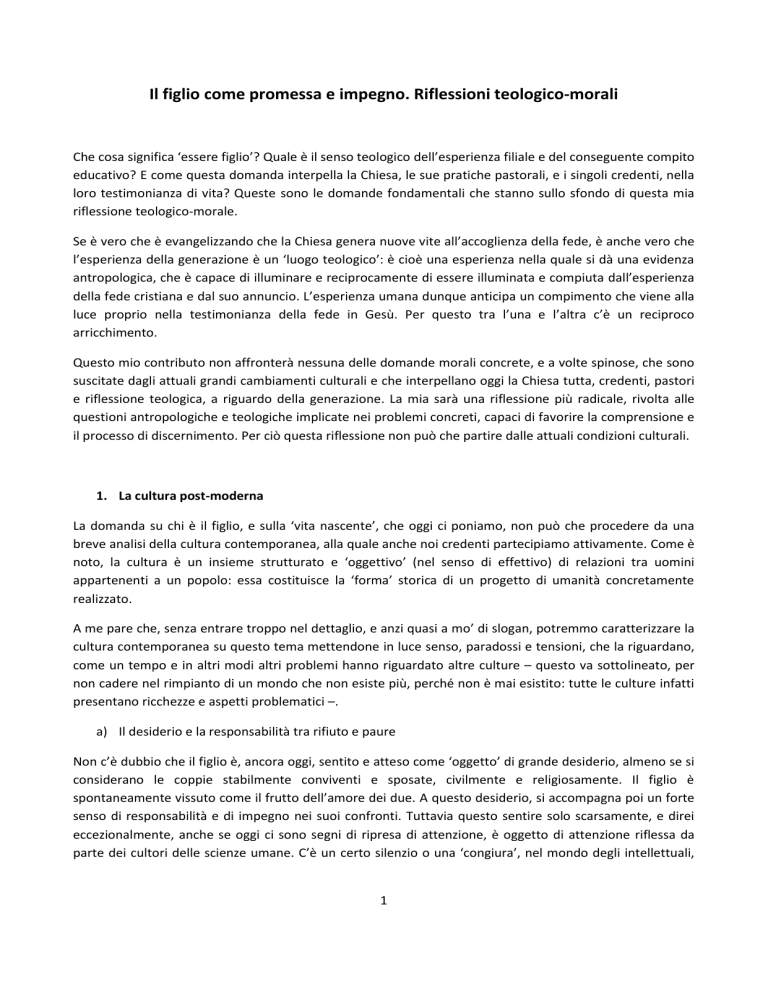
Il figlio come promessa e impegno. Riflessioni teologico-morali
Che cosa significa ‘essere figlio’? Quale è il senso teologico dell’esperienza filiale e del conseguente compito
educativo? E come questa domanda interpella la Chiesa, le sue pratiche pastorali, e i singoli credenti, nella
loro testimonianza di vita? Queste sono le domande fondamentali che stanno sullo sfondo di questa mia
riflessione teologico-morale.
Se è vero che è evangelizzando che la Chiesa genera nuove vite all’accoglienza della fede, è anche vero che
l’esperienza della generazione è un ‘luogo teologico’: è cioè una esperienza nella quale si dà una evidenza
antropologica, che è capace di illuminare e reciprocamente di essere illuminata e compiuta dall’esperienza
della fede cristiana e dal suo annuncio. L’esperienza umana dunque anticipa un compimento che viene alla
luce proprio nella testimonianza della fede in Gesù. Per questo tra l’una e l’altra c’è un reciproco
arricchimento.
Questo mio contributo non affronterà nessuna delle domande morali concrete, e a volte spinose, che sono
suscitate dagli attuali grandi cambiamenti culturali e che interpellano oggi la Chiesa tutta, credenti, pastori
e riflessione teologica, a riguardo della generazione. La mia sarà una riflessione più radicale, rivolta alle
questioni antropologiche e teologiche implicate nei problemi concreti, capaci di favorire la comprensione e
il processo di discernimento. Per ciò questa riflessione non può che partire dalle attuali condizioni culturali.
1. La cultura post-moderna
La domanda su chi è il figlio, e sulla ‘vita nascente’, che oggi ci poniamo, non può che procedere da una
breve analisi della cultura contemporanea, alla quale anche noi credenti partecipiamo attivamente. Come è
noto, la cultura è un insieme strutturato e ‘oggettivo’ (nel senso di effettivo) di relazioni tra uomini
appartenenti a un popolo: essa costituisce la ‘forma’ storica di un progetto di umanità concretamente
realizzato.
A me pare che, senza entrare troppo nel dettaglio, e anzi quasi a mo’ di slogan, potremmo caratterizzare la
cultura contemporanea su questo tema mettendone in luce senso, paradossi e tensioni, che la riguardano,
come un tempo e in altri modi altri problemi hanno riguardato altre culture – questo va sottolineato, per
non cadere nel rimpianto di un mondo che non esiste più, perché non è mai esistito: tutte le culture infatti
presentano ricchezze e aspetti problematici –.
a) Il desiderio e la responsabilità tra rifiuto e paure
Non c’è dubbio che il figlio è, ancora oggi, sentito e atteso come ‘oggetto’ di grande desiderio, almeno se si
considerano le coppie stabilmente conviventi e sposate, civilmente e religiosamente. Il figlio è
spontaneamente vissuto come il frutto dell’amore dei due. A questo desiderio, si accompagna poi un forte
senso di responsabilità e di impegno nei suoi confronti. Tuttavia questo sentire solo scarsamente, e direi
eccezionalmente, anche se oggi ci sono segni di ripresa di attenzione, è oggetto di attenzione riflessa da
parte dei cultori delle scienze umane. C’è un certo silenzio o una ‘congiura’, nel mondo degli intellettuali,
1
sul tema della generazione. Eppure, anche nella vita pratica, si tratta di un’esperienza molto importante
che però, per altri aspetti, non va ‘da sé’.
C’è un lato oscuro che nelle coppie si accompagna al desiderio del figlio, e che è oggi alquanto diffuso. È
quello che potremmo chiamare la paura e il rifiuto. Certo, il rifiuto non è di solito definitivo, ma è
prevalentemente solo temporaneo: la coppia, all’inizio, esclude il figlio; se questo arriva troppo presto, è
come un ‘incidente’ non ‘desiderato’. La cultura contemporanea sottolinea molto, e per certi aspetti in
modo comprensibile, la necessità che la coppia trovi una propria stabilità, necessaria per poter accogliere
un figlio. Il rifiuto (temporaneo) è collegato alle paure di non essere pronti, di non essere all’altezza, di
accogliere un altro che scombina gli equilibri, oppure alla paura di un mondo pieno di pericoli e con poche
speranze. Questo rifiuto si manifesta anche nello scarso numero dei figli, anche se ovviamente un numero
ridotto non implica affatto automaticamente il rifiuto e un numero elevato non significa necessariamente
una ‘apertura’ all’accoglienza. In ogni caso, per vari motivi, legati anche – ma non solo – alle condizioni
obiettive di vita, le disponibilità economiche, il lavoro e l’abitazione, l’assenza di politiche attente alla
famiglia e la volontà di assicurare un elevato standard di vita ai propri figli, le coppie tendono a considerare
assai rilevante il ‘costo’, anche in termini economici di un nuovo figlio. Per ciò limitano le nascite.
Possiamo forse dire che questo ‘rifiuto’ e paura manifesta oggi una questione umana, che è la relazione tra
sessualità (anche coniugale) e generazione. La modernità, riproponendo in modi nuovi e macroscopici un
antico problema, si caratterizza per questa relazione problematica tra amore (di coppia) e generazione.
Affermare il legame, però, non equivale a subordinare l’amore alla generazione, ma chiede un saggio
discernimento.
b) Il diritto e la pretesa
Paradossalmente, al rifiuto si accompagna la pretesa o addirittura la rivendicazione del figlio considerato
come un diritto. Pur avendo posticipato la ricerca del figlio, di solito arriva il momento in cui la coppia lo
ricerca e ‘lo vuole’ attivamente. Ma questo non arriva sempre: si parla di coppie sterili (o infertili) nella
misura del 20% circa. E si comprende il forte aumento di coppie sterili, se si considerano, tra le altre cose, le
condizioni di stress e l’età tardiva (della donna), che diventano fattori obiettivamente controindicati per la
fertilità. È su questo sfondo che, dopo il rifiuto, può nascere la pretesa del ‘diritto di generare’. Questa
pretesa (diritto) nasconde un atteggiamento che, enfatizzando la scelta (necessaria), la assolutizza,
dimenticando che nella ‘decisione’ di generare è inscritto un evento che sfugge semplicemente al potere
assoluto dell’uomo. In effetti qui nasce la domanda: chi è il figlio? E quale relazione hanno un padre e una
madre con il ‘proprio’ figlio?
c) In conclusione
In conclusione, tutto sommato mi pare che si possa dire che la nostra cultura chiede alla responsabilità
personale di superare i rischi e di cogliere le opportunità. Per le coppie il compito fondamentale è di
recuperare la responsabilità nel generare, senza cadere nelle paure e nelle pretese. Certi, quando poi il
figlio arriva davvero, il rischio è che la coppia ‘scarichi’ su di esso una eccessiva concentrazione,
circondandolo di attese e attenzioni eccessive, che non favoriscono una buona relazione con lui. Trovandosi
al centro delle attenzioni ed essendo molto protetto, un figlio tende a ipervalutarsi e a pretendere di
soddisfare tutto quel che vuole. Per questo occorre considerare con attenzione che cosa è in gioco nella
relazione al figlio.
2
2. Il figlio e la ‘relazione’
A me pare che la difficoltà che sta sullo sfondo di questa nostra cultura, paradossalmente, sta nel vivere
bene e nel custodire il senso della relazione, che è fondamentale nella esperienza filiale. Da questo punto di
vista, forse, la difficoltà maggiore sta nel riconoscere che generare un figlio è generare una nuova relazione
con un ‘altro’, che ha la sua autonomia e identità, che tuttavia si ‘forma’ (educa) proprio nella buona
relazione, anzitutto con chi lo ha generato e si prende cura di lui. Dunque, per un padre e una madre ogni
figlio è altro da sé, anche se nessuno assomiglia di più a qualcun altro, se non un figlio a chi lo ha generato.
Tuttavia va aggiunto che il figlio non è solo l’altro: sono io stesso! Figlio è ogni essere che viene al mondo.
Ogni uomo dunque è figlio. L’interrogativo sul figlio – «che cosa significa mettere al mondo un figlio?» –
pone una domanda che mette in gioco ciascuno di noi e riguarda dunque il modello antropologico più
complessivo. La domanda su chi è un figlio e chi è l’uomo si incrociano l’una con l’altra.
Non si può comprendere chi è l’uomo se non a procedere dalla sua condizione filiale. Questa è la struttura
fondamentale che sta agli inizi della nostra vita: ogni uomo è generato da altri. Questa ‘sorpresa’ tuttavia
non è sempre così piacevole o rassicurante. O meglio a volte la nascita di un bimbo avviene in contesti
sociali e culturali problematici e all’interno di relazioni familiari difficili, che la privano di quella atmosfera
bella e ricca di attesa che più spesso la circonda. La scoperta di non essere stato voluto, o la relazione
troppo conflittuale o problematica tra i genitori che può arrivare fino alla separazione, o l’abbandono
occulto o palese di cui sono oggetto molti figli, tutto ciò sembra essere una smentita alla troppo entusiasta
affermazione che un bimbo è sempre fonte di gioia. Ma, al di là di queste oscurità e ambiguità
drammatiche, dobbiamo riconoscere che la luce e la promessa sono originarie: come appare, per esempio,
nel fatto che, quando un figlio si scopre abbandonato, egli ha l’impressione di essere stato tradito e che
qualcosa gli sia stato tolto. Ed è proprio per questo che le esperienze più difficili e problematiche
suppongono una affermazione e una promessa originaria. La vera domanda, a questo punto, è: come
rimediare al ‘dramma’? Come restituire ai figli la promessa di bene, inscritta nel loro essere stati generati?
E in che cosa consiste questa ‘promessa di bene’? Anzitutto, si deve dire che c’è una forte valenza simbolica
legata alla generazione di un bimbo: dare alla luce un uomo non è un semplice fatto materiale o animale. La
relazione con un figlio istituisce un segno che va compreso nel suo senso. In sintesi, si può dire che egli è da
una parte un frutto e compimento di un’attesa e dall’altra è anche un inizio e novità assoluta. Come frutto e
compimento di un’attesa, un figlio nasce all’interno di una relazione sponsale, e di amore coniugale. Il
generare accade in un incontro d’amore e di comunione reciproca.
Ma, come ‘novità’, un figlio è il ‘terzo’, che nasce dalla relazione, e va oltre essa. Un figlio non è
semplicemente il frutto dell’amore dei due. Egli è l’apparire di un altro, nella sua singolarità unica e
preziosa e con tutta la carica di novità che questo comporta.
Questo significa che, dinanzi alla generazione, un padre e una madre non sono semplicemente ‘attori’ di
una scelta. C’è infatti nella generazione qualcosa che sfugge ai soggetti coinvolti. Questo è evidente, per
esempio, se si pensa che si potrebbe voler generare, ma senza poterlo fare (sterilità), oppure che viceversa
e per molti differenti motivi, l’uomo e la donna in un rapporto potrebbero non volere affatto o non pensare
per nulla alla generazione e tuttavia potrebbe arrivare un figlio.
3
In questi ‘paradossi’ di vita si annuncia un senso più profondo: la generazione non è semplicemente un
volere dell’uomo. Certo, un figlio viene desiderato e va voluto, anche fortemente. Ma non può essere
voluto come un possesso, bensì come un dono (da ricevere). Per ciò non basta volerlo perché arrivi.
Quando arriva, è sempre in certo modo una ‘sorpresa’. Si annuncia così, nell’esperienza comune del
generare, qualcosa che sfugge alla semplice decisione dell’uomo e della donna, anche se non si realizza
senza di essi.
Questo ‘accadere’, inscritto nell’evento del generare, manifesta la sua originaria qualità trascendente e
‘religiosa’. Il figlio non è semplicemente programmabile e non è solo il prodotto della scelta. Esso arriva
sempre, come un ‘dono’. Inaspettato, spesso sorprendentemente bello e altre volte sconvolgente, e in ogni
caso irriducibile alle attese dei genitori. Questo elemento di ‘sorpresa’ che accompagna la nascita di un
figlio appare particolarmente istruttivo e rivelatore: la promessa, suscitando sorpresa, chiede di essere
riconosciuta e accolta con fede. Essa chiede una risposta fiduciosa e un impegno fattivo, perché – per gli uni
e gli altri, genitori e figli – l’evento possa davvero attuarsi come una promessa buona.
3. La Rivelazione: il figlio come figura della promessa di Dio
A questa struttura di senso (antropologica), risponde, come il suo compimento, la Rivelazione cristiana. In
essa, fin dai testi del Primo (o Antico) Testamento, il figlio è annunciato come figura paradigmatica della
promessa di Dio. Ma, nello stesso tempo, la promessa di Dio va oltre il figlio. Di fatto, la promessa del figlio
troverà compimento nella storia del Figlio, Gesù, nel quale ogni promessa trova compimento.
Il figlio è nell’Antico Testamento la figura della promessa di Dio, a cominciare da Gn 1,28, che è la prima
benedizione divina rivolta direttamente all’uomo, e che è immagine di ogni benedizione successiva, perché
trasmessa di padre in figlio. La benedizione di Dio rimane stabile, attraverso, oltre e nonostante le
vicissitudini del tempo umano. In questo testo mirabile appare che la generazione, prima e più che un
comando o un imperativo cui obbedire, è anzitutto una benedizione e una promessa di cui partecipare. È
un comando proprio perché all’origine è un dono. È dal dono che scaturisce l’impegno! Nella generazione
umana è inscritta la benedizione di Dio, nonostante il dramma legato alle vicende della storia.
Del resto, questo dramma – fatto di luce e ombre – appare chiaramente nella S. Scrittura, a cominciare
dalla storia di Caino, Abele e Set i primi figli della coppia umana. Gn 4 è un testo carico di luci e anche di
ombre. È anzitutto straordinario che la nascita di Caino sia collegata alla prima preghiera, e che questa sia
un grido di giubilo, non di lamento, come ci si sarebbe potuti aspettare dopo Gn 3,16 (‘con dolore partorirai
figli’). La forza di questo grido di giubilo appare ancor più se si riflette sul ‘silenzio’ con cui l’autore sacro
circonda la nascita di Abele. D’altra parte questo nome evoca il ‘soffio’, la vanità (abel), la fugacità di
un’esistenza, quella di Abele, che sarà precocemente soppressa dal fratello. Abele in certo senso ci
rappresenta tutti: egli è cifra della fragilità dell’esistenza umana. Infine, c’è da notare che anche la terza
nascita, quella di Set è caratterizzata da un grido di giubilo, da parte del padre, anche se, dopo il fratricidio,
il grido è più contenuto. La benedizione di Dio è più forte del peccato dell’uomo.
Altra figura fondamentale è Abramo. A questi Dio promette una discendenza che diventerà ‘una grande
nazione’ (Gn 12,2). La vicenda di Abramo è ricca di peripezie, difficoltà e rovesciamenti. A Mamre, la prima
scena di annunciazione di tutta la Bibbia, Dio promette ad Abramo e Sara un figlio, dopo un anno. E poi,
4
dopo la nascita del figlio, in un nuovo rovesciamento, Gn 22 racconta la ‘prova’ di Abramo (Gn 22,1: ‘Dio
mise alla prova Abramo’). Il significato fondamentale di questo testo è che la promessa di Dio richiede una
fede incondizionata. Ad Abramo è chiesto di essere disposto a rinunciare al figlio della promessa. E solo
quando è disposto a perdere – in una obbedienza e un abbandono incondizionato alla voce di Dio – il figlio
egli lo ritrova. Il figlio, figura della promessa, non coincide con essa. La promessa di Dio va oltre ogni umana
possibilità di realizzazione e di previsione.
Infatti, la promessa di Dio si compie in Gesù. Nella scena dell’annunciazione dell’angelo Gabriele a Maria,
l’inviato di Dio (Lc 1,37: ‘nulla è impossibile a Dio’) riprende le parole di Dio ad Abramo: ‘c’è forse qualche
cosa di impossibile per il Signore?’ (Gn 18,14). Tutta la vita di Gesù e poi al suo culmine la sua morte e
resurrezione rivelano come in Lui Dio stesso abbia compiuto la promessa fatta ad Abramo e in lui a tutte le
nazioni: sulla croce si rivela in modo radicale la condizione filiale di Gesù e dunque la sua relazione con il
Padre e quella del Padre con lui. Questa relazione di comunione filiale viene a noi donata nello Spirito, che
è dono del Risorto. A questo siamo chiamati, dunque: a essere figli, nel Figlio.
Questo è ciò che i genitori sono chiamati a riconoscere quando, nel Battesimo, si fanno testimoni per il
proprio figlio di quel dono che essi stessi hanno ricevuto per primi: la chiamata a vivere da figli, nel Figlio. In
questo rito del Battesimo si realizza la fecondità del vangelo. Riconoscendo che il ‘proprio’ figlio è, più che
proprio, figlio di Dio, i genitori accolgono di nuovo la promessa di Dio sulla loro vita, facendosene testimoni
per il figlio: a questo siamo tutti chiamati, ad accogliere il dono di Dio, la sua chiamata a una comunione
filiale. È solo acconsentendo a tale dono, con gratitudine e in modo incondizionato, e dunque riconoscendo
in Gesù il compimento di ogni la promessa di Dio, che l’uomo consente che essa si realizzi davvero.
È nella fede che al credente si dischiude in pienezza quella chiamata che è per ogni uomo (universale): Dio
ti ama con amore di Padre. Ti chiede di vivere una vita di figlio, in mezzo ai tuoi fratelli, secondo quel dono
di carità che è la sintesi e il compimento della Legge e dei Profeti. La fede infatti opera mediante la carità
(Gal 5,7), e la carità non si aggiunge alla fede, ma ne è la forma pratica.
Questo è l’obiettivo del piano pastorale: come individuare, nel nostro cammino di chiesa, le forme di
questa carità?
4. L’impegno e la testimonianza dei credenti
Sullo sfondo dell’ultima domanda, collocandoci all’interno del piano pastorale, che indica le linee
complessive di pratiche collegate a questa esperienza paradigmatica e fondamentale che è il figlio, mi
limito qui a indicare tre questioni (nodi) che mi paiono centrali su questo tema e che chiedono di essere
attuate e declinate nelle condizioni singolari di ogni coppia e dentro la nostra testimonianza di Chiesa. Si
tratta di una testimonianza che ci qualifica in modo specifico come credenti, e che ci chiede di essere
portatori, nel nostro impegno di fede, di una condizione antropologica (universale), che deve quindi
opportunamente entrare in dialogo critico con il contesto culturale odierno.
a) Accoglienza e ospitalità
In molti modi, ma in un senso essenziale, i genitori credenti si assumono il compito di testimoniare, anzi
tutto l’un l’altro, l’accoglienza e l’ospitalità nei confronti del proprio figlio, e dunque di quella promessa di
Dio che benedice e rende fecondo e fruttuoso il loro amore. A essi e alla comunità cristiana tutta,
generando nuovi figli e aprendosi a forme di accoglienza come l’affido e l’adozione, è chiesto di riconoscere
5
nel ‘dono’ del figlio la promessa di Dio, accogliendolo in prima persona e facendosi anche carico delle
situazioni più difficili, vissute da altri, nelle quali la speranza dischiusa dalla promessa di Dio sembra del
tutto svanita, offuscata, senza vie d’uscita. Nella fede, ai genitori credenti è consentito di essere testimoni
di una speranza contro ogni speranza. Nella loro attività a sostegno e a favore della ospitalità nei confronti
dei figli, le singole famiglie, o i gruppi o le associazioni di famiglie, o la comunità cristiana intera, senza alibi
né deleghe, si fanno concretamente testimoni della affidabilità e stabilità della promessa di Dio, al di là
delle fatiche, delle prove, delle difficoltà umane.
b) Il compito educativo
Un secondo ambito è quello propriamente educativo. L’educazione, certo, non è solo cosa di un momento.
I genitori educano i propri figli in ogni gesto e parola della vita, facendosi testimoni in prima persona di
quella verità (pratica) e di quella promessa di bene per la quale vale la pena di spendere la vita. Educare è
mantenere fede alla ‘promessa’ fatta generando: ‘puoi contare su di me!’; ‘mi prenderò cura di te, perché
tu possa imparare a prenderti cura di altri!’.
Eppure la relazione educativa, che pure è atteggiamento ‘diffuso’ in tutta la vita, si incarna anche in
momenti specifici, nei quali i genitori si propongono di testimoniare esplicitamente scelte e attenzioni
educative, nelle quali si rivela il senso di una vita quotidiana. Quali sono le attenzioni educative che i
genitori sono chiamati ad offrire in quegli ambiti di vita che sono deputati significativamente a investire
nella ‘formazione’ e nella educazione dei bambini e dei giovani? L’amore reciproco nella coppia,
l’attenzione alla qualità delle relazioni in tutta la famiglia, nella comunità cristiana, nell’oratorio, nella
scuola, nei gruppi giovanili, nelle attività ‘culturali’: è qui che, pur nel difficile contesto culturale
contemporaneo, alle famiglie (e alla comunità cristiana) si chiede – nelle forme e nei modi rispettivamente
legati ai diversi ambienti – un impegno capace di testimoniare nel concreto, pur nella fragilità della propria
vita, la bellezza della promessa di Dio, inscritta nel dono stesso della vita.
c) L’accoglienza dei figli
Il dono ricevuto, nell’essere generati ed accolti e nella testimonianza del compito educativo, impegna
naturalmente anche i figli, in prima persona. L’impegno di una coppia e di una famiglia – a partire dalla
generazione e poi nell’impegno educativo – non produce frutto in modo spontaneo ed automatico. Esso
suscita nel figlio una risposta di responsabilità, che comporta i suoi tempi e le sue fatiche. Nella relazione
con i genitori – e con chi si prende cura della sua educazione – un figlio non è mai semplice spettatore, ma è
impegnato nella attiva decisione di sé. Egli deve ‘lasciarsi accogliere’ come figlio, riconoscendo, con
gratitudine, un dono ricevuto. Questo richiede il riconoscimento della relazione e la sua decisione
personale.
Ogni figlio è infatti destinatario e recettore del dono (donatario), che non si realizza senza il suo consenso.
In fondo, il riconoscimento (necessario) che è richiesto al figlio, rivela quello che è in gioco non solo per i
figli, ma anche per tutti noi: come i nostri figli, anche noi siamo donatari, e dunque destinatari del dono di
Dio. Senza il nostro consenso, e la nostra testimonianza, il dono di Dio non potrebbe accadere e andrebbe
semplicemente perduto.
don Maurizio Chiodi
6