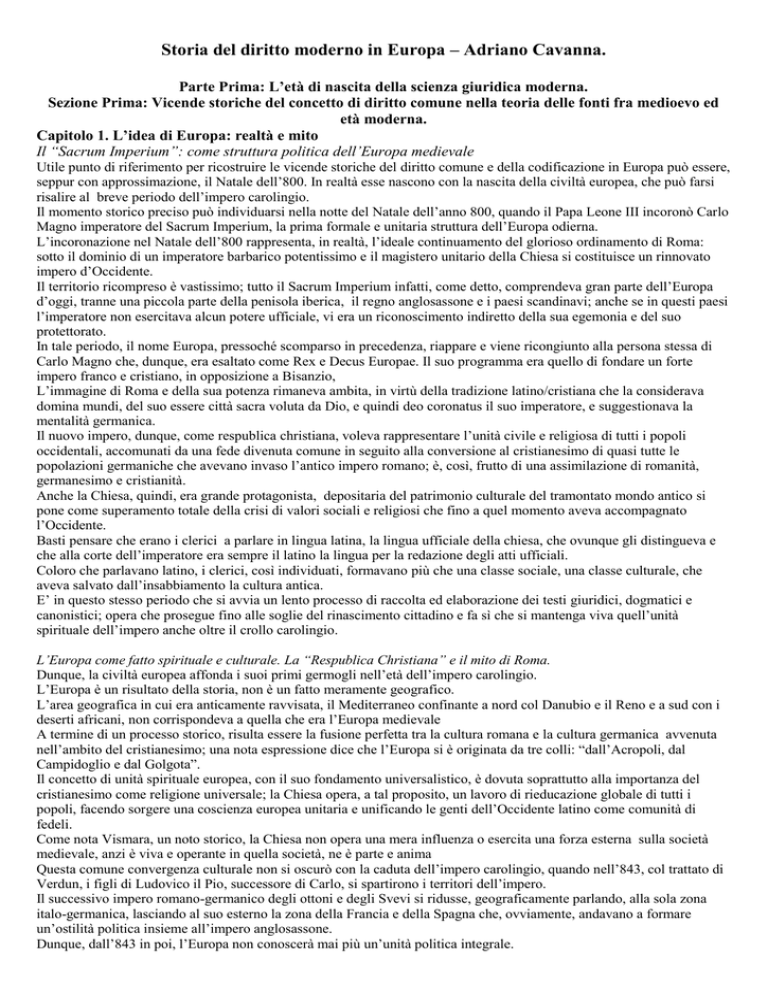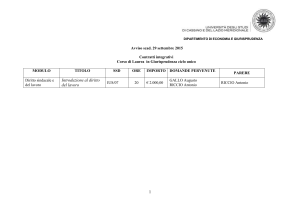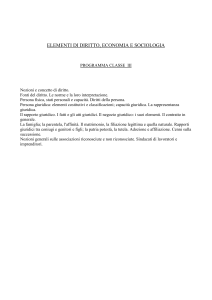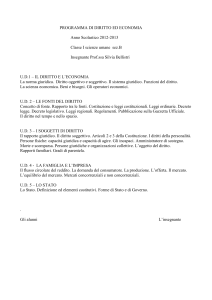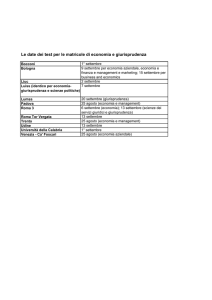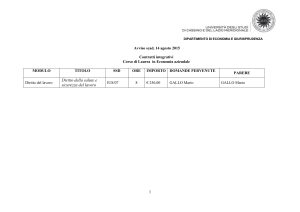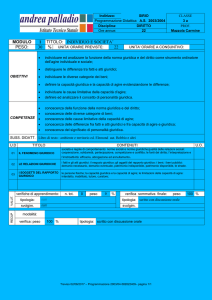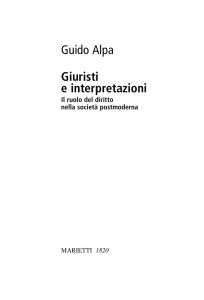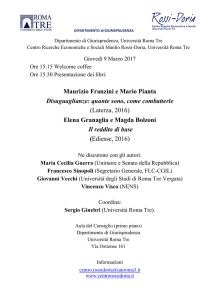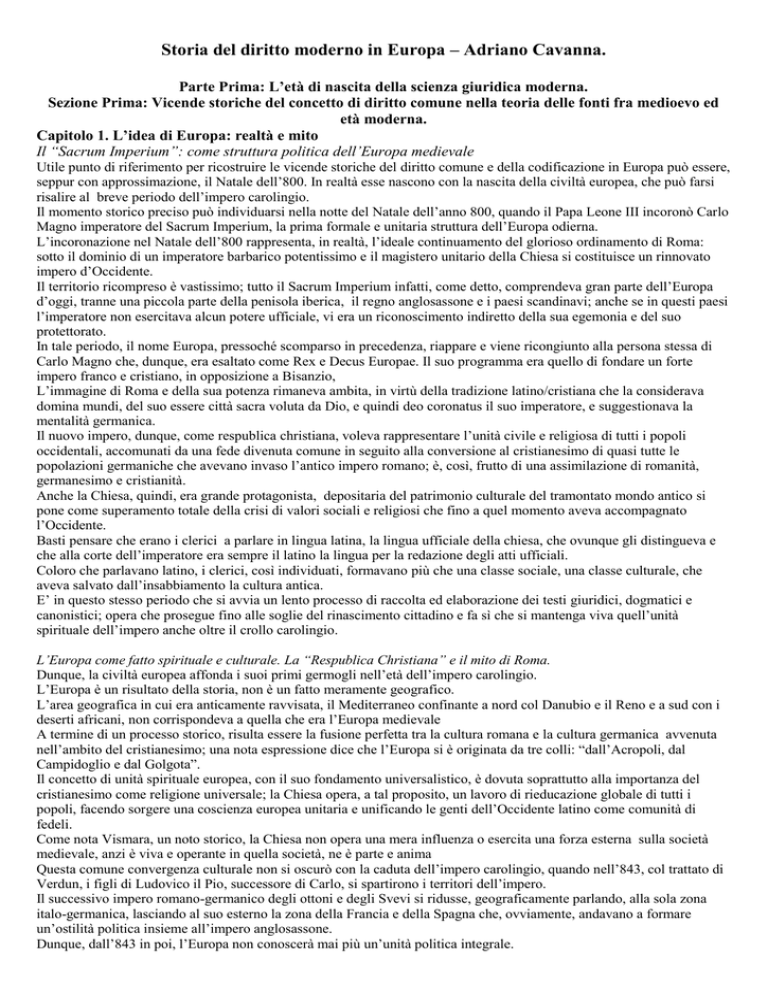
Storia del diritto moderno in Europa – Adriano Cavanna.
Parte Prima: L’età di nascita della scienza giuridica moderna.
Sezione Prima: Vicende storiche del concetto di diritto comune nella teoria delle fonti fra medioevo ed
età moderna.
Capitolo 1. L’idea di Europa: realtà e mito
Il “Sacrum Imperium”: come struttura politica dell’Europa medievale
Utile punto di riferimento per ricostruire le vicende storiche del diritto comune e della codificazione in Europa può essere,
seppur con approssimazione, il Natale dell’800. In realtà esse nascono con la nascita della civiltà europea, che può farsi
risalire al breve periodo dell’impero carolingio.
Il momento storico preciso può individuarsi nella notte del Natale dell’anno 800, quando il Papa Leone III incoronò Carlo
Magno imperatore del Sacrum Imperium, la prima formale e unitaria struttura dell’Europa odierna.
L’incoronazione nel Natale dell’800 rappresenta, in realtà, l’ideale continuamento del glorioso ordinamento di Roma:
sotto il dominio di un imperatore barbarico potentissimo e il magistero unitario della Chiesa si costituisce un rinnovato
impero d’Occidente.
Il territorio ricompreso è vastissimo; tutto il Sacrum Imperium infatti, come detto, comprendeva gran parte dell’Europa
d’oggi, tranne una piccola parte della penisola iberica, il regno anglosassone e i paesi scandinavi; anche se in questi paesi
l’imperatore non esercitava alcun potere ufficiale, vi era un riconoscimento indiretto della sua egemonia e del suo
protettorato.
In tale periodo, il nome Europa, pressoché scomparso in precedenza, riappare e viene ricongiunto alla persona stessa di
Carlo Magno che, dunque, era esaltato come Rex e Decus Europae. Il suo programma era quello di fondare un forte
impero franco e cristiano, in opposizione a Bisanzio,
L’immagine di Roma e della sua potenza rimaneva ambita, in virtù della tradizione latino/cristiana che la considerava
domina mundi, del suo essere città sacra voluta da Dio, e quindi deo coronatus il suo imperatore, e suggestionava la
mentalità germanica.
Il nuovo impero, dunque, come respublica christiana, voleva rappresentare l’unità civile e religiosa di tutti i popoli
occidentali, accomunati da una fede divenuta comune in seguito alla conversione al cristianesimo di quasi tutte le
popolazioni germaniche che avevano invaso l’antico impero romano; è, così, frutto di una assimilazione di romanità,
germanesimo e cristianità.
Anche la Chiesa, quindi, era grande protagonista, depositaria del patrimonio culturale del tramontato mondo antico si
pone come superamento totale della crisi di valori sociali e religiosi che fino a quel momento aveva accompagnato
l’Occidente.
Basti pensare che erano i clerici a parlare in lingua latina, la lingua ufficiale della chiesa, che ovunque gli distingueva e
che alla corte dell’imperatore era sempre il latino la lingua per la redazione degli atti ufficiali.
Coloro che parlavano latino, i clerici, così individuati, formavano più che una classe sociale, una classe culturale, che
aveva salvato dall’insabbiamento la cultura antica.
E’ in questo stesso periodo che si avvia un lento processo di raccolta ed elaborazione dei testi giuridici, dogmatici e
canonistici; opera che prosegue fino alle soglie del rinascimento cittadino e fa sì che si mantenga viva quell’unità
spirituale dell’impero anche oltre il crollo carolingio.
L’Europa come fatto spirituale e culturale. La “Respublica Christiana” e il mito di Roma.
Dunque, la civiltà europea affonda i suoi primi germogli nell’età dell’impero carolingio.
L’Europa è un risultato della storia, non è un fatto meramente geografico.
L’area geografica in cui era anticamente ravvisata, il Mediterraneo confinante a nord col Danubio e il Reno e a sud con i
deserti africani, non corrispondeva a quella che era l’Europa medievale
A termine di un processo storico, risulta essere la fusione perfetta tra la cultura romana e la cultura germanica avvenuta
nell’ambito del cristianesimo; una nota espressione dice che l’Europa si è originata da tre colli: “dall’Acropoli, dal
Campidoglio e dal Golgota”.
Il concetto di unità spirituale europea, con il suo fondamento universalistico, è dovuta soprattutto alla importanza del
cristianesimo come religione universale; la Chiesa opera, a tal proposito, un lavoro di rieducazione globale di tutti i
popoli, facendo sorgere una coscienza europea unitaria e unificando le genti dell’Occidente latino come comunità di
fedeli.
Come nota Vismara, un noto storico, la Chiesa non opera una mera influenza o esercita una forza esterna sulla società
medievale, anzi è viva e operante in quella società, ne è parte e anima
Questa comune convergenza culturale non si oscurò con la caduta dell’impero carolingio, quando nell’843, col trattato di
Verdun, i figli di Ludovico il Pio, successore di Carlo, si spartirono i territori dell’impero.
Il successivo impero romano-germanico degli ottoni e degli Svevi si ridusse, geograficamente parlando, alla sola zona
italo-germanica, lasciando al suo esterno la zona della Francia e della Spagna che, ovviamente, andavano a formare
un’ostilità politica insieme all’impero anglosassone.
Dunque, dall’843 in poi, l’Europa non conoscerà mai più un’unità politica integrale.
Neppure allora, però, si dissolse quell’unitaria realtà culturale, romano-cristiana di tipo universalistico; anche dopo l’età
carolingia ad essa non si sottraeva alcun paese cattolico seppur non rientrante nell’impero dei sovrani tedeschi: era
qualcosa di più vasto e comprensivo dello stesso ordinamento imperiale, che superava.
La consistenza di tale unità spirituale europea era basata sul mito di Roma su cui faceva perno un ideale impero
universale romano e cristiano ed era assorbita dagli ambienti colti d’Europa, in primo luogo dagli ambienti ecclesiastici
Il vincolo tra Roma e l’impero non era cessato neppure, quindi, nell’età degli ottoniani e degli Svevi, anzi col concetto di
renovatio imperii, era stato rafforzato. La cristianità dunque, in questo periodo, contava più della nazionalità, e faceva sì
che l’impero romano-germanico rappresentasse per eccellenza il mondo cristiano non disconoscendogli quella superiore
auctoritas che il legame con Roma gli conferiva.
Ciò che all’impero si negava era il predominio politico, che a tal proposito passa però in secondo piano poiché mera
formula retorica che non impediva di identificare il tutto con la sua parte più rappresentativa quale era la cristianità per
l’impero. Però, è anche vero che era la chiesa la vera forza motrice di tutto; supera, infatti, la sfera dell’impero, portatore
di un’idea universale piuttosto che di un’effettiva potenza universale. L’impero appare dunque più l’oggetto che il
soggetto di quest’esperienza culturale e i successivi scontri tra impero e chiesa tra l’11esimo e 12esimo secolo non
saranno altro che tentativi compiuti dall’impero di ritornare ad essere il soggetto principale di un’azione politica e di
un’esperienza di potere universale, offuscata dalla cristianità manifestata dalla Chiesa.
La Chiesa, quindi, ha sempre agito intelligentemente da protagonista. Con l’incoronazione di Carlo Magno infatti, si era
scelta per sempre il suo partner, legandosi alla forza temporale più potente di tutto l’occidente cristiano: legame forte che
opererà per secoli sia costruttivamente che distruttivamente a seconda che vi fosse l’idea di una chiesa nell’impero o un
impero nella chiesa.
In conclusione quindi, la teoria del Sacrum Imperium appare operante sotto più prospettive: come strumento spirituale che
la chiesa pone al servizio del proprio magistero evangelico, come base ideologica presupposto temporale della missione
della chiesa e veicolo di ingerenza statuale nella sfera spirituale.
E’ la concezione medievale della natura cristiana degli ordinamenti temporali: lo stato ha un fondamento religioso legato
a valori trascendenti. Terreno ideologico su cui prende vita il fenomeno unitario Europa, originato da una concezione
estranea al mondo antico, che non si eclisserà nemmeno quando tale concezione sarà distrutta e sostituita da quella laica
dell’organizzazione civile.
L’idea di Europa odierna ovviamente non è fondata su una fede religiosa o sull’aspirazione di un ordinamento
giuspolitico universale; tuttavia è importante sottolineare che su tali basi si parla di una tendenza di fondo che interessa
gradualmente anche il campo del diritto anch’esso interessato da un processo unificante: i carolingi iscrissero sulla
“tabula rasa” dell’età barbarica molte domande tra cui la questione relativa alla unità del diritto in tutta Europa. Le
risposte giunsero più tardi.
Ciò che preme individuare non sono le risposte dell’età carolingia ma è l’ambiente di nascita di un tal contesto capace di
generare movimenti e correnti di pensiero di dimensioni europee.
Infatti, come scrisse Dawson,” l’importanza storica dell’età carolingia, non sopravvisse a lungo al suo fondatore e non
raggiunse mai l’apice per la poca maneggevolezza dell’impero di Carlo Magno che mai ebbe un’organizzazione
economica e sociale degna di uno stato civile. Eppure segna il primo emergere della cultura europea”.
Capitolo 2. Unum imperium, unum ius. Le origini medievali del diritto comune.
Il dogma universalistico della unità del diritto: un rinvio alle dottrine della scuola giuridica di Bologna.
La concezione del Sacrum imperium, non poteva non trovare una unità omogenea anche nel diritto, un qualcosa che si
traducesse in una LEX COMMUNIS per tutti i popoli che l’impero comprendeva
storicamente parlando, ciò ebbe una lunga incubazione; solo nel XII secolo, con la nascita della “Scuola di diritto” a
Bologna e con il Rinascimento giuridico, troverà piena e completa elaborazione il processo della LEX COMMUNIS.
La scuola di Bologna, diventa sede di uno studio scientifico del diritto specificamente autonomo rispetto a quello noto alla
tradizione altomedioevale delle artes liberales dell’alto medioevo, fondando i proprio studi su una riscoperta dei testi
giustinianei elaborandoli come ufficiale diritto vigente; il diritto romano, secondo i giuristi medesimi, quindi si trova a
sovrastare i diritti particolari dei vari popoli.
Il diritto romano giustinianeo, quale communis lex, entra quindi nei paesi dell’occidente europeo, ma solo nell’ambito
romano-germanico avrà vigore e legittimazione politica-formale e in base alla teoria delle fonti. In tutti gli altri Stati si
diffonderà come una forma di cultura e di rispetto nei confronti della prestigiosa interpretazione italiana e della razionalità
dei suoi schemi concettuali.
La tradizione della “lex romana” nel Medioevo barbarico e feudale.
E’ vero che l’idea di LEX COMMUNIS della respublica christiana è posta in essere dalla scuola di Bologna, ma è pur
vero che nell’età carolingia e post-carolingia, storicamente parlando, precedente al XII secolo, ci sono delle tracce e degli
elementi di quest’idea.
Per cogliere tali tracce basti pensare, da un lato, alla forza suggestiva dell’idea di Roma domina mundi tradottasi
nell’idea di respublica dei credenti in Cristo unificata sotto la guida del pontefice e nell’idea dell’unificazione delle
molteplicità degli ordinamenti politici sotto il potere dell’imperatore consacrato a Roma.
Da un altro lato alla territorializzazione del diritto romano sommerso nel periodo delle invasioni barbariche da una
miriade di leggi “personali” che il mito di Roma aspirava a far convergere verso un diritto universale comune a tutti i
popoli conviventi sul territorio dell’impero.
Fenomeno preparatorio rilevante l’emergere della lex romana, quindi, proprio in questo periodo, tra fine X e metà XI
secolo, che vede in Germania il pluralista sistema giuridico della personalità del diritto. Il tutto rafforzato da vari fattori
quali una fusione etica e spirituale delle genti latine e germaniche con l’emergere di un linguaggio comune, il comune
organizzarsi delle scuole episcopali nelle varie città, la recezione delle stesse norme romane nei testi canonistici e il
ricorso ad esse nell’interpretazione e applicazione del diritto longobardo e franco.
Questo, a Pavia, capitale del Regnum Italiae, è oggetto di elaborazione scientifica e insegnamento; i giuristi in ciò
impegnati, conoscitori dei testi romano-canonici, con questi ultimi lo integrano laddove risulti lacunoso e incompleto.
A tutto questo si aggiunse la volontà di AGOBARDO, arcivescovo di Lione, che manifestò un’espressa condanna verso la
tanta diversitas legum per un popolo (siamo nel periodo dell’impero italo tedesco, successivo quindi a Carlo Magno) che
seguiva interamente l’una lex Christi.
In conclusione, tali fermenti non consentono però alcuna saldatura teorica generale tra la renovatio imperii e una
conseguente esigenza di renovatio del diritto romano . Saldatura che si dovrà alla scuola giuridica di Bologna e al
“rinascimento giuridico” del XII secolo la cui nuova scienza romanistica legittimerà il diritto romano come lex omnium
generalis, diritto universalmente valido nella respublica christiana.
Ancora una volta l’impero è l’oggetto e non il soggetto dell’operazione; non è lui che ridà vita alla scienza giuridica
romana ma è quest’ultima a spiegare i tratti di un impero universale e del suo imperatore, solo conditor et interpres del
diritto, sciolto dalle leggi, egli stesso lex animata in terris, signore del mondo: dominus mundi.
Le “Quaestiones de iuris subtilitatibus” e il problema dell’unità del diritto nell’età del rinascimento politico medioevale.
Nelle Quaestiones de iuris subtilitatibus, trattatello giuridico opera del glossatore Piacentino, trova luogo la
razionalizzazione teorica del principio di unità dominante nel medioevo. A fondamento della indiscussa legittimità delle
norme dell’impero è richiamata direttamente l’autorità divina.
Queste norme sono per eccellenza i precetti romani emanati dai Cesari e dai loro successori per il proprio impero,e il capo
dell’impero non può tollerare che le statuizioni, a suo tempo promulgate dagli imperatori barbarici, continuino ad essere
osservate come diritto vigente, con la conseguenza che vi siano “totidem fere leges…quot domus”
E’ necessario che ci sia un diritto comune discendente, secondo Piacentino, dall’unità dell’ordinamento giuridico.
Infatti poiché l’imperium è idealmente, per volere stesso di Dio, l’ordinamento simbolo dell’unità della comunità
cristiana, nel duplice aspetto religioso e civile, l’unum ius cioè il diritto romano, non può non essere il diritto universale
vigente in tutto l’imperium stesso.
La pluralità degli ordinamenti politici: molteplicità e unità nel mondo medievale del diritto
L’autore delle QUAESTIONES trae delle conclusioni che chiudono una fase nella storia dell’unità giuridica europea.
E’ questa un’età che, come detto, getta le proprie fondamenta nel 9 secolo e si lega alle vicende politico-culturali
dell’impero romano cristiano d’Occidente mettendo a fuoco una cultura giuridica, con un unico IUS, che dominata dalla
fede cristiana possa farne di quest’ultimo l’universale in tutto l’impero.
Dal XII secolo in poi il concetto di UNUM IUS diventerà poi l’IUS COMMUNE attraverso un processo culturale di cui
ne seguiamo i tratti.
Al tempo delle QUAESTIONES, alla fine del XII secolo, l’impero appariva, per varie circostanze politiche e spirituali
connesse alla crisi del mondo feudale, un mosaico di ordinamenti giuridici particolari tutti volti alla propria indipendenza
e ognuno dei quali si reggeva su proprie consuetudini, costituzioni e statuti.
La concreta struttura è caratterizzata da una pluralità di ordinamenti giuridici, territoriali e personali, più o meno
indipendenti a cui consegue un fenomeno di particolarismo nel mondo delle fonti del diritto.
La società si apprestava a vivere un’età di “rinascimento” e il fenomeno più rilevante si riscontra nel sorgere di una
civiltà comunale basata sui liberi comuni.
A questo rinascimento della società si legano anche dei fatti storici quali la lotta per le investiture conclusasi a Worms nel
1122, la riforma gregoriana della chiesa, le crociate, ma è la nascita della scuola giurista a Bologna e della scienza
giuridica fondata sul diritto romano che avrebbe dominato l’Europa per tutta l’età moderna (di cui le Quaestiones sono il
prodotto più cospicuo) il più rilevante.
Come conciliare l’unum ius nell’unum imperium con la pluralità di ordinamenti giuridici creatisi entro l’impero stesso?
In ambito italiano, tali norme sono rappresentate perlopiù da consuetudini e statuti cittadini.
Per esempio nel REGNUM SICILIAE, vasto fino a confinare con lo Stato Pontificio, ritroviamo l’imponente complesso
della legislazione sovrana normanno-sveva (le Assise Normanne promulgate nel 1140 dal re RUGGERO II e le
Constitutiones Augustales emanate a MELFI nel 1231 da FEDERICO II) norme vigenti in modo preminente e generale.
Quanto alle consuetudini locali, la fonte più antica del diritto e da sempre tramandata in via orale, saranno ancora così
tramandate per poi nel secolo successivo consolidate, essendo messe per iscritto.
Le raccolte scritte di consuetudini, quindi, diventeranno la prima manifestazione della pluralità degli ordinamenti giuridici
minori (essendo cittadine), che sono venuti emergendo entro l’orbita dell’impero, in ogni sua parte, e che ora
contrappongono le loro norme di convivenza , garantite dalla forma scritta, a quelle cui l’autorità superiore
dell’imperatore, dei signori e dei sovrani, tende ad assoggettarle.
accanto alla raccolta di consuetudini, vanno crescendo gli Statuti comunali, piccoli codici in cui le nuove comunità
politiche particolari, nelle forme ufficiali previste dall’ordinamento di ciascuna, fissano il proprio libero assetto
costituzionale e amministrativo, le proprie procedure giudiziarie, le proprie regole di diritto privato.
Lo statuto esprime non una volontà normativa e sovrana come quella incarnata nella lex imperiale ma l’autonomia che
ciascun ordinamento particolare rivendica entro i propri confini nei confronti della Lex medesima pur riconoscendone la
sovranità della sua superiore autorità di intervenire ove lo statuto taccia.
Talvolta gli statuti lasciano intatte le CONSUETUDINI gia formatesi in loco, altre volte si sostituiscono ad esse e altre
volte ancora sono proprio le stesse consuetudini che, per volontà delle autorità comunali, vengono ufficialmente
trasformate in statuto, assumendo la medesima forza cogente di cui sono munite le due tipiche manifestazioni formali
della volontà statutaria:
- i BREVIA giurati delle magistrature comunali
- le DELIBERAZIONI delle assemblee cittadine (“statuta” in senso stretto).
La gamma degli statuti si diversifica in moltissime forme; nell’ITALIA CENTRO SETTENTRIONALE, ove lo statuto
non si subordina ad una legislazione regia ma presuppone unicamente la concorrenza di quella imperiale,iI codici
comunali dei più grossi e potenti centri cittadini, raggiungono nel XII e XIV secolo, una notevole consistenza: sono
articolati in più libri, in titoli e rubriche, sottraendo al diritto dell’impero la disciplina di una amplissima serie di rapporti
giuridici.
Ampiezza minore e minore spazio di incidenza, gli Statuti dei centri minori.
Particolari forme di statuti sono gli statuti marittimi in cui i centri portuali raccoglievano le loro consuetudini in materia di
navigazione e commercio; gli statuti corporativi ove i associazioni e corporazioni di mestiere portavano le loro
consuetudini in materia di organizzazione interna conferendosi una autonoma disciplina di cui il codice è
contemporaneamente vincolo e modello.
L’unum ius quindi deve ora misurarsi con questa abbondante, normativa impossibile da paralizzare, contenente energie
vitali e insopprimibili volte a sottolineare la propria indipendenza, specie a livello comunale, nata come superamento del
sistema della personalità del diritto di cui l’autore delle Quaestiones, auspica la fine.
Il problema di rapporti tra vecchi e recenti poteri fu superato grazie all’idea centrale dello ius commune.
Tale espressione indica il diritto romano imperiale concepito come elemento di un sistema organizzato di fonti giuridiche
nel quale esso, come diritto generale e universale, si coordinasse secondo certe regole ai diritti locali e particolari.
In tal modo, tramite tali industriosità, l’antico diritto romano è divenuto diritto del presente tornando a rivivere e
alimentandogli strati più profondi del pensiero giuridico occidentale.
La configurazione originaria del concetto di “ius commune”: l’ideologia giuridica universalistica
Il quadro del contrasto tra lo ius propriium degli ordinamenti particolari e l’unum ius dell’impero è tracciato, dunque, con
chiarezza assoluta nelle QUAESTIONES DE IURIS SUBTILITATIBUS sottolineando soprattutto che quando si parla di
unum ius, si vuole indicare il diritto unico dell’impero, e non il diritto unico nell’impero, ovvero lo ius commune
contrapposto al complesso degli iura propria di ciascun popolo, l’unità da cui la molteplicità deriva.
L’espressione UNUM IUS compariva già in un celebre frammento delle ISTITUZIONI DI GAIO accolto nel Digesto,
volto a designare il diritto delle genti basato sulla naturalis ratio, patrimonio collettivo di tutta la comunità umana.
Nel linguaggio del giurista medioevale il termine comune diventa IL DIRITTO ROMANO cioè il diritto dell’impero
universale emanato in vista delle esigenza della respublica christiana e avente come propri destinatari tutti i vari popoli
organizzati in singoli ordinamenti giuridici; in questo quadro, l’impero e il suo diritto diventano l’unità, cui si collegano
in subordinazione le norme che provengono da ogni parte dell’impero.
Tale schema gerarchico, di schietta natura scientifica, presenta il diritto comune nell’ambito di un sistema di fonti
normative sorrette da un’unica ratio nel quale esso è, posto in preminente posizione gerarchica, sorgente da cui
scaturiscono i diritti particolari, ai quali non è lasciato spazio se non laddove la legge generale non provveda e non
contrasti con questa.
Utilizziamo il concetto di sistema poiché tale quadro risulta essere sistematico nel momento in cui istituisce vincoli di
coordinazione tra le fonti giustinianee e il diritto particolare.
L’ideale di unità non riuscì mai ad essere oscurato, neppure dai conflitti di potere delle due forze configgenti: la Chiesa e
l’Impero. La naturale veste giuridica di questo ideale era il diritto comune: età d’equilibrio questa, tra universalismo e
particolarismo.
Solo lo stato moderno, nella sua evoluzione post-medievale verso l’assolutismo, avrebbe rotto quest’equilibrio:
frapponendosi tra i due estremi gli avrebbe annientati sulla pretesa di essere l’esclusiva forma perfetta di ordinamento non
derivante da alcuna volontà trascendente che non fosse la propria sovranità.
L”utrumque ius”: la legge della chiesa e la legge dell’impero.
La questione più importante, in special modo nel XII secolo, nell’ambito del concetto di ius commune, è quella del
rapporto tra impero e Chiesa e relativa rilevanza dei rispettivi ordinamenti normativi.
I dibattiti dottrinali che ne nacquero, furono roventi e plurisecolari per il loro diretto collegarsi al più ampio scontro
politico fra la dottrina curialistica (che presuppone la superiorità del pontefice) e la dottrina imperialistica (che teorizza la
separazione dei due poteri).
Pur attraverso incertezze e contrasti mai pienamente conclusi, si arriva alla formulazione del postulato della ordinatio ad
unum delle due potestà supreme, sovrane e indipendenti, aventi ciascuna la propria iurisdictio e produttrici di due separati
corpi normativi.
Si presuppone, quindi, la loro reciproca irrilevanza: le norme canoniche vlte a regolare casi temporali valgono solo nelle
terre soggette al pontefice; diversamente, ogni sfera è a se e non deve ricevere intromissioni dall’altra.
Tuttavia, l’ordinatio presuppone uno stretto legame tra norme imperiali e canoniche costituenti insieme lo ius commune.
Questa conciliazione fu resa dai giuristi con l’espressione UTRUMQUE IUS, che indicava il rapporto essenziale tra i due
mondi, distinti ma al tempo stesso coniuncti.
L’idea dell”imperator dominus mundi” e la “potestas” degli Stati nazionali cristiani: verso il moderno concetto di
sovranità.
Ulteriore questione quella riguardante i problemi pratici e teorici connessi alla pluralità degli ordinamenti giuridici.
In tutto il continente europeo era emersa una molteplicità di monarchie territoriali e nazionali indipendenti che tuttavia
rimanevano legati a Roma dal comune vincolo ideale della cristianità, già a fondamento di quella che fu l’unità politica
poi dissoltasi nel crollo carolingio.
La giurisprudenza medioevale, specialmente in Italia e in Francia, costruì un fondamento teorico al carattere sovrano di
questi regni, postulando che i nuovi monarchi potessero rifiutare l’autorità di qualsiasi SUPERIOR e che ciascuno di essi,
in regno suo, avesse appunto quella stessa potestà che l’imperatore esercitava per volontà di Dio su tutta la terra, pur
rilasciando all’imperatore, una superiorità del tutto formale.
Nonostante tutto questo, il mito di Roma e dell’imperatore come dominator mundi era davvero forte; questo soprattutto
perché Roma era capace di suggestionare culturalmente e religiosamente tutta l’Europa, sin da quando l’imperatore
Ottone I fu incoronato a capo dell’impero romano-germanico, fino a quando quest’ultimo fu definito, da Federico I,
sacrum.
Essendo il medioevo cristiano e, quindi, universale, come osservato da KOSCHAKER, per l’uomo medioevale il
contrasto fra cristiani e pagani è molto più importante di quello fra tedeschi italiani e francesi.
Ciò riporta poi l’attenzione su un altro tipico carattere della mentalità medioevale, che è quello d’essere dominata
dommaticamente dal principio d’autorità e di essere priva di ogni reale capacità di penetrazione storica: ecco perché l’idea
autoritaria di Roma e dell’impero romano non è assolutamente un concetto del passato, ma una realtà presente
sprigionante tutto il suo fascino.
In effetti è troppo semplice pensare che l’antica ideologia di ROMA DOMINA MUNDI, andasse via via eclissandosi
semplicemente cedendo il passo alla forza di concezioni e di situazioni politiche nuove.
Al contrartio, quella ideologia, illanguidendosi , offriva alimento indispensabile alle idee nuove.
E’ attraverso l’utilizzo del concetto di imperium che i giuristi del periodo vollero giustificare la plenitudo potestatis dei
monarchi di quel tempo.
“Ius commune” e “ius proprium”: l’evoluzione del concetto di ius comune come diritto universalmente sussidiario
I giuristi medioevali, affrontando il problema di trovare un fondamento legittimo all’insieme dei poteri che ogni
ordinamento esercitava per autogovernarsi, volsero in modo specifico la propria attenzione alla potestà di emanare norme
giuridiche. Il problema per eccellenza la legittimazione dei comuni come fonti del diritto, come fonti di ius proprium,
valido di fronte al diritto comune.
I comuni rivendicavano gelosamente la potestà di darsi leggi proprie (statuti), di emanarle se era il caso anche contro lo
ius comune, di applicarle con assoluta precedenza nei suoi confronti e di interpretarle secondo criteri letterali.
I comuni richiedevano, inoltre, la formazione di un diritto suppletivo in relazione al solo diritto romano e non a quello
canonico, insofferente di deroghe e limitazioni.
In breve, fino a quasi tutto il XIII secolo, mentre i comuni cercano di strappare a quel potere politico, che la scienza
giuridica teorizza come esclusivo, la facoltà di graduare gerarchicamente le fonti e cercano di imporre l’assoluta
precedenza della norma statutaria, i giuristi resistono a questa pressione. Reagiscono tentando, a loro volta, di ribaltare la
situazione, difendendo la prevalenza gerarchica del diritto comune e dichiarando legittime le sole norme del diritto
particolare che con quello non contrastino.
Lo spirito di sistema suggerisce loro una visuale in cui il diritto dell’impero appare davvero quell’unum supremo e
universale che non implica la scomparsa di ogni legge concorrente, ma al quale tutti gli altri diritti devono coordinarsi e
subordinarsi. Gli Statuti dunque, in questo quadro prospettico, risultano essere una eccezione al diritto comune, laddove
questo è venuto configurandosi come tale, perché ritroviamo lo ius proprium.
Ma gradualmente, verso la fine del XIII secolo, la forza di pressione della legislazione particolare, diventa irresistibile e il
fenomeno dello IUS STATUENDI appare un fatto compiuto.
Il diritto statutario si impone, con la suggestione dei suoi impulsi creativi e non solo con il consolidamento delle
autonomie; esso è la vera chiave della questione: gli sono riconosciuta precedenza sul diritto comune che assume una
funzione sussidiaria, rendendolo però ancor più comune perchè postula una pluralità di sistemi operativi che ne
partecipano a motivo della propria insufficienza, si erge quindi senza rivali sugli schemi elementari e lacunosi del diritto
statutario.
Lo ius comune si presenta dunque, ora più che mai, quale corpus normativo universale e quindi completo che va a
colmare lo ius proprium, ma che si vanta dello ius proprium, da cui si è rigenerato, per essere ancor più efficiente, vigente
e completo.
La visione pluralistica dell’esperienza giuridica: l’autonomia degli ordinamenti particolari
Tale piena legittimazione allo ius proprium si operò attraverso delle teorie che furono di più ampio respiro dal momento
che, elaborata la teoria della permissio, la potestas condendi statuta fu concessa ai comuni dallo stesso imperatore.
Il grandissimo giurista trecentesco BARTOLO DA SASSOFERRATO ritrovando nello stesso concetto di iurisdictio la
legittimazione della potestas statuendi quale necessaria manifestazione della facoltà di autogoverno di ciascun
ordinamento, affermò che quanto più ampie sono tali facoltà che l’imperatore in persona conferisce ai comuni, tanto più
ampia è la loro potestà normativa e viceversa.
Il suo discepolo BALDO DEGLI UBALDI, enunciando una dottrina ancor più profonda, giustifica l’esistenza delle
comunità politiche con il diritto naturale. Queste comunità nascono come vitale fenomeno spontaneo, senza derivare da
alcuna formale fonte di potere, da alcuna autorità superiore da cui derivare la propria esistenza; è proprio tale esistenza a
conferire il relativo regimen, cioè la propria organizzazione. Ciascuna comunità politica deve, per il solo motivo che
esiste, reggersi con delle norme che provvedano alla sua vita e che, di conseguenza, non derivano da alcuna fonte
autoritaria esterna.
Questa giustificazione dello ius proprium per la prima volta apre ad una completa visione pluralistica dell’esperienza
giuridica.
Occorre poi notare il carattere dell’intervento teorico “a posteriori”, proprio di tale speculazione della giurisprudenza
medioevale, che non fece che offrire un successivo supporto dottrinale a quel diritto che si sosteneva già essenzialmente
sull’indiscutibile forza politica degli ordinamenti che lo esprimevano.
Ultimo dato altrettanto importante in questa complessa operazione politico-culturale di salvaguardia dell’universalismo
attraverso il recupero del particolarismo, il fatto che lo stesso ceto dei giuristi si sia trovato, ad un certo punto, coinvolto
nella vita politico-giuridica degli ordinamenti particolari.
I giuristi divennero spesso i diretti compilatori, o i consulenti dei compilatori, degli statuti cittadini e si trovarono a
svolgere attività diplomatiche e amministrative di non poco rilievo nell’ambito di queste repubbliche: piccoli e grandi
sistemi di potere capaci di impegnare, professionalmente e politicamente, il doctor che, tuttavia, a sua volta vi immetteva
la sua tecnica e la sua mentalità razionalizzante, la sua terminologia e le sue categorie astratte.
Tuttavia, era necessario che il ceto dei giuristi si rendesse indipendente da condizionamenti e seppur legato da mille fili
alla volontà delle autorità pubbliche, si ritagliasse un’autonoma area d’azione a livello professionale che ne faceva, del
ceto stesso, un prestigioso gruppo di potere che appariva più in rapporto di alleanza che di subordinazione con l’autorità
politica.
Capitolo 3. Diritto comune e gerarchia delle fonti alla crisi del pluralismo politico medievale
Principati e regni in Europa: la concentrazione del potere e del diritto nel processo formativo dello Stato moderno.
Il secolo XVI rappresenta, cronologicamente, un momento di non lieve trasformazione per il concetto medievale di diritto
comune.
Nel cercare di cogliere come e perché questo accada, si dà per presupposta la distinzione tra la situazione dei territori
imperiali e situazione dei territori già investiti dal processo di formazione della nazionalità.
Un’altra distinzione va presupposta all’interno dell’area imperiale: tra paesi italiani e paesi germanici.
Nei territori estranei all’area italo-tedesca e svincolati dall’impero romano-germanico, le dottrine della giurisprudenza
medioevale sulla plenitudo potestatis degli ordinamenti monarchici avevano assolto la funzione di giustificare le pretese
di assoluta indipendenza politica e legislativa di quei regni nei confronti dell’imperatore, solo indirettamente
riconfermato dominus mundi ma, di fatto, non più esercitante alcuna egemonia;
Ne derivava che il diritto comune, in tali regni, era applicato solo se accettato e reso parte del diritto nazionale dal
monarca dello stato: il vigore, a titolo sussidiario, si basava quindi sul mero consenso dei sovrani (placitum regis); ciò si
delinea già nel XIII secolo, definendosi nella prima metà del XIV.
Nei paesi invece collegati direttamente all’impero, come il territorio italico, le teorie medioevali avevano avuto il
compito di coordinare in tipici sistemi di fonti coesistenti il diritto romano-canonico e la varia normativa di città e
signorie territoriali: al tempo stesso hanno, quindi, legittimato gli autonomi poteri della pluralità degli ordinamenti minori
e hanno salvaguardato teoricamente la suprema e unitaria autorità imperiale.
Il fatto che l’impero fosse in liquidazione e che comuni e signori fossero pienamente indipendenti e avessero il potere di
legiferare, anche contro i principi dello ius comune, non escludeva che il diritto romano fosse, per antonomasia, il diritto
dell’impero; anche se era venuto ad assumere un valore sussidiario rispetto ai preminenti ordinamenti positivi delle
singole comunità era pur sempre la ratio di un sistema politico-giuridico teoricamente unitario in cui quelle comunità si
riconoscevano.
A partire dalla fine del secolo XV questa concezione ancora universalistica del diritto comune entra in una profonda crisi
di evoluzione: la posizione riservata, nei territori italiani, allo ius commune si avvia, infatti, a divenire quella che gli vien
riservata già dal XIII secolo dalle grandi monarchie nazionali europee estranee all’impero.
Tale crisi è ovvia conseguenza di alcuni cambiamenti nell’assetto politico dei paesi italiani: essi vanno strutturandosi,
attraverso l’esperienza delle signorie e successivamente del principato, in forme di organizzazione statuale su base
regionale, simili a quelle delle grandi monarchie nazionali europee.
Queste ultime erano venute politicamente consolidandosi destinando via via alla crisi e al tramonto la grande idea del
medioevo che postulava una unità universale fra la società religiosa e la società civile e si avviavano ad organizzarsi in
quella forma tipica accentrata e burocraticamente organizzata dello stato moderno, solitamente identificata con
l’assolutismo monarchico.
Ciò finì per svuotare di significato anche solo teorico l’ideologia universalistica della comune appartenenza ad un unum
imperium. Mutò così il configurarsi del concetto di IUS COMMUNE che venne ad inquadrarsi in una teoria delle fonti,
simile a quella già da tempo emersa nei regni d’Europa, ove era presente ad altro titolo che non fosse quello imperiale
cioè con esclusivo riferimento alla sua qualità sussidiaria e non più universale.
Tale evoluzione culturale variò nel tempo e negli ambienti politici ma giunse comunque ai suoi sbocchi più maturi fra la
fine del XVI e gli inizi del XVII, nell’età degli stati principeschi italiani e degli stati della penisola soggetti al dominio
spagnolo, francese e austriaco anche detta Ancien règime .
Il principato, dunque, costituitosi come sviluppo del governo signorile, sul pieno disfacimento politico delle autonomie
comunali, tende ad affermarsi quale ordinamento sovrano e primario, unitariamente sorretto da un potente e organizzato
governo centrale e da un’articolata amministrazione burocratica: risulta essere, quindi, stato di tipo patrimoniale e
autocratico che persegue una politica di accentramento amministrativo, legislativo e giudiziario.
Per certi aspetti, anzi, si può dire che questa nuova formula di organizzazione del potere politico emerga attraverso un
processo di interno assorbimento delle autonomie di origine medioevale piuttosto che dallo sfaldarsi esterno dell’impero,
fenomeno questo già praticamente concluso con la formazione delle signorie territoriali accentrate nei comuni dominanti.
Negli ordinamenti principeschi,quindi, la formazione dell’unità statuale passa attraverso due fasi successive: quella del
superamento esterno dell’universalismo e del pluralismo medievali e quella del superamento interno degli elementi
residuali di quei modelli di organizzazione
La nuova strategia assolutista fa perno sulla figura del princeps, formalmente soggetto de iure all’imperatore di cui è
nominato vicarius e per questo legittimato dei poteri che esercita senza, di fatto, alcuna intromissione imperiale.
La “statualizzazione” del diritto comune e il dissolversi del suo antico fondamento imperiale.
Il principe ora, in tale contesto che indubbiamente modifica il quadro delle fonti giuridiche, appare come come la prima e
suprema fonte di produzione del diritto, con la conseguenza che ogni altra norma a lui non risalente ma derivante da altri
ordinamenti interni o esterni al suo Stato, è giuridicamente rilevante solo se oggetto di sua approvazione e di
sottoposizione al suo controllo.
In questo modo, fra lo IUS COMMUNE e lo IUS PROPRIUM, si contrappone la nuova legislazione generale dello stato,
che basandosi sulla volontà assoluta dello stesso sovrano, di cui è espressione, tende a porsi come diritto comune primario
in quanto impone la propria precedenza assoluta su ogni altra fonte di diritto.
In questo contesto però, se si vuol far riferimento al diritto romano , unico vero diritto considerato universale, si riscontra
una posizione alquanto mutata: ad esso viene a mancare quella che è la componente imperiale del diritto, il fondamento
legittimo della sua applicazione, liquefattasi nella realtà frammentata delle signorie e dell’assolutismo principesco.
Ora è la volontà dei principi la base della sua applicazione, che fa sì che sia pur sempre commune ma come diritto dello
Stato, all’interno della quale è sussidiario e subordinato alla superiore normativa generale sovrana.
La posizione del diritto romano imperiale appare ora esattamente rovesciata rispetto alla situazione medievale: in
quest’ultimo caso erano gli iura propria degli ordinamenti particolari ad esser vigenti in quanto derivanti dal consenso
dell’imperatore, da lui accettati come localmente suppletivi del diritto universale. Gradualmente, invece, è lui ad esser
considerato, ovunque, sussidiario rispetto ai diritti locali fino poi, tra il secolo XV e XVI, nei vari stati principeschi in
formazione, all’avvio di un fenomeno già prospettato da tempo: il diritto comune diviene DIRITTO POSITIVO dello
stato in virtù della accettazione, espressa o tacita, fatta dal sovrano, non più in virtù della sua origine imperiale.
In questo modo si particolarizza e si regionalizza ed è comune solo in ciascuna unità politica nazionale statuale.
Si può parlare, quindi, di diritto comune particolare.
Il capovolgersi del fondamento legittimante la vigenza è, dunque, collegato al definito disfacimento dell’ideologia
universalistica. I nuovi stati sovrani fondano le loro strutture laiche, razionali e autosufficienti, sulla tabula rasa
conseguente alla distruzione dell’universalismo e quindi del particolarismo politico, poli dell’equilibrio medievale rottosi
anche sugli ultimi lembi di territorio europeo non germanico ove era sopravvissuto.
Solo la Germania, nella metà del 500, era stata rifugio dell’idea e del titolo imperiale, che si dissolverà più avanti, verso la
metà del XVII secolo, quando anche qui i principati innalzeranno la loro sovranità di fronte all’impero.
Tale particolarizzazione del diritto comune si ripercuote sulla sua sostanza normativa: all’interno di ciascuna unità
statuale, assume lineamenti propri, diversi da Stato a Stato; ogni compagine politica gli imprime un’impronta sua a
seconda delle proprie tradizioni ed esigenze.
E’ consegnato alla prassi giudiziaria, sensibile alle tendenze politiche e ai bisogni locali e si differenzia, parzialmente, da
Stato a Stato.
Questo processo di differenziazione che tende a fare del diritto comune un particolare patrimonio giuridico che ciascun
ordinamento amministra, assimila e reinterpreta secondo la peculiare situazione socio-economica interna è, con le dovute
eccezioni, fenomeno tanto più sensibile, quanto più ci si avvicina nel tempo all’età delle codificazioni e se proiettato nel
vasto contesto europeo.
Considerando i diversi stati dell’Europa che, in vario modo, hanno recepito anch’essi quale IUS COMMUNE, il diritto
della compilazione giustinianea e della sua intepretatio italiana, si può parlare più di una tendenza alla nazionalizzazione
del diritto comune, che di una tendenza alla differenziazione dello stesso.
La sopravvivenza di uno ius commune superstatale nell’età moderna
La tendenza ad una statalizzazione del diritto comune in atto nella giurisprudenza dei supremi tribunali centrali convive
pur sempre con la non sopita tendenza contraria, quella tendenza ad uniformarsi agli indirizzi giurisprudenziali accreditati
presso più paesi.
Questo perché il fenomeno non è radicale e neppure nella sua fase più matura si crea assoluta inconciliabilità ed estraneità
fra i diritti comuni regionali sviluppatisi nei vari ordinamenti: i caratteri di universalità, continuità e unità prevalgono e
ciò ad opera dei grandi giuristi italiani dei secoli XII-XVI che lo salvaguardano e alla cui prestigiosa opinione è
subordinata anche la prassi dei supremi collegi giudicanti di diffusione europea.
Laddove una certa soluzione scaturiva unicamente da un atteggiamento dottrinale scavalcava le barriere geograficopolitiche e trovava ovunque identico accoglimento di fondo.
Lo ius comune, dunque, è sempre concepito come sistema legale completo, l’unico capace di sopperire alle insufficienze
degli ordinamenti positivi che lo accolgono: una universalità comprovata dal fatto che si prenda atto dalla regola che
risulti praticata presso i tribunali supremi di più Stati.
Esauritasi, infatti, l’epoca scientificamente più robusta e produttiva delle scuole di diritto, la giurisprudenza ha assunto ora
un carattere prevalentemente pratico e avvocatesco: lo svolgimento del diritto comune è ormai affidato alle decisioni dei
tribunali; il lavoro dei giuristi vive un erosione e viene sottoposto a controllo essendo ora la figura del magistrato o
dell’avvocato ammesso a patrocinare presso il tribunale, modello dominante.
Si può dire che, nella nuova giurisprudenza, il diritto comune entra ancora, con l’autorevole assetto che gli è stato
conferito dal diritto medioevale, negli squarci dei sistemi normativi degli stati assoluti passando, però, entro il filtro della
quotidiana prassi giudiziaria che seppur lo salvaguardi fa sì che molte sue norme siano variate in relazione alla situazione
di ciascun ambiente politico. Il tutto, ovviamente, non va ad intaccare il loro contenuto o i loro principi.
Il diritto è comune in quanto lo è PLURIBUS PRINCIPATUS cioè partecipato da più ordinamenti politici. Si parla, così,
di “diritto comune europeo”; il diritto comune principesco, invece, è tale solo in un principato .
Capitolo 4. L’elemento canonico del diritto comune: la costruzione e lo svolgimento di uno ius commune
in spiritualibus (sec. XII – XVI)
Il volto spirituale di un diritto universale
Secondo la concezione di utrumque ius, lo ius comune sarebbe anche dal diritto canonico.
L’idea di un unico ordinamento normativo, temporale e spirituale, era stata un fermo pilastro della coscienza medioevale.
L’ordinatio ad un unico fine di CHIESA ed IMPERO postulava che IUS CIVILE e IUS CANONICUM, pur distinti nelle
loro sfere di applicazione, si componessero nella ideale unità dello IUS COMMUNE attraverso lo stretto rapporto della
comune dipendenza dalla volontà di DIO.
La concezione unitaria dei due diritti si alimentava attraverso una visione integralmente religiosa dell’ordinamento
immaginato come poggiante su un’unica e originaria norma di sostegno, la volontà divina.
E’ dunque questa una visione biblica del diritto, la questione fondamentale della idea medioevale di legge.
L’elaborazione e l’interpretazione del diritto romano, era stata fatta, del resto, non molti secoli prima, tenendo conto dello
spirito suggerito dalla chiesa cristiana tanto che, a sua volta, la stessa chiesa, fin dai più lontani secoli, aveva fatto della
lex romana la propria lex saecularis, una legge sempre più legata al sistema ecclesiale e ai canoni.
Il diritto romano ha conferito apporti decisivi alla chiesa, alla struttura e alle prassi interne ricevendone una nuova
animazione per essere corpo vivo e vitale.
Dal “Decreto” di Graziano al “corpus iuris canonici”
Il corpus della normativa canonistica è venuto costruendosi nel clima della grande riforma gregoriana della chiesa, in
connessione con la quale, non erano mancate robuste collezioni volte a tentare un primo riordinamento del materiale
normativo che si ebbe poi solo nel XII secolo ad opera del monaco camaldolese GRAZIANO che, prendendo spunto dal
teologo ABELARDO nel famoso SIC ET NON, scrisse il celebre DECRETUM dal titolo “concordia discordantium
canonum”. Fu questo un testo con cui Graziano, lavorando mediante il metodico assestamento dialettico dei vari testi
sacri, puntava alla razionalizzazione normativa ovvero al concordare le antinomie fra i precetti accumulatisi nel tempo.
Graziano, insomma, aveva riunito un certo numero di testi di diversa provenienza (auctoritates), li aveva raggruppati per
soggetto aggiungendovi talvolta un breve commento (dictum) e quando certi testi di autori diversi si presentavano
contrastanti, cercò di conciliarli attraverso i loro punti comuni, talvolta anche minimi, o di tirarne fuori una dottrina su cui
è possibile appoggiarsi .
Il metodo utilizzato, ripreso da Abelardo, era nuovo: poneva volta per volta una quaestio, ne prospettava opposte
soluzioni, individuava quella che potesse sciogliere il problema oppugnando l’argomentazione contraria.
Vennero così coordinati 3823 testi in esso contenuti: l’opera fu messa al pari dello stesso IUS CIVILE e pur essendo non
ufficiale conquistò un immenso prestigio.
Al Decretum, che aveva aperto ampi orizzonti per il diritto canonico successivo, seguirono varie raccolte di
DECRETALES, emanate successivamente dai pontefici, tra i quali ALESSANDRO III e INNOCENZO III; ritroviamo le
c.d. Quinque compilationes antiquae.
Nel 1234 poi, papa GREGORIO IX promulgò la propria maestosa collezione di “decretales” in 5 libri, Liber
Extravagantium, nel senso che raccoglieva decretali che erano extra, cioè fuori dal Decretum di Graziano
Il Liber Extra costituiva il mediato e ufficiale riordinamento tecnico di tutta la abbondante produzione normativa
successiva al Decretum.
Le decretali di Gregorio IX, che avevano forza di legge, divennero col DECRETUM il principale oggetto di studio e di
elaborazione scientifica fino all’entrata in vigore del Codex Iuris Canonici nel XX secolo.
Nella compilazione Gregoriana, il diritto canonico si presentava sistemato entro quella grande partizione quinaria delle
materie delineatasi dopo Graziano:
1- orientamento dei tribunali ecclesiastici
2- processo canonico
3- vita dei chierici, monaci e gerarchie ecclesiastiche
4- matrimonio
5- delitti, pene, magistero punitivo della chiesa
Il Liber Sextus promulgato nel 1298 da papa BONIFACIO VIII e le Constutiones Clementinae del 1317 raccolte dai papi
CLEMENTE V e GIOVANNI XXII e successivamente, anche se senza carattere ufficiale, le Extravagantes Iohannis
XXII e le Extravagantes Communes, furono le compilazioni pontificie con cui ufficialmente si concludeva l’imponente
attività legislativa della Chiesa, forse la più imponente attività legislativa di tutto il medioevo, il cui Risultato era così un
corpus di sei distinte compilazioni, tre ufficiali e tre private,
E’ importante sottolineare che così come il diritto civile si fondi, in questo periodo, sull’opera moralizzatrice delle
consuetudini e degli usi, il diritto canonico si fonda su una natura prevalentemente legislativa.
Cenni ai caratteri della scienza giuridica canonistica: il coordinamento medioevale fra ius civile e ius canonicum
A questo grande corpo di norme solo nel 1918 sarebbe successo il Codex iuris canonici e su di esso si svolse un secolare
lavorio dottrinale.
L’intensa elaborazione scientifica svolta dai canonisti sul DECRETUM e sulle raccolte successive di DECRETALES,
presentava tipici caratteri che le derivano da 2 aspetti specifici:
1.dall’essere attività interpretative di un diritto in gran parte vivo e contemporaneo
2.dall’essere lavoro speculativo dominato dal problema di individuare il fatto umano, valutabile in termini puramente
giuridici, rispetto al fatto rilevante sul superiore terreno della dogmatica religiosa e della teologia morale.
Attorno al Decretum e alle decretales, si formarono apparati di GLOSSAE, TRATTATI e SUMMAE, opere di
sistemazione scientifica effettuata da giuristi del calibro di Paucapalea (discepolo di Graziano), Rolando Bandinelli,
Bernardo Pavese,...che esercitò una profonda influenza sulla giurisprudenza civilista.
Questa influenza fu ambivalente;La dogmatica civilista era indispensabile al canonista che, a sua volta, nell’occuparsi
degli aspetti spirituali della condotta umana toccava materie prettamente temporali invadendone il campo, soggetto al foro
“esterno”. La considerazione della ratio peccati e della salus animae , fondamenti prevalentemente cristiani, guidavano il
canonista anche in ambiti strettamente civilistici; l’ottica fu dunque quella del rispetto di valori quali l’aequitas,
l’indulgentia, la benignitas che, spesso, potevano contrapporsi al rigor dello ius civile.
Un romanista farà difficilmente a meno del diritto canonico, un canonista non potrebbe fare a meno del diritto romano
sentendo la necessità di citarlo, di applicarlo costantemente portando a maturazione certe tendenze del diritto romano.
L’ambito in cui le due dottrine e i due diritti confluirono concordemente fu quello del PROCESSO.
Sotto l’ottica dell’ordo iudiciorum romano, esso fu perfezionato dall’opera legislativa pontificia, i decretales, e da
un’opera di tessitura dottrinale svolta dalla scienza canonista, summae e trattati.
Il tipo di processo creato, scrisse il CAPPELLETTI, costituiva un meccanismo logico basato sugli atti scritti e non dalle
procedure orali dell’età feudale: tutto era razionalmente ordinato e previsto.
Strumento immediatamente attivo nella prassi, si diffuse rapidamente dalle corti ecclesiastiche ai tribunali supremi a
cominciare da quelli dei comuni italiani, costituendo procedura accolta e conservata fino al XVIII secolo in tutta Europa.
Tale processo, processo cattolico per eccellenza, fu definito romano-canonico: romano per la terminologia e il richiamo
alle fonti giustinianee da cui furono desunti i concetti fondamentali, canonico per le innovazioni provenienti da
disposizioni pontificie.
Come disciplinare eventuali contrasti tra precetto canonico e precetto civile?
La regola consisteva nel far soccombere la norma civile qualora si trattasse di questioni spirituali e pertinentes ad fidem.
In temporalibus, nelle questioni temporali invece, bisognava distinguere se il problema si ponesse ad un giudice delle
terrae subiectae Ecclesiae oppure delle terre subiectae Imperio. Nel primo caso, nuovamente, il diritto laico doveva
cedere il passo al canonico; nel secondo caso se l'osservare la legge civile costituiva peccato allora ci si atteneva a quella
corrispondente canonica; se invece non vi erano problemi di "ortodossia" allora ad essere applicato era il diritto civile
("aut servare legem est inducere peccatum...et tunc stamus canonibus..., aut non inducit peccatum, et tunc stamus legi")
Tale massiccia presenza del diritto canonico era dovuta alla presenza stessa della Chiesa nella società del medioevo, alla
stessa dimensione storica conferita alla Chiesa dalla visione medievale del mondo e della vita.
Questa aveva la struttura di un impero e la sua competenza si estendeva su tutte le questioni spirituali poiché nessuna
azione umana era estranea al peccato, ogni questione ha una certa vocazione spirituale: ecco perché la legge doveva
cercare di limitare il peccato dalle azioni degli essere umani, tenendo conto del fatto che persino il principe era un essere
umano e come tale, peccatore, e quindi soggetto ad una sorta di debolezza politica.
La Chiesa governava la famiglia attraverso la sua competenza esclusiva in materia matrimoniale, controllava la sfera
politica, sociale ed economica con le sue norme morali, che sancivano penitenze e censure.
Ius canonicum e Placitum Principis
Lo sfacelo dell’unità imperiale, lo scisma d’Occidente (1378-1429), l’avvento degli Stati monarchici e poi degli Stati
principeschi in Italia e in Germania non si determinò senza profonde conseguenze.
Già il sorgere dei regni nazionali, aveva spezzato l’unità politico giuridica dell’universo medioevale e l’idea di questa
unità era formalmente rimasta intatta solo nei paesi italiani e germanici, appartenenti all’impero; ora che gli stati nazionali
d’Europa andavano assolutizzandosi, contrastando con la dottrina del medioevo che teorizzava equilibrio e preminenza tra
la potestà imperiale e pontificia, e anche in Italia e in Germania venivano emergendo gli stati principeschi, anche l’unità
religiosa di una superstatale respublica christiana era destinata a dissolversi.
Avanza dunque, lo spirito laico connesso ad una assoluta sovranità statuale, cui si collegava il concetto di una totale
autonomia del potere terreno e di un primato laico dell’organizzazione civile che portava, inevitabilmente, mutamenti di
fondo nei rapporti tra Stato e Chiesa.
In Italia, le unità principesche inaugurarono una politica ecclesiastica caratterizzata dalla sottrazione alla chiesa di una
molteplicità di attribuzioni tradizionali e da una decisa ingerenza statuale nella sfera religiosa.
Lo Stato si erse, così, di fronte alla Chiesa, tendendo a prevalere su ogni altro valore etico e religioso.
Lo stesso processo si verificava in tutti gli Stati dell’Occidente e “a rincarare la dose” ci fu anche la Riforma protestante
che, dove attecchì, diede luogo alla rottura della tradizionale unità organizzativa cristiana e religiosa e al sorgere di chiese
nazionali indipendenti, controllate dai sovrani.
Questo marcato fenomeno di territorializzazione della chiesa e di nuovo particolarismo religioso non fu senza influenza
anche sulle monarchie nazionali dell'Europa rimasta cattolica. Anche qui, ad eccezione dei principali italiani, le chiese
rivendicarono quella particolare posizione di autonomia rispetto alla curia romana che ne fece delle vere “chiese di stato”,
legate al sovrano.
Pure in Italia la chiesa venne considerata dai principi quale organo basilare della struttura statale; si può, dunque, parlare
di politica giurisdizionalista di tipo confessionale che fa della Chiesa strumento di appoggio ideologico ai poteri di
governo.
Come ha osservato il Marongiu, il principio religioso è inserito nell'ordinamento giuridico dello stato come parte
integrante di esso. Ma non è, più, superiore e quindi anche estraneo, ad esso; è soltanto uno dei gli elementi, sfruttato dai
governanti come giustificazione razionale della propria autorità e per dare a questa maggiore dignità e prestigio.
La politica ecclesiastica assolutistica fu, dunque, volta a imporre il primato dello Stato in una molteplicità di sfere
giudicate di importanza vitale: in particolar modo nel campo di privilegi e delle immunità riguardanti lo status del clero e
della gestione dei vasti patrimoni ecclesiastici.
Il raggio d'azione del diritto canonico, ad eccezione dello Stato Pontificio, fu così notevolmente ridotto perché la
legislazione statale rompendo le frontiere tradizionali, si estese a disciplinare una pluralità di situazioni giuridiche
temporali già di tassativa competenza canonistica soggette a giudice ecclesiastico e anche perché la normativa della
Chiesa fu considerata vigente subordinatamente al consenso del sovrano o del principe.
Tale situazione, che vide il diritto canonico ritirarsi in un ambito meramente ecclesiale, portò ad una distacco del diritto
della Chiesa da quello civile, separazione alquanto moderna e degna di uno Stato laico.
Il fondamentale vincolo ideale dell’utrumque ius tramontava col dissolversi del dominio spirituale della Chiesa di Roma
su tutta la cristianità, base dell’immediata vigenza ovunque del diritto canonico ora recepito con vari limiti, poggiando sul
placitum principis la propria validità e alla condizione di non derogare alla volontà assolutamente indipendente del
monarca.
Lo studio del diritto canonico nelle università europee, fu soppresso durante il XVI secolo, nei paesi calvinisti e in Svezia.
Nelle università luterane della Germania fu limitato a quanto delle decretales era stato accolto nella prassi processuale.
Anche in Francia Luigi XVI stabilì che lo studio universitario venisse soprattutto svolto quale base delle teorie gallicane.
Solo in Spagna la materia canonistica crebbe di importanza nell’ambito del quadro degli studi giuridici.
Tuttavia, tale visione non deve impedire di considerare l’evoluzione del diritto della Chiesa e il suo contributo al mondo
giuridico moderno; Come ha scritto il Prosdocimi, in questo periodo la cristianità vive e si trasforma e la novità dell’era
moderna risiede nel fatto che ciò che nel medioevo appariva come una dualità di poteri in un unico ordinamento a
carattere universale appare ora un’effettiva dualità di ordinamenti, la Chiesa da una parte e gli Stati dall’altra.
Non tramonto del diritto canonico ma quindi evoluzione lungo filoni vecchi e nuovi, resa possibile grazie al clima
politico e culturale che troviamo all'interno degli stati europei da cui nasce lo spirito laico.
Ciò che differenziò, non poco, il diritto canonico dal diritto romano fu il fatto che parte di esso fu conservato in maniera
attiva e non subì, pertanto, quel processo di razionalizzazione e di particolarizzazione giurisprudenziale che il diritto
romano conobbe.
Già in età medioevale il diritto canonico era commune e collegato al diritto romano nella concezione dell’utrumque ius,
ma non comunque allo stesso livello: nessun limite di derogare al diritto romano da parte dello ius proprium; precisi
limiti, invece, nel derogare al diritto canonico.
La chiesa, vigile e intransigente, non cessò mai di difendere la supremazia delle proprie norme su ogni altra norma
terrena.
In questo modo, il diritto canonico conservò il suo carattere principale di autenticità, riuscendo a mantenere, dunque, più
del diritto romano, la veste di normativa unitariamente “comune” a più ordinamenti politici.
Nel determinare in Europa questa spiccata tendenza all'uniforme applicazione del diritto canonico, giocò un ruolo
importante il grande tribunale della SACRA ROTA romana, massimo organo di controllo giurisdizionale del mondo
cattolico. La ROTA restava, anche durante l'era moderna, non solo il tribunale supremo dello Stato Pontificio in campo
civile, ma anche il comune ed unico tribunale supremo in campo spirituale, possedendo uno stile di giudizio invalicabile
dai vari tribunali ecclesiastici sparsi nei diversi paesi.
Anche la scienza canonistica si orientò alla ricerca di nuove e più ampie soluzioni metodologiche che esulassero dallo ius
civile e di nuove sistemazioni delle materie, delle categorie e degli istituti entro l’ordine suggerito dalle Decretali.
Apparirono, così, accanto alle tradizionali, nuove opere che via via nei secoli hanno tracciato il segmento che porta al
diritto moderno.
Sezione Seconda. La formazione e l’apogeo del diritto comune (Secoli XII – XV)
Capitolo 5. I caratteri intrinseci del diritto comune
Sull’uso ed espressione del “diritto comune”
Con l’espressione “diritto comune” si allude al modo di organizzare in un sistema il diritto romano-canonico e le fonti con
esso concorrenti.
Notevoli differenze e varietà si riscontrano, nel tempo e nello spazio, nel modo di concepire il carattere comune, il titolo
in base al quale fu accettato nei diversi ordinamenti e le proporzioni in cui si svolse.
In ogni caso, fu universalmente presente in Europa e ciò pose il problema dei limiti di applicazione di una normativa
comune, appunto.
L’espressione “diritto comune” è pur sempre usata nell’accezione indicata; tuttavia, non è infrequente che, specialmente
in età moderna, si alluda solo alla mera normativa delle fonti giustinianee.
Dal punto di vista del contenuto, ciò si spiega perché lo ius civile romano costituì la fonte prima, rispetto agli altri
elementi, dello ius commune: la scienza giuridica canonistica ebbe una portata produttiva minore anche se talvolta il suo
uso raggiunse una superiore capacità di penetrazione nei fatti umani.
Dal punto di vista formale, invece, il ridursi concettuale dell'espressione “diritto comune” al solo diritto romano, ha un
fondamento storico e appare pienamente in atto nell'età assolutistica.
Questo si spiega col fatto che la separazione del diritto civile dal canonico, quest’ultimo perda apparentemente valore e
non sia più considerato fonte diretta del diritto comune. Naturalmente l’integrazione che fu effettuata nei secoli con il
dettato delle fonti romane, fu invece costante.
Il diritto comune considerato come diritto giurisprudenziale.
Occorre adesso portare l'attenzione su un aspetto ulteriore del concetto di diritto comune.
Non si può considerare il diritto comune quale diritto universalmente accolto, con certi criteri sistematici, da una pluralità
di ordinamenti senza considerare il valore dell’opera scientifica e pratica, attraverso cui tali norme vennero, dalla
giurisprudenza dottrinale e giudicante, sistemate rispetto agli iura propria ed elaborate e rese applicabili nella vita sociale
dei secoli successivi alla nascita della scuola di Bologna.
E’ la giurisprudenza il vero soggetto attivo, costruttore e unificatore del tipico regime “del diritto comune”; tanto da
divenire, per antonomasia, fonte del diritto comune.
Considerando il diritto comune come inserito, entro ciascuno ordinamento, in un certo sistema di fonti concorrenti, fu la
giurisprudenza medioevale a coordinare sistematicamente queste fonti, contrapponendo un diritto comune universale, lo
ius vetus, alla molteplicità di diritti particolari, lo ius novum.
Il contenuto normativo risultante era poi compito della giurisprudenza mettere a fuoco: partendo da un’interpretazione
esegetica e dogmatica del diritto di Giustiniano, ne elaborava gli istituti adattandoli al sistema in cui era immesso e
piegandoli allo spirito nuovo che in esso vi alitava, plasmando così il nuovo volto che l’antico diritto andava assumendo.
Il punto di partenza era, quindi, sempre il precetto del testo Giustinianeo ma l'interpretazione che di esso dava il giurista
doveva tener conto dell'interazione di tutte le fonti del sistema, in merito alla situazione disciplinata da quel precetto.
È, dunque, soprattutto grazie alla plurisecolare interpretazione ricevuta in sede dottrinale o giudiziale dalla
giurisprudenza, che il diritto comune, divenne una normativa del presente, nonchè l'espressione di una nuova civiltà
giuridica e di una mutata coscienza sociale e che sviluppò - nelle università, nei tribunali, nella vita quotidiana - un
immenso potenziale di sapienza giuridica ancora latente, riuscendo così a rendere disponibile il suo apparato tecnicoconcettuale per la definizione di forme sempre nuove di esperienza.
Le fonti legislative che suscitarono questa grandiosa opera di evoluzione non furono tutto il diritto comune ma sua parte
legale e la sua base di partenza su cui si pone l’immenso patrimonio giurisprudenziale elaborato dagli interpreti, rivelatosi
produttivo nei diversi ambienti sociali, politici e culturali susseguitisi in Europa.
Dal punto di vista della loro collocazione tradizionale, tecnica e formale, le opere dell’attività dottrinale si inseriscono
nelle fonti di cognizione del diritto comune stesso, tra cui si collocano le compilazioni romana e canonica.
Tra le fonti di produzione, invece, quali Impero e Chiesa non si può annoverare la giurisprudenza.
Le fonti giustinianee sono quindi la materia grezza da cui vennero ricavati i materiali per la costruzione del diritto comune
e i giuristi non sono conditores iuris e la loro opinione non è legge: il diritto comune stesso non si può identificare solo
sulla nuova disciplina costruita dalla dottrina e accolta nella prassi, sradicandolo dalla sua base legislativa.
Bisogna considerare che le creazioni della giurisprudenza non soffocarono mai la rilevanza del testo legislativo di
partenza ma vi fu il raggiungimento, da parte degli interpreti, di una autorità pari a quella del testo, nel senso che le norme
in esso contenute vennero ad ordinarsi ed operare conformemente alla dottrina dell'interprete. Il doctor diventò, così,
esclusivo ed indispensabile mediatore fra la norma “di Giustiniano” e i consociati destinatari della norma, la cui presenza
rimane imprescindibile e insostituibile supporto legale cui il giurista non poteva sostituirsi e che si considera più oggetto
che soggetto d’esperienza giuridica: il soggetto attivo è il doctor.
Il diritto comune si presenta allora come diritto giurisprudenziale i cui aspetti sono stati distinti dal Lombardi di recente;
egli ha riscontrato l'aspetto dell’incidenza dell’opera del giurista sulla “morfologia” dell’ordinamento e l’aspetto
dell’incidenza dell’opera del giurista sul contenuto normativo dell’ordinamento. Nell’ambito di quest’ultimo aspetto ha
distinto l’inventività del giurista medievale, nel formulare la norma, dall’autorità che questa verrà ad esercitare.
Il ruolo dei giuristi nella creazione delle norme
Ci sono nell’ ambito del diritto comune, del suo svolgimento ed evoluzione produttiva alcuni punti fermi:
1. la funzione del diritto comune lo concepisce come operante in un sistema di fonti normative concorrenti in cui la
molteplicità dei diritti particolari si coordinò all’unità di un diritto generale e universalmente suppletivo; sistema
che deve essere moltiplicato per il numero di ordinamenti storici in cui il diritto comune fu variamente accolto.
2. Le fonti e gli elementi costitutivi del diritto comune, punto importante perché ci fanno capire quanto la
giurisprudenza abbia inciso su tale diritto, quale sia la portata effettiva del carattere giurisprudenziale.
Con il termine “giurisprudenza” si intende sia la produzione scientifica, didattica e teorica della dottrina
sia le funzioni svolte dai giuristi nella pratica quotidiana del diritto.
Di questa si tengono presenti il grado di creatività e il grado di autorità attribuito alla soluzione formulata
dal giurista.
Si può concludere che l’opera interpretativa della giurisprudenza, nello sforzo di adeguamento del testo normativo alla
realtà sociale, è evolutiva ma perlopiù creativa tanto da portare ad esiti del tutto diversi da quelli in origine avuti di mira
dal legislatore romano.
Questa complessiva operazione di reinvenzione del testo normativo ci appare molto lenta e graduale: la giurisprudenza
medioevale, e quindi il giurista, non giunse ma i a troncare il legame ufficiale con la norma che le era precostituita e che
adoperava come materiale legale costruttivo. Per questo la sua autorità fu enorme e si confuse con quella del testo stesso.
Il rapporto di simultaneo contatto-distacco dell'interprete col testo assicura quella continuità dello sviluppo giuridico, che
è necessaria.
La grande importanza dell'esperienza del diritto comune, caratterizzata da un accentuato momento giurisprudenziale, sta
nel fatto che essa mostra a quale limite massimo di operatività potè giungere il ruolo del giurista.
Il giurista non crea il diritto, lo riforma giorno per giorno; non lo rivoluziona poiché non né ha il potere né l’istinto della
rivoluzione, ma lo muta e lo plasma di continua. Ne garantisce la stabilità e la vitalità ma, allo stesso tempo, né determina
una crescita graduale che, in rapporto al periodo storico in cui ci si trova a far giurisprudenza, non si percepisce.
La si percepirà dopo lungo tempo quando si avrà un contenuto nuovo della stessa legge formale di partenza.
Capitolo 6. Il rinascimento giuridico e la scuola bolognese dei glossatori
La” culla” e i “padri” del pensiero giuridico moderno.
Il sorgere del diritto comune è legato al sorgere della scienza medievale del diritto, cioè alla fondazione della scuola di
Bologna.
L’attività dottrinale della scuola bolognese dei “Glossatori”, (da “glossa”, genere letterario in cui si concentrarono i
risultati del loro metodo: la notazione apposta al testo dal doctor che svolge la lettura in chiave di analisi esegetica) si
estende, dal punto di vista storico, dal secolo XI alla seconda metà del XIII.
E’ la nascita di questa scuola che segna il prender corpo del fenomeno chiamato “Rinascimento giuridico”, periodo di
generale rinascita politica, economica e spirituale della società post-feudale del secolo XI.
La scuola di Bologna nasce come centro di cultura laica, producendo un fenomeno di secolarizzazione del sapere
giuridico; inoltre, con la costituzione di questo centro di insegnamento a Bologna, lo studio del diritto acquista una
propria autonomia rispetto agli schemi in cui erano distribuite le nozioni scientifiche nella concezione altomedievale del
sapere giuridico. Vengono a cadere due concezioni fondamentali: la prima, quella dell’insegnamento del diritto rientrante
nella retorica e dunque fra le sette arti liberali del trivio e del quadrivio, e la seconda, quella secondo cui la norma è
intesa innanzitutto come norma etica, per cui il diritto rientra nell’etica.
Nel pensiero dei Glossatori la norma si pone come giuridica, in maniera autonoma.
Tra gli esponenti della scuola si menziona IRNERIO, che la tradizione addita quale precursore e fondatore della stessa,
BULGARO, UGO, JACOPO e MARTINO quali suoi discepoli, ROGERIO, GIOVANNI BASSIANO, PILLIO DA
MEDICINA, PIACENTINO, CARLO DI TOCCO, UGOLINO DE’ PRESBITERI, AZZONE quali esponenti del periodo
aureo, ODOFFREDO E ACCURSIO, che vivono il tramonto e la crisi della scuola.
Irnerio, considerato la “lucerna iuris” riesce a sovvertire gli aspetti di quell’età buia che è l’alto medioevo
Tutto quel che è importante ricordare di questi illustri giuristi però, è il loro lavoro intorno ai testi romani.
La glossa e gli altri “strumenti di lavoro” dei Glossatori
La Glossa non è altro che l’elementare e l’immediato chiarimento che il professore apporta alla litera del testo durante la
lettura del testo agli studenti; essa consiste, nella sua struttura più semplice, in una postilla volta a chiarire una parola o
un’espressione ritenuta oscura e difficile.
A seconda della posizione in cui viene collocata nel testo, essa può essere interlineare o marginale. Non è, in genere
anonima: è seguita da una lettera, una sillaba o una sigla che ne indica la paternità.
Possono essere divise in base al loro contenuto che da grammaticale può divenire interpretativo.
Ve ne sono alcune a struttura semplicissima con lo scopo di annotare un sinonimo, una variante, una puntualizzazione
verbale elementare ed altre che richiamano una serie di passi paralleli tendendo all’interno della compilazione molti fili
logici che mettono in collegamento organico parti e norme;
Un’imponente categoria di glosse marginali è quella delle glosse apposte ad un titolo.
Altri generi letterari utilizzati dai Glossatori sono:
1. Le DISTINCTIONES, scomposizioni analitiche del punto di diritto in esaminato in una serie articolata di sotto
proposizioni speciali e autonome, ciascuna delle quali riflette un distinto aspetto sotto cui quel punto può essere
considerato.
2. Le REGULAE IURIS, che racchiudono in una sintetica proposizione regole, principi e dogmi giuridici
fondamentali
3. I CASUS, raffigurazioni di fattispecie pratiche a titolo esemplificativo cui la norma può essere applicata.
4. Le DISSENTIONES DOMINORUM, specificanti le diverse e opposte soluzioni proposte dai maestri in merito
ai più noti e problematici temi di discussione
5. Le QUAESTIONES, forma letteraria attraverso cui il doctor pone il problema, enumera i testi e le regioni a
favore e contro una determinata soluzione e espone la propria interpretazione conclusiva, la solutio.
6. Le SUMMAE, opere in cui è condensata l’intera sostanza di un titolo, un libro o un argomento. Nella loro forma
più robusta, le glosse imbrigliano una parte della compilazione giustinianea, di preferenza il CODEX; Celebri
sono la SUMMA TRECENSIS, la SUMMAE CODICIS dei giuristi Rogerio e Piacentino e la SUMMA
CODICIS di Azzone.
La “lucerna di Irnerio” e la “scoperta” del corpus iuris
La prima attività dei Glossatori e soprattutto di quella lucerna iuris che fu Irnerio, fu un lavoro di esplorazione conoscitiva.
Il primo risultato fu la scoperta di testi del diritto Giustinianeo dimenticati da secoli, alterati e mutilati da una rozza cultura
altomedievale che ne aveva maldestramente fatto uso.
Prima fra tutti fu la riesumazione del DIGESTO, riammesso nel circolo della cultura giuridica come tesoro di sapienza legale
perduto e ritrovato. L'operazione diretta a restituire la genuinità e la completezza alle varie parti di quello che i Glossatori
chiamarono CORPUS IURIS CIVILIS, fu indubbiamente complessa.
Questi utilizzarono una partizione dello stesso che non rispecchiava l’originale anche per quel che riguardava il contenuto.
Il CORPUS IURIS CIVILIS medievale si divide infatti in cinque volumina.
I primi tre di esso accolgono il contenuto del digesto secondo questa ripartizione:
1. DIGESTUM VETUS
2. DIGESTUM INFORTIATUM
3. DIGESTUM NOVUM
non importante il perché di questa tripartizione, anche se è importante sapere che sono stati scoperti prima il vetus e il novum
e poi l’infortiatum.
Quanto gli ultimi due volumi il quarto contiene il Codice, del quale accoglie solo i primi nove libri.
Il gruppo dei tre libri restanti è inserito nel quinto volume con l'appellativo di tres libri.
Questo scorporo del Codex non fa altro che riflettere una tradizione della cultura giuridica altomedievale, in seno alla quale
le materie trattare negli ultimi tre libri, fiscali e amministrative, fossero ritenute meno interessanti.
Il quinto ed ultimo volume comprende: i quattro libri delle Istituzioni, i tres libri finali del Codex, le novelle comprese nella
raccolta detta Authenticum, (delle 134 solo le prime 97 che si presentano, in seno al volumen, in 9 Collationes)
Tale è la struttura del corpus iuris nella fase originaria;
intorno alla prima metà del XIII secolo il volumen si presenta integrato nel modo seguente: alle 9 Collationes raggruppanti le
novelle giustinianee ne viene aggiunta una decima, contenente talune costituzioni degli imperatori romano-germanici, il
trattato di Costanza e i Libri Feudorum, considerati poi una fonte del diritto comune, raccolta privata di consuetudini feudali;
Nelle edizioni glossate del Cinque-Seicento si rinviene anche la Lombarda, celebre raccolta sistematica delle leggi
longobardo-franche redatte sulla fine del secolo XI, rientrante nel novero dei testi in cui era racchiusa la legalis sapientia.
Il “libro caduto dal cielo” e la sua legittimazione ufficiale.
L’operazione di ricostruzione del corpus iuris fu svolta dai Glossatori con la reverenza di chi si accosti ad un “libro caduto
dal cielo”. I testi giustinianei apparvero come il condensato di tutta la legalis sapientia: non contenevano un diritto, ma “il
diritto” per ispirazione divina.
I glossatori si inchinavano di fronte alle norme romane come dinanzi ad un’autorità biblica,attribuendo a Dio la paternità
prima del diritto da loro riscoperto: collocano il diritto fuori dalla storia.
Ma il diritto dei testi giustinianei, reso intoccabile da questa suprema ascendenza, era anche il diritto dell’imperatore, fonte
terrena per volere di Dio, pertanto legittimato, dai Glossatori, quale diritto imperiale era immediatamente vigente.
Tale legittimazione colora di giurisprudenzialità lo stesso fondamento genetico del diritto comune: l’imperatore non ha alcun
merito nella rinascita del diritto di cui viene ad essere, a sua insaputa erede e fonte; glielo regalano i giuristi di Bologna.
Il dominio sull’indomabile: lo studio sistematico del “corpus iuris”
Attraverso la loro metodica e articolata attività di esegesi testuale, i maestri di Bologna pervennero ad un’unificazione
organica, raggiunsero la completa padronanza del ciclopico testo giuridico, che per come si presentava era alquanto
complesso, nonché tecnicamente complicato: innumerevoli antinomie c’erano al suo interno, il suo contenuto era
storicamente eterogeneo e frammentato in una casistica sterminata e non sempre logicamente sistemata in precetti generali.
I glossatori attraverso l’impiego di un metodo logico in cui la glossa come chiarimento testuale non era che il momento di
avvio, vennero a capo della mens, dello spirito di quelle norme coperte da uno spessore storico di sei secoli.
Esse vennero rimesse a fuoco entro nuove dimensioni sistematiche.
Pur se i veri capolavori sistematici sarebbero venuti dopo, i Glossatori ne misero in luce i logici coordinamenti e l’assetto
armonico: non si spiegherebbe, altrimenti, il perché la giurisprudenza moderna sia nata a Bologna.
Pu riscontrando, nel vivo dell’opera dei glossatori, errori e imperfezioni questi saranno occasione di creativa opera di
sviluppo successiva: “ciò che è insufficiente è produttivo” disse il Bellomo.
Lo spirito unitario e la volontà di voler lavorare, in base ad un ordine prestabilito rappresentavano la tipica “ideologia
giuridica” dei Glossatori.
Il “corpus iuris” diventa legge del presente
Irnerio e i suoi discepoli operarono la trasformazione del corpus giustinianeo in una normativa del presente suscettibile di
concreta applicazione e utilizzabile dalla prassi del tempo.
Fondamentali sono due aspetti di tale risultato pratico conseguito:
- il suo carattere di MEDIAZIONE tra testo del corpus iuri e prassi in cui doveva essere applicato.
- il suo carattere fortemente GIURISPRUDENZIALE.
Quanto al primo aspetto, un testo così complesso come il corpus iuris, non sarebbe mai potuto essere applicato da un
magistrato senza il lavoro dei glossatori, attraverso una semplice consultazione; ed è per questo che è necessario un
intermediario che attraverso un lavoro preparatorio, ordinasse e tenesse pronto il complesso materiale della legislazione
giustinianea, per poi potersene servire lì per lì. Il Glossatore fu tale intermediario. Tale opera di mediazione ha carattere
altamente scientifico e può essere svolta solo da una classe di giuristi che, dottrinalmente, sappiano signoreggiare su esso e
insegnarne i segreti.
Quanto al secondo aspetto, è riscontrabile che tale opera di approntamento del corpus iuris non è conseguita con
un’interpretazione solo evolutiva ma anche creativa di nuovo diritto e quindi giurisprudenziale.
I Glossatori e la “Bibbia del diritto”
L’atteggiamento mentale che caratterizzò l’opera dei glossatori fu quello della assoluta subordinazione ad elementi
autoritari.
Il corpus iuris, fu autorità per eccellenza, verità dogmatica indiscussa, l’intoccabile “Bibbia del diritto ” apparendo ai giuristi
come la sacra Scrittura per i teologi e i testi di Aristotele e Platone per i filosofi.
Poiché l’autorità è, per sua natura, realtà che esula dalla storia essa altro non è che attivo e immediato presente: l’autorità si
associa con una integrale mancanza di senso storico nonché di quella capacità critica che dà la percezione della storia e del
passato.
Così l’intera realtà del passato, non percepita con il senso della storia, si trasfigurava in realtà contemporanea: l’imperatore
romano-germanico reincarnava Giustiniano senza alcuna soluzione di continuità del potere legislativo e senza alcuna
imposizione di tempo.
Può allora sembrare impensabile lo sforzo effettuato dai Glossatori per adeguare innovativamente il vecchio testo
giustinianeo alla coscienza sociale del loro tempo. Sforzo che, in quanto riuscito a uomini privi di visione storica, ha aspetti
paradossali poiché si risolveva proprio in una storicizzazione del diritto.
In realtà i giuristi, quindi i glossatori, di quel tempo, facevano tutto ciò in maniera autonoma, perché trovandosi ad applicare
norme la cui originaria funzione storica impediva una loro automatica applicazione alle concrete condizioni del presente,
ricollegavano inconsapevolmente tali norme a situazioni della realtà contemporanea, fornendole intuitivamente di scopi
attuali, cui esse non potevano aver mirato e quindi di una volontà positiva che esse non potevano aver avuto.
Tutto ciò accadeva perché ai giuristi sfuggiva la giustificazione storica della norma facendo svanire la cosiddetta MENS
LEGIS; ma l’interprete aveva, comunque, assolto il dovuto obbligo di rispetto formale del testo autoritativo e aveva portato
la norma a livello del presente, recuperandola con geniale creatività, che il GENZMER chiama MALINTESO
PRODUTTIVO:(questa inconscia operazione intellettuale dei glossatori) che fa si che quelle parole dell’autore si stacchino
dall’autore stesso e possono essere usate nel presente.
Si concilia così la libertà di un’interpretazione altamente inventiva con l’autorità (e quindi, l’intoccabilità) della
compilazione giustinianea.
I Glossatori racchiudono l’intera attività entro i limiti formali della legge e considerano tutto il loro operare coperto dalla
volta autoritaria e protettiva del sistema normativo. “Per tutti i casi si doveva dunque cercare una norma di legge” osservò il
Brugi.
“Author iuris homo, iustitiae deus”: l’idea di aequitas nella vita del diritto.
Il mantenimento dell’equilibrio fra il diritto e la mutevole realtà sociale non avviene in maniera del tutto meccanica, ma vi è
piuttosto un criterio orientativo che impedisce ogni deleterio squilibrio tra il diritto “amministrato” è la situazione sociale:
l’aequitas.
L’aequitas è un parametro ideale cui il giurista può commisurare le soluzioni dei problemi e per comprenderlo è necessario
ripensare alla dimensione etico-religiosa dell’universo giuridico medioevale. Questo universo è sovrastato dalla volontà
divina e tale volontà si esprime in una giustizia ideale che alita nella natura stessa delle cose e dei rapporti umani.
Dio ha posto nell’animo dell’uomo un lumen etico naturale che gli dà il senso del giusto e dell’ingiusto. Per capire cosa è e
come si situa l’aequitas e che rapporto esiste tra aequitas e iustitia possiamo far capo ad Irnerio e ai primi giuristi bolognesi.
L’equità è la sorgente stessa della giustizia: è dunque essa medesima giustizia, ma è quella giustizia naturale che per volontà
divina è intrinseca alle quotidiane relazioni umane, le quali da sempre la contengono come regola primordiale.
Perché l’aequitas diventi giustizia in atto, è necessario che una volontà terrena la tragga fuori dal cuore degli uomini e la
traduca il norma giuridica cogente.
In questo modo si trasforma una giustizia intrinseca, da valore morale, aequitas rudis, in giustizia giuridicamente attiva,
aequitas constituta.
Carattere importante del concetto di equità è quello della razionalità, per cui esso non è solo il criterio del giusto, ma anche
quello del vero e dell'esatto.
Questo parametro di interpretazione non solo del giusto ma anche del ragionevole costituisce uno strumento propulsivo,
potenziatore e stabilizzatore dell’ordinamento giuridico, del cui equilibrio spetta al solo giurista decidere.
È il giurista ad interessarsi che le norme attivino, in maniera giusta e ragionevole, il concetto dell’aequitas.
Ma che potere ha l’interprete laddove constati che la norma positiva non ha quel carattere o che manchi, addirittura, la norma
stessa?
Nel Codex c'è infatti in una costituzione di Costantino che pare sottolinei che solo l'imperatore ha il potere di rendere
conforme all’equità le norme che non lo sono in quanto egli stesso può emanare le norme e tradurre la giustizia in equità, ma
pare che questo compito sia stato affidato anche ai giuristi, proiettando la Costituzione Costantiniana entro un più vasto
contesto di principi e di regole generali, cercando di superare, così, l’impasse dogmatico.
Non a caso, nell’immagine allegorica con cui si aprono le Quaestiones de iuris subtilitatibus, nel tempo in cui la giustizia
misura con la bilancia dell’equità “causas dei et hominum”, compaiono anche quegli honorabiles viri che sono i giuristi.
Essi stanno dinanzi ad una parete di vetro su cui, incisi i caratteri d’oro, si leggono tutti i precetti contenuti nei libri legales, e
quando si avvedono che qualcuno di questi è contrario all’equità, loro compito è cancellarlo.
Il potere e la responsabilità di decidere, in forza del suo personale ma non arbitrario apprezzamento, della congruenza della
norma con l’equità o di decidere dell’aequitas rudis dalla quale va ricavata la norma giusta, spetta dunque all’interprete.
L’università come centro di diffusione di un sapere giuridico europeo
Europeo fu dunque il carattere del centro di diffusione del sapere giuridico legato all’idea universale di Roma, cosi come
sedi di una cultura giuridica europea divennero le varie università che sull’esempio e con l’organizzazione di Bologna
cominciarono a sorgere un po’ dovunque in Italia e oltralpe. Quella di Bologna fu, comunque, la prima in assoluto sul suolo
italiano.
Lo studio scientifico del corpus iuris non poteva non sorgere con caratteri universitari perché rendere la compilazione
giustinianea praticabile necessitava di una classe di giuristi preparati che potessero a loro volta preparare altre generazioni di
tecnici ad alto livello: solo un organizzato centro di studio poteva ssolvere a quel compito.
L’UNIVERSITA’ a Bologna nasce quale spontanea organizzazione corporativa degli studenti, un’associazione in cui gli
scolari si raggruppano a scopo di difesa e di assistenza in un paese loro straniero, con i propri uffici, le proprie magistrature,
gli statuti e che all’interno si organizza sulla base delle diverse nationes a cui appartengono gli studenti.
Una volta che l’ordinamento universitario bolognese raggiunse la sua consolidazione, si poterono osservare 2 universitates:
nella prima, dei CITRAMONTANI, si raggruppano gli studenti italiani; nella seconda, degli ULTRAMONTANI, si
aggregano 13 nationes di studenti originari dei paesi d’oltralpe.
Quanto al governo del mondo universitario, ogni anno ciascuna università elegge il proprio rettore, che è uno studente di
volta in volta scelto nell’ambito di una nazione e che viene assistito nella tenuta delle matricole e nella raccolta delle
collectae da un collegio di consiliarii rappresentanti le varie nationes.
Nella storia dell’università bolognese, la Costituzione di FEDERICO I, l’Habita ha non poca importanza; essa sancisce sia
l’autonomia degli studenti nei confronti del paese ospitante, vale a dire, esenzione dalle tasse, sottrazione ai locali tribunali
ordinari, immunità per debiti, sia la giurisdizione civile e penale ai maestri nei confronti degli allievi.
La storia dell’università è legata alle vicende politiche comunali: il comune di Bologna tende nel tempo, a controllare
l’autonoma e potente organizzazione dello studium vincolandola al territorio e alle leggi cittadine , altri comuni premono
sugli studenti per tirarli fuori da Bologna e ospitarli. Talune università, quali quella di Modena, Padova, Siena, nascono
proprio da emigrazioni di masse ingovernabili di studenti in burrascoso conflitto con il comune ospite o dall’esilio di
professori insofferenti di pressioni e condizionamenti politici.
Ecco perché la Costituzione imperiale del 1158 fu un atto legislativo di grande rilievo. Essa isolò l’ancora indifferenziato
gruppo di dottori ed allievi della città, costituendolo in una realtà giurisdizionale ed umana contrapposto al Comune.
In linea di massima, saranno poi i comuni comunque ad imporre la loro supremazia nell’ambito universitario, perché è dai
loro bilanci che proverranno gli stipendi dei professori e saranno loro che si arrogheranno il potere di tassare gli studenti e di
disciplinare con legislazione propria lo studium, fino a restringere ai minimi termini il potere decisionale degli studenti.
A Bologna, nascerà la magistratura comunale dei Riformatori addetti al controllo delle cose universitarie.
A partire dal secolo XIII cominciano a sorgere STUDIA, non organizzate dalle autorità comunali ma direttamente fondati
dall’imperatore o dal pontefice che diventano veri e propri strumenti di politica e di corsa al potere.
Si giunge così al momento in cui non vi è studium che non nasca per privilegio papale o imperiale e, parallelamente, non vi
è università sorta di fatto, come Bologna, che non cerchi di strappare un ufficiale riconoscimento ex post o non cerchi
addirittura di fondare sulla inveterata consuetudine o su qualche falso diploma le proprie nobili origini.
Ma intanto durante il secolo XII a Bologna, a Padova e successivamente in molte città universitarie assistiamo ad un
fenomeno di significativa importanza: il costituirsi di un potente collegio cittadino di giuristi “dottori”, che verrà via via a
monopolizzare e a controllare l’attività di insegnamento universitario. Mentre calerà sempre più l’astro delle corporazioni
studentesche, questi nuovi collegi verranno a porsi come insopprimibili e politicamente attivi interlocutori del comune, della
signoria e della pubblica magistratura dei RIFORMATORI: la nomina dei professori e tutte le decisioni più importanti della
vita universitaria passeranno anche attraverso il consenso di tali corporazioni.
Quanto alla organizzazione degli studi, gli studenti sono tenuti a superare un piano di studi che va dai 4 ai 6 anni: devono
frequentare le lezioni mattutine e serali e devono prender parte alla discussione delle quaestiones periodicamente
organizzate.
Poiché il tipico metodo didattico delle lecturae permette un sondaggio pressoché quotidiano delle attitudini e del profitto
personali e poiché la vita molto spesso comunitaria di docenti e studenti agevola la conoscenza della personalità dei
discepoli, non vi sono singoli esami.
Hanno invece particolare importanza le prove di laurea, che si svolgono con gran solennità alla fine dell’intero corso di studi.
Una commissione estratta dal collegio dei giuristi della città, assegna al candidato due tesi di discussione: in diritto civile sul
DIGESTO e sul CODEX, in diritto canonico sul DECRETUM e sulle DECRETALES.
Lo studente è presentato alla commissione da un relatore che ne ha preventivamente controllato la preparazione e soprattutto
le attitudini didattiche.
Anche se la licentia si ottiene con esito positivo dinanzi alla commissione, il laureando deve discutere, per tradizione, le tesi
assegnatali durante una solenne cerimonia, tenutasi nella cattedrale, con folto pubblico e in presenza del vescovo.
La consegna della toga, del berretto e dell’anello sanzionano il conferimento della licentia docenti, un titolo che, ove il
doctor abbia frequentato le lezioni in uno studium c.d generale, gli permetterà di esercitare e di insegnare il diritto ovunque
nel mondo giunga la tradizione romano-cristiana.
A questi cenni essenziali sull’organizzazione medievale degli studi universitari dobbiamo far seguire una importante
osservazione.
Per forma, metodo e contenuti, l’insegnamento del diritto è identico in tutte le università europee a quello relativo
all’Università di Bologna: ne deriva, quindi, una sostanziale unità dell’istruzione giuridica su tutto il continente europeo, che
perdurerà fino alla meta del XVI secolo.
I caratteri essenziali del piano di studio bolognese sono tutti rivolti al CORPUS IURIS CIVILIS e al CORPUS IURIS
CANONICI, con esclusione di ogni normativa particolare.
Nel programma di studio poi, non v’è distinzione di materie (tutto è o diritto civile o diritto canonico) ma solo una
bipartizione di lezioni in ordinarie (tenute di mattina e riguardanti perlopiù il DIGESTUM VETUS e il CODEX) e lezioni
straordinarie (lezioni pomeridiane o serali riguardanti altre parti del CORPUS IURIS CIVILIS e di quello CANONICO).
Fu la cultura umanistica a stravolgere l’unità metodologica e sostanziale universitaria, perché le teorie del giusnaturalismo e
del razionalismo giuridico determineranno l’emergere del diritto naturale, come fondamentale materia d’insegnamento, che
segnerà la fine del diritto romano come base di una buona preparazione giuridica.
In Francia invece la rivoluzione dell’ordinamento universitario sarà dovuta ad un celebre editto del 1679.
Con tale provvedimento Luigi XIV affiancherà allo studio del diritto romano anche quello, razionalizzato, del diritto vigente,
individuato dal materiale giuridico fornito dalle ordinanze regie, delle coutumes provinciali, dalla giurisprudenza dei
parlaments del regno. L’insegnamento del diritto francese avrà una specifica finalità pratica di preparare allo svolgimento
delle attività forensi prima ancora di fornire una preparazione burocratica, come nelle università germaniche.
La scuola di Bologna non fu solo cosmopolita punto di incontro di studenti e maestri, ma anche base di partenza per una vera
e propria evangelizzazione in Europa delle nuove dottrine giuridiche e del loro metodo di insegnamento: i glossatori Vicario
e Piacentino, ad esempio, esportarono rispettivamente ad Oxford e a Montpellier le tecniche della glossa.
V’è, infine, un dato su cui riflettere: si è osservato che l’insegnamento del diritto ebbe in tutta l’Europa medioevale il solo
scopo ufficiale di far conseguire la Licentia Docenti. Tuttavia, anche se l’educazione legale non fu postulata come pratica
condizione necessaria per l’esercizio degli uffici pubblici, è facile intuire come la classe dei legum doctores, preparata
all’insegnamento del diritto, abbia indirettamente influito sulla loro mentalità, sulla loro cultura, sulla loro azione.
Il ceto dei giuristi, soprattutto a Bologna, risulta essere il nucleo di potere negli ordinamenti politici medioevali e questo
spiega perché proprio da Bologna, centro universalistico di una scienza del diritto, parte quello sviluppo, come fosse una
sorta di centro propulsore di una circolazione europea delle tecniche del ragionamento giuridico.
Il “vademecum” del diritto comune: la “Magna Glossa”.
Nello svolgersi del “rinascimento giuridico” connesso all’attività dei Glossatori sul corpus iuris (svolta parallelamente e
contemporaneamente dai giuristi canonisti nella loro elaborazione del diritto della chiesa, Irnerio e Graziano) vi è un dato
centrale caratteristico poi del moderno spirito europeo: la formazione di una classe di uomini colti e di sapere giuridico
ineguagliabile: i GIURISTI (ossia i Glossatori).
I glossatori dimostrarono che il testo giuridico può essere compreso e capito a fondo. Tal considerazione evidenzia l’autorità
di questi, pari a quella dello stesso corpus iuris che interpretavano ed è manifesta nelle innumerevoli e importantissime opere
come la Summa Codicis di Azzone o la Glossa Magna di Accursio, monumentale reticolato di glosse intorno alle 4 parti
della compilazione giustinianea.
Le facciate di ciascun foglio dei 5 volumi del corpus iuris si presentano con al centro il testo della norma giustinianea e,
disposto tutto intorno, il complesso delle annotazioni alle parole della legge e alla legge nel suo complesso, raccolte e
coordinate in modo compiuto da Accursio.
Nonostante le inevitabili lacune, le contraddizioni e i fraintendimenti più che spiegabili in un’opera di tanta complessità, la
GLOSSA MAGNA si qualifica immediatamente come un accreditato VADEMECUM del diritto comune.
Accanto alla compilazione giustinianea diviene corredo inseparabile, come una sorta di chiave di lettura indispensabile; ha lo
stesso valore della legge e il diritto comune non si identifica più col solo testo giustinianeo: la Glossa è codice di “diritto
pratico e vigente” e non trova ostacoli, per lo meno sino al tramonto del secolo XVI; con l’opera Accursiana, la scuola dei
Glossatori pare aver dato tutto ciò che poteva dare: il corpus iuris è completamente chiuso in una fitta intelaiatura esegetica
che ne costituisce lo strumento applicativo nella prassi: con lo stesso metodo non si sarebbe potuti andare oltre.
Capitolo 7. Il trionfo del diritto comune: la scuola dei commentatori e il suo secolo d’oro.
Il genio del diritto comune verso più ampi orizzonti. Dai “Post-accursiani” ai giuristi del Trecento
Tra la scuola dei Glossatori e quella successiva dei Commentatori, che prende il nome dal genere letterario che agli inizi del
secolo XIV viene a prevalere sulla glossa, vi è un’impercettibile continuità, per cui il commento è prima di tutto una tecnica
di reperimento del diritto che si pone come maturazione e sviluppo della glossa, piuttosto che come una negazione.
Le differenze qualitative più nette, rientranti entrambi nell’alveo scolastico, sono principalmente di tipo didattico e attengono
al diverso modo di leggere e di esporre il testo giustinianeo.
Quanto invece alla realizzazione di quest’ultimo ai fini della sua concreta applicazione, i nuovi giuristi attingono a quei
prodigiosi risultati pratici che ne fanno più grandi maestri della giurisprudenza europea in quanto essi percorrono sino alla
fine una strada già imboccata dai Glossatori.
Solo la completa comprensione del testo raggiunta con strumenti esegetici da questi ultimi rende, infatti, possibile la
successiva applicazione al diritto della logica aristotelica la cui forte originalità fa conseguire ai Commentatori esiti
sistematici e creativi decisamente nuovi.
Bisogna comunque sottolineare che glossa e commento non sono la stessa cosa.
I commentatori sostituiscono nuovi schemi al procedimento esegetico e si spingono in una trattazione sistematica di
norme ed istituti che si spinge molto più in fondo di quello dei Glossatori.
Nel commento prevale questo spirito sistematico , in quanto esso tende ad un inquadramento logico-sintetico (e non
esegetico) della materia giuridica.
I commentatori sono gli insuperabili costruttori di una dogmatica giuridica eminentemente volta a esiti pratici: le loro
categorie logiche hanno soprattutto valore in quanto funzionali in una concreta realtà di rapporti giuridici nuovi e in
continua crescita piuttosto che nello sclerotizzato contesto giustinianeo.
Anch’essi procedono, come i glossatori, sotto il dominio incombente del principio di autorità e appaiono anch’essi
completamente sprovvisti di senso storico; anch’essi forzano quindi nella norma giustinianea i contenuti di un immediato
presente, con una interpretazione che è tanto più originale quanto meno è storicamente giustificabile. Ma mentre i
glossatori traggono dal testo giustinianeo la continua sollecitazione per la creazione di un diritto nuovo, ai commentatori
questo impulso deriva immediatamente dalla realtà socio-politica esterna.
Né gli uni né gli altri sono staccati dal loro tempo ma mentre i Glossatori costringono tutta la realtà entro la prospettiva
del corpus iuris, per i commentatori vale il contrario con conseguente più elevato e libero esito di produzione giuridica:
risultano essere autentica tecnica di costruzione del diritto.
Sono, poi, i commentatori che danno una conclusa sistemazione teorica al quadro dei rapporti tra diritto civile e diritto
canonico e fra ius commune e ius proprium, dedicando a quest’ultimo una realistica attenzione che non trova precedenti
nell’ambiente culturale dei glossatori, ma che è giustificata invece dalla cospicua incidenza nella prassi degli statuti
comunali e dalla enorme importanza politico sociale del loro ius novum.
Sussiste un periodo di transizione tra glossa e commento di circa cinquant’anni (1250-1300), che non è di crisi e di
esaurimento, solitamente contrassegnato come età dei POST- ACCURSIANI: è una età ponte, nella quale peraltro si
sviluppa al massimo quella attenzione ai problemi generati dalla applicazione dello IUS PROPRIUM che sembravano
trascurati in precedenza.
Attraverso il genere letterario del TRACTATUS (che trionferà poi tra il XIV e il XV secolo) i giuristi post-accursiani
sistemano con intenti eminentemente pratico-forensi taluni settori vitali del diritto, che trovano ora una loro elaborazione
organica ed autonoma, quali la materia notarile e processuale.
Una figura importante di giurista di questo periodo è quella di ALBERTO DA GANDINO al quale viene associata la
raccolta di Quaestiones Statutorum, ove sono selezionate le più frequenti e scottanti questioni reperite nella variopinta
casistica statutaria; a lui ancora si associa la prima vera trattazione di diritto penale: il Tractatus de maleficiis.
E’ proprio il campo del diritto penale ad essere uno dei campi in cui meglio si scorge la svolta avvenuta nella scuola, in
cui i contatti con tribunali, giudici, statuti si palesano più evidenti, e in cui il genere letterario del tractatus si riduce di
frequente a non essere altro che una collana organica di quaestiones utili per i giuristi professionisti.
Con i commentatori il sistema delle fonti trova poi la sua piena integrazione e si apre allora la vera e propria epoca del
diritto comune sussidiario: mentre i diritti locali vengono applicati con precedenza assoluta sullo ius commune, essi
vengono d’altro canto attirati dai giuristi entro l’orbita interpretativa del CORPUS IURIS e assoggettati alle massime e
agli schemi di questo.
Cambia lo stato d’animo del giurista: alla venerazione commossa del Glossatore succede la critica fredda del
Commentatore: questi frantuma, analizza, discute e ricompone a modo suo il testo legislativo dal quale è
psicologicamente staccato. Non ritiene, come il Glossatore, che nel dissidio tra legge antica e realtà, debba essere questa a
piegarsi alla prima ma si propone di verificare fino a che punto la legge antica può essere utilizzata per regolare i rapporti
nati dalla nuova esperienza giuridica.
La galleria delle “autorità” del diritto
La metodologia del commento nasce come destino europeo seppur la sua messa a punto sia italiana come italiano è il
merito della sua diffusione: non a caso la nuova tecnica interpretativa è chiamata mos italicus.
Il periodo più creativo del “Commento” è quello che va dagli inizi del XIV secolo alla prima metà del XV, periodo
storico in cui si ricordano nomi importantissimi come quello di CINO DA PISTOIA, BARTOLO DA SASSOFERRATO,
BALDO DEGLI UBALDI,…
L’eccellere di tali somme personalità si traduce nell’emersione dell’opera di alcuni singoli giuristi come autorità
dominanti le Università e la prassi giuridica.
A fianco della GLOSSA, dunque, vengono a collocarsi i grandi commentari al corpus iuris, scaturiti dal genio
interpretativo di un Bartolo o un Baldo che con il loro prestigio mettono in ombra, addirittura, il testo da cui sono
originati, fino a divenire vincolanti per il giudice, in caso d’incertezza, venendo riguardata come legge.
La logica giuridica dalla originalità all’acrobazia di maniera
L’emergere di così tante figure geniali in un arco di tempo relativamente breve testimonia la fecondità del nuovo metodo;
Tuttavia, intorno alla prima metà del ‘400, si verificò un calo della tensione creativa e del livello qualitativo del mos
italicus. Ciò è comprensibile alla luce del fatto che tale metodo, avendo spaziato su tutte le varie parti del corpus iuris ed
essendo stato immagazzinato in prestigiosi commentari, pareva aver dato tutto ciò che poteva dare.
Il giurista Matteo Gribaldi Mofa avrebbe schematizzato in un DISTICO il metodo interpretativo del MOS ITALICUS
nell’articolarsi delle sue varie operazioni logiche: era, infatti, un metodo preciso e complicato che si esplicava in una
successione ferrea e meccanica di momenti costitutivi.
Egli, in tal distico, premette una serie di nozioni e considerazioni introduttive (praemitto);
- divide il testo in tante parti strutturali autonome da analizzare separatamente (scindo);
- lo ricompone mostrandone la portata complessiva (summo);
- esemplifica una o più fattispecie concrete (casun figuro);
- rilegge il passo nella sua integrità (perlego);
- spiega ragioni e scopi della legge appellandosi allo schema aristotelico delle “quattro cause” : causa materiale,
efficiente, formale e finale (do causas);
- segnala le più notevoli deduzioni cui il testo dà luogo, comprese le regulae iuris e il principio generale che lo
ispira (connoto);
- formula una serie di tesi, sulla base delle deduzioni, cui contrapporre altrettante antitesi (obiicio);
Questo strumento, per nulla spontaneo e controllato in modo da condurre diritto alla ratio legis, metteva il giurista in una
condizione tale da essere troppo racchiuso in schemi rigidi.
Un’arma a doppio taglio quindi, che impelagava il giurista in un “acrobatica del cervello”da cui né usciva trionfatore il
giurista che sa meglio ed originalmente destreggiarsi nell’immane trafila.
Di conseguenza, le generazioni di giuristi successive non ebbero lo stesso vigore e l’originalità nell’affrontare quegli
stessi temi, rivelando una tendenza all’esaurimento degli schemi del commento. Vigeva più la quantità che la qualità in
merito.
Si era, ormai, in un periodo in cui l’universalismo medievale stava crollando; contestualmente, la politica dell’assolutismo
andava originando quei grandi tribunali centrali alla cui attività la dottrina si legava in modo extra-universitario, e le
lectiones universitarie non erano più una guida per la prassi giuridica.
Capitolo 8. La prammatizzazione del diritto comune: l’età della communis opinio.
I giuristi trattalisti e consulenti. In particolare: la giurisprudenza consulente.
A partire dalla fine del XV secolo la scienza giuridica manifestava due tendenze opposte: quella influenzata dalla cultura
umanistica e rinascimentale e quella volta a continuare la tradizione dello studio dogmatico del diritto (BARTOLISMO).
La prima tendenza, attecchita in Italia, era alimentata da un nuovo interesse verso il corpus iuris, un interesse storicistico,
filologico, all’apparenza completamente svincolato da immediate preoccupazioni pratiche, e come tale diametricalmente
opposto alla cultura dei seguaci di Bartolo.
La seconda tendenza, invece, era più tradizionalista rimanendo nell’alveo del mos italicus, caratterizzandosi al contrario
per un prevalente atteggiamento di pragmatismo giuridico e per una produzione legata alle esigenze forensi.
Quanto a questo secondo orientamento, da un lato, considerando che gli schemi del commento scolastico non sono più
produttivi, si afferma il TRACTATUS, cioè quella monografia volta a contemplare un definito settore del diritto e la
relativa prassi, in maniera specialistica e sistematica. Si tratta di materie tendenti, per loro natura, a sottrarsi alla ratio iuris
communis nonché all’influenza dei testi romani, che acquistano autonomia scientifica.
Basti pensare al diritto penale e al diritto processuale penale nei quali eccelle TIBERIO DECIANI o GIULIO CLARO,
entrambi nel ‘500. Oppure basti pensare al diritto marittimo o commerciale che conosce le sistemazioni di BENVENUTO
STRACCA; o al diritto civile, nel quale eccelle FRANCESCO MANTICA.
Fra tutti, però, occorre sottolineare l’opera di GIAMBATTISTA DE LUCA che prende l’audace e intelligente iniziativa
di volgere finalmente in lingua italiana, le dissertazioni in 15 libri del suo enciclopedico “Theatrum veritatis et iustitiae”,
compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale.
Dall’altro lato, il pragmatismo giuridico, che si fa strada nel mos italicus è motivo di una crescente prevalenza del genere
letterario dei CONSILIA, cioè di quella letteratura consiliare che accoglie i risultati dell’ormai preminente attività extrauniversitaria e consulente della giurisprudenza.Il fenomeno ha una tale portata da denominare “dei consigliatori” il
periodo che si apre nella seconda metà del XV secolo.
Fra le tipiche forme di consulenza, molto diffuso il CONSILIUM SAPIENTIS IUDICIAE, parere che i magistrati
comunali (consoli, podestà, ecc.) richiedevano al giurista di cattedra, per esse assistiti nella definizione della causa; Questi
riproducevano poi nella sentenza il consilium ricevuto, operazione talvolta prevista perfino dagli stessi statuti comunali.
Ove si tratti di magistratura podestarile, il giudice ha un ulteriore vantaggio: nella severa procedura, il sindacato, cui i
comuni sottopongono a fine gestione l’operato del podestà (di regola un forestiero), costui difficilmente correrà il rischio
di vedersi contestata una sentenza quando quest’ultima poggia sulla glossa o sul parere di un giurista dalla fama
indiscussa. Questo strumento si avvia al declino nel secolo successivo, con l’affermarsi negli stati assoluti della
giurisprudenza dei grandi tribunali, tutti composti da giuristi di alta qualificazione e tutti funzionanti secondo la regola
“iura novit curia” (la legge non deve essere provata al giudice, perché egli la conosce a prescindere da ogni attività delle
parti).
Altra tipologia di giurisprudenza consulente quella dei consilia scritti dati dal giurista alle parti, anziché dal giudice.
Nel XV secolo era stata consuetudine generale che glossatori e commentatori dedicassero parte della loro produzione alla
consulenza privata, dei cui risultati venivano curate raccolte scritte, che avevano sia peso politico che dottrinale.
Politico perché, talvolta, anche pontefici e imperatori richiedevano l’intervento dei doctores della legge, perché questi
spesso si associano in collegi e centri professionali per l’elaborazione del consilium, i cui relativi onorari a questi
corrisposti sono in genere altissimi. Il consilium risulta una manifestazione concreta del potere esercitato dal ceto dei
giuristi professionalmente e corporativamente organizzati.
Dal punto di vista dottrinale, si può dire che fino al ‘400 l’attività consiliare appariva accessoria, così come secondaria
risultava la relativa letteratura; solo Bartolo, baldo e pochi altri sopravvivono ai secoli attraverso i propri consilia.
L’attività dei CONSILIA acquista maggior rilievo nel momento in cui l’attività dottrinale e universitaria si va
intorpidendo e nel XV e XVI secolo trionfa il pragmatismo..
La scoperta della stampa determina poi la massima amplificazione del fenomeno. Tutti fanno i consulenti e scrivono
consilia e tutti ne curano ambiziosamente la pubblicazione, anche quei giuristi minori che svolgono solo attività di
consulenza: le raccolte diventano, così, una fondamentale fonte di cognizione del tardo diritto comune, fino al chiudersi
del XVIII secolo.
In Italia le raccolte di consilia stampate si avvicinano al numero di cinquecento e hanno una circolazione europea.
L’ utilità pratica e l’illimitato successo della letteratura consiliare è evidente: se il giurista lega ora fama e prestigio
personali alla raccolta dei pareri legati dati ai clienti, la richiesta delle collezioni consiliari è altissima anche da parte
degli stessi avvocati e magistrati, poiché tali collezioni costituiscono repertori casistici in cui è facile ritrovare il facsimile
della soluzione da adottare e della relativa argomentazione legale.
La condanna principale fatta a questa “modalità di far diritto”, che la fece anche entrare in crisi, deriva dal fatto che alla
raccolta del prestigioso giurista, ne seguivano decine di giuristi meno qualificati che tentavano di farsi largo.
Si consolidò una vera e propria tradizione di denunce, accuse e disprezzo per tale attività; famoso fu il rimprovero che
l’umanista ANDREA ALCIATO rivolse ai consulenti. Ad egli rispose TIBERIO DECIANI, grande penalista e
consigliatore, che rivendicò la pars sana della giurisprudenza consulente e i suoi meriti obiettivi: la promozione della
concreta funzionalità dell’ordinamento giuridico nel suo complesso. Difatti, il pratico, a differenza del dotto, doveva
risolvere il pressante problema giuridico delle infinite situazioni della realtà e non con ipotesi teoriche ed, inoltre, doveva
coordinare una serie di fonti concorrenti, non solo il corpus iuris, cui l’ordinamento faceva capo in età moderna;
coordinamento che lo portava a dover cercare una risposta concreta al caso propostogli.
Era il giurista che faceva muovere la giurisprudenza e il diritto, perché quest’ultimo si muoveva attraverso il capillare e
quotidiano scioglimento normativo degli infiniti casi pratici di cui l’ordinamento giuridico realmente viveva e funzionava.
E poteva fare ciò solo lasciando la veste di cattedratico e assumendo quella di consulente: ad egli era affidata la certezza,
la vitalità e la crescita dell’ordinamento giuridico.
La “communis opinio”
Il secolo d’oro del commento aveva creato una galleria di nuove autorità le cui opinioni erano venute quasi a sostituirsi
integralmente al testo; tuttavia queste non erano state d’ostacolo al formarsi di soluzioni univoche verso cui varie opinioni
convergessero districandosi nella selva di opiniones contrastanti e conseguenti controversie.
Tale eterogeneità generava la più grande malattia del diritto: l’incertezza del diritto
Comprensibilmente, si originò così la consuetudine di verificare, di fronte ad ogni singolo caso problematico, se vi fosse
coincidenza d’opinioni delle massime autorità dottrinali, da considerare quindi determinante.
Il vero e proprio trionfo della communis opinio fu decretato dalla prassi a partire dalla seconda metà del XV secolo.
I motivi di tal trionfo sono ben comprensibili: i giudici necessitavano, in mancanza di una sviluppata giurisprudenza dei
precedenti, di regole comunque autorevoli che costituissero un facsimile per la loro sentenza, e il consilium del giurista
rivestiva tanta importanza agli occhi del giudice, quanto più esso era confortato da numerose e autorevoli opinioni
consimili.
La maggioranza di numero in fatto di opinioni simili e l’autorità dei giuristi furono infatti i due elementi da cui la
communis opinio si originava.
La letteratura consiliare alimentava la communis opinio e la communis opinio alimentava quella consiliare perché il
consulente ricercava l’opinione maggioritaria tra le raccolte di consilia già pronte.
Questa opinione comune assume sempre più nel tempo un’importanza fondamentale fino a sostituite la norma giuridica o
l’interpretazione specificamente dottrinale di questa anche nei tribunali dove responsabilizzava giudici e consulenti nel
caso di una sua ingiustificata inosservanza.
Appare quindi come strumento di certezza, bisogno costantemente vivo in un ordinamento dai caratteri in prevalenza
giurisprudenziali che costringe il giurista a rinunciare alla creatività di pensiero per sottostare alle opinioni dei molti;
Segna, così, il punto di massima giurisprudenzalizzazione del sistema del diritto comune e si presenta come strumento di
tipo legalistico, autoritario e impersonale con cui supplire alle carenze e al silenzio dello Stato.
Si identifica all’interno della giurisprudenza come una sua autolimitazione che solo in seguito vedrà il passaggio da un
diritto giurisprudenziale ad un diritto legale e la ricerca della certezza del diritto con soluzioni alternative.
La giurisprudenza dei grandi tribunali: considerazioni generali.
Le polemiche sorte come quella fra l’alciato e il deciani, evidenziano la crisi della giurisprudenza consulente, attività la
cui prevalenza è, a sua volta sintomo di una crisi precedente: quella della produzione scientifica e universitaria.
Gli specifici aspetti di tale crisi sono appunto da ricercarsi tra il solco apertosi tra la prassi forense e l’insegnamento
universitario e nel prevalere della quantità sulla qualità della giurisprudenza consiliare.
Inoltre, vi è la crisi dello spazio di potere indipendente dei giuristi a favore di strutture con profili marcatamente
pubblicistici: un lungo tramonto che non avrà fine se non con le codificazioni.
Contemporaneamente quindi,si verifica il calo di importanza dei consilia e la crescita di consistenza e autorità della
giurisprudenza, quindi delle decisiones, delle grandi corti statuali parallelamente alla diffusione della raccolte
compendianti tale giurisprudenza.
Ciò si spiega alla luce del fatto che in tali corti siedevano personalità reclutate fra i migliori specialisti del diritto che in
quanto tali non sono certo vincolati al parere del singolo consulente. Analogamente, le raccolte di decisiones sono
maggiormente accreditate delle raccolte di consilia poiché portano a conoscenza dei pratici la giurisprudenza di un
tribunale autorevole che, mettendo a disposizione il materiale casistico, rende possibile l’individuazione delle tendenze
della corte e dei principi accreditati presso essa.
A partire dal XVII secolo la giurisprudenza dei grandi tribunali diviene in Italia e in altri paesi europei la fonte più vitale e
creativa nel regime del diritto comune.
Questi tribunali furono dotati di cospicui poteri e di competenze sia specifiche in un unico grado e sia generali sulle
decisioni delle magistrature inferiori e il formarsi, nei vari stati, di una potente casta di magistrati di elevata preparazione
tecnica e di notevole influenza politica determinarono una prevalenza della giurisprudenza specificatamente giudicante
venendo a svolgere nel secolo XVII quel ruolo primario e fondamentale che era stato proprio della sola giurisprudenza
consulente: collocandosi accanto a questa e via via sopra di questa, concorse ad accentuare ancor di più il complessivo
fenomeno di prammatizzazione tipico del tardo regime di diritto comune.
Contemporaneamente anche la figura del giurista consulente passò in secondo piano così come era accaduto al doctor
universitario. Il tipo di giurista in posizione trainante nel processo di quotidiano svolgimento del diritto comune divenne
quello del magistrato operante presso un supremo tribunale centrale o dell’avvocato quivi patrocinante.
L’effettiva operatività della communis opinio venne a dipendere da una ufficiale conferma accordata dalle supreme corti
statuali, ma anche queste ultime poterono concorrere a creare un atteggiamento uniforme su un dato caso: le opiniones
sostenute in iudicando si aggiunsero a quelle sostenute in consulendo.
Della giurisprudenza di ciascun tribunale è possibile distinguere la forza vincolante all’interno dello Stato dalla portata
autoritativa all’esterno dello Stato stesso, cioè la capacità di porsi come modello autorevole presso altre corti europee.
Quanto al primo punto, in non pochi ordinamenti vige la tendenza dei supremi tribunali ad attribuire forza vincolante ai
propri precedenti. Nella prassi, infatti, le decisiones hanno vis legis e preminenza sulle fonti del diritto scritto nel senso
che gli operatori giuridici, ricorrono anzitutto alla soluzione contenuta nelle pronunce della corte suprema.
Ciò era alimentato dagli stessi tribunali che nella posizione di assoluta preminenza si arrogavano la prerogativa di poter
creare diritto e che questo avesse una sorta di infallibilità.
Quanto al secondo punto, bisogna sottolineare che le decisioni accolte presso talune corti prestigiose avevano una
notevole tendenza espansiva; la giurisprudenza di numerose corti, si rivela alquanto permeabile alle soluzioni accolte
presso gli organi giudicanti di altri paesi. Questo contribuisce ad un ricambio e ad una vicendevole integrazione fra le
giurisprudenze di più paesi che portano alla formazione di usi forensi europei.
Ciò è reso possibile grazie all’impiego dello ius commune, diritto cui tutti i paesi sono compartecipi e grazie a quella
considerazione superstatale e universale che i giuristi continuano a conservare del diritto comune.
Le soluzione accolte da una corte e poi divenute generali, perché inserite nella prassi di più collegi, tendono a funzionare
come communes opiniones giudizialmente recepite poiché, proprio come queste, sono riconosciute da una vasta cerchia di
tribunali supremi, in questo caso.
Ciò non toglie che i tribunali possano orientarsi liberamente nell’accoglimento del diritto comune fino ad esercitare un
sindacato equitativo sull’applicazione delle norme giustinianee e della relativa dottrina.
Il riferimento all’equità evidenzia l’originalità e l’innovazione della giurisprudenza in questione; l’equità è, infatti, un
ambito riguardante il potere legislativo, potere in cui esorbita il potere giurisdizionale non essendo delimitato in capo ad
un unico soggetto ma unito e commisto con altri poteri in capo al sovrano.
L’equità e/o la discrezionalità del giudice sono concetti a cui si ricorre nell’ambiente giuridico in cui i grandi tribunali
operano ed è impensabile che il giudice si subordini alla lettera della legge in veste di mero applicatore della stessa, come
invece diviene ovvio nel pensiero moderno.
La successiva polemica illuministica contro la figura del giudice-interprete dell’Ancient Regime, accusato d’essersi fatto
padrone assoluto e arbitrario manipolatore della legge, è a questo riguardo significativa: da un lato testimonia le infinite
implicazioni politiche e ideologiche del problema della interpretazione in questo periodo, dall’altro conferma a quali
livelli fosse giunta, nella sua tarda evoluzione, la giurisprudenzializzazione del diritto comune.
Si può concludere che l’incidenza della giurisprudenza giudiziale nel determinare le modalità di svolgimento del tardo
diritto comune è assai forte anzi, costituisce ora la principale cinghia di trasmissione di quel diritto, ed è volta ad una
duplice funzione: sia al consolidamento e alla certificazione del diritto all’interno degli Stati, sia come correttivo ad un
possibile uso indiscriminato dei poteri discrezionali.
La giurisprudenza dei grandi tribunali: esame di taluni aspetti problematici
Sono quelle sopra analizzate le tendenze complessive della giurisprudenza nei secoli XVI – XVIII. Tuttavia sono
tendenze di fondo che, nelle diverse realtà dove esigenze eterogenee producono risultati eterogenei e la giurisprudenza si
differenzia per la diversa politica del diritto che la ispira, possono subire certe oscillazioni, anomalie, impulsi divergenti o
addirittura contrari che si innestano con forza riduttiva nello sviluppo di tale giurisprudenza stessa. Qualche esempio.
La convivenza di due tendenze, entrambi forti, quella volta ad unificare l’ordinamento positivo dello Stato e quella ad
aprire questo ordinamento alla giurisprudenza di altri paesi provoca, all’interno del diritto comune, fenomeni di
particolarizzazione e simultaneamente di europeizzazione.
Ci sono tribunali che si caratterizzano per il primo filone descritto, e altri per il secondo; ciò provoca non pochi problemi
in chiave di ordine.
Vi sono poi corti che svolgono un’opera unificatrice sufficientemente coerente nel tempo in armonia con i programmi
uniformatori del potere centrale ad esso organicamente funzionali e altre le cui tendenze giurisprudenziali rivelano un
marcato atteggiamento di indipendenza nei confronti del sovrano, sviluppando una loro particolare politica peculiare
espressione di particolarismo: sono temporanei alleati ma non organi al servizio del sovrano.
Ancora, moltissimi tribunali esercitano il loro potere discrezionale prevalentemente nel rispetto delle esigenze di certezza
e di coerenza interpretativa: le rispettive desisiones sono caratterizzate da tendenziale fedeltà ai precedenti e al non
scavalcare le comune opinio giudizialmente canonizzate. Altre mostrano aspetti di arbitrarietà e, in genere, son le stesse
che non agiscono in accordo agli intenti di unificazione dell’ordinamento giuridico: utilizzano il diritto comune in modo
spregiudicato oltrepassando anche gli ampi poteri equitativi loro concessi.
Il quadro complessivo della situazione del diritto comune vede un diritto praticato dai paesi europei nei secoli XVII e
XVIII che ha le sue fonti solo in parte nella legislazione statuale, nei diritti locali e speciali, nello ius commune; rilevano
soprattutto gli usus fori cioè l’applicazione che di tali fonti fa la giurisprudenza dei grandi tribunali.
In tale fonte si ritrova, quindi, la concreta disciplina delle materie civili, penali e processuali: disciplina fondata
sull’esercizio di poteri discrezionali solo in parte limitati dai precedenti e dalle communes opiniones recepite.
Le raccolte di giurisprudenza e il loro ruolo nel tardo regime di diritto comune. La distribuzione dei principali tribunali
supremi sul continente europeo: cenni.
L’elemento consiliare prevale indubbiamente nel XVI secolo che viene definito “età dei consulenti”. Nel seicento e nel
settecento, alla cospicua massa dei CONSILIA, però si viene ad aggiungere copioso materiale giurisprudenziale tra le
fonti di cognizione: raccolte di dispositivi, motivazioni, massimari, che raccolgono la produzione giudiziale dei più
importanti tribunali, giurisprudenza che si afferma definitivamente nel XVIII secolo.
Di particolare rilevanza, tra i prodotti di tale giurisprudenza, sono i MASSIMARI relativi alla giurisprudenza di più paesi:
compilati attraverso la selezione e la elaborazione di un vastissimo complesso di precedenti raccolte di varia nazionalità,
compendiano sistematicamente le massime prodotte dal consolidarsi e dal convergere di decisiones adottate dalle più
autorevoli corti. Sono anche qualificati come summae del diritto giurisprudenziale europeo, le opre forse più espressive
della sopranazionalità del diritto comune.
Tuttavia, nonostante il ruolo di preminenza che riveste tale giurisprudenza non va contrapposta al diritto dottrinale poiché
ne è sempre un elemento.
Di particolare rilevanza fra i grandi tribunali quello della SACRA ROTA, massimo tribunale per il civile nello Stato della
chiesa e massimo organo giudicante della comunità dei paesi cattolici nelle materie disciplinate dal diritto canonico;
In Francia il PARLAMENTO di Parigi; nella penisola iberica i REGI CONSIGLI di Castiglia, Aragona e Catalogna o il
supremo Senato del regno di Lusitania; nei Paesi Bassi il GRAN CONSIGLIO d’OLANDA per le province settentrionali
e il GRAN CONSIGLIO di MALINES per quelle meridionali; in Germania il TRIBUNALE CAMERALE dell’IMPERO
in Germania, corte suprema del reich nel 1495; i 3 grandi tribunali della Sassonia di HALLE, MAGDEBURGO E
LIPSIA;
In Germania, però, mancarono tribunali capaci di sviluppare un vigoroso processo interno di unificazione giuridica
territoriale, cioè una giurisprudenza che nell’uso congiunto del diritto romano e del diritto locale, acquistasse una
uniforme impronta regionale. Pertanto la giurisprudenza ivi prodotta non fu usata come pretesto per una unificazione
interna del diritto ma come modello imitato. Furono l’università e la dottrina a conservare più a lungo, tramite l’attività
consulente, il predominio sulla prassi.
Negli Stati italiani furono centri maggiormente creativi i due SENATI REGI in SAVOIA e in PIEMONTE, la ROTA
FIORENTINA, la SENESE e la LUCCHESE, il SACRO REGIO CONSILIO nel regno di Napoli, la REALE UDIENZA
di Cagliari, la ROTA CIVILE e CRIMINALE nella repubblica di Genova, il prestigioso SENATO di MILANO, i
tribunali veneziani della QUARANTIA.
Nel novero di questi tribunali europei si distinguono le corti la cui giurisprudenza è univoca espressione di un’unitaria
autorità legislativa centrale e le corti che sviluppano la loro giurisprudenza in maniera indipendente dal potere sovrano,
(come accadde in FRANCIA).
Con questi caratteri pratici e per un periodo di tre secoli, il MOS ITALICUS si sviluppa fino alla codificazione, in
maniera lenta ma mai stagnante.
Il diritto comune, reso operante dal mos italicus continua a crescere: come un fiume lento che si avvia alla foce, trascina
nelle proprie acque tutto ciò che, dall’origine in poi, vi sia confluito; nulla si disperde o è abbandonato.
Diviene oggetto di speculazione per nuovi movimenti, come l’umanesimo (mos gallicus) e il giusnaturalismo:
speculazione storica e filologica nel primo caso, razionalistica e sistematica nel secondo.
Ma non è più l’Italia il crogiuolo di queste nuove dottrine; lo sono Francia, Olanda, Prussia e Austria.
In Italia queste correnti innovatrici sono poste piuttosto in ombra dal bisogno di strumenti miranti alla certezza giuridica:
si affiancano o si subordinano così al perdurante mos italicus senza mai poterlo integralmente sostituire.
Capitolo 9. L’umanesimo giuridico e la scuola culta.
“Umanesimo” medievale e umanesimo rinascimentale nel mondo del diritto.
Durante l’umanesimo rinascimentale si origina un pensiero giuridico che ripudia la tradizione scientifica portata al
culmine dai Commentatori.
Tuttavia questo distacco non è netto né irriducibile: si può cogliere un processo evolutivo nel segno della cultura classica
fra Medioevo ed età moderna.
Analogo discorso per il pensiero giuridico.
Per quanto il pensiero moderno si fondi nell’umanesimo rinascimentale, l’alveo generatore della giurisprudenza moderna
è ancora quello medievale.
Seppur il rinascimento consista nella “scoperta dell’uomo e del mondo, la speculazione giuridica umanista si compie sui
fondamenti del corpus iuris. Difatti se la definizione dell’Umanesimo è la scoperta dell’uomo, l’Umanesimo nel mondo
del diritto allora era cominciato con Irnerio che aveva scoperto un diritto, secondo Ermogeniano, costituito “hominum
causa”.
Ad ogni modo vigeva una certa continuità che lega medioevo ed età umanistica e moderna e la consapevolezza che lo
spirito di entrambe le epoche si rivolge a contenuti comuni; ma, per quanto l’oggetto degli studi possa essere identico, non
lo è il modo con cui l’oggetto fu visto ed interpretato e ciò permette di individuare storicamente quelle età.
La filologia e la storia alla riscoperta del corpus iuris: fermenti e polemiche dell’umanesimo letterario
Una speculazione umanistica specificatamente giuridica sui testi del corpus iuris, condotta attraverso l’attività di una
SCUOLA UMANISTICA (O CULTA) DEL DIRITTO, si dispiega solo nei primi decenni del secolo XVI, con la
comparsa dell’eminente figura di Alciato. I nuovi presupposti per accostarsi ai testi romani sono già, invece, operanti nel
secolo precedente: vi è l’esigenza di un ritorno ai modelli culturali dell’antichità classica, di una riscoperta della
personalità umana nella sua integralità esistenziale e nella sua originalità, di recuperare il passato nella sua forma
storicamente genuina attraverso un ripristino filologico dei testi antichi.
Il corpus iuris,in precedenza “sequestrato dai giuristi” e trattato alla stregua di un intoccabile e autoritario testo
normativo, acquista dunque un valore inestimabile per gli umanisti, monumento dell’antichità romana; non più un sacro
compendio di norme imperative, di un diritto del presente da applicare senza discutere ma un libro che deve essere
filologicamente storicizzato e recuperato proprio per rendere testimonianza alla sapientia dei romani.
Riguardarlo come Glossatori e Commentatori hanno fatto significa, agli occhi degli Umanisti, mascherare da codice
vigente un testo che ha lo stesso valore di un’opera di Varrone o di Cicerone.
Ed ecco che riaffiorano così manoscritti della giurisprudenza romana estranei al corpus iuris, fonti antiche pressoché
ignorate, in cui i giuristi si rituffano e di cui scrivono trattati e studi di critica filologica come il De verborum
significatione di MAFFEO VEGIO o l’Elegantiae latinae linguae di LORENZO VALLA.
Giuristi come ANGELO POLIZIANO e LUDOVICO BOLOGNINI intraprendono l’opera di revisione filologica del
corpus iuris nonché la comparazione tra l’antico manoscritto del Digesto e il testo utilizzato da Glossatori e
Commentatori.
E’ pertanto comprensibile un rifiuto nei confronti dei giuristi medioevali e dei bartolisti, ritenuti barbari ignoranti privi di
nozioni storiche e critiche che hanno pasticciato rozzamente sui testi giustinianei interpretandone le parole come se
fossero state scritte il giorno prima e costruendovi appresso glosse e commenti nel modo più orribile e incolto.
Tale atteggiamento di polemica domina il Quattrocento e raggiungerà gli estremi in pieno XVI secolo, divenendo una
tradizione consolidata e d’obbligo. Non stupisce che VALLA definisca “cigni”: Sulpicio, Varrone, Scevola, Ulpiano,
Cicerone, e “oche”: Bartolo, Accursio e Dino, e che tutta la schiera di umanisti maggiori e minori alimentino una
letteratura accusatoria contro la rozza giurisprudenza del Medioevo e il Bartolismo che non accenna a scomparire: da
AMBROGIO TRAVERSARI, il FILELFO, GIOVANNI FORTEGUERRI, ANGELO POLIZIANO e l’allievo PIETRO
CRINITO.
Dai letterati ai giuristi, dall’Italia alla Francia. La battaglia umanistica cambia terreno. I grandi giuristi
dell’Umanesimo
Il culto per l’antichità generò la penetrazione storico-filologica dell’umanesimo letterario nel mondo del diritto e in
particolare in quel diritto romano classico che Giustiniano fu accusato, sempre dagli Umanisti, di aver manipolato e
sottratto ai posteri. Ciò sommosse, mettendo in discussione, l’autorità stessa del corpus iuris quale giustizia eterna e
universale e normativa vigente e attuale.
Mettere a fuoco e razionalizzare questi argomenti spettava alla scuola CULTA, il cui fondatore di un indirizzo umanistico
specificamente giuridico fu ANDREA ALCIATO. Alciato, pur formatosi in ambiente italiano, alla scuola del commento e
perfetto padrone del mos italicus, per il metodo storico filologico professato e per gli interessi perseguiti nella sua
produzione scientifica, incontrò molte resistenze in Italia, tanto da decidere di trasferirsi in Francia. La sua presenza
presso l’Università di Bourges fece emergere tale scuola come centro per eccellenza dell’indirizzo culto ma segna anche
l’esplosione dell’umanesimo giuridico fuori dall’Italia con feconde manifestazioni scientifiche della nuova corrente del
mos gallicus
Con l’ALCIATO, si compone “il grande triumvirato” dei primordi dell’umanesimo giuridico formato da: ALCIATO, il
francese GUGLIELMO BUDE’ e il tedesco ULRICO ZASIO.
La storicizzazione del diritto romano. L’Antitribonianus di Francesco Hotman
Il movimento umanistico nasce quindi in Italia, si sviluppa poi in Francia e si propaga in Europa sotto l’appellativo di
MOS GALLICUS, svolgendosi contemporaneamente su due tipici filoni fondamentali: da un lato, attraverso l'impiego
dell’esegesi filologica, tende ad una storicizzazione e ad una relativizzazione del diritto romano; dall'altro, genera una
spiccata tendenza alla costruzione sistematica del diritto, inteso come un edificio dogmatico di principi, di norme, di
istituti da coordinarsi secondo un metodo razionale, anche fuori dai criteri giustinianei di collocazione delle materie.
Se prendiamo in considerazione la prima linea di sviluppo, ci accorgiamo che a liberare la compilazione giustinianea dalle
incomprensioni interpretative medievali, è stato proprio il mos gallicus in “obbligata” contrapposizione a quello italiano.
Gli attacchi polemici dei Culti ai metodi ritenuti sofistici della giurisprudenza medievale e bartolistica, furono, infatti, di
una violenza inaudita, come già le accuse dell’umanesimo letterario. Definirono i bartolisti degli asini ultramontani
poiché, come Budè sottolineò, come potevano essere descritti coloro che ritenevano le leggi giustinianee cadute dal cielo
e non scritte e concepite da un uomo?
Non mancano numerose polemiche e colorite definizioni; basta ricordare chi in questo periodo sono “condannati”
parecchi esponenti giuridici precedenti finanche Giustiniano e Triboniano, rei di aver frammentato e confuso il grande
patrimonio giuridico della romanità classica.
Spicca il volumetto di HOTMAN, l’Antitribonianus, all'interno del quale ritroviamo attacchi ingenti a giuristi precedenti
ritenuti plebei e ignoranti, specialmente Triboniano. Il nocciolo di tale summae di polemiche consiste in un’istanza molto
più rivoluzionatrici di semplici accuse.
Egli riteneva che il diritto di Giustiniano fosse superato ed inattuale per essere applicato ad un mondo storico che aveva
ben altre esigenze organizzative quanto a strutture politiche e prassi giuridica e che fosse inutile cercare di resuscitarlo per
renderlo applicabile.
Bisognava invece che una commissione di uomini di Stato e di giuristi fosse incaricata di trarre dal diritto romano quanto
ancora vi fosse di vivo e irrinunciabile e con esso, sulle basi della filosofia, della legge mosaica e delle consuetudini del
regno, compilare in lingua francese uno o due buoni volumi di norme semplici e chiare che sostituissero la molteplicità
delle leggi e delle interpretazioni, ponendo fine al caos giurisprudenziale creato nei secoli dagli interpreti del corpus iuris.
Il programma dello Hotman, si risolveva, dunque, in una drastica proposta di semplificazione in un codice di tutto il
diritto francese, pubblico e privato, cioè in uno dei primi veri propri progetti di “codificazione” nazionale.
Essa rivelava così che tanto accanito disprezzo contro Giustiniano, aveva un preciso aggancio nella situazione politicogiuridica del presente e che mirava ad una uniformità giuridica nazionale e ad una nazionalizzazione del diritto
corrispondente pienamente allo sforzo di accentramento politico della monarchia, economico e delle strutture sociali.
Per quanto riguarda le personali idee di codificazione dell’Hotman, solo più di due secoli dopo la Francia avrebbe accolto
e attuato alcune istanze provenienti proprio dal suo pensiero, che opponeva la Bibbia a Giustiniano e che andava
predicando la fine del diritto comune, cioè la distruzione di quello che era l'orizzonte giuridico stesso della società
europea.
Il volume dell’Hotman può essere considerato come un vero e proprio manifesto delle nuove dottrine sulla storicizzazione
del diritto romano e sulla codificazione, il cosiddetto antitribonianismo. In esso si percepisce netta la preparazione ad una
svolta del pensiero giuridico.
La difesa del mos italicus e i dialogi di Alberico Gentili: i “barbari” rispondono alle accuse umanistiche
Da parte sua il MOS ITALICUS, che comunque in Italia e in Germania andava continuando impavidamente a
predominare, non rimase senza robusti paladini. Gli esponenti del tradizionale metodo del commento trovarono il
massimo difensore nel giurista italiano ALBERICO GENTILE.
Nei suoi De iuris interpetibus dialogi sex, egli riconosceva la fondatezza di alcune critiche lanciate dai Culti ai bartolisti,
pur riconfermando quella che era a suo avviso la sostanziale e superiore bontà del mos italicus; egli concluse quindi che
era necessario emendare storicamente e filologicamente la preparazione scientifica dei bartolisti nonché i risultati della
loro attività interpretativa; fondamentalmente però l’impostazione metodologica doveva rimanere quella tradizionale,
impiegata con libertà scientifica e con il rispetto dovuto alla verità storica e al latino. L’esatta comprensione del
disposizioni del corpus iuris non doveva rimanere fine a se stessa ma doveva servire come accesso alla principale attività
del giurista che era quella di far funzionare le norme romane della pratica della vita giuridica quotidiana.
Seguire in toto il mos gallicus avrebbe significato tramutare l’accessorium in principale, ovvero ridurre la scienza
giuridica ad un preziosismo teorico praticato da esigua casta di eruditi.
Nei tribunali, secondo il Gentili, non serviva tanto l'ornamento storico-filologico, ma un robusto e realistico senso
giuridico che permettesse di comprendere la norma nella sua pratica funzionalità è che desse la possibilità al
giureconsulto di risolvere secondo giustizia il caso concreto.
In sostanza, al Gentili, l’atteggiamento dei Culti appare alquanto unilaterale. Accettare un metodo che svigoriva il corpus
iuris, isolandone varie parti e facendone così risultare antinomie e lacune anziché colmarle significava, per lui, avviarsi
verso un avvenire di incertezze.
La sua opera viene definita “un grido di allarme”. In egli vige quello “spirito di sistema”, una sorta si senso pratico
spiccatamente conciliativo del mos italicus che non sarà senza peso nel fenomeno di persistenza in Italia dello stesso mos
italicus.
Lo stesso senso pratico e professionale alitante nel mos italicus impedì l’accoglimento della tesi degli Umanisti e, talvolta,
furono gli studenti stessi ad esigere l’insegnamento del metodo bartolistico contestando quello svolto secondo il mos
gallicus.
Questo si ritiene sia stato un metodo per il diritto teorico contrapposto all’opera pratico-giuridica del mos italicus.
Questa contrapposizione tra teoria e pratica è, tuttavia, superficiale e non spiega a fondo perché in nessuna nazione
europea il mos gallicus si sostituì in toto al mos italicus. Perché?
I programmi dell’umanesimo, nato sulle rovine dell’universalismo politico e religioso del Medioevo, erano solidali con le
ideologie accentratrici dello Stato assoluto e con quello della riforma protestante e miravano all’unificazione dei diritti
nazionali perseguita con un’operazione filologica di storicizzazione del diritto romano. Storicizzazione che, valorizzando
gli elementi giuridici nazionali rafforza lo Stato unitario: la filologia era, così, utile alla politica; per cui l’espulsione di
parti del diritto romano era a vantaggio delle normative indigene.
Tali programmi, proiettati in Italia, risultano però impensabili così come il mos italicus appare preminente.
Questo perché la frammentazione in principati, repubbliche e domini stranieri si riscontrava anche nel diritto che mancava
di ideologia unitaria né tantomeno i singolo ordinamenti avevano la forza di realizzare un’unificazione giuridica capace di
prescindere dal diritto comune.
Nell’assenza di un tribunale centrale superiore ed operante indipendentemente dal diritto locale, anzi, era unicamente il
diritto romano, come diritto comune vigente in più principati, ad assicurare una certa uniformità giuridica.
Simile la situazione dell’area germanica, di particolarismo giuridico e politico in cui il diritto romano e la sua
interpretazione italiana vennero recepiti in blocco costituendo il diritto secondo cui il Tribunale camerale giudicava:
anche qui il diritto romano fu diritto comune unificatore, dipendente dall’opera del mos italicus.
Nella stessa Francia non fu senza peso l’operato di giuristi dall’orientamento pratico o bartolista né mancarono giuristi
culti che sapessero maneggiare perfettamente il mos italicus.
Alla luce di ciò i conflitti che, a fondamento, ponevano la contrapposizione di teoria e pratica favecano perdere le vere
proporzioni dello scontro tra i metodi. Venne addirittura sostenuto che uomini come il Gentili combattevano per una
causa sbagliata perché non capivano il significato della ricostruzione che i Culti volevano fare per rispondere
essenzialmente ad un’esigenza loro e del loro tempo, non universalistica ma nazionale.
Tale incomprensione poteva non giustificarsi alla luce del fatto che i tempi lavoravano più per le idee umanistiche; lo era,
invece, se visto dai rispettivi punti di vista: quello del Gentili che conoscendo la situazione italiana non poteva
obiettivamente intendere e quello degli Umanisti che non comprendevano la vitale funzione del metodo bartolistico né il
genio da cui scaturiva.
Il filone sistematico dell’umanesimo giuridico
Nella cultura giuridica umanistica accanto all'indirizzo storico-filologico si affiancò un orientamento sistematico, volto a
riordinare organicamente i concetti giuridici, delle norme e gli istituti secondo un ordine razionalmente ed esteticamente
più valido del cosiddetto “ordine legale di Giustiniano”.
Anche questa indirizzo rispondeva da un lato al bisogno di libera chiarificazione critica dell'apparato di Giustiniano,
dall’altro al rinnovamento sistematico della scienza giuridica che superasse l’analitica e casistica giurisprudenza
tradizionale.
Tale rinnovamento sistematico fu incoraggiato dalla tradizione tramandata da Aulo Gellio e derivante da Cicerone.
In sostanza si voleva mettere a disposizione non solo di giuristi ma anche agli studenti di diritto un prospetto panoramico
del diritto che si sostituìsse al precedente ritenuto troppo scomposto, analitico e dispersivo e fosse armonico, semplice e
chiaro.
L’attività sistematica degli umanisti culminò nell'opera del francese UGO DONELLO, il DONEAU, nei suoi
Commentarii di diritto civile in 28 libri che costituivano la prima autentica trattazione sistematica del mondo moderno.
Tuttavia, da tale opera come, in genere, da tutte le costruzioni sistematiche degli Umanisti non esulava il mos italicus di
cui un aspetto è notevole: l’influenza esercitata dal classico schema gaiano (personae, res, actiones) in cui erano
organizzate le istituzioni giustinianee.
I Culti, pur disprezzando i criteri di distribuzione delle materie che presiedevano al codice e al Digesto, non riuscivano a
rendersene indipendenti.
Tali tendenze facevano scorgere un filo che colegava ai grandi sistemi giusnaturalistici successivi, come Domat, a loro
volta premessa dottrinale alla codificazione napoleonica. Anche seguendo il filone sistematico, dunque, si fa viva l’idea di
un nuovo terreno culturale, quello delle codificazioni: un nuovo ordine dottrinale del diritto richiamava un nuovo ordine
legislativo che fosse ugualmente unificante sul piano legale, non solo su quello scientifico.
Parte Seconda. Il diritto comune nell’età dell’assolutismo
Sezione Prima. La situazione delle fonti del diritto positivo.
1. La crisi del diritto comune e la situazione di particolarismo giuridico nell’europa moderna (sec. XVI –
XVIII)
L’accentramento assolutistico del potere statuale e la crisi di certezza del diritto comune.
Il diritto romano elaborato dalla giurisprudenza medievale fu, a diverso titolo e con varietà di vicende, elemento vitale
dominante nell’esperienza degli ordinamenti politici europei. In ciascuno di questi la presenza del diritto romano diede
vita a quel caratteristico sistema di fonti giuridiche qualificato come regime di diritto comune.
Tale diritto era ovunque contrapposto ai vari diritti locali e particolari che in ogni paese erano vigenti, o quantomeno, era
utilizzato per completarli laddove essi presentavano lacune, realizzando un’uniforme consolidazione.
Ma col progressivo accentrarsi dello stato moderno il concetto di diritto comune, di un regime pluralistico delle fonti e di
una sua gestione giurisprudenziale, iniziò ad entrare in crisi.
Cominciò ad opporsi ad esso un concetto di diritto come legge dello stato sovrano nonché l’immagine dello Stato stesso
produttore esclusivo e autoritario di norme giuridiche anzichè conservatore di molteplice diritto precostituitogli; lo stato
quindi, stava diventando unica fonte del diritto. La politica assolutista, volta a raggiungere il pieno controllo
dell'ordinamento positivo e della gestione del diritto, si avviò a risolvere il problema dell’unificazione giuridica da essa
generato facendo leva sull’intervento legislativo statuale anziché su un programma di riordino e certificazione del regime
di diritto comune poiché questo era pur sempre largamente giurisprudenziale ed evolventesi da secoli senza alcun
intervento del legislatore. Come tale, lo ius comune:
1- Era sentito come un diritto sovrabbondante e controverso, il cui dettato passando per l’interpretatio si
decomponeva in un fascio di opinioni dottrinali diverse, dalle quali il giudice traeva la regola per il caso singolo
con procedimento, di conseguenza, incerto e arbitrario.
2- Era stato ed era monopolio dei giuristi, a cui ne era stata completamente affidata l'evoluzione. In questo modo
non era riconducibile ad assoluti canoni di certezza giuridica.
3- Pur potenzialmente completo, si sosteneva su una base legale storica che necessitava di continuo di essere
mantenuta a livello del presente, attraverso un'opera di interpretazione creativa e di integrazione con le fonti
giuridiche del presente.
Diveniva così sussidiario di diritti preminenti in vigore a carattere generale o in particolare che esso integrava e da cui era,
a sua volta, integrato.
Il suo uso non poteva così non essere condizionato da una normativa locale rispondente a bisogni tecnici e specifici ma,
soprattutto, esso presentava nodi che generano l’esigenza di certezza: mancanza di semplicità e di compendiosità nonché
assetto casistico e controverso.
Il problema della certezza si presenta sempre in termini di urgenza se si affermano ideologie e dottrine secondo cui la
“gestione” del diritto e la garanzia della sua certezza debbono essere compito del legislatore statuale, come nel caso della
società del tardo diritto comune. Se, tuttavia, prevalgono ideologie e dottrine secondo cui devono essere i giuristi a
risolvere questo problema, le varie risposte giurisprudenziali sono espressione di un buon equilibrio fra ordine giuridico e
attese sociali: è questo il caso della società medievale .
La complessità del corpus iuris e le difficoltà di una sua applicazione come legge vigente, avevano aperto la strada ad una
attività interpretativa. Obiettivamente, il corpus iuris era divenuto poca cosa se raffrontato alla massa di opere dottrinali
generatesi nei secoli sulla sua base.
Dalla sterminata letteratura dottrinale accumulatasi fino al XVI secolo emergeva pur sempre la GLOSSA e gli autorevoli
COMMENTARII, ma ora chela letteratura consiliare e giudiziale si dilatava all’estremo e l'attività universitaria in crisi
aveva ceduto il passo ad una produzione essenzialmente pratica, la presenza di questi “libri di autorità” non era più
sufficiente a suggerire criteri di certezza.
Come osservò Ludovico Antonio Muratori si era oramai innescato quel meccanismo del processo degenerativo del regime
del diritto comune; d’altra parte i disegni statalistici postulavano il richiamo al sovrano di ogni potere politico e
normativo. Quest’ultimo si ritrovò di fronte ad un ordinamento avviatosi a perdere quelli che erano i suoi crismi di
certezza: il parere dei giuristi, divenuto privata opinio, e il pluralismo politico e sociale, tradotto in patologico
particolarismo.
Il lungo cammino e il lento chiarirsi dell’idea di codificazione nella cultura giuridica europea: cenni anticipati
Questi inconvenienti aprirono la strada, nella cultura giuridica europea, alla codificazione.
L’idea di un codice che in ogni ramo del diritto sostituisse in blocco il pluralismo e il disperso regime di fonti di diritto
comune e che costituisse un razionale, organico sistema di norme prodotte dallo stato fu, alla fine del XVIII secolo
totalmente anteposta e privilegiata rispetto alle soluzioni di semplificazione e certificazione del diritto basate sulla
tradizione.
Tuttavia, le dovute difficoltà tecniche fecero sì che la concreta attuazione di un tale programma si dilazionasse per quasi
tre secoli, ricevendo solo dall’assolutismo illuminato e dalla rivoluzione francese la spinta decisiva.
La lotta dell’assolutismo per la statalizzazione e l’accentramento della giurisdizione incontra tenaci resistenze.
Quest’unificazione politica dell’assolutismo post-medioevale ha favorito quella di unificazione giuridica, ma ha solo
annunciato e preparato l’idea di codificazione. Il lungo processo storico attraverso cui si passò dal sistema del diritto
comune a quello del diritto codificato giunse al suo stadio risolutivo attraverso momenti intermedi caratterizzati da
soluzioni parziali, fu solo astrattamente unitario poiché intercorsero crescenti interferenze ideologiche attraverso motivi
culturali sempre nuovi: solo al tramonto dell’assolutismo si giunse al completo rinnovamento generale delle norme per
ciascun ramo del diritto con conseguente soppressione dello ius commune.
Le motivazioni politiche e giuridiche di partenza, pertanto, non bastano da sole a spiegare il fenomeno della codificazione
nelle sue mature proporzioni conclusive ma sono, tuttavia, utili a comprendere il fenomeno della scomparda del diritto
comune sul continente europeo, nel suo complesso.
Il regime di diritto comune fu affossato definitivamente dalle ideologie di certezza incarnate dai codici europei, non solo
perché questi si presentavano come strumenti più compendiosi ma anche perché in una società con un’economia e una
cultura che cercava certezze, soprattutto nelle leggi, e quindi diversa da quella del passato non vi erano rispondenze alle
esigenze unitarie dell’assolutismo né a quelle egualitarie del liberismo.
Aspetti del particolarismo giuridico nel tardo regime di diritto comune: considerazioni sulla situazione degli ordinamenti
italiani.
La norma positiva è straordinariamente complessa in una situazione di particolarismo giuridico, dove vi è mancanza di
unità del diritto e coesistono un diritto comune (romano-canonico-feudale), un diritto regio o principesco e più diritti
particolari.
Il quadro delle fonti tra la fine del secolo XVI e del secolo XVIII (periodo d’ANCIENT REGIME) può costituire una
base di riferimento.
La distinzione fondamentale che caratterizza il diritto positivo è quella fra un DIRITTO COMUNE, applicabile in via
sussidiaria, e più DIRITTI PARTICOLARI, da applicarsi con precedenza sul comune poiché “ius particulare praevalet
iuri magis generali”.
Questo rapporto fra norme comuni e particolari è ancora reso più difficile dalla presenza di altri diritti che vengono ad
inserirsi tra i primi due; basta far riferimento al diritto FEUDALE, da isolare nell’ambito dello ius commune, che si
contrappone come normativa generale ad alcune particolari consuetudini e ai privilegi vigenti in non pochi territori ricchi
di feudi, e al diritto canonico che, però, risolve a proprio vantaggio la contrapposizione con lo ius proprium , col solo
limite dell’ingerenza sovrana.
Quindi tra il diritto comune e i diritti particolari non v’è legame più diretto come in età medievale.
Nel regime di diritto moderno tale coordinazione subisce l’interferenza della legislazione sovrana e principesca che come
normativa generale dello Stato e lex superior ha precedenza assoluta su tutte le altre fonti concorrenti, tollerate solo
laddove con essa non contrastino o laddove essa non sia intervenuta. Di conseguenza risulta rovesciata la precedente
formula: “lex superior derogat legi inferiori”.
Il problema del coordinamento delle fonti e il faticoso funzionamento della legislazione sovrana.
Al primo posto nella gerarchia delle fonti si pone il diritto generale dello stato, consistente nei precetti di provenienza
sovrana. Nel secolo XVI le sue norme costituenti presentavano una duplice condizione di assetto: in prevalenza si
trovavano in una situazione di dispersione e di accumulazione naturale, in minor parte si presentavano in assetto di
precostituita consolidazione, in quanto ordinate in conclusi corpi normativi.
In quest’ultimo caso tali corpi normativi potevano consistere in testi organici di promulgazione relativamente recente ma
anche meno recente o addirittura in corpi di legislazione medievale mantenutisi in vigore in singoli territori.
Dopo il XVI secolo furono tali corpi consolidati a costituire i soli nuclei unitari di diritto generale in quasi tutti i territori
italiani mentre la parte più abbondante si trovò in condizioni di dispersione e frammentazione.
La massa della legislazione sovrana era integrata, in via sussidiaria, dal diritto comune che, sorretto dal placitum
principis, colmava le sue lacune attraverso la prassi giudiziaria di uno o più tribunali centrali, la cui uniformità era
innegabile ma altrettanto arbitrale.
L’arbitrio dei magistrati nella decisone del caso concreto e la conseguente possibile contraddittorietà delle decisioni via
via adottate potevano derivare:
1- dal carattere frammentario, sovrabbondante e incoerente del diritto di provenienza sovrana nonché dalla
situazione di dispersione e disordine in cui esso si presentava;
2- dalla conseguente incertezza delle sue linee di saldatura con lo ius comune e quindi dalle notevoli difficoltà di
trovare un coordinamento, caso per caso, dei due sistemi normativi;
3- dalla mancanza di ordine nello stesso diritto comune, ormai sempre meno riducibile ai testi legali del corpus iuris.
E in aggiunta a tutto questo, il complesso del diritto positivo vigente a titolo generale nel territorio dello stato (risultante
dal diritto di provenienza sovrana cosi come affiancato dallo ius comune) era in parte derogato dal diritto canonico,
spesso attraverso deroghe per nulla pacifiche, cagione di forte contrasto fra gli ordinamenti normativi di Stato e Chiesa.
Inoltre, il diritto generale operava in coordinamento con i vari diritti particolari e il che accentuava la situazione di
incertezza. Seppur questi erano oggetto di continua revisione e livellamento da parte dell’autorità centrale che cercava di
ridurre le autonomie locali ma soprattutto le giurisdizioni locali e seppur tali statuti avessero, a fondamento, il placitum
principis ed in genere fossero interpretate in maniera restrittiva, la “polverizzazione del diritto” era solo in parte
riassorbita in quanto oggetto di un’opera velleitaria ed occasionale più che mirante al coordinamento dello stesso diritto
statutario, che rimaneva, in gran parte, materia viva e scoordinata tanto che poteva accadere che negli statuti di due
comuni nemmeno troppo distanti la medesima situazione giuridica fosse disciplinata in base a principi opposti.
Si consideri poi che tali leggi versavano in un pessimo stato conservativo che ne impediva il facile reperimento e
consultazione; a ciò si aggiunga il fatto che non vennero sottoposte ad alcuna elaborazione scientifica e dottrinale e non
rientravano, pertanto, nello formazione teorico-professionale dei giuristi, il cui studio si basava solo sulle fonti romanocanoniche: la loro conoscenza era patrimonio esclusivo di un ceto avvocatesco e notarile interessato a conservare
l’incertezza del diritto e relativi inconvenienti.
L’ordine di precedenza delle fonti negli ordinamenti era normalmente il seguente: 1) precedenza assoluta alla legislazione
del sovrano; qualora questa non disciplinasse il caso e la fattispecie non rientrasse nella disciplina canonistica o non vi
fosse un rinvio diretto allo ius commune si applicavano 2) le disposizioni statutarie o consuetudinarie locali e in,
mancanza, in ultima istanza 3) il diritto comune.
L’ordine di precedenza poteva subire poi modifiche a seconda della prassi giudiziaria delle varie corti.
Altri aspetti della mancanza di unità giuridica: la frammentazione locale e personale del diritto.
Il fenomeno del particolarismo giuridico caratterizzava un ordinamento costituito da una pluralità di fonti, a vario titolo
concorrenti, che risultavano:
1- lacunose, disperse e difficilmente conoscibili con certezza = mancanza di certezza;
2- di problematico e complesso coordinamento = mancanza di semplicità ;
3- non produttive di un unico e unitario diritto positivo, nell’insieme = mancanza di unità;
L’ordinamento giridico complessivo caratterizzato da una pluralità di fonti,non si riassumeva in un diritto positivo
unitariamente valido nello Stato, ma in più diritti positivi vigenti.
Saremo, per logica, indotti ad immaginare che non soccorrendo la fonte preminente, le varie situazioni giuridiche
trovassero disciplina in qualcuna delle altre fonti gerarchicamente susseguenti; così non è. L’ordinamento di fatto si
scompone in più diritti differenti a seconda che l’elemento di moltiplicazione sia oggettivo o soggettivo.
1)OGGETTIVO: la moltiplicazione del diritto su base oggettiva si produceva a livello locale, di ius proprium; in una
determinata situazione giuridica la cui disciplina fosse contenuta nella legislazione sovrana, la disciplina stessa avrebbe
avuto valore in tutto il territorio dello Stato; qualora questa fosse lacunosa e non esauriente, nel suo silenzio sarebbe stata
sostituita dallo ius proprium. Ecco il caso in cui poteva accadere che, nonostante il più o meno capillare e approfondito
livellamento delle legislazioni degli usi locali operato dall’autorità centrale, ogni statuto contemplasse la stessa situazione
giuridica con differenti discipline.
Si produce, così, una oggettiva moltiplicazione del diritto con un elemento sostanzialmente qualitativo.
Lo stesso fenomeno poteva verificarsi in connessione con un elemento quantitativo, producendo risultati analoghi.
Difatti, lo ius proprium poteva divergere non solo per soluzioni differenti ma anche per la differente estensione della
disciplina delle materie, più o meno ampia. Ne derivava che in alcuni territori la situazione fosse disciplinata dal diritto
comune nella totalità o in prevalenza e in altri, dove la legislazione era più puntuale, cadesse sotto uno ius proprium
ispirato a principi opposti a quelli dello ius commune o comunque divergenti.
2) SOGGETTIVO: la moltiplicazione del diritto su base soggettiva allude alla mancanza di unità giuridica in relazione
allo status sociale delle persone e riflette, la composizione stratificata in stati, in ordini, in classi della società europea
dell’età moderna. Il diritto positivo si scomponeva, così, in una serie di diritti speciali collegati ad una pluralità di
situazioni, privilegi corporativi o di status.
Il fenomeno della moltiplicazione soggettiva del diritto sotto il profilo sostanziale e giurisdizionale
La moltiplicazione soggettiva del diritto cioè il variare del diritto da persona a persona o da ceto a ceto si manifestava sia:
- sotto il PROFILO SOSTANZIALE. Attraverso il funzionamento di talune tra le fonti principali una certa situazione
riceveva una disciplina “ordinaria”. Tale disciplina tollerava una serie di deroghe fissate da altre fonti a vantaggio o
svantaggio di determinate categorie di persone individuate in base allo status sociale, professionale, confessionale,…
Tale deroga poteva derivare anche dalla stessa legislazione generale dello Stato che poteva prevedere più discipline
diverse per altrettanti gruppi o ceti di persone.
In ogni caso, la moltiplicazione del diritto avveniva o perché ad un complesso di precetti o istituti si affiancavano, in via
d’eccezione, varianti e modifiche o perché, in riferimento ad un determinato status si delineavano determinate situazioni
giuridiche o diritti e doveri, capacità e incapacità.
- sotto il PROFILO GIURISDIZIONALE. Col variare della norma si potevano profilare anche una pluralità di
giurisdizioni, ciascuna competente a decidere di un certo caso, esclusivamente in relazione allo status personale delle
parti, con conseguente sottrazione di determinati rapporti alla giurisdizione ordinaria e un ampliarsi dei conflitti di
competenza.
Le distinzioni di “status” più rilevanti quanto al variare del diritto. In particolare: l’esempio del diritto commerciale.
Le distinzioni di status capaci di maggior incidenza e di maggior produttività sul piano del particolarismo sono:
la distinzione fra laici e chierici, quella fra cattolici e non cattolici, come anche l’esistenza di una complessa e variabile
serie di privilegi generali, locali, familiari riservati ai nobili.
Prescindendo da quella tra liberi e servi che fu, talvolta, variamente operante, importanti conseguenze sortiva quella tra
soggetti commercianti e non commercianti.
La pluralità delle corporazioni di arti e mestieri, beneficianti ciascuna di propri statuti e di propria giurisdizione, aveva
costituito nel medioevo il contesto istituzionale di sviluppo dell’intera attività economica, cioè di tutte le forme di
produzione e circolazione della ricchezza. Nella varietà di posizioni soggettive che ne derivavano quella del mercator era
la più rilevante.
Lo specifico IUS MERCATORUM era applicabile a qualsiasi negozio attinente alla sfera commerciale nel quale avesse
preso parte un mercante, e non solo al solo rapporto tra i mercanti.
Il presupposto d’applicazione era dunque soggettivo: aveva funzione di porre al servizio del soggetto commerciante una
vantaggiosa ed efficiente disciplina speciale, che egli poteva utilizzare comunque e con chiunque si fosse trovato
professionalmente a contatto. Un certo atto era riconducibile nell’ambito d’azione del diritto commerciale e dei tribunali
della mercanzia in quanto posto in essere da un commerciante, non in quanto tale.
Dalla seconda metà del XVI secolo, lo stato, che andava assolutizzandosi, dovette fare i conti anche con questa eredità del
particolarismo medioevale ovvero con questa situazione di monopolio dell’attività mercantile che contrastava con i
programmi dell’assolutismo almeno per due versi: innanzitutto perché era fonte di complicazione giuridica e poi perché
sottraeva al sovrano la regolamentazione in senso statuale di questo ramo del diritto. La politica economica del potere
assoluto era tipicamente mercantilistica, volta ad attuare programmi di sviluppo interno della produzione: protezionistica
e interventistica presuppose un controllo sovrano del mercato e del commercio; per questo lo scopo delle monarchie fu
quello di limitare l’influenza politica della classe mercantile, di creare una disciplina statuale e pubblicistica del
commercio, avocando a sé le funzioni giudiziarie corporative.
La Francia è un esempio lampante nella realizzazione di tali programmi concretizzatisi in un precoce passaggio allo Stato
della giurisdizione commerciale e in una completa unificazione legislativa attuata con l’Ordonnance du commerce del
1673 e la successiva sulla marina mercantile del 1681, strumenti della politica mercantilistica di Luigi XIV.
La Francia fu il modello, ma questo fenomeno di assolutizzazione del diritto mercantile, non fu ovunque così rapido e
nemmeno in Francia stessa fu mai attuato del tutto; rimase, comunque, un modello cui gli stati assoluti europei ambivano.
Tuttavia, anche laddove il diritto commerciale si consolidò in forme organiche e unitarie in virtù di una disciplina
statuale,conservò il suo carattere originario di ius speciale e, come tale, non cesso di costituire un elemento che
accresceva la moltiplicazione personale dei diritti: solo la codificazione della materia lo avrebbe trasformato in attività
esercitabile da qualsiasi individuo (c.d. obiettivizzazione del diritto)
Il particolarismo giuridico soggettivo come tratto saliente della società europea d’Ancient regime
Una situazione di particolarismo giuridico innestata sul particolarismo territoriale rifletteva l’assetto di una società
cristallizzata in classi, ceti ed ordini ed ancorata d una concezione rigidamente corporativistica in cui la diffusione di
posizioni privilegiate di corpo e ceto era così capillare che la norma ordinaria emergeva con difficoltà.
L’affermazione di un diritto uguale per tutti che presupponeva l’assoluta eguaglianza giuridica dei consociati ed era a sua
volta connessa al principio liberale di una loro insopprimibile eguaglianza naturale, ebbe un lungo travaglio.
L’unificazione del diritto si doveva attuare, quindi, oltre che con una semplificazione tecnico-formale delle leggi con
l’eliminazione sostanziale degli ordini e corpi privilegiati rivendicanti particolari prerogative, postulando l’unificazione
del destinatario delle stesse norme da sostanziarsi nell’ignorare quanto più possibile status soggettivi.
Tale azione fu solo preparata ma non compiuta dall’assolutismo poiché questa mirava sì a far scomparire privilegi e
autonomie ma più perché risultavano essere limitanti per lo stesso poter sovrano che per smussare le differenziazioni
sociali alla volta dell’uguaglianza.
Pare esservi una certa soluzione di continuità fra particolarismo dell’età contestuale alla nascita dello stato assoluto e
quello medievale: unica differenza nella mancanza, della cultura dell’età moderna, di quel senso d’appartenenza ad una
repubblica cristiana; lo stato assoluto, concepito come laico, monocratico e razionale conferì al particolarismo ereditato
dal medioevo caratteri nuovi: quello di contraddittorietà con i programmi di concentrazione del potere dell’assolutismo,
quello di immobilismi conservatore e di irrigidimento delle barriere di ceto e gruppo dai caratteri discriminatori ed
oppressivi che facevano si che ad essere istituzionalizzato fosse l’elemento della disuguaglianza, non più quello della
gerarchia. Solo al tramonto del secolo XVIII si sarebbe aperta la vera battaglia contro il particolarismo.
Il particolarismo giuridico nel contesto europeo. Cenni.
La complessa situazione di particolarismo del diritto si riflesse in maniera varia nei diversi paesi europei, a seconda delle
varie tradizioni ivi presenti..
Ad esempio, in Francia, i motivi di frammentazione e moltiplicazione del diritto si complicavano per la presenza di una
frattura tra pays de droit ècrit e pays de droit coutumier; nell’una era il diritto romano ad avere vigore come ius commune
nell’altra vigeva invece una sorta di diritto comune consuetudinario.
In Germania, il processo di unificazione del diritto e delle strutture pubbliche ha uno sviluppo assai lento; inoltre vige un
accentuato particolarismo territoriale a cui si affianca un accentuato particolarismo giuridico e personale: in ciascun stato
germanico il diritto territoriale era integrato dal diritto romano in via sussidiaria; al contempo era eterogeneo e
frammentato da rendere già incerto e complicato il coordinamento interno delle sue componenti senza contare che questo
andava intrecciandosi con i vari diritti statutari e consuetudini locali e che, inoltre a livello di particolarismo personale, i
soggetti erano distinti in tre ceti: nobili, cittadini e contadini.
Le conseguenze del particolarismo sul piano della certezza del diritto e nel mondo della prassi giudiziaria.
La complessità degli ordinamenti giuridici positivi in tardo regime di diritto comune si traduceva:
1. in inevitabili conflitti tra norme;
2. in conseguenti conflitti giurisdizionali, poiché a più fonti si collegavano più giurisdizioni e più gradi di questa.
A ciò si connetteva una generale situazione di incertezza del diritto che, in particolare, era:
1. incertezza del singolo destinatario della norma
2. incertezza del giudice
- nel coordinamento delle fonti:
- nel ritrovamento della norma in quel diritto;
- nell’interpretazione della norma medesima.
E’ soprattutto da questo punto di vista che occorre considerare la situazione; il complesso ordinamento formale era,
infatti, trasformato e fluidificato nella realtà dalla multiforme prassi giudiziaria, la quale attraverso le sentenze e gli usi
forensi, rivela gli aspetti pratici della crisi.
Ciò che riusciva a far funzionare gli inceppati meccanismi dell’ordinamento era proprio la giurisprudenza forense che, a
partire dal XVII secolo, risulta il meccanismo primario del sistema. Solo un ampio potere discrezionale del magistrato ed
una sua libertà nell’apprezzamento del caso ispirata a criteri equitativi permettevano alla legislazione sovrana di
funzionare o di far funzionare in via sussidiaria le disposizioni locali e il diritto comune, supplendo anche all’eventuale
silenzio delle fonti.
Però, il prezzo da pagare per il funzionamento del sistema era il sacrificio - se non totale, parziale – della certezza. Questo
perché il giudice, fra più soluzioni interpretative già date al caso, sceglieva quella che gli pareva più probabile o
addirittura né dettava lui stesso una nuova: ciò poteva costituire una valida via alla degenerazione in abuso del potere
giudiziario. Il Muratori, a metà del Settecento, descrisse senza mezzi termini questa situazione; egli, forse per certi versi
in modo troppo pessimistico e generalizzante, non attribuì la giusta importanza al ruolo svolto nella prassi dalla
communis opinio e non tenne conto dell’obiettivo di ridurre il ricorso a numerose opinioni espresse in dottrina, nel ritener
vincolanti i precedenti; il suo giudizio, però, regge nel momento in cui egli critica l’abuso del potere discrezionale e non
il potere discrezionale di per sé o l’uso di certe tecniche giurisprudenziali.
Appare, infatti, lecito domandarsi se vi furono degli efficaci limiti politici e istituzionali al potere equitativo degli organi
giudicanti. Chiarendo che tali organi sono esclusivamente i grandi tribunali, massimi organi del potere giudiziario nei vari
ordinamenti, si può affermare che essi amministrano la giustizia in nome del monarca e sono i supremi e privilegiati
interpreti della sua volontà; a loro il sovrano attribuiva, addirittura, quei poteri equitativi e arbitrari per far si che agissero
svincolati dai rigori e dalle pastoie del diritto positivo, da ricondurre comunque al rispetto della legalità impersonata dal
principe ed espressa attraverso la sua legislazione.
Questo il principio del programma dei monarchi: consolidare l’unità giuridica dello stato attraverso l’unificazione
giurisdizionale, attraverso l’attività controllata di propri privilegiati organi giudiziari impostando in essi il primato della
loro, dei monarchi, legislazione.
Alcuni grandi tribunali, tipo la SACRA ROTA ROMANA, funzionavano davvero come univoca espressione di una
volontà centrale e svolgevano realmente un ruolo unificante; altri, invece, opponevano una lunga e vivace resistenza
contro i vari interventi regi volti a ridurli sotto il controllo della corona. Esempio di tale opposizione fu il Senato di
Milano o il Sacro consiglio regio di Napoli.
Questi potenti collegi furono per anni il freno del potere della corona sulla giurisprudenza.
Il problema però resta sempre quello dell’arbitrio giudiziale:
1- era lo strumento chiave per sbloccare i congegni delle complicazioni tra norme, fonti, procedure
2- era espressione di incertezza, ma espressione ufficiale poiché tollerata dal sovrano e da questo ricondotto nei
limiti del rispetto della norma scritta;
3- in se stesso come concetto non rivestiva durante l’assolutismo una portata negativa che avrebbe assunto in
seguito con l’affermazione delle moderne teorie di separazione dei poteri e di subordinazione del giudice alla
legge;
4- ciò che appariva fonte di disordine e di incertezza, era il fatto che certi tribunali rendevano illusori e teorici i
limiti imposti dal sovrano e dalla dottrina aprendo così la strada a possibili manifestazioni patologiche
dell’arbitrio: errori, eccessi di potere, abusi, irregolarità procedurali,...
La possibilità di una degenerazione dell’arbitrio giudiziale rendeva ancor più precaria la già incerta situazione di molti
ordinamenti dell’Ancien Régime, caratterizzati dal particolarismo giuridico.
Proprio l’arbitrio del giudice, infatti, pareva un’arma a doppio taglio: era lui a render possibile il funzionamento pratico di
quei sistemi che minacciavano la paralisi ma poteva succedere che i tribunali scavalcassero gli stessi criteri
endogiurisprudenziali di certezza.
Proprio per questo i sostenitori illuministi della codificazione avrebbero fatto di tale dispotismo il principale bersaglio
delle loro accuse contro il regime di diritto comune e avrebbero teorizzato la sottomissione del giudice alla legge.
Non bisogna, tuttavia, sottovalutare l’operato dei tribunali: in virtù di un’autorità rispettata anche dai sovrani, queste corti
svilupparono un’abbondante elaborazione del copioso diritto del tempo e, pur responsabili del persistere di ampie zone di
incertezza, realizzarono una, seppur precaria, unità dell’ordinamento normativo, la sola ormai possibile visto la
configurazione storica raggiunta dal diritto comune, assicurandoli una stupefacente facoltà di sopravvivenza.
Capitolo 2. Gli inizi del processo di superamento del diritto comune
Governi, opinione pubblica, giuristi: i tre poli della tensione innovativa
I fermenti innovativi di riorganizzazione della vita giuridica e di condanna del diritto comune, i quali con maggiore o
minore chiarezza vennero via via manifestandosi negli stati del continente europeo (soprattutto in Francia), mostrano che
il processo culturale verso ogni forma di rivoluzione legislativa passa in genere necessariamente attraverso 3 poli:
1- un programma di politica del diritto formulato dall’autorità = governo
2- una presa di posizione del ceto dei giuristi o di talune componenti d’elite = giuristi
3- un movimento d’opinione pubblica nel corpo sociale = opinione pubblica
Tutto ciò riguarda tutti i regimi giuridici d’Europa, fatta eccezione per il mondo giuridico anglosassone, rimasto estraneo
alla codificazione. In Inghilterra, infatti, le grandi correnti di pensiero che andavano evolvendosi in tutto il continente, non
riuscirono ad affermarsi, per via di una cultura giuridica molto forte, legata alla “common law” che aveva stabilito
equilibri politici diversi fra i suddetti tre poli.
La storia complessiva della codificazione mostra bene i modi con cui si combinarono, nel tempo e nei diversi paesi, le
forze spirituali condensate nei tre poli. Il terzo di essi, la comunità dei consociati, non manifestò mai ufficialmente e in
modo collettivo il proprio atteggiamento: tutto ciò non solo perché sul continente europeo le forze sociali non ebbero
storicamente pieno potere di manifestarsi con risultati incisivi se non nei regimi parlamentari scaturiti dalla Rivoluzione,
ma anche perché l'idea di “codificare” il diritto si chiarì assai lentamente a livello d'opinione pubblica e non senza urtare
tendenze “provincialistiche” a lungo persistenti nella coscienza popolare.
Si doveva giungere all’89 perché l'esigenza della codificazione fosse espressa attraverso una imponente dimostrazione
collettiva quale furono i Cahier De Doleance (in francese quaderni delle lamentele) degli Stati Generali francesi.
Le istanze di rinnovamento nella cultura giuridica europea: un passo oltre la communis opinio
A tal a proposito occorre ricordare il pensiero di Antonio Muratori, il quale, apprestandosi a suggerire un suo rimedio alla
patologica situazione d’incertezza del regime di diritto comune, pensò che il solo sovrano potesse imporre in modo
efficace il rimedio da lui proposto, poiché nel quadro che egli tracciava era il quisque de populo ad apparire direttamente
interessato alla riorganizzazione del diritto e ed egli sintetizza bene la schematizzazione prima tracciata e la sua triplice
componente.
Fra la gente saggia e desiderosa di ovviare in qualche modo alla crisi di certezza giuridica della quale Antonio Muratori
tracciava la sua descrizione, i giuristi v'erano certamente: proprio da essi, infatti, già almeno due secoli avanti, si erano
elevate le prime voci volte a denunciare lo stato di confusione pratica cui si avviava la scienza del diritto; da essi
provenivano quei tentativi di unificazione teorico-scientifica del diritto che battevano sul tempo i primi seri sforzi ufficiali
di unificazione legislativa attuati dai sovrani.
Con sufficiente approssimazione si può cogliere l'atteggiamento degli ambienti della cultura giuridica di fronte alle
esigenze di accertamento semplificativo del diritto via via emergenti in Europa, distinguendo nell'ordine: la posizione di
piccoli e medi rappresentanti delle categorie forensi, la posizione dei giuristi preposti alle massime funzioni giudiziarie,
quella dei dotti impegnati nell’insegnamento universitario, quella dei grandi funzionari con alti compiti burocraticoamministrativi negli ambienti di governo.
Le ultime due categorie sono quelle da cui partono reazioni critiche e proposte di intervento.
La posizione dei pratici, vale a dire dei notai e avvocati, appare depositaria di quelle tendenze immobilistiche e
conservatrici che per eccellenza spiegano la situazione di vischiosità del particolarismo.
Anche il potente e chiuso ceto degli alti magistrati assumeva atteggiamenti di diffidenza nei confronti di tentativi di
unificazione giuridica posti in essere dai sovrani e dalla loro cerchia di burocrati.
Alla luce di queste affermazioni si può affermare che il giurista è per sua natura vincolato all'ordinamento normativo
esistente, di cui egli non può non presupporre la stabilità come condizione essenziale della propria attività.
In tal modo il giurista può operare nel tempo, attraverso una creativa attività di interpretazione il lentissimo sviluppo
dell’ordinamento stesso, quasi impercettibile di cui ci si può avvedere solo al termine di periodi molto lunghi.
Ecco perché il giurista è sempre legato al diritto vigente: egli non può essere un riformatore o un rivoluzionario; tutto ciò
che è riforma deve essere riservato al legislatore: per questo le epoche caratterizzate da eventi profondamente
rivoluzionari si esprimono attraverso una intensa attività legislativa.
Il giurista non risulta un nemico delle riforme legislative, al contrario, è proprio il suo ceto a sollecitarle, pur se
conservatore per istinto. Una spiccata diffidenza invece nei confronti dei giuristi, futuri interpreti e trasformatori della
legislazione nuova, ha il legislatore che quella stessa legislazione ha attuato.
Una prima forma di risposta alla crisi di certezza del regime postmedievale di diritto comune si era delineata in seno alla
stessa giurisprudenza che dal diritto comune si alimentava; tale risposta consisteva nella prassi di osservanza della
communis opinio, strumento di certezza in un sistema divenuto prettamente giurisprudenziale. Rappresentava,
paradossalmente, un tentativo di auto superamento, attuato dall’interno, da parte della giurisprudenza stessa: l’autorità del
singolo giurista scompariva a favore di un’autoritaria presunzione di verità emersa da un fascio di interpretazioni in base
ad un criterio maggioritario.
Anche la tendenza dei grandi tribunali di attribuire autorità vincolante ai propri precedenti tanto da farne delle communes
opiniones si inseriva nella direzione della certezza del diritto, provocando un altro fenomeno di consolidazione della
giurisprudenza. Gli usus fori si presentarono, di regola, come un'area di certezza giuridica sovrastante al conflitto fra le
molteplici communes opiniones.
In generale, però risultano chiari i motivi per cui nel XVI secolo si invocò un intervento legislativo che sbarrasse la via
alla dilagante avanzata dei pareri dottrinali; la COMMUNIS OPINIO tendeva per sua natura a sdoppiarsi e a modificarsi
per cui, attorno ad uno stesso caso potevano profilarsene più d’una e diveniva difficile capire quale fosse davvero quella
COMMUNIS o MAGIS COMMUNIS o COMMUNISSIMA.
Riguardo poi alla prassi del rispetto dei precedenti, neppure essa poté far conseguire ai vari ordinamenti giuridici quei
sostanziali livelli di certezza e di unificazione accettabili, sia per elementi d’ostacolo tecnici come, ad esempio, il fatto
che in alcuni tribunali non vigesse l'obbligo di motivazione della sentenza, sia per l'uso dell'arbitrio e le sue possibili
manifestazioni degenerative.
Tutto questo spiega come l'idea, radicalmente opposta, di ridurre il diritto ad un chiaro e stabile schema, abbia cominciato
a presentarsi nella coscienza giuridica europea quale soluzione decisamente più sicura e razionale, oltre che politicamente
preferibile. A formulare variamente questa soluzione e a sollecitarne l’attuazione concorsero alcuni giuristi per primi.
Importanti furono le idee formulate da Francesco Hotman nell’ANTITRIBONIANUS che costituivano una serrata
requisitoria contro la confusione delle norme vigenti, esprimendo la necessità che un maneggevole corpo normativo
creasse in Francia un ordinamento giuridico del tutto semplificato, esponendo ancor di più una denuncia di crisi del diritto
comune.
In Italia, prima dell’Hotman, Giovanni NEVIZZANO D’ASTI nel 1522 aveva avanzato proposte pressoché analoghe;
La denuncia della crisi del diritto comune, l’indicazione di un programma di semplificazione delle norme, la preferenza
per un diritto nazionale erano motivi tipici che si ritrovano nell’opera dei giuristi appartenenti al secolo XVI: in Italia, in
Tiberio DECIANI, in Francia di Louis CHARONDAS LE CARON; in Germania invece, troviamo Hermann CONRING
che sulla base di inoppugnabili argomentazioni storico-critiche scaricava per sempre la leggenda del diritto romano
dichiarato diritto vigente da Lotario II, nel XII secolo, che avendo ritrovato, ad Amalfi, l'antico manoscritto del digesto,
ne avrebbe reso obbligatorio lo studio e l’utilizzo.
Per quanto queste fossero voci vigorose erano ancora isolate: solo nel secolo XVIII, sulla base di nuove correnti di
pensiero, si sarebbero moltiplicate fino ad assume una forma quasi epidemica.
Alcune manifestazioni dell’opinione pubblica in Francia
In francia, alcune pressanti istanze per un'opera di riordinamento e di accentramento dei diritti vigenti furono avanzate
non solo dagli uomini di legge, ma anche da quelle tipiche istituzioni rappresentative francesi che furono le assemblee dei
3 stati: anche la comunità sociale fece udire, per la prima volta, la sua voce.
La prima manifestazione di un’esigenza di certificazione del diritto si ebbe nell’assemblea degli stati generali riunitasi ad
ORLEANS nel 1560, dove il terzo stato si pronunciò affinché si riunissero le ordonnances e se facesse una raccolta “di
ciò che doveva, d’ora in avanti, essere conservato ed osservato tra gli argomenti, tagliando l'eccedenza”, al fine
di troncare la lunghezza dei processi e le cavillosità di parti e giudici.
Più tardi a BLOIS il CLERO e il terzo STATO parlarono attraverso i propri cahiers de doleance ancora più chiaramente,
invocando il compendio in un solo testo di ordonnances, di coutumes ed editti del parlamento, solo però quelle norme
“che si dovranno conservare e che si troveranno utili e necessari in questo regno allo scopo d' abrogare tutte le
altre”.
Anche a Parigi, nell’assemblea degli stati generali, nel 1614, fu ancora una volta denunciata lo stato di confusione e
l’incertezza del diritto. Dopo questa data, la monarchia francese, non avrebbe mai più riunito gli Stati Generali, perché
riscontrava in essi resistenze alla politica dispotica della stessa CORONA.
Quando nel 1789 vennero riconvocati la crisi sociale era suprema e le istanze di codificazione vennero presentate in
termini diversi, nel contesto di un ideologia che segnava la fine stessa dell’Ancien Règime.
I primi provvedimenti antigiurisprudenziali del potere pubblico: “le leggi delle citazioni”.
Dopo le prime isolate proposte dei giuristi, in Francia, e le prime timide voci dell’opinione pubblica vediamo quali furono
i primi tipi di intervento diretto del potere assoluto nella situazione delle fonti giuridiche.
Un primo intervento, dal carattere antigiurisprudenziale, consistette in provvedimenti autoritari volti a limitare le
allegazioni in giudizio e le citazioni nelle sentenze delle opiniones dei giuristi.
Negli ordinamenti ove il sovrano adottò tale soluzione, il conseguente provvedimento volto ad arrestare l’arbitraria
manipolazione forense della massa di opinioni contrastanti assume così la caratteristica natura di LEGGE DELLE
CITAZIONI, in tutto simile alla celebre costituzione imperiale emanata nel 426 con la quale veniva attribuita forza di
legge solo all’opinione di pochi, ma importanti giuristi, quali ULPIANO, PAOLO, MODESTINO, PAPINIANO e GAIO.
Se le leggi delle citazioni erano dirette a paralizzare e a ridurre al minimo l’impiego giudiziario di gran parte delle
sovrabbondanti opere dottrinali, le poche di queste che non erano state messe al bando, venivano ad assumere un valore
enorme, un’autorità che in alcuni casi era resa legalmente vincolante alla pari della lettera del provvedimento sovrano.
E i giuristi cui in tal modo era concessa l’esclusiva dell’autorevolezza, venivano così ad essere letteralmente canonizzati,
costituendo una specie di TRIBUNALE DEI MORTI.
Fra i provvedimenti si ricordano in particolare una prammatica DEL 1427 di GIOVANNI II DI CASTIGLIA con il quale
si proibiva nei tribunali la citazione dei giuristi posteriori a Giovanni D’ANDREA e a BARTOLO; il notevole intervento
principesco, del 1613, di FRANCESCO MARIA II DELLA ROVERE per il ducato di URBINO, nella cui legge, il duca
proclamava di aver provveduto ad eliminare per i giudici e professori della legge l’incertezza che molte volte dovevano
affrontare, elencando le uniche fonti tassativamente a disposizione.
Tipici esempi non più di limitazione delle citazioni ma di proibizione totale del ricorso all’autorità dei giuristi sono offerti
da una disposizione di VITTORIO AMEDEO II contenuta nella redazione del 1729 delle Costituzioni di S.M. il Re di
Sardegna e da un dispaccio napoletano del 1774 emanato da FERDINANDO IV che introdusse tra l’altro l’obbligo per i
giudici dei tribunali maggiori di motivare le sentenze e di fondare queste ultime solo sulle “LEGGI ESPRESSE DEL
REGNO E DEI COMUNI”.
Capitolo 3. Le “consolidazioni” e le ultime vittorie del diritto comune.
Realtà e ideale nei programmi di superamento del diritto comune.
Tracciare il quadro del tramonto del diritto comune significa alludere alla singolare capacità di sopravvivenza di un tipo
pluralistico di regime normativo che solo agli inizi del XIX secolo fu completamente sostituito dai codici, col definirsi
politico-strutturale degli stati assoluti e col decadere delle metodologie giurisprudenziali tradizionali.
In pieno secolo XVIII infatti, l’idea culturale di un regime normativo unico, appariva ancora un mitico traguardo ideale,
da cui le ambizioni semplificatrici e i concreti programmi di riorganizzazione del diritto si tenevano realisticamente
lontani e in una prospettiva troppo conservatrice legata soprattutto ad un dato spirituale e culturale.
Per quasi tre secoli, infatti, si pensò di poter raggiungere risultati di semplificazione, di certezza e di ordine operando sul
complesso delle norme vigenti, attraverso un riordino dei materiali giuridici che si esaurisse, però, all’interno del sistema
di fonti tradizionale.
L’abrogare totalmente e in maniera ufficiale tutto il diritto vigente, riformularlo in un corpo normativo completo e
uniforme suscettibile di unica applicazione e non tollerante l’integrazione sussidiaria di fonti esterne, la realizzazione non
solo di un’unificazione strutturale ma anche di un radicale rinnovamento di contenuto del diritto,erano passi impensabili
per quel tempo, significava osare l’inosabile.
L’immagine di un mutamento, per tutti i consociati, si collegava a una concezione rivoluzionaria dell’ordine sociale,
difficilissima soluzione da applicare, in antitesi alle incertezze del diritto di quel tempo, ma che era rappresentata dalla
codificazione che la sola Rivoluzione avrebbe portato.
Osservazioni introduttive sulla tipologia di collezioni e compilazioni precedenti i codici.
Da un punto di vista storico sono i secoli XVII e XVIII quelli in cui si iniziano a fare i primi tentativi di apportare ordine
e certezza nella situazione delle fonti, in Europa.
Bisogna però innanzitutto tener conto del fatto che l’ideologia della certezza che vide in tali tentativi non è di certo quella
che ispirerà le codificazioni moderne: i limiti spirituali già menzionati prevalgono e questi tentativi culminano per lo più
in compilazioni giuridiche e collezioni del materiale legislativo o giurisprudenziale esistente, che viene raccolto e
riordinato secondo criteri di repertorio o privatamente da giuristi isolati o ufficialmente per intervento sovrano.
Al pieno secolo XVIII viene, specie in FRANCIA, redatto un secondo tipo di compilazione, su iniziativa sovrana; si tratta
di massicci testi legislativi muniti di valore ufficiale, i quali costituiscono una risistemazione razionale ed organica di
parte della normativa preesistente, cui vengono aggiunti anche precetti completamente nuovi e quindi, per questo,
oltrepassano i limiti della tradizionale collezione di norme vigenti.
Queste raccolte rappresentano una ricompilazione decisamente innovativa del diritto, in quanto le norme in essi inserite
perdono la loro individualità, e assumono una forza collettiva e primaria nell’ordinamento, tanto da abrogare quelle
norme che nelle fonti locali e nel diritto comune riguardano materie già disciplinate nella nuova compilazione.
Ma neppure questi ampi interventi legislativi possono essere assimilata ad una codificazione; La differenza tra questa
raccolta e un codice è che essa mira ad una sopravvivenza del diritto comune e dei diritti particolari, sostituendosi talvolta
all’uno e talvolta agli altri, ma non possiede la caratteristica primaria del codice: il principio della completezza, assioma
secondo cui nell’ordinamento normativo realizzato dal codice non esistono lacune, cosicché per ogni caso concreto esiste
una soluzione all’interno dell’ordinamento stesso.
Quei testi, la cui incidenza sul diritto comune è solo parziale, mirano, come diceva Viora, alla sola consolidazione del
diritto vigente; volendo menzionare qualche testo fra i più importanti, bisogna tener presente che:
1- occorre distinguere, quanto a valore e portata innovativa, tra consolidazione-raccolta dalla ufficiale compilazione
realizzata in una legislazione sistematica;
2- la differenza sostanziale con un codice risiede nel fatto che solo questo disciplina in totale via esclusiva un certo
ramo del diritto, rompendo ogni rapporto col diritto comune;
3- non è rilevante la differenza secondo cui conterrebbero materiale legislativo preesistente e non del tutto
innovativo come un codice. L’innovatività può riscontrarsi anche in un riordino che mette sotto nuova luce i
contenuti.
La peculiarità del codice sta nella sua esclusività; esso sostituisce in blocco il sistema tradizionale che non riconosce
come nelle consolidazioni , quale proprio sistema vigente precostituito.
Infine, accanto alle collezioni non ufficiali e alle rielaborazioni del materiale giuridico vigente vi è un terzo genere di
compilazione: sono testi che riuniscono norme prive di un qualsiasi riscontro nelle tradizione, quindi totalmente nuove.
Non appartengono quindi alla famiglia delle consolidazioni e neppure a quella delle codificazioni, poiché realizzavano
una disciplina solo parziale della materia contemplata ed ammettevano la funzione suppletiva delle fonti previgenti.
Valido esempio la Riforma della legislazione criminale emanata dal Granduca Leopoldo, nel Granducato di Toscana.
Redazione privata di “consolidazioni-raccolta” negli Stati italiani (secoli XVII-XVIII)
Tornando alle consolidazioni è opportuno distinguere quelle attuate per volontà privata, e quelle promosse dai sovrani e
da questi pubblicate come corpi di legislazione dello Stato.
Al primo gruppo appartengono per eccellenza le CONSOLIDAZIONI-RACCOLTA, cioè le collezioni di materiale
legislativo e giurisprudenziale compilate con intenti di semplificazione e di documentazione.
Più comuni le raccolte di tutto il materiale appartenente ad una certa fonte; sicuramente meno quelle concernenti una data
materia. Molto utili e di gran successo.
Vi sono molte consolidazioni private italiane:
1. Quanto alla consolidazione della COMMUNES OPINIONES si menzionano i cinque volumi di Paolo Francesco
PERREMUTO (Conflictus iureconsultorum inter se dscrepantium, sec. XVII) e il De comuni opinione di Anton Maria
CORAZIO (inizi sec. XVI)
2. Quanto alla consolidazione della GIURISPRUDENZA DELLE CORTI si ricorda il Codex fabrianus, raccolta della
giurisprudenza del Senato di Savoia curata da Antonio FAVRE, la raccolta della giurisprudenza del senato piemontese
curata da Antonino e Gaspare Antonio TESAURO, i numerosi volumi in cui si compendiano varie collezioni di decisioni
della Rota Romana tra cu emergono quella del GOMEZ, del CANTALMAI, del DE LUCA,
3.Quanto alla consolidazione della LEGISLAZIONE STATUALE si ricorda la raccolta generale delle norme
principesche emanate per la Savoia, curata dall’avvocato Gaspare BALLY; la raccolta di leggi toscane immagazzinate in
32 volumi da Lorenzo CANTINI; le raccolte di provvedimenti regi promulgati nel regno di napoli quali gli 11 volumi di
dispacci napoletani curati da Diego GATTA; numerosi Gridari, collezioni di bolle papali,…
Menzioniamo la compilazione del regno di Napoli del consigliere Carlo TAPIA, il quale sistemò entro gli schemi del
codice giustinianeo l’intero materiale legislativo del regno fra il 1605 e il 1643. La collezione aspirava, nelle intenzioni
dell’autore, all’approvazione ufficiale di Filippo II e avrebbe dovuto chiamarsi Codice Filippino. Resto, invece, opera
privata a dimostrazione del fatto che non risolvesse, se non in minima parte, il problema dell’accertamento e
dell’unificazione del diritto napoletano.
Relativamente alla repubblica di VENEZIA, si riscontra un’esperienza esemplare nel campo della consolidazione. Qui la
poderosa mole del diritto locale poggiava sugli Statuti eccellenti dei dogi Jacopo TIEPOLO e Andrea DANDOLO e su un
corpo di consuetudini. Su questa solida base fiorì una copiosa legislazione a titolo di integrazione, modifica o
aggiornamento. non erano ammessi sul corpo del diritto vigente interventi di nessun tipo. Il che aveva i suoi vantaggi, di
continua manutenzione sul tradizionale macchinario giuridico, e i suoi svantaggi ovvero l’immanità di un materiale che
non viene mai “sfrondata dei rami morti”.
Si ricordano, nel novero delle mere collezioni, le Leggi criminali del serenissimo dominio veneto del 1751, curato da
Angelo SABINI e il Codice feudale della serenissima repubblica di Venezia del 1780, curato da Lorenzo MEMMO.
Alcune “consolidazioni-raccolta” in Francia, in Spagna e nei paesi germanici
Anche nei paesi d’oltralpe, in particolare in Francia e in Spagna, si realizza il fenomeno delle CONSOLIDAZIONI e la
situazione non differisce da quella italiana: si registra una mancanza di legame tra volontà tecnica di consolidare il diritto
e una volontà politica di riformarlo attraverso la consolidazione.
1)In Francia tre testi si segnalano all’attenzione:
- il Code Henry III del 1587, raccolta di ordonnance non priva di lacune confezionata per commissione del
sovrano ENRICO III in risposta alle dolèance degli stati di Blois, da BRISSON;
- il Code Henry IV del 1603, ad opera del magistrato CORMIER, blando sommario del diritto giustinianeo con
l’aggiunta di brani di ordinanze e norme consuetudinarie francesi;
- il Code Marillac, collezione normativa, o più propriamente tentativo di riorganizzazione di alcuni settori del
diritto, di ordinanza sovrana, messa a punto nel 1629, facente seguito alle istanze rivolte a LUIGI XIII a Parigi,
dagli Stati Generali.
2) In Spagna l’attività di compilazione fu notevole e intensa. Bisogna ricordare:
- l’Ordenamiento De Montalvo, commissionato ad Alonso DE MONTALVO, dai Re cattolici: ordinata collezione dello
sconfinato materiale legislativo in vigore, non ricevette carattere ufficiale perché giudicata frammentaria
- fu completata e promulgata da FILIPPO II in 9 libri, nel 1567, quale testo normativo ufficiale preminente, col nome di
Nueva Recopilacion;
- la Novissima Recopilacion,del 1805, che rimase in vigore fino al XIX secolo, revisione del precedente testo ad opera di
Jean DE REGUERIA VALDELOMAR, in 12 libri.
3) Nel mondo germanico, due collezioni meritano d’essere menzionate:
- il Codex Augusteus, opera privata del giurista Christian VON LUNIG, raccoglie vari interventi legislativi pertinenti al
territorio sassone, ricompresi tra il XVI secolo e il 1724.
- il Codex Austriacus, collezione appartenente all’Austria che raccoglie la legislazione emanata da Ferdinando I in poi, in
ordine alfabetico delle intitolazione delle materie, curata da Francesco VON GUARIENT.
Le grandi compilazioni ufficiali del secolo XVII: le “Ordonnances” di Luigi XIV
Tra le organiche e massicce compilazioni legislative la cui elaborazione si stacca completamente per tecnica e criteri
ispiratori dalle consolidazioni-raccolta merita senza dubbio un posto preminente le grandi ordinanze di LUIGI XIV di
Francia.
Esse anticipano sotto non pochi aspetti le futura codificazione, anche se lo spirito che le anima è assai lontano dagli ideali
giusnaturalistici e dalle esigenze di rinnovamento presenti nella codificazione rivoluzionaria e sono la diretta espressione
della politica perseguita da Luigi XII e da Richelieu sviluppatasi su terreno legislativo di Luigi XIV attraverso l’opera del
ministro Colbert che ne diresse i lavori e la redazione.
Il programma politico del sovrano si incentrava su un progetto di unificazione addirittura globale del diritto francese,
sull’aspirazione cioè a realizzare una unità giuridica nazionale. Queste idee di unificazione sono ben espresse nel
Memoire sur la reformation de la justice che il ministro COLBERT presentò al sovrano nel 1665, ispirando quest’ultimo;
attraverso lavori successivi e preparatori nel Conseil general de reformation de la justice, presieduto dal monarca stesso,
si concretò una grandiosa serie di ordinanze.
Non fu solo la proposta di Colbert a suscitare fervore culturale e costruttivo, ma anche il ragguardevole lavoro di un
gruppo di specialisti chiamati a discutere e ad elaborare i progetti di riforma, fra i quali eccellono figure di grandi
giureconsulti come
La prima a vedere la luce fu l’Ordonnance civile pour la formation de la justice, un corpo normativo di ben 35 titoli che
si presentava con una brevità e chiarezza perfette. Seguì poi, nel 1670, l’Ordonnance criminelle, poderosa ristrutturazione
della procedura penale, di rigore e precisione quasi intimidatori. Si ricordano poi l’ Ordonnance du commerce e
l’Ordonnace de la marine che racchiudevano un insieme di consuetudini, le catalogavano, quasi ad innovarle e renderle
più comprensibili.
Quanto ad una valutazione complessiva di queste compilazioni, si può affermare che non risolvano il problema dell’unità
della normazione ma che sciolgano comunque non pochi nodi del particolarismo giuridico.
Sono degnamente messe al paragone dell’opera di Giustiniano e delle codificazioni napoleoniche e a queste si avvicinano
molto perché abrogano tutto ciò che è a loro precedente o in contrasto con esse e sottopongono il giudice alla legge.
Comunque non possono essere considerate del tutto innovative, essendo una sapiente raccolta e risistemazione sistematica
e unificatrice di consuetudini e norme preesistenti.
Vi sono quindi dei caratteri che differenziano i codici moderni dalla complilazione dell’Ancien règime: indubbio che
quest’ultime presentino novità sostanziali rispetto alla tradizione e che vadano a collocarsi allo stadio di un avanzato ma
non concluso processo verso la codificazione.
Le Ordonnance sono, infatti, riformulazioni di una normativa preesistente che comunque contengono elementi nuovi,
sono a loro modo innovative, come d’altronde lo sono tutti i codici.
Non è, dunque, la novità del materiale, la netta differenza tra questa giurisprudenza dell’ANCIENT REGIME e quella
futura degli stati modernissimi regolata dai codici: essa risiede nella completezza che dovrebbe vigere in un sistema,
configurandolo come unico, esclusivo e non etero integrabile.
Le ORDONNANCE non possono, quindi, essere considerati dei codici in quanto etero integrabili. Si limitano ad abrogare
ogni fonte esterna che disciplini diversamente o in modo contrario i casi previsti nel suo testo. Non contiene alcuna
esclusione però delle norme che regolano casi non previsti: ammette così la concorrenza di usi e disposizioni
giurisprudenziali che li regolano o che sono espressamente salvi dalla deroga.
Le “Ordonnance” del cancelliere Daguessau
Nella prima metà del Settecento e durante il regno di Luigi XV la Francia conobbe una seconda generazione di
ordonnance: essa si sostanziò in tre importanti testi legislativi in materia civile elaborati dal cancelliere guardasigilli
Henry Francois DAGUESSAU:
1- L’ORDINANZA sulle DONAZIONI del 1731
2- L’ORDINANZA sui TESTAMENTI del 1735
3- L’ORDINANZA sui FEDECOMESSI del 1747
Queste ordinanze furono preparate con uno scrupoloso lavoro preliminare attuato attraverso la delicata consultazione dei
Parlamenti, allo scopo di eliminare gli elementi di contraddittorietà nella giurisprudenza delle varie corti, piuttosto che ad
una completa e innovativa disciplina sostanziale della materia.
Da un punto di vista pratico, l’opera di DAGUESSAU ha un ruolo secondario rispetto a quella di COLBERT.
In realtà non è di minore importanza anzi, al contrario, da un punto di vista dei criteri e della politica che la ispira, è la
parte iniziale di un progetto che si attua gradualmente e che gradualmente acquisisce importanza, perché il cancelliere a
differenza di COLBERT, ritiene che l’opera di riunificazione deve essere effettuata attraverso riforme parziali e
progressive, al fine di eliminare le contraddittorie coutumes vigenti nelle province e la diversità e l’arbitrarietà della
giurisprudenza dei vari tribunali. Queste 3 ordinanze miravano a sanare, in particolare, l’ultimo punto attraverso cui, poi,
si sarebbe realizzata l’unificazione del primo.
Quanto al suo più vasto progetto di unificazione giuridica che sta alle spalle delle tre ordinanze, egli ne prospettò l’idea
nel suo Memoire sur la reformation de la justice, nella quale egli prospettava una raccolta da pubblicarsi procedendo per
parti.
Di che raccolta si parlava? Le ordinanze non lasciavano dubbi sul fatto che si trattasse, perlopiù, di unificare tra loro
regole giurisprudenziali piuttosto che materiale normativo. L’unificazione totale non si poteva attuare così.
Le Costituzioni piemontesi
Tra le raccolte che anche il Daguessau riteneva essere molto innovative, spicca quella di VITTORIO AMEDEO II, Re di
Sardegna. Egli, cui va riconosciuto un genio politico e militare, è tra i principi che giganteggiano come statisti nella storia
del piccolo ordinamento sabaudo.
Egli aveva l’idea di semplificare il diritto nell’ambito di un più vasto programma riformistico in cui era prevista una
ristrutturazione interna dell’apparato governativo centrale, una politica ecclesiastica di tipo giurisdizionalista, una
riorganizzazione dell’amministrazione giudiziaria che rendesse possibile un rigido controllo sui grandi tribunali, una serie
di interventi economico-finanziari volti alla riduzione dei privilegi nobiliari.
Già nel 1713 aveva dato corso agli studi e ai lavori per una ordinata pubblicazione e sistemazione di tutte le leggi proprie
dei suoi predecessori in un corpus normativo che avrebbe dovuto costituire l’unitaria legislazione generale dello Stato,
insieme ad abili professori e magistrati del calibro di ZOPPI, RICCARDI, FOGASSIERES.
Ad orientare verso la matura concezione del piano fu Tommaso PLATZAERT, suo segretario di guerra, con le sue idee
riformistiche e innovatrici, il quale in un intervento suggerì al sovrano di mettere da parte l’idea di una raccolta semplice
di editti e di riformulare con precisione e chiarezza questi ultimi, facendone la sua uniforme volontà.
La pubblicazione delle Costituzioni si ebbe nel 1723 poi ripubblicate nel 1729 con l’aggiunta di un libro, e in fine con
un’ampia revisione successiva di Carlo Emanuele III ripubblicate nel 1770.
Il contenuto normativo delle COSTITUZIONI è ripartito in 6 libri ciascuno suddiviso in titoli e paragrafi:
il primo riguarda il culto cattolico e la condizione degli ebrei, il secondo la struttura dell’apparato giudiziario, il terzo la
procedura civile, il quarto il diritto e la procedura criminale, il quinto il diritto civile, il sesto la materia feudale e il fisco.
Per quanto riguarda il rapporto tra le Costituzioni e il diritto comune, sappiamo che esse proibivano ai magistrati e
avvocati il ricorso alle autorità dottrinali e che, dunque, questo divieto delle citazioni e il fatto che le nuove norme si
sostituissero in non pochi settori al diritto comune comportava una non indifferente riduzione del raggio d’azione dello
stesso. Tuttavia le Costituzioni tolleravano espressamente l’integrazione suppletiva degli Statuti locali, della
giurisprudenza delle corti e infine del diritto comune. Rappresentavano un’imponente compilazione che si inseriva in
modo innovativo e massiccio nel regime del diritto comune ma che non giungeva a sostituirsi completamento ad esso.
I tentativi di riordinamento generale del diritto nel Regno di Napoli e nel Granducato di Toscana
a) REGNO DI NAPOLI
Anche nel Regno di Napoli, nel primo Settecento, si mise in moto un processo di riforma del sistema giuridico che si
collegava ad una più ampia volontà politica di riordinamento razionale dello Stato e ad un momento storico
particolarmente felice per un movimento generale di rinnovamento.
Il periodo politico napoletano più prolifico e conforme a questo processo di rinnovamento è sicuramente quello del primo
decennio di regno di CARLO di BORBONE, il sovrano la cui incoronazione, nel 1734, rappresentò la fine di un secolo e
mezzo di egemonia spagnola nel Mezzogiorno d’Italia e il costituirsi a Napoli di un regno indipendente, sotto la dinastia
più favorita dal popolo della storia di Napoli.
La situazione normativa e pratica del diritto napoletano che il nuovo monarca, ispirato dal giurista Bernardo TANUCCI,
suo ministro, intendeva fiduciosamente riformare, era senza dubbio scoraggiante.
Vi era infatti un ordinamento senza certezze, fatto di abusi di potere e di norme che erano descrivibili come pericolanti,
stesso attributo facilmente attribuibile all’ordinamento stesso.
Il nuovo governo cercò subito di porre una preliminare organizzazione delle strutture giudiziarie, tentando di creare una
magistratura centralizzata ed efficiente al posto o a fianco dei precedenti e troppo autonomi organi giudicanti per poi
programmare una riformulazione del diritto contenuto nel complesso delle fonti normative del regno.
La prima impresa fu quella di un codice generale delle leggi napoletane e fu affidata da TANUCCI nel 1740 al giurista
Pasquale CIRILLO, professore di diritto municipale e poi di diritto pubblico.
Questo tentativo di codificazione era destinato ad un completo fallimento.
Il professore preparò un CODEX LEGUM NEAPOLITANARUM col titolo di “CODICE CAROLINO”, diviso in 12 libri
secondo lo schema del codice giustinianeo e redatto in doppia versione, quella latina e quella italiana.
Il testo rifondeva in forma sintetica un eterogeneo gruppo di disposizioni di diritto amministrativo, civile, criminale e
processuale; si trattava però di un semplice processo di riorganizzazione del sistema giuridico esterna e superficiale.
La Giunta, poi, trascinò per più di 30 anni l’idea di completare questo codice (il che di per sé è in contraddizione per
quella che è la regola generale della codificazione, che riconosce nel codice una impossibilità di completamento, perché
già considerato completo per definizione) senza esiti apprezzabili.
Anche il disegno di un codice della navigazione naufragò: nel 1781, sotto il successore di CARLO di BORBONE,
l’eminente commercialista napoletano Michele DE JORIO, elaborò un pregevole progetto di codificazione delle norme
marittime, intitolato Codice marittimo compilato per ordine di Ferdinando IV, che però, giudicato carente dal punto di
vista tecnico, non divenne ufficiale.
b) GRANDUCATO DI TOSCANA
Negli stessi anni, in Toscana, fervevano tentativi giuridici analoghi a quelli in corso nel regno di Napoli. Nel 1737, il
governo del granducato era passato all’ultimo dei Medici alla dinastia lorenese, nella persona di FRANCESCO
STEFANO duca di Lorena.
Questo nuovo sovrano, anch’egli appoggiato da un ministro il conte Emanuele di RICHECOURT, si trovò di fronte ad
una situazione molto grave di particolarismo giuridico-amministrativo e di particolarismo economico-sociale.
In questo periodo molti giuristi, tra i quali è bene ricordare Giuseppe AVERANI e Leopoldo GUADAGNI, erano alla
continua ricerca di un rinnovamento giuridico che garantisse stabilità.
Nel 1745, si diede l’incarico a Pompeo NERI di preparare un codice di “diritto patrio”, sull’esempio delle Costituzioni
Sabaude, e contemporaneamente si diede l’incarico al senatore Venturi NERI di elaborare un piano di riassetto nazionale
delle strutture giudiziarie.
Il piano elaborato da Pompeo NERI però fallì, per via di un aspetto troppo conservatore e poco propenso ad una vera e
propria rivoluzione giuridica.
Il nuovo testo aveva ancora una volta un impianto romanistico e talvolta appariva come una volontà di voler ampliare il
diritto giustinianeo, in antitesi e in opposizione a tutto quello che stava accadendo in tutta Europa.
Le Costituzioni modenesi del 1771
La strada delle Costituzioni Sabaude fu ripercorsa con egual esito ed egual importanza dal sovrano riformatore
FRANCESCO III duca di Modena, che regnò dal 1737 al 1780.
Anche nel piccolo ordinamento modenese, troviamo una situazione difficile e non omogenea che comportava non pochi
nodi da sciogliere, ma che FRANCESCO III riuscì, in parte, a risolvere brillantemente con la sua compilazione che può
essere accostata, senza paragoni eccessivi, a quella piemontese.
Alludiamo al Codice di leggi e costituzioni per gli stati di Sua Altezza Serenissima, o più semplicemente CODICE
ESTENSE, promulgato dal duca nel 1771.
Questo corpo normativo rappresenta il più cospicuo riordinamento legislativo compiuto con intenti di unità nello stato
modenese dalle origini del ducato alla codificazione estense della metà dell’800.
Esso occupa un posto importante perché, nei contenuti, evidenzia nell’ideologia giuridica della certezza, la vera chiave
del rinnovamento senza, tuttavia, giungere alla completa scomparsa del diritto comune nel sistema delle fonti.
Già nel 1775 FRANCESCO III aveva pubblicato una ordinata raccolta delle proprie gride e decreti, preliminare alle
COSTITUZIONI successive. Successivamente la prima “deputazione” si arenò nella stesura di un organico testo
normativo che racchiudesse il diritto del ducato; così, nel 1768, ne venne istituita una seconda, in cui spiccavano
Bartolomeo VALDRIGHI e Giuseppe Maria GALAFASSI, che condusse in porto l’ampio progetto legislativo da cui
scaturirono le Costituzioni.
Il testo era una raccolta del materiale normativo in 5 libri: il primo era dedicato alle strutture giudiziarie e alla procedura
civile, il secondo al diritto privato, il terzo a materie feudali e finanziarie, il quarto e il quinto a norme di procedura e di
diritto penale.
L’ordinanza di promulgazione del duca esprimeva chiaramente che questo intervento così drastico, era stato realizzato al
fine di eliminare tutte le antinomie e le incertezze dell’ordinamento, e “seccare le norme che sono in obsolescenza”.
La funzione politica del nuovo testo dunque, appare chiara nella sua portata e nei suoi limiti. Essa consiste nel
neutralizzare in parte il potere esercitato, sotto la protezione di uno sistema particolaristico, territoriale e personale, dai
ceti sociali privilegiati, dai tribunali e dalla opinione dei giuristi e nel rinsaldare il potere sovrano, rivendicandogli
l’esclusiva prerogativa della produzione del diritto.
La nuova legge proclama che dovrà essere osservata come unica sovrana legge fondamentale, indirizzando chiari
avvertimenti ai vari tribunali del ducato. Cessano in blocco d’aver vigore i diritti locali e particolari: l’integrazione in via
sussidiaria è ammessa solo per il diritto comune.
Il problema della troppa libertà conferita alla interpretazione dei giudici viene sciolto brillantemente, creando una
magistratura super partes che giudicasse, in una visione molto futuristica (una sorta di CSM), l’operato dei singoli
magistrati.
Infine, bisogna dire che l’opera di FRANCESCO II fu, insieme alle Costituzioni Sabaude, la più imponente anche se
l’autorità del sovrano doveva ancora fare conto con una pluralità di centri sociali e professionali di potere ch’essa non
aveva avuto la forza giuridica di disarmare e che aveva avuto dunque l’interesse a considerarli alleati.
Francesco III ha rotto col passato ma a metà; cioè, riuscì a colpire il clero, ma aveva perpetuato i privilegi dei feudatari e
ancora accanto ai tribunali pubblici sorgevano tanti fori speciali e i tribunali dei signori mediati;
Il rinnovamento ,però, non fu radicale. Le Costituzioni tolleravano la sopravvivenza in via sussidiaria dei principi del
diritto comune, irrinunciabili strumenti per l’epoca, fallendo nel trapasso alla completa unificazione.
Complessivamente fu però una delle opere di rinnovamento della vita giuridica del ducato, più importanti.
I codici settecenteschi della Baviera
L’ultima compilazione dei secoli XVII e XVIII sono i CODICI BAVARESI.
E’ corretto menzionare per ultimo tali testi perché essi si trovano in una fascia di confine tra le compilazioni tradizionali e
le moderne codificazioni.
Nel XVIII secolo il principato di BAVIERA è, con l’AUSTRIA e la PRUSSIA, il terzo grande ordinamento dell’area
germanica ove si mette a punto un massiccio e organico programma statuale di rinnovamento del diritto territoriale e di
parziale superamento del diritto comune.
Ordinata dal principe MAXIMILIAN JOSEPH III, la raccolta, iniziata nel 1750, culminò nel 1753 quando erano pronti il
testo della nuova legislazione penale, il Codex iuris bavarici criminalis, e quello della nuova disciplina del processo
civile, il Codex iuris bavarici civilis.
- Il primo si sostituiva alla normativa precedente, ma era ancora del tutto ispirato a culture e modus operandi del diritto
troppo tradizionali e estranee alle idee liberali e umanitarie che in tutta Europa spopolavano; esso era si un sistema aperto,
ma privo di garanzie di certezza e tale da rendere in certi casi possibile un’ampia discrezionalità da parte del giudice
nell’applicazione della pena.
- Il secondo si limitava a risistemare entro un quadro organico il vigente sistema processuale.
Nel 1756 venne pubblicato un Codex bavaricus civilis, detto Maximilianeus; esso si rifaceva al piano delle Istituzioni
giustinianee, reinterpretandole completamente attraverso schematismi razionali che comunque apparivano decisamente
moderni. Seppur organico e molto chiaro, il vecchio codice civile bavarese però continuava ad avere effetto laddove esso
non intervenisse con la sua disciplina. Nel complesso, per quanto evolutiva ed eccellente, conservava un certo taglio
conservatore.
Capitolo 4. Riflessioni conclusive sulla politica assolutistica del diritto nel settecento preilluministico
L’assolutismo di fronte al particolarismo giuridico: il peso dell’eredità medievale.
L’esperienza giuridica vissuta dallo Stato Moderno appare costantemente incentrata sull’azione politica dell’assolutismo,
ovunque intesa a modellare la società, la cultura e le istituzioni dell’età moderna.
Lo stato assoluto persegue, nel tempo, un suo particolare ma vitale obiettivo, punto chiave nella logica di conservazione e
pienezza del potere: la razionalizzazione del sistema giuridico, inteso come un processo di semplificazione delle fonti
normative e l’autoritaria riconduzione allo Stato, cioè al sovrano, dell’intera attività di produzione e di applicazione del
diritto. Gli strumenti principali per il raggiungimento di questi fini cono il potenziamento di una legislazione sovrana
estesa a settori via via più ampi ed il completo controllo dell’amministrazione giudiziaria, secondo il principio che unica
fonte del diritto è il monarca e che tutta la giustizia è amministrata per sua delega.
La situazione di partenza riscontrata è l’estremamente complessa situazione di particolarismo giuridico ereditato
dall’universalismo e pluralismo medievale di cui, paradossalmente, era la negazione.
La pluralità giuridica esprimeva pluralità di gruppi organizzati, forze ora contrastanti con i piani accentratori
dell’assolutismo.
Il diritto comune, diretta espressione di una concezione universalistica e perciò stesso pluralistica dell’ordinamento
sociale, veniva a rappresentare la massiccia eredità trasmessa, senza possibilità di rinunce, dallo spirito del medioevo allo
stato moderno in formazione: pur statuato e nazionalizzato, pur parzialmente eroso da una legislazione sovrana, pur
privato del suo fondamento politico e autoritario e pur messo sotto accusa nei suoi aspetti antinomici e controversi,
rimaneva comunque un pilastro unitario su cui reggere gli equilibri di legalità formale e pacifica convivenza dello Stato.
Nel processo di formazione della propria identità, lo Stato moderno doveva affrontare il problema di integrare e di
dissolvere nelle nuove strutture pubbliche le antiche e ossificate istituzioni organizzative con cui, attraverso una
dispersione di gerarchie e di centri di potere indipendenti, si era pluralisticamente retta la vita pubblica della società
feudale e comunale.
Il problema dello Stato assoluto fu quindi la necessità di dissolvere il particolarismo ereditato dal medioevo. Ma quel che
nell’età moderna fu negativamente sentito come particolarismo era stato naturale pluralismo nel medioevo. Solo col
nascere dello Stato moderno si generò, in termini drammatici, il problema dell’unità e della certezza giuridica.
L’ideologia statualistica sottrasse potere ai giuristi tendendo a toglier loro il controllo dell’ordinamento normativo,
passando da una dimensione giurisprudenziale ad una dimensione legale.
Entrando in crisi le persone dei giuristi, entrò in crisi l’opinione dei doctores che ridivenne opinio privata, e con lei anche
l’intero ordinamento pluralistico medioevale, che aveva garantito certezze e stabilità fino ad allora, che divenne
particolarismo e individua nel diritto romano-comune un diritto controverso e poco praticabile.
Da allora i governi assoluti intrapresero una lotta contro il particolarismo giuridico ed attuarono sforzi a vari livelli
tecnici con l’intento di promuovere un ordinamento normativo uniforme atto a costituire un corpo di precetti parimenti
coercitivo per tutti i membri della comunità sociale.
Il cammino degli Stati fu faticoso e diseguale: dalla promulgazione di leggi sulle citazioni all’avocazione al sovrano
dell’interpretazione delle norme regie, dalla compilazione di repertori dei materiali giuridici alla pubblicazione di
massicci corpi legislativi volti a riformulare vasti settori della normativa tradizionale.
Tutte le operazioni effettuate erano state fatte al servizio del principio della certezza giuridica, ma attraverso
un’interpretazione ancora tutta tradizionale e conservatrice di questo principio, secondo la quale era la certezza del diritto
esistente che si tendeva a raggiungere: semplificazione e razionalizzazione da effettuarsi, dunque, entro il sistema di fonti
in vigore.
Una contraddizione interna a tutto il sistema, tra fine dichiarato e mezzi impiegati. Come si spiega?
L’atteggiamento del ceto giuridico e delle forze sociali rispetto alla politica assolutistica del diritto.
L’ordinamento a cui si mirava non sarebbe potuto essere se non il risultato di una complessa operazione dalla duplice
portata innovativa: un’operazione di radicale riforma politica, realizzata sfruttando le indirette conseguenze di una
difficile operazione di tecnica giuridica.
In particolare si sarebbe trattato:
a) di creare ex novo un sistema giuridico autosufficiente e b) di realizzare un potenziamento dell’istituto statale in
monopolio della produzione del diritto unico e eguale per tutti.
In un eventuale operazione di questo genere erano coinvolti direttamente i giuristi da un lato e le varie forze della
comunità dei consociati dall’altra.
a)Quanto al ceto dei giuristi, occorre distinguere e diversificare l’atteggiamento della minoranza di intellettuali assorbiti
da interessi dottrinali e teorici da quello degli appartenenti al mondo dei forensi e dei “pratici”.
Se i primi erano tendenzialmente solidali con la politica di semplificazione giuridica dei governi assoluti, nell’ambiente
avvocatesco e curiale dei secondi vigeva un immobilismo conservatore e tradizionalista, d’ostacolo, attivo o passivo che
fosse, al possibile accentramento legislativo e giudiziario.
Tale opposizione non è da definirsi in termini di anti-assolutismo ma in termini di difesa, ai fini della conservazione, del
corporativismo, del potere personale e dei privilegi che vantavano. Indubbia la loro utilità nell’ambito della creazione
giuridica e del funzionamento della macchina giudiziaria, innegabile però lo strumentalità di ciò ai fine del potere.
b)Quanto alla molteplicità dei consociati, bisogna anche qui operare delle differenze. Vi fu, sicuramente una parte
dell’opinione pubblica che si espresse in favore di un diritto semplice e certo come, d’altra parte ve ne fu un’altra che fu
motivo frenate, perché risultò, in molti stati, difficile spiegare e poi attuare nuove disposizioni a persone che per secoli si
erano attenute a disposizioni dettate da consuetudini entrate nel proprio DNA e ritenute le più idonee, e pertanto le uniche
giuste a regolare magari i rapporti. V’è anche da tener conto della sistematica opposizione conservatrice dei ceti
ecclesiastici e nobiliari: nella fitta ragnatela dei privilegi tardo feudali che caratterizzava il sistema particolaristico v’era la
condizione per la loro stessa esistenza.
La duplice operazione di cui sopra, laddove fu tentata, scadde in dei compromessi.
Modesto compromesso tecnico fu il sollecitare l’intervento sovrano non tentando di uscire dal pluralismo dello ius
commune: dinnanzi all’impresa unificatrice si ripiegò su rimedi legislativi di parziale incidenza che non privavano,
comunque, il diritto comune del suo valore sussidiario.
Dal punto di vista politico il compromesso assume i tratti di una resa: è vero che i sovrani limitava la libertà dei tribunali
nell’interpretazione delle compilazioni emanate ma è pur vero che i giudici se la riprendevano laddove il silenzio della
norma regia richiedeva l’intervento del diritto comune o dei diritti particolari.
L’ideologia antigiurisprudenziale
Costante nella cronica crisi della giustizia, l’ideologia giurisprudenziale di cui le prime manifestazioni si colgono nella
polemica umanistica.
Nella cultura di questi secoli post medioevali, la figura del giurista diviene nemica della certezza e dell’ordine giuridico
Poiché inquadrata in ceto giuridico volto a conservare un ordinamento controverso e poco propenso al rinnovamento.
Gli uomini di legge riuscivano, comunque per via del loro arbitrio, ad evitare una paralisi del sistema: potevano essere
accusati di non incoraggiare una riforma dell’assetto giuridico, sociale e politico ma, così rimanendo, il loro operato si
adeguava alla complessità e alle disfunzioni.
Quando si sentì il bisogno di rinnovare, essi apparirono come un ceto fastidioso, incapace di rappresentare l’intero corpo
sociale ed essere portatore di soli interessi particolari.
Ci si illudeva che l’innovazione dovesse nascere da una “guerra” da fare a giudici e avvocati e perciò ci si nascondeva
dietro questa “miopia” , nel senso che realmente non si vedeva o si faceva finta di non vedere quale fosse la reale
soluzione, ovvero l’abbattimento dell’intero regime del diritto comune, addossando al ceto giuridico responsabilità che
non erano sue ma degli stessi governi assoluti: questo era il compromesso, questa era la rinunzia ad operare una scelta di
fondo a favore di una compromissione di potere con le forze particolaristiche.
L’Ancient Règime è l’apice di tale miopia seppur volesse manifestare all’esterno quella sorta di voglia di rinnovamento.
Il pensiero di Ludovico Antonio Muratori
La testimonianza essenziale di tale situazione ce la dà il MURATORI.
La rilevanza del suo pensiero risiede nel fatto che in questo vi si convogliano tutti i motivi culturali della polemica
cinque-settecentesca contro il diritto giustinianeo e la giurisprudenza romanistica e vi si riflettono le convinzioni, le
aspirazioni , le preoccupazioni e le tendenze più comuni della società del primo Settecento.
Egli è un genuino interprete di quell’atteggiamento antigiurisprudenziale e antiforense che si sviluppa già a partire dal
secolo XVI in certi settori dell’opinione pubblica, negli ambienti di governo e nella stessa cultura giuridica: atteggiamento
nel quale confluiscono e si perpetuano le dottrine antigiustinianee della scuola culta e molte ideologie di natura
assolutistica., postulanti un massiccio intervento riordinatore nella vita del diritto.
Le teorie dei Muratori non sono di tipo codificatorio ma solo preparatorie alla codificazione, talvolta superficiali e non
originali nella sostanza ma pur basate su una clamorosa denuncia delle condizioni patologiche del regime di diritto
comune, provocante e non tecnica e, quindi, comprensibile dal comune lettore.
Egli nacque a Vignola nel 1672, si laureò a Modena in utroque iure, qui consacrato sacerdote, poi dottore nella biblioteca
Ambrosiana e, infine, direttore della biblioteca privata del duca di Modena. Tipico dotto di formazione, quindi.
Della sua monumentale produzione hanno rilievo, ai nostri fini, gli scritti giuridici e il trattatello Dei difetti dell
giurisprudenza, pubblicata nel 1742.
Già nel 1726 inviò una lettera all’imperatore Carlo VI, il De codice carolino sive de novo legum codice insituendo, in cui
lo invitava ad una semplificazione autoritaria del diritto e ad una concentrazione in un piccolo tomo ufficiale.
Il pensiero di questo straordinario storico-giurista, manifesto nella sua opera di maggior successo, si fissa sulla situazione
giuridica ormai inquinata da una serie di mali gravissimi. I difetti dell’ordinamento sono per lui intrinseci ed estrinseci.
I primi, secondo lui, sono ineliminabili al pari di malattie congenite da curare ma mai rimuovere completamene. Sono:
1- la non chiarezza delle norme giuridiche che, perciò devono essere interpretate e possono assumere un contenuto
ancor più equivoco;
2- il limitato campo d’azione di una norma che per quanto vasta non può coprire ogni fattispecie;
3- la volontà e l’intenzione manifestate da troppi uomini di legge;
4- il diritto, nella sua applicazione pratica, troppo dipendente e condizionato dalla testa dei giudici.
Parla anche di difetti estrinseci eliminabili perché non dipendenti dalla natura del diritto, ma da aspetti riconducibili al
comportamento degli operatori giuridici. Sono:
1- il caos oceanico delle interpretazioni dottrinali e giudiziali che aveva soffocato il testo giustinianeo;
2- l’applicazione giudiziale del diritto necessariamente arbitraria e fin troppo libera.
Il problema è di riuscire a limitare e a bloccare il torrente di opinioni dottrinali e la libertà incontrollata dei tribunali.
Egli pone la risoluzione del problema individuando vari rimedi che, nel complesso, si rivelano deboli e poco convincenti
e rapidamente superabili, nel tempo. Si potrebbe pensare, secondo il Muratori, all’opportunità di proibire agli avvocati
l’utilizzo nei tribunali delle opinioni della dottrina, obbligandoli a fondarsi sul nudo testo di legge: il rimedio sarebbe solo
apparente però; gli avvocati, pur non citando le opere dei giuristi, continuerebbero ad ispirarsi ad esse ed, inoltre, venuta
meno la soggezione alle opiniones, aumenterebbe l’estensione dell’arbitrio dei giudici.
Il rimedio effettivo, invece, dovrebbe essere effettuato direttamente dal sovrano, con un intervento legislativo unico e
drastico che si sostituisse alle tanti pullulanti opiniones.
Menzionando il piccolo codice in cui riunire le soluzioni dei casi più controversi, il Muratori considera un risanamento
del regime del diritto comune, non un suo superamento; il suo merito risiede, pertanto, nel calare in termini di comune
buon senso la discussione sui guai del diritto vigente: quanto a carica innovativa siamo piuttosto fermi.
Anch’egli è consapevole che il diritto romano non è perfetto, ma perfettibile. La novità l’avrebbe detta se lo avesse
dichiarato sostituibile.
In risposta a questo “trattatelo” , che comunque suscita scalpore, prende la parola fra i tanti anche un grande giurista
napoletano: Francesco RAPOLLA, che critica garbatamente l’opera del MURATORI con la Difesa della giurisprudenza,
e lo stesso giurista modenese giudicandolo inesperto ed utopista.
Anche il Rapolla è un conservatore, concorda con Muratori sui mali del sistema ma non condivide i rimedi da questo
proposti. Combattono entrambi per lo stesso regime vigente, non contro di esso. Tale polemica è, però, abbastanza in
ritardo con i tempi.
Mentre entrambi conducono il loro dialogo senza presagi nel quarto decennio del 700, in tutta Europa fervono i lavori per
una rivoluzionaria codificazione. Trent’anni dopo Voltaire lancerà la nuova formula che riassume la nuova idea di
codificazione:”Volete avere delle buone leggi? Bruciate le vostre e fatene delle nuove”. Non vi è un abisso d’anni ma di
pensiero, che separa due diverse concezioni di diritto e società.