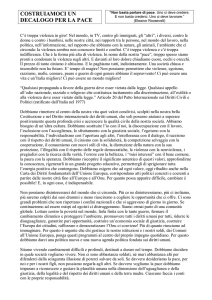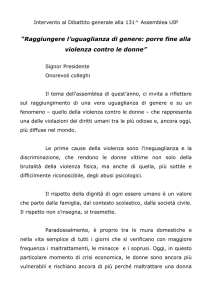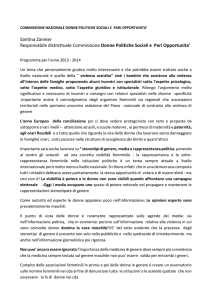La violenza in un’era di incertezza
di Zygmunt Bauman
Traduzione, sintesi ed editing della relazione presentata da Zygmunt Bauman in occasione dell’omonima lectio
magistralis presso l’Università di Roma “La Sapienza” il 10 giugno 2002, sono state curate da Mariella Nocenzi.
1. Introduzione
Quello di “violenza” è un concetto che potrebbe ben essere utilizzato come un esempio
emblematico fra le tante costruzioni di Austin - ossia quelle parole che solo pronunciandole
raffigurano la realtà cui fanno riferimento. Inoltre, quello di “violenza” è essenzialmente un
concetto che non può essere nulla di diverso dalle asserzioni descrittive e valutative che in esso si
mescolano e completano e che non possono essere separate. Il contesto in cui il concetto di
“violenza” è naturalmente inteso è quello in cui si realizza la legittimazione della forza. La
“violenza”, però, è una coercizione non legittimata: più precisamente una coercizione che non ha
ottenuto o a cui è stata negata la legittimità. In contesti costruiti e mantenuti con l’ordine la
legittimazione è per necessità al primo posto. In realtà, tutti i conflitti sono combattuti intorno alla
delimitazione fra il concetto di coercizione propria (che è impunibile) ed impropria (che, al
contrario è punibile). La dichiarata fine della “guerra contro la violenza” nel nome della legge e
dell’ordine può essere rappresentata dalla pace sociale e dalla civiltà, ma la finalità e gli eventuali
profitti della guerra non sono rappresentati dall’eliminazione della coercizione, quanto dal suo
monopolio. La “eliminazione della violenza”, ossia la finalità prioritaria di questa guerra, è
raffigurabile come una condizione in cui il monopolio non è più contestualizzabile e solo alcune
debitamente autorizzate agenzie possono ricorrere alla coercizione. In altre parole, la “non
violenza” presentata quale componente della vita civilizzata non significa “assenza di coercizione”,
quanto assenza di una coercizione non autorizzata. Queste sono le principali ragioni per le quali la
guerra contro la violenza è una guerra senza fine che sarà caparbiamente ed irreparabilmente
invincibile. Per tutte queste empiriche riflessioni, un ordine sociale senza violenza è una
contraddizione in termini.
Ne derivano due importanti conclusioni. In primis, a differenza della dichiarazioni di intenti che
accompagnano la promozione di un ordine civilizzato, una posizione di un certo rilievo contro la
violenza è improbabile sia assunta da qualsiasi degli attori sociali, mentre potrebbe piuttosto
rimanere un concetto molto sentito in pratica, altrettanto quanto enfatizzato a parole. La censura
della violenza potrebbe sortire effetti di coesione sociale solo se fosse estesa alla sola accezione di
coercizione; ma questo è semplicemente impossibile. Anche coloro che hanno costituito e che oggi
mantengono l’ordine non possono, infatti, trascurare l’utilità e la necessità della coercizione.
Secondariamente, è impossibile affermare con una certa oggettività se la storia moderna è stata un
continuum di alti e bassi di violenza - così come è quasi impossibile trovare la definizione di una
violenza senza ambiguità separata dalla coercizione per misurarne “oggettivamente” l’entità.
2. Chi ha paura della criminalità?
Questa seconda conclusione acquisisce un’importanza di rilievo ogni qualvolta si tenti di dare un
senso alle “statistiche sui crimini” e la accresce quando si cerchi di comprendere il ricorrente - e
troppo spesso autorizzato - allarme sui crescenti livelli di violenza così come i messaggi veicolati
dalle più note fonti di pericolo. In questa crescente percezione della violenza interagiscono tre
differenti fattori che sono estremamente connessi fra loro e virtualmente impossibili da separare
nettamente.
Il primo consiste nel fatto che, ogni qualvolta si diffonda un segnale di crescita della violenza, si
può supporre che la notoriamente sfuocata linea che separa la “coercizione “naturale” - ossia la
coercizione inevitabile e “giustificata”, quella contro cui “non ci si può fare nulla”, la parte
indifferibile della routine quotidiana nella quale non si ha possibilità di scelta - e la violenza - cioè
la coercizione percepita come “eccessiva”, ingiustificabile e deplorata dagli individui - divenga
ancor meno visibile di quanto lo sia solitamente. Quelle azioni, che prima erano subite con una mite
placidità, diventano ora una vera e propria coercizione illegittima.
Il secondo fattore si ha quando quelle norme ormai consolidatesi che distinguono la costrizione
legittimata dalla violenza - mi si lasci ribadire che la violenza è una coercizione a cui è giusto
resistere e che deve essere punita - stanno decisamente perdendo la loro vigenza e sembrano
riaprirsi ad una riformulazione. Allora può accadere che si attui una sorta di tiro alla fune nel corso
del quale ogni azione perda la sua normatività e sia percepita come violenta da chi la perpetra e da
chi la subisce allo stesso modo. Sia la difesa delle usuali pertinenze ad esercitare la coercizione sia
le re-azioni per resistergli vengono così diffusamente percepite come atti di violenza.
Il terzo aspetto, infine, riguarda la percezione di una violenza crescente quando questa riflette un
deciso aumento dell’insicurezza che anche solo marginalmente può essere indotto dall’oggettivo
sommarsi di casi e attori violenti. L’incertezza circa il futuro e il senso doloroso di insicurezza
provati nella vita pubblica e privata generano “scorte” di ansia che sempre più spesso sono
difficilmente superabili. In mancanza di soluzioni possibili al problema, il flusso d’ansia generata
da questa insicurezza esistenziale e dalla paura di un futuro incerto cerca più tangibili “estuari” così da convergere su tematiche di sicurezza come quella del corpo, della proprietà, della casa, dei
vicini. Guardando da vicino queste “immagini di paura” da cui è generata l’ansia, si può sentire
meno il loro intrinseco potere di disturbo rispetto a quell’incertezza e insicurezza con cui
alimentano il panico.
Accade così che questi nostri tempi siano dominati da processi di profondo e rapido cambiamento;
non si può negare che ognuno di noi, in diverso grado e per una diversa ragione, si senta insicuro.
Anche coloro i quali sembrano essere saldi sulle loro posizioni non possono dire di conoscere cosa
porterà loro il domani. Aziende, fabbriche, intere compagnie scompaiono senza preavviso
riducendo ad un servizio al mondo del lavoro la domanda occupazionale, mentre i governi di destra
come di sinistra dichiarano di voler essere più flessibili promettendo più cambiamenti, ma in realtà
anche una maggiore, soffocante incertezza. Neppure la famiglia costituisce più quel riparo
tranquillo e sereno dove ci si poteva rifugiare. Ormai poche persone sono sicure di poter vivere la
loro vita sempre al fianco della stessa persona. Anche i vicini non sono più gli stessi; i suoni
familiari di chi viveva accanto a noi possono svanire all’improvviso sostituiti da altri sconosciuti e
mai sentiti.
Questi individui così insicuri potrebbero, quindi, essere giustificati per il loro desiderio di un mondo
meno opaco e di una vita più prevedibile di quella di cui dispongono. Non ci sarebbe nulla di nuovo
in tutto ciò. Ma ciò che c’è di diverso è che se nel passato un simile desiderio incideva sul tempo
delle persone, occupandole nella costruzione di una “buona società”, più adatta ad una vita umana
degna, coalizzandone le energie, oggi non è più così. Di questi tempi. chi governa la nostra società
può fare davvero poco per combattere alle sue radici l’insicurezza. Le mani dei governatori sono
legate da quelle “tendenze globali” - quelle dettate dalle anonime forze del mercato di cui nessuno
può ritenersi davvero gestore. Come tristemente osservato da Richard Rorty nel 1983
ogni tentativo fatto dagli stati di prevenire l’impoverimento dei propri lavoratori può portare questi
ultimi solo ad avere sempre meno lavoro”.
Così, privi di significati collettivi per la tutela della società e non più sicuri di poterli tracciare
partendo da una pur semplice base, ognuno di noi nel suo proprio è chiamato a trovare con le
proprie energie e forze la via per affrontare i problemi contingenti. Come ha delineato in una nota
osservazione Ulrich Beck (1992), ci troviamo a cercare soluzioni biografiche per contraddizioni
sistemiche.
Prima o poi ognuno di noi è costretto a chiedersi e ad adoperarsi per il da farsi, consapevole che il
disagio dell’insicurezza non sarà facilmente rimovibile. Sembra comunque pacifico che i nostri
governi non potranno fare nulla. Se una buona società in cui ognuno si senta sicuro è ormai un
miraggio, non si può che dare più valore alla sicurezza nella nostra ricerca dello star meglio. Alla
fine noi potremmo sentirci un po’ meglio se solo attribuissimo più valore alla sicurezza. Non
potremmo essere né biasimati, né derisi da alcuno per esserci arresi. Come l’eroe di Qualcuno volò
sul nido del cuculo, al più potremmo dire di aver fatto qualcosa di tangibile e concreto per
combattere i pericoli e di averli rimossi.
Non meravigli la diffusa convinzione di vivere in tempi molto violenti. Sarebbe sbagliato,
comunque, considerare questa comune percezione come il segnale di una crescente violenza.
Lasciatemi ribadire che se la routinaria, ripetitiva e monotona coercizione non suscita alcun
interesse, accende comunque allarme e risentimento - infatti, quando la routine si spezza, allora
balza in evidenza la coercizione che dalla routine è di solito mantenuta. Proprio in questa
condizione la coercizione prende a divenire violenza, ingiustificato uso della forza e attacco alla
sicurezza, integrità e dignità personale. Ma, come è stato prima accennato, questo è solo un aspetto
della storia. La crescente frequenza con la quale oggi la gente ricorre all’illegittimato uso della forza
non può essere considerato un problema di errata percezione.
Una volta che le regole consuetudinarie della coabitazione vengono ad indebolirsi, nuove regole
tendono ad essere stabilite e imposte attraverso un “riconoscimento in guerra” (nella pratica militare
questo termine si riferisce alla manovra di attacco del nemico per mostrargli la propria capacità
difensiva). Gran parte della violenza esercitata nei nostri giorni - dalla schermaglie familiari, ai litigi
con i vicini, fino alle guerre fra nazioni o fra religioni - si fonda su questo “riconoscimento in
guerra”, in attesa di tempi di transizione.
Lo stesso sentore della violenza è in sé una fonte considerevole di ansia e, se si considera il
problema della legittimazione, allora ogni condivisione di spazi e di tempi fra gli individui diviene
difficilmente libera dall’ombra di forme di violenza esercitabili. La rinegoziazione del modus
vivendi è piena di rischi - e così la strategia del disimpegno - ossia il rifiuto di negoziare e prendere
decisioni a distanza - pare il modo meno traumatico per andare avanti. Questa strategia si manifesta
in tutti quei disperati tentativi di erigere impalpabili barriere per separare gli spazi - dalle comunità
e i circuiti TV chiusi, alla ghettizzazione degli indesiderabili e alle pulizie etniche.
La paura della violenza può essere vicina, ma non è mai distribuita fra gli strati dell’emergente
gerarchia della globalizzazione che rende un concetto universalmente diffuso di violenza come il
più difficile da comprendere appieno. Presupposto tutto ciò, la dimostrazione di capacità alla
Houdini, l’abilità di muoversi velocemente, così come la prassi o la tentazione di fuggire e
disimpegnarsi, tendono ad essere sostituite, nell’attuale liquido stato della modernità, dalla
meticolosa regolazione normativa di un tempo così come da una ferrea azione di polizia quali
uniche strategie di dominio e di lotta di potere. Dal momento che questa lotta sempre più
contrappone velocità e lentezza, extraterritorialità e località, libertà di muoversi e necessità di stare
fermi, il livello dell’attuale, potenziale” fermezza mobile” diviene la principale caratteristica della
nuova gerarchia globale e della stratificazione intrasociale.
Girling et. al. (2000), che hanno studiato le tipologie di percezione della violenza endemica e della
criminalità in alcune località della contea inglese dell’est Cheshire, si sono sentiti obbligati a negare
la presunta diffusa assunzione che la “paura del crimine” potrebbe essere ascritta in egual misura ad
individui indipendentemente dalle loro specifiche condizioni sociali. Ad esempio, il noto “disagio
giovanile” non
può essere interpretato in modo univoco. Gli individui (e le intere comunità) vivono diversamente
cause ed effetti del disagio giovanile e altrettanto diversamente lo giudicano e scelgono soluzioni
per controllarlo … In alcuni casi … questo disagio non sembra correlato agli altri aspetti della vita
sociale. Ciò appare più evidente in quelle società in cui non ci sono autorità e paradigmi valoriali
depositari degli scopi della stessa e della garanzia della sicurezza delle persone … [il che rende
impossibile per queste persone] vivere lontani dai problemi e i disagi del loro ambiente
quotidiano… Il disagio giovanile endemico e radicato nella società, al contrario, attiene ad una
situazione nella quale “il problema adolescenziale” è vissuto come evidente metafora, come diretto
effetto di più ampie problematiche sociali. (ibid., p. 171).
3. Possibili stereotipizzazioni della paura
In realtà, come più volte osservato da David Matza (1969, p. 14) “darsi delle regole e concedersi la
possibilità di disobbedirvi sono come le due facce di una stessa medaglia”. Così, quanto più quelle
azioni coercitive, una volta considerate tranquillamente parte della natura umana, tendono ad essere
classificate come violenze contro la persona e la dignità umana, tanto più aumenterà il numero di
quei fatti definiti criminali. Richiede comunque del tempo e tutta una serie di riclassificazioni e
stereotipizzazioni la trasformazione di questi “nuovi” fatti criminali in materiale per le forze
dell’ordine e per le corti di giustizia, per trasformarsi in ciò che David Sudnow (1965) definisce
“crimini normali”, “ … ossia atti che hanno tutti i requisiti per essere giudicati dalle corti di
giustizia” (ibid., p. 255). La probabilità che un atto sia considerato criminale, pertanto, cresce con il
livello di suo riconoscimento da parte di un gruppo sociale quale “crimine normale” riconoscimento che il gruppo sociale condivide anche con le autorità pubbliche. Al pari dei membri
di una corte di giustizia, gli individui riconoscono quell’atto come criminale corredandolo di tutti
gli attributi e le specificazioni che tale lo rendono e che appunto lo classificano davanti alla legge
come un atto da giudicare ed eventualmente perseguire. Questo complesso processo di
“riconoscimento-sentenziabilità” dell’atto costituisce il meccanismo della sua “autentificazione”: si
genera così l’evidenza di crimini e criminali “reali” e “normali”.
Nell’ultima edizione della sua collana di critica al diritto di procedura penale Nils Christie (2000),
formula alcune vexatae quaestiones:
Possono essere ugualmente eletti re i figli di Dio e quelli di criminali particolarmente efferati? E a
quegli individui arrivati al top delle loro carriere manageriali o artistiche possono essere attribuite
virtù interiori pari a quelle professionali? Possono essere tutti giudicati oziosi ubriaconi, buoni a
nulla o anche vittime incolpevoli delle condizioni sociali in cui vivono quelle persone in stato di
povertà? I luoghi della vita sociale urbanizzata possono definirsi come quegli spazi in cui le persone
convivono senza avere possibilità di scelta o sono siti in cui non è dato godere di alcun beneficio tra
quelli dati dalla modernità? La domanda più intrigante è allora perché gli spazi urbani americani
sono visti come obiettivi di attacchi terroristici piuttosto che come luoghi in cui attuare drastiche
riforme sociali” (p. 109).
Il punto della questione è che il meccanismo del riconoscimento-sentenziabilità e le procedure
poliziesco-giudiziarie che alimentano il meccanismo medesimo operano effettivamente per
prevenire le domande che si pone Christie e, nel caso in cui venissero ugualmente formulate, fanno
in modo di negare quanto esse implicano, rendendole irrilevanti.
D’accordo, non è il sistema poliziesco-giudiziario che produce le folte schiere di individui che
violano la legge - sebbene sia evidente come faccia anche molto poco per ridurne il numero - né
tantomeno lo stesso sistema può essere ritenuto responsabile di creare quel clima favorevole al
crimine che turba i giorni e le notti di chi vive nei nostri tempi incerti. Però, non si può nemmeno
dire che esso sia coinvolto solo nella fase di riparazione degli effetti da questo clima prodotti. E
neanche si può ritenere che esso non influenzi la percezione o il grado di sensibilità comuni
riguardo alle minacce alla propria incolumità. Il meccanismo su citato, infatti, partecipa a tutte
queste fasi e, avendo contratto un matrimonio di interessi con il sistema dei media - il principale
tessitore delle trame biografiche della condizione umana dei nostri tempi - esso supporta quei
parametri cognitivi della criminalità, della violenza e della responsabilità richiesta per garantire gli
stessi individui dall’insicurezza esistenziale che producono.
Non a caso generi come i thriller o i film polizieschi - molti dei quali ispirati a storie vere e
verosimili - sono oggi quelli che vanno per la maggiore fra il pubblico televisivo e fra i cinofili.
Mentre gli schermi nascondono il mondo visibile che c’è fuori dalle nostre case, come i tappeti che
da parete a parete ricoprono il pavimento, scene di crimini, guerre e indagini poliziesche riempiono
i nostri schermi. Nel “mondo dei media” senza alcun dubbio la violenza sta aumentando. Oltre a
divenire sempre più spietata e inquietante. Raramente si proietta un film o una serie televisiva che
non mostri dinamiche violente, spesso anche gratuite. Poi, dopo lo shock, il termine più adatto usato
dagli spettatori per definire la loro reazione, subentra piuttosto velocemente un’assuefazione per la
continua ripetizione della rappresentazione di questi atti che i produttori televisivi non possono che
combattere alimentando l’iperbole della crudeltà, della virulenza e sanguinarietà delle scene
violente trasmesse. Per rilanciare il cosiddetto “fattore shock” le rappresentazioni della violenza si
spostano sempre più spesso dalla categoria cara a Walter Benjamin delle storie di mare a quelle di
campagna; invece di collocare astuti farabutti in luoghi lontani, i produttori preferiscono inscenare
le loro storie nei tipici contesti quotidiani - nella famiglia, nella casa del vicino, nella strada della
città più frequentata - creando stereotipi di tipici scenari di pericolo. E, avendo messo al bando tipici
contesti quale quello dell’aula di una corte di giustizia, i produttori televisivi americani portano i più
oscuri dettagli dei crimini e i drammi dei colpevoli nel mezzo della vita di tranquilli borghi e nel
privato della vita familiare. Giorno dopo giorno, la rappresentazione della violenza all’interno di
ogni angolo della Lebenswelt fortifica la convinzione che con la violenza non si è più di fronte ad
un evento eccezionale, quanto presente in ogni settore della vita sociale, pronto a manifestarsi
appena se ne presentino le condizioni. Resta il dubbio se la rappresentazione continua di fatti
violenti favorisce simili azioni anche negli spettatori, come affermano i critici moralisti. Più
probabilmente, forse, alimenta una sorta di “stanchezza dell’orrore” e abbassa il livello di
repulsione etica alla violenza che pure era stata suscitata nei soggetti meno influenzabili a livello
emotivo. Ma il più evidente, portentoso effetto è che nell’immaginario collettivo di un numero
crescente di persone il crimine e la violenza non sono più giudicate deviazioni dalla norma, quanto
la norma stessa.
Così, il sistema poliziesco-giudiziario-penale con le rappresentazioni mediali diffuse ricicla,
ripropone e talvolta manipola le ansie che sono quotidianamente alimentate dalle esperienze comuni
di vita nei contemporanei assetti incerti ed insicuri, nei quali quei vecchi e duraturi standard della
“buona società” sono ormai tutti fuori moda.
Riciclare pare la più grande scoperta dei nostri tempi, una sempre più apprezzata strategia nella
cultura industriale. In realtà, essa potrebbe produrre opportunità di rilievo, ma ancora non le ha rese
senza limiti. La qualità degli oggetti contrassegnati come riciclabili è condizionata da quella degli
oggetti che a loro volta li compongono, non garantendo sulla buona riuscita del processo di riciclo.
Si potrebbe sempre cercare l’originale dietro il prodotto finale del riciclo. Ciò profila proprio quei
tratti della paura e dell’odio che così costituente parte hanno nella Weltanschauung degli uomini e
delle donne del nostro tempo. Questi tratti potrebbero e dovrebbero essere individuati in quelle
rappresentazioni vaghe e diffuse, quanto comuni e quotidiane delle paure e delle angosce degli
individui. Le ansie quotidiane suscitate dall’esperienza di un incerto futuro e da un presente insicuro
sono gli autentici “originali” successivamente riciclati in crescenti minacce alla sicurezza
individuale e collettiva. La disperata ricerca di un antidoto a queste angosce e per la liberazione da
una sempre più cumulata tensione sta nella riciclata routine di quei tratti della paura e dell’odio che
vengono rappresentati.
Della vasta gamma di queste rappresentazioni, sono soprattutto tre le categorie che paiono meglio
circoscrivere la natura dell’endemica paura dell’attuale condizione umana. I ladri e i malfattori
costituiscono la parte più cospicua della prima categoria. Nel nostro mondo totalmente
individualizzato, nel quale la condizione umana si frammenta in tanti deboli rapporti individuali e
ogni uomo e donna deve affrontare da solo le prove cui lo sottopone il destino, utilizzando solo le
energie di cui dispone, i ladri e i malfattori accantonano prendendone il posto della folla
ribelle/rivoluzionaria che angariava i nostri avi: folla ribelle, mobile vulgus, gruppi di persone in
rivolta, riottosi intenzionati a distruggere l’ordine naturale cerato dai nostri avi, sono cresciuti in un
clima familiare e sociale ordinato e sicuro. La tendenza all’odio e alla paura cominciò a serpeggiare
come nuova percezione del pericolo fino ad allora sconosciuto al milieu pubblico e privato in cui
questi individui vivevano; nuove cose apparivano e senza alcun avvertimento scomparivano così
velocemente come erano apparse. Con il termine generico “cose” si fa riferimento ad un ampia
varietà di elementi costitutivi della vita sociale: negozi e banche, come luoghi di lavoro, professioni,
stazioni, vicinati, volti della pubblicità, compagni di vita e così via. Sabbie mobili si sono estese
dove un tempo c’erano scogli rocciosi e terreno coltivabile. I tratti del paesaggio, una volta
dominato da dune di sabbia, ora sta rapidamente mutando. Sapere che una casa è costruita sulla
sabbia è certo fonte di preoccupazione, un motivo per non dormire sonni tranquilli. La nuova
fluidità di un mondo che sempre più si liquefà produce al contempo una folta schiera di ottimisti
pianificatori a lungo termine e tragici bilanci per le promesse a lunga scadenza (Bauman, 2000).
Un misterioso senso di pericolo promana da una nuova inquietudine che agita le “cose”, proprio
quanto può rendere più odioso costruire un ordine e non farlo sentire vago, senza limiti, inaffidabile.
Si è in una condizione tale che non si può in alcun modo predire come andranno le “cose”: così
come non se ne possono predire di nuove, ne delle stesse è possibile prevedere il momento in cui
arriveranno. Volendo essere ancora più critici, sembra non esserci più un’autorità centrale che
coordini un’attività di controllo dell’ordine sociale, così come non c’è un recapito cui indirizzare
proteste, una strada in cui innalzare delle barricate e nessuno stabile da occupare o presso cui
manifestare. Questo è, in poche parole, il processo definito di “globalizzazione” (che si barcamena
fra poteri già globali e altre potenzialità senza speranza limitate che dovrebbero competere con i
primi), raccontato in alcuni suoi riflessi sulla condizione umana contemporanea. Per tutti noi uomini
di questi tempi, l’assenza di un controllo delle torri delle città o il soffocamento prodotto dalle
serrate agende quotidiane rende necessario trovare una soluzione nelle nostre stesse capacità e
possibilità, ma senza avere davanti un chiaro percorso e una precisa idea del cammino da fare. Per i
buoni nuotatori la liquidità del mondo è un vantaggio unico. Ma per i poveri è un vero portento di
disastro. Quegli individui che non sono legati ad un luogo fisso, che viaggiano e si muovono
facilmente, possono vincere tutti gli ostacoli e le competizioni cui li mette di fronte questo mondo.
Ma la loro vittoria corrisponde alla sconfitta degli altri, così che il segno del loro exploit ricorda, di
contro, la sofferenza di qualcun altro. Uno potrebbe anche non muovere neanche un dito rispetto ai
risultati spettacolari ottenuti da questi easy riders. Un altro può ammirare e rallegrarsi per le loro
capacità quando i media proiettano con grande enfasi le loro gesta che vanno oltre ogni fantasia.
Visti nello schermo, infatti, mentre combattono contro ogni ostacolo, non possono che suscitare
invidia, risentimento, ma anche paura.
Si potrebbe dire che dove non ci fossero né ladri né malfattori, si dovrebbe proprio inventarli. I
nemici pubblici tendono ad essere censurati con le stesse regole comunemente condivise dalla
comunità contro cui essi si pongono e al “numero uno” dei nemici si applicano queste censure con
più vigore che ad altri. Cosa rende loro così diversamente reattivi rispetto alle paure che
sconvolgono i più è l'essere totalmente liberi di muoversi, l’apparire e lo scomparire ad un
momento, l’entrare in luoghi che generalmente sono considerati inaccessibili. Eppure costoro sono
individui non diversi da noi, che seguono i loro percorsi individuali, che agiscono individualmente,
che soffrono individualmente e combattono nel loro proprio. Come noi, costoro non congiungono le
loro forze, non agiscono all’unisono, non formano battaglioni di guerra - non si aiutano
reciprocamente appunto come noi. Ladri e malfattori sono fra loro nemici - come si deve essere
chiaramente in una società individualistica quale la nostra. Nella loro immagine si riflette la nostra
stessa condizione solitaria. Ladri e malfattori sono strettamente connessi con quelle incarnazioni
della paura che meriterebbero di essere collocate in altre categorie, da quando costoro vengono
riconosciuti come le incarnazioni di ansie ben più profonde relative alla sicurezza dell’incolumità
fisica e dell’ambiente in cui viviamo. Come hanno osservato Antoine Garapon e Denis Salas
(1997), per gli uomini e le donne contemporanei “la delinquenza è diventata un rischio come un
altro (p. 11): le loro risposte ad una violenza che sia genuina o putativa - più precisamente il modo
in cui essi costruiscono il significato della criminalità - costituiscono solo una parte delle loro ansie
rispetto al rischio con le quali riempiono fino all’orlo le loro biografie. Ugualmente, l’emergente
ordine giuridico non si fonda più su valori comunemente condivisi, ma su preoccupazioni
riguardanti la sicurezza individuale. Il tabagismo (il termine di origine francese che indica
l’assunzione di nicotina e i pericoli associati al suo consumo), gli eccessi e le offese sessuali sono,
secondo Garapon e Salas, i crimini maggiormente additati e quelli più severamente puniti. Questa
triade dei più angoscianti rischi sembra essere messa alla rinfusa. Queste tre tipologie di rischio
sembrano avere ben poco in comune. Comunque, le apparenze ingannano, poiché tutti e tre questi
angoscianti e additati rischi convergono sullo stesso “oggetto”: il corpo umano.
Le paure suscitate dalle minacce alla salute e al benessere del corpo non sono naturalmente una
novità nella nostra era della “modernità liquida”, Queste paure continuano comunque a crescere e a
suscitare una profonda emozione come mai era accaduto prima. Questi rischi hanno occupato un
posto centrale nei pensieri angosciati e nelle preoccupazioni degli uomini e delle donne dei nostri
giorni. Si può ipotizzare perché tutto ciò è potuto e, forse, dovuto accadere. Nel mondo degli
obiettivi flessibili, dei punti di riferimento mutanti e dei percorsi fluttuanti, l’esistenza fisica
individuale - un tempo considerata breve e fragile se misurata con una comune longevità e comuni
valori - è divenuta (pur rimanendo di durata e fugacità uguale a quella di prima) un’entità con
un’aspettativa non più lunga di una parte della Lebenwelt. Il corpo oggi sembra essere l’unico filo
che può unire gli altrimenti disparati episodi nei quali si frammentano le biografie contemporanee.
Quelle energie mentali ed emozionali, un tempo impiegate nella preoccupazione dell’immortalità
dell’anima, oggi convergono sul corpo, l’unico scoglio nel mezzo delle sabbie mobili. Ogni cosa
che conta arriverà alla sua fine solo con il cedimento del corpo - ma i vantaggi stanno nel fatto che
gran parte delle cose che contano precedono lo svanire del corpo - e il suo oblio.
Non ci si meravigli che il corpo divenga il focus delle più forti preoccupazioni e la fonte di un’ansia
senza fine. Ciò che rende l’ansia inevitabile e la preoccupazione imperativa è il fatto che il rapporto
fra il corpo e il resto del mondo, dove stanno in agguato gran parte dei pericoli, non può essere
evitato: non solo per il fatto che la vita segue un incessante e inevitabile processo metabolico, ma
anche perché noi tutti, a partire dallo stato di figli di una società di consumatori, siamo educati a
vivere come collezionatori di sensazioni e di sempre più piacevoli percezioni - e proprio queste
sensazioni possono essere solo poste all’interfaccia fra il corpo e il mondo al suo esterno. I rischi,
perciò, possono essere evitati e il ritiro dal mondo in un eremo o in ascesi non è certo un’opzione.
Nell’interfaccia del corpo con il mondo al suo esterno l’aspirazione ai piaceri è insopprimibile, ma
anche terrificanti pericoli sono in agguato. Gli orifizi del corpo e la pelle che lo copre - e
contemporaneamente lo protegge e ne permette l’esposizione - diventano quindi vere e proprie
“zone di battaglia”: luoghi di una guerra che non può mai essere definitivamente vinta e che quindi
non potrà mai finire. L’interfaccia è un sublime territorio, forse il prototipo di ogni sublimità.
Qualsiasi cosa accada in questa zona è oggetto di un’ambivalenza comportamentale e di una
tensione inevitabile, come di un’ansiosa paura.
Sono l’apprensione e il conseguente ingabbiamento e vigilanza concentrate sull’interfaccia corpomondo che cristallizzano l’immagine del “crimine contro la sicurezza e l’incolumità del corpo”.
Garapon e Salas (ibid.) individuarono queste tre tipologie di crimini, definendo con essi i titoli delle
fasi della loro ricerca. Ma il problema che ne sorse era che tutte le successive effigie sulle quali le
tensioni di cui era impossibile disfarsi sono ritenute scomparse, costituiscono precisamente l’ultima
ed ineliminabile tensione. Bruciare però ogni pur piccola effigie può portare al massimo solo un
breve, temporaneo sollievo, fino a quando i problemi dell’interfaccia, restando in sospeso, generano
nuove scorte di ansia. La panoplia di effigie intercambiabili deve essere ampia poiché sempre nuove
acquisizioni sono necessarie. L’attenzione non può soffermarvisi troppo a lungo. L’avversa fatica
profusa nonostante un’evidente pigrizia nel placare l’ansia si esaurisce rapidamente e già un’altra
cattiva stella nella galassia del corpo inizia a catalizzare la comune attenzione e preoccupazione.
La galassia portata avanti dal “big bang” delle paure sul corpo è potenzialmente infinita - poiché,
eccetto per quelle parti dell’universo che non hanno una chiara connessione con il corpo e che
quindi non possono essere fonte di alcuna ansia (sebbene nessuno potrebbe giurare che anche in un
futuro lontano questa connessione non possa essere scoperta, quando ormai gli effetti del danno
sono già irreversibili, come nel caso della “mucca pazza” o dell’amianto), tutto il resto non può
essere neutrale, né tantomeno innocuo rispetto al corpo. Gli alimenti geneticamente modificati, i
rifiuti tossici, i campi elettromagnetici, il fumo passivo o le emissioni di gas che causano il
cosiddetto “buco nell’ozono” e così via, tutti contribuiscono potenzialmente a costituire minacce
per l’integrità del corpo e sono sottoposti a controlli e successivi divieti. Pochi di essi, però,
riuscirebbero ad eguagliare il potenziale di allarme sociale destato dai pericoli associati con
l’alimentazione e gli atti sessuali, a causa dell’indissolubile associazione di entrambi con l’idea di
sostanze esterne che entrano nel corpo umano. Esse costituiscono nell’immaginario collettivo una
più temibile minaccia, potendo entrare in contatto con parti del nostro corpo precluse a tanti altri
agenti pericolosi. Ciò che rende il cibo e il sesso i fattori più temuti e all’attenzione degli individui
fra le minacce verso il corpo è che, rispetto a fattori chimici alla base delle emissioni nell’aria o ai
pericoli della guida ad eccessiva velocità, essi evocano emozioni inevitabilmente ambivalenti. I
piaceri in essi si intrecciano con i rischi: il desiderio si mescola con la paura. La scissione fra i due è
quasi impossibile. Al contrario l’uomo ha bisogno di distinguere fra ciò che è piacevole e ciò che è
pericoloso per poter chiaramente percepire un piacere o avere chiara la minaccia da evitare. Così, la
costruzione del rischio insita nel cibo e nel sesso diviene un vero e proprio atto di purificazione
tentato nella speranza che, una volta che gli effetti negativi del piacere siano stati individuati e
smascherati, possa essere spazzata via questa angosciante ambivalenza.
Questa speranza, però, è condannata a spegnersi rapidamente e così, invece di un purificato piacere,
gli individui sono costretti a percepire tutti i pericoli del cibo e del sesso vivendoli con un piacere
misto ad incertezza ed apprensione. In tematiche così poco definite è impossibile tracciare una linea
di separazione fra il buono e il cattivo, il dubbio non può che essere alimentato e ogni azione, ogni
oggetto non potrà mai apparire nella totale innocuità, ovvero rischiosità. In queste condizioni, un
delinquente che potrebbe essere senza alcuna reticenza ritenuto colpevole e la cui colpa sia
unanimemente riconosciuta diviene un dono inviato da Dio per tutta quella tensione accumulata
dagli individui dei nostri giorni innanzi a cotanta incertezza. Ci sono pochi criminali che possono
unire il potere della pedofilia di eliminare ogni paura e i dubbi di tutti coloro che non possono
temere il sesso e che non possono non praticarlo. Sorvegliare una notte la casa di un pedofilo e nella
quiete più profonda forzarne la porta o entrarvi dalla finestra e spingere il pedofilo al suicidio
sarebbe un atto di redenzione o di esorcismo dei demoni dell’ambivalenza.
Un’altra categoria di atti e figure criminali sono generate, al pari delle altre due, ladri e pedofili,
dalla crescente ansia che caratterizza le nostre biografie. Come le precedenti categorie, anche questa
nasce da uno stato di apprensione diffuso, non definito, ineffabile. Tracciare l’immagine di queste
figure della paura e individuarne le loro cattive intenzioni, i loro odiosi scopi è come voler rendere
leggibile ciò che non lo è: è come dare un nome all’ansia, definire le sue cause e pianificare efficaci
strategie per controllarla. Poiché tutte queste categorie si formano attraverso la stessa esperienza di
una generalizzata insicurezza, i loro tratti sono confusi, le loro strutture semantiche, almeno in
parte, sovrapposte. La loro separazione - un vero e proprio artificio di classificazione - tende,
peraltro, ad esagerarne le differenze, trascurando molte delle loro affinità.
Con queste premesse, si potrebbe individuare come terza categoria dei crimini e dei criminali il
vasto insieme di comportamenti che sono stati recentemente sempre più riuniti sotto il concetto di
“sottoclasse” (n.d.t.: l’Autore usa in inglese il termine “underclass” che si è preferito tradurre in
senso letterario), coniato negli Stati Uniti, ma ben presto diffusosi nel resto del mondo sviluppato.
La portentosa capacità del termine “sottoclasse” di contenere tanti significati è meglio rappresentata
da Herbert Gans (1995) quando afferma:
Questa definizione comportamentale definisce quelle persone povere che non vanno a scuola, non
lavorano e, se giovani donne, dipendono totalmente dal sostegno del sistema assistenziale, non
avendo alle spalle una famiglia. Il comportamento di questa “sottoclasse” può essere associato
anche a figure come quelle dei senzatetto, mendicanti, dei poveri dediti all’alcol e alle droghe e dei
delinquenti di strada. Dal momento che questo termine è flessibile, la povera gente che vive in
istituti di assistenza, gli immigrati irregolari e i componenti delle gangs giovanili possono essere
inclusi in questa categoria. Infatti, la grande adattabilità di questo termine a più tipologie di
comportamento lo rende quasi un’etichetta che può essere usata per stigmatizzare la povera gente,
anche quella che non si comporta nei modi fin qui elencati (p. 2).
Che cosa unisce una così variegata collezione di spostati e derelitti per giustificare una loro comune
denominazione, per ritenerli fonte delle stesse ansie per gli altri e per punirli con simili misure
restrittive? Lawrence Mead (1992), uno dei maggiori critici di questa nuova, esponenziale crescita
di violenza che atterrisce il corpo sociale nei nostri giorni, offre una spiegazione, sebbene non arrivi
a chiare conclusioni. Innanzitutto, non sembrerebbero così numerosi gli aspetti che accomunano la
“sottoclasse” da indurre negli Stati Uniti a disporre una definizione e misure punitive comuni per
tutti i soggetti che vi sono riconosciuti. Piuttosto, ciò che unisce tipologie così divergenti di
comportamento in una “classe fuori dalla altre classi” è l’avversione con cui gli Americani
guardano e giudicano il modo di vivere di queste persone. Secondariamente, ciò che agli Americani
“normali” non piace assolutamente della varietà degli appartenenti alla “sottoclasse”, ciò che li
unisce in una comune presa di posizione contro di loro, ciò che li vede unanimi nel volere che siano
puniti duramente, cacciati dalle città e dalla loro vista, è il peccato originale di cui tutti gli
appartenenti alla “sottoclasse” sono colpevoli in egual modo: il peccato di offendere i valori - quelli
che la “maggioranza normale” tiene cari e rispetta, mentre in modo arrogante si sgomita per
partecipare ai vantaggi della società del consumo, facendo credere agli altri di esserselo meritato
onorando proprio i valori che quelli della “sottoclasse” ignorano.
Per essere più pungenti si potrebbe aggiungere che i peccati manifesti della “sottoclasse” mettono in
luce quelli latenti dei loro detrattori - la “maggioranza normale” - il rimorso di aver sbagliato,
l’indolenza o l’inettitudine. I valori della società del consumo possono essere universalmente
rispettati, ma seguirli fedelmente non è semplice. La vita di un consumatore è piena di scelte da
compiere, però, in condizioni di incertezza, un’incertezza maledettamente insolubile. La necessità
di scegliere lo tormenta, ma non meno insidiosi sono i dubbi che lo assalgono dopo aver compiuto
una scelta e la paura di avere rimpianti. Inoltre, anche se il mondo fosse pure ripudiato come un
contenitore di scelte appetibili e la vita di successo come l’arte di rubacchiare qua e là quelle più
gustose, non si otterrebbe mai la “piena soddisfazione” e si comincerebbe seriamente a pensare di
rivalutare il resto. Infatti, viaggiare pieni di speranza può essere meglio di arrivare. Ma viaggiare
senza speranza di arrivare non è una bella prospettiva. La vita di un consumatore può essere molto
allettante in alcuni momenti. Ma la felicità sembra stare sempre ed inesorabilmente oltre l’orizzonte
e mai a portata di mano.
La vita di un consumatore è, pertanto, vulnerabile, piena di tensioni e davvero incerta. A lungo
andare, il consumatore potrebbe avere una vita più estenuante che eccitante. Ogni consumatore si
costruisce i propri demoni interiori nutrendoli con l’apparente e insanabile ambivalenza di gioie e
paure. La repulsiva visione della “sottoclasse” come incarnazione del fallimento nel raggiungere gli
standards che un mondo consumistico offre pieni di opportunità, aiuta notevolmente ad esorcizzare
questi demoni.
Nella nostra società individualizzata, la costruzione della condizione sociale raramente è ben
definita e sempre meno è palesemente visibile e apertamente discussa. La buona fortuna può essere
un prodotto sociale, ma, intanto, sono gli individui vittime della sfortuna cui viene attribuita la
responsabilità per la mancanza di una buona sorte; così costoro aspettano nel loro cantuccio di
essere sospinti dalla fortuna, aspettano di spingere se stessi, senza dover condividere con nessun
altro la loro sventura. Che essi non riescano a spingersi da soli fuori dalla loro triste sorte è l’unica
evidenza di cui si dispone per provare che essi non hanno mai tentato seriamente di farlo.
Samuel Butler (1998) deve aver profeticamente anticipato l’affermarsi di questo tipo di società
quando racconta di un giudice di Erewhon che all’imputato portato davanti a lui dice: “Lei dice che
la sua sfortuna è quella di essere un criminale. Io le rispondo che è il suo crimine ad essere
sfortunato”. Ad Erewhon, come nella nostra società, era
un assioma della moralità che la fortuna è il solo oggetto degno di venerazione. Quanto un uomo
abbia il diritto di essere più fortunato e felice e, quindi, venerato, dei suoi vicini, è una questione
che sempre è stata e sempre sarà risolta con un mercanteggiamento e, infine, con la bruta forza;
comunque se ne discuta, ciò non preclude che non dovrebbe essere permesso a nessun uomo di
essere sfortunato in una misura solo modesta (p. 109).
Il messaggio che questi tempi trasmettono è che per capire il crimine è necessario risolvere un
rompicapo. Difficilmente se ne può avere una nitida immagine. Per renderlo evidente si dovrebbero
avere sue incarnazioni come avviene con la criminalizzazione della cattiva sorte e del peccato
collettivo della “sottoclasse”. Infatti, la “sottoclasse” è colpevole di non aver ottenuto tutto quello
che gli altri hanno; se la fortuna di avere successo fosse un crimine punibile, noi, la parte fortunata,
dovremmo provare con sacrificio ad evitare l’eventualità di un errore.
I poveri e i miserabili sono gli archetipi dei consumatori viziati. Viziati, o meglio imperfetti,
inadeguati consumatori noi tutti almeno una volta abbiamo sentito di esserlo. Peggio ancora, noi
non siamo in grado di allentare il nostro sospetto di inadeguatezza. La linea che divide una buona da
una imperfetta performance non è ancora stata definita e raramente resta fissa nello stesso posto per
più di un certo tempo. Potrebbe aiutarci nella nostra incertezza una sua più precisa definizione,
specie in termini legali e giuridici. Criminalizzare coloro che consumano in modo sbagliato è un
primo passo per definirla. La criminalizzazione della “sottoclasse” parallelamente dichiara
l’assoluzione di tutti gli altri, cancellando ogni dubbio. Alla fine tutto sarebbe chiarissimo: chi fosse
armato di un paio di occhi ben aperti non avrebbe più il diritto di essere perdonato per ignoranza.
4. Cosa si può fare con i criminali?
Sconcertata per la rapida diffusione della violenza e della paura nelle aree urbane, Sharon Zukin
osservava nel 1995 che gli elettori americani, veri e propri militari di truppa, così come le loro
preferite élites di opinione avevano davanti a loro una scelta. Essi
potevano affrontare la soluzione di una politica governativa di polizia contro la povertà, di controllo
del confronto etnico e di integrazione di ognuno all’interno delle istituzioni pubbliche. Al contrario,
essi hanno scelto di acquistare la protezione alimentando la crescita dell’industria della sicurezza
personale. Costituiscono tutte manifestazioni della politica della paura quelle di far costruire più
prigioni o di imporre la pena di morte”.
Nel porre il crimine al centro dell’attenzione pubblica - alle spese e a detrimento di tutte le altre
possibili preoccupazioni presenti nella vita di una società - cittadini e loro governanti hanno
cooperato come mai prima in altre sfere della vita pubblica, ognuno, enfatizzando e alimentando i
timori e l’urgenza maturati dall’altro. I governati - ossia coloro che se lo possono permettere
visitando negozi della sicurezza di alta moda - sono occupati nella costruzione della loro security
aggiornandosi con lo “stato dell’arte” degli allarmi, delle videospie, dei gadgets di difesa portatili e
accedendo nelle comunità protette e barricate che si trovano spesso nell’ordinario spazio di una
città. Facendo così, essi rendono lo spazio urbano di tipo minaccioso-preventivo. Rispetto alla
tranquillità delle comunità fortificate o della salvezza che si gode dentro auto super sicure, le
normali strade appaiono fuori dal mondo ed ogni zona sporca e minacciosa; lasciando le zone sicure
in cui è difficile entrare e camminando senza difesa per la strada può sembrare come affrontare
rischi da eroi avventurieri. A lungo la più popolare figura pubblica di New York in questi ultimi
anni, l’ex sindaco Rudolf Giuliani- favorito nella corsa al Senato prima del suo inatteso ritiro dalla
vita politica - accanto al capo della Polizia di New York, William Bratton, hanno riscosso enorme
successo fra i loro concittadini con una politica autoritaria e di “tolleranza zero”: una guerra, la loro,
di dichiarato logoramento contro prostitute, ladri e tutti gli altri delinquenti nelle strade più
“infestate” della città. Nessuno si è avventurato a censire la loro politica contro la povertà e le
condizioni disagiate di vita, poiché essi si sono organizzati per rimuovere dalla vista e dalla
coscienza della decent people, altrimenti disturbata, le forme di crimine violento riducendole
notevolmente per la prima volta in tanti anni. Il primo vistoso effetto è stato l’ingente incremento
degli uomini della Polizia presenti per le strade della città, l’aumento delle celle carcerarie e delle
persone condannate. Secondo le stime raccolte da Loic Wacquant nel 1999, dal 1994 al 1999 i
finanziamenti per la Polizia di New York sono aumentati del 40% passando a 2,6 miliardi di dollari
- corrispondenti a quattro volte il totale delle risorse stanziate per gli ospedali della città - e le
risorse-uomo della Polizia sono salite da 12 mila a 46 mila unità. Allo stesso tempo, la spesa per i
servizi sociali è scesa del 30% e il numero degli operatori sociali è diminuito più di 5 mila unità.
Evidentemente, i problemi fin qui considerati sono stati classificati non più come sociali, ma come
attinenti alla legge e all’ordine. La povertà a New York è stata criminalizzata e mostrare la povertà
in pubblico è praticamente diventato un crimine. E New York non è un caso unico negli Stati Uniti
e altrove.
Accade che in quella che io definisco la nostra “modernità liquida” e individualizzata, la società dei
consumatori, l’avvizzita regolazione del mercato del lavoro e la spettacolare espansione di differenti
profitti non favoriscono un dissenso e una ribellione sociale, ma atti criminali. Così non si configura
lo spettro di celati nemici, quanto la paura di squallidi individui visti come nemici pubblici.
Wacquant osserva come “la politica della criminalizzazione della povertà è un indispensabile
completamento dell’impiego precario e sottopagato”. La politica del welfare e del lavoro può
rimuovere la povertà dalle statistiche sulla disoccupazione, ma solo per trasferirle in quelle sul
crimine. Una volta ottenuto ciò, la necessità di costruire nuove prigioni e di moltiplicare i loro
ospitati diventa una conseguenza naturale. Per un sociologo non è così sorprendente che fra il 1979
e il 1990 solo negli Stati Uniti i fondi stanziati per le carceri siano aumentati del 325% mentre la
somma destinata alla costruzione di nuovi penitenziari sia arrivata a crescere del 612%: la finalità
del finanziamento penitenziario non è tanto quella della riabilitazione dei colpevoli e del loro
reinserimento nella società, quanto, al contrario, dell’isolamento di quelle categorie definite come
pericolose e la neutralizzazione dei suoi più minacciosi esponenti. Quanto finora osservato deve
essere ponderato alla luce del fatto che nelle statistiche sul crimine sono registrati solo una parte dei
dati. Inoltre, bisogna osservare che nella nostra modernità liquida e individualizzata, la società
sempre più consumistica che abbiamo scelto più o meno volontariamente consente a coloro che
possiedono molto di non avere nulla a che fare con il controllo della sicurezza dal momento che è la
stessa società che ha deciso di non imporgli alcuna forma di controllo. Il più evidente risultato,
come osserva Jock Young, è l’emergere di una società dell’esclusione o, meglio di una società che
accetta l’esclusione sociale come metodo principale di controllo sociale, che protegge i viziati
clienti di una società dei consumi e ne integra la parte restante. In questa società il grado di mobilità
- l’abilità di cambiare spazi, ruoli e identità velocemente e senza dolori, diventa il principale e forse
più efficace fattore di stratificazione rispetto a tutti gli ortodossi fattori sociali di diseguaglianza.
Essere inattaccabili, senza costrizioni sociali, extraterritoriali, liberi dall’abbraccio soffocante di
ogni condizione predefinita, è oggi il valore più pregnante, in realtà un “metavalore”, la chiave di
tutti gli altri valori qualitativi della vita. Di conseguenza, l’immobilità - lo stato di essere legato ad
un luogo, irrevocabilmente definito e impossibilitati ad ogni movimento - torna ad essere il più
significativo sintomo di una disperata privazione e incapacità e così anche la forma di punizione
inflitta più aspra cui la “modernità” liquida può condannare. Nulla trasmette un più rassicurante
messaggio di quello che dice che “il crimine è stato adeguatamente punito” come le immagini di
mura rinforzate, guardie armate e sorveglianze elettroniche. La certezza che risiede nello stare
immobili è vista ed è fatta vedere come l’ultima e più disastrosa che può venire in sorte al cittadino
della società della modernità liquida. In comparazione, gli svantaggi e inconvenienti dell’incertezza,
l’insicurezza e una vita rischiosa sembrano meno insopportabili per vivere felicemente, forse come
mai più accadrà in futuro.
Bibliografia
Bauman Z., Liquid Modernity, Polity Press, Cambridge, 2000.
Beck U., Risk society: Towards a New Modernity, Sage, London, 1992.
Butler S., Erewhon, Prometheus Books, Amhrest, 1998.
Christie N., Crime Control as Industry: Towards Gulag Western Style, Routledge, London, 2000,
3° ed.
Gans H. J., The War against the Poor. The Underclass and Antipoverty in America, Basic Books,
New York, 1995.
Garapon A., Salas D., (eds.), La Justice et le mal, Éditions Odile Jacob, Paris, 1997.
Girling E., Loader I., Sparks R., Crime and Social Change in Middle England: Question of Order in
an English Town, Routledge, London, 2000.
Matza D., Becoming Deviant, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ., 1969.
Mead L. M., The New Politics of Poverty: The Nonworking Poor in America, Basic Books, New
York, 1992.
Rorty R., Achieving Our Country, Harvard University Press, Cambridge, Ma., 1988.
Sudnow D., “Normal crimes: sociological features of the penal code in a Public defender office”, in
Social Problems, 3, 1965, pp. 255-268.
United Nations, Crimes Trends and Criminal Justice Operation at the regional and Interregional
Levels, United Nation Publication, Rome, 1993.
Wacquant L., Les Prisons de la misère, Èditions Liber, Raison d’Agir, Paris, 1999.
Young J., The Exclusive Society: Social Exclusion, Crime and Difference in Late Modernity, Sage,
London, 1999.
Zukin S., The Culture of Cities, Blackwell, Oxford, 1995.