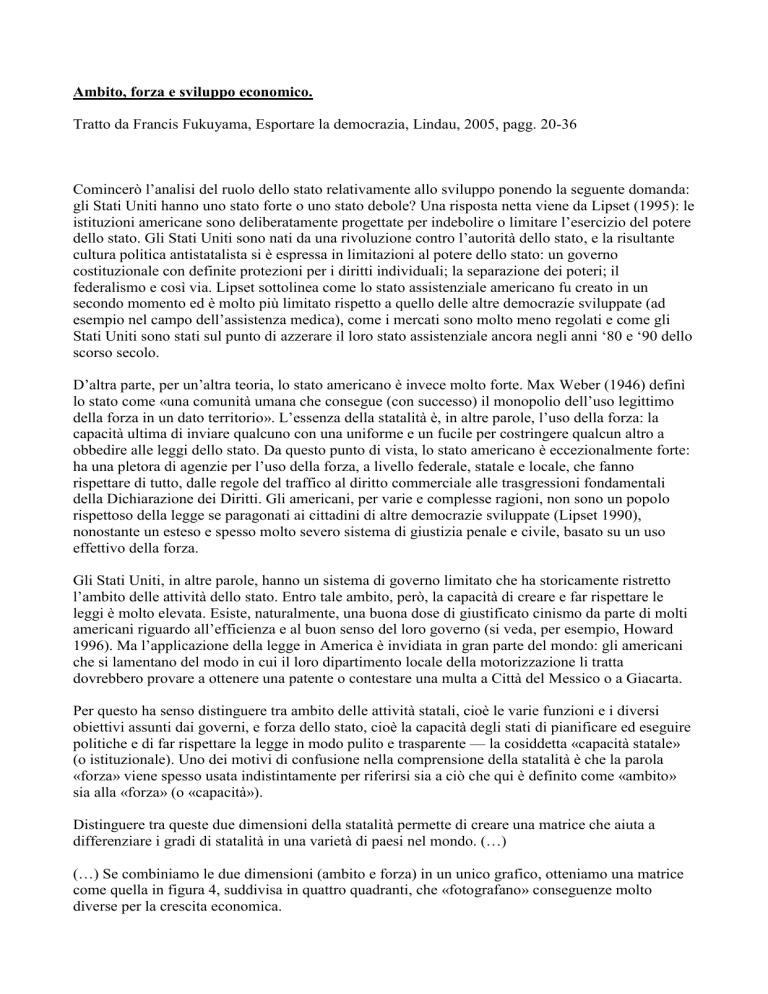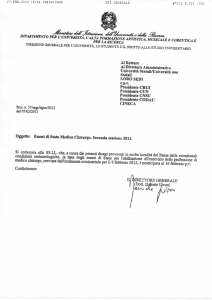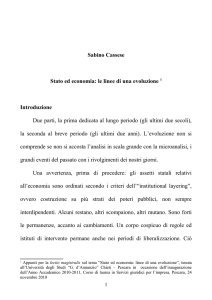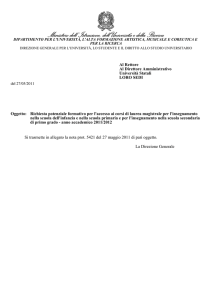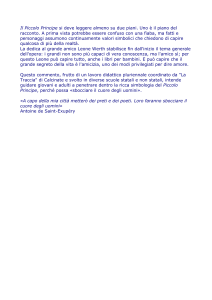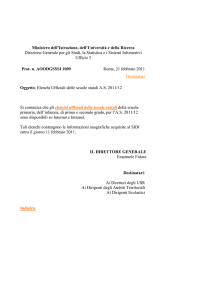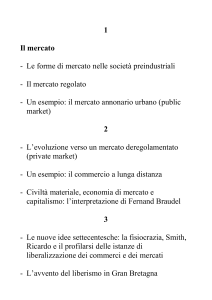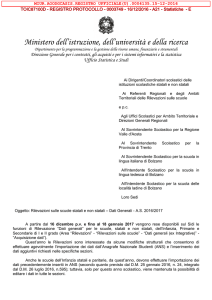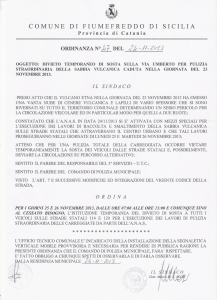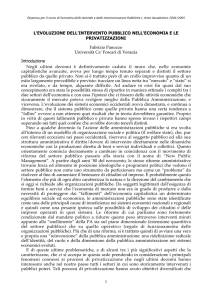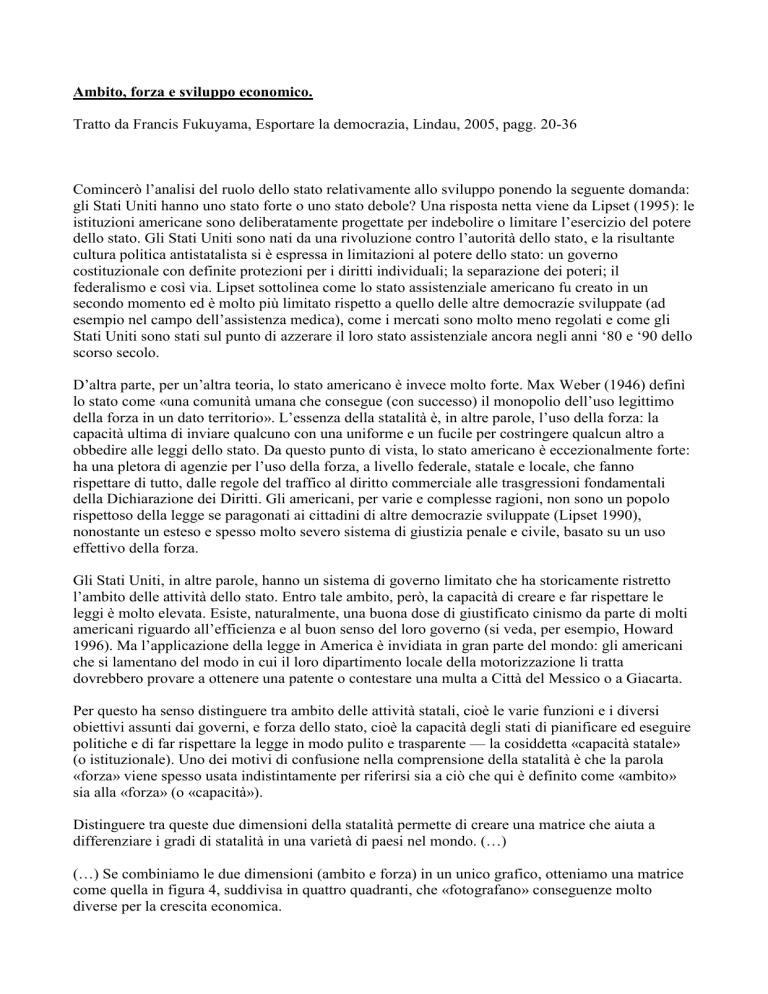
Ambito, forza e sviluppo economico.
Tratto da Francis Fukuyama, Esportare la democrazia, Lindau, 2005, pagg. 20-36
Comincerò l’analisi del ruolo dello stato relativamente allo sviluppo ponendo la seguente domanda:
gli Stati Uniti hanno uno stato forte o uno stato debole? Una risposta netta viene da Lipset (1995): le
istituzioni americane sono deliberatamente progettate per indebolire o limitare l’esercizio del potere
dello stato. Gli Stati Uniti sono nati da una rivoluzione contro l’autorità dello stato, e la risultante
cultura politica antistatalista si è espressa in limitazioni al potere dello stato: un governo
costituzionale con definite protezioni per i diritti individuali; la separazione dei poteri; il
federalismo e così via. Lipset sottolinea come lo stato assistenziale americano fu creato in un
secondo momento ed è molto più limitato rispetto a quello delle altre democrazie sviluppate (ad
esempio nel campo dell’assistenza medica), come i mercati sono molto meno regolati e come gli
Stati Uniti sono stati sul punto di azzerare il loro stato assistenziale ancora negli anni ‘80 e ‘90 dello
scorso secolo.
D’altra parte, per un’altra teoria, lo stato americano è invece molto forte. Max Weber (1946) definì
lo stato come «una comunità umana che consegue (con successo) il monopolio dell’uso legittimo
della forza in un dato territorio». L’essenza della statalità è, in altre parole, l’uso della forza: la
capacità ultima di inviare qualcuno con una uniforme e un fucile per costringere qualcun altro a
obbedire alle leggi dello stato. Da questo punto di vista, lo stato americano è eccezionalmente forte:
ha una pletora di agenzie per l’uso della forza, a livello federale, statale e locale, che fanno
rispettare di tutto, dalle regole del traffico al diritto commerciale alle trasgressioni fondamentali
della Dichiarazione dei Diritti. Gli americani, per varie e complesse ragioni, non sono un popolo
rispettoso della legge se paragonati ai cittadini di altre democrazie sviluppate (Lipset 1990),
nonostante un esteso e spesso molto severo sistema di giustizia penale e civile, basato su un uso
effettivo della forza.
Gli Stati Uniti, in altre parole, hanno un sistema di governo limitato che ha storicamente ristretto
l’ambito delle attività dello stato. Entro tale ambito, però, la capacità di creare e far rispettare le
leggi è molto elevata. Esiste, naturalmente, una buona dose di giustificato cinismo da parte di molti
americani riguardo all’efficienza e al buon senso del loro governo (si veda, per esempio, Howard
1996). Ma l’applicazione della legge in America è invidiata in gran parte del mondo: gli americani
che si lamentano del modo in cui il loro dipartimento locale della motorizzazione li tratta
dovrebbero provare a ottenere una patente o contestare una multa a Città del Messico o a Giacarta.
Per questo ha senso distinguere tra ambito delle attività statali, cioè le varie funzioni e i diversi
obiettivi assunti dai governi, e forza dello stato, cioè la capacità degli stati di pianificare ed eseguire
politiche e di far rispettare la legge in modo pulito e trasparente — la cosiddetta «capacità statale»
(o istituzionale). Uno dei motivi di confusione nella comprensione della statalità è che la parola
«forza» viene spesso usata indistintamente per riferirsi sia a ciò che qui è definito come «ambito»
sia alla «forza» (o «capacità»).
Distinguere tra queste due dimensioni della statalità permette di creare una matrice che aiuta a
differenziare i gradi di statalità in una varietà di paesi nel mondo. (…)
(…) Se combiniamo le due dimensioni (ambito e forza) in un unico grafico, otteniamo una matrice
come quella in figura 4, suddivisa in quattro quadranti, che «fotografano» conseguenze molto
diverse per la crescita economica.
Dal punto di vista di un economista, la posizione ottimale in cui stare è il quadrante I, che combina
un ambito limitato delle funzioni statali con una forte efficienza istituzionale. La crescita economica
cesserebbe, ovviamente, se lo stato si spostasse troppo vicino all’origine degli assi e non fosse più
in grado di espletare funzioni minime, quale la protezione dei diritti di proprietà, ma si presume che
la crescita cali a mano a mano che gli stati si spostano verso destra lungo l’asse X.
Il successo economico non è, naturalmente, l’unica ragione per preferire un dato ambito delle
funzioni statali; molti europei sostengono che l’efficienza dello stile americano viene ottenuta al
prezzo di sacrificare la giustizia sociale, e sono felici di stare nel quadrante II invece che nel
quadrante I. D’altra parte, il posto peggiore dove trovarsi in termini di performance economica è il
quadrante IV, dove uno stato inefficiente affronta un’ambiziosa serie di attività che non è in grado
di eseguire bene. Sfortunatamente questa è la posizione in cui si trovano diversi paesi in via di
sviluppo.
A scopo illustrativo ho posizionato alcuni paesi entro questa matrice (figura 5). Gli Stati Uniti, per
esempio, hanno uno stato meno invadente sia della Francia che del Giappone; non hanno neppure
tentato di gestire ampie transizioni settoriali attraverso l’allocazione del credito, come fece il
Giappone nella sua politica industriale degli anni ‘60 e ‘70, né possono vantare la burocrazia di
altissima qualità e livello che ha la Francia con le sue grandes écoles. D’altra parte, la qualità della
burocrazia americana è considerevolmente più efficiente di quella della maggior parte dei paesi in
via di sviluppo. La Turchia e il Brasile, per contrasto, hanno allocato grandi percentuali del loro PIL
nel settore pubblico, gestiscono industrie nazionalizzate e regolano e proteggono un vasto spettro di
attività economiche. (…)
(…) Dovrebbe inoltre essere chiaro che i paesi possono spostarsi nel tempo all’interno della
matrice. Uno dei suoi scopi è proprio la dimostrazione della natura dinamica dei cambiamenti della
statalità. L’ex Unione Sovietica è passata dall’essere uno stato con un ambito molto esteso (per
esempio senza proprietà privata), e con un grado modesto di forza nella capacità amministrativa, a
essere uno stato con un ambito di funzioni molto più ristretto e un grado di capacità statale
ugualmente diminuito. Lo stesso può essere detto del Giappone degli ultimi due decenni: ha fatto
tentativi timidi di liberalizzazione del mercato, privatizzando alcune aziende statali (in gran parte a
causa di pressioni internazionali), vedendo nel contempo la qualità delle sue tanto decantate
burocrazie (in particolare il ministero delle finanze) deteriorarsi o finire preda di interessi lobbistici.
Perciò, sia il Giappone che l’Unione Sovietica hanno visto i loro settori pubblici muoversi allo
stesso modo, in direzione «sud-ovest» tra il 1980 e il 2000, anche se ovviamente partivano da
posizioni molto diverse e si muovevano a velocità molto differenti (figura 6).
Questi casi contrastano fortemente con quello della Nuova Zelanda, che a metà degli anni ‘80 dello
scorso secolo ha dato inizio a una serie di riforme liberalizzatrici sotto la guida del Labour Party e
del suo ministro delle finanze, Roger Douglas. Fino a quell’epoca la Nuova Zelanda aveva
sviluppato uno degli stati assistenziali più estesi al mondo, ma stava chiaramente avviandosi verso
una crisi, con l’esplosione del debito pubblico e un costante peggioramento della bilancia dei
pagamenti. Le riforme, cominciate nel 1984, liberalizzarono il cambio della moneta nazionale, il
dollaro neozelandese; abolirono i controlli valutari, i sussidi agricoli e quelli ai consumatori, le
licenze d’importazione, gli incentivi alle esportazioni; cambiarono la struttura fiscale, sostituendo
un sistema basato sulle imposte dirette e indirette con un altro fondato sulla tassazione di consumi
dalla base d’imposta molto ampia; e privatizzarono le industrie statali (New Zealand State Service
Commission 1998). Tutte misure classiche in vista di una riduzione dell’ambito dello stato.
Tuttavia, con l’approvazione dello State Sector Act nel 1988, cominciò una seconda fase
riformatrice, che cercò di rafforzare la capacità amministrativa delle agenzie statali sopravvissute.
Tali riforme richiedevano ai dipartimenti di compilare rapporti finanziari mensili applicando gli
standard della contabilità commerciale, e li ponevano sotto la direzione di manager assunti con
contratti a termine che definivano le condizioni d’impiego, il risultato richiesto e aumentavano la
discrezionalità manageriale, e stabilivano un sistema di contabilità imperniato su accordi di tipo
contrattuale in ambito governativo (Schìck 1996; Boston et al. 1996). Così la Nuova Zelanda, alla
metà degli anni ‘90, ha cominciato a muoversi in direzione «nord-ovest». (…)
(…) Ci vollero la crisi dell’economia asiatica del 1997-98 e i problemi Incontrati dalla Russia e
dagli altri paesi post-comunisti perché la riflessione su questi temi cominciasse a cambiare. Le crisi
finanziarie vissute dalla Thailandia e dalla Corea del Sud erano entrambe direttamente collegate alla
prematura liberalizzazione dei capitali non sostenuta da un’adeguata istituzione regolatrice che
potesse supervisionare i settori bancari nazionali, improvvisamente inondati da enormi quantità di
capitali stranieri a breve termine. (Lanyi e Lee, 1999; Haggard 2000). Ex post risulta evidente che
in simili circostanze una liberalizzazione non controllata può essere più pericolosa che non una
mancata liberalizzazione. La Corea del Sud, per esempio, aprì ai capitali stranieri il proprio mercato
obbligazionario, condizione per poter entrare nell’OCSE, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico, ma non fece altrettanto per il mercato azionario e non acconsentì a maggiori
investimenti stranieri diretti. Il risultato fu che gli investitori internazionali, interessati a una fetta
del miracolo economico coreano, misero il loro denaro in conti a breve termine, che potevano
essere chiusi al minimo accenno di guai. Quando la bilancia commerciale cominciò a peggiorare,
nel 1996-97, la divisa nazionale, il won, fu sottoposta a una pressione insostenibile mentre i capitali
esteri venivano ritirati. Tale situazione pose le basi per la crisi economica della fine del 1997.
Il problema in Russia e negli altri paesi post-comunisti fu alquanto diverso. La privatizzazione delle
industrie di stato è naturalmente un obiettivo appropriato per una riforma economica, ma richiede
un grado elevato di capacità istituzionale per essere condotta efficacemente. La privatizzazione crea
inevitabilmente enormi asimmetrie di informazione, ed è compito del governo correggerle. I beni e i
diritti di proprietà devono essere correttamente identificati, valutati e trasferiti in modo trasparente; i
diritti dei nuovi azionisti di minoranza devono essere tutelati per prevenire abusi quali lo
«spacchettamento» delle immobilizzazioni di un’azienda rilevata per fini di lucro speculativo, lo
svuotamento endogeno dell’azienda, e altri. Perciò la privatizzazione si risolve in una riduzione
dell’ambito delle funzioni statali e richiede mercati funzionanti e un alto grado di capacità statale.
Tale capacità non esisteva in Russia, e il risultato fu che buona parte dei beni privatizzati non
finirono nelle mani di imprenditori che avrebbero potuto renderli produttivi. Il furto di risorse
pubbliche da parte dei cosiddetti oligarchi contribuì pesantemente a delegittimare lo stato russo
postcomunista.
Il nuovo riconoscimento della priorità della forza sull’ambito si riflette in un commento di Milton
Friedman, decano degli economisti liberisti ortodossi, nel 2001. Egli disse che un decennio prima
avrebbe avuto tre sole parole per i paesi che dovevano compiere la transizione dal socialismo:
«Privatizzare, privatizzare, privatizzare». «Ma mi sbagliavo » proseguì, «il rispetto della legge è
probabilmente più necessario della privatizzazione» (intervista con Milton Friedman, Gwartney e
Lawson 2002).