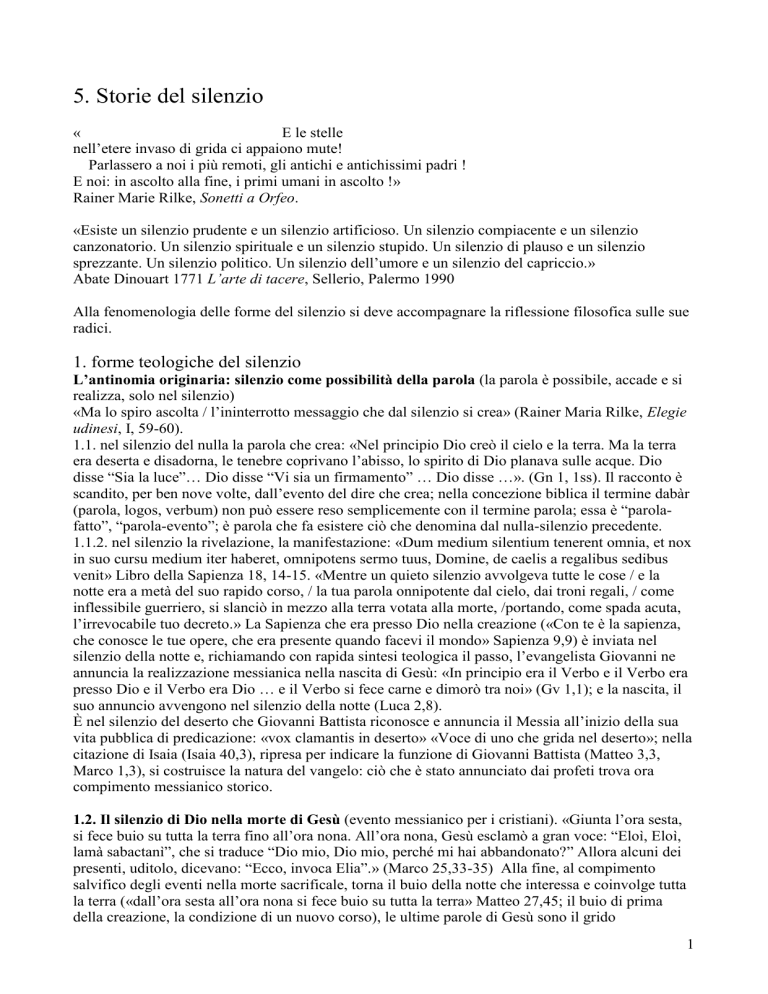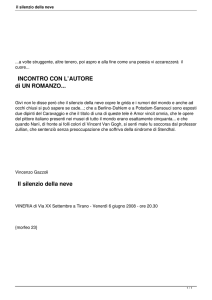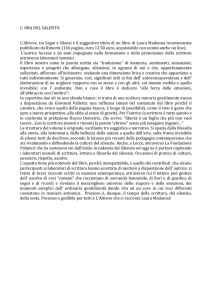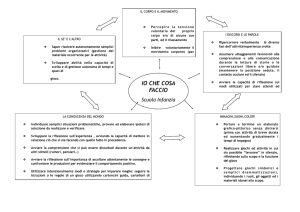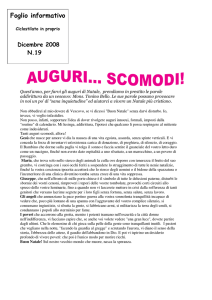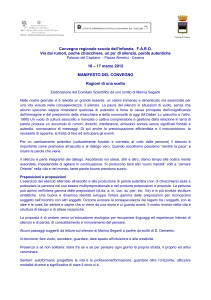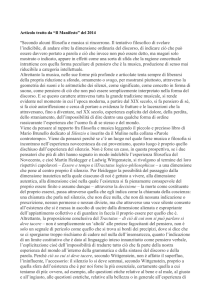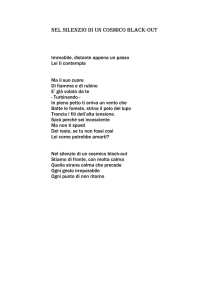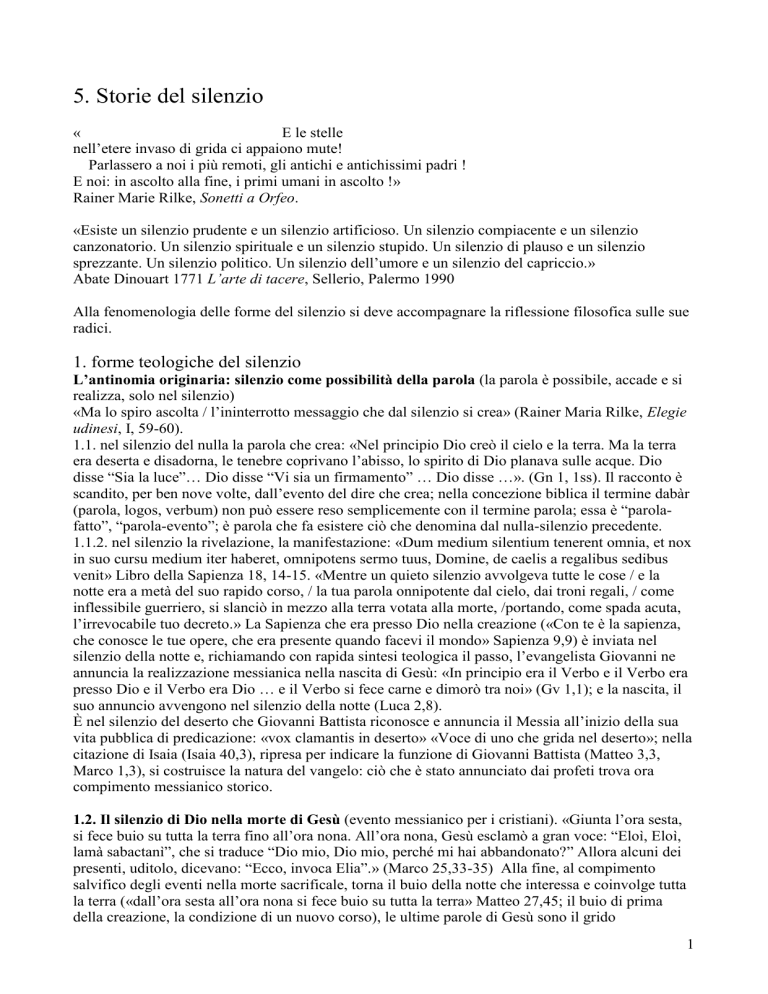
5. Storie del silenzio
«
E le stelle
nell’etere invaso di grida ci appaiono mute!
Parlassero a noi i più remoti, gli antichi e antichissimi padri !
E noi: in ascolto alla fine, i primi umani in ascolto !»
Rainer Marie Rilke, Sonetti a Orfeo.
«Esiste un silenzio prudente e un silenzio artificioso. Un silenzio compiacente e un silenzio
canzonatorio. Un silenzio spirituale e un silenzio stupido. Un silenzio di plauso e un silenzio
sprezzante. Un silenzio politico. Un silenzio dell’umore e un silenzio del capriccio.»
Abate Dinouart 1771 L’arte di tacere, Sellerio, Palermo 1990
Alla fenomenologia delle forme del silenzio si deve accompagnare la riflessione filosofica sulle sue
radici.
1. forme teologiche del silenzio
L’antinomia originaria: silenzio come possibilità della parola (la parola è possibile, accade e si
realizza, solo nel silenzio)
«Ma lo spiro ascolta / l’ininterrotto messaggio che dal silenzio si crea» (Rainer Maria Rilke, Elegie
udinesi, I, 59-60).
1.1. nel silenzio del nulla la parola che crea: «Nel principio Dio creò il cielo e la terra. Ma la terra
era deserta e disadorna, le tenebre coprivano l’abisso, lo spirito di Dio planava sulle acque. Dio
disse “Sia la luce”… Dio disse “Vi sia un firmamento” … Dio disse …». (Gn 1, 1ss). Il racconto è
scandito, per ben nove volte, dall’evento del dire che crea; nella concezione biblica il termine dabàr
(parola, logos, verbum) non può essere reso semplicemente con il termine parola; essa è “parolafatto”, “parola-evento”; è parola che fa esistere ciò che denomina dal nulla-silenzio precedente.
1.1.2. nel silenzio la rivelazione, la manifestazione: «Dum medium silentium tenerent omnia, et nox
in suo cursu medium iter haberet, omnipotens sermo tuus, Domine, de caelis a regalibus sedibus
venit» Libro della Sapienza 18, 14-15. «Mentre un quieto silenzio avvolgeva tutte le cose / e la
notte era a metà del suo rapido corso, / la tua parola onnipotente dal cielo, dai troni regali, / come
inflessibile guerriero, si slanciò in mezzo alla terra votata alla morte, /portando, come spada acuta,
l’irrevocabile tuo decreto.» La Sapienza che era presso Dio nella creazione («Con te è la sapienza,
che conosce le tue opere, che era presente quando facevi il mondo» Sapienza 9,9) è inviata nel
silenzio della notte e, richiamando con rapida sintesi teologica il passo, l’evangelista Giovanni ne
annuncia la realizzazione messianica nella nascita di Gesù: «In principio era il Verbo e il Verbo era
presso Dio e il Verbo era Dio … e il Verbo si fece carne e dimorò tra noi» (Gv 1,1); e la nascita, il
suo annuncio avvengono nel silenzio della notte (Luca 2,8).
È nel silenzio del deserto che Giovanni Battista riconosce e annuncia il Messia all’inizio della sua
vita pubblica di predicazione: «vox clamantis in deserto» «Voce di uno che grida nel deserto»; nella
citazione di Isaia (Isaia 40,3), ripresa per indicare la funzione di Giovanni Battista (Matteo 3,3,
Marco 1,3), si costruisce la natura del vangelo: ciò che è stato annunciato dai profeti trova ora
compimento messianico storico.
1.2. Il silenzio di Dio nella morte di Gesù (evento messianico per i cristiani). «Giunta l’ora sesta,
si fece buio su tutta la terra fino all’ora nona. All’ora nona, Gesù esclamò a gran voce: “Eloì, Eloì,
lamà sabactanì”, che si traduce “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” Allora alcuni dei
presenti, uditolo, dicevano: “Ecco, invoca Elia”.» (Marco 25,33-35) Alla fine, al compimento
salvifico degli eventi nella morte sacrificale, torna il buio della notte che interessa e coinvolge tutta
la terra («dall’ora sesta all’ora nona si fece buio su tutta la terra» Matteo 27,45; il buio di prima
della creazione, la condizione di un nuovo corso), le ultime parole di Gesù sono il grido
1
dell’abbandono a realizzare il compiersi completarsi del “mistero” (disegno, storia) della salvezza.
Il grido ultimo (di sanzionamento profetico) di Gesù è accompagnato dalla scontata ironia dei
presenti che parafrasando affermano «Ecco, invoca Elia…»; ma si tratta di un passaggio biblico e
teologico; la citazione di Elia non è affatto casuale, secondo la scrittura Elia non è morto, ma rapito
al cielo…(2 Re 2,1-15). Il grido che annuncia l’abbandono di Dio è qui rimarcato dal silenzio dei
profeti, dal silenzio del profeta per antonomasia, Elia, considerato precursore del Messia; di lui
Gesù stesso aveva annunciato il ritorno [Mt 11,14; 17, 10-13], e proprio lui era presente nella
trasfigurazione di Gesù [Mt 17,3-8]).
1.3. Il silenzio di Dio: la fine della rivelazione. In un arco di tempo storico piuttosto ristretto (tra
in IV e il VII secolo d.C.) le religioni del mediterraneo codificano per tradizione e prassi (poi per
norma) i propri testi sacri, i libri canonici (il proprio canone) e annunciano contemporaneamente il
silenzio di Dio: la rivelazione di Dio è terminata, Dio è nel silenzio. È il dato che emerge con forza
e potenza dogmatica concordemente nelle tre religioni rivelate del mediterraneo (ebraismo,
cristianesimo, islamismo) che definiscono il proprio canone dei libri della rivelazione e dichiarano
chiusa la rivelazione, consegnata ai testi sacri; non c’è più alcuna parola di Dio al di fuori di quei
libri, canonici e sacri; quelle religioni vivono nella fede della parola già pronunciata. Il silenzio di
Dio è il punto centrale della fede delle tre religioni rivelate. Il mondo è dunque senza profeti (coloro
che parlano al posto di Dio, riportandone la parola).
1.3.1 Il silenzio di Dio è tuttavia anche (almeno nella religione cristiana) dono dello spirito e
compito evangelico. La parola passa all’uomo come compito di vangelo, di annuncio, di
interpretazione e commento, senza però che mai il suo dire possa essere assistito e sostenuto dalla
affermazione che la sua parola sia quella di Dio. La religione è allora il lungo sforzo ermeneutico
della fede come espressione della speranza presente nell’attesa dello svelarsi finale (escatologico)
del pieno senso della parola di Dio da parte di Dio stesso. In questa attesa la parola dell’uomo cade
nel silenzio di Dio e deve annoverare tra i suoi tratti, oltre alla fedeltà dell’ascolto e della missione
di annuncio (di vangelo), la certezza dell’incompletezza e la possibilità dell’errore.
Il silenzio di Dio, poiché la rivelazione è terminata, in quanto fede centrale delle religioni “del
libro”, è anche fondamento interno alle religioni molto potente per sostenere e imporre un doppio
dialogo: tra le religioni, delle religioni con il mondo ateo e secolarizzato. Il silenzio di Dio infatti si
traduce in una consegna etica senza precedenti: l’assunzione della responsabilità da parte dell’uomo
nei confronti dell’uomo stesso, dell’universo, della storia (Bonhoeffer, Jonas).
1.4. Il silenzio degli oracoli. Quasi contemporaneamente alle evoluzioni in atto nelle “religioni
rivelate”, nella cultura greca, nel lungo periodo indicato come ellenismo, prende corpo
l’affermazione e la convinzione del silenzio degli oracoli. Il mondo divino delineato dalla cultura
greca è fitto di mediazioni e di figure intermedie tra il divino e l’umano. La distanza tra i due mondi
non è tuttavia colmata; essa risalta con clamore proprio negli oracoli divini. Prefigurano scenari
spesso tragici e solo con difficoltà condivisibili. Risultano oscuri e solo l’arte degli indovini è in
grado di svelarne il senso e l’inesorabile realizzazione. Sono formulati da profeti e profetesse in
forma volutamente ambigua. Già nel cuore dell’età classica e in modo esplicito nel periodo
ellenistico poeti e indovine ne segnalano il silenzio: gli oracoli sono muti.
1.4.1. consulto e salotto “divino” in camera da letto alla ricerca di un oracolo e di uno stratagemma:
«Gli eroi se ne stavano, così, nascosti nel fitto canneto, senza che alcuno si accorgesse di loro; li
videro Era e Atena, e subito, lasciata la compagnia di Zeus e degli altri dèi immortali, si recarono
nella camera da letto per prendere una decisione. Fu prima Era a saggiare le intenzioni di Atena:
«Comincia tu, figlia di Zeus, a dare un consiglio! Che si deve fare? Sei capace di escogitare
un’astuzia per cui essi riescano a prendere e a portar via nell’Ellade il vello d’oro di Eeta? o forse
esortandolo con parole cortesi potrebbero convincerlo? Certo, quello è estremamente orgoglioso e
arrogante: tuttavia, nessun mezzo conviene lasciare intentato». Così disse, e subito le rispose Atena:
«Anch’io, o Era, pensavo e ripensavo dentro di me a ciò che tu con franchezza mi chiedi! Ma non
2
riesco ancora a concepire un piano tale che possa essere utile agli eroi; eppure di piani ne ho passati
tanti in rassegna!» Tenevano gli occhi fissi dinanzi ai piedi, abbandonandosi ciascuna a vari
pensieri.»
Si tratta della scena che apre il terzo libro delle Argonautiche, di Apollonio Rodio (composto
intorno al 243 a.C.), libro interamente dedicato alla figura di Medea. La mitologia si fa salotto; di
divino la scena conserva solo la presenza delle protagoniste, le dee dell’Olimpo omerico, ma tutto
trasuda di salotto borghese di una Alessandria che si sente ormai metropoli del regno ellenistico. Ai
simposi olimpici della tradizione omerica, epici e drammatici ma immediati e decisivi nelle scelte
che definivano il corso degli eventi, succedono, come nella ripresa di un secondo tempo, divinità (le
stesse) in affanno e fortemente disorientate nello svolgere il tradizionale compito divino di
interferenza nell’umano; l’aura mitica è scomparsa, tutto sembra profondamente umano, la
conversazione si interrompe in un pensoso silenzio: «Tenevano gli occhi fissi dinanzi ai piedi,
abbandonandosi ciascuna a vari pensieri.» [come nella recente commedia teatro, libro e film di
Cristina Comencini, Due partite, 2009]
1.4.2. il tramonto e il silenzio degli oracoli. «la Pizia… ricevendo il pnéuma pronuncia oracoli in
versi e in prosa» (Strabone) Anche quando parlavano la loro oscurità e la loro contraddizione
voluta portavano a rasentare l’assenza di messaggio. Il tema del loro progressivo silenzio fino alla
condivisa percezione del loro estinguersi compare con forza nelle riflessioni di Plutarco (46-120)
che, nei suoi ultimi trent’anni (circa) svolse proprio il compito di sacerdote presso il santuario di
Apollo a Delfi. La raccolta di opuscoli intitolati Moralia comprende anche i suoi Dialoghi delfici
come De Ε [epsilon) apud Delphos, De Pythiae oraculis, De defectu oraculorum. Quest’ultimo, Il
tramonto degli oracoli, è un dialogo che affronta appunto il tema della progressiva estinzione degli
oracoli avanzando ipotesi sulla causa del loro tramontare. Tra queste, uno degli interlocutori
suggerisce che a reggere gli oracoli non siano gli dei ma i demoni, intermediari tra uomini e dei; ora
si è in un momento della speculazione umana in cui gli dei da una parte ascendono sempre più in
alto a fondersi in un’unica divinità, sempre più remota e trascendente, dall’altra discendono a
dèmoni, sempre più comuni e popolari, paurosamente richiamati in pratiche di superstizione.
L’impressione di Plutarco è che l’oracolo delfico senta “il disgusto delle domande volgari che
salgono al tripode e avviliscono la gloria di 3000 anni: ‘sposarsi, navigare, mercanteggiare!’» (V.
Cilento, Plutarco. Diatriba iliaca e Dialoghi delfici, Sansoni, Firenze 1967). E, ancora nel De
defectu oraculorum, Plutarco racconta di una Pizia del tempo che, costretta a pronunciare oracoli,
sarebbe rimasta vittima di «uno spirito muto e maligno». La constatazione del tramonto degli
oracoli si accompagna dunque alla denuncia di un uso superstizioso della religione, ma anche alla
ipotesi di una diversa sede dei demoni. Il tema è antico. Già nelle affermazioni di Socrate, e quindi
almeno nei circoli filosofici, i demoni si sono trasferiti nel soggetto e diventano il segreto destino e
la segreta forza, talora la felicità (eudaimonia) dell’uomo. «C'è dentro di me non so che spirito
divino e demoniaco; quello appunto di cui anche Meleto, scherzandoci sopra, scrisse nell'atto di
accusa. Ed è come una voce che io ho dentro sin da fanciullo; la quale, ogni volta che mi si fa
sentire, sempre mi dissuade da qualcosa che sto per compiere, e non mi fa mai proposte.» Apologia
di Socrate (31 d) In questa sede umana e interiore i demoni restano per secoli, sia quando ne viene
stravolta la natura ad opera di religiosi esorcisti e satanisti (ancora moltitudine) che si occupano di
presunti indemoniati e della loro criminale eliminazione, sia quando, con intenti terapeutici i
demoni riemergono alla coscienza come nelle tesi della psicanalisi di Jung.
Il dialogo di Plutarco, nel racconto di un interlocutore, contiene, come suo vertice, la notizia
sconcertante e drammatica della morte del dio Pan. «Su la morte dei dèmoni ho udito un racconto
da uno, che non era né uno sciocco né un ciarlatano. Epiterse, padre del retore Emiliano – le cui
lezioni taluni di voi hanno udito - è mio concittadino e maestro di grammatica. Ecco quanto mi
raccontò: navigava egli una volta verso l’Italia, su un naviglio che trasportava mercanzie e una folla
di passeggeri. A sera, già presso le isole Echinadi, il vento cadde repente, e la nave fu portata dai
flutti nelle vicinanze di Paxo. I più erano desti; e molti continuavano a bere, dopo aver pranzato.
D’improvviso, dall’isola di Paxo fu udita una voce, o meglio un grido, che chiamava Tamo. Erano
3
tutti stupiti. Tamo era il nostro pilota egizio e molti, a bordo, non ne sapevano neppure il nome. Per
ben due volte chiamato, egli tacque; poi, alla terza volta, rispose a colui che lo chiamava. E questi
con tono ancora più alto disse: ‘Allorché giungi nei pressi di Palode, annuncia che Pan, il grande, è
morto’. A tali parole, continuava Epiterse, furono tutti atterriti. E si consultavano a vicenda: se fosse
meglio eseguire il mandato oppure non impicciarsene e lasciar andare.» (Plutarco, Moralia. Sul
tramonto degli oracoli, 17)
Commenta V. Cilento (o.c.) riprendendo il tema generale del silenzio degli oracoli: « Poi la voce
oracolare tacque. Non solo la Beozia, ma tutta la Grecia — risonante per secoli di molteplici voci
divine: arte, poesia, pensiero, responsi di numi — ammutolì per sempre. È un’epoca stanca. … di
tutta l’opera religiosa plutarchea, la morte di Pan batte la nota fondamentale cupa come una marcia
funebre.»
1.4.3. In forma provocatoria e ironica da Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) riprende il tema del
tramonto e silenzio degli oracoli nell’opera La Pizia. «Stizzita per la scemenza dei suoi stessi
oracoli e per l’ingenua credulità dei Greci, la sacerdotessa di Delfi Pannychis XI, lunga e secca
come quasi tutte le Pizie che l’avevano preceduta, ascoltò le domande del giovane Edipo, un altro
che voleva sapere se i suoi genitori erano davvero i suoi genitori, come se fosse facile stabilire una
cosa del genere nei circoli aristocratici, dove, senza scherzi, donne maritate davano a intendere ai
loro consorti, i quali peraltro finivano per crederci, come qualmente Zeus in persona si fosse
giaciuto con loro. Vero è che in simili casi, essendo comunque dubitosi coloro che venivano a
consultarla, la Pizia soleva rispondere con un semplice: sì e no, dipende...; quel giorno però l’intera
faccenda le parve di un’idiozia veramente intollerabile, forse soltanto perché quando il pallido
giovanotto arrivò claudicando al santuario erano ormai le cinque passate, invece di starlo a sentire
Pannychis avrebbe dovuto chiudere, e allora, vuoi per guarirlo dalla fede incondizionata nelle
sentenze degli oracoli, vuoi perché essendo così di cattivo umore le saltò il ghiribizzo di fare
arrabbiare quel principe di Corinto dall’aria altezzosa, la Pizia gli fece una profezia che più
insensata e inverosimile non avrebbe potuto essere, la quale, pensò, non si sarebbe certamente mai
avverata, perché nessuno al mondo può ammazzare il proprio padre e andare a letto con la propria
madre, senza contare che per lei tutte quelle storie di accoppiamenti incestuosi fra dèi e semidei
altro non erano che insulse leggende. Va detto però che un leggero disagio la colse nel momento in
cui, udite le parole dell’oracolo, quel tipo maldestro di un principe di Corinto sbiancò in volto; la
Pizia lo notò pur assisa sul tripode e avvolta com’era da una nuvola di vapori, e pensò che dovesse
trattarsi di un credulone straordinario.» (Dürrenmatt Friedrich La Pizia, Marcos y Marcos, Milano
1996, p. 9-10)
1.4.4. In forma filosofica e di teoria generale: la tesi di Epicuro e della sua filosofia.
«Il supremo perturbamento sorge negli uomini, primieramente ove si creda che tali nature siano
beate ed immortali, e che pur abbiano volontà ed opere e cause che contraddicano a questi attributi
loro… Non è irreligioso chi gli dei del volgo rinnega, ma chi le opinioni del volgo applica agli dei.»
(Epicuro 341-271, Lettera a Erodoto, a Meneceo)
«Ogni natura divina ... deve godere di per sé in imperturbabile pace una vita immortale, appartata
dalle nostre vicende e del tutto remota. Infatti, esente da ogni dolore, immune da pericoli, potente
delle sue proprie forze, per nulla bisognosa di noi, non è conquistata dai meriti, né l’ira la sfiora.”
(Lucrezio Caro 98-54, La natura delle cose, Rizzoli, Milano 1994 pp. 73 -75)
1.5. il silenzio di Dio ad Auschwitz… di fronte alla morte del suo popolo.
1.5.1. il Dio assente: «La morte di mio padre. L’anniversario della morte di un certo Shlomo ben
Nissel cade il diciottesimo giorno del mese di Shevat. Era mio padre, il giorno è domani e, come
ogni anno, non so come pormi di fronte a questo avvenimento. Eppure nello Shulchan Aruch, il
grande libro di precetti di Rabbì Joseph Caro, lo straordinario legislatore-visionario del sedicesimo
secolo, ci sono regole precise e rigorose su quest’argomento. Potrei e dovrei semplicemente
conformarmi ad esse. Ubbidire alla tradizione. Seguirne le orme. Fare ciò che in un giorno come
questo fanno tutti: recarmi per tre volte alla sinagoga, celebrare la funzione, studiare un capitolo
4
della Mishnàh, recitare il Kaddìsh dell’orfano e, in presenza della comunità vivente di Israele,
proclamare la santità e la grandezza del Signore, perché le sue vie sono tortuose ma giuste, la sua
grazia dura da sopportare ma indispensabile, sia sulla terra che in cielo, oggi e sempre. Che sia fatta
la sua volontà, e così sia.
Questo è indubbiamente ciò che farei se mio padre fosse morto di vecchiaia, di malattia o anche di
disperazione. Ma le cose non stanno così. Neppure la sua morte gli appartiene. Non so a quale causa
attribuirla, in quale libro iscriverla. Non c’è nessun legame fra essa e l’esistenza che ha condotto. La
sua morte, perduta fra tutte le altre, non ebbe nulla a che fare con la persona che egli era stato. Con
altrettanta facilità avrebbe potuto semplicemente sfiorarlo e risparmiarlo. Lo ha colto
inavvertitamente, distrattamente. Per sbaglio. Senza sapere che si trattava di lui. È stato derubato
della sua morte.
Disteso su un tavolaccio in mezzo a una moltitudine di cadaveri coperti di sangue, gli occhi sbarrati
dalla paura, una maschera di sofferenza sopra la maschera barbuta e sconvolta del suo volto, così
mio padre esalò l’anima a Buchenwald. Un’anima inutile in quel luogo, e che egli sembrava aver
voluto rimandare in cielo. Ma non la restituì al Dio dei suoi padri, ma piuttosto all’impostore,
crudele e insaziabile, al Dio nemico. Gli avevano ucciso il suo Dio, glielo avevano cambiato.»
Wiesel Elie 1966 L’ebreo errante, Giuntina, Firenze 1991 (pp. 7-8)
1.5.2. il Dio non onnipotente: «Qualunque sia stata la condizione iniziale e originaria della divinità,
essa cessò di essere chiusa in se stessa nel momento in cui si mise in relazione con l’esserci di un
mondo, o creandolo o permettendone l’origine. … Egli è perciò un Dio in costante situazione di
pericolo, un Dio che rischia in proprio. […] Dopo Auschwitz possiamo e dobbiamo affermare con
estrema decisione che una Divinità onnipotente o è priva di bontà o è totalmente incomprensibile
(nel governo del mondo in cui noi unicamente siamo in condizione di comprenderla). Ma se Dio
può essere compreso solo in un certo modo e in un certo grado, allora la sua bontà (cui non
possiamo rinunciare) non deve escludere l’esistenza del male; e il male c’è solo in quanto Dio non è
onnipotente. Solo a questa condizione possiamo affermare che Dio è comprensibile e buono e che
nonostante ciò nel mondo c’è il male. E poiché abbiamo concluso che il concetto di onnipotenza è
in ogni caso un concetto in sé problematico, questo è l’attributo divino che deve venir abbandonato.
Fino ad oggi l’argomento invocato a favore della onnipotenza si è limitato ad affermare, in accordo
con la teologia di origine ebraica, il principio fondamentale secondo cui la potenza di Dio ha il suo
limite in qualcosa, la cui esistenza in virtù di un diritto che le è proprio e di un potere di agire per
autorità propria — egli riconosce. Tale riconoscimento viene interpretato come una concessione da
parte di Dio, che può essere revocata in ogni momento, come se Dio trattenesse in sé un potere
integro che ha esercitato in modo parziale a vantaggio della creazione e del diritto proprio di
quest’ultima. Tuttavia questo non può bastare, poiché di fronte alle cose veramente inaudite che, nel
creato, alcune creature, fatte a sua somiglianza, hanno fatto ad altre creature innocenti, ci si
dovrebbe aspettare che il Dio, somma bontà, venga meno alla regola che si è imposto di trattenere
in sé la propria potenza e intervenga con un miracolo di salvezza. Ma questo miracolo non c’è stato:
durante gli anni in cui si scatenò la furia di Auschwitz Dio restò muto. I miracoli che accaddero
furono unicamente opera di uomini: le azioni di quei giusti, appartenenti ad altri popoli che, in
modo isolato e sovente sconosciuto, accettarono l’estremo sacrificio per salvare, alleviare, se non
erano in grado di far altro, condividere la sorte di Israele. Anche di costoro parlerò. Ma Dio tacque.
Ed ora aggiungo: non intervenne, non perché non lo volle, ma perché non fu in condizione di farlo.
Per ragioni che in modo decisivo derivano dall’esperienza contemporanea, propongo quindi l’idea
di un Dio che per un’epoca determinata — l’epoca del processo cosmico — ha abdicato ad ogni
potere di intervento nel corso fisico del mondo; un Dio che nell’urto con gli eventi mondani rivolti
contro di lui, non ha reagito “con la mano forte e con il braccio teso” come noi ebrei recitiamo ogni
anno ricordando l’esodo dall’Egitto — bensì continuando con muta perseveranza la realizzazione
del suo fine incompiuto.» Jonas Hans 1984 Il concetto di Dio dopo Auschwitz, il melangolo,
Genova 2000, pp.30-35 (passim)
5
Un Dio assente alla propria onnipotenza è privato di una caratteristica considerata, dal pensiero
religioso teologico e comune, fondamentale per la nozione stessa del divino. Negare l’onnipotenza
di Dio, per coerenza e rispetto dello stesso Dio di fronte agli eventi drammatici del secolo scorso e
del secolo presente, significa abbandonare il concetto religioso del divino. Il compito che si impone
(posto con chiarezza e drammaticità da Dietrich Bonhoeffer) è quello di ripensare radicalmente il
concetto di Dio e questo sforzo, in apparenza paradossale, porta a pensare Dio di nuovo in termini
biblici, non religiosi, di fronte ad una religione ormai totalmente secolarizzata e di fronte ad un
mondo che avverte le incoerenze della religione e della teologia.
[vedi Giorello Giulio 2010 Senza Dio. Del buon uso dell’ateismo, Longanesi, Milano: il rifiuto di
ogni sottomissione]
1.5.3. Il silenzio di Dio, la scoperta del vuoto allo squarciarsi del velo del tempio, il tema
dell’abbandono di Dio, il suo svelarsi come mistero, come ri-velarsi … possono, in modo
sorprendente, essere interpretati come una conseguenza coerente con il concetto antropologico di
“Padre” applicato a Dio nella bibbia cristiana, e con la consapevolezza secolarizzata dell’uomo
diventato adulto. Un’interpretazione che apre la strada a teologie lontane da visioni miracolistiche
di un divino legato all’onnipotenza. « Il vuoto di cui parla, che si nasconde sotto le cose, è la
scoperta con cui termina l’infanzia: nessuno ha una risposta definitiva per le domande che contano;
nessuno è depositano del “vero” senso per cui tutto accade; i nostri genitori sono nostri compagni
nel tentativo incessante di attribuire un senso a quel che accade; vale per loro quanto per noi che il
tentativo equivale a gettare risorse ed energie nel pozzo “senza fondo” della richiesta di una
giustificazione.» Bencivenga Ermanno 2010 La filosofia come strumento di liberazione, Raffaello
Cortina Editore, Milano p. 95
1.5.4. Il dio dell’abbandono essenza dell’ebraismo. «Cercherò di dire, in modo molto elementare,
quel che mi sembra almeno uno dei punti essenziali: la rinuncia alla protezione; e per protezione
intendo tutto ciò che tiene lontano dalla nostra esistenza le immagini non misurabili: i sogni, le
caverne oscure cui la nostra anima accede e dove dimorano gli dèi, la solitudine non terrestre ma
universale, la violenza dei simboli che ci aggrediscono e ci sorprendono, la notturna altezza del
mistero, il non sapere che cosa significa questa serie di eventi disordinati che chiamiamo «vita», e
che non ha quiete e senso se non appunto nell’incontro col terribile, con l’altrove; forse quest’ultima
parola tocca da vicino il tema di cui è impossibile parlare se non con tremore e angoscia;
l’occidentale ha il terrore dell’altrove, odia l’altrove, e tuttavia sa nelle sue viscere geroglifiche che
solo l’altrove custodisce il suo significato. Ora, l’ebreo è sempre stato l’uomo dell’altrove, e in
questo senso è stato lo scandalo, giacché egli era ciò appunto che all’occidentale si chiede di essere,
e che l’occidentale rifiuta di essere.» Manganelli Giorgio 2007 Mammifero italiano, Adelphi,
Milano p. 44
1.5.5. il silenzio di Dio in Israele: l’ebraismo che è uscito dalla relazione religiosa della promessa.
La promessa fondativa dell’ebraismo è quella che Dio ha fatto ad Abramo; essa costituisce un
paradigma che struttura l’intera sua storia di ascolto e di attesa e di fiducia: stare nella promessa
diventa la cultura religiosa di Israele. Nello Stato di Israele, interpretato come ritorno alla terra
promessa, la promessa è tradita in una realizzazione unilateralmente politica, frutto per lo più di
equilibrismi internazionali, sull’onda di una civiltà europea che non riesce a fare i conti con il
proprio abisso etico di violenza, sopraffazione, ingiustizia e crudeltà. Non più religiosa, sottratta
all’iniziativa di Dio, la vicenda decreta accanto al silenzio di Dio, la fine dell’attesa messianica.
2. Forme cosmiche/cosmologiche del silenzio
2.1 Pitagora: la musica delle sfere celesti è il nostro silenzio; diventata il nostro contesto e le
nostre abitudini non è più avvertita e pensiamo che non ci sia … ma dove c’è movimento e numero
c’è armonia e musica. Quella musica cosmica, primordiale e dunque perenne, ha l’effetto di creare
su di noi il silenzio proteggendoci dal rumore della realtà; allo stesso modo in cui la musica, forma
suprema di arte, secondo Schopenhauer (che riprende motivi pitagorici), trasforma in dolce melodia
6
il dolore e il rumore del mondo, imponendo il silenzio alla insensata sofferenza dell’universo; il
rumore della vita, si può dire, corrisponde al suono della musica.
«C’è infatti chi crede che, movendosi corpi così grandi, ne nasca un suono, perché suono è prodotto
dal movimento dei corpi che sono quaggiù, i quali pure sono meno grandi e meno veloci di quelli.
Non può, dicono, non nascere un suono straordinariamente grande dal movimento del sole e della
luna e degli astri, che sono tanti e tanto grandi e procedono con tanta velocità. Così essi credono, e
che i rapporti delle velocità degli astri in relazione alle distanze siano i medesimi degli accordi
musicali; e perciò dicono che è armonico il suono degli astri rotanti. Poi, a giustificare il fatto che
questo suono noi non lo udiamo, dicono che la causa sta in ciò, che esso c’è sempre dal nostro
nascere; manca per questo, dicono, ogni contrasto col silenzio, e quindi non possiamo distinguerlo,
ché suono e silenzio si discernono appunto perché sono in contrasto. Insomma accade, per tal
suono, agli uomini quello che accade ai fabbri, che, per l’abitudine fatta al rumore, non lo
distinguono più.» Aristotele, De coelo B 9. 290b12 (I presocratici I, p. 527)
Una teoria del silenzio-musica, armonia dell’universo, che ha un esito sistematico totale. «Pitagora
fu il primo a chiamare cosmo la sfera delle cose tutte, per l’ordine che esiste in esso.» (Aetius, in
Presocratici I, p.131). Pitagora può costituire simbolicamente l’inizio di una concezione filosofica
“metafisica”, in grado cioè di cogliere l’ordine immanente del mondo, della realtà in sé, il “cosmo”
(il disegno e l’ordine) posto come legge e struttura oltre i dati sensibili e oltre l’esperienza
soggettiva di chi percepisce.
2.1.1. per riprendere il tema del suono del silenzio: «Il silenzio, insomma, è un suono e non può che
essere così perché noi non possiamo non sentire qualcosa, anche se ci turiamo le orecchie o se ci
immergiamo in un liquido che ci avvolge. In questi casi passiamo ad ascoltare il suono interno, il
battito del cuore e la pulsazione alle tempie e il respiro e ogni altro rumore che dall’interno il nostro
corpo ci invia. Il silenzio è un suono, ma può anche essere una produzione di suono. Il pulsare del
sangue nelle nostre tempie. Il suono dei nostri passi sul selciato. C’è una connessione forte tra
tempie e tempo e una volta si misurava il battito cardiaco sulle tempie. In molte culture il silenzio è
una costruzione assidua. Si “fa” silenzio. Lo sanno bene i maestri orientali che insegnano a ripetere
l’Om primordiale, il suono dello scorrere e della vita, lo sanno bene i mistici dell’islam, quando
ripetono, cantando e girando su se stessi il nome di Dio fino a farlo coincidere con il respiro
affannato. Danzare per i dervisci è un modo di creare un arco di silenzio, l’uomo che gira su se
stesso diventa il proprio suono. Lo sanno coloro che recitano mantra, ma anche le vecchiette che
recitano il rosario. Il rosario è uno degli strumenti più diffusi nel mondo e più antichi. Sono stati
rinvenuti grani di preghiera negli scavi dell’Indo di tremila anni fa e la corona di grani è presente
nell’induismo come nel buddismo, nell’islam come nell’ebraismo e nel cristianesimo. Senza che
nessuno di questi culti ammetta di averlo in comune. Sembra che l’origine indiana sia stata tramitata
dai monaci buddisti al Rumi, il grande mistico Sufi che l’ha portata fin verso il MonteAthos, dove i
monaci l’hanno utilizzata per la preghiera esicasmica, quella che ripete continuamente il nome di
Cristo. Il mistico non sta in silenzio, ma lo costruisce, si tratta di una tecnica del corpo. Il silenzio
non è dato, si apprende come tecnica del corpo, come si apprende a parlare, a camminare in
montagna, a digiunare. Assorbiti come siamo dalle ovvietà del presente ci sembra che il problema
di non avere il silenzio sia una questione ambientale: dobbiamo pretendere il silenzio! Ma non è
così, il silenzio è una composizione e una musica che possiamo costruire noi stessi; pazientemente.
E la ripetizione ci aiuta, perché per quanto il nostro tempo aborrisca la ripetizione, poi è alla base di
buona parte delle nostre azioni e sostanzia il nostro vivere quotidiano, dal respiro, al passo con cui
ci muoviamo, al ritmo che ci fa ballare in discoteca. In fin dei conti nel koan zen che cerca di farci
capire in cosa consiste il battito di una mano sola, c’è tutto questo. Ci sono suoni che si possono
percepire solo nel silenzio e ci sono silenzi che si possono costruire solo con una successione di
suoni. L’importante è sapere che il silenzio è una porta e non è chiusa.» La Cecla Franco, Il nostro
presente che si arrende al rumore del mondo, art. in La Repubblica 04.04.2010, p. 30-31).
7
2.2. La fine della metafisica, il silenzio del mondo e l’indagine trascendentale. La lunga storia
della metafisica e la sua pretesa di pervenire a una descrizione del mondo colto nella sua essenza e
per come è in se stesso è anche, in parallelo, la lunga storia della critica ad un simile progetto. Gli
esiti tanto discordanti quanto dogmatici cui la metafisica giunge nella sua lunga produzione, al
variare degli autori, generano da subito una storia ad essa parallela di scetticismo e profonda
sfiducia nei confronti della possibilità di afferrare il presunto ordine cosmico. In particolare Kant
(1724-1804) e Husserl (1859-1938) prendono atto della fine della metafisica e tratteggiano, con
ampiezza di progetto, le linee di una filosofia trascendentale.
2.2.1. Kant. Fin dalle sue prime opere I sogni di un visionario chiariti con i sogni della metafisica
(1766) e la Dissertazione, De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis (1770) Kant
prende le distanze dalle pretese, proprie della metafisica razionalistica, di pervenire ad una
descrizione del mondo per come esso è in se stesso. Compare qui la distinzione fondamentale tra
materia e forma del conoscere: la materia è costituita dai dati sensibili (il fenomeno), la forma dalle
attività e dai modi mediante cui tali contenuti sono colti e organizzati conoscitivamente dal
soggetto.
2.2.1.1. Il mondo in sé, distinto dalle sensazioni che ne abbiamo e collocato al di là di esse, è per
definizione un mondo non dato; diventa una nozione (un noumeno), può essere pensato come
esistente ma ad un tempo è pensato come assolutamente inconoscibile. La realtà in sé,
assolutamente indeterminata, non possiede né mostra forme, per la conoscenza umana torna al
silenzio.
2.2.1.2. Il compito della filosofia è quello di svolgere una indagine critica sulle possibilità della
ragione umana nel campo del conoscere, dell’agire e del volere. (Critica della ragion pura (1781),
Critica della ragion pratica (1787), Critica del giudizio (1790). L’indagine filosofica diventa
trascendentale, con questo termine Kant indica quella ricerca che si occupa «non tanto di oggetti,
quanto invece del nostro modo di conoscere gli oggetti, nel senso che una tale modo di conoscenza
deve essere a priori». L’unica possibilità per fare uscire dal silenzio la realtà è passare attraverso il
soggetto allo scopo di mettere in luce le forme a priori con cui la mente dell’uomo coglie e ordina il
dato sensibile in sistemi scientifici.
2.2.2. Husserl segue le linee della impostazione trascendentale della filosofia. La crisi delle scienze
infatti nasce dalla caduta nell’“obiettivismo”, nel “naturalismo”: l’abitudine delle scienze a
presentare i propri risultati come oggettivi, definitivi e naturali (coincidenti con la realtà in sé), fa
dimenticare una dato elementare e primo che dove c’è una scienza c’è sempre un soggetto
conoscente. La naturalizzazione dei dati della scienza, mentre sembra esaltare i successi della
ricerca proclamandone l’esito oggettivo e definitivo, si traduce quindi in negazione del soggetto, in
silenzio imposto all’uomo, alle potenzialità della propria coscienza e, di conseguenza, in negazione
del mondo e delle possibilità di disporsi secondo sempre nuove, imprevedibili ma feconde aree di
senso. Per uscire da questa crisi, che blocca ogni sviluppo del sapere e della cultura, è necessario
ridare la parola al soggetto, alla coscienza, indagando con metodo fenomenologico descrittivo,
paziente e analitico, le potenzialità e le forme a priori con cui essa guarda e si rapporta (intenziona)
al mondo. Solo una libertà dal mondo inteso come un già dato e in sé definito fa uscire la mente e il
mondo stesso dal silenzio tirannico in cui li vorrebbe ricacciare una ragione che si presenta come
specchio naturale oggettivo e definitivo della realtà.
2.2.2.1. L’opera maggiore di Husserl, vero e proprio programma per l’avvio di una filosofia
dell’indagine fenomenologica trascendentale ha il proprio progetto nel titolo: Idee per una
fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica (1913 e 1952 I vol.; II e III vol. postumi).
2.3. restano e resistono i paradossi dell’esperienza; occorre procedere per teorie-ipotesi,
“congetture e confutazioni”.
«Alla fine del secolo scorso pareva che la scienza di base fosse prossima alla sua trionfale
conclusione. L’Universo funzionava secondo regole chiare, ben definite e comprensibili a livello
intuitivo, che erano state descritte con precisione. Il grande Lord Kelvin si spinse ad affermare che
8
nel futuro il compito degli scienziati si sarebbe limitato a stime sempre più accurate delle costanti
fisiche: non restavano più territori da esplorare.
Eppure, restavano poche anomalie irrisolte. Un paradosso riguardava la velocità della luce, che
sembrava stupefacentemente costante, indipendentemente dal movimento della sua sorgente e da
quello dell’osservatore. Altri paradossi riguardavano il mondo microscopico, che sembrava
stranamente resistente a una descrizione accurata. Nei primi decenni del Novecento questi dettagli
non risolti avrebbero portato alla distruzione completa dell’immagine confortevolmente armoniosa
dell’Universo che gli scienziati ottocenteschi avevano così pazientemente costruito. Non ci siamo
ancora ripresi da tale cataclisma. I paradossi della natura ancora da risolvere sono più affascinanti di
tutti i rompicapo ideati dall’uomo; però, gli uni e gli altri hanno un punto in comune: la stuzzicante
sensazione che per risolverli potrebbe bastare un unico lampo di genio.» p.1
Bruce Colin 1997 Sherlock Holmes e i misteri della scienza, Raffello Cortina Editore, Milano 1997
3. Forme umane del silenzio
3.1. il silenzio e la solitudine dell’eroe
3.1.1. Aiace. Nell’incontro di Odisseo con le anime dell’Ade, affollate attorno ai suoi sacrifici, tra
la ciarliera assemblea delle ombre che si affollano e domandano ansiose e desiderose di sapere
spicca il silenzio di Aiace, solitario e in disparte.
«Le altre anime dei morti defunti
stavano tristi, dicevano ognuna i propri dolori.
L’anima sola di Aiace Telamonide
se ne stava in disparte, in collera per la vittoria
con cui io lo vinsi in giudizio, ottenendo presso le navi
le armi di Achille…» (Odissea XI 541-546)
Ulisse richiama i fatti, la componente divina, il loro volere, e il valore degli eroi nel definire la sorte
che tocca i viventi, e tenta un coinvolgimento e una conciliazione attraverso il racconto.
«Dicevo così, ed egli non mi rispose, e andò
nell’Erebo tra le altre anime dei morti defunti.
Avrebbe potuto parlarmi, allora, anche se irato …» (Odissea XI, 563-565)
3.1.2. il tema è ripreso nell’Aiace di Sofocle che mette in scena la solitudine dell’eroe nei confronti
degli uomini e delle loro tradizioni, degli dei e del loro inflessibile e incomprensibile destino, delle
leggi necessarie del cosmo. Si tratta di un progressivo ritirarsi e consegnarsi al silenzio. Prima
accompagnato da una apparente accettazione delle leggi dominanti, accettazione che in realtà suona
immediatamente come ironia tragica e profezia di propositi di ribellione fino alla morte, il
drammatico e radicale dire no, il chiudere la vita con uno sdegnato silenzio.
«Apprenderemo d’ora innanzi a cedere, / ossequenti agli dèi, apprenderemo / or finalmente a
venerar gli Atridi. / Comandano; è pur giusto l’obbedirli! / E come no? Ogni forza più terribile / a
più possente cede vinta: cedono / a fruttuose estati i verni gelidi, / e le fosche di notte ombre cerulee
/ del giorno ai folgoranti corsier candidi: / dei venti le ululanti fiere raffiche /placan, cedendo, il
mugghiante oceano; / ed il sonno che doma tutti gli esseri / scioglie chi prima tenne in suo dominio!
/ Apprender non dovremo noi saggezza? […] Fate ciò che v’impongo; apprenderete / certo che
tosto avrò salvezza prospera, / se pur su me fosca sventura infuria.» (669-677, 691-692)
Poi l’ambiguità ironica di quelle parole cede il posto alla risoluzione di uccidersi sulla riva del
mare, in solitudine, con la spada di Ettore: «Là s’aderge chi a me dovrà dar morte, / quant’esser può
tagliente, per trafiggermi; / se indugio è ancor concesso di riflettere, / dono è d’Ettore, a me di tutti
gli ospiti /il più nemico, sempre odiosissimo, / ed è confitto nella terra d’Ilio, / di tutte più nimica, e
l’affilò / or or la cote che l’acciaro addenta; / e saldo d’ogni parte lo confissi, / perché a quest’uomo
or mostrisi benevolo, / a fargli dono di fulminea morte.» (815-822)
Un tragico dire no ad un destino universale, incomprensibile ed avverso, e un drammatico opporre il
silenzio della morte alle presunte leggi dell’ordine diventate petulanti soprattutto quando sono
9
riprese e riproposte da un irriflesso chiacchierare comune. In conclusione, Aiace «parla della legge
naturale eternamente valida cui anche il più forte deve conformarsi e cedere considereremo le sue
parole come una reale esperienza di vita, alla quale neppure un Aiace può sottrarsi: la sua tragicità
risiede proprio nel suo sentirsi costretto, nonostante questa esatta intuizione della propria vita spinto
dal suo demone a intraprendere la via opposta che lo conduce alla morte. Anche queste parole
hanno la funzione esterna di rendere credibile a chi gli sta intorno il suo mutamento d’animo: ma il
loro intimo valore sta nel fatto che Aiace stesso svela inconsapevolmente il senso più profondo
della sua tragicità: l’ordinamento cosmico esige che anche il più grande si inserisca in esso,e se ad
Aiace per la sua natura ciò non è possibile, il mondo non ha più spazio per lui» (M. Pohlenz, La
tragedia greca. trad. it., Paideia Brescia, 1961 p. 206).
«… financo la morte per lui / fu soltanto un pretesto per essere: la sua ultima nascita.» (Rainer
Maria Rilke, Elegie udinesi, I, 41).
3.1.1.1. A commento. «Se guardiamo all’estetica novecentesca, ci risulta notevole l’interesse
longiniano (dello Pseudo Longino, indicato come autore del trattato, anonimo, Sul Sublime) per le
forme non verbali di comunicazione, evidente quando tratta l’esempio del silenzio di Aiace, l’eroe
immeritatamente sconfitto da Odisseo nell’assegnazione delle armi di Achille che, nell’episodio
dell’evocazione dei morti (Odissea, XI), ascolta senza reagire le parole mielate e subdole con cui il
protagonista omerico tenta la riconciliazione, per poi andarsene sempre chiuso in un eloquentissimo
silenzio: un silenzio più sublime di ogni discorso, conclude l’autore (IX, 2).
Fusillo Massimo 2009 Estetica della letteratura, il Mulino, Bologna, p. 26
3.1.1.2. A bilancio. «Il sovvertimento del destino si manifesta, nella tragedia, solo con il mutismo
dell’eroe, con la consapevolezza, da parte del genio pagano, della sua superiorità rispetto agli dei —
una consapevolezza che gli toglie il respiro. In questo istantaneo silenzio, le leggi del destino, la
colpa e il castigo, vengono confuse e agitate insieme. Questo è, per Benjamin, «il sublime della
tragedia»: il fatto che l’eroe, ancora muto, ancora minore, ancora sopraffatto, riesca ad affermare
istantaneamente l’inizio della propria libertà. […] L’ethos in tal modo non è più imposto come
ordine mitico: con la morte, l’eroe se ne riappropria, contrapponendolo all’ordine destinale della
colpa.» Desideri Fabrizio, Baldi Massimo 2010 Benjamin, Carocci editore, Roma p.57-58, 96
3.1.2. Bartleby: il silenzio dell’arretrare, del dire no, il coraggio del nichilismo che è un ritirarsi
denunciante il nichilismo inavvertito e perciò imperante della “ragione strumentale”.
Bartleby lo scrivano: una storia di Wall Street (titolo originale Bartleby the Scrivener) è un
racconto di Herman Melville. (Fu pubblicato per la prima volta anonimo, in due parti, sulla rivista
Putnam's Magazine nel 1853, e fu poi incluso nella raccolta The Piazza Tales nel 1856 con qualche
piccola variante testuale. A quanto pare l'opera fu ispirata a Melville dalla lettura di Ralph Waldo
Emerson, tanto che sono stati trovati dei paralleli con il saggio di Emerson Il trascendentalista. Il
racconto è stato adattato per lo schermo due volte: nel 1970, con Paul Scofield, e nel 2001, con
Crispin Glover.)
La presentazione del racconto da parte di Evelina Somenzi, Bartleby. Il teschio sotto la pelle
[«You will not?» «I prefer not». … «I would prefer not» he replied, with his back still toward me.»
«You must»; H. Melville, Bartleby; o la versione più efficace dell’espressione «I would prefer not
to», versione «che, per quanto grammaticalmente e sintatticamente corretta, risulta, come ha scritto
Gilles Deleuze “agrammaticale” (la sua conclusione “not to”, che lascia in sospeso quello che
respinge)» così nota Belpoliti Marco 2010 Senza vergogna, Guanda, Parma p.168]
Il Principe del Foro e il foro, il buco da cui fuoriesce la sostanza del racconto, la sua morale; e tutto
il racconto si capovolge, come una clessidra.
Wall Street, è circa il 1850; un ufficio d’avvocato schiacciato tra il nero e il bianco, unica visuale
dalle finestre quasi cieche sui grattacieli; l’avvocato-narratore (padreterno della situazione
narrativa), tre scrivani operosi, ma non troppo. Nulla in confronto, però, a Bartleby, il nuovo
assunto. Quasi appena schizzato a matita, al suo apparire crea subito un vuoto incolmabile; come un
cadavere, come la macchia di sangue sulle mani di Lady Macbeth, riaffiora continuamente. Chi è
10
Bartleby? Una presenza, un’assenza: magro, silenzioso e spettrale, logoro ma signorile, mite ma
cadaverico, lo scrivano risucchia subito il racconto intorno a sé, diventando l’ombra dell’avvocato;
da dietro il paravento verde posto nell’ufficio del capo, a tratti imbambolato davanti al vuoto della
finestra “morta” vicino a sé, lui è sempre là, di giorno e di notte, sempre al lavoro. Da questa
sagoma vuota, senza passato, irrompe gradualmente un Assurdo scialbo, inspiegabile: lo
sconosciuto Bartleby, irrelato, recluso, comincia a rifiutarsi di lavorare, poi di uscire dall’ufficio,
quindi di scrivere, e infine di andarsene. La formula di sottrazione è sempre quella: «I would prefer
not to». Bartleby non è il Male, l’Irrazionale ma, più modestamente, il quieto vettore di un male, di
un’irragionevolezza contagiosa e ignota. Ogni atto con cui si rende sempre più inadatto,
imbarazzante, “di troppo” nella parabola discenderne, appare incontrovertibile e resta lì, come un
sasso che, al massimo, si può capovolgere — col suo mondo senza divenire, nella sua lingua priva
di comunicazione. Solo, una vita molecolare dietro cui trincerarsi. Sgomento, incredulo, il narratore
agisce, reagisce: che fare? Dio non c’è già più, Amleto è un’eco distante. Il dubbio rovescia la
pietra: e se fosse invece...: l’eremita mostruoso, il misero parassita, disumano nella sua inetta
indifferenza, quel “resistente passivo” dal margine d’esistenza sempre più sottile, appare
sovrumanamente solo, forse è un naufrago disperato alla deriva, di certo un poverino grondante
pietosa umanità. Basterebbe un’iniziativa, un’espressione, a parole, nei gesti scarni, per gettargli
addosso una rete di umanità che lo mostri meno nudo, più presentabile; ma Bartleby “preferisce di
no” e basta, con un’ostinazione che passa ogni limite, e lo rende, per gli altri, per quelli che si
credono liberi di scegliere e di agire, vittima del proprio destino. Rintocchi lugubri, oscillazioni,
rovelli, furie, e congetture; e scene madri dal ritmo inesorabile con l’ormai quasi autistico Bartleby:
l’isolamento di questo nel silenzio e nell’inespressività scatena la facondia dell’avvocato che, nel
tentativo di sfuggire alla trappola della sorte, moltiplica le metafore, gli stili, le osservazioni
“positive” così da irretirlo in una narrazione, se non negli eventi narrati, così da rimettere quel
“povero cristo” sul cammino di una qualche redenzione. E quanto più lo scrivano si sottrae al
lavoro, ergendosi spettrale nel centro pulsante del motore del mondo, la morte stessa nel cuore della
vita, tanto più si moltiplicano gli sforzi di recupero dalla devianza — dargli del denaro, trovargli un
altro lavoro, offrirgli ospitalità, ma liberarsene finalmente! Impossibile assimilarlo: e vano sarebbe
strappare l’ombra dal corpo, un corpo dall’anima. Altrove, altrimenti; Bartleby è intoccabile,
intangibile come la neve. Cacciarlo, come fa il narratore, è condannarlo alla separazione, alla morte,
e prendere su di sé la propria predestinazione misteriosa. Il licenziamento e lo sfratto di Bartleby,
poi il trasloco precipitoso di tutto l’ufficio, indi l’imprigionamento dell’ex-scrivano alle sinistre
Tombe per vagabondaggio, e infine la morte, con l’uomo rannicchiato su fili d’erba
miracolosamente cresciuti negli interstizi della grande muraglia di cinta (ha messo radici: la storia si
ripete?). Una scena finale degna di 2001: Odissea nello spazio: il feto sotto la piramide muraria,
secondo le metafore finali del racconto, con gli occhi aperti — tutto ciò che sappiamo di lui: un eximpiegato all’ufficio Lettere Morte (cioè, posta non recapitata) reso improvvisamente “superfluo” e
deranged — per il resto, il silenzio nel cuore della parola. Finita la sua passività masochista e
tirannica, annullata l’immagine di un sé negato e riaffiorante — e se fosse invece… - se io fossi
Bartleby, dentro, se tutti avessimo un buco, dentro? Se, con il narratore, ci fulminasse l’intuizione
che non c’è realmente niente che possiamo fare, né per gli altri, né per noi; che possiamo toccare i
corpi, le parvenze, non le anime — che siamo soli nell’universo, e tutto ciò che facciamo fa parte di
un destino da cui a volte siamo sfiorati? Quando il prossimo è l’Altro, sentiamo il teschio sotto la
pelle. «Ah, Bartleby! Ah, humanity!» (tratto da Baratta Stefano, Ermini Flavio (a cura di) 2004 I
nomi propri dell’ombra, Moretti & Vitali, Bergamo, p. 27-29)
Un silenzio accompagnato da profondo sconcerto per un sistema abituato ad una routine consolidata
che viene posta di fronte alla sua insensatezza da un rifiuto la cui invincibile determinazione deriva
dalla disarmante cortesia del condizionale con cui viene espressa: “preferirei di no”.
3.1.3. la Metamorfosi di Kafka
3.1.4. la portata etica e rivoluzionaria del silenzio “tragico” (della e nella tragedia) [a proposito di
Walter Benjamin]
11
« Già l’eroe tragico, che leva la testa contro il destino, affrontandolo nella mutezza della morte,
significa per Benjamin la crisi di questa necessità, e con essa la crisi non solo della forma della
tragedia, ma anche di ogni tentativo di elevare il tragico a paradigma generale di comprensione del
tempo umano.
Se la stessa nascita della filosofia, con il Socrate platonico, è pensabile unicamente sullo sfondo di
una critica del mito, che ha inizio dentro la tragedia stessa, questo non esonera certo il tardo
Benjamin dal compito di cogliere e sciogliere le immagini mitiche in cui si irrigidisce il tempo
presente, il cosiddetto tempo della modernità.» Desideri Fabrizio, Baldi Massimo 2010 Benjamin,
Carocci editore, Roma p.17
3.2. il silenzio del sublime; se la parola si affaccia alla dimensione del sublime ha il solo scopo di
introdurre e indicare l’estremo per morire nel silenzio di ciò che non può essere consegnato al dire.
Il tema del sublime (ýpsos) compare come Trattato in un’opera composta nella prima metà del I sec.
d.C. e pubblicata, in stato frammentario, per la prima volta nel 1554 ; attribuita falsamente a
Longino (denominato poi lo Pseudo-Longino [sorprendentemente o significativamente il tema del
silenzio compare con forza in opere “Pseudo-”]) è rimasta anonima per abbondanza di attribuzioni.
«Rivolgendomi poi a te, mio caro, che sei competente in letteratura, ho potuto tralasciare di
diffondermi troppo a spiegare che il sublime è, per così dire, il culmine e l’apice dell’arte della
parola e che i più grandi tra i poeti e i prosatori non per altro che per esso si segnalarono e
conseguirono gloria immortale.
Tutto ciò che è straordinario infatti guida gli ascoltatori non alla persuasione, ma all’estasi; e da per
tutto su quanto mira a convincerci ed a piacerci la vince sempre, con lo stupore che suscita, il
prodigioso, perché, mentre il lasciarsi persuadere per lo più dipende da noi, esso, servendosi di un
potere e di una forza irresistibile sopraffà ogni ascoltatore. Inoltre il pregio dell’invenzione e
l’ordine e la proporzione dell’esposizione risultano non da uno o da due particolari, ma appena
dall’intero contesto, mentre il sublime, quando appare proprio al momento giusto, a guisa di
fulmine trapassa tutto e mostra subito tutta quanta la valentia dello scrittore.»
Commenta M. Fusillo (Estetica 2009 o.c. p.26) «L’arte autentica si ottiene infatti per sottrazione:
Longino tratta a lungo del falso sublime, dovuto a magniloquenza gonfia, a puerilità, a
un’ispirazione vuota. Il suo ideale estetico è una parola così efficace da diventare azione: come nel
Fiat lux della Genesi biblica, direttamente citato come opera del «legislatore dei Giudei» («Sia la
luce e la luce fu; sia la terra e la terra fu»: Gn 1,3-10, in IX, 10), o in alcuni brani di Omero (fra i
meno topici, scelti forse per la loro ascendenza orientale) che descrivono eventi terribili e
tumultuosi, in cui domina la dimensione visiva e sonora. Longino è infatti anche assai attento al
rapporto fra le arti (il famoso ut pictura poesis di Orazio, già presente in Simonide): usa spesso la
musica per mettere a fuoco le sue teorie, e assimila il sublime alla luce in un quadro, che sembra
promanare dall’opera stessa, come se fosse naturale (altro fortunato precetto estetico: l’arte consiste
nel nascondere l’arte); e d’altronde il suo trattato ha giocato un ruolo importante nella storia della
pittura e dell’architettura, fino ai giorni nostri. Questa esaltazione del pensiero «spoglio, privo di
voce» (LX, 2) che leggiamo a proposito del silenzio di Aiace si proietta dunque direttamente verso
le poetiche novecentesche dell’azzeramento concettuale.»
3.2.1. Il tema e l’opera Del sublime non conoscono sosta nella ripresa e rielaborazione storica
successiva. Nella sensibilità romantica il tema riprende, dopo la stagione illuministica, tutta la sua
rilevanza e un fascino molto partecipato. Diventa un tema estetico nella filosofia di Kant,
nell’opera Critica del giudizio. Le indagini della sua filosofia trascendentale mettono in luce le
radici antropologiche a priori dell’esperienza del sublime individuandole nel sentimento, nella sua
struttura, nella finalità oggettiva e soggettiva come sue specifiche forme.
3.2.1.1. Il bello e il sublime. «Il bello della natura riguarda la forma dell’oggetto, la quale consiste
nella sua limitazione; il sublime invece, si può trovare anche in un oggetto privo di forma, in quanto
implichi o provochi la rappresentazione dell’illimitatezza, pensata per di più nella sua totalità»
(Kant Immanuel 1790 Critica del Giudizio, Laterza, Roma-Bari 1979 p.91). Due sono le
12
componenti del sublime, costituenti l’antinomia (antinomia “oggettiva”) che lo sorregge
dinamicamente: l’illimitato e la totalità; l’esperienza del sublime consiste nella capacità di tenere in
relazione questi due “estremi”; si può definire l’ossimoro del sublime. Al tratto di caos e di
disordine che accompagna il primo fa da contrasto l’idea di una totalità; idea che è una modalità a
priori propria della ragione, la quale ha nella propria struttura il compito di mostrare all’intelletto
come obiettivo e punto prospettico l’idea della completezza nel proprio campo di indagine. (Non è
una modalità dell’intelletto i cui concetti hanno la funzione di delimitare, definire e sono dunque in
relazione con la forma e con il bello).
3.2.1.2. La radice antropologica (antinomia antropologica, “soggettiva”) del sublime, un “piacere
negativo”. Bello e sublime sono esperienze del sentimento e chiamano in causa l’immaginazione, la
facoltà di esibire forme; tuttavia la loro diversità va ricercata nel modo con cui l’immaginazione
entra in accordo con le facoltà della mente: intelletto e ragione. Il bello rappresenta l’armonia tra
l’immaginazione e il concetto dell’intelletto poiché entrambi (immaginazione e intelletto) fanno
riferimento ad una forma definita e dalla loro armonia deriva un piacere immediato e positivo, una
esperienza di gusto e un giudizio di bellezza. Il sublime rappresenta l’armonia irrisolta tra
l’immaginazione e l’idea della ragione; poiché l’idea della ragione contiene la nozione della
completezza, ed è quindi una totalità che prescrive un compito ma non potrà mai avere alcuna
forma o rappresentazione (indica un illimitato), quell’armonia è irrisolta e quindi inquieta; genera
attrazione e repulsione ad un tempo, è ostacolo e spinta; da essa deriva quella situazione che Kant
chiama “piacere negativo” ed è l’esperienza del sublime.
3.2.1.3. La parola e il silenzio : il bello e il sublime. Se all’esperienza del bello, per il suo legame
con i concetti si addice la parola (la critica e l’educazione estetica), l’esperienza del sublime
provoca uno smarrito e affascinato silenzio di fronte all’indeterminata e irrisolta percezione di una
infinità. Scrive Kant: «…mentre il bello implica direttamente un sentimento di agevolazione e
intensificazione della vita …il sentimento del sublime invece è un piacere che sorge solo
indirettamente, e cioè viene prodotto dal senso di un momentaneo impedimento, seguito da una più
forte effusione delle forze vitali … e poiché l’animo non è semplicemente attratto dall’oggetto, ma
alternativamente attratto e respinto, il piacere del sublime non è tanto una gioia positiva, ma
piuttosto contiene meraviglia e stima, cioè merita di essere chiamato un piacere negativo» (Kant
1790 p. 92)
3.2.1.4. Il tema del sublime domina la produzione artistica del Romanticismo; stagione con la quale
Kant (così come con l’Illuminismo) mostra affinità e interesse fin dalle opere “precritiche”
(Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime, 1764). Nella Critica del Giudizio tuttavia,
trattando il tema del sublime, Kant critica, più o meno direttamente ma in modo acuto, la
concezione che ne hanno i “romantici”. L’esaltazione e la centralità che i romantici attribuiscono al
sublime deriva, secondo Kant da una esaltazione della sola immaginazione, senza alcun
coinvolgimento della ragione e delle idee; esso rimanda perciò più all’esperienza del caos e del
disordine della natura più che al principio di un finalismo oggettivo attribuito alla natura di cui il
sentimento coglie, attraverso l’incontro dell’immaginazione con la ragione, i tratti di una realtà ad
un tempo infinita e totale; quel sentimento del sublime è dunque solo esperienza di un terrore; è
soltanto terribile (“selvaggio disordine e devastazione”); un terrore non sorretto e non
accompagnato dalla ammirazione per la incontenibile potenza e grandezza della natura; se ne è
dunque respinti senza esserne attratti. «… poiché il vero sublime non può essere contenuto in
alcuna forma sensibile, ma riguarda solo le idee della ragione, le quali, sebbene nessuna esibizione
possa esser loro adeguata, anzi appunto per tale sproporzione che si può esibire sensibilmente, sono
svegliate ed evocate nell’animo nostro. Così l’immenso oceano sollevato dalla tempesta non può
esser chiamato sublime. La sua vista è terribile; e bisogna che l’animo sia stato già riempito da
parecchie idee, se mediante tale intuizione deve esser determinato ad un sentimento, che è esso
stesso sublime, in quanto è sospinto ad abbandonare la sensibilità e ad occuparsi di idee che
contengono una finalità superiore.» (Kant CdG p.93)
13
3.2.1.4.1. Kant forse intravede nella sensibilità romantica l’esperienza e l’intuizione di un terrore
puro, di una grandezza che coincide con il caos in quanto non accompagnata dall’idea, propria della
ragione, della totalità; l’idea della ragione è infatti quella di infinito certamente, cioè senza fine, ma
anche di totalità; un infinito quindi proiettato verso un’armonia di sistema. In retrospettiva si può
pensare che forse Kant colga in anticipo il tema e la logica dell’orrore, del terrore allo stato puro,
senza sensatezza e senza alcuna possibilità di venir condotto a idea, di essere spinto verso la parola;
quel tema del male assoluto e senza redenzione che affiorava nel giovane Socrate in discussione con
Parmenide (nel Sofista di Platone) e che sembra trovare realtà storica nelle tragedie del ‘900 e che
continuano a lasciarci non nel silenzio di una contemplazione turbata e affascinata, ma nel solo
terrore del silenzio (nostro e di Dio ad Auschwitz).
3.3. il silenzio mistico: Dionigi l’Areopagita (lo Pseudodionigi) [vedi storie del respiro]:
«Adunque, in tal modo il divino Bartolomeo dice che la parola di Dio è grande e piccolissima e il
Vangelo è vasto e ampio e così pure è conciso. Mi sembra che egli abbia capito in modo mirabile
che la Causa buona di tutte le cose si può esprimere con molte parole [teologia simbolica] e con
poche [teologia razionale, affermativa], ma anche con l’assenza assoluta di parole [teologia
mistica]; infatti, per esprimerla non c’è né parola, nè intelligenza, perché è posta
soprasostanzialmente oltre tutte le cose, e si rivela veramente e senza alcun velame soltanto a coloro
i quali trascendono tutte le cose impure quelle pure e superano tutta la salita di tutte le sacre vette, e
abbandonano tutte le luci divine e i suoni e i discorsi celesti e penetrano nella caligine dove
veramente risiede, come dice la Scrittura, colui che è al di là del tutto.» Dionigi Areopagita, Tutte le
opere, Rusconi, Milano 1981, p 410
3.4. la contemplazione laica (la laicizzazione della contemplazione): indicata da Schopenhauer
come espressione di Noluntas e Nirvana, al termine di un processo di liberazione, negazione e
disubbidienza alla Volontà di vita e al suo esprimersi nella Ragione, forma di illusione e di inganno
supremo per l’uomo, è ripresa da Nietzsche ancora come forma di liberazione e negazione dello
spirito di gravità e di schiavitù cui l’umanità facilmente, troppo facilmente, si consegna. È la portata
liberante e costituente del nichilismo; un creare dal nulla. «È passato il tempo in cui la Chiesa
possedeva il monopolio della meditazione, quando la vita contemplativa doveva essere sempre in
primo luogo vita religiosa: e tutto quanto la Chiesa ha costruito esprime questo pensiero. Io non
saprei come potremmo lasciarci appagare dalle sue costruzioni, anche se queste fossero spogliate
della loro destinazione ecclesiastica: queste costruzioni parlano un linguaggio anche troppo patetico
e parziale, in quanto case di Dio e sfarzose sedi di un commercio ultramondano, perché noi, i senza
Dio, si possa qui dar vita ai nostri pensieri. Quando andiamo errando in questi loggiati e giardini, è
noi che vogliamo aver tradotto in pietra e pianta, è in noi stessi che vogliamo passeggiare.»
Nietzsche Friedrich 1886 La gaia scienza, A. Mondadori, Milano 1878, § 280, p.156
3.5. l’arte muta: quadrato nero e quadrato bianco (il silenzio delle origini, “del deserto” [Borges]);
“il y a trop d’art” (il silenzio dell’eccesso, “della metropoli” [Borges])
3.5.1. un’immagine oltre l’immagine, oltre il senso, “la sua forza consiste nel suo silenzio, nel suo
mistero”. «Si sa che il Quadrato nero fu esposto nel 1915 a San Pietroburgo nell’ambito dell’ultima
esposizione di quadri futuristi. Era, dunque, malgrado tutto, un “quadro” ad essere messo in mostra
da Malevič nel 1915, ma un quadro al limite del possibile dal momento che le astuzie insite nel
titolo con cui l’esposizione si presentava facevano “oscillare” il termine “ultimo” in modo da
rendere difficile stabilirne il referente (e sarebbe del resto errato farlo): ultima esposizione? Ultima
esposizione di quadri? Ultima esposizione di quadri futuristi?»
«Tra le prime reazioni vi fu quella di chi volle interpretare l’opera di Malevič come un fenomeno
intelligibile solo all’interno di una dialettica che abbracciasse l’intera storia dell’arte considerata nel
suo complesso: “Vi era là una forza che si opponeva a tutto ciò che si era sempre inteso coi termini
di ‘quadro’, ‘pittura’, ‘arte’. Il suo artefice voleva ridurre tutte le forme, l’intera pittura, a zero” (El
14
Lissitzky). […] Intento di Malevič è infatti «realizzare un quadro “alogico”, il che non vuol dire
necessariamente un’immagine priva di senso, quanto piuttosto un’immagine che supera il senso, che
si colloca oltre il senso. … La sua forza consiste nel suo silenzio, nel suo mistero. Copre la
rappresentazione, ma ne è già anche un’immagine indeterminata: l’immagine delle possibilità
infinite della rappresentazione. Sappiamo — è Malevič a dirlo — che in questa “tremenda potenza”
si trova come la somma di tutte le immagini dell’universo che aspettano di essere sviluppate. Il
massimo di mimesis uccide la mimesis. […] È il momento (metafisico e segnico) dell’ombra e del
suo particolare silenzio formale. Rappresentando l’ombra in assoluto, l’arte sembra voler tornare
alle proprie origini e alla densità di significato che definisce le origini; un «momento forte della
storia della rappresentazione occidentale in cui, investita dello statuto di non-effigie, l’ombra va a
far corpo con la rappresentazione.» (Stoichita I. Victor, 1997 Breve storia dell’ombra. Dalle origini
della pittura alla pop art, il Saggiatore, Milano 2008, p.175-178 passim)
3.5.2. Il y a trop d’art. Quando anche una cappelliera (un orinatoio, un rastrello, un pettine, una
ruota di bicicletta, una sedia, un vasetto di escrementi, degli stracci, il proprio corpo tatuato …
Duchamp, Manzoni, Pistoletto, Franko B. ; insomma: ready made e performer di body art) può
essere presentata come opera d’arte, allora vi è un eccesso di arte, l’arte scompare, si mimetizza
(non è mimesis ma si mimetizza), scompare, entra nella sfera del silenzio e tace come arte; per
ottenere una risonanza sono costretto ad un artificio: a collocare l’oggetto (comune) nel silenzio e
nel vuoto dei luoghi che classicamente vengono destinati ad essere sede dell’arte: una sala di
museo, al centro di una piazza, di un giardino … attuando una estrazione (astrazione, estraniazione)
dell’oggetto già costruito (ready made) dal suo stato di fatto utile, considerato socialmente normale.
In un periodo in cui tutto può o rischia di diventare arte, “il y a trop d’art” (titolo di un’opera
dell’artista Ben Vautier e proclama dello stesso Malevič), l’arte si consegna ad un silenzio di
eccesso; ad una assenza di logica e di senso che non deriva dalla mancanza di senso e di logica ma
da un suo oltrepassamento (come accade alla assenza di logica e di parola nella tradizione mistica).
Se tutto può essere arte… “Anything can be art without having to look like art at all”(Arthur
Danto); ogni cosa può essere arte senza dover assolutamente apparire arte (valga il richiamo ai
ready made), di conseguenza l'arte può recuperare qualsiasi procedimento all'artisticità, è allora
difficile (impossibile, inutile) distinguere nell’arte l’unicum, l’opera, dal seriale, ripetuto e dal
quotidiano; «se tutto si estetizza, diventa sempre più difficile parlare di estetica.» (il y a trop d’art).
Per quali ruoli e per quali direzioni?
3.5.2.1. l’estetica del quotidiano e la sua funzione rivoluzionaria: «… l’Estetismo è stato spazzato
via dalle avanguardie: ora che anche la loro rivoluzione si è spenta, alcuni tratti sembrerebbero
ritornare, soprattutto la disseminazione incondizionata della sfera estetica e la sua diffusione sempre
più massificata. Si parla infatti per il postmoderno di estetizzazione del quotidiano, fenomeno che
sarebbe legato all’espansione del virtuale e del mediatico e all’indebolirsi dei confini tra finzione e
realtà, e che possiamo valutare in maniera più o meno negativa a seconda del nostro grado di
«apocalitticità». Bisogna certo ricordare che molte epoche hanno estetizzato l’universo quotidiano,
in varie forme, magari più ritualizzate e meno massicce di quanto accada oggi. C’è insomma il
rischio che anche l’estetizzazione del quotidiano divenga una formula facile per classificare un
presente ancora arduo da comprendere.» Fusillo Massimo 2009 Estetica della letteratura, il Mulino,
Bologna p.50
3.5.2.2. il bivio di fronte al quale pone l’arte “muta”: 1. occorre prendere atto della morte dell’arte
ed esibirne il silenzio; l’arte muta, il quadrato nero di Malevič. 2. al centro dell’estetica si colloca la
forma e prendono la parola i processi innovativi che l’autonomia della forma e dei suoi tratti
(estensione, colore, densità, rumore…) in campo percettivo e, di conseguenza, artistico è in grado di
generare aprendosi ad una imprevedibile e spesso provocatoria formalizzazione.
4. le ragioni filosofiche del silenzio
Alla filosofia spetta il compito della chiarificazione: liberare il pensiero e il linguaggio dai
fraintendimenti da cui derivano inganni e falsi problemi, indicare la strada per un uso autentico
15
della parola, individuare con franchezza e determinazione le aree che non possono essere
consegnate alla parola e sulle quali è doveroso il silenzio. Si tratta di un progetto, ma anche di una
biografia, delineato e attuato da Wittgenstein con una costanza etica e filosofica che ha costruito
una direzione insopprimibile e doverosa della cultura contemporanea.
Tractatus logico philosophicus: la chiarificazione filosofica del dicibile. Quando nel 1922
Wittgenstein decide, dopo molte discussioni e verifiche, di pubblicare il suo primo scritto, con il
titolo Tractatus logico-philosophicus, egli giustifica la propria scelta con la convinzione di aver
trovato e indicato, in quest’opera, la strada per risolvere in modo definitivo tutti i problemi filosofici
nella misura in cui sono risolvibili. In questo testo Wittgenstein mira a circoscrivere con rigore
l’ambito di ciò che può essere detto, di ciò che è esprimibile, indicando le condizioni logiche che
permettono di costruire un linguaggio logicamente corretto, in grado di indicare con chiarezza
assoluta il significato di tutti i propri enunciati. Qualsiasi teoria deve infatti la propria scientificità
alla capacità di fornire una completa chiarificazione dei propri asserti: nel mondo della scienza e del
linguaggio non vi è posto per enigmi; «tutto ciò che può essere pensato — afferma Wittgenstein —
può essere pensato chiaramente, tutto ciò che può formularsi, può formularsi chiaramente», «quanto
a ciò di cui non si può parlare — conclude — si deve tacere». Il Tractatus logico-philosophicus si
propone così come manifesto del rigore logico-linguistico.
4.1. Il progetto di Wittgenstein poggia su nozioni preliminari opportunamente chiarite; in
particolare: linguaggio, mondo, fatti – cose, proposizioni.
4.1.1. nozione preliminare di linguaggio. Al centro del Tractatus Wittgenstein pone un’innovativa
concezione del linguaggio: esso non consta di «etichette» per le cose del mondo; nomi e
proposizioni non si riferiscono al mondo esterno, non designano una realtà esterna al linguaggio; il
linguaggio è, anzi, ciò che ci consente di avere un mondo, è lo spazio logico nel quale il mondo ha
una forma, un senso. Non è possibile, spiega Wittgenstein, parlare del rapporto tra linguaggio e
mondo (le cose, la realtà esterna); anche questo rapporto è momento del linguaggio (se ne parla); il
mondo è tale solo all’interno del linguaggio, all’interno della sua costituzione linguistica; non è
ovviamente possibile parlarne senza parole, senza linguaggio; l’uomo non ha oggetti o fatti al di
fuori del linguaggio: i fatti non sono «nel mondo», ma nella configurazione del linguaggio-mondo.
L’insieme di tutti i fatti costituisce lo spazio logico del mondo. Tra linguaggio e mondo vi è una
corrispondenza formale biunivoca: i fatti linguistici raffigurano (secondo diversi livelli di
complessità) i fatti del mondo; la totalità di ciò che accade è esprimibile in forme logicolinguistiche. Il linguaggio (come il mondo) non ha nulla al proprio esterno, sia perché il mondo
logico non conosce nulla di esterno alla logica, sia perché il mondo, per definizione, non ha nulla
che accada fuori di esso: «il mondo è la totalità dei fatti».
4.1.2. nozione preliminare di mondo. «Il mondo è la totalità dei fatti»; «il mondo è tutto ciò che
accade»; dunque fatti e non cose o oggetti. La realtà non è presentata come un insieme di oggetti in
sé definiti e a sé stanti, non è un magazzino di cose. Le cose sono infatti sempre in relazione e in
contesti di spazio e d’uso: non possiamo rappresentarci alcun oggetto indipendentemente dalle sue
relazioni con altri oggetti con i quali forma «stati di cose»; le combinazioni, contingenti, variabili e
molteplici degli oggetti in stati di cose costituiscono i fatti del mondo, perciò «il mondo — afferma
Wittgenstein — è la totalità dei fatti, non delle cose». Se di cose si può parlare è solo per astrazione
dagli stati di cose, dai fatti. Le nostre proposizioni logiche sono immagini, proiezioni di fatti e non
di cose, di relazioni e non di oggetti semplici; lo stesso nome che significa un oggetto ha senso solo
all’interno di una proposizione. Il primato delle relazioni rispetto agli elementi (come in sede
linguistica: il primato delle proposizioni nei confronti delle parole; queste prendono significato e
senso in quelle).
4.1.3. nozione e distinzione preliminare tra proposizioni fattuali e proposizioni logiche. Gli
enunciati fattuali esibiscono fatti e sono veri se il fatto raffigurato sussiste, falsi in caso contrario:
«la totalità delle proposizioni vere — afferma Wittgenstein — è la scienza naturale tutta».Gli
16
enunciati logici illustrano le proprietà formali che le proposizioni devono avere per raffigurare i
fatti; la loro verità o falsità non dipende dal rapporto, con la realtà; esse: «le proposizioni della
logica — sottolinea Wittgenstein — non dicono nulla sul mondo», sono tautologie, nella loro
enunciazione implicano (il principio di identità ha una identità) come valido per sé ciò che
enunciano e hanno nella non contraddizione la loro verifica.
4.2. «Ciò che può essere detto chiaramente»
Grazie all’identificazione delle proposizioni fattuali (il mondo inteso come la totalità dei fatti
linguisticamente formulabili) e delle proposizioni logiche Wittgenstein ritiene di essere riuscito a
demarcare l’ambito «di ciò che può essere detto chiaramente», escludendo tutti quegli enunciati
(come quelli metafisici) dei quali non è possibile stabilire le condizioni di verità. In tal modo
afferma di aver posto le condizioni per raggiungere l’obiettivo enunciato: la tesi che sorregge
l’opera è infatti che l’esprimibile, in quanto rientra nell’ambito della logica, può essere detto con
chiarezza definitiva; ciò che non è definitivamente chiarificabile è anche inesprimibile. In quanto
prodotto logico, il linguaggio è per definizione capace di attuare il pieno controllo del proprio
campo di espressione e di chiarire con esattezza definitiva le proprie possibilità e i propri enunciati.
4.3. la chiarificazione e il rimando al silenzio, al mistico.
Il linguaggio non può mostrare i propri confini, può solo, sulla base delle proprie coordinate logicoformali, dire con definitiva chiarezza ciò che può essere detto; ma, così facendo, mostra ciò che non
è dicibile, rimanda cioè ai propri limiti.
Oltre agli enunciati fattuali e logici esistono molti altri enunciati che non concernono nè i fatti, nè la
struttura del linguaggio; sono gli enunciati della metafisica, della teologia, della morale e
dell’estetica. Pur esprimendo questioni «vitali», questi enunciati eccedono l’ambito del dicibile,
dell’esprimibile, di essi non possiamo «dire».
4.3.1. Gli enunciati metafisici sono, per lo più, enunciati totali: essere, mondo,vita, bene, bello,
giusto, amore, dolore ecc. in generale: il «che è» e non il «come è».
4.3.1.1. Non possiamo definirli (delimitarne l’ambito e il significato globale) perché non possiamo
avere su di essi uno sguardo esterno; non possiamo parlare del mondo se non in quanto fatti del
mondo; non possiamo parlare della parola se non in quanto parte della parola.
4.3.1.2. Non possiamo perciò ridurli a problema; definirli in termini di domanda, perché siamo noi
stessi l’oggetto di quella domanda, cadiamo, esistiamo in quel domandare. Il problema invece e la
domanda sono formulati, in contesti specifici, in modo che di essi vi sia una trattazione controllata e
una risposta, una risoluzione (un “come dovevasi dimostrare”) come accade nei problemi della
geometria, della matematica e della logica formale.
4.3.1.3. Presentarli in termini di domande (e di risposte!!) significa non comprenderne la rilevanza,
l’ampiezza, la profondità e, insieme, escludere la persona da quelli come se essi (il bene, il bello,
l’amore, il dolore, la vita, la morte) fossero oggetti, cose e non costituissero il suo mondo-della-vita
(alla Husserl). Non sono dati al linguaggio; al linguaggio che è definito da ciò che è dicibile con
chiarezza. Di loro, per onestà, non si può parlare (con pretese di chiarificazione); è meglio tacere.
4.3.2. Con l’invito a tacere su «ciò di cui non si può parlare» Wittgenstein non intende affatto
negare la centralità delle questioni metafisiche, etiche ed estetiche (del bene, del giusto, del bello,
dell’essere, della verità, del senso …) ma sottolinearne la rilevanza. Essa è stabilita e accresciuta
proprio dalla consapevolezza dell’impossibilità riformulare su di esse un discorso sensato e
controllabile. «Se quest’opera ha un valore, il suo valore consiste in due cose. In primo luogo, i
pensieri son qui espressi; e questo valore sarà tanto maggiore quanto meglio i pensieri siano
espressi. Quanto più si sia colto nel segno. — Qui so d’essere rimasto ben sotto il possibile.
Semplicemente poiché la mia forza è impari al compito. — Possa altri venire e far ciò meglio.
Invece, la verità dei pensieri qui comunicati mi sembra intangibile ed irreversibile. Io ritengo,
dunque, d’avere definitivamente risolto nell’essenziale i problemi. E, se qui non erro, il valore di
17
quest’opera consiste allora, in secondo luogo, nel mostrare a quanto poco valga l’avere risolto
questi problemi.»
La convinzione dell’importanza di questi «problemi vitali» è ribadita più volte: presentando il
Tractatus, afferma, paradossalmente: «La mia opera consta di due parti: di ciò che qui è scritto e di
tutto ciò che io non ho scritto. E proprio questa seconda parte è quella più importante.» E ancora:
«anche una volta che tutte le possibili domande scientifiche hanno avuto risposta, i nostri problemi
vitali non sono ancora neppur toccati». Questo «ineffabile» che non può essere espresso, non è
«dicibile», tuttavia esiste, «si mostra», secondo Wittgenstein «è il mistico».
4.3.2.1. la corretta e nuova relazione tra filosofia e mistica, chiarificazione e mistero. Logica e
mistica sono legate, nel testo di Wittgenstein, da un insolito rapporto. Tradizionalmente la mistica
segnala l’incapacità del pensiero razionale, l’impotenza e l’inadeguatezza della parola e, svalutando
la dimensione logica, invita al silenzio; nel Tractatus invece la dimensione mistica si presenta come
sfera dell’ineffabile proprio in quanto la sfera logico-linguistica è in grado di definire se stessa con
chiarezza piena e di indicare in modo completo e definitivo i fatti del mondo e i fatti logici. Allora,
nella piena chiarificazione del dicibile (di ciò che è dicibile), indica oltre il dicibile, il mistico, il non
dicibile.
4.3.2.2. vanno nella stessa direzione, di scoperta del silenzio a partire dalla natura della ragione,
diverse e note direzioni del pensiero filosofico. La consapevolezza che la lettura scientifica
(matematica) del mondo è possibile grazie ad un processo di semplificazione logica dei dati; le tesi
antropologica di una natura umana complessa ben oltre la propria razionalità (la stessa impostazione
di Descartes che, per fare chiarezza, riporta l’uomo a pensiero ed estensione, ha l’effetto di
segnalare che l’uomo non si riduce a ragione; lo presenta addirittura come un composto di due
sostanze, le tradizionali anima e corpo, che, proprio in quanto dualisticamente contrapposte come
res, sostanze, rendono ancora più difficile il problema della comunicazione); e tutte le teorie sulla
complessità dello psichismo, sull’inconscio, sul “sottosuolo” («Ed è per esempio del tutto naturale
che io voglia vivere soddisfacendo a tutte le mie facoltà vitali e non alla sola facoltà raziocinativa,
ossia alla ventesima forse parte sull’intera somma delle mie facoltà vitali. Che cosa sa la ragione?
La ragione sa soltanto quello che le è riuscito di conoscere (e magari certe cose non le conoscerà
mai; questo non è forse edificante, ma perché nasconderselo?), mentre la natura umana agisce tutta
intera, con tutto quanto contiene in sé, coscientemente e incoscientemente, e se anche mentisca vive
però.(p. 45) Qui si ragiona seriamente; ma se poi non volete degnarmi della vostra attenzione, non
vi verrò mica a pregare. Ho il mio sottosuolo. (p.56)» Dostoevskij Fëdor 1864 Ricordi dal
sottosuolo, Adelphi, Milano 1995
4.4. i passaggi con cui si conclude il Tractatus:
«6.5 D’una risposta che non si può formulare non può formularsi neppure la domanda.
L’enigma non v’è.
Se una domanda può porsi, può anche avere una risposta.
6.51 Lo scetticismo è non inconfutabile, ma apertamente insensato, se vuoi mettere in dubbio ove
non si può domandare.
Ché dubbio può sussistere solo ove sussista una domanda; domanda, solo ove sussista una risposta;
risposta, solo ove qualcosa possa essere detto.
6.52 Noi sentiamo che, persino nell’ipotesi che tutte le possibili domande scientifiche abbiano avuto
risposta, i nostri problemi vitali non sono ancora neppure sfiorati. Certo, allora non resta più
domanda alcuna; e appunto questa è la risposta.
6.521 La risoluzione del problema della vita si scorge allo sparire di esso. (Non è forse per questo
che degli uomini ai quali il senso della vita divenne, dopo lunghi dubbi, chiaro, non seppero poi dire
in che cosa consistesse questo senso?)
6.522 Ma v’è dell’ineffabile. Esso mostra sé, è il Mistico.
6.53 Il metodo corretto della filosofia sarebbe propriamente questo: nulla dire se non ciò che può
dirsi; dunque, proposizioni della scienza naturale — dunque, qualcosa che con la filosofia nulla ha a
18
che fare —, e poi, ogni volta che altri voglia dire qualcosa di metafisico, mostrargli che, a certi
segni nelle sue proposizioni, egli non ha dato significato alcuno. Questo metodo sarebbe
insoddisfacente per l’altro — egli non avrebbe la sensazione che noi gli insegniamo filosofia—,
eppure esso sarebbe l’unico metodo rigorosamente corretto.
6.54 Le mie proposizioni sono chiarificazioni le quali illuminano in questo senso: colui che mi
comprende, infine le riconosce insensate, se è asceso per esse — su esse — oltre esse. (Egli deve,
per così dire, gettar via la scala dopo che v’è salito.)
Egli deve superare queste proposizioni; è allora che egli vede rettamente il mondo.
7 Su ciò, di cui non si può parlare, si deve tacere.»
L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, pp. 173-175, Einaudi, Torino 1989
4.5. in conclusione, il doppio coraggio della filosofia: 1. della grammatica per portare a chiarezza
pensieri; 2. del silenzio per rispettare l’indicibile e la centralità delle “questioni” vitali; le parole e le
questioni totali che esse indicano o suscitano si danno come contesti di riflessione, non come
problemi; non possono perciò ricevere alcuna risposta, e ciò per una serie di possibili considerazioni
e sviluppi.
4.5.1. La domanda per cui non c’è risposta (non è possibile vi sia una risposta) non è una domanda.
A proposito della tentazione scettica che potrebbe cogliere di fronte all’esito della sua filosofia,
Wittgenstein non esita ad affermare che «dubbio può sussistere solo ove sussiste una domanda»: di
ciò che non è esprimibile, non si può né formulare domanda o dubbio, né risposta; «lo scetticismo è
non inconfutabile, ma apertamente insensato se vuole mettere in dubbio ove non si può
domandare».
4.5.2. Quel problema e quella domanda (falsa domanda) non sono privi di rilevanza quando
vengono negati come problemi, anzi la loro importanza viene proprio sottolineata dal fatto che non
possono ridursi a problemi; non possono ridursi a questioni per le quali si può pensare di avere
risposte e magari definitive. Sono il nostro luogo vitale originario e costante, sono il contesto stesso
del nostro domandare, perciò non sono domande. L’essere, il bene, il bello, il vero, la vita ecc.
parole che, per come linguisticamente vengono formulate e per come filosoficamente sono state
trattate paiono questioni e problemi totali ritenuti considerati centrali per la filosofia, non sono
domande perchè sono la condizione e il luogo stesso del nostro pensare, dire agire, sperare,
desiderare e quindi anche domandare. Quella zona del “che è”, non del “come è”, quando assume la
veste di problemi, questi in realtà si autoimplicano e presuppongono come contesto di problema:
una domanda sulla realtà e sull’essere presuppone che io vi faccia parte e che esista; una domanda
sul parlare presuppone che io parli… La loro traduzione in questioni avvia rimandi all’infinito.
4.5.3. Il silenzio su questi problemi e la scoperta in loro della non domanda possibile, quindi la
posizione del silenzio, dell’ascolto e dell’indagine fenomenologica sugli atti linguistici che in quel
contesto prendono sede, costituiscono la posizione laica della filosofia e, con il coraggio dell’onestà
e con lo sforzo etico della chiarificazione, pongono fine alla costruzione di metafisiche ideologiche,
prive di fondamento nei fatti e nella logica. Se nel mondo tutto è chiaro, «tutto è come è», le
domande sui valori, sulle motivazioni, sul dover essere, sono «fuori del mondo», fuori
dell’esprimibile. Il Tractatus traccia così una netta linea di demarcazione tra ciò di cui si può
parlare e ciò di cui si deve tacere: posto all’intersezione tra l’esprimibile e l’ineffabile, esso si
presenta non come un’opera di bilancio e di conclusione, ma come punto di partenza di una
riflessione che si apre all’indicibile. Quando si richiama il linguaggio all’obbligo di costruire un
percorso di enunciati dotati di senso definitivo, lo si libera dal compito, vano, illusorio, di indagare
e parlare dei fondamenti ultimi della realtà e dei principi assoluti del mondo; ma, in tal modo, si
indica anche alla filosofia quanto sia vasto il mondo del silenzio. Il Tractatus acquista così il
significato di una imprescindibile e preliminare operazione etica. Le possibilità di senso vanno ben
al di là di quanto è esprimibile dal linguaggio scientifico, idealmente perfetto; tuttavia quest’ultimo,
delimitando il mondo dei fatti linguistici esprimibili con chiarezza, indica, di conseguenza,
l’ineffabile, il mistico: «la filosofia significherà l’indicibile rappresentando chiaramente il dicibile».
19
4.5.4. Il silenzio dell’ascolto: ascolto filosofico nella indagine linguistica della filosofia,
un’indagine analitica sul linguaggio quotidiano per coglierne densità e direzioni di senso; il
linguaggio formalmente perfetto è soltanto una delle forme che il linguaggio, nella sua concretezza
storica, può assumere; ne é anzi la forma più povera in quanto è dominata dal proposito di
conservare un rigido legame di univocità tra termine e significato, chiudendosi in un mondo di
artefatta perfezione formale.
« e dunque quel silenzio in sé rivolto
non da astuzia nasceva o da timore,
ma dall’ascolto. »
Rainer Maria Rilke Sonetti a Orfeo
20