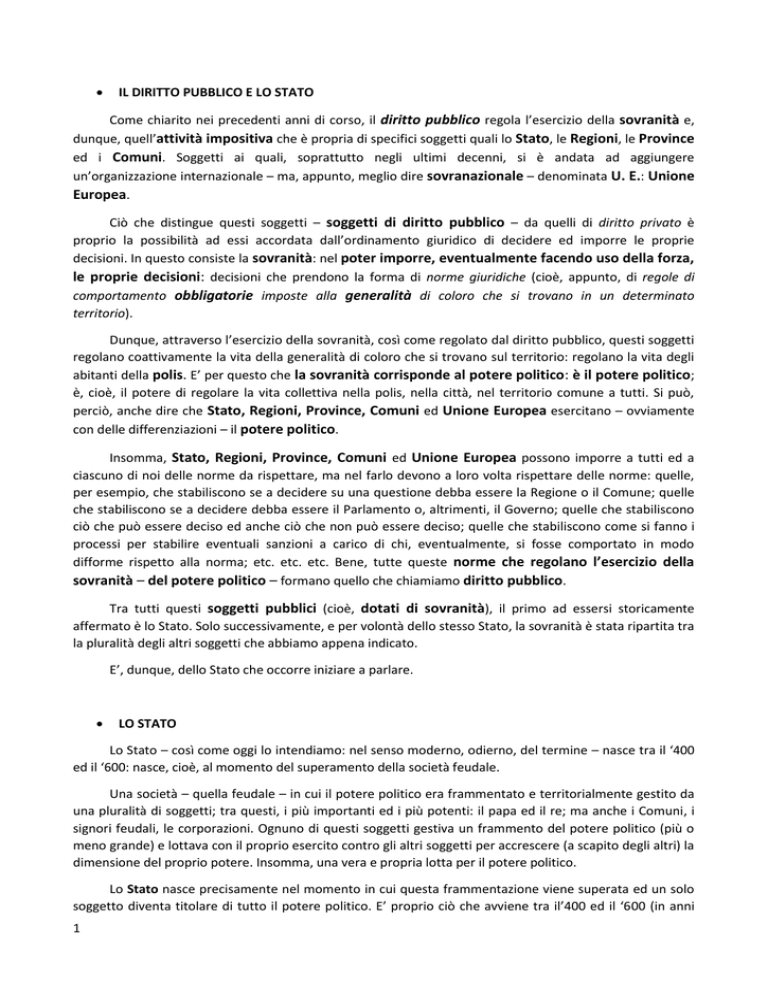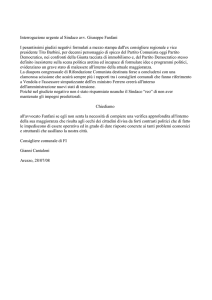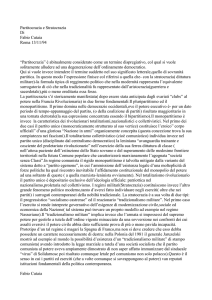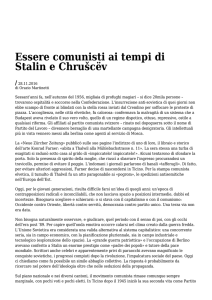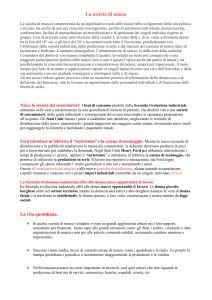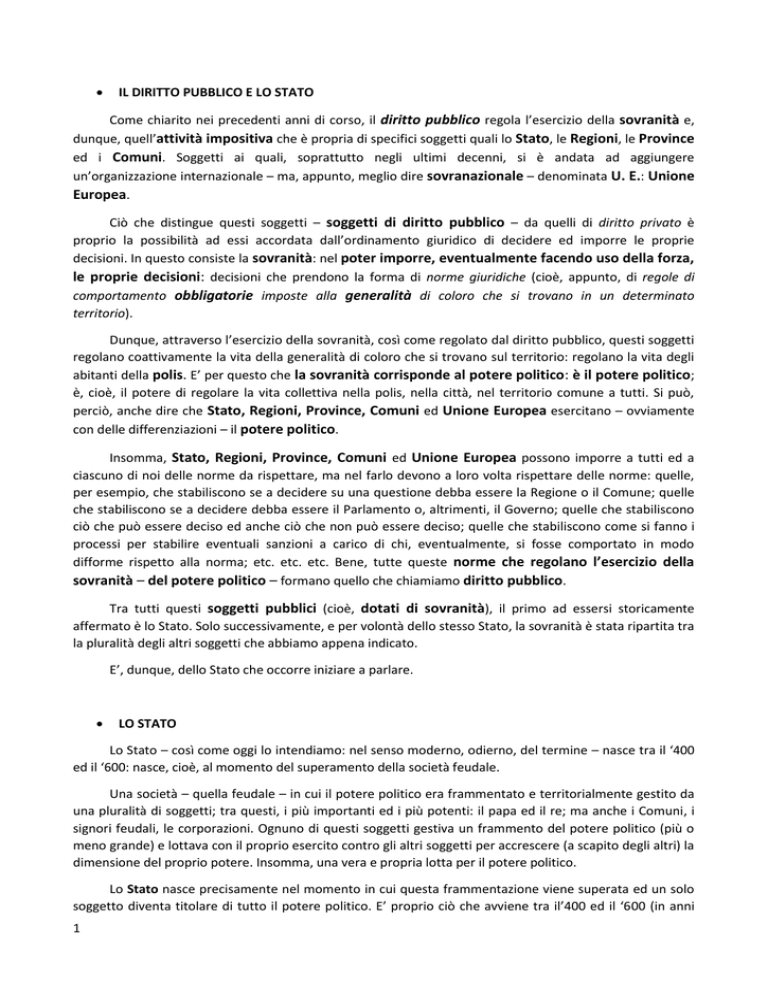
IL DIRITTO PUBBLICO E LO STATO
Come chiarito nei precedenti anni di corso, il diritto pubblico regola l’esercizio della sovranità e,
dunque, quell’attività impositiva che è propria di specifici soggetti quali lo Stato, le Regioni, le Province
ed i Comuni. Soggetti ai quali, soprattutto negli ultimi decenni, si è andata ad aggiungere
un’organizzazione internazionale – ma, appunto, meglio dire sovranazionale – denominata U. E.: Unione
Europea.
Ciò che distingue questi soggetti – soggetti di diritto pubblico – da quelli di diritto privato è
proprio la possibilità ad essi accordata dall’ordinamento giuridico di decidere ed imporre le proprie
decisioni. In questo consiste la sovranità: nel poter imporre, eventualmente facendo uso della forza,
le proprie decisioni: decisioni che prendono la forma di norme giuridiche (cioè, appunto, di regole di
comportamento obbligatorie imposte alla generalità di coloro che si trovano in un determinato
territorio).
Dunque, attraverso l’esercizio della sovranità, così come regolato dal diritto pubblico, questi soggetti
regolano coattivamente la vita della generalità di coloro che si trovano sul territorio: regolano la vita degli
abitanti della polis. E’ per questo che la sovranità corrisponde al potere politico: è il potere politico;
è, cioè, il potere di regolare la vita collettiva nella polis, nella città, nel territorio comune a tutti. Si può,
perciò, anche dire che Stato, Regioni, Province, Comuni ed Unione Europea esercitano – ovviamente
con delle differenziazioni – il potere politico.
Insomma, Stato, Regioni, Province, Comuni ed Unione Europea possono imporre a tutti ed a
ciascuno di noi delle norme da rispettare, ma nel farlo devono a loro volta rispettare delle norme: quelle,
per esempio, che stabiliscono se a decidere su una questione debba essere la Regione o il Comune; quelle
che stabiliscono se a decidere debba essere il Parlamento o, altrimenti, il Governo; quelle che stabiliscono
ciò che può essere deciso ed anche ciò che non può essere deciso; quelle che stabiliscono come si fanno i
processi per stabilire eventuali sanzioni a carico di chi, eventualmente, si fosse comportato in modo
difforme rispetto alla norma; etc. etc. etc. Bene, tutte queste norme che regolano l’esercizio della
sovranità – del potere politico – formano quello che chiamiamo diritto pubblico.
Tra tutti questi soggetti pubblici (cioè, dotati di sovranità), il primo ad essersi storicamente
affermato è lo Stato. Solo successivamente, e per volontà dello stesso Stato, la sovranità è stata ripartita tra
la pluralità degli altri soggetti che abbiamo appena indicato.
E’, dunque, dello Stato che occorre iniziare a parlare.
LO STATO
Lo Stato – così come oggi lo intendiamo: nel senso moderno, odierno, del termine – nasce tra il ‘400
ed il ‘600: nasce, cioè, al momento del superamento della società feudale.
Una società – quella feudale – in cui il potere politico era frammentato e territorialmente gestito da
una pluralità di soggetti; tra questi, i più importanti ed i più potenti: il papa ed il re; ma anche i Comuni, i
signori feudali, le corporazioni. Ognuno di questi soggetti gestiva un frammento del potere politico (più o
meno grande) e lottava con il proprio esercito contro gli altri soggetti per accrescere (a scapito degli altri) la
dimensione del proprio potere. Insomma, una vera e propria lotta per il potere politico.
Lo Stato nasce precisamente nel momento in cui questa frammentazione viene superata ed un solo
soggetto diventa titolare di tutto il potere politico. E’ proprio ciò che avviene tra il’400 ed il ‘600 (in anni
1
diversi, a seconda degli Stati): quando il re sconfigge il papa e si afferma detentore unico del potere
politico.
Lo Stato, perciò, nasce nel momento in cui il potere politico – precedentemente frammentato in una
pluralità di soggetti – viene centralizzato: nel momento in cui del potere politico si individua un centro di
ogni decisione politica. E questo centro è il re.
Dunque, lo Stato nasce come monarchia: nasce avendo a capo un re e nasce nella forma della
monarchia assoluta.
FORMAZIONE DELL’APPARATO DELLO STATO
Il re, sbaragliato ogni antagonista nella lotta per il potere politico, diventa l’unico soggetto che possa
assumere decisioni relative alla vita collettiva e ne possa imporre il rispetto ricorrendo, se necessario,
all’uso della forza.
Si tratta, tuttavia, di un potere che, per sua natura, richiede che il re si avvalga dell’opera di altri
soggetti. Di una forza armata, per esempio: nel caso specifico, a quell’epoca, di un esercito.
In realtà, il re aveva già un esercito, che gli aveva garantito la vittoria contro il papa; ma un esercito
aveva anche quest’ultimo, così come lo avevano i Comuni ed i signori feudali. Ora, nel momento in cui
l’intero potere politico è esercitato dal re, questi eserciti non hanno più ragion d’esistere: devono essere
eliminati o inglobati in quello del re. Quello del re deve diventare un esercito nazionale, in grado di
pretendere il rispetto delle decisioni del re in ogni angolo del territorio nazionale.
E poi, occorre una magistratura: occorre un certo numero di giudici incaricati di dirimere eventuali
liti, stabilendo, tra le parti, ragione e torto.
Esercito e magistratura, necessari ad imporre il rispetto delle decisioni del re. Ma anche nel decidere,
il re non può essere solo. Le decisioni da prendere sono tante – ed, a volte, così complesse – che nessuna
persona al mondo potrebbe pretendere di decidere tutto da sola. E’ bene farsi aiutare da persone di
propria fiducia, ad ognuna delle quali si affidi l’incarico di seguire uno specifico settore e di decidere in
merito alle questioni che lì, in quel settore, si pongono: una per la difesa nazionale, una per i rapporti con
gli altri Stati, una che si incarichi di seguire le questioni dell’ordine pubblico all’interno del territorio,
un’altra che si occupi di sanità pubblica, etc. Persone che stiano al servizio (ministri) del re, per coadiuvarlo
nelle sue decisioni. Insomma, il re deve formare un suo governo.
Esercito nazionale, magistratura, governo … tutto questo costa: costano gli armamenti, costano i
tribunali e le prigioni, costano i militari, i giudici, i ministri … per non dire della vita di corte dello stesso re …
E chi paga?! Occorre introdurre delle imposte ed assicurarsi del fatto che i contribuenti le paghino e le
paghino nella misura stabilita. Un certo numero di persone deve essere destinato proprio a questo
compito. Costoro andranno a formare l’apparato fiscale: più semplicemente, il fisco.
Esercito nazionale, magistratura, governo, fisco … cominciano ad intravvedersi quelle strutture
(quegli organi) tipiche di ciò che noi, ancora oggi, in sintesi, chiamiamo Stato. Strutture – organi – che,
tutte insieme, e ciascuna con un proprio specifico compito, consentono allo Stato di esercitare la sovranità.
Ed allora, possiamo definire lo Stato come quella organizzazione – quell’apparato – che
esercita la sovranità su un territorio e sulla comunità che in quel territorio vive .
2
Certo, possiamo distinguere tra i vari organi dello Stato. Possiamo distinguere dal punto di vista dei
compiti affidati a ciascuno, ad esempio. Ed, infatti, vi sono organi che hanno il compito di prendere le
decisioni (questi, all’epoca, erano il re ed il suo governo): questi organi si dicono politici.
Altri organi, invece, hanno il compito di eseguire le decisioni prese dagli organi politici. Gli organi con
funzioni esecutive si dicono burocratici.
Nel tempo – molti secoli dopo la nascita delle prime monarchie – si vedrà che gli organi politici
diventeranno elettivi e, perciò, temporanei (l’incarico politico, cioè, sarà affidato tramite elezione
popolare e, perciò, valido fino alle nuove elezioni); mentre l’incarico burocratico sarà attribuito per
concorso e, una volta attribuito, sarà da considerare tendenzialmente stabile (cioè valido per tutta la vita
del lavoratore).
In conclusione, possiamo definire lo Stato come quella organizzazione – quell’insieme di
organi politici e burocratici – che esercita la sovranità su un territorio e sulla comunità che in
quel territorio vive.
LO STATO ASSOLUTO
Il re, dunque, concentra nelle sue mani tutto il potere politico, forma un suo governo, costituisce un
esercito nazionale ed una magistratura, struttura un apparato fiscale.
Attraverso tutte queste strutture, il re decide sulla vita collettiva ed impone le sue decisioni. In
questa attività decisionale e, poi, impositiva delle decisioni, il re non trova alcun limite: non trova, cioè,
norme giuridiche che limitino la sua volontà, né dal punto di vista del contenuto, né dal punto di vista delle
procedure con le quali le decisioni vengono prese. Insomma, il re decide ciò che vuole – prende le decisioni
che vuole – e decide come vuole: non ci sono norme giuridiche limitative del suo potere.
Quello del re, dunque, si definisce come potere assoluto, e la prima forma di Stato – quella di cui,
appunto, stiamo parlando – come monarchia assoluta.
Il termine assoluto, infatti, deriva dal latino ab solutum: senza limite, senza quei limiti giuridici
(che, invece, successivamente, saranno introdotti) costituiti dalle norme giuridiche di
regolamentazione del contenuto e delle procedure della sovranità. Ma perché quei limiti – quelle
norme – vengano introdotte, bisognerà attendere la fine del 18° secolo, la Rivoluzione Francese e
l’emanazione delle Costituzioni.
Al cospetto del potere assoluto del re, tutti gli altri devono, per definizione, subordinarsi: al cospetto
del potere del re, tutti gli altri sono sudditi: soggetti privi di diritti, senza diritti.
E sono sudditi necessariamente: la sudditanza dei membri della comunità è l’altro lato della medaglia
del potere assoluto del re. Infatti, se i membri della comunità avessero diritti, il re non potrebbe decidere
qualunque cosa, ma solo ciò che non fosse in contrasto con questi diritti. Se i membri della comunità
avessero diritti, il potere del re sarebbe limitato, non assoluto! Ne deriva, dunque, che la natura assoluta
del potere del re implica, necessariamente, che la comunità sia costituita da soggetti privi di diritti:
subordinati, appunto; tecnicamente, sudditi.
E’ proprio questo che caratterizza e distingue lo Stato assoluto dalle altre forme di Stato che si
susseguiranno nel corso della storia: il rapporto tra una organizzazione (lo Stato) dotata di una sovranità
assoluta ed una comunità costituita da soggetti privi di qualunque diritto, una comunità di sudditi.
3
Quello del re è, dunque, un potere assoluto, illimitato. Il re può tutto: è onnipotente. Opera in terra
come Dio nel cielo: è una sorta di Dio in terra. Ed, infatti, viene assunto come scelto da Dio: gode di
un’investitura divina. E’ Dio che l’ha scelto, è lui che gli ha conferito l’incarico di governare: così si dice, per
giustificare il potere del re nella sua onnipotenza.
E, d’altra parte, non potendosi giustificare l’attribuzione del potere politico come espressione della
volontà popolare (così sarebbe oggi, in conseguenza delle elezioni), necessariamente doveva offrirsi
un’altra giustificazione: se l’incarico non può giustificarsi dal basso (dal popolo), deve giustificarsi dall’alto
(appunto, da Dio).
Si istituisce così un’analogia tra la potenza di Dio in cielo e quella del re in terra: questi governa in
nome di Dio; per volontà di Dio; come emissario di Dio.
C’è, però, un problema: che Dio, nella sua onnipotenza, è solo a governare dal cielo; il re, nella sua
onnipotenza è solo a governare in terra. Dio è spirito; il re è, comunque, un uomo e, dunque, in quanto
uomo, non può non temere i tentativi terreni, umani di rovesciare il suo potere. L’onnipotenza del re lo
eleva rispetto a tutti gli altri membri della comunità (tutti suoi sudditi), ma, al contempo, lo isola rispetto a
tutti gli altri: in una condizione di totale solitudine e, perciò, anche, di infinita debolezza, possibile vittima di
qualunque congiura, di qualunque tentativo di destituzione violenta.
Occorre che il re si renda meno solo: che si crei un consenso sociale; che intorno a lui si crei una
massa di uomini che si avvantaggiano delle sue scelte e che, perciò, lo vogliono al potere. Meglio se si tratta
di uomini importanti, influenti nella vita sociale: uomini dalle decisioni dei quali derivino i destini, più o
meno felici, di tanti. Meglio, insomma, se il consenso proviene dalla classe economicamente (e, dunque,
socialmente) dominante.
All’epoca – si ricordi: siamo tra il ‘400 ed il ‘600 – l’economia era ancora pressochè totalmente
agricola: il destino degli uomini, dunque, dipendeva dalle decisioni dei proprietari terrieri (degli
aristocratici): a seconda che questi decidessero di tenere incolti i propri terreni, o di darli in affitto agli
imprenditori agricoli … a seconda del livello degli affitti pretesi … le condizioni di vita della popolazione
potevano migliorare di molto o, al contrario, di molto peggiorare, fino alla morte per fame. Erano questi – i
proprietari terrieri: la classe dell’aristocrazia – la classe dominante. E’ di questa classe che il re cerca,
riuscendoci, di conquistare il consenso.
Il re, perciò, cerca il consenso degli aristocratici prima di tutto formando un governo aristocratico:
scegliendo i ministri dalle file dei proprietari terrieri. Ed il governo aristocratico, ovviamente, adotta
politiche favorevoli agli interessi dell’aristocrazia, piuttosto che a quelli della (nascente) borghesia
capitalistica (la classe degli imprenditori): in particolare, il governo aristocratico pratica
una politica economica protezionistica; ed
una politica fiscale squilibrata a vantaggio delle rendite.
Per politica protezionistica si intende una politica che impone elevati dazi doganali alle
merci importate dai Paesi esteri, così da determinare un aumento dei prezzi degli stessi e
spingere la domanda interna verso l’acquisto di beni prodotti sul territorio nazionale .
E’ chiaro che una politica di questo tipo, eliminando o riducendo i beni di importazione (all’epoca,
essenzialmente, i beni alimentari), spinge ad aumentare la produzione nazionale di quei beni, almeno fino
al livello dei bisogni di sopravvivenza della popolazione. Di conseguenza, con una politica di questo tipo,
aumenta la domanda di beni alimentari prodotti all’interno, questo fa aumentare la necessità di
produzione interna di quei beni; da ciò, la necessità di aumentare la produzione agricola
4
mettendo a coltura sempre nuova terre: aumenta la domanda di terre e, con questa, le rendite
(cioè i redditi dei proprietari terrieri).
Dal punto di vista della politica fiscale il governo aristocratico riduce il carico tributario sulle
rendite e lo aumenta sui profitti (cioè, sul reddito degli imprenditori) .
In definitiva, dal punto di vista di classe, nello Stato assoluto:
l’aristocrazia vede aumentare le proprie rendite e, su queste, paga anche meno tasse;
la borghesia, paga rendite (affitti) più alti ed anche più tasse allo Stato.
Lo Stato assoluto rappresenta il dominio dell’aristocrazia – sia sul piano economico, che su quello
politico – sulla borghesia capitalistica.
E, tuttavia, malgrado tutto, la borghesia capitalistica non ha poi da lamentarsi troppo. Infatti, la
novità fondamentale costituita dallo Stato assoluto consiste nell’aver unificato l’intero territorio nazionale
sotto il potere politico del re, eliminando tutte quelle zone territoriali che precedentemente erano
attribuite a terzi (papa, Comuni, signori feudali). Ora le decisioni del re – che, ovviamente, si esprimono
nella forma di norme giuridiche – valgono su tutto il territorio dello Stato. L’ordinamento giuridico diventa
un ordinamento giuridico nazionale: regola, ad esempio, l’attività d’impresa allo stesso modo dalla Sicilia
alla Val d’Aosta. E’ per questo che, ora, un’impresa siciliana può vendere (se ne è capace) anche in Val
d’Aosta, ed un’impresa valdostana anche in Sicilia. Cioè, insomma, il mercato di riferimento delle
imprese non è più locale, ma nazionale, perché nazionale è, ormai, l’ordinamento giuridico . Lo
Stato assoluto, unificando l’ordinamento giuridico, unifica il mercato nazionale.
Ogni impresa, perciò, può ora contare su una domanda ben più ampia che in precedenza: una
domanda nazionale; dunque, può vendere di più e, vendendo di più, ottenere maggiori profitti; questi
possono essere, almeno in parte reinvestiti nell’azienda, così che questa si ingrandisca sempre di più e
diventi economicamente sempre più importante… Tutto questo è proprio ciò che le imprese fanno negli
anni dello Stato assoluto, diventando via via sempre più grandi ed economicamente forti.
In definitiva, è vero che nello Stato assoluto la classe economicamente dominante – tanto dal punto
di vista economico, che politico – è l’aristocrazia; e, tuttavia, per la ragione appena detta, la borghesia
accetta ben volentieri la sua condizione di subordinazione economica e politica, avvantaggiandosi
dell’unificazione del mercato, conseguenza dello Stato assoluto.
Insomma, dal punto di vista dei rapporti di classe, può dirsi che lo Stato assoluto è un compromesso:
tra l’aristocrazia e la borghesia, sebbene a vantaggio dell’aristocrazia.
LO STATO LIBERALE
Dunque, nello Sato assoluto, malgrado il protezionismo e la politica fiscale sbilanciata a favore
dell’aristocrazia, le imprese diventano sempre più grandi e sempre più alti i livelli di profitto. Una parte di
questi viene reinvestita nelle innovazioni tecnologiche in agricoltura, ed una parte comincia ad essere
investita in aziende manifatturiere (prima artigiane, poi industriali) sempre più grandi e sempre più
produttive.
Insomma, sempre più ingenti diventano i capitali investiti in agricoltura e, sempre di più,
nell’industria: sempre più ricchi ed economicamente decisivi per le sorti della società diventano gli
imprenditori capitalisti.
5
Ormai, nel ‘700, non è più possibile parlare dell’aristocrazia come sola classe dominante. Forse, dal
punto di vista economico, non aveva ancora perso il suo dominio: l’agricoltura rimaneva un settore
economico fondamentale, benchè sempre meno importante; la preminenza economica dell’aristocrazia
terriera, perciò, permaneva ma sempre meno netta e sempre più affiancata (fino ad essere superata) dalla
borghesia capitalistica (soprattutto, commerciale ed industriale).
E, tuttavia, all’ascesa economica della borghesia continuava a fare riscontro il persistente dominio
politico della sola aristocrazia, secondo l’assetto del potere politico che abbiamo descritto nello Stato
assoluto.
Una contraddizione, evidentemente, sempre meno accettabile. La borghesia, non più, ormai, classe
dominata, non poteva ancora accettare di essere esclusa dall’esercizio del potere politico, limitandosi a
subire le politiche economiche decise dal governo aristocratico.
Non è un caso che le rivolte borghesi nei paesi anglosassoni si fanno al grido: “no taxation without
rappresentation”; “nessuna tassazione senza rappresentanza”: non accettiamo più di pagare le tasse allo
Stato, senza che ci siano nostri rappresentanti negli organi politici dello Stato.
Occorre che nell’organizzazione dello Stato sia previsto un organo rappresentativo (della comunità …
in realtà, vedremo, più precisamente: della borghesia).
Un organo che, per essere rappresentativo della borghesia, deve essere da questa eletto: deve, cioè,
essere espressione del voto dei borghesi.
Con la Rivoluzione Francese, la borghesia rivendica l’istituzione di un Parlamento, quale organo
rappresentativo eletto tramite voto censitario (il cui esercizio, cioè, veniva riconosciuto solo a coloro
che fossero in possesso di un certo livello di censo, di reddito).
Occorreva che il re emanasse una Costituzione, cioè un documento solenne nel quale fosse
riconosciuto da un lato il diritto di voto, dall’altro fosse istituito il Parlamento.
Ma anche questo non bastava: non poteva bastare!
Infatti, votare significa scegliere: tra cosa?! Tra opinioni politiche diverse, evidentemente! E, dunque,
occorreva che la Costituzione riconoscesse anche la libertà di manifestazione del pensiero, e – siccome il
Parlamento era un organo dello Stato e, perciò, un organo nazionale – che le differenti idee politiche
potessero esprimersi liberamente sugli organi di stampa: così che tutti potessero esserne informati. Cioè,
insomma, il diritto di voto comportava il diritto alla libertà di stampa.
Una libertà di parola, di pensiero, di stampa che doveva potersi esplicare in ogni campo: da quello
politico, a quello culturale … anche a quello religioso (allora, come oggi, molto importante). Insomma,
occorreva che tutti potessero professare e difendere liberamente la propria religione, così come esprimere
le proprie idee politiche, o artistiche o culturali … senza che qualcuno potesse immaginare di sanzionarlo in
conseguenza di quelle idee. E’ il diritto alla libertà personale, in base al quale nessuno può essere
ristretto nei suoi movimenti e nella sua libertà (insomma, nessuno può essere incarcerato) se non in
conseguenza di un reato commesso (e non della libera espressione di una sua opinione).
In definitiva, nel corso del ‘700, con la Rivoluzione Francese, la borghesia capitalistica rivendica
l’emanazione di una Costituzione che riconosca una serie di diritti ai membri della comunità:
6
il diritto di voto;
la libertà di manifestazione del pensiero;
la libertà di culto;
la libertà di stampa;
la libertà personale.
E nemmeno questo basta, perché nessuno può a priori garantire che il governo del re, anziché –
come dovrebbe – operare per tutelare questi diritti, in realtà non utilizzi l’esercito (la forza armata) per
reprimere le libertà di chi col governo non è d’accordo.
Il governo è un organo pericoloso: siccome è lui che dispone della forza armata e delle risorse
economiche che derivano dalle entrate fiscali, potrebbe utilizzare questi due strumenti per colpire le libertà
degli oppositori.
Dunque, è necessario: che la Costituzione dichiari inviolabili i diritti dell’uomo; che i poteri del
governo vengano limitati e controllati.
E così accade: il re, costretto dalla Rivoluzione, concede (è costretto a concedere) una Costituzione:
queste Costituzioni, le prime Costituzioni, infatti, si dicono concesse. Le Costituzioni sono divise in due
parti:
nella prima parte riconosce i diritti inviolabili dell’uomo e del cittadino;
nella seconda parte, così come suggerito da Montesquieu, organizza la sovranità sulla base
del principio della divisione dei poteri.
Il carattere di inviolabilità che la Costituzione riconosce ai dritti dell’uomo e del cittadino – il fatto
che questi vengano definiti inviolabili – sta a significare che a nessun soggetto è permesso violarli:
nessuno può reprimerli, soffocarli, negarli … Sta a significare che essi sono costitutivi della stessa
natura dell’uomo e, perciò, dello Stato.
Nemmeno lo Stato, dunque, nemmeno il governo può reprimere i diritti costituzionalmente
riconosciuti: al contrario, lo Stato, il governo si impegna a rispettarli integralmente; così come, d’altra parte,
lo Stato pone a suo fondamento la Costituzione e si obbliga a rispettarla in ogni sua parte; così come, lo
Stato si impegna al rispetto delle sue proprie leggi, del suo stesso ordinamento giuridico. Lo Stato, nel suo
operare, si obbliga a rispettare il principio di legalità: ad operare nel rispetto delle leggi e, prima di
tutto, della sua stessa Costituzione.
La divisione dei poteri, ideata da Montesquieu, serve proprio a cercare di garantire meglio il
rispetto del principio di legalità da parte del governo.
Esso, infatti, prevede che i poteri del governo vengano ridotti al solo potere esecutivo (potere
amministrativo) e che questo venga sottoposto ad un duplice limite: quello costituito da un
Parlamento dotato del potere legislativo; quello di una magistratura – autonoma ed indipendente
rispetto al Parlamento ed al governo – dotata del potere giurisdizionale e, dunque, incaricata anche
di verificare il rispetto delle leggi da parte del governo, così come il rispetto della Costituzione da parte del
Parlamento.
Insomma, lo schema è questo:
7
il governo non decide: esegue quanto deciso dal Parlamento con le leggi;
il Parlamento approva le leggi nel rispetto pieno della Costituzione;
la Magistratura controlla che gli atti di esecuzione del governo siano conformi alla legge,
altrimenti li annulla; e controlla che le leggi siano conformi alla Costituzione, altrimenti le
annulla.
In questo modo, con la divisione dei poteri, si cerca di limitare e di controllare il potere del governo
che, altrimenti, se mal utilizzato, rischierebbe di annullare i diritti e le conquiste ottenuti con la Rivoluzione
Francese.
Ma, come sempre, tutto questo assume significato e giustificazione solo alla luce della sostanza
economica dei rapporti tra le classi sociali all’epoca dominanti: l’aristocrazia terriera, in fase di decadenza;
la borghesia capitalistica, in fortissima ascesa.
I rapporti di forza tra queste due classi sociali si ribaltano, definitivamente, proprio con la Rivoluzione
Francese. Le Costituzioni stabiliscono, nella loro prima parte, i principi di uguaglianza e di libertà di
tutti gli uomini: affermano, per la prima volta nella storia dell’uomo, che tutti gli uomini sono
ugualmente liberi; che, cioè, hanno uguali diritti, le stesse libertà. Che, dunque, i diritti che la
Costituzione riconosce (che le leggi riconoscono) sono riconosciuti ugualmente a tutti gli uomini,
senza distinzioni.
E’ l’uguaglianza giuridica degli uomini: l’uguaglianza degli uomini di fronte alla legge. E’ con
questo motto che si è realizzata la Rivoluzione Francese: libertè, egalitè!!
Con la sua affermazione, decadono le caste sociali tipiche della società feudale pre-borghese, e si
affermano le classi sociali. Al posto di raggruppamenti umani fissi, rigidi: chi nasceva contadino moriva
contadino; si affermano le classi sociali: raggruppamenti di uomini accomunati dallo stesso
(ipoteticamente) momentaneo rapporto con il lavoro: la classe dei lavoratori subordinati (proletariato); la
classe degli imprenditori capitalisti, sovraordinati alla forza lavoro in quanto proprietari d’azienda.
Raggruppamenti dai quali, riuscendoci, era possibile uscire: un operaio poteva, in teoria, diventare
capitalista o, anche, semplicemente, agiato, ricco. Come, ad un capitalista, se le cose fossero andate male,
era possibile, in teoria, cadere nel gruppo dei lavoratori subordinati.
La struttura di classe, sottesa allo Stato che emerge dalla Rivoluzione Francese, vede, dunque, una
classe subordinata (quella del proletariato); una classe dominante, ma in decadenza: l’aristocrazia; una
classe dominante ed in impetuosa ascesa: la borghesia capitalistica.
Questa struttura di classe della società si rivela con assoluta chiarezza nella struttura dello Stato. Il
Parlamento, infatti, è costituito da due Camere: una Camera Alta, di nomina regia e destinata a
rappresentare gli aristocratici; una Camera Bassa, eletta con diritto di voto censitario, destinata a
rappresentare la borghesia capitalistica.
La prevalenza, sempre più netta, della borghesia sull’aristocrazia, è resa evidente dal fatto che, nel
tempo, la Camera Bassa è andata acquisendo sempre più potere, al cospetto di una Camera Alta che,
invece, è andata perdendo potere.
La subordinazione (anche) politica del proletariato è resa evidente dall’esclusione dei lavoratori dalla
possibilità di esercitare il diritto di voto: non più per ragioni di casta, ma per ragioni censitarie. Di fatto,
tuttavia, dall’esclusione dal Parlamento di qualunque forma di rappresentanza degli interessi dei lavoratori.
Una subordinazione politica – quella dei lavoratori – derivante, come sempre, da una subordinazione
economica giuridicamente sancita.
8
Le Costituzioni borghesi, infatti, non dimenticavano affatto gli aspetti economici del vivere
collettivo e ben rappresentavano – anche da questo punto di vista – gli interessi della nuova classe
dominante (la borghesia capitalistica), lì dove riconoscevano e garantivano la proprietà privata (in
generale e, dunque, anche quella dei mezzi di produzione) e la libertà di iniziativa economica
privata (cioè la libertà, per chi avesse risorse economiche, di farne libero uso per i suoi privati
interessi).
Insomma, le Costituzioni sancivano giuridicamente l’assetto capitalistico della società, lasciando
che fossero i privati ad occuparsi delle questioni economiche e prevedendo per lo Stato un ruolo minimo
all’interno del sistema.
In definitiva, volendo sintetizzare schematicamente le caratteristiche di questa nuovo Stato, che
sorge in conseguenza della Rivoluzione Francese, dovremmo dire che si tratta di uno Stato
costituzionale, in quanto si organizza ed opera secondo quanto è previsto dalla
Costituzione;
di diritto, in quanto pone a suo fondamento il principio di legalità, obbligandosi al
rispetto dell’ordinamento giuridico;
rappresentativo, in quanto, attraverso le elezioni, il potere politico si esercita non più
in nome di Dio, ma in nome del popolo;
elitario, in quanto, per effetto della natura censitaria del voto, il Parlamento
rappresenta solo un piccolo gruppo (èlite) di cittadini;
laico, in quanto, riservando a sé il potere politico ed escludendo da esso ogni pretesa
della Chiesa, riconosce, tuttavia, a tutte le fedi religiose pari dignità e pari libertà di
esercizio sul piano spirituale;
liberista, in quanto, riducendo al minimo il proprio intervento, lascia che la materia
economica sia sostanzialmente campo d’azione dei soli soggetti privati.
Bene, uno Stato che abbia queste caratteristiche, si definisce, sinteticamente, liberale.
Per effetto della Rivoluzione Francese alla forma di Stato assoluto succede quella liberale.
Quest’ultima è, perciò, cronologicamente, la seconda forma di Stato.
Nel mentre nello Stato assoluto l’apparato statale doveva confrontarsi con una comunità di soggetti
privi di qualunque diritto, con una comunità di sudditi; nello Stato liberale il rapporto comincia a
rovesciarsi: nel senso che l’apparato statale esercita il potere politico su mandato di una comunità di
soggetti dotati di diritti (di cittadini). La comunità dei sudditi si trasforma in popolo: comunità di
cittadini, di soggetti dotati di diritti.
In questo passaggio storico possiamo rinvenire i primi segni del passaggio da un concetto di Stato
come organizzazione che esercita la sovranità su un popolo stanziato in un determinato
territorio (Stato-organizzazione), al concetto di Stato come comunità che, stanziata su un
territorio, si organizza per l’esercizio della sovranità (Stato-comunità).
POPOLO, TERRITORIO, SOVRANITA’
9
Lo Stato, dunque, è l’organizzazione che esercita la sovranità su un popolo stanziato su un
determinato territorio.
Territorio, popolo e sovranità sono i tre requisiti dello Stato: sono i tre elementi in assenza
dei quali non è possibile parlare di Stato.
Per territorio si intende un insieme di elementi, quali:
la terraferma, cioè la parte di crosta terrestre sulla quale lo Stato esercita la
sovranità e separata da quella di altri Stati tramite i confini;
il sottosuolo;
lo spazio aereo (disponibile per i velivoli);
le acque territoriali (che si estendono fino a 12 miglia dalla costa);
le navi e gli aerei, anche se momentaneamente si trovano sul territorio di altri Stati;
le sedi diplomatiche (consolati ed ambasciate).
Su tutto questo vale la sovranità dello Stato di appartenenza.
La questione del popolo, invece, è più interessante.
Per popolo, infatti, si intende la comunità dei cittadini dello Stato: cioè, il gruppo di coloro
che hanno la cittadinanza di un determinato Stato, anche se, eventualmente, al momento, si
trovano all’estero.
Fanno parte del popolo italiano tutti coloro che hanno cittadinanza italiana, che siano o meno in
Italia. Non fanno parte del popolo italiano coloro che non hanno cittadinanza italiana, anche se, al
momento, si trovano in Italia.
Così è da un punto di vista giuridico. E, dunque, da questo punto di vista, importante è sapere come
si acquisisce la cittadinanza di uno Stato: che sarebbe come dire, in che modo si diventa cittadini di uno
Stato, componenti del suo popolo. E su questo, specificamente torneremo, in riferimento al caso italiano.
Ma, intanto, dal punto di vista politico, importante è dire che non è possibile parlare di popolo nello
Stato assoluto. Se, come abbiamo detto, per popolo si intende l’insieme dei cittadini e se, per cittadini,
politicamente intendiamo soggetti titolari di diritti, allora dobbiamo dedurne che la comunità, nello Stato
assoluto, era costituita da sudditi, non da cittadini! Quella dello Stato assoluto era una comunità di
sudditi.
Tale comunità si trasforma in popolo nel momento in cui, alla fine del ‘700 e per effetto
dell’emanazione delle Costituzioni, ai membri della comunità vengono riconosciuti dei diritti: in quel
momento, i sudditi si trasformano in cittadini, al rapporto di sudditanza si sostituisce quello di
cittadinanza e la comunità diventa politicamente un popolo.
Di qui, dunque, l’importanza del riconoscimento della cittadinanza. Ad essa sono legati una serie di
diritti: per esempio, il diritto all’elettorato attivo (cioè il diritto di voto) e all’elettorato passivo (cioè
il diritto di candidarsi alle elezioni per ottenere, se ci si riesce, dei voti ed essere, eventualmente,
eletto); per esempio, il diritto al soggiorno ed alla libera circolazione sul territorio nazionale. Altri
10
diritti, invece, sono propri di tutti gli uomini a prescindere dalla cittadinanza: il diritto alla libertà di
manifestazione del pensiero, quello all’integrità personale, quello alla salute.
Insomma, la pienezza dei diritti costituzionali è legata al riconoscimento della cittadinanza: è legata al
fatto che si venga riconosciuti come cittadini dello Stato.
Ora, nel caso italiano, la cittadinanza si acquisisce in tre possibili modi :
per nascita: quando chi nasce ha almeno un genitore (mamma o padre) italiano;
per matrimonio: quando ci si sposa con un italiano o una italiana;
per concessione: quando, dopo dieci anni di residenza in Italia, chi non ha la
cittadinanza italiana la chiede al Capo dello Stato e questi, verificato l’esistenza dei
requisiti, residenza, buona condotta, reddito … la concede.
E’ evidente che, essendo così giuridicamente importante acquisire la cittadinanza, soprattutto in
tempi di forti flussi migratori come gli attuali, in Italia si è aperta una lunga e tesa discussione intorno ai
criteri di attribuzione della cittadinanza. In particolare è stato messo in discussione il primo criterio di
attribuzione della cittadinanza: quello che abbiamo indicato “per nascita”.
Questo criterio, infatti, risponde al principio del cosiddetto jus sanguinis: diritto di sangue, in
base al quale è cittadino italiano chi ha sangue italiano; chi ha almeno un genitore italiano.
Come si fa, si è detto, a non riconoscere la cittadinanza a chi nasce in Italia, frequenta le scuole
italiane, parla italiano (e, spesso, anche il dialetto locale), lavora in Italia ed in Italia paga le tasse … per il
solo fatto di avere genitori non italiani?! Questa situazione non pare accettabile!
Bisogna affiancare allo jus sanguinis lo jus soli (il diritto di suolo): in base al quale è cittadino
italiano chi nasce in Italia (anche, eventualmente, da genitori non italiani) .
Questo consentirebbe di attribuire la cittadinanza a molti stranieri giunti in Italia attraverso i recenti
flussi migratori, consentendo loro di entrare a far parte della comunità dei cittadini italiani e, così,
favorendone l’integrazione. E, tuttavia, come facilmente si capirà, in molti non sono affatto d’accordo con
questa indicazione: si pensi alla Lega Nord, ad esempio, o, in generale alle forze politiche di destra o,
comunque, nazionaliste … e, in conclusione, la discussione è ancora in corso e non pare avrà uno sbocco in
tempi stretti.
La sovranità consiste nel potere impositivo dello Stato, nel potere politico: nel potere,
cioè, di imporre alla comunità dei cittadini determinate regole di comportamento (norme
giuriche).
Come abbiamo visto, nello Stato moderno la sovranità nasce come assoluta, senza limiti normativi. E’
solo successivamente – con la nascita dello Stato liberale – che viene limitata in conseguenza
dell’emanazione delle Costituzioni e del diritto di voto da queste previsto (e, dunque, del controllo popolare
sulle decisioni politiche). Vedremo, in seguito, che, nel corso della storia, la sovranità dello Stato andrà
subendo ancora ulteriori limitazioni.
LA QUESTIONE SOCIALE E LA CRISI DELLO STATO LIBERALE
Lo Stato liberale, abbiamo detto, istituisce una sorta di compromesso tra borghesia (nuova classe
dominante) ed aristocrazia (vecchia classe dominante ma, ormai, in decadenza).
11
Ma lo scontro sociale, a partire dall’800, non sarà più tra borghesia ed aristocrazia, bensì tra
borghesia ed la nuova classe sociale dei lavoratori dipendenti: quella che Marx chiama proletariato.
La formazione di questa nuova classe sociale è la conseguenza dello sviluppo industriale del ‘700 e
dell’800 e della formazione delle grandi fabbriche in luogo delle vecchie imprese artigiane.
Lo sviluppo industriale determina da un lato la forza economica della borghesia capitalistica che di
quelle fabbriche ha la proprietà; dall’altro, l’estensione numerica delle file dei lavoratori dipendenti che,
sempre più numerosi, sono necessari in fabbriche sempre più grandi.
Ed è evidente che tra queste due classi il rapporto sociale è giocato sullo scontro! Per effetto di
interessi assolutamente contrapposti e per la prevalenza degli interessi della borghesia capitalistica rispetto
a quelli del proletariato.
I lavoratori, infatti, stretti nella morsa del ricatto della minaccia di licenziamento e della drammatica
disoccupazione di tanti, sono di fatto costretti ad accettare condizioni di lavoro pessime: con orari
lunghissimi (12-14 ore al giorno), salari bassissimi (a livello di sussistenza) ed assenza di qualunque diritto.
Si comprende, perciò, come i lavoratori, nel corso dell’800, abbiano dato vita ad una ventata di lotte
sociali tesa a migliorare le proprie condizioni di vita ma, soprattutto e prima di ogni altra cosa, a
conquistare diritti.
E’ ciò che si è definito questione sociale: la questione costituita dalle pessime condizioni di
vita dei lavoratori e, conseguentemente, dalle lotte da questi poste in essere per riuscire a
migliorarle.
L’800 è, in buona parte, segnato dalla questione sociale!
I lavoratori, dunque, vivono in condizioni pessime e cercano, con ogni mezzo possibile, di migliorare
le proprie condizioni di vita.
“Con ogni mezzo possibile”: ma, quali sono “i mezzi possibili”?
Non ce ne sono! Non sono previsti! Le Costituzioni liberali non li riconoscono!
Le Costituzioni liberali riconoscono sì dei diritti: importanti, fondamentali … ma si tratta di
diritti individuali, diritti dell’uomo (singolo) e del (singolo) cittadino. I liberali pensano la società
come l’insieme dei singoli uomini, dei singoli cittadini: ed a questi singoli che, tramite le
Costituzioni, riconoscono dei diritti!
Ora, una simile visione della società (ed un ordinamento giuridico costruito su queste basi) se può
andar bene per un imprenditore capitalista – per un soggetto dotato di un proprio (caso mai, persino
ingente) patrimonio, non può, certo, andare bene per un lavoratore, che altra ricchezza non ha che quella
delle proprie braccia e delle braccia della propria prole (di qui, il termine proletariato).
Sulla base dell’ordinamento giuridico liberale, le condizioni di lavoro erano determinate dall’accordo
(accordo?) tra singolo lavoratore e singolo imprenditore. Ma chi volete che vinca in questo rapporto?! Chi
volete che riesca ad imporre i propri interessi sull’altro?! E’ chiaro: l’imprenditore! Questi avanza le proprie
proposte (?) al lavoratore, aggiungendo (esplicitamente o meno) che, se non gli piacciono… be’, è libero (?)
di non accettare (restando disoccupato) … Che straordinaria libertà! Ancor più, in considerazione delle
centinaia di miglia di disoccupati che girano per il mondo in attesa di riuscire a trovare, comunque, un
lavoro!!
12
E, dunque, guarda un po’, il lavoratore liberamente (?) accetta le proposte dell’imprenditore: in
genere, è difficile che avanzi anche una ipotesi di controproposta!! Accetta e basta, pur di non restare
senza lavoro e senza alcun reddito.
E’ sulla base di questo discorso, sulla base di questa analisi, che i lavoratori capiscono subito che, per
riuscire a migliorare le proprie condizioni di vita, devono superare il piano del confronto individuale, per
agire insieme, collettivamente. Capiscono che, se la forza dell’imprenditore è la ricchezza, quella dei
lavoratori può essere il numero: il mettersi insieme, il difendere insieme le condizioni di vita di tutti i
lavoratori, non dei singoli.
Ma, per far questo, occorre poter esercitare dei diritti collettivi: il diritto di riunione (per poter
discutere insieme e decidere, insieme, cosa fare), il diritto di associazione (per potersi
organizzare insieme ed insieme decidere comuni iniziative), il diritto di sciopero (per far sentire
insieme la propria voce e cercare di migliorare le condizioni di vita di tutti) …
Diritti collettivi che, però, come abbiamo detto, le Costituzioni liberali non prevedevano.
Indispensabili, però, ai lavoratori nella loro lotta per migliori condizioni di vita e di lavoro.
E’ così che le prime lotte dei lavoratori comportano durissimi scontri con la polizia: le assemblee, i
cortei, gli scioperi vedono sistematicamente l’intervento della polizia inviata a ripristinare l’odine violato.
Ma i lavoratori non si fermano: non possono fermarsi! E gli scontri continuano. E i morti si contano a
centinaia.
I lavoratori lottano, prima di tutto, per i diritti collettivi: premessa indispensabile per ogni altro
discorso.
Il caos, il disordine sociale generato dalle lotte dei lavoratori, la paura, la tensione, alla fine qualcosa
determinano: i diritti collettivi, lentamente, progressivamente, vengono introdotti in
Costituzione. E, dunque, le Costituzioni cambiano nella loro prima parte: lì dove venivano
riconosciuto soltanto i diritti individuali, ora, grazie alle lotte dei lavoratori, si riconoscono anche
i diritti collettivi.
Ora, per i lavoratori, è possibile discutere, organizzarsi, manifestare, protestare, scioperare senza che
ci sia più il rischio dell’intervento della polizia! Ora la voce dei lavoratori è più libera e, dunque, è più forte!
Nascono, così, le prime associazioni dei lavoratori; in particolare, i lavoratori si organizzano sul piano
economico-sociale e sul piano politico:
sul piano economico-sociale, danno vita a quelle organizzazioni che prendono
nome di sindacati (trade unions, in Inghilterra);
sul piano politico, danno vita a quelle organizzazioni che prendono nome di partito:
nascono i primi partiti dei lavoratori.
Sindacati e partiti: gli uni – i sindacati – con il compito di agire così che i lavoratori potessero
ottenere nell’immediato salari più alti, una riduzione dell’orario di lavoro, un maggior numero di riposi e di
pause … Il partito, per estendere il diritto di voto in modo che esso diventasse esercitabile anche dai
lavoratori ed, in prospettiva, per cercare di costruire – nella prospettiva indicata da Marx – una società di
uomini liberi ed uguali, senza classi sociali, in cui non fosse distinguibile una classe di subordinati, rispetto
ad una di sovraordinati, in cui nessuno uomo fosse più subordinato ad un altro, in cui non ci fosse più
sfruttamento dell’uomo sull’uomo… Insomma, quella che Marx, appunto, chiamava società socialista o
società comunista.
13
I sindacati dei lavoratori chiedono che si riduca l’orario di lavoro, che si tuteli il lavoro delle donne e
dei bambini (si ricordi che, all’inizio della prima rivoluzione industriale, la manodopera era costituita, in
maggioranza, proprio da donne e bambini): e per ottenere tutto questo, organizzano scioperi, proteste,
manifestazioni. Una lunga serie di lotte sociali (la questione sociale, appunto), al termine della quale,
tuttavia, qualcosa ottengono: lo Stato approva leggi che riducono l’orario di lavoro e che tutelano il lavoro
delle donne e dei bambini.
Si noti, così facendo, lo Stato rinuncia alle politiche liberiste proprie dello Stato liberale,
interviene in materie economiche che, invece, secondo l’impostazione liberista, avrebbero
dovuto rimanere appannaggio dei soli operatori economici privati: lo Stato comincia ad
intervenire nel sistema economico. Da che era liberista, comincia ad adottare politiche
interventiste.
Lo sappiamo: non è la prima trasformazione dello Stato liberale indotta dalle lotte operaie.
La prima l’abbiamo richiamata prima: l’introduzione in Costituzione dei diritti collettivi, a fianco
a quelli individuali già contemplati.
Ed un terzo cambiamento avviene per effetto dell’azione dei partiti dei lavoratori. Questi, l’abbiamo
detto, rivendicano l’estensione del diritto di voto: vogliono che tutti possano andare a votare,
indipendentemente dal reddito. Certo, ci sarà bisogno di anni, ma, in conclusione, sotto questa spinta, il
livello del censo richiesto per l’esercizio del voto viene progressivamente diminuito, fino all’affermazione
del suffragio universale: e, dunque, della possibilità per tutti di votare, indipendentemente dal
proprio livello di reddito.
Una conquista straordinaria, quella del suffragio universale, che in Italia si otterrà solo nel 1912:
dopo anni di lotte e di scontri ed esclusivamente per i maschi. Bisognerà attendere il 1946 per il
suffragio universale maschile e femminile.
Un cambiamento politicamente rilevante: grazie al suffragio universale e, dunque, al voto dei
lavoratori, in Parlamento diventeranno sempre più numerosi i rappresentanti dei partiti operai e contadini
e, grazie a questi, sempre più forte si farà sentire la voce dei ceti poveri della società.
Cambiamenti - quelli indotti dalle lotte dei lavoratori – giuridicamente rilevanti: tali da modificare
alcune caratteristiche proprie dello Stato liberale. Ed, infatti: le lotte dei lavoratori spingono perché lo
Stato liberale
non sia più elitario, diventando universalmente rappresentativo: per effetto
dell’estensione del voto;
non sia più liberista, diventando sempre più interventista: per effetto delle leggi a
tutela dei lavoratori;
non contempli più solo i diritti individuali, ma riconosca anche quelli collettivi.
Si tratta di trasformazioni in senso democratico dello Stato liberale: trasformazioni che una
parte della società – in particolare le classi dominanti: la borghesia capitalistica ed, in Italia, ancora, i
proprietari terrieri del sud – non vedono affatto di buon occhio ed alle quali, vedremo, cercheranno,
tragicamente, di reagire.
14
Ma, per intanto, nel mentre in Inghilterra lo sviluppo industriale galoppa a velocità inaudita e, con
esso, il consolidamento della società capitalistica e le conseguenti lotte operaie, l’Italia è alle prese con ben
altro problema: quello della sua unità.
L’UNITA’ D’ITALIA E LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE
L’Italia ha raggiunto molto tardi la sua unità politica: dopo tutti gli altri grandi Paesi europei ed a
seguito di un processo storico molto complesso. C’è voluto l’esercito più forte presente sul territorio della
penisola – quello del Regno di Sardegna – per conquistare all’unità dello Stato i territori del sud, fino ad
allora assoggettati ai borboni. C’è voluta una spedizione militare (e la conseguente occupazione militare),
con tutte le violenze ed i morti che sempre tali situazioni determinano, perché, nel 1861 si potesse
proclamare l’unità d’Italia. E nemmeno fu sufficiente! Perché quell’unità – pur importante, fondamentale
– tuttavia, non comprendeva i territori dello Stato Pontificio e, dunque, non comprendeva Roma che, del
nuovo Stato italiano, era destinata ad essere la capitale naturale.
Ci vollero ancora 10 anni ed una nuova impresa militare (la Breccia di Porta Pia), perché, nel 1871,
anche Roma ed i territori precedentemente soggetti al potere politico del Papa, venissero, anch’essi,
integrati nel nuovo Stato.
L’unità d’Italia si è fatta sulla punta delle baionette: più un processo di annessione forzata, che di
comune determinazione. E’ facile dimostrarlo:
il re Vittorio Emanuele …., re di Sardegna, diventa automaticamente re d’Italia;
lo Statuto Albertino – la Costituzione emanata nel 1848 dal re Carlo Alberto per il
regno di Sardegna – diventa automaticamente la prima Costituzione italiana;
le leggi del regno di Sardegna diventano automaticamente le leggi dell’Italia.
Di fatto, dunque, l’Italia viene a configurarsi come un’estensione del vecchio regno di Sardegna ad
altri territori.
Questo, tuttavia, qualche problema, anche grave lo comporta. I territori annessi, quelli meridionali,
infatti, presentano molte differenze ed assai rilevanti rispetto agli altri. Solo per fare qualche esempio:
il sud è ancora, pressochè completamente, agricolo, a fronte di un nord in via di
industrializzazione;
il sud è assai povero, rispetto ad un nord con un tenore di vita europeo;
nel sud la popolazione è ancora pressochè totalmente analfabeta e, piuttosto che parlare
l’italiano, parla i dialetti locali; nel nord il livello di istruzione è mediamente più alto e la
lingua parlata, in genere, è l’italiano;
nel sud l’amministrazione pubblica borbonica è sempre stata un esempio di inefficienza; al
nord l’amministrazione pubblica si è conformata ai meccanismi dell’amministrazione
austriaca, tradizionalmente dotata di elevati livelli di efficienza.
L’unità d’Italia ha unificato sul piano politico-istituzionale popolazioni – i settentrionali ed i
meridionali – tra loro assai differenti: per condizione economica, per storia, per cultura. Il nuovo Stato,
perciò, si trova immediatamente di fronte ad un grave e complesso problema: fatta l’unità dello Stato,
15
come fare l’unità del popolo; come integrare i meridionali con i settentrionali, così da formare una sola,
compatta, comunità.
Si pone il problema – oggi, per effetto dei flussi migratori da fuori confine, più attuale che mai – delle
politiche di integrazione: quelle che, potremmo definire, politiche nazionali.
Sì, perché bisogna distinguere: un conto è il popolo, altro conto è la nazione.
Se
per popolo intendiamo l’insieme dei cittadini: di coloro che hanno cittadinanza di
uno Stato;
per nazione intendiamo l’insieme di coloro che si sentono di appartenere ad uno
stesso gruppo.
Quello di popolo è un concetto giuridico: l’insieme di coloro che hanno la cittadinanza di
uno Stato, in base alle sue leggi. Quello di nazione è un concetto culturale, psicologico: l’insieme
di coloro che si sentono, avvertono, percepiscono di appartenere ad uno stesso gruppo.
Esempio tipico di nazione è quello al quale si assiste durante una gara di baseball o di atletica
leggera, o durante una commemorazione… negli Stati Uniti d’America, quando al suono dell’inno nazionale
tutti si alzano – bianchi, neri, ispanici, asiatici, anglofoni o meno … - e cantano insieme: bene, quella è la
nazione … lo spirito di appartenenza allo stesso gruppo, anche se si ha un diverso colore della
pelle, anche se si hanno origini diverse, anche se si hanno diverse religioni e, caso mai, si parlano
lingue diverse … insomma, anche se si appartiene a differenti etnie.
Eccolo un altro importante – oggi, sempre di più – concetto: l’etnia.
L’etnia è l’insieme di coloro che sono accomunati da caratteri somatici simili, da una stessa
lingua, da una stessa religione, dalle stesse tradizioni, etc. E’ un concetto antropologico.
Oggi, gli Stati ricchi del mondo – quelli europei e quelli nord-americani – sono sempre più
multietnici, nel senso che sul loro territorio convivono etnie diverse e, sempre più spesso, soggetti
appartenenti ad etnie diverse entrano a far parte dello stesso popolo (sono cittadini dello stesso
Stato).
E’ evidente che la multietnicità comporta politiche di integrazione: politiche nazionali, che facciano
crescere quel comune spirito di appartenenza che travalica i confini etnici. Lo sanno bene gli Stati Uniti, che,
da sempre, si sono dovuti confrontare con questo problema, per altro, come si vede bene dalle cronache,
non ancora definitivamente risolto. E lo sanno – oggi più che mai – gli Stati europei, Italia compresa che,
tuttavia, come si diceva, un problema di integrazione – pur all’interno della stessa etnia: tra meridionali e
settentrionali – lo ha avuto sin dalla sua nascita come Stato unitario.
Politiche di integrazione che i governi post-unitari hanno affrontato secondo due linee direttive:
la politica scolastica;
la politica di guerra.
La politica scolastica – con l’obbligo della scuola elementare – serviva a ridurre l’analfabetismo,
soprattutto nel meridione, e a diffondere dappertutto l’uso della lingua italiana.
16
La politica di guerra – con l’istituzione dell’esercito nazionale popolare: la naja obbligatoria –
serviva ad affratellare – consentire la reciproca conoscenza e favorire la solidarietà reciproca – tra
meridionali e settentrionali. Questo, soprattutto, in considerazione del fatto che l’esercito veniva
effettivamente utilizzato nelle imprese coloniali (…………., ………..): l’avere di fronte un esercito nemico,
richiedeva un saldo rapporto di solidarietà, una forte compattezza tra i membri dell’esercito, a
prescindere dalle origini geografiche di ciascuno.
Si tratta di politiche – quella scolastica e quella di guerra e coloniale – che, avviate subito dopo l’unità
d’Italia, proseguiranno, sostanzialmente immodificate, fino agli anni ’40 del secolo scorso.
GLI ESITI DELLA CRISI DELLO STATO LIBERALE
E’ chiaro che allo scontro tra borghesia e proletariato (alla questione sociale), alle tensioni sociali
derivanti da questi scontri che hanno segnato l’intera storia della società capitalistica, bisognava dare una
qualche soluzione. E’ chiaro che le lotte dei lavoratori qualcosa avrebbero dovuto, necessariamente
produrre: o nel senso della prospettiva rivoluzionaria indicata da Marx (e sulla quale, tra breve, torneremo);
o nel senso della repressione di quelle lotte, a favore degli interessi e della permanenza al potere della
borghesia capitalistica; o, infine, nel senso di un qualche accordo di convivenza tra le due classi, di una sorta
di compromesso tra interessi antagonisti.
Ed, infatti, tutte e tre le prospettive appena indicate si sono storicamente realizzate. Sul piano
cronologico, nel seguente modo:
nel 1917, in Russia, con la rivoluzione comunista di Lenin e la nascita dello Stato socialista;
nel 1922, in Italia, con l’ascesa al governo di Benito Mussolini e la nascita dello Stato
fascista;
negli anni ’30, soprattutto negli Stati Uniti, con l’opera di governo del presidente T. Roosevelt
e del suo consigliere economico J. M. Keynes e la nascita dello Stato democratico.
Sono queste le tre nuove forme di Stato che derivano dalla crisi dello Stato liberale , derivante
dalla questione sociale o, come avrebbe detto Karl Marx, dallo scontro di classe.
Ognuna di queste tre nuove forme di Stato rappresenta, come abbiamo detto, un differente
tentativo di soluzione dello scontro tra borghesia e proletariato:
lo Stato socialista, rappresenta una soluzione istituzionale che si pone dalla parte dei
lavoratori;
lo Stato fascista, una soluzione che si pone dalla parte della borghesia capitalistica del
nord e dei proprietari terrieri del sud Italia;
lo Stato democratico, rappresenta una sorta di compromesso di classe, che concede
qualcosa ai lavoratori, pur confermando la loro condizione di subordinazione politica ed
economica alla borghesia capitalistica.
MARX ED IL MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA
17
Nel 1848, Karl Marx, un filosofo tedesco poi dedicatosi a estesissimi e fondamentali studi
economici, pubblica “Il manifesto del Partito Comunista”, un libricino destinato a divulgare, tra i
lavoratori e coloro che erano culturalmente e politicamente schierati dalla loro parte, l’idea della necessità
e dell’opportunità di avviare e portare a termine un processo rivoluzionario.
In quel libretto si delineava l’ipotetico percorso che la rivoluzione avrebbe dovuto seguire, secondo le
tappe qui, sinteticamente, riportate:
i lavoratori avrebbero dovuto costituire un proprio partito;
il partito dei lavoratori avrebbe dovuto andare al governo;
dal governo avrebbe dovuto espropriare i mezzi di produzione (aziende, terre, banche,
negozi) ai privati e socializzarli;
contemporaneamente alla socializzazione dei mezzi di produzione avrebbe dovuto
instaurare la dittatura del proletariato (Stato socialista);
infine, con l’attenuarsi dei tentativi controrivoluzionari fino all’estinzione degli stessi, si
sarebbe potuto dare vita alla società comunista.
Questa, la logica di tale processo: per costruire una società socialista – una società, cioè, priva della
proprietà privata dei mezzi di produzione – occorreva mettere nel conto l’uso della forza: nessuno, infatti, si
lascia espropriare senza provare, in ogni modo, a reagire ed a cercare di impedirlo. Perciò, gli espropri
darebbero stati possibili solo dal governo: potendo, solo da lì, far uso della forza pubblica. Per questo – per
andare al governo – era necessario il partito dei lavoratori (il Partito Comunista).
Dal governo, contemporaneamente agli espropri, il Partito Comunista avrebbe dovuto instaurare la
dittatura del proletariato: vale a dire, fare uso della forza per stroncare ogni tentativo controrivoluzionario, teso a ripristinare la società capitalistica appena rovesciata. L’autoritarismo dello Stato si
sarebbe dovuto mantenere per tutti gli anni che fossero stati necessari per eliminare, nell’immaginazione
delle vecchie classi privilegiate, e nei loro discendenti, ogni velleità di ripristinare il precedente ordine,
inducendo queste ad accettare pacificamente il nuovo stato di cose.
Marx sosteneva che la dittatura del proletariato è la massima espressione della democrazia, in
quanto è lo strumento col quale la stragrande maggioranza della popolazione impone la propria volontà
ed i propri interessi ad una ristretta minoranza di (ex) privilegiati.
La socializzazione dei mezzi di produzione e la contemporanea dittatura del proletariato
caratterizzano quella che si definisce società socialista.
E’ solo nel prosieguo del processo rivoluzionario, solo allorquando – terminati i tentativi
controrivoluzionari – non ci sarà più bisogno dello Stato autoritario, non ci sarà più necessità della
repressione dello Stato, che questo – come centro della sovranità, come monopolista della forza, verrà
meno: lo Stato si attenuerà come soggetto dell’esercizio del potere di imperio e rimarrà, essenzialmente,
come soggetto organizzatore di servizi per la collettività.
A quel punto, con mezzi di produzione definitivamente socializzati ed in presenza di uno Stato puro
erogatore di servizi, nascerà la società comunista: una società senza classi, di uomini tutti uguali
politicamente ed economicamente, in grado di autogovernarsi.
LA RIVOLUZIONE SOVIETICA E LO STATO SOCIALISTA
18
Le condizioni della rivoluzione socialista si creano in Russia, nel 1917.
In Russia: non proprio nella situazione ideale! Marx, infatti, pensava che la rivoluzione si sarebbe
dovuta realizzare in un Paese industrialmente sviluppato … in Inghilterra, in Germania … dove sviluppato
culturalmente e forte organizzativamente fosse anche la classe operaia… La Russia, al contrario, era un
Paese poverissimo: quasi soltanto, ancora, agricolo; con un regime politico – lo zarismo – preliberale … una
sorta di regime ancora feudale …
In ogni caso, è lì che si creano le condizioni della rivoluzione…
Lì, infatti, vi è un partito operaio, il Partito Socialdemocratico Russo (POSDR): non proprio un partito
rivoluzionario. Un partito diviso in due: una parte riformista ed una rivoluzionaria.
La parte rivoluzionaria si trovò ad essere maggioranza nel partito: per questo si chiamò bolscevica
(in russo “bolscevico” significa, appunto, di maggioranza). L’altra parte, quella riformista si definì
menscevica: appunto, di minoranza.
A capo della fazione bolscevica vi era V. I. Lenin.
A seguito di un lungo periodo di sommosse e di tentativi rivoluzionari di vario genere, che durò anni,
il partito operaio socialdemocratico russo si trovò a far parte del governo della Russia: dunque, la parte
maggioritaria – bolscevica – di quel partito - ed il capo di quella parte: Lenin – si trovarono nella
condizione di poter controllare l’operato del governo russo.
Nell’ottobre del 1917, a seguito dell’ennesimo tentativo rivoluzionario, Lenin – bolscevico:
rivoluzionario, comunista – divenne capo del governo e presidente della Repubblica.
Immediatamente, a seguito della rivoluzione che portò Lenin al governo, la Russia cambiò nome e si
definì URSS: Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche; così anche fece il POSDR, che divenne Partito
Comunista dell’Unione Sovietica. Oltre alle cariche di capo del governo e presidente della Repubblica, Lenin
assunse anche quella di segretario generale del Partito Comunista.
Da quella posizione – in particolare, da capo del governo comunista – Lenin diede immediatamente
inizio ai provvedimenti necessari alla costruzione di una società socialista: in particolare
all’espropriazione dei mezzi di produzione e
alla repressione di tutte le forze politiche, i movimenti, le organizzazioni, le
manifestazioni culturali, le pubblicazioni editoriali e giornalistiche
controrivoluzionarie.
Si trattava di misure che davano attuazione a quel programma rivoluzionario che Marx aveva indicato
nel Manifesto del Partito Comunista; con un paio di specificazioni, tuttavia:
1. si consentì ai privati di continuare a tenere la proprietà delle aziende più piccole;
2. i mezzi di produzione sottratti ai privati vennero statalizzati, affidati, cioè, allo Stato.
In realtà, Marx non ha mai parlato di statalizzazione dei mezzi di produzione. Mai, nelle migliaia di
pagine da lui scritte, compare il termine statalizzazione. Marx ha sempre utilizzato il termine
socializzazione!, e non è necessariamente detto che per socializzazione debba intendersi
statalizzazione! Molti, infatti, nel movimento comunista internazionale, non furono d’accordo
con la scelta di Lenin di statalizzare i mezzi di produzione: pensavano a differenti forme di
socializzazione!
19
Fatto sta che questa – la statalizzazione – fu la scelta del governo leninista.
La statalizzazione dei grandi mezzi di produzione: di quelli più importanti, più decisivi per le sorti
economiche della nazione. Non di quelli più piccoli: secondo quanto previsto dalla NEP (Nuova Politica
Economica) voluta da N. Bucharin, ministro dell’economia del governo Lenin.
Con queste misure, lo Stato socialista iniziò ad assumere determinate caratteristiche: quelle di uno
Stato autoritario: tale, cioè, da reprimere con la forza il dissenso politico rispetto al
governo
e di uno
Stato a partito unico: tale, cioè, da considerare legale, sostanzialmente, solo il
Partito Comunista.
Insomma, Lenin instaurò quella che Marx chiamava la dittatura del proletariato.
Conseguentemente, la società si intrise di violenza: quella delle forze di polizia e dell’esercito contro
le attività controrivoluzionarie.
Tra le forze controrivoluzionarie, bisogna fare uno specifico riferimento alla Chiesa, nel caso
dell’Unione Sovietica, alla Chiesa ortodossa. Questa, evidentemente, non era affatto favorevole alla
rivoluzione: essa stessa era da annoverare tra i grandi proprietari terrieri e, dunque, tra coloro che avevano
subito le espropriazioni.
Per di più, Marx aveva sostenuto che la religione è l’oppio dei popoli: rimandando il riscatto dei
poveri ad un momento extraterreno – alla fine della vita – induceva questi all’inattività nel corso della
vita, ad accettare la propria condizione – per altro, voluta da Dio: giacchè nulla accade senza la sua
volontà – supinamente, senza reagire. Dunque, il contrario della prospettiva rivoluzionaria che, invece,
incita all’azione, a prendere in mano il proprio destino, per costruire oggi, qui in terra, una società più
giusta.
E, dunque, conseguentemente, la religione fu vietata: furono vietati tutti i culti religiosi.
L’ateismo divenne l’unica ideologia “religiosa” ammessa dallo Stato. Lo Stato divenne ateo.
E, tuttavia, gli anni successivi al 1917 furono, in Unione Sovietica, anni di grande fulgore nel campo
delle arti (della poesia, del teatro, della letteratura, della danza, del cinema…): anni di grandi
sperimentazioni e di grandi dibattiti e confronti culturali, dentro alle forze, politiche ed intellettuali,
schierate dalla parte della rivoluzione.
Tanto dura fu la repressione contro la reazione borghese, quanto ampio ed intenso fu il dibattito
all’interno del campo delle forze rivoluzionarie!
Nel 1922 Lenin si ammala di una malattia degenerativa che, progressivamente, lo porta a non poter
più esercitare le funzioni pubbliche che gli erano state affidate. Si apre, perciò, la lotta per la successione.
La morte di Lenin sopravviene nel 1924.
Il dibattito per la successione presenta tre distinte posizioni:
20
quella di Bucharin, designato da Lenin come suo preferito a succedergli, che rappresenta
la linea di continuità col periodo leninista;
quella di Trotzskj, riassumibile nel motto rivoluzione permanente;
quella di Stalin, riassumibile nel motto socialismo in un Paese solo.
Mentre Bucharin, come detto, s poneva in continuità con Lenin – del quale, d’altra parte, era stato
ministro dell’economia – Trotzskj e Stalin si ponevano un problema nuovo, inedito: quello di come
difendere la rivoluzione in Unione Sovietica, visto che il mondo intero era assoggettato a regimi capitalistici.
Da questi, era prevedibile, in qualunque momento, anche nell’immediato, un attacco militare allo scopo di
spazzare via l’unica esperienza rivoluzionaria esistente al mondo. Occorreva, dunque, prepararsi a
respingere tale attacco, possibilmente prevenirlo e, comunque, essere militarmente in grado di resistere e
sconfiggere il tentativo militare reazionario delle potenze capitalistiche. Occorreva mettere il socialismo,
per quanto possibile, al riparo: in sicurezza.
A questo problema Trotzskj e Stalin offrono due risposte diametralmente opposte. Il ragionamento di
Trotzskj è questo: per difendere la rivoluzione in URSS occorre rompere l’accerchiamento capitalistico,
occorre che anche in altri Paesi scoppi la rivoluzione, occorre dare alleati all’URSS. Dunque, la rivoluzione
non è finita: deve continuare anche in altri Paesi. Di qui, il motto della rivoluzione permanente.
Tutt’altro il ragionamento di Stalin; questo: l’URSS non ha le forze per esportare la rivoluzione;
bisogna prendere atto che l’unico Paese socialista al mondo è l’Unione Sovietica. E’ qui che bisogna
concentrare le forze per dotarsi di un esercito in grado di prevenire ed, eventualmente, respingere l’attacco
delle potenze capitalistiche. E bisogna farlo subito, immediatamente: mettendo in campo tutti gli sforzi
possibili, essendo disponibili ad ogni sacrificio.
Il durissimo scontro tra le varie posizioni nel Comitato Centrale del PCUS si concluse con la vittoria di
Stalin che, dunque, divenne segretario generale del PCUS, capo del governo e presidente della Repubblica.
Inizia così, nel 1924 e sotto il motto socialismo in un Paese solo il periodo stalinista della rivoluzione.
La necessità di costruire un esercito sufficientemente potente da poter contrastare quelli dei Paesi
capitalistici, costituiva, in URSS, un enorme problema. Il Paese, come abbiamo detto, era quasi
completamente agricolo, l’elettricità era ancora un bene assai scarso… Occorreva, perciò, dotarsi
velocemente di una rete elettrica distribuita in tutto il Paese e di una struttura industriale destinata alla
costruzione di armamenti. Occorreva elettrificare il Paese e mettere in funzione fabbriche nel settore
dell’industria pesante: quella siderurgica, elettronica, metalmeccanica, chimica…: le industrie necessarie
per produrre armamenti, appunto.
Occorreva distogliere i lavoratori dal lavoro nei campi e portarli nelle zone industriali a scavare
carbone, a lavorare nelle industria aeronautiche, siderurgiche…: a costruire carri armati, aerei, bombe, navi
da guerra… Ciò di cui c’era bisogno, nell’immediato, più che del pane, erano le armi.
Stalin diede inizio a questo processo forzato di industrializzazione nel 1928, con l’avvio del primo
piano quinquennale: un piano di produzione predisposto dallo Stato e tale da definire gli
obiettivi produttivi da raggiungere, settore per settore, nell’arco di un quinquennio.
Allo scopo di realizzare tale progetto, una enorme massa di lavoratori vennero mandati via dalle
campagne e spostati nei centri urbani intorno alle fabbriche ed alle miniere. Si diffuse la retorica del lavoro
socialista, dell’eroe socialista del lavoro che contribuisce alla rivoluzione con la sua attività produttiva,
instancabile, perché consapevole della necessità di difendere la costituenda società dei liberi e degli uguali.
Vennero istituiti premi a quei lavoratori che si dimostrassero più produttivi. Stakanov ne è stato
l’emblema: di qui, il termine stakanovismo, per indicare una attività lavorativa che non prevede sosta e che
si svolge a ritmi elevatissimi.
21
Il primo piano quinquennale ebbe grande successo: gli obiettivi produttivi in esso fissati,
vennero raggiunti in anticipo; in solo quattro anni, anziché in cinque. Così che, nel 1932, con un
anno di anticipo, appunto, partì il secondo piano quinquennale.
Grazie ai piani quinquennali l’URSS riuscì in breve tempo a dotarsi di un potentissimo esercito: così
potente da poter competere con quello inglese e statunitense, i più grandi del mondo.
E, tuttavia, la realizzazione dei piani quinquennali significò anche l’abbandono delle campagne ad
opera di una massa enorme di popolazione: milioni e milioni di persone che smisero di produrre grano e
tutto quanto era necessario alla vita delle persone, per mettersi a produrre armi. Di qui, la povertà, la
penuria, la scarsità di alimenti e la denutrizione: condizioni di lavoro durissime e poco, assai poco da
mangiare!
Una situazione assai problematica, perché il malcontento dei lavoratori andava a saldarsi con le
spinte reazionarie delle vecchie classi dominanti (la borghesia e l’aristocrazia terriera), costituendo una
minaccia per il governo rivoluzionario.
Non bastava, perciò, il piano quinquennale. Occorreva, nel contempo, accentuare la repressione nei
confronti dei tentativi controrivoluzionari: occorre stroncarli e, per quanto possibile, prevenirli
individuando ed eliminando per tempo chi ne fosse a capo.
Stalin agì in questa direzione, adottando la teoria del nemico interno: la teoria secondo la
quale, i controrivoluzionari occorreva scovarli non al di fuori del Partito Comunista, ma al suo
interno, tra i dirigenti stessi del partito. Infatti, chi avesse voluto rovesciare il governo
rivoluzionario, sapendo di non poterlo fare all’esterno del partito – perché sarebbe stato
immediatamente represso – avrebbe agito spacciandosi per comunista, anzi, per comunista
integerrimo, cercando di raggiungere i massimi livelli di potere nel partito e nel governo e, da lì,
operando contro la rivoluzione.
E’ chiaro che una simile teoria era terribile per il clima all’interno stesso del partito e del movimento
rivoluzionario: perché significava instillare il sospetto nei confronti di colui che ha sempre lavorato al tuo
fianco; significava diffondere l’idea che chiunque potesse essere un traditore, anche colui del quale mai
prima avresti sospettato.
E come distinguere, poi, tra comunisti e comunisti: come distinguere i veri comunisti, dai comunisti
falsi, dai traditori vestiti da comunisti?
La risposta fu semplice ed ovvia. Individuando in Stalin il capo della rivoluzione, ne discendeva come
conseguenza che chiunque non fosse stato d’accordo con Stalin era un possibile traditore; e tanto più
rilevante era il dissenso da Stalin, tanto più probabile era che il dissenziente fosse un controrivoluzionario
spacciatosi per comunista.
Ebbe così inizio la stalinizzazione del Partito Comunista e dello Stato.
Si noti la torsione storica del processo: per Marx la dittatura del proletariato doveva essere la più
piena delle democrazie: la sovranità esercitata dalla stragrande maggioranza della popolazione, contro una
piccola minoranza di privilegiati nostalgici dei propri privilegi; nel periodo leninista diventò la dittatura del
Partito Comunista, per quanto larga fosse la discussione ed il confronto delle idee dentro quel partito ed, in
generale, all’interno del movimento rivoluzionario; con Stalin divenne, infine, la dittatura di un uomo solo,
ritenuto unico, autentico interprete degli interessi dei lavoratori e l’unica, legittima prospettiva di salvezza
per i poveri ed i subordinati di tutto il mondo.
22
Stalin – la persona di Stalin – venne elevato dalla propaganda ad una dimensione sovra-umana: issata
ad un livello quasi divino. Di qui, l’avvio di una sorta di adorazione nei suoi confronti: quello che è stata
definito culto della personalità.
A Stalin vennero attribuite qualità eccezionali, straordinarie: carismatiche. E la sua persona fu posta
al centro dell’intero apparato statuale. Lo Stato venne così a definirsi come carismatico, cioè
organizzato intorno alla personalità di un soggetto al quale si riconoscono qualità eccezionali:
carismatiche, appunto.
E tuttavia, come sempre succede in tutti i casi in cui un soggetto viene elevato al di sopra del livello
umano (come succedeva al sovrano nello Stato assoluto); come succede in tutti i casi in cui ad un soggetto
vengono attribuiti poteri illimitati, fino a corrispondere ad una sorta di onnipotenza, si crea il problema del
consenso: il problema, cioè, di garantire al sovrano un’adesione popolare che ne eviti la solitudine e,
dunque, l’assoggettamento ad ogni possibile e facile tentativo di ribaltamento.
Fu così per il sovrano nello Stato assoluto, fu così anche per Stalin in Unione Sovietica.
Stalin affrontò il problema del consenso cercando di risolverlo con una strategia nuova: quella del
totalitarismo.
Questo fu il ragionamento: alla creazione del consenso non basta l’autoritarismo. Con questo non
creo consenso, semplicemente elimino i dissenzienti, o impedisco loro di operare pubblicamente: li
reprimo. Per creare consenso al governo ed al suo capo, invece, occorre educare ai valori ed al pensiero del
capo: occorre diffondere dappertutto il suo punto di vista, la sua ideologia; far intendere che il capo è
presente ovunque, e che sostiene e rassicura tutti, educando ad agire nell’interesse comune da lui indicato
e da lui rappresentato. Se i valori, l’ideologia, la presenza del capo si avverte dappertutto, in ogni ambito;
se, in ogni ambito, si educa a quei valori ed a quella ideologia; se l’informazione è interamente governata
dal capo… allora sì, si può sperare che tra la gente si diffonda, automaticamente, come per natura,
l’ideologia del capo e, con questa, il consenso nei suoi confronti.
E’ questo il totalitarismo: l’idea di occupare ogni ambito della vita sociale, civile, politica,
economica, culturale, allo scopo di generare consenso al capo ed alle sue idee.
Di qui, da questa strategia, il conformarsi dello Stato sovietico come Stato totalitario.
Una strategia di occupazione millesimale di ogni ambito della vita individuale e collettiva. Dalla
politica, in cui già il controllo era ferreo per via della legittimità del solo partito unico; all’economia, in cui
già lo Stato era l’unico soggetto economico ammesso; alle scuole ed all’università (dove lo Stato si
assicurava che gli insegnanti fossero di provata fede stalinista e che i libri adottati ricalcassero il pensiero di
Stalin e ne esaltassero la persona; per altro, nelle scuole venne introdotta l’ora di dottrina marxista); ai
giornali, ammessi soltanto se conformi alla volontà ed alle idee del capo; ai libri, sottoposti ad
autorizzazioni e censura per poter essere stampati e posti in vendita; al cinema, al teatro, alla radio …
Tutto venne posto sotto controllo e omologato. Fu istituita anche una polizia segreta – con una rete di
spionaggio, costituita da gente comune, appositamente pagata – incaricata di riferire alle forze di sicurezza
delle opinioni eventualmente espresse in privato, di critica all’operato del governo ed al suo capo.
Si può comprendere bene come certo la situazione non fosse delle migliori dal punto di vista delle
libertà. Ma il tutto si giustificava con la necessità di intensificare l’attività economica per riuscire a costruire
un esercito e degli armamenti in grado di difendere la neonata rivoluzione.
E, sotto questo altro profilo, le cose andarono per il verso giusto. In pochissimi anni, l’Unione
Sovietica – paese agricolo e poverissimo – riuscì a dotarsi di un esercito imponente, in grado di entrare
23
nella seconda guerra mondiale al fianco degli eserciti di Stati Uniti ed Inghilterra, ed a uscirne vittorioso
contro la Germania Nazista. Per altro, l’esercito sovietico fu il primo ad entrare ad Aushwitz ed a liberare gli
ebrei che ancora stavano lì, essendo fortunosamente riusciti a sfuggire alle camere a gas.
La fine della guerra si ha nel 1945: la conclusione ufficiale si fa risalire al 6 agosto, quando gli
americani sganciarono la bomba atomica su Hiroshima.
Tuttavia, che le sorti della guerra volgessero ormai a sfavore dell’alleanza tra Hitler, Mussolini ed il
Giappone era ormai chiaro dall’anno precedente: tanto che, appunto nel 1944, i leader dell’alleanza
antinazista – Roosevelt per gli USA, Churchill per l’Inghilterra e Stalin per l’URSS – tennero tre conferenze
internazionali, proprio allo scopo di decidere come organizzare politicamente il mondo, una volta che la
guerra fosse definitivamente finita.
In quelle conferenze, le potenze vincitrici decisero che il mondo dovesse essere diviso in due
grandi blocchi: da una parte, il blocco dei Paesi occidentali, sotto l’egemonia statunitense;
dall’altra, quella dei Paesi orientali, sotto il dominio sovietico.
Dopo molte discussioni, l’Italia fu attribuita al blocco dei Paesi occidentali.
E, così, accadde, effettivamente. Emblema di questa divisione del mondo in due blocchi fu la
Germania, divisa in due differenti Stati: la Germania dell’est, sul modello sovietico; e quella dell’ovest, sul
modello statunitense. Una divisione addirittura millesimale, tracciata all’interno della stessa città –
Berlino – a sancire, anche fisicamente, la quale fu costruito nel 1961 il famigerato muro: il muro di
Berlino.
La divisione del mondo in due blocchi veniva a rappresentare, geopoliticamente, il ritorno dei due
grandi contendenti – USA e URSS – su fronti opposti e contrapposti, non appena spazzata via la minaccia
comune del nazifascismo. Fu la premessa di quella che venne definita guerra fredda: una situazione,
cioè, di continua minaccia di guerra, di continuo, imminente rischio di apertura di una nuova guerra,
senza, tuttavia, che tale minaccia si concretizzasse mai; senza che, effettivamente, e per fortuna, una
nuova guerra fosse mai davvero avviata.
Una situazione strana, di guerra, per fortuna non guerreggiata sebbene continuamente minacciata:
quella situazione che, pure, è stata definita equilibrio del terrore.
Equilibrio del terrore: a significare il terrore di ciascuno dei due contendenti – USA e URSS
– rispetto alla possibile risposta dell’altro ad un eventu ale attacco militare. Il terrore di una
risposta militare che sarebbe potuta essere devastante, annichilente. Insomma, la paura di una
risposta atomica, ad un eventuale attacco.
L’equilibrio del terrore si reggeva, dunque, sulla capacità di ciascuno di terrorizzare l’altro rispetto
alla propria capacità militare. Di qui, quella che è stata chiamata ed è rimasta nella storia come corsa agli
armamenti: una corsa, cioè, ad armarsi via via di più, per scoprire armi sempre più devastanti,
destinate ad un uso definitivo; una corsa che ha coinvolto entrambe le super-potenze.
E, dunque, sia gli Stati Uniti, che l’Unione Sovietica.
L’URSS, perciò, anche dopo la fine della seconda guerra mondiale, ha dovuto continuare a finanziare
l’industria degli armamenti, trascurando ancora i settori economici destinati a migliorare le condizioni di
vita della popolazione. E’ così che, nei decenni 50 e 60, le condizioni di vita della popolazione in Unione
Sovietica non sono sostanzialmente cambiate e, conseguentemente, non si è affievolito il malcontento
sociale, né la necessità, per lo Stato, di ricorrere al controllo ed alla repressione del dissenso.
24
Anzi, in quel lasso di tempo, l’esercito sovietico fu inviato a reprimere moti popolari – per altro
guidati da dirigenti comunisti locali – fuori dai confini sovietici: nel 1956 in Ungheria; nel 1968, in
Cecoslovacchia.
Qualche elemento di cambiamento si intravede nel corso degli anni ’70, inizialmente per effetto di
fenomeni sociali che nulla sembrerebbero avere a che fare con le vicende politiche internazionali.
A muovere un po’ le acque furono, infatti, le trasmissioni via satellite e il turismo di massa.
Le trasmissioni via satellite diffusero sugli schermi televisivi di tutti i Paesi del mondo – quindi, anche
nei Paesi socialisti – le immagini che la televisione trasmetteva in occidente. E quelli erano gli anni di
Canzonissima, di Rischia Tutto… di trasmissioni leggere, di intrattenimento che, alla sera, incollavano allo
schermo le grandi masse popolari, bisognose di sublimare nel sogno della TV la realtà, non semplice, delle
loro vite.
La televisione mandava in onda, in Italia, ma anche nei Paesi dell’est, la (falsa) immagine di una
società dedita allo show, al ballo, al divertimento, alle canzoni, alla risata: una società felice, scanzonata, in
cui a tutti era data la possibilità di divertirsi.
Ed il turismo di massa interveniva a confermare quella (falsa) immagine.
I decenni ’50 e ’60 costituirono nell’occidente europeo un periodo di fortissima espansione
economica: trainata dalle esigenze proprie della ricostruzione post-bellica e dal ritorno della produzione
industriale a destinazioni civili, piuttosto che alla soddisfazione delle esigenze militari dello Stato. Quegli
anni, in Italia, vennero qualificati come gli anni del boom economico.
In quel periodo lo sviluppo industriale, fondato sulla produzione di massa (in serie, tayloristica),
consentì il raggiungimento di elevati livelli di occupazione (sebbene, concentrati al nord, lasciando
gravemente depresso il meridione d’Italia) e, conseguentemente, di livelli di benessere sociale via via più
elevati anche per i lavoratori.
Costoro poterono così accedere a consumi precedentemente riservati a ristretti gruppi sociali,
privilegiati rispetto al tenore di vita medio della popolazione. Tra questi nuovi consumi, la possibilità di
viaggiare e di visitare altri Paesi in qualità di turisti. Frotte di lavoratori – famiglie di lavoratori – partivano,
dunque, dall’Italia – come, d’altra parte, dagli altri Stati europei – per sbarcare in Paesi stranieri, ma non
troppo distanti e, comunque, accessibili per le tasche dei lavoratori: nei Paesi dell’est, dunque,
geograficamente vicini e poco dispendiosi.
A Budapest, in Polonia, a Mosca e negli altri Paesi dell’est europeo cominciarono, così, ad arrivare
gruppi di lavoratori occidentali per puro scopo turistico. Arrivavano i ricchi, nella psicologia dei cittadini di
quei luoghi: lavoratori come loro, ma più fortunati; ricchi, anziché, come loro, poveri; insomma, lavoratori
occidentali: che avevano avuto la fortuna di nascere e di vivere in occidente, in un Paese capitalistico,
anziché in uno Stato socialista. In un Paese capitalistico, occidentale, che non soltanto conferiva loro i mezzi
economici per viaggiare, ma concedeva loro la libertà di farlo: di uscire dal territorio dello Stato di
appartenenza, per recarsi altrove. Cosa, quest’ultima, che certamente non era consentita ai cittadini degli
Stati dell’est.
Il turismo di massa, dunque, rappresenta, agli occhi dei cittadini dell’est, la condizione di un
occidente in cui i lavoratori erano più ricchi e più liberi di quanto loro non fossero. E ciò, a conferma di
quanto già le trasmissioni via satellite lasciavano immaginare.
25
Tutto questo, ovviamente, non faceva che inasprire il risentimento delle popolazioni contro i governi
e le autorità che guidavano quei Paesi, rinfocolando volontà di cambiamento e di omologazione a quelle
società occidentali ritenute più fortunate.
Si inasprì, dunque, e si diffuse una grande voglia di cambiare le cose. Una protesta, al momento
silente, nascosta, che, però, trovò una sponda importante nell’elezione di Karol Wojtyla a papa, nel 1978.
Prima che diventasse papa con il nome di Giovanni Paolo II, infatti, Wojtyla era vescovo di una città
polacca: Kracovia; perciò, di una delle città appartenenti a quei Paesi che avevano usato la repressione
anche contro la Chiesa, legittimando solo l’ateismo, e contro le comunità dei credenti.
In quanto eminente membro della Chiesa polacca, Wojtyla era stato da sempre avversario del regime
socialista. Era, perciò, sperabile che, anche ed ancor più dopo l’elezione a papa, si opponesse
pubblicamente e con tutta la forza – morale e culturale – del suo alto magistero ai regimi socialisti dell’est,
alle loro politiche repressive ed ai governi che le adottavano.
I cittadini dell’est vedono nell’elezione di Wojtyla a papa l’occasione buona per liberarsi di quei
regimi e di quei governi: di cambiare quelle società, per assimilarle a quelle occidentali. Pensano che, ora
che c’è un papa polacco, non sarebbe più stato possibile per i governi dell’est reprimere con la violenza la
protesta popolare: perché certamente il papa sarebbe intervenuto a difesa dei cittadini e della loro libertà
di espressione e di associazione.
E la protesta popolare ha inizio. Ha inizio a Danzica: città polacca dei cantieri navali. Qui, i lavoratori
dei cantieri scendono in sciopero per protestare contro condizioni di vita e di lavoro particolarmente
disagiate e per rivendicare diritti di libertà politica e sindacale; occupano le fabbriche; costituiscono un
sindacato autonomo ed indipendente rispetto al Partito Comunista: prende nome di Solidarnosc, issano
sulla fabbrica le bandiere di solidarnosc.
Il governo, le autorità di polizia sono presi di sorpresa. Sono tentati di intervenire, ma sono consci
che un intervento militare, questa volta, potrebbe scatenare la reazione del Vaticano. Esitano… rimandano
l’intervento… quindi, l’occupazione continua…
E, come previsto, il papa interviene: a sostegno dei lavoratori di Danzica e delle loro rivendicazioni.
Non solo: il Vaticano interviene anche a finanziare le lotte di quei lavoratori ed il loro sindacato.
Giorni… mesi di lotte operaie… addirittura, di occupazione delle fabbriche, senza l’intervento
rpressivo della polizia! Una situazione inaudita: mai vista prima, in un Paese socialista!
Le televisioni di tutto il mondo rimandano questa notizia straordinaria e le immagini dei lavoratori
festanti ed in lotta. Ed il contagio si diffonde a tutti i Paesi dell’est europeo: se è possibile farlo in Polonia,
allora è possibile anche in Germania est ed in Romania ed in Ungheria…
Dappertutto, nel blocco dei Paesi socialisti, si diffonde la protesta popolare: durissima e questa volta
non più repressa dalle forze di polizia. Ed il fiume diventa sempre più grande ed impetuoso.
Il Partito Comunista dell’Unione Sovietica capisce – non può non capirlo – che bisogna cambiare
qualcosa. Nel 1985 viene eletto segretario generale del PCUS, capo del governo e presidente dell’Unione
Sovietica Michail Gorbacev. Questi presenta un programma di importanti riforme sociali e politiche: l’idea
che lo muove è quella di riuscire a salvare il socialismo accogliendo una serie di rivendicazioni popolari.
Lancia, perciò, due parole d’ordine, che fanno da guida all’azione del suo governo:
glasnost, cioè trasparenza e
perestroika, cioè ristrutturazione.
26
Glasnost, vale a dire trasparenza, quella che deriva dal fatto che le notizie sugli accadimenti
politici, economici, sugli eventi culturali, sui fatti internazionali, etc., non vengano più filtrati
esclusivamente dalla lente del governo, ma possano venire raccontati da chiunque voglia farlo e
raccolga notizie per farlo. E’ la premessa teorica indispensabile alla realizzazione di un programma
riformista per il pluralismo delle opinioni e per la libertà di informazione e di stampa. Sono i
primi elementi di libertà e di democrazia che, dopo tanti decenni, vengono introdotti nel sistema
politico sovietico.
Perestroika, vale a dire ristrutturazione. Ristrutturazione di un sistema economico totalmente
affidato alle mani dello Stato, in favore del ritorno della piccola proprietà privata e della libertà delle
piccole imprese private: insomma, una sorta di ritorno alla NEP (Nuova Politica Economica) di
Bucharin e Lenin.
Gorbacev capisce che non è più possibile difendere il socialismo impedendo qualsivoglia modifica.
Capisce che, per placare il malcontento e la protesta popolare, ed anche per gli obiettivi insegnamenti della
storia, sono necessarie profonde modifiche al sistema: e, con la glasnost e la perestroika, le mette in
cantiere; modifiche politiche ed economiche. E spera, così, di salvare, adeguandolo il socialismo sovietico.
Ma, ormai, il malcontento popolare è tale, è così dirompente, che nulla può arginarlo. Alle
popolazioni dei Paesi dell’est non bastano più singole riforme… vogliono un cambiamento totale: vogliono
uscire dal socialismo e vivere in società come quelle occidentali. E lo stesso Gorbacev, in patria, è visto
come un comunista sotto mentite spoglie: insomma, una persona inaffidabile.
Dunque, le proteste continuano. In particolare, in Germania prendono la forma dei tentativi di
scavalcare il muro di Berlino: quel muro che per decenni aveva diviso, oltre che il mondo, le stesse famiglie
tedesche, separate artificialmente (ma definitivamente) tra coloro che vivevano ad est e coloro che
vivevano ad ovest. Questa situazione penosa di affetti spezzati – unita alla volontà dei cittadini dell’est di
liberarsi della coercizione del regime – aveva moltiplicato, negli anni, i tentativi dei tedeschi orientali di
scavalcare il muro per passare ad ovest. Contro questi tentativi, sempre, sistematicamente, l’esercito aveva
risposto con le armi e con la violenza.
Ma in quel fatidico anno 1989, quando masse enormi di cittadini di Berlino est si riversarono alla
porta di Brandeburgo per scavalcare il muro ed andare, finalmente, ad ovest (verso la libertà, verso la
democrazia, verso i propri familiari), l’esercito e la polizia non intervennero: per una volta zittirono le armi.
Il muro fu preso d’assalto, fu scavalcato, fu picconato… in breve, cadde: fu la caduta del muro di Berlino
e, con esso, cadde la divisione del mondo in due blocchi, venne meno la divisione della Germania
in due distinte repubbliche, caddero gli Stati socialisti.
Da quell’anno ebbe inizio una nuova storia del mondo. I nuovi conflitti non si sarebbero più svolti
sulle coordinate est-ovest, quanto nord-sud del mondo. Altri equilibri si sarebbero determinati, altri
soggetti si sarebbero affermati, altri problemi sarebbero insorti. Un nuovo mondo: una nuova storia.
La fine dell’esperienza socialista nel mondo (ora ne sono rimaste poche e malconce briciole…) pone,
soprattutto a chi ha sperato nei cambiamenti promessi, domande ineludibili. Perché? Poteva andare
diversamente?
Al contrario di ciò che pensano in tanti (“con i se non si fa la storia”), si può senza dubbio dire che
alcune scelte fondamentali non erano obbligatorie (ed, infatti, furono ampiamente discusse). Non era
obbligatorio statalizzare i mezzi di produzione: si potevano realizzare altre forme di socializzazione; non era
obbligatoria l’ascesa al potere di Stalin nel ’24 e, dunque, non era obbligatoria l’affermazione della teoria
27
del nemico interno, con tutto quanto ne è conseguito dal punto di vista del dibattito democratico e
dell’accentramento del potere (ipoteticamente) proletario nelle mani di una sola persona.
Non si tratta di riflessioni inutili, perché, se è vero che il socialismo (il socialismo reale, quello che
storicamente si è riusciti a realizzare) ha fallito, intatti, ineludibili e sempre più drammatici restano i
problemi ai quali quell’esperienza intendeva rispondere: il problema di una disparità di ricchezza nel mondo
che fa sì che ogni 6 secondi un bambino muoia di fame, nel mentre, nei Paesi ricchi, altri muoiono per gli
effetti della bulimia; il problema di masse enormi di popolazione costrette alla subordinazione economica e
politica nei confronti di ridottissime minoranze detentrici del potere economico e politico; il problema di un
dominio capitalistico mondiale che costringe buona parte dei Paesi del mondo alla condizione di colonie o
di Stati vassalli; il problema della distruzione e della rapina delle risorse naturali della terra, al fine di
aumentare il più possibile il lucro di pochi; il problema di libertà democratiche, anche giuridicamente
affermate, e, tuttavia, conculcate per effetto di uno strapotere economico che non conosce limiti, né
regole…
Tutti questi problemi permangono e pretendono, ancora oggi, una risposta – civile, democratica – se
non si vuole che esplodano come strumenti di guerra nelle mani delle organizzazioni terroristiche
internazionali.
LO STATO FASCISTA
L’esperienza socialista è stata un tentativo di porre fine allo scontro sociale (alla questione sociale),
ponendosi dalla parte dei lavoratori e cercando di costruire, per la prima volta nella storia dell’uomo, una
società di persone libere ed uguali: dal punto di vista giuridico e politico (come già era – ed è - nella società
borghese-capitalistica) ma anche, ed anzi, prima di tutto, dl punto di vista economico (eliminando
subordinazione e sfruttamento).
Ma, è ovvio, in uno scontro sono previsti almeno due soggetti; e nello scontro sociale del quale qui si
parla sono coinvolte due classi: la borghesia capitalistica da un lato, ed il proletariato dall’altro. E, dunque, è
nell’ordine delle cose che, se le forze socialiste e comuniste si sono impegnate a rappresentare gli interessi
e le aspettative di quest’ultimo, qualcun altro dovesse prendere le parti – rappresentare gli interessi e le
aspettative – della prima.
Questo qualcun altro sono stati i fascisti: ed il fascismo come ideologia.
Il fascismo – e Benito Mussolini, che ne era il capo – va al potere in Italia, nel 1922:
precisamente, il 28 ottobre. Ma per capirne le ragioni ed il senso bisogna ricostruire un po’ il contesto
storico nel quale questa ascesa al potere avviene.
Dunque, già lo sappiamo, dalla fine dell’800 i lavoratori fanno sentire sempre più forte la loro voce
organizzandosi in partiti e sindacati rappresentativi dei propri interessi. E, come ancora sappiamo, le lotte
dei lavoratori portano, benchè lentamente, a grandi conquiste: innanzitutto un più ampio intervento dello
Stato nel sistema economico, a tutela dei soggetti sociali più deboli; quindi, ad una sempre più ampia
estensione del diritto all’esercizio del voto.
Sotto quest’ultimo profilo, il suffragio universale maschile si conquista, in Italia, nel 1912.
E’ di tutta evidenza l’importanza del suffragio universale: grazie ad esso è ora possibile che in
Parlamento ci siano sempre più rappresentanti dei partiti dei lavoratori e che, dunque, grazie all’iniziativa di
questi soggetti, le leggi sanciscano sempre più ampi diritti e sempre più estese provvigioni pubbliche a
favore delle classi sociali più povere.
28
Tutto questo, ovviamente, non può far piacere alle classi dominanti: la borghesia industriale del nord
e l’aristocrazia terriera del sud (l’Italia, all’epoca, era ancora un Paese completamente agricolo nella sua
parte centro-meridionale: tale, per altro, rimarrà fino agli anni ’50).
Per di più, l’Italia entra nella prima guerra mondiale nel 1915 . La guerra serve anche come
sbocco per una gran massa di disoccupati che trovano nel lavoro militare (nella carneficina della grande
guerra) la possibilità di riuscire a recuperare un reddito per sostenere le proprie famiglie. Ma la guerra
finisce – nel 1918 – e, con essa, anche il lavoro ed il reddito. Una massa enorme di lavoratori tornano alle
proprie case e, così come prima di partire per il fronte – tornano ad essere disoccupati e, dunque, ad una
vita da accattoni e sottoproletari: massa di uomini disponibili – per un tozzo di pane – a qualunque lavoro,
anche sporco.
1917: rivoluzione comunista in Unione Sovietica. Non proprio un evento che lasci indifferenti la
borghesia capitalistica e l’aristocrazia agraria occidentale. Il timore è che quanto sta avvenendo in URSS
possa estendersi anche in occidente e che, dunque, da un momento all’altro un governo proceda, anche qui
da noi, agli espropri che avevano caratterizzato la prima fase della rivoluzione in Unione Sovietica. Un
pericolo, questo, che le classi dominanti hanno assai sbandierato e tale, per loro - da dover essere
scongiurato ad ogni costo.
In realtà, un pericolo assolutamente inesistente in Italia.
Qui, infatti, l’unico Partito rappresentativo degli operai del nord – il PSd’I, Partito Socialista d’Italia –
era strettamente in mano al suo segretario Filippo Turati: un signore anziano di fede decisamente
riformista e, dunque, senza alcuna velleità rivoluzionaria.
Ed anche il partito più rappresentativo dei contadini del sud, nato nel 1919, il Partito Popolare era
il prodotto dell’iniziativa di un prete – Don Luigi Sturzo – e, dunque, assumeva come ideologia non certo
la teoria marxista, quanto, invece, la dottrina sociale della Chiesa.
Insomma, in Italia, mancavano forze rivoluzionarie e, dunque, del pericolo comunista mancava
proprio qualunque premessa politica.
In realtà, l’agitare un pericolo in realtà inesistente serviva alle classi dominanti non per scongiurare
un ipotetico tentativo rivoluzionario, ma per un’esigenza ben più concreta ed immediata: per giustificare la
repressione delle lotte poste in essere dai lavoratori, soprattutto nei periodi dei rinnovi dei contratti di
lavoro.
Per questa specifica ragione si formarono le prime squadre fasciste: squadre paramilitari pagate dai
latifondisti del sud e dagli industriali del nord per mettere in atto azioni di intimidazione nei confronti dei
leader sindacali, dei dirigenti dei partiti dei lavoratori e dei loro giornali, dei dirigenti delle cooperative e,
direttamente, dei lavoratori in lotta: si trattava di minacciare, bastonare; a volte, uccidere; dare fuoco alle
sedi… insomma, tutto quanto si riteneva necessario per costringere all’interruzione della lotta e a far
tornare a lavorare i lavoratori. Dunque, non sedare tentativi controrivoluzionari, ma costringere i lavoratori
ad una silente subordinazione. A questo scopo, venivano utilizzati disoccupati, reduci spiantati della prima
guerra mondiale, soggetti border line tra il rispetto della legge e la pratica di attività illegali, persone aduse
alla violenza: insomma, quel sottoproletariato povero ed incolto disponibile a qualunque attività pur di
racimolare un qualche guadagno.
In realtà, all’interno del PSd’I vi era una ridottissima fazione di rivoluzionari: capeggiati da un
sardo trapiantato a Torino – Antonio Gramsci – che aveva fondato una rivista l’Ordine Nuovo.
Furono questi che guidarono le lotte degli operai nel 1919-1920: quelli che son rimasti nella
storia come il cosiddetto biennio rosso. Dal nome della rivista di riferimento questi rivoluzionari
29
presero il nome di ordinovisti: furono quelli che, nel congresso del PSd’I di Livorno, del 1921,
uscirono da quel partito per fondare il PCd’I (Partito Comunista d’Italia). Ma, appunto, una
ristrettissima minoranza del Partito Socialista.
Le lotte dei lavoratori per i contratti, le attività intimidatorie dei fascisti e gli scontri diretti tra questi
ed i lavoratori, creavano (artatamente, volutamente) un clima sociale di tensione che sembrava pretendere
l’intervento delle forze di polizia per rispristinare l’ordine. Per di più, industriali del nord e latifondisti del
sud – ma anche ampi settori di piccola borghesia – ed i loro rispettivi rappresentanti (ipocritamente)
spingevano perché il re ed il governo intervenissero con sempre maggiore decisione per il ripristino
dell’ordine violato (il che, concretamente, dal loro punto di vista, significava far smettere le proteste e
costringere i lavoratori a rinunciare alle proprie rivendicazioni e tornare, in silenzio, al lavoro).
E per ripristinare l’ordine chi meglio dei fascisti (che, con le loro intimidazioni, erano proprio quelli
che l’ordine lo violavano continuamente)? Tanto più che – proprio tramite l’esercizio della violenza – i
fascisti aveva dato ampia prova di riuscire nell’intento!
E per dare un’ulteriore dimostrazione di forza, Mussolini convoca tutte le squadracce fasciste d’Italia
a Roma per il 28 ottobre 1922: doveva trattarsi di un corteo armato; quella che restò nella storia come la
marcia su Roma. Una vera e propria occupazione armata ed illegale della capitale dello Stato. Un’iniziativa
alla quale il re Vittorio Emanuele III avrebbe dovuto rispondere con la dichiarazione dello stato di
emergenza e facendo intervenire contro i fascisti polizia ed esercito.
Tutto questo, come si sa, non avvenne. Il re, al contrario, la sera stessa del 28 ottobre nominò
Mussolini capo del governo.
Nacque, così, il primo governo Mussolini: con un’alleanza tra fascisti, conservatori, una
parte dei liberali, una parte dei cattolici. Come si vede, Mussolini non era affatto isolato. Al contrario,
riuscì a mettere su una alleanza all’interno della quale erano presenti, sostanzialmente, tutte le forze antioperaie presenti nel panorama politico italiano; coinvolgendo in questa operazione anche personalità del
mondo liberale e cattolico che, in origine, non si resero conto del pericolo che Mussolini ed il fascismo
avrebbero costituito per le libertà ed i diritti democratici così duramente conquistati nel nostro Paese, al
prezzo di enormi sacrifici. Giunsero troppo tardi a questa consapevolezza, ma, allora il disastro era, ormai,
già compiuto.
Nel 1923 il governo Mussolini fece approvare la riforma elettorale.
Per riforma elettorale si intende la riforma del sistema elettorale.
IL SISTEMA ELETTORALE
Intanto, occorre dire che i seggi sono i posti disponibili per i parlamentari (o, anche, per i consiglieri
regionali, provinciali o comunali): ogni parlamentare, un seggio. Così che se ad una lista vengono
attribuiti 100 seggi, significa che quella lista ha diritto a 100 parlamentari.
Occorre, però, capire cosa vuol dire corrispondente, cioè come si determina il numero di seggi – cioè,
appunto, di parlamentari – ai quali una lista – un partito che presenti la sua lista di candidati alle elezioni –
ha diritto.
30
Da questo punto di vista, vi sono, fondamentalmente, due tipi di criteri possibili: quello
proporzionale e quello maggioritario. Conseguentemente, vi sono due tipi di sistemi elettorali:
Il sistema elettorale proporzionale,
Il sistema elettorale maggioritario.
Per sistema elettorale proporzionale si intende quel sistema elettorale che attribuisce ad
ogni partito una percentuale di seggi pari alla percentuale di voti ottenuta alle elezioni. Dunque,
se un partito ha ottenuto il 25% dei voti, avrà diritto al 25% dei seggi in Parlamento (al 25% dei
parlamentari); se ha ottenuto il 37% dei voti, avrà diritto al 37% dei parlamentari; etc. etc.
Per sistema elettorale maggioritario si intende quel sistema elettorale che attribuisce al
partito di maggioranza (quello che ha ottenuto il maggior numero di voti) una percentuale di
voti maggiore di quella che avrebbe avuto con il sistema proporzionale. Dunque, se il partito che
ha ottenuto più voti alle elezioni ha ottenuto il 25% dei voti, avrà diritto al 30, al 40, al 50, al 60… % dei
seggi; se il partito che ha ottenuto più voti alle elezioni ha ottenuto il 40% dei voti, avrà diritto al 50, al
60… % dei parlamentari.
I sistemi elettorali sono fondamentalmente così: o proporzionali, o maggioritari. Poi sono possibili
infinite modalità intermedie, che mischiano i due sistemi (in parte proporzionali ed in parte maggoritari),
cercando di correggere i difetti dell’uno e dell’altro: ed allora avremo l’infinita serie dei maggioritari corretti
e dei proporzionali corretti.
Sì, perché questo è il problema: che né il sistema proporzionale, né quello maggioritario sono privi di
difetti. Anzi, ognuno ha sia pregi, che difetti: precisamente, hanno pregi e difetti opposti l’uno all’altro.
Il sistema proporzionale ha un pregio indiscutibile: con esso il Parlamento è
pienamente rappresentativo della volontà popolare. Ogni partito – anche i partiti
più piccoli – è presente in Parlamento se e nella misura nella quale è presente tra i
cittadini. Il pregio è la massima rappresentatività dei cittadini.
Il difetto del sistema proporzionale è l’instabilità politica che determina (o
contribuisce a determinare). Infatti, proprio perché in Parlamento vi sono tutti i
partiti politici, anche quelli più piccoli, ognuno col proprio peso misurato dalla
percentuale dei voti ottenuti, è facile trovarsi nella situazione nella quale nessun
partito, da solo, abbia la maggioranza in Parlamento. Questo determina la necessità
– per approvare le leggi, per formare un governo – delle coalizioni tra partiti: anche
3… 4… 5… partiti. Ed è ovvio, che è più facile litigare tra partiti diversi, che nello
stesso partito. In definitiva, è facile che i partiti in coalizione ad un certo momento
comincino a litigare, che la coalizione si sciolga, che in Parlamento non ci sia più una
maggioranza e che, perciò, cada il governo e si debba andare alle elezioni
anticipate. Il difetto del sistema proporzionale è l’instabilità del sistema politico.
31
Col sistema maggioritario accade il contrario. Siccome favorisce il partito più
grande, questo sistema sfavorisce i partiti più piccoli: e può sfavorirli tanto che
molti piccoli partiti alle elezioni non si presentano nemmeno, perché tanto sanno
che non riusciranno ad entrare in Parlamento. Così che in Parlamento ci sono pochi
partiti e, tra questi, uno, alle elezioni sarà risultato quello più votato. Bene, a
questo partito si dà un numero di seggi abbastanza alto perché possa, da solo,
avere la maggioranza in Parlamento: il 55… il 60… % dei seggi. Il pregio di questo
sistema è, dunque, la stabilità del sistema politico.
Il difetto è che il Parlamento è poco rappresentativo della volontà popolare. Infatti,
mettendo insieme i partiti più piccoli non entrati in Parlamento (o con meno
parlamentari della propria percentuale di voti), la quota di cittadini che non ha
rappresentanti (o ne ha pochissimi) potrebbe essere anche molto elevata. E questo
è palesemente non giusto.
Ora, fino al 1923 il sistema elettorale italiano era stato un sistema proporzionale. Con la legge
Acerbo – dal nome del ministro proponente – il sistema divenne maggioritario. Tale legge
prevedeva che la lista che alle elezioni avesse avuto il maggior numero di voti, con una
percentuale comunque superiore al 25% dei voti, avrebbe ottenuto in Parlamento il 75% dei
seggi.
Ben si comprende la follia – o, meglio, la natura autoritaria – di una simile disposizione. Con essa,
infatti, il partito più votato alle elezioni, che, per esempio, avesse avuto il 30% dei consensi, avrebbe
ottenuto i ¾ dei seggi in Parlamento: avrebbe, cioè, controllato completamente il Parlamento con un terzo
dei voti degli elettori! E gli altri 2/3 dei cittadini – che avevano votato altri partiti – non avrebbero avuto
alcun potere e quasi nessuna rappresentanza!
E’ chiaro che, in una simile situazione, per ogni partito, diventava fondamentale riuscire a vincere le
elezioni: ad ottenere anche solo un voto in più rispetto agli altri partiti. Chi non fosse risultato vincitore
sarebbe stato destinato all’irrilevanza.
Le elezioni si tengono nel 1924.
Ovviamente, anche in quell’anno continuano le scorribande delle squadracce fasciste: le minacce, i
manganellamenti, fino agli assassini (il deputato socialista Giacomo Matteotti venne assassinato proprio in
quell’anno).
Dato il nuovo sistema elettorale avrebbe dovuto essere chiaro, per chiunque si presentasse alle
elezioni, che c’era la necessità di aggregarsi; di presentare le liste più ampie possibili, così da convogliare il
maggior numero di voti possibile: perché la lista che avesse preso anche solo un voto in più delle altre,
avrebbe ottenuto il 75% dei seggi in Parlamento e, dunque, avrebbe potuto approvare pressochè
qualunque legge e formare un proprio, solido governo.
Questa necessità di aggregazione la comprese Mussolini, che presentò una lista di candidati in gran
parte fascisti, ma che comprendeva anche candidati conservatori, liberali e cattolici: insomma, una lista – il
cosiddetto listone – comprendente i rappresentanti di tutte e forze politiche che sostenevano il primo
governo Mussolini.
Al contrario, le forze antifasciste (comunisti, socialisti, popolari) fecero prevalere le ragioni della loro
reciproca differenza, presentandosi separatamente, ognuno per conto proprio.
Chi volete che vincesse le elezioni?! Mussolini, ovviamente!, il listone… cioè, insomma, i
fascisti…
In questo modo il Parlamento si trovò sotto il pieno controllo dei fascisti che, progressivamente,
emarginarono sempre di più i loro alleati liberali e cattolici; Mussolini divenne capo del governo.
32
A partire dal 1925, con le cosiddette leggi fascistissime, comincia la costruzione dello Stato
fascista.
Per comprendere la logica unitaria di quelle che, appunto, sono state chiamate leggi fascistissime,
bisogna partire da una caratteristica fondamentale dell’ideologia fascista e, dunque, dello Stato
fascista: il corporativismo. Lo Stato fascista è, innanzitutto, uno Stato corporativo.
Da un punto di vista socialcomunista, da un punto di vista marxista, una tale organizzazione non ha
senso: non si possono mettere insieme, nella stessa organizzazione, lavoratori ed imprenditori. Questi,
infatti, sono soggetti tra loro antagonisti, con interessi contrapposti e tra loro confliggenti. Ognuno di questi
soggetti avrà una propria organizzazione, tramite la quale cercherà di realizzare al meglio i propri interessi,
scontrandosi con l’organizzazione avversa.
Quella marxista è la logica del conflitto: di quel conflitto che dovrebbe condurre alla distruzione della
società capitalistica ed alla costruzione della società socialista.
Precisamente il contrario del corporativismo fascista.
Secondo questa ideologia, infatti, gli imprenditori sono assimilabili ai lavoratori: come loro
lavorano (benchè con funzioni direttive, piuttosto che esecutive), come loro hanno interesse al
buon funzionamento dell’impresa (all’aumento della produzione e del reddito d’impresa).
Dunque, non c’è alcuna ragione di conflitto. Anzi, c’è la possibilità e la necessità della
collaborazione per migliorare le sorti dell’impresa. E c’è la possibilità e la necessità di coesistere
e cooperare all’interno di una unica associazione di settore: la corporazione, appunto. Per altro,
cooperando al buon funzionamento dell’impresa e del sistema economico, si contribuisce al
raggiungimento di quell’obiettivo di interesse nazionale che è l’aumento del PIL e, dunque, del
benessere generale della società.
Per converso, chi si ostina a fomentare il conflitto (gli scioperi dei lavoratori, le loro
proteste, etc.), chi indice scioperi, chi vi partecipa, etc., agisce contro l’interesse nazionale e,
dunque, commette un reato. Per di più, il lavoratore che sciopera viene meno ad un suo preciso
dovere contrattuale e, dunque, è giusto che ne subisca le conseguenze sul piano civilistico.
Ecco, questa, in sintesi, è la sostanza del corporativismo. Un’ideologia dalla quale sono, come adesso
vedremo, derivate buona parte di quelle leggi fascistissime che hanno strutturato il regime fascista.
Dalla logica corporativa, infatti, deriva che il conflitto sociale non ha ragion d’essere e chi l’organizza
o vi aderisce opera contro immotivatamente l’interesse nazionale: commette, cioè, un reato.
Di qui, le leggi che eliminano il diritto di sciopero, dichiarandolo reato ed inadempimento
contrattuale, con la conseguenza che coloro che dovessero indire o aderire ad uno sciopero verrebbero
licenziati ed incarcerati.
33
E chi dichiara scioperi? Quali organizzazioni si avvalgono degli scioperi come normale, ordinaria
forma di pressione nei confronti degli imprenditori, allo scopo di conseguire migliori condizioni per i
lavoratori?
I sindacati, ovviamente! Dunque, leggi che dichiarano illegali le organizzazioni sindacali e che ne
impediscono l’attività, facendo spazio, così, alla nascita delle corporazioni.
Ma eliminare i sindacati non basta. Queste, infatti, sono organizzazioni che operano grazie al
sostegno delle forze politiche non corporative; che hanno come dirigenti persone con una determinata idea
politica differente rispetto a quella del partito fascista. Quali sono queste forze politiche? Tutte: tutte
quelle non corporative!, tutte le forze politiche che non siano il partito fascista. Di qui, le leggi che
dichiaravano illegali tutte le forze politiche che non fossero il partito fascista. E, perciò, la formazione
di uno
Stato autoritario e
a partito unico.
L’esercizio della forza contro gli oppositori politici venne affidato ad un particolare ramo della
magistratura appositamente istituito: il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, incaricato di
perseguire i reati politici ed i cui giudici rispondevano direttamente al governo. Per questa via, la
magistratura – organo assolutamente autonomo ed indipendente rispetto al potere politico, nello Stato
liberale – venne assoggettata al governo ed alle sue disposizioni.
Il governo sommò nelle sue mani il potere esecutivo – conformemente al modello liberale – ma
anche quello giurisdizionale, in radicale contraddizione con quello stesso modello.
Ma lo stesso Parlamento fu completamente travolto, a seguito di un lento processo di svuotamento.
Intanto, perse la sua natura di organo rappresentativo della volontà popolare, a seguito della
natura del fascismo come Stato autoritario e a partito unico. E’ evidente, infatti, che non può ritenersi
rappresentativo un organo eletto sulla base di una sola lista di candidati scelti dal partito fascista e dal
governo fascista! Poi, il governo operò così da ridurre, fino ad eliminare il potere legislativo del
Parlamento, attribuendolo progressivamente al governo.
Dunque, da un lato, il Parlamento rimase una scatola vuota: priva di senso politico (non più
rappresentativo) e privo di poteri (esautorato); tanto che, nel 1939, venne definitivamente eliminato e
sostituito con la camera dei fasci e delle corporazioni. Dall’altro lato, il governo venne a detenere ogni
potere: quello suo proprio, quello esecutivo; ma anche, come visto, quello giurisdizionale; ed infine,
anche quello legislativo.
Ma, in realtà, dovremmo meglio specificare: non fu, infatti, il governo – nella sua collegialità – a
sommare su di sé tutti i poteri. Piuttosto, fu chi guidava quel governo – Mussolini – giuridicamente
qualificato come capo del governo: sopraelevato, dunque, rispetto ai suoi altri membri (i ministri).
Mussolini veniva, così, a ricoprire un ruolo centrale nella struttura statuale: dotato di un enorme potere
assoluto, non più limitato da alcun contrappeso istituzionale.
Lo Stato venne identificato con Mussolini. E per giustificare un così ampio ed illimitato potere, a
Mussolini vennero attribuite qualità eccezionali, superiori a quelle di qualsiasi altro uomo, quasi divine: gli
venne attribuito un carisma tale da rendere sensato l’attribuzione alla sua persona di un così grande
potere.
34
Lo Stato fascista si strutturò, dunque, intorno alla figura carismatica di Mussolini: depositario di
ogni potere.
Quello fascista fu uno Stato carismatico.
E per la stessa logica che già abbiamo visto in opera nello Stato socialista – con Stalin – e, prima
ancora – per altre vie – nello Stato assoluto, col re, anche in questo caso si pone il problema del consenso:
di dotare la figura del leader (del duce) di un consenso, il più possibile largo, di massa tra la popolazione.
Un problema, quello del consenso, che Mussolini e lo Stato fascista affrontano con determinazione:
seguendo la stessa logica (il totalitarismo) dello Stato socialista, ma, forse, con più incisività e più efficacia.
Nella logica totalitaria, lo Stato fascista controlla e pervade ogni ambito della vita sociale, civile e
politica della popolazione: controlla, come già sappiamo,
la politica, consentendo il solo partito fascista;
l’istruzione: le scuole e le università, imponendo nelle scuole l’ora obbligatoria di dottrina fascista,
libri di testo commemorativi del regime e della figura di Mussolini, e pretendendo – a prezzo del
licenziamento – da tutti gli insegnanti il giuramento di fedeltà al fascismo (pochi rifiutarono e vennero
cacciati dalle scuole e dalle università);
la stampa e l’editoria, impedendo l’uscita dei giornali di opposizione o, comunque, non allineati col
governo e ripristinando, per gli altri e per i libri, la censura (la cui eliminazione era stata una grande
conquista liberale);
il cinema, attraverso l’istituzione di un apposito istituto pubblico gestito dal governo, l’Istituto Luce;
la radio, anche qui istituendo un ulteriore istituto pubblico gestito dal governo, l’EIAR, che, alla
caduta del fascismo diventerà RAI;
l’economia, a partire dagli anni ’30, con la costituzione, nel ’33, dell’IRI (Istituto per la Ricostruzione
Industriale), destinato a gestire imprese in crisi per effetto della grande depressione partita dagli Stati Uniti
d’America; con l’ideologia corporativa, la nascita delle corporazioni e l’eliminazione dei sindacati;
il tempo libero delle persone, con una serie di associazioni in cui era pressochè obbligatorio
iscriversi, che seguivano ogni individuo dalla nascita fino alla morte (i figli della lupa, i balilla, i giovani
avanguardisti, etc.)…
tutto, insomma, tutto controllato dallo Stato e, per esso, dal governo.
Solo un soggetto sfuggiva al controllo dello Stato, un soggetto forte, potente: la Chiesa cattolica. Un
soggetto potente ed, allo stesso tempo, inaffidabile: per la sua avversione filosofica alla violenza, per un
orientamento politico che la legava piuttosto al partito popolare, che a quello fascista…
E Mussolini seguì, con la Chiesa cattolica, il vecchio adagio secondo il quale se uno non si può
sconfiggere, allora è il caso di farselo amico. In questa strategia, Mussolini approfittò del rincrescimento,
che ancora covava nei vertici ecclesiastici, per la conquista di Roma nel 1971 da parte dei bersaglieri di casa
Savoia e per la conseguente eliminazione del potere politico papale.
Nel 1929, il governo fascista ed il papa Pio XI (per lui, il segretario di Stato, cardinale Pietro Gasparri)
firmarono i Patti Lateranensi.
I patti lateranensi sono degli accordi che consistono in tre documenti: il trattato, il concordato e la
convenzione finanziaria.
35
Con il trattato lo Stato italiano tornava a riconoscere alla Chiesa cattolica la sovranità su una parte
della città di Roma, ricostituendo, così, lo Stato Vaticano e sanando la ferita inferta con la breccia di Porta
Pia del 1871 e mai, precedentemente, risanata.
Con il concordato lo Stato italiano riconosceva alla Chiesa cattolica tutta una serie di privilegi; tra
questi:
il riconoscimento della religione cattolica come religione dello Stato (in realtà, era già così
per effetto dell’art. 1 dell’allora Costituzione italiana, lo Statuto Albertino. Il Concordato
ribadisce tale principio e lo rafforza);
l’introduzione nelle scuole di ogni ordine e grado dell’ora obbligatoria di religione cattolica;
il riconoscimento ai fini civili dei matrimoni religiosi (per effetto di questa norma il
sacerdote diventa, in qualche misura, funzionario di stato civile);
il riconoscimento ai fini civili dello scioglimento del matrimonio decretato dai tribunali
ecclesiastici (la cosiddetta Sacra Rota).
Con la convenzione finanziaria lo Stato italiano riconosceva alla Chiesa cattolica tutta una serie di
agevolazioni economiche, soprattutto di natura fiscale.
Si può comprendere bene come i Patti Lateranensi potessero soddisfare le esigenze di una Chiesa
cattolica ancora risentita per i fatti del Risorgimento italiano: per la perdita di Roma e, dunque, del potere
politico su una parte del territorio italiano; per la perdita delle sue proprietà confiscate ed acquisite dallo
Stato italiano.
Soprattutto, con i Patti Lateranensi lo Stato fascista si configura come Stato confessionale:
uno Stato che assume una specifica religione come religione di Stato, elevandola rispetto al
livello delle altre fedi religiose e, di conseguenza, conferendo ad essa diritti non riconosciuti,
invece, alle altre confessioni.
In questo modo, con la stipulazione dei Patti Lateranensi, si compie il disegno totalitario dello Stato
fascista: attraverso il controllo di ogni ambito e di ogni soggetto della vita sociale e civile delle persone e
tramite l’alleanza con quei soggetti (la Chiesa cattolica) che non appaiono assoggettabili a controllo.
E, tuttavia, il potere assoluto del governo ed il controllo totalitario da esso esercitato sulla società
devono pur avere un indirizzo di fondo, devono pure orientarsi verso uno specifico, individuabile obiettivo.
E l’obiettivo, in effetti, si individua: la formazione di una società organica (dunque, non conflittuale), di un
organismo sociale compatto che si rappresenti nello Stato e nella determinatezza della sua azione. Una
organicità sociale che si esplichi sul piano economico (corporativismo), sul piano ideologico (totalitarismo),
ed anche sul piano culturale ed istituzionale.
Sul piano culturale, il fascismo si trova a dover fronteggiare gli stessi problemi di integrazione tra
meridionali e settentrionali con i quali avevano dovuto fare i conti i primi governi nazionali dopo l’Unità
d’Italia. E li affronta seguendo pressochè la stessa linea di condotta:
36
scuola elementare obbligatoria, per diffondere, su tutto il territorio nazionale, la
comprensione e l’uso – nella forma scritta ed in quella orale – della lingua italiana, in luogo,
soprattutto nel meridione, dei dialetti locali. Anzi, il fascismo, nella sua concezione
autoritaria dello Stato, radicalizza tale approccio, procedendo con la cosiddetta
italianizzazione forzata: impedendo, cioè, alle minoranze linguistiche, situate nelle zone di
confine del Paese (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta), di parlare la loro
lingua tradizionale (il tedesco ed il francese), per costringerle a parlare l’italiano. Per altro,
elimina dalla lingua italiana tutti i termini di derivazione anglofona;
esercito nazionale popolare – quella che un tempo si chiamava naia – così da imporre a tutti i
giovani del nord e del sud un periodo (forzato) di convivenza e, dunque, di conoscenza
reciproca, di reciproca comunicazione e di reciproco affratellamento;
guerra: guerra di conquista coloniale, così, anche, da costruire un nemico esterno (gli eserciti
nazionali anti-coloniali) per combattere il quale l’esercito nazionale italiano avrebbe dovuto
mostrarsi compatto, solidale e solido, al di là delle origini territoriali dei singoli componenti
dello stesso, condividendo tutti la stessa, drammatica, sorte.
Insomma, lo Stato fascista, ai fini dell’integrazione nazionale, adotta, sostanzialmente, due politiche:
una politica scolastica,
una politica di guerra.
Nel corso del ventennio fascista sono state intraprese numerose guerre: in Libia, in Somalia, in
Eritrea, in Etiopia, in Albania … fino al disastro della seconda guerra mondiale a fianco della Germania
nazista.
Quello fascista, dunque, fu anche uno Stato di guerra.
La sete e la volontà di controllo del regime su ogni aspetto della vita civile e sociale non poteva,
infine, non avere un riscontro anche dal punto di vista istituzionale. Occorreva che la volontà del governo
fosse vigente e rispettata ad ogni livello territoriale, tanto sul piano nazionale, che su quello locale.
All’epoca non esistevano le Regioni; vi erano, però, i Comuni e le Province.
Bene, il governo fascista, per assicurarsi che anche le politiche locali fossero conformi alla
sua volontà ed al suo orientamento, mise a capo delle Province i Prefetti, nominati dal governo
stesso; e, per quanto riguarda i Comuni, abolì la figura del Sindaco – soggetto eletto dai residenti
del Comune e, dunque, autonomo rispetto agli orientamenti politici del governo – per sostituirla
con quella del Podestà, soggetto, anche questo, nominato dal governo.
Agì, dunque, in modo da attribuire ogni decisione al governo: organo dello Stato centrale,
in quanto deputato ad assumere decisioni relative all’intero territorio dello Stato.
Sostanzialmente, eliminò ogni autonomia locale, rimettendo ogni potere allo Stato e, nello
specifico, al governo. E’ per questo che, sul piano istituzionale, è possibile dire che lo Stato
fascista fu uno Stato accentratore.
Dal punto di vista internazionale – geopolitico – il regime fascista, lo abbiamo detto, operò come uno
Stato di guerra: per la conquista delle colonie; in sostegno al colpo di Stato di Francisco Franco in Spagna,
nel 1936; ed, infine, per l’ingresso nella II guerra mondiale, a fianco della Germania di Hitler.
Quest’ultima follia – che si rivelò il definitivo disastro dell’Italia e del regime – aveva, tuttavia,
bisogno di una certa preparazione. Occorreva che Mussolini desse prova di adesione ai piani criminali
nazisti di sterminio nei confronti degli ebrei: che sostenesse fattivamente e legislativamente i nazisti nel
loro tentativo di soluzione finale della questione ebraica (secondo il loro linguaggio).
37
E Mussolini si adoperò a questo scopo, approvando, nel 1938, le leggi antiebraiche: leggi razziste che
impedivano agli ebrei di sposarsi liberamente, di avviare un’impresa, di lavorare alle dipendenze dello Stato
o di istituzioni educative, di studiare, etc.. E ciò, quando non imponevano rastrellamenti, detenzioni in
carcere o in campi di concentramento, o affidamenti ai tedeschi perché fossero loro a decidere la sorte di
queste persone (e la storia ci insegna quale sorte i nazisti abbiano riservato agli ebrei).
Le politiche coloniali e le leggi antiebraiche qualificano, dunque, lo Stato fascista come
Stato razzista.
Dunque, in definitiva, volendo sintetizzare le caratteristiche proprie dello Stato fascista, dovremo
dire che lo Stato fascista è:
corporativo, in quanto rifiuta l’idea del conflitto sociale e pretende di imporre la cooperazione tra le
classi sociali;
autoritario, in quanto reprime con la violenza il dissenso politico rispetto al governo;
a partito unico, in quanto mette fuori legge tutti i partiti che non siano quello fascista;
carismatico, in quanto si struttura intorno alla figura del capo del governo, al quale vengono attribuite
qualità sovra-umane;
totalitario, in quanto controlla e pervade, con la sua ideologia, ogni campo della vita sociale e civile delle
persone;
confessionale, in quanto assume una religione come religione di Stato, sopraelevandola rispetto a tutti
gli altri culti religiosi;
accentratore, in quanto elimina ogni autonomia degli Enti Locali rispetto al governo centrale;
razzista, in quanto, con le leggi antiebraiche, aderisce e coopera con l’ideologia nazista della superiorità
della razza ariana;
di guerra. In quanto usa l’esercito per conquistare territori ed in funzione delle politiche di integrazione
nazionale.
Il regime fascista entra in guerra, al fianco della Germania di Hitler, 10 giugno 1940. Hitler ha già
occupato buona parte dell’Europa e pare non avere ostacoli al suo progetto di conquista. Mussolini pensa
che, alleandosi con Hitler, riuscirà a guadagnare territori a seguito della vittoria di questi.
In realtà, le sorti della guerra, dopo qualche anno e per effetto dell’intervento anglo-americano,
volgono in direzione opposta. Con l’avanzata dell’esercito sovietico verso la Germania e lo sbarco in Sicilia
degli inglesi e degli americani, nel luglio del 1943, la guerra è ormai persa: e nella maniera più vergognosa.
E’ così che, nella notte tra il 24 ed il 25 luglio 1943, il Gran Consiglio del fascismo, organo che riunisce
i capi del regime e del partito, vota la sfiducia nei confronti di Mussolini. Finalmente, il re Vittorio Emanuele
III, che era rimasto silente e connivente per un ventennio, torna a prendere la parola per destituire
Mussolini e sostituirlo col generale dell’esercito Pietro Badoglio. Questi, immediatamente, dichiara fuori
legge il partito fascista, facendo tornare alla legalità tutti gli altri partiti. L’Italia, intanto, è divisa in due:
occupata a sud dalle truppe anglo-americane che dalla Sicilia risalgono verso Roma, ed a nord dalle truppe
tedesche che, a loro volta, si dirigono verso Roma per fermare l’avanzata anglo-americana.
Per di più, Mussolini non ha affatto rinunciato al governo. Liberato, dal luogo (sul Gran Sasso, a
Campo Imperatore) dove era tenuto prigioniero dopo l’arresto, da un commando tedesco, e portato a nord,
38
sul Lago di Garda sotto la tutela dei tedeschi, a Salò fissa la sede del suo nuovo governo, per opera del
quale avrebbe dovuto ricostruire in Italia un nuovo regime fascista: è la cosiddetta Repubblica di Salò.
L’8 settembre 1943 Badoglio firma (in realtà, rende pubblico, essendo stato già firmato nei giorni
precedenti) l’armistizio con gli anglo-americani. Per effetto di questo atto, l’Italia, prima alleata
con la Germania, diventa alleata degli inglesi e degli americani. Non accade spesso una cosa così! Fu
un momento di grande confusione: di sbandamento, come si disse. Per un certo tempo non si capiva bene
se i militari italiani dovessero ancora continuare a combattere contro gli anglo-americani o, invece,
dovessero volgere le armi contro i tedeschi. La confusione politica e della catena di comando, spinse
moltissimi a scegliere individualmente: alcuni, i nostalgici del fascismo, seguirono Mussolini a Salò; altri, gli
antifascisti, scelsero di organizzarsi in squadre paramilitari (squadre partigiane), per affiancare gli angloamericani con azioni di guerriglia (quel fenomeno che fu chiamato Resistenza).
La liberazione del territorio italiano dall’occupazione nazi-fascista fu definitivamente conquistata nel
1945: il 25 aprile.
Gli anni compresi tra la seconda metà del 1943 ed il primo di gennaio 1948, data in cui
entrò in vigore la nuova Costituzione della Repubblica democratica italiana, sono ricordati come
il cosiddetto periodo transitorio. Transitorio, cioè di passaggio: dal regime fascista ad una nuova
forma di Stato: lo Stato democratico.
Durante gli anni dal ’43 al ’45, La Resistenza coinvolse tutte le forze politiche antifasciste: anche
quelle – liberali e cattoliche - che originariamente non avevano ben compreso la gravità del fenomeno
fascista ed, anzi, avevano dato il loro sostegno a Mussolini. Si formarono, così formazioni partigiane
liberali, cattoliche, oltre, ovviamente, a quelle socialiste e comuniste.
Un panorama composito al quale, tuttavia, occorreva garantire coerenza d’intenti e d’azione. A
questo scopo venne costituito il Comitato di Liberazione Nazionale, organo di direzione della guerra
partigiana, composto unitariamente da esponenti di tutte le forze politiche antifasciste: dai liberali, ai
comunisti.
Si comprenderà assai bene, negli anni successivi, l’importanza di questa esperienza unitaria nella
lotta di liberazione: dirigenti di orientamento politico assai differente, costantemente in dialogo allo
scopo di raggiungere un obiettivo per tutti, analogamente, fondamentale; l’obiettivo di liberarsi
definitivamente della dittatura fascista e dell’occupazione nazista del territorio italiano. Questi partiti
politici ed i loro dirigenti anteposero questo obiettivo immediato alle differenze di prospettiva politica
che, ovviamente, sarebbero tornate ad essere centrali una volta conseguito l’obiettivo unitario.
Ed, anzi, per il raggiungimento di questo obiettivo, in un ulteriore sforzo di reciproca
comprensione, diedero vita, a partire dal 1944, ai cosiddetti governi di unità nazionale: governi composti
da ministri di tutti i partiti politici antifascisti e guidati dai capi del Comitato di Liberazione Nazionale (il
governo Parri ed il governo Bonomi).
Il periodo transitorio fu, dunque, una grande, importantissima palestra unitaria per le forze
politiche antifasciste.
E, tuttavia, non bastava aver definitivamente sconfitto il nazifascismo. Occorreva procedere alla
costruzione di un nuovo Stato, ben diverso rispetto a quello appena crollato.
Si decise così di convocare, per il 2 giugno del 1946, a suffragio universale maschile e
femminile
39
un referendum istituzionale e
l’elezione della Assemblea Costituente.
Un referendum istituzionale, col quale il popolo fosse chiamato a scegliere se l’Italia
dovesse restare una monarchia o, altrimenti, diventare una Repubblica.
L’elezione di una Assemblea Costituente, cioè di un organismo di 556 componenti,
incaricato di scrivere una nuova Costituzione in sostituzione del vecchio ed arretrato Statuto
Albertino.
Come si sa, nel referendum istituzionale la Repubblica ebbe la meglio sulla monarchia.
L’Assemblea Costituente si trovò, dunque, a scrivere una nuova Costituzione questa volta
non più monarchica, ma repubblicana.
E’ proprio in sede di lavori dell’Assemblea Costituente che si rivelò fondamentale l’esperienza
unitaria, antifascista, del periodo transitorio. Infatti, i partiti politici antifascisti, forti di quella esperienza,
riuscirono a dialogare tra loro al di là delle differenze politiche: così da dare al nuovo Stato democratico
italiano una Costituzione profondamente innovativa rispetto all’esperienza fascista e, allo stesso tempo,
fortemente unitaria e, dunque, di compromesso tra orientamenti politici spesso assai differenti.
Tanto che, se si volessero sintetizzare i caratteri propri della Costituzione italiana,
occorrerebbe dire che essa è
innovativa e
di compromesso.
Innovativa, nel senso che organizza una comunità ed uno Stato completamente diversi
rispetto a quelli dell’esperienza fascista.
Di compromesso, nel senso che essa realizza una sintesi fra differenti scuole di pensiero
politico, estraendo da ciascuna la parte migliore e ponendola a sintesi con i contributi
provenienti dalle altre parti. Insomma: nella Costituzione italiana è possibile rinvenire elementi
del pensiero politico social-comunista, liberale e cattolico, senza, tuttavia, che sia possibile
comprenderla nella sola ottica di uno qualsiasi di questi orientamenti politici.
Ma più nello specifico del dettato costituzionale entreremo in seguito.
Ora occorre soffermarci sulle caratteristiche di questa nuova forma di Stato, che abbiamo chiamo
democratico, e che in Italia, come abbiamo visto, si conquista solo con la fine della dittatura fascista.
LO STATO DEMOCRATICO
Se, in Italia, lo Stato democratico si conquista solo a seguito della caduta del fascismo, in altri Paesi il
processo è più veloce. Per comprendere come tale processo si articola, è bene ricordare che quella
democratica è una terza forma si Stato che deriva dalla questione sociale.
Si ricorderà che dallo scontro tra proletariato e borghesia capitalistica – appunto, la cosiddetta
questione sociale – derivano
40
lo Stato socialista
lo Stato fascista e, ora lo possiamo dire,
lo Stato democratico.
Tuttavia, mentre i primi due – lo Stato socialista e quello fascista – rappresentalo uno stravolgimento
dell’assetto socio-economico e politico del sistema capitalistico (quello fascista, essenzialmente, del solo
sistema politico; quello socialista, di entrambi) e, dunque, richiedono la realizzazione di una qualche azione
rivoluzionaria; lo Stato democratico non è affatto una rivoluzione del sistema capitalistico – non è
affatto un suo ribaltamento – quanto, piuttosto, una sua evoluzione (un suo lento adeguamento
alle nuove situazioni storiche, che si realizza senza che vengano meno le sue caratteristiche di
fondo).
Dunque, la democrazia si conquista, nel mondo, progressivamente, lentamente: a seguito di ripetuti
cambiamenti in vari aspetti del precedente assetto politico-economico liberale. Tanto che, lo Stato
democratico mantiene, come vedremo, molte delle caratteristiche proprie dello Stato liberale,
qualificandosi, come molti pure dicono, come Stato liberal-democratico.
Un primo cambiamento in senso democratico dello Stato liberale avviene già nel corso dell’800, in
conseguenza delle lotte del movimento operaio.
I lavoratori, infatti, come abbiamo visto, non potevano accontentarsi dei diritti individuali –
dell’uomo e del cittadino – che le Costituzioni liberali riconoscevano. Avevano, piuttosto, bisogno di poter
esercitare diritti collettivi: di poter svolgere un’assemblea; di potersi associare per formare un partito
politico, o un sindacato; di poter indire e realizzare uno sciopero… Furono queste le prime rivendicazioni
operaie… Rivendicazioni portate avanti a suon di scontri con le forze dell’ordine, di arresti, di incarcerazioni,
di morti anche… E, però, alla fine, i governi ed i parlamenti furono costretti a riconoscere questi nuovi
diritti: affiancandoli nelle Costituzioni, come diritti collettivi, ai già riconosciuti diritti individuali.
Questo fu il primo grande cambiamento in sede costituzionale: nelle Costituzioni democratiche si
riconoscono oltre ai dritti individuali, anche quelli collettivi.
Ed altri cambiamenti giunsero a seguito dell’esercizio di quei diritti collettivi appena conquistati.
I partiti dei lavoratori (il Partito socialista… quello comunista…: ebbero varie definizioni, a seconda
dei luoghi…) si proposero immediatamente un obiettivo: quello di riuscire ad estendere la possibilità di
esercizio del diritto di voto anche a coloro che, al contrario, ne erano esclusi in base al criterio del voto
censitario.
Ed anche qui: non fu facile… ci vollero anni… In Italia, si ricorderà, si dovette attendere il 1912… E,
tuttavia, il diritto di voto venne progressivamente esteso fino a ricomprendere l’intera popolazione:
prima soltanto maschile (suffragio universale maschile), poi anche quella femminile (suffragio
universale maschile e femminile; in Italia, nel 1946 ).
Ed eccola, un’ulteriore differenza tra lo Stato liberale e quello democratico: lo Stato liberale
riconosce il diritto di voto censitario e, dunque, si qualifica per essere uno Stato elitario
(rappresentativo, cioè, del ristretto gruppo – elite – dei più ricchi); lo Stato democratico
riconosce il suffragio universale e, dunque, si qualifica per essere uno Stato universalmente
rappresentativo (cioè, rappresentativo di tutta la popolazione).
In definitiva, ecco le prime caratteristiche: lo Stato democratico è uno
41
Stato costituzionale,
di diritto,
universalmente rappresentativo.
Esercitando gli appena conquistati diritti collettivi, i lavoratori costituirono propri partiti politici e
diedero vita a delle proprie associazioni in campo socio-economico. Queste ultime presero nome di
sindacati.
Attraverso i sindacati, i lavoratori si organizzarono allo scopo di ottenere migliori condizioni di lavoro:
una riduzione delle ore di lavoro giornaliere; l’aumento delle retribuzioni; una qualche forma di provvigione
nel caso di malattia, o di infortunio, o di vecchiaia; una qualche salvaguardia in caso di malattia…
Rivendicazioni che i lavoratori rivolgono agli imprenditori, certamente; ma questi, ovviamente, fanno
resistenza, tentano di non cedere, o di cedere il meno possibile… ed hanno la forza di cedere il meno
possibile: hanno la forza che deriva loro dalle sostanze economiche di cui dispongono.
Ed, allora, i lavoratori e le loro organizzazioni rivolgono le loro rivendicazioni allo Stato: l’unico
soggetto in grado di imporre con la forza, tramite le leggi, quelle migliori condizioni di lavoro che,
altrimenti, gli imprenditori tarderebbero così tanto ad accettare.
Le lotte sindacali e dei lavoratori sono così intense, ed anche così prolungate nel tempo, che lo Stato,
in definitiva, anche sotto la pressione dei partiti dei lavoratori, è costretto ad accettare: ad emanare leggi
che si muovono nella direzione delle richieste del movimento operaio. E’ così che vengono approvate le
leggi
sulla riduzione della giornata lavorativa, che riducono le ore di lavoro giornaliere;
sulla tutela del lavoro minorile e femminile, che impediscono ai bambini al di sotto di
una certa età di andare al lavoro ed impediscono ai datori di lavoro di utilizzare donne in
gravidanza nei turni lavorativi notturni e nei lavori pesanti.
Nel far questo, lo Stato opera per la pace sociale, per l’attenuazione del conflitto sociale e, in qualche
modo, riconosce la legittimità delle richieste dei lavoratori. Ma, operando in questo modo, soprattutto, lo
Stato implicitamente riconosce l’opportunità e, forse, la necessità di intervenire nelle questioni di ordine
economico: di intervenire in quelle materie che le politiche liberiste avrebbero lasciato completamente
nelle mani dei soggetti privati (lavoratori da un lato, imprenditori dall’altro). In questo modo, lo Stato
è meno liberista e più interventista: più interessato, più attento e più partecipe di quanto
avviene nel sistema economico.
Inizia così, dalle prime leggi approvate nell’800 in questioni di ordine economico, quel processo che
porterà lo Stato ad intervenire sempre più massicciamente nel sistema economico: soprattutto, a tutela dei
soggetti sociali più deboli. Un processo che si articolerà nelle prime forme di previdenza sociale realizzate in
Prussia da Otto Von Bismarck, all’amplissimo piano di interventi infrastrutturali e redistributivi (new deal)
posti in essere da Franklin D. Roosevelt, negli Stati Uniti, allo scopo di superare i disastrosi effetti della crisi
del ’29. Fino a giungere alla formazione di sistemi economici – quali, ad esempio, quello italiano –
che, pur mantenendo una struttura indiscutibilmente capitalistica, prevedono, tuttavia, un
amplissimo intervento pubblico nel sistema economico sia in forma diretta (attraverso la
gestione di aziende in mano pubblica), che indiretta (attraverso strumenti di politica
economica): sistema capitalistico ad economia mista.
Insomma,
42
lo Stato democratico è interventista: interviene nel sistema economico, soprattutto a
vantaggio delle fasce di popolazione più deboli. Nel far questo, lo Stato democratico si conforma
come Welfare State (Stato sociale): uno Stato che opera allo scopo di assicurare a tutti un livello
minimo accettabile di benessere sociale.
Si comprende bene quali siano gli effetti politici dell’intervento pubblico in economia.
Essi servono a ridurre l’intensità delle lotte sociali: insomma, a ridurre la rabbia dei lavoratori per le
proprie condizioni di vita e di lavoro; e, per questa via, a preservare la solidità e la stabilità di un sistema
capitalistico che, altrimenti, a fronte di lotte particolarmente veementi, rischierebbe di venir meno. La
logica è: se si vuole evitare una rivoluzione come quella sovietica, allora bisognerà fare in modo che i
lavoratori non abbiano troppo da lamentarsi!
L’intervento pubblico in economia – le misure di welfare – funzionano come ammortizzatori sociali:
misure capaci di contenere e ridurre lo scontro sociale (rinsaldando così, la stabilità del sistema).
Quello democratico è, dunque, dal punto di vista del rapporto tra le classi sociali, uno
Stato di compromesso: la borghesia capitalistica mantiene intatto il potere economico (e,
dunque, politico), concedendo, tuttavia, ai lavoratori provvidenze che ne migliorano (a volte
anche in modo significativo) le condizioni di vita.
Dunque, in definitiva, potremmo dire che lo Stato democratico non è altro che lo Stato liberale
così come, nel tempo, è andato modificandosi sotto due riguardi:
quello politico, attraverso l’abbandono del suffragio censitario a favore del
suffragio universale;
quello economico, attraverso l’abbandono delle politiche liberiste a favore
dell’intervento in economia e delle politiche di welfare.
LA COSTITUZIONE ITALIANA
Il 2 giugno 1946, per effetto del referendum istituzionale, l’Italia diventa una Repubblica.
L’Assemblea Costituente, eletta a suffragio universale maschile e femminile quello stesso
giorno, deve, dunque, scrivere la Costituzione repubblicana di uno Stato che intende essere
assolutamente diverso rispetto all’appena decaduto Stato fascista. Deve trattarsi, perciò, di una
Costituzione innovativa.
Ed innovativa, effettivamente, è; per un’infinita serie di aspetti – che cercheremo di vedere nello
specifico – ma che, in sintesi, potremmo indicare con un solo termine: antifascista. La nostra
Costituzione è, prima di tutto ed essenzialmente, una Costituzione antifascista: una Costituzione
nata dalla Resistenza al nazi-fascismo.
Lo si dice esplicitamente, negli artt. 12 e 13 delle Disposizioni finali e transitorie: nell’art.
12 che dichiara “vietata la ricostituzione, sotto ogni forma, del disciolto partito fascista”;
nell’art. 13 che dispone l’esilio per i membri ed i discendenti di Casa Savoia (per via delle enormi
responsabilità della monarchia Savoia nella nascita del governo fascista, nella costruzione e nelle politiche
del regime).
43
E poi, il carattere innovativo della Costituzione italiana risulta evidente dall’
art. 1, che definisce lo Stato italiano una Repubblica (per di più, una Repubblica nella quale
non è consentito tornare ad una
forma istituzionale monarchica)
ed una Repubblica democratica
fondata sul lavoro (sul diritto al lavoro: art. 4) e, cioè, sul riconoscimento
dell’autonomia organizzativa e politica dei lavoratori e sulla
piena tutela dei loro diritti. In questo senso è da intendere il
diritto alla libertà sindacale (art. 39), ripristinata in luogo della
coazione corporativa e, conseguentemente, il diritto di
sciopero (art. 40); il diritto alla retribuzione (art. 36),
proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto e,
comunque, tale da “assicurare al lavoratore ed alla sua
famiglia un’esistenza libera e dignitosa”; il diritto alla parità
della donna lavoratrice con le condizioni riservate ai lavoratori
maschi per identiche attività lavorative (art. 37); il diritto
all’assistenza sanitaria e previdenziale (art. 38).
Una democrazia nella quale lo Stato interviene ampiamente a garantire i diritti dei
lavoratori – quelli appena indicati, ed altri ancora previsti in apposite leggi – ed, in generale, il
benessere dell’intera collettività, anche, se necessario, limitando la libertà d’impresa. Di qui, gli
artt. 41-42-43 che, pur disegnando un sistema economico capitalistico (riconoscimento
della proprietà privata dei mezzi di produzione, delle aziende (quelli che
l’art. 42 chiama “beni economici”) e la “libertà di iniziativa economica
privata” (art. 41), impongono allo Stato di intervenire nel sistema
economico allo scopo di assicurare “la sicurezza, la libertà, la dignità
umana” (art. 41), anche, eventualmente, con proprie aziende (art. 42), e
persino espropriando aziende precedentemente private (art. 43).
Un sistema dunque, sì capitalistico, ma ad economia mista ed a sviluppo
programmato.
E, poi, gli articoli che sostanziano, dal punto di vista delle libertà, l’assetto democratico – e,
perciò, pluralista - dello Stato:
art. 13, la libertà personale;
art. 17, libertà di riunione;
art. 18, la libertà di associazione (in generale) e quella di associazione in partiti politici (art.
49);
art. 19, la libertà di culto;
art. 21, la libertà di manifestazione del pensiero, con la connessa libertà di stampa e
l’eliminazione della censura.
44
Infine, gli articoli che strutturano lo Stato democratico dal punto di vista istituzionale:
quelli che ripristinano la divisione dei poteri, dando al Parlamento nuova centralità ed, anzi,
rafforzandone i poteri; quelli che ripristinano, rafforzandola, l’autonomia e l’indipendenza della
magistratura dal potere politico; quelli che recuperano l’autonomia degli enti pubblici territoriali
rispetto al potere centrale ed, anzi, pongono le basi per quell’ampio decentramento dei poteri
che ha caratterizzato la storia istituzionale italiana per buona parte degli anni successivi
all’entrata in vigore della Costituzione, fino ai giorni nostri.
Altri ancora, pur molto importanti, ne potremo citare: l’art. 6, che riconosce e tutela le
minoranze linguistiche; l’art. 11, che stabilisce il ripudio della guerra.
Insomma, l’abbiamo già detto, in sintesi, la nostra, è una Costituzione antifascista.
E, tuttavia, si trattava di realizzare insieme queste innovazioni: così come, insieme, era stata condotta
la guerra di liberazione nazionale dal nazi-fascismo. Si trattava, perciò, di mettere d’accordo correnti
politiche diverse; appunto, quelle che avevano dato vita alla Resistenza: quella social-comunista, quella
liberale e quella cattolica. Alle forze politiche che esprimevano questi differenti orientamenti era rimesso il
compito di trovare tra loro un compromesso, un accordo per scrivere insieme la Costituzione del nuovo
Stato democratico italiano.
E l’accordo fu trovato. Ne venne fuori, appunto, una Costituzione di compromesso, segnata da un
delicato equilibrio tra principi di ispirazione ed origine politica diverse. Molti articoli della Costituzione
portano i segni di questo compromesso: anche molti degli articoli più innovativi citati in precedenza.
Facciamone qualche esempio:
art. 1, che definisce lo Stato italiano una Repubblica democratica, nel senso di
liberal(democratica) – un principio
propriamente liberale, dunque – ma
fondata sul lavoro (e sulla tutela dei
diritti dei lavoratori), secondo un
principio
tipicamente
socialcomunista;
art. 2, che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo (secondo un principio propriamente
liberale…
dalla
Rivoluzione
Francese…); ma, al contempo,
richiede l’adempimento dei doveri di
solidarietà economica e sociale
(secondo un principio di origine
socialcomunista e cattolica);
art. 3, che riconosce l’uguaglianza degli uomini di fronte alla legge (uguaglianza
tipicamente liberale), ma pretende
che lo Stato agisca per eliminare gli
ostacoli di ordine economico e sociale
che, di fatto, impediscono una
effettiva uguaglianza tra gli uomini
45
(richiamo, questo, alla tradizione
socialcomunista);
artt. 7-8 e 19, che, nel complesso, disegnano uno Stato laico (secondo l’ispirazione liberale)
e, tuttavia, riconoscendo, all’art. 7, i
Patti Lateranensi, introduce in
Costituzione
elementi
di
confessionalismo (secondo le volontà
dei cattolici);
e poi, gli
artt. 41-42-43 che, disegnano uno società sì capitalista, secondo l’ispirazione liberale, ma
ad economia mista ed a sviluppo
programmato (riprendendo, così,
l’idea, socialcomunista ed anche
cattolica,
della
necessità
dell’intervento pubblico nel sistema
economico, soprattutto a tutela dei
più deboli).
Insomma, sul testo della Costituzione italiana si è realizzato un compromesso che ha visto tutte le
forze politiche antifasciste, pur di differente orientamento politico, convergere sull’esigenza di procedere a
grandi innovazioni nella struttura giuridica della società e dello Stato italiani.
Un compromesso di alto profilo, dunque, capace di disegnare uno Stato democratico molto avanzato
sul piano giuridico, sociale e civile; un compromesso pensato per durare nel tempo. Tanto che, se dal punto
di vista del contenuto, come detto, la Costituzione italiana è innovativa e di compromesso, dal punto di
vista formale – cioè, delle procedure di approvazione e di revisione – è votata e rigida.
Votata, nel senso che fu votata dall’Assemblea Costituente eletta dal popolo a suffragio
universale; rigida, nel senso che prevede alcune parti immodificabili (per esempio la natura
repubblicana dello Stato), e le altre parti – modificabili – possono essere modificate solo
attraverso leggi costituzionali, più lunghe e più difficili da approvare rispetto alle leggi ordinarie.
La difficoltà alla quale l’Assemblea Costituente ha voluto sottoporre le modifiche alla Costituzione,
sta a significare il fatto che il dettato costituzionale, così come approvato, era destinato – come poi è
effettivamente successo – a permanere nel tempo in modo stabile: a costituire un saldo punto di
riferimento della vita istituzionale e civile del Paese.
Sarebbe stato logico attendersi una veloce attuazione delle nuove norme costituzionali: soprattutto
di quelle più innovative. Per questo c’era stata la guerra di liberazione: per cambiare radicalmente lo stato
di cose e per farlo al più presto possibile.
Le cose, però, non andarono così.
GLI ANNI DELLA REPUBBLICA: gli anni ‘50
Le prime elezioni politiche in Italia si tengono il 18 aprile 1948.
46
Si tengono in un clima di fortissimo scontro, non soltanto per ragioni interne: i partiti politici, una
volta abbattuto il regime fascista, tornano a scontrarsi in conseguenza delle radicale differenze politiche ed
ideologiche; ma anche per ragioni internazionali: Stati Uniti ed Unione Sovietica si erano divisi il mondo e
l’Italia, dopo grandi discussioni, era stata inserita nel blocco occidentale dominato dagli USA.
La campagna elettorale del ’48, dunque, risente fortemente di questo clima di contrapposizione
internazionale: la DC (Democrazia Cristiana) rappresenta il partito politico di riferimento degli Stati Uniti,
il PCI (il partito di riferimento dell’Unione Sovietica). Che vinca l’uno, o vinca l’altro, a vincere o a perdere
non è soltanto il partito, ma anche una delle due superpotenze. Insomma, la campagna elettorale del ’48 è,
in sede locale, un momento dello scontro tra le due grandi potenze del mondo.
Le elezioni sono vinte dalla Democrazia Cristiana che – appoggiata anche dalla Chiesa, oltre che dagli
USA – riesce a conquistare la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento.
Non si rivelò un buon inizio per l’applicazione della Costituzione: soprattutto, non lo fu per
l’attuazione di quella parte della Costituzione più innovativa. D’altra parte, la DC è sempre stata un partito
moderato, ostile ad ogni forma di veloce e profondo cambiamento: più portato ai tempi lenti ed ai
cambiamenti lievi e progressivi…
A seguito delle elezioni dell’aprile del 1948, la Democrazia Cristiana formò un governo di coalizione
comprendente 4 partiti: se stessa, ovviamente, il PRI (Partito Repubblicano Italiano), il PSDI (Partito
Socialdemocratico Italiano) e il PLI (Partito Liberale Italiano); insomma, un governo di centro-destra.
L’attuazione della Costituzione fu molto lenta. Solo nel 1956 – dunque, otto anni dopo la sua entrata
in vigore – fu istituita la Corte Costituzionale. Solo nel 1958 – dieci anni dopo – fu istituito il CSM, il
Consiglio Superiore della Magistratura.
Si badi che si tratta di organi importanti.
La Corte Costituzionale ha come propria funzione fondamentale l’annullamento delle leggi
che risultino, secondo il suo giudizio, in contrasto con la Costituzione. E tante ce ne dovevano
essere in quel periodo, visto che si veniva fuori dal ventennio fascista e, dunque, una parte consistente
delle leggi allora in vigore era stata approvata in quel periodo: perciò, molto probabilmente, da annullare.
La mancata istituzione immediata della Corte Costituzionale ha, quindi, determinato grandi ritardi nel
rinnovamento della legislazione italiana in senso antifascista e democratico: tanto più se si considera che
non bastava istituire la Corte… occorre che questa iniziasse a funzionare effettivamente… ed anche questo
richiese un certo tempo… Insomma, ci siamo tenuti leggi fasciste per tanto tempo, dopo la caduta del
fascismo (si pensi solo alla legge sulla scuola…); ed ancora oggi, non ci siamo ancora completamente liberati
di quel retaggio.
Il CSM è l’organo che garantisce l’autonomia e l’indipendenza della magistratura rispetto
al potere politico: dunque, garantisce quel principio di legalità che è a fondamento dello Stato
democratico. Ora, se si ricorda che lo Stato fascista asservì la magistratura al governo, si comprende bene
come fosse necessario istituire immediatamente il CSM, per garantire al nuovo Stato italiano quella
divisione dei poteri che è struttura tipica di uno Stato democratico. Anche sotto questo profilo, al contrario,
i ritardi sono stati tali che c’è da chiedersi se le pretesa di impunità che spesso viene imputata al potere
politico e l’inefficienza della magistratura per troppo tempo troppo distratta rispetto alle malversazioni
della classe politica, non dipendano … certo dal fascismo, ma anche da chi, dopo la liberazione, non ha
saputo immediatamente disfarsi dei retaggi del fascismo.
Tuttavia, il governo italiano, in quegli anni, non era solo chiamato ad attuare la nuova Costituzione,
ma anche ad operare per la ricostruzione del Paese distrutto dalla guerra e rilanciare l’economia nazionale.
47
Quest’ultimo era compito del governo italiano, come, d’altra parte, di tutti i Paesi dell’Europa occidentale. E
proprio con l’intento di sostenere al meglio il rilancio dei sistemi economici, nel 1951, 6 Paesi europei –
tra questi l’Italia – diedero vita alla CECA: Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio.
Dal punto di vista elettorale, tuttavia, c’è da considerare che la Democrazia Cristiana – maggioranza
assoluta in Parlamento, con le elezioni del 1948 – è andata progressivamente perdendo consensi, a
vantaggio del Partito Comunista e della sinistra in generale.
GLI ANNI DELLA REPUBBLICA: gli anni ‘60
Gli anni ’50 e ’60 sono ricordati come gli anni del boom economico: il periodo nel quale, in Italia, ma
non solo, si assiste ad uno sviluppo economico fortissimo, dovuto alle esigenze di ricostruzione poste dalle
conseguenze della seconda guerra mondiale ed ai finanziamenti pervenuti a questo scopo dagli Stati Uniti
d’America (il cosiddetto Piano Marshall).
Si trattò di una fase di fortissima espansione, trainata soprattutto dall’industria del nord e, più nello
specifico, dalla FIAT di Torino. In funzione di quest’ultima e del suo consolidamento, si dotò l’Italia delle
infrastrutture necessarie all’incremento del traffico veicolare privato: strade e autostrade, trascurando, di
converso, lo sviluppo dei trasporti pubblici che, altrimenti, avrebbero finito per fare concorrenza a quello
provato automobilistico e, dunque, alla FIAT.
Lo sviluppo industriale del nord, con il corrispondente ritardo di sviluppo del sud (rimasto agricolo e
povero), spinse masse enormi di popolazione meridionale ad emigrare verso il triangolo industriale, in cerca
di lavoro e di un reddito sufficiente ad assicurare alle famiglie una vita dignitosa. La grande disponibilità di
manodopera (in buona parte ex contadini meridionali) per le industrie del nord, fece sì ce i livelli salariali
restassero assai bassi, seppure in ascesa nel corso del tempo.
E, dunque, emigrazione e bassi salari si rivelarono le architravi dello sviluppo economico italiano degli
anni ‘50 e ’60. Una condizione che, ovviamente, gli operai non potevano considerare soddisfacente: che
cercavano di migliorare, attraverso le lotte sindacali e politiche.
Il problema di quelle grandi masse di popolazione che producevano il benessere di un Paese – l’Italia
– sempre più ricco, rimanendo esse, tuttavia, in condizioni di indigenza; e di una popolazione meridionale
sempre più povera rispetto a quella settentrionale, richiamò anche l’attenzione della Chiesa cattolica.
Nel 1958, viene eletto papa Angelo Roncalli, con il nome di Giovanni XXIII. Nel 1962 papa
Giovanni XXIII convoca il Concilio Vaticano II.
L’elezione del nuovo papa, così come l’orientamento emerso dal Concilio Vaticano II, spingono la
Chiesa ad una presenza e ad un’azione più netta e determinata sul terreno della difesa dei diritti dei più
poveri, dei più deboli, degli sfruttati e degli oppressi: con ciò riprendendo le tematiche che erano state
proprie della dottrina sociale della Chiesa fin dalla fine dell’800.
48
In questo modo, la Chiesa cattolica finiva per prendere una posizione politica che, di fatto, la
collocava a fianco di chi, dalla parte degli sfruttati, dei poveri, aveva sempre combattuto: a fianco, cioè, dei
socialisti e dei comunisti; a fianco della sinistra politica.
Questa nuova disposizione della Chiesa, più sensibile alle tematiche sociali di quanto non fosse in
precedenza, ebbe immediati riflessi politici. Nel 1962, la Democrazia Cristiana dà vita ad un nuovo
governo all’interno del quale non sono più presenti i liberali, ma i socialisti: un governo di
coalizione formato da DC, PRI, PSDI e PSI. Nasce, così, il primo governo di centro-sinistra.
I governi di centro-sinistra, che hanno caratterizzato tutti gli anni ’60, fino ai primi anni ’70, hanno
cercato di porre in attuazione la Costituzione, soprattutto nelle norme della stessa relative all’economia.
Così, uno dei primi provvedimenti fu la costituzione dell’ENEL, in applicazione dell’art.43 Cost. che
prevede la possibilità per lo Stato di riservare a se stesso la produzione di servizi fondamentali per la
collettività, anche attraverso l’espropriazione di imprese private: così, infatti, fu nel caso dell’ENEL.
Insieme all’ENEL, si costituirono, in quegli anni, altri due enti pubblici economici: precisamente due
holding pubbliche – l’ENI e l’EFIM – che andarono ad affiancare la già esistente IRI (si ricorderà, costituita
nel ’33), con lo scopo di investire – tramite aziende pubbliche – nel meridione d’Italia, così da ridurre il
gap nei livelli di sviluppo tra nord e sud del Paese. Il sistema che vedeva a capo – come holding in mano
pubblica – l’IRI, l’ENI e l’EFIM ed il grandissimo numero di imprese che, nell’insieme, esse finirono per
gestire, si definì sistema delle partecipazioni statali: un sistema che ha avuto una rilevanza enorme
nell’economia italiana.
Un ulteriore provvedimento di grande portata riguardò la riforma della scuola media – la cosiddetta
scuola media unica – che eliminò quell’impianto fascista che prevedeva di distinguere i bambini,
immediatamente dopo le elementari, tra coloro che erano destinati agli studi classici – e, dunque, a far
parte della classe dirigente – per i quali era prevista, appunto, la scuola media; e coloro che erano destinati
alle attività manuali, operaie, per i quali era previsto l’avviamento professionale.
La riforma eliminò questa dicotomia ed istituì una scuola media unica, appunto: cioè tre anni di
studio uguali per tutti, dopo il quinquennio delle elementari.
Nel complesso, lo Stato governato dal centro-sinistra intervenne maggiormente nel sistema
economico, cercando di ridurre le distanze tra le parti agiate della popolazione e quelle meno benestanti:
assumendo su di sé, in qualche misura, una funzione di più accentuata redistribuzione del reddito.
Si giunge, in questo modo, al 1968: fra lotte dei lavoratori per migliorare le proprie condizioni di vita
e tentativi del governo di conciliare i meccanismi propri del sistema capitalistico con migliori livelli di
welfare.
Il 1968 è una data importante nell’evoluzione delle società capitalistiche occidentali: tutte le società
capitalistiche occidentali; anche, non solo quella italiana.
E’ rimasto nella storia come l’anno della rivolta studentesca. Dagli Stati Uniti, in particolare
dall’Università di Berkeley parte un movimento di rivolta giovanile radicale, mirato a mettere
profondamente in discussione tutte le strutture fondamentali della società dell’epoca: dalla
scuola, all’università, alla famiglia, alla cultura dominante, alla sessualità, al rapporto uomodonna.
Un movimento che, da un punto di vista sociale, di classe, non poteva certo definirsi proletario:
non erano certo i proletari a frequentare le università! … ancor meno, le università americane tipo
49
Berkeley! Piuttosto, si trattava di un movimento nato all’interno stesso delle classi dominanti: tra i nuovi
rampolli della borghesia capitalistica ed, in generale, dei ceti agiati dell’occidente.
Anche per questo, quel movimento non poteva nemmeno definirsi comunista! Piuttosto, portatore
di una cultura libertaria, anarchica… come si vedrà, fondamentalmente antiautoritaria. In questo senso,
anzi, spesso (non sempre) in contrasto – anche aspro – con le tradizionali organizzazioni della sinistra
politica, più abituate a forme di lotta ed a logiche di pensiero strutturatesi nel tempo, nel corso di lunghi
anni di battaglie.
Un movimento con una chiara impronta generazionale; una rivolta dei giovani, prima di tutto: dei
giovani studenti.
Di qui, è facile comprendere, i bersagli principali – non gli unici – della rivolta: i vecchi e la scuola.
Una scuola pensata e strutturata per tramandare un sapere funzionale ad un sistema sociale ormai
obsoleto e, comunque, diventato, agli occhi dei giovani, inaccettabile. Una scuola organizzata
gerarchicamente per produrre conformismo, per distruggere ogni forma di pensiero critico: una scuola
repressiva di ogni tentativo di innovazione e di originalità; destinata a riprodurre una società ingiusta,
iniqua, mortifera. Ed i depositari del potere disciplinare all’interno delle scuole e delle università, i
funzionari passivi ed opportunisti di tale sistema sociale risultano essere i presidi, i rettori, i professori.
Costoro, di fatto, devono essere considerati nemici del movimento: per la loro funzione lavorativa
(sociale) e, spesso, anche per la loro cultura politica conservatrice o troppo moderata.
Una scuola del conformismo e della conservazione che, per sua scelta, si affianca alla famiglia, nella
sua funzione repressiva di ogni tentativo di liberazione.
Una famiglia patriarcale, nella quale ad esercitare il potere sono i vecchi, i padri. Questi, nella loro
pretesa di disciplinamento verso i figli, affiancano, di fatto, le scuole e le università. Il movimento del ’68
freudianamente uccide i padri: nel senso che sottopone a critica radicale la cultura delle vecchie
generazioni, rivelandone il carattere conservatore dell’assetto sociale esistente.
Nella critica alla famiglia, alla scuola ed all’università, il movimento del ’68 scopre la sua
vera natura politica: quella di un movimento fondamentalmente antiautoritario, volto alla
critica radicale delle autorità sedimentatesi nel tempo: quelle dei padri, dei presidi e dei rettori,
dei professori. Tutte figure, queste, viste come sinergiche nella strategia della repressione
sociale.
E, tuttavia, dal movimento del ’68 scaturisce anche una nuova figura sociale, che negli anni
successivi avrà un ruolo determinante nel rinnovamento profondo della cultura politica dell’occidente –
Italia compresa – ed anche, specificamente, della nostra cultura politica. Si tratta delle donne e di quel
particolare movimento – interno ed in rapporto dialettico col movimento del ’68 – al quale le
donne diedero vita: il movimento femminista.
Importantissimo il discorso aperto dalle donne del movimento femminista: inteso a porre
in rilievo come – spesso, troppo spesso – persino i maschi leader del movimento, così tanto
impegnati nella critica radicale ad ogni forma di autoritarismo, fossero poi particolarmente
accondiscendenti rispetto alle connotazioni autoritarie, maschiliste del rapporto uomo-donna
strutturatosi nel corso di secoli. Che, insomma – questo il discorso delle donne - non era
accettabile che, nel momento in cui si metteva in discussione ogni tipo di autoritarismo
consolidato nel tempo, non si facesse altrettanto con l’autoritarismo maschile nel rapporto tra i
50
generi (e che, addirittura, quel modello di rapporto venisse praticato persino dai leader del
movimento).
Di qui, da questo discorso, hanno nuovo inizio le lotte per l’emancipazione femminile – per
la parità uomo-donna – e, con maggiore radicalità, il movimento di liberazione della donna.
E la minigonna assume il valore simbolico di un oggetto di liberazione. Per la prima volta le
donne – da sempre considerate carne a disposizione del maschio (del marito, del compagno, del
fidanzato…) – decidono di gestire il proprio corpo in autonomia: senza dover rendere conto delle
proprie scelte ai propri partner. E, così facendo, pongono al centro dell’attenzione e del dibattito
anche il problema della propria soggettività sessuale: non più corpi passivamente a disposizione,
ma soggetti sessuali dotati di una propria volontà, di propri diritti, di una propria autonomia
perfettamente equiparabile a quella dei maschi.
Anzi, nella necessità, pur esistente, di indicare una via di radicale rinnovamento della
società, il sesso – la libertà sessuale – viene ad assumere un ruolo centrale: simbolo e strumento
di liberazione; leva simbolicamente pregnante di contrasto alla repressione culturale e sociale.
Il sesso, e tutto quanto come il sesso, consente di giungere ad una dimensione altra
rispetto all’esistente: tutto ciò che forza i limiti della realtà, che allude a possibilità non già
sperimentate… Dunque, sì: sesso, ma anche musica ed anche l’uso sociale delle sostanze
stupefacenti (della cannabis, degli allucinogeni).
Insomma, una vera e propria rivolta politica ma, prima di tutto, culturale.
Una rivolta che, partita dagli Stati Uniti, si diffonde in tutti i Paesi dell’Europa occidentale: dalla
Francia (in cui il movimento ebbe un enorme rilievo), alla Germania, ai Paesi del nord Europa… fino a
sfiorare i Paesi dell’est europeo (si ricorderà la Cecoslovacchia ed il tentativo innovatore di Alexander
Dubceck); e, ovviamente, all’Italia.
Qui, in Italia, il movimento del ’68 ebbe più nette connotazioni politiche: un po’ per la tradizione
politica italiana, più marcata e conflittuale rispetto a quella degli altri Paesi; un po’ – forse, soprattutto –
per il fatto che il movimento del ’68 confluì – l’anno seguente, il ’69 – con l’autunno caldo dei lavoratori.
Il ’69 fu un anno di grandi lotte dei lavoratori, qui, in Italia: scadevano un gran numero di contratti
nazionali di lavoro e, come sempre, in questi casi, i lavoratori scendevano in lotta per il rinnovo dei contratti
alle migliori condizioni possibili.
Non poteva non esserci convergenza tra lavoratori e studenti! Ed, infatti, come gli studenti lottavano
contro ogni precostituita autorità, così anche i lavoratori, in fondo, lottavano contro l’autoritarismo
dell’imprenditore in fabbrica e la struttura gerarchica del suo potere. Non avrebbe avuto senso sottoporre
a critica la scuola, l’università, la famiglia e non la fabbrica: perno centrale, quest’ultima, del funzionamento
e della struttura dell’intera società e, dunque, anche della famiglia, della scuola e dell’università.
Si crea, così, tra il 1968 ed il 1969, un ampio movimento di lotta – un movimento operai-studenti –
che opera congiuntamente, cercando di innovare ogni ambito della vita collettiva: contro il sistema, con
una visione di sistema. Il movimento è tanto ampio e tanto determinato, tanto culturalmente assennato e
radicale, tanto forte ed originale che in tanti cominciano a temerlo. Tra questi, anche le organizzazioni
tradizionali della sinistra: il PCI ed i sindacati, in particolare, visti come una forza culturalmente arretrata e
non in grado di comprendere le nuove tematiche poste dal movimento.
51
Proprio in rapporto dialettico – a volte, polemico – con queste organizzazioni, si creano e crescono,
alla sinistra del PCI, nuove realtà politiche e nuovi giornali: quella galassia di associazioni che è stata
definita in vari modi… nuova sinistra … sinistra extraparlamentare … sinistra radicale … Nel complesso,
una forza elettorale consistente, forte e determinata.
Il quadro politico nazionale, sempre più spostato a sinistra, mise in allarme le forze – spesso occulte –
della destra conservatrice e reazionaria.
Il 12 dicembre 1969 scoppia una bomba alla Banca Nazionale dell’Agricoltura, a Milano: il
bilancio è di 17 morti e 88 feriti. E’ l’inizio di quella che, nella storia italiana, è rimasta
tristemente nota come strategia della tensione.
Per strategia della tensione si indica un progetto – ordito e realizzato da ambienti della
destra eversiva e neo-fascista, in combutta con rami deviati dei servizi segreti – volto a far
crescere la tensione sociale, i pericoli insiti nello scontro sociale, così da costringere le forze
politiche – il Parlamento e, soprattutto, il governo – ad adottare misure repressive
dell’antagonismo operaio; determinare nella società una svolta culturale antidemocratica;
costringere PCI e sindacati a ridurre la spinta antagonista.
Insomma, con la strategia della tensione, in sostanza, si voleva ridimensionare la spinta progressiva
del movimento operaio e della sinistra, e ciò costringendo sindacati e PCI a ridurre il grado e l’intensità
dell’opposizione sociale e politica; costringendoli ad accettare leggi limitative del diritto di sciopero e di
manifestazione; e convincendo la popolazione che, insomma, andare in piazza a protestare fosse pericoloso
che, dunque, tanto valeva restarsene a casa ed evitare di partecipare.
La strategia della tensione si realizzò con una serie impressionante di bombe che scoppiarono nel
corso di un lungo periodo di tempo, in vari luoghi e senza che ne fossero chiari i mandanti. Di questa serie,
la bomba alla Banca Nazionale dell’Agricoltura a Milano, il 12 dicembre 1969, fu la prima. Ad essa
seguirono:
22 luglio 1970: strage di Gioia Tauro;
31 maggio 1972: strage di Peteano;
17 maggio 1973: strage alla questura di Milano;
28 maggio 1974: strage a Piazza della Loggia a Brescia;
4 agosto 1974: strage del treno Italicus;
2 agosto 1980: strage alla stazione di Bologna;
23 dicembre 1984: strage di San Benedetto val di Sambro.
Quelli su riportati sono solo i fatti più eclatanti: non tutti quelli che hanno tragicamente punteggiato
gli anni della strategia della tensione. Si calcola che solo nel periodo 1969-1975 ci furono 4584 attentati,
riconducibili alla destra neofascista, con 113 morti e 351 feriti.
Ovviamente, in seguito ad ogni strage partono le indagini giudiziarie. L’intento, politicamente
orientato, è quello di far ricadere la responsabilità delle bombe sulla sinistra antagonista. In questo senso,
per esempio, va l’indagine sulla bomba alla Banca Nazionale dell’Agricoltura a Milano, nell’ambito della
quale viene immediatamente arrestato Pietro Valpreda, un anarchico milanese, indicato dai giudici e dai
mezzi di informazione come il mostro di Milano. Pietro Valpreda è incarcerato prima ancora del processo
ed è costretto a subire 4 anni di carcerazione preventiva, al termine dei quali viene scarcerato, del tutto
52
scagionato da ogni accusa e l’indagine inverte la propria direzione e si orienta verso gli ambienti neofascisti
e dei servizi segreti.
Di molte di queste stragi non sono ancora – a distanza di decenni – stati accertati definitivamente gli
autori ed i mandanti. Però, alcune condanne definitive vi sono state ed alcune cose sono state, ormai,
definitivamente accertate: che le bombe provenissero dagli ambienti neofascisti e dei servizi segreti, di cui
si è detto; che molti alti vertici delle forze dell’ordine (carabinieri, polizia, guardia di finanza) operarono non
perché si scoprisse la verità sulle stragi ma, al contrario, per inquinare le prove e convogliare le indagini su
ipotesi investigative infondate.
Per effetto della strategia della tensione si diffuse nella società una sempre più ampia ed intensa
voglia di sicurezza, di rassicurazione: si alzò la richiesta di ritorno all’ordine, alla pace sociale.
Le forze politiche della sinistra tradizionale risposero riducendo l’ampiezza e l’intensità
dell’opposizione sociale e politica. I sindacati elaborarono l’idea delle “compatibilità”: l’idea, cioè, che le
rivendicazioni operaie dovessero stare entro le compatibilità del sistema capitalistico, senza muoversi nella
prospettiva di un cambio di sistema; il PCI finì, addirittura, per astenersi in Parlamento sulla fiducia ai
governi ancora guidati dalla Democrazia Cristiana e poi a fornire il suo voto favorevole agli stessi (furono i
cosiddetti governi di solidarietà nazionale).
Nell’ambito della nuova sinistra, l’avvio della strategia della tensione comportò l’approfondimento di
un’analisi che immediatamente rese consapevoli dell’origine politica di quelle bombe: il quotidiano Lotta
Continua, proprio nei giorni in cui Valpreda veniva indicato come il mostro, usciva con il titolo La strage è di
Stato, a dimostrazione di una grande capacità di analisi e di intuizione politica.
Tuttavia, una parte di quel movimento, elaborò l’idea che non fosse ormai più possibile alimentare le
lotte con gli ordinari strumenti, pacifici, della tradizione operaia: che fosse necessario difendere il
movimento di lotta con gli stessi strumenti della violenza neofascista. Nacquero, così, le formazioni
terroristiche, la più rilevante delle quali furono le Brigate Rosse.
Queste risposero alla violenza neofascista con una serie lunghissima di attentati contro coloro che
venivano individuati come i simboli del potere: contro dirigenti d’azienda, contro politici (il più clamoroso: il
rapimento e l’uccisione di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana), contro magistrati, contro
professori universitari ed intellettuali collaterali al governo; persino contro sindacalisti (si veda l’uccisione di
Guido Rossa, operaio e sindacalista della CGIL a Genova).
In questo clima drammatico di si entra e poi, soprattutto, ci si inoltra, negli anni ’70.
GLI ANNI DELLA REPUBBLICA: GLI ANNI ‘70
Sappiamo già quale fu l’esito: la drastica riduzione della capacità di lotta e di conquista del
movimento operaio; ma gli inizi furono esaltanti.
La grande capacità della sinistra di mettere in campo analisi culturali e politiche originali e strategie di
lotta, consentì, in un primo momento – per alcuni anni – di raggiungere risultati insperati fino a qualche
tempo prima.
L’anno 1970 fu un anno particolarmente significativo da questo punto di vista: per il numero e la
rilevanza delle conquiste sociali e politiche che, proprio in quei dodici mesi, si realizzarono.
In quel solo anno si riuscì a:
53
approvare la legge di attuazione del referendum abrogrativo, in applicazione dell’art.
75 Cost., e così da poter, finalmente, utilizzare uno dei pochi strumenti di democrazia
diretta previsti dalla Costituzione italiana;
approvare la legge 300, il cosiddetto Statuto dei Lavoratori, che, finalmente,
introduceva anche nelle fabbriche i principi di libertà e di partecipazione democratica
interni alla Costituzione italiana;
approvare la legge sul divorzio (contro il parere della Chiesa cattolica), importantissima
per l’attuazione dei principi di laicità dello Stato contenuti nella Costituzione;
tenere le prime elezioni per i Consigli Regionali, essenziali per avviare quel processo di
decentramento dei poteri che la Costituzione prevedeva.
Come si vede, in un solo anno, così tante conquiste, e così importanti, che non si erano viste in tale
misura in molti e molti anni precedenti. Frutto delle lotte del ’68, del movimento operai-studenti di quegli
anni, del suo grande livello di consapevolezza e di capacità di organizzazione.
Un periodo di lotte che iniziò negli anni ’60, che ebbe il suo culmine alla fine di quel decennio, ma che
si protrasse lungo buona parte degli anni ’70 riuscendo a produrre ulteriori, grandi conquiste giuridiche e di
civiltà.
Per esempio, la riforma del sistema tributario del 1973, in applicazione dell’art. 53 Cost. e del
principio di progressività in esso contenuto; i decreti delegati della scuola del 1974, che per la prima volta
introdussero il diritto di assemblea degli studenti ed il loro diritto a partecipare alle decisioni degli organi
collegiali; la riforma del diritto di famiglia del 1975, con il riconoscimento della parità giuridica uomodonna nel rapporto coniugale ed all’interno della famiglia nel rapporto tra genitori e figli. E poi, ancora,
negli anni successivi, la riforma sanitaria che ha garantito a tutti un eguale diritto alla salute, così come
previsto dalla Costituzione e la legge Basaglia sulla chiusura dei manicomi, così che la malattia mentale
fosse riconosciuta, appunto, malattia e non invece stigma sociale e ragione di emarginazione per chi ne
fosse vittima.
E’ da ricordare, inoltre, importantissimo, il 1974, anno in cui, per la prima volta si tenne in Italia un
referendum abrogativo (grazie alla legge approvata 4 anni prima). Fu quello voluto dalla DC e dalla Chiesa
cattolica contro la legge sul divorzio. Referendum che gli stessi promotori persero: cosa fondamentale per
comprendere quanto il movimento del ’68-69 incise non solo sotto il profilo politico e giuridico nella storia
di quegli anni, ma anche sotto il profilo culturale, cambiando opinioni precedentemente assai diffuse,
costumi e pratiche precedentemente molto condizionate dalla presenza in Italia del Vaticano. Il referendum
del ’74, con la sconfitta della DC e della Chiesa, disse che l’Italia si era, ormai, laicizzata.
Come si vede, gli anni ’70 furono anni di grandi lotte e di altrettanto grandi conquiste: un periodo
così fecondo nella crescita civile della società e nell’evoluzione democratica dell’ordinamento giuridico, da
non trovare riscontri in alcun altro periodo della nostra storia.
E, tuttavia, l’abbiamo detto, nel corso degli anni – prese nella tenaglia delle stragi di Stato e del
terrorismo brigatista – l’intensità e la capacità di innovazione politica della lotta venne affievolendosi, fino
quasi a sparire del tutto: per le ragioni che abbiamo indicato, e per il particolare contesto internazionale in
cui gli anni ’70 si aprono. Ci riferiamo, nello specifico, a quanto accaduto nel 1973 in Cile. Lì, il governo
socialista democraticamente eletto di Salvador Allende, venne rovesciato attraverso un colpo di Stato
ordito dalla CIA (l’agenzia di spionaggio del governo degli Stati Uniti). Al posto del legittimo governo di
Allende fu posto un governo fascista con a capo il generale Augusto Pinochet. Salvador Allende morì,
54
imbracciando un mitra, rinchiuso nel palazzo della Moneda, sede della presidenza della Repubblica, per
contrastare l’arrivo dei militari che erano lì giunti per arrestarlo.
Il colpo di Stato in Cile, contro un governo democraticamente eletto e di sinistra moderata (insomma,
non un governo comunista), suscitò grande scalpore in occidente ed, in particolare, in Italia. Il segretario del
Partito Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, ne dedusse che, in un Paese sottoposto del blocco
occidentale, sottoposto al dominio degli Stati Uniti – come era, appunto, il Cile, ma come anche era l’Italia –
non sarebbe mai stato possibile realizzare un governo di cambiamento senza l’accordo degli USA; e che,
dunque, se il PCI voleva andare al governo – dopo decenni di opposizione – non poteva che farlo in accordo
con il partito che, in Italia, faceva da garante degli Stati Uniti: in accordo con la Democrazia Cristiana. Di qui,
la strategia del compromesso storico: l’idea, cioè, di un grande accordo tra socialisti, comunisti e cattolici
che, sull’esempio della lotta di Resistenza, riuscissero a sconfiggere il terrorismo, far cessare le bombe
ed apportare i necessari cambiamenti nella legislazione e nell’economia italiana, soprattutto a tutela
delle fasce di popolazione più povera.
Nell’ottica del compromesso storico e nella speranza di rispondere alla sempre più pressante
richiesta collettiva di ritorno all’ordine ed alla sociale, la sinistra tradizionale – PCI e sindacati – rinunciarono
all’idea di cambiamenti profondi, strutturali del sistema economico, e si acconciarono a rivendicazioni di
ridotto significato politico, tutte interne alle compatibilità del sistema.
E, dunque, se gli anni ’70 iniziarono con l’entusiasmo dei grandi cambiamenti in corso o attesi,
finirono, invece, con la consapevolezza della fine imminente di una fase di grandi speranze e di un riflusso
verso arretrate posizioni politiche, culturali, civili.
Simbolo del riflusso politico e civile in corso, fu il governo di Margaret Thatcher, in Inghilterra.
Thatcher governò l’Inghilterra dal 1979 al 1990, aprendo una guerra senza esclusione di colpi contro i
sindacati dei lavoratori, e riuscendo, in definitiva a sconfiggerli pesantemente: da quella sconfitta storica, i
sindacati inglesi, precedentemente fortissimi, non sono ancora riusciti a riprendersi del tutto. I governi
Thatcher operarono per un drastico ritorno alle politiche liberiste (questo ritorno venne definito
neoliberismo), con una conseguente estesissima privatizzazione di beni precedentemente in mano pubblica
e con l’eliminazione di buona parte delle norme che, fino ad allora, regolavano l’attività economica privata
(la cosiddetta deregulation).
GLI ANNI DELLA REPUBBLICA: GLI ANNI ‘80
Gli anni ’80 si aprono, dunque, su questo scenario: una fortissima ondata di riflusso su posizioni
moderate ed apertamente di destra … il Cile, da una parte; Margaret Thatcher, in Inghilterra; compromesso
storico, governi di solidarietà nazionale … ma anche ristrutturazione della FIAT, con il licenziamento di
decine di migliaia di lavoratori, in Italia.
Un’ondata neoliberista radicale e generalizzata: una guerra aperta dei ricchi contro i poveri, per il
ripristino integrale dei loro privilegi intaccati dalla forza delle lotte operaie e per il ritorno ad un rapporto di
classe fondato sulla mera subordinazione dei lavoratori rispetto agli imprenditori.
Un’onda lunga – nella quale ancora oggi stiamo e della quale ancora oggi paghiamo le conseguenze che non poteva non avere gli Stati Uniti come soggetto protagonista. Ed infatti, nel 1981, viene eletto
presidente della Repubblica Ronald Reagan. Questi riuscirà a tenere quella carica fino al 1989: per due
mandati consecutivi.
55
Reagan era un così convinto assertore delle dottrine economiche neoliberiste che, queste ultime,
spesso, sono state definite reaganomics cioè, insomma, le dottrine di politica economica del governo
Reagan.
In Italia, la ventata neoliberista fu interpretata da un socialista – Bettino Craxi – che guidò i governi
dal 1983 al 1989: non ci si meravigli del fatto che un socialista sia stato portabandiera di politiche
economiche di destra! Questo, purtroppo, è capitato spesso nella storia, tanto da poter legittimare lo
slogan che “le politiche di destra le fanno meglio quelli di sinistra”. Ed, infatti, Craxi riuscì a sferrare colpi
durissimi ai sindacati dei lavoratori, togliendo la scala mobile (che garantiva automaticamente
l’adeguamento dei salari e delle pensioni al costo della vita, limitando drasticamente l’esercizio del diritto di
sciopero, mettendo in discussione lo Statuto dei lavoratori … e le conseguenze ultime le abbiamo avute in
questi anni, con l’eliminazione dell’art. 18).
Tanto sono stati progressivi gli anni ’70, quanto regressivo il decennio ’80.
Ciò malgrado – malgrado la drastica riduzione dell’intervento pubblico in economia e la
semplificazione, sotto ogni profilo, dell’iniziativa economica privata – gli anni ’80 sono stati, in Italia, gli anni
dell’esplosione del debito pubblico: gli anni in cui il debito pubblico ha superato il 100% del PIL, diventando
praticamente ingestibile.
Come mai, visti i tagli alle pensioni ed ai salari… visti i ticket sanitari… visto il blocco del turn over
negli enti pubblici… la dismissione dei beni e delle imprese pubbliche… come mai, malgrado tutto questo, il
debito pubblico aumenta?
E’ su questa domanda che finisce il decennio ’80 e si aprono gli anni ’90.
GLI ANNI DELLA REPUBBLICA: GLI ANNI ‘90
Il 17 febbraio 1992 venne arrestato a Milano Mario Chiesa, un dirigente del Partito Socialista di
quella città. Venne arrestato in flagranza di reato, nel momento in cui, in qualità di presidente di una
casa di riposo, il Pio Albergo Trivulzio, intascava una tangente da un imprenditore.
A seguito dell’arresto di Mario Chiesa, la procura di Milano, guidata da Francesco Saverio Borrelli –
un anziano magistrato di cultura liberale – avviò le indagini per scoprire i vari aspetti della vicenda e per
accertare se vi fossero altri casi di corruzione simili a quello che aveva coinvolto Mario Chiesa.
Il pool di magistrati che si occupò delle indagini, sotto la guida di Borrelli, comprendeva gente come
Antonio Di Pietro, Piercamillo Davigo, Francesco Greco … insomma, non proprio un gruppo di comunisti!,
piuttosto un gruppo di bravi magistrati, politicamente eterogeneo (ma piuttosto su posizioni di destra
liberale). Il filone di indagini che venne avviato fu denominato mani pulite e, di qui, la denominazione del
pool: pool di mani pulite.
Le indagini di mani pulite portarono a scoprire un sistema corruttivo che aveva coinvolto, ormai, tutti
i partiti che avevano governato lo Stato, le Regioni e le città in Italia: un sistema così diffuso e così ormai
usuale, che per ogni appalto affidato da un ente pubblico ad un’impresa privata era previsto un tabellario
che stabiliva, a seconda del valore economico dell’appalto, la percentuale che l’imprenditore avrebbe
dovuto pagare al partito (o ai partiti al governo dell’ente), al singolo (o ai singoli) personaggi politici che si
erano occupati dell’affidamento dell’appalto. Denaro – un’enorme quantità di denaro – che i corrotti
utilizzavano per finanziare l’attività del proprio partito (finanziamento illecito ai partiti) o per
arricchimento personale (corruzione o concussione).
56
Un’enorme quantità di denaro intascato illecitamente da soggetti privati (dirigenti politici e partiti
politici) e proveniente dalle casse pubbliche: denaro dei cittadini, versato nelle casse pubbliche attraverso
le imposte. Infatti, gli imprenditori che si dichiaravano disponibili a pagare le tangenti ai politici,
pretendevano, tuttavia, di aumentare il prezzo dell’appalto, così che, in definitiva, pur pagando la tangente,
il proprio margine di guadagno sarebbe rimasto inalterato. E, dunque, qualunque opera pubblica, in Italia,
veniva ad avere prezzi enormemente più elevati che negli altri Paesi europei: un chilometro di autostrada o
di ferrovia, un ospedale, una scuola, la gestione delle mense negli asili nido, la manutenzione del sistema
fognario o dell’illuminazione pubblica … tutto costava enormemente di più. Tutto questo sistema venne
denominato tangentopoli: poli, cioè una polis… una città… uno Stato fondato sulle tangenti… Non un fatto
corruttivo singolo, non un ladro, non una truffa … non uno… un intero sistema: l’intero sistema fondato
sulle tangenti…
Dunque, il debito pubblico, giunto a livelli enormi, superiori allo stesso Prodotto Interno Lordo, non
era tanto dovuto al peso delle pensioni, degli stipendi pubblici, della cassa integrazione, delle spese per la
sanità e dell’istruzione, etc., come volevano farci credere. Era, invece, dovuto alle malversazioni nella
gestione della cosa pubblica: all’uso privato ed illecito del denaro pubblico allo scopo di finanziare i partiti o
per arricchimento personale.
L’indagine di mani pulite portò in galera quelli che fino a qualche tempo prima erano stati ai vertici
dello Stato, delle più grandi imprese pubbliche e private, delle Regioni e dei Comuni. Fu una decimazione di
potenti: di un’intera classe dirigente e, con essa, dei partiti che questa classe dirigente aveva diretto. Alcuni
non ressero all’umiliazione del carcere e si suicidarono. Altri, proprio per sfuggire all’arresto, scapparono
all’estero: Craxi, in Tunisia e lì morì. Altri ancora scomparvero dalla vita politica, essendo diventati bersaglio
facile dell’ira dell’opinione pubblica.
I partiti di governo – DC, PSI, PRI, PSDI, PLI – scomparvero improvvisamente dalla scena politica.
Anche il PCI scomparve – come tale – dalla scena politica ma, in questo caso, non per corruzione, ma
per il cambiamento del nome – da PCI a PDS, Partito Democratico della Sinistra – che quel partito decise a
seguito del crollo del muro di Berlino e del modello comunista sovietico.
Ci si è chiesto come mai le indagini di mani pulite abbiano colpito tutti i partiti, tranne che il Partito
Comunista. Si è detto che mani pulite è stato un complotto delle toghe rosse: dei giudici comunisti. Si tratta
di sciocchezze. L’abbiamo detto: il pool di mani pulite era tutto, tranne che comunista! Il PCI è rimasto fuori
dalle conseguenze delle indagini di mani pulite per varie ragioni, ma prima di tutto per una assai semplice:
e, cioè, che non è chi sta all’opposizione che affida gli appalti; dunque, non è chi sta all’opposizione che può
pretendere tangenti in cambio dell’affidamento di appalti. Se il PCI fosse stato al governo, forse avrebbe
fatto le stesse cose che hanno fatto gli altri… ma non sono state queste le circostanze e, dunque, non è
possibile dirlo.
Parallelamente alle indagini di mani pulite, si sviluppa in Italia il dibattito intorno all’anomalia
italiana. Si cerca di comprendere come mai un simile sistema corruttivo sia nato e si sia strutturato proprio
in Italia, solo in Italia, senza nulla di corrispondente negli altri Paesi europei. In questi sì, certo, ci sono stati
e ci sono esempi di politici corrotti, di furti perpetrati ai danni dei cittadini… ma non un sistema, non
un’intera organizzazione finalizzata al furto di denaro pubblico!
Un dibattito importante, perché se si comprendono le ragioni di questa singolarità, forse si riesce a
trovare anche la terapia da mettere in atto affinchè queste cose non accadano più: per normalizzare il
sistema italiano, per renderlo simile a quello degli altri Paesi europei.
Nel dibattito, tutte le forze politiche, pur da punti di vista tecnicamente diversi, tutte le forze
politiche concordano che l’anomalia italiana, ciò che fondamentalmente distingue l’Itala dagli altri Paesi
57
occidentali, sta in questi due elementi: la mancanza di stabilità politica e la mancanza di alternanza al
governo. In Italia, a differenza degli altri Paesi, non c’è stabilità politica, né c’è alternanza di governo.
Non c’è stabilità politica, nel senso che i governi, che dovrebbero per Costituzione durare 5 anni,
durano invece, mediamente, un solo anno: dopo di che, una crisi di governo provvede a far cadere quel
governo ed a richiedere la formazione di uno successivo. E siccome la formazione di un governo necessita
della fiducia del Parlamento – e questa non è detto che venga data: cioè che in Parlamento si formi una
maggioranza che sostenga con la sua fiducia il governo – il rischio – spesso verificatosi nella storia italiana
– è che il Presidente della Repubblica debba sciogliere il Parlamento ed indire elezioni anticipate.
Per effetto dell’instabilità, in Italia si sono succeduti l’uno all’altro infiniti governi … ma, tutti,
pressochè identici: tutti, dal 1948 in poi, retti sostanzialmente sulla Democrazia Cristiana ed i suoi storici
alleati (PRI, PSDI; con la sola variante dell’alternativa tra PSI o PLI o, come negli anni ’70, della
compresenza di entrambi). Un’infinita serie di governi tutti politicamente uguali: sempre la DC al
governo; sempre, all’opposizione, il Partito Comunista. In Italia, fino al 1993, non era mai capitato che la
DC andasse all’opposizione ed il PCI al governo. In Inghilterra, storicamente, un periodo di governi
laburisti segue ad un periodo di governi conservatori, e così di seguito; negli Stati Uniti ad un periodo di
governi repubblicani, seguono, prima o poi, governi democratici; in Francia, ai governi liberali seguono
quelli socialisti; in Germania ai governi socialdemocratici, seguono quelli cristianodemocratici…
Insomma, in tutti i Paesi occidentali vi è alternanza di governo, meno che in Italia.
Questo è il ragionamento che fanno le forze politiche a quell’epoca (non è molto diverso da quello
che, ancora, fanno oggi). Bisogna fare in modo che anche in Italia vi sia, come negli altri Paesi, stabilità ed
alternanza. Anche perché se non vi è alternanza si riduce il livello di controllo sulla gestione del denaro
pubblico: se un partito sa che dopo il suo governo potrebbe giungere il governo degli attuali oppositori, sta
più attento a fare un uso corretto del denaro pubblico, perché, altrimenti, il prossimo governo potrebbe
denunciare all’opinione pubblica ed alla magistratura le malversazioni compiute. E, d’altra parte, se un
governo (ed un Parlamento) non sono stabili – nel senso della durata della legislatura – non possono
nemmeno essere efficienti: i procedimenti legislativi ed amministrativi sono lunghi … e se un governo non
dura almeno una legislatura, non ha nemmeno il tempo di vedere approvati le proprie deliberazioni…
Ecco, questo il ragionamento che si fece a quell’epoca e queste le connessioni tra assetto politico e
gestione del denaro pubblico.
Ma come fare a garantire all’Italia stabilità ed alternanza?
Un’operazione di questo tipo avrebbe richiesto una revisione della Costituzione – qualcuno
proponeva la trasformazione dell’Italia in uno Stato simile agli Stati Uniti o alla Francia; qualcun altro
proponeva l’eliminazione del Senato e la trasformazione del Parlamento italiano in un Parlamento
monocamerale; altri ancora proponeva di rafforzare i poteri del governo… - ma, farlo, non era semplice, né
veloce. Modifiche della Costituzione, infatti, avrebbero richiesto l’approvazione di una legge costituzionale,
visto che la Costituzione italiana è rigida e, dunque, secondo l’art. 138, modificabile solo tramite legge
costituzionale: con tutte le difficoltà del caso (tempi lunghissimi, maggioranze altissime e difficilmente
raggiungibili, probabilità del referendum confermativo…).
La situazione politica degli inizi degli anni ’90 – con la corruzione dilagante resa evidente dalle
indagini di mani pulite, la conseguente fine di un’intera classe politica di governo, il debito pubblico giunto
a livelli assolutamente insostenibili – non consentivano di aspettare i tempi lunghi della riforma
costituzionale. Sotto questo profilo, la discussione continuò, certamente; ma, sul piano operativo, si decise
di procedere all’unica riforma che non richiedesse una modifica costituzionale: la modifica della legge
elettorale.
58
La legge elettorale è la legge che stabilisce il sistema elettorale adottato in un determinato Paese,
per l’elezione di un determinato organo rappresentativo (in questo caso, il Parlamento).
Dalla caduta del fascismo in poi, il sistema elettorale italiano era sempre stato proporzionale, in
contrapposizione, dunque, con la scelta maggioritaria del fascismo nel ’23. Bene, con la riforma
elettorale del 1993 si tornò ad un sistema elettorale maggioritario (sebbene, ovviamente, diverso
rispetto a quello ideato dal regime fascista).
Con questo nuovo sistema elettorale, ci si preparò alle elezioni politiche previste nel 1994.
Il ragionamento alla base della riforma elettorale era questo: con il maggioritario si riduce il numero
dei partiti; fondamentalmente, alle elezioni si presentano due soli partiti: i più grossi, quelli che possono
aspirare a vincere. Dunque, con questo sistema è probabile che un partito riesca ad ottenere la
maggioranza assoluta in Parlamento ed a formare un suo governo: si formeranno, perciò, governi
monocolore (formati da un solo partito). Il partito che non esce vincitore alle elezioni, in Parlamento starà
all’opposizione del governo. Un governo monocolore è più stabile di un governo di coalizione: avremo
raggiunto, perciò, la stabilità politica. Allo stesso tempo, si potrà raggiungere anche l’alternanza di
governo: perché, se le cose vanno male, se il Paese è governato male, non sarà possibile per il partito al
governo scaricare su altri la responsabilità (come, invece, capita nei governi di coalizione). Agli elettori sarà,
perciò, chiaro che, se le cose vanno bene il merito è del partito al governo e, dunque, alle prossime elezioni
gli confermeranno il voto; se le cose vanno male, le colpe sono del partito al governo e, alle prossime
elezioni, voteranno per il partito che è stato all’opposizione. In questo modo, si innescherà un meccanismo
analogo a quello dei Paesi anglosassoni, l’alternanza, appunto: per un periodo governa un partito; poi,
dopo alcuni anni, toccherà governare all’altro partito.
Ma, la logica di questo ragionamento cozza radicalmente con la complessità della società civile e
politica italiana. Non è per il fatto che due sistemi elettorali sono identici (o, come nel caso in questione,
simili), che due società diventano identiche (e nemmeno simili). Dunque, malgrado la riforma elettorale,
l’Italia non diventa un Paese come l’Inghilterra: non si trasforma in un Paese bipartitico come, invece, da
sempre, è l’Inghilterra. L’Italia rimane un Paese multipartitico: come è stata sempre nel corso della propria
storia.
Ed è così che alle elezioni del 1994 si presentano sì, in due… ma non due partiti … ma due poli: due
coalizioni, una di centro-destra (formata da Forza Italia, Lega nord ed Alleanza Nazionale) – denominata
Casa delle libertà; l’altra di centro-sinistra (formata dal PDS, Rifondazione Comunista e Verdi) – denominata
l’Ulivo. Per effetto della legge elettorale, il sistema dei partiti italiano, anzichè diventare bipartitico, è
diventato bipolare.
Qualche parola va spesa sulla composizione delle due coalizioni.
Per quanto riguarda la casa delle libertà, la novità fondamentale è Forza Italia. Un partito creato ex
novo da Silvio Berlusconi, sceso in politica nel 1993, per impedire quella che, all’epoca sembrava dovesse
essere una vittoria scontata dei comunisti (o degli eredi dei comunisti: il PDS). Per costruire questo nuovo
partito, Berlusconi mobilita Publitalia, la società del gruppo Fininvest incaricata di raccogliere la pubblicità
sui canali televisivi del gruppo e, dunque, vera cassaforte del gruppo stesso. Publitalia viene incaricata da
Berlusconi di adoperare tutte le proprie energie per garantire la buona riuscita di un nuovo marchio, questa
volta non commerciale, ma politico: il simbolo del suo nuovo partito e, col simbolo, il partito stesso alle
prossime elezioni politiche. La Lega nord è l’espressione politica di quel movimento secessionista,
vagamente (o propriamente) razzista, che si diffonde e si radica nel settentrione d’Italia negli anni ’80. Ed
Alleanza Nazionale è il partito (precedentemente denominato Movimento Sociale Italiano) che raccoglie
l’eredità dei nostalgici del regime fascista.
59
L’Ulivo, invece, capeggiato da Romano Prodi, sembrava realizzare un antico sogno della sinistra:
quello dell’unità tra le sue tante, distinte anime. Il PDS era nato dalla rinuncia del PCI al riferimento al
comunismo, a seguito della caduta del muro di Berlino nell’89. Rifondazione Comunista, raggruppava,
invece, coloro che mantenevano vive le istanze della rivoluzione sociale e del superamento della società
capitalistica. I Verdi rappresentavano quella parte della sinistra più attenta alle nuove tematiche ecologiste
e della salvaguardia dell’ambiente contro un modello economico iperproduttivista e dissipatorio delle
risorse naturali scarse del pianeta.
Due… sì… ma due coalizioni.
Tra le due, in modo del tutto inaspettato, alle elezioni del 1994 vince la Casa delle libertà e
Presidente del Consiglio diventa Silvio Berlusconi.
Il Governo Berlusconi dura due anni. Dopo due anni, la Lega esce dalla coalizione e va all’opposizione,
accusando Forza Italia e Berlusconi di essere mafiosi ed Alleanza Nazionale di essere fascista. Il Governo,
dunque, perde la maggioranza in Parlamento. Si va a nuove elezioni dopo appena due anni dall’inizio della
legislatura.
Alle elezioni del 1996 si ripresentano le stesse coalizioni: il Polo delle Libertà (ex Casa delle Libertà) e
l’Ulivo. Questa volta, a vincere è l’Ulivo: e Prodi diventa Presidente del Consiglio.
Il Governo Prodi dura due anni: sarà Rifondazione Comunista a determinarne le caduta, in dissenso
sulla politica pensionistica del governo. Non si va, però, alle elezioni anticipate, perché, nell’ambito del
centro-sinistra, si riesce a riformare un accordo per sostenere un nuovo governo. Durante quella stessa
legislatura si susseguiranno – dopo il governo Prodi – quello D’Alema e quello Amato.
Si va alle elezioni nel 2001: di nuovo le stesse coalizioni. Vince Berlusconi. Etc. etc. etc. … fino ai giorni
nostri.
Insomma: nel 1994 vince il centro-destra; nel 1996 vince il centro-sinistra; nel 2001 vince il centrodestra; nel 2006 vince il centro-sinistra; nel 2008 vince il centro-destra; nel 2013 vince il centro-sinistra… e
siamo ai giorni nostri. Un merito (se tale è) la riforma elettorale l’ha avuto: quello di aver
affermato l’alternanza al governo.
Ciò che non pare proprio essersi affermato è la stabilità politica. Malgrado la riforma, nessun
governo è riuscito a durare – come dovrebbe – l’intera legislatura ed, anzi, a volte, si è dovuto ricorrere
alle elezioni anticipate.
D’altronde, le indagini della magistratura hanno messo in rilievo come non pare proprio che alle
malversazioni ed alla corruzione nell’uso del denaro pubblico sia stato posto alcun argine. Anzi, al contrario,
quelle indagini hanno spesso rilevato come, per effetto dell’istituzione delle Regioni e del decentramento
amministrativo, i centri di uso illecito del denaro pubblico siano stati moltiplicati: non più soltanto governo,
enti e società dell’amministrazione centrale dello Stato; ma anche gli enti pubblici territoriali, gli enti e le
società alle quali essi partecipano. Una grande festa, ad ogni livello, fatta a spese e col denaro dei cittadini.
Tale è la situazione che, ancora oggi si continua a parlare di riforma elettorale (solo da pochissimo
tempo è stata approvata una nuova legge elettorale che va sotto il nome di Italicum) e siamo in attesa che
venga convocata la data di un referendum costituzionale convocato per confermare una riforma
costituzionale approvata dal Parlamento a strettissima maggioranza ed osteggiata da una vasta parte delle
forze politiche, dell’opinione pubblica, dei magistrati e degli studiosi del diritto.
60
Vedremo come andrà a finire. L’Italia sembra essere condannata a permanere inesorabilmente nel
limbo di trasformazioni sempre annunciate, sempre apparentemente imminenti e mai effettivamente
realizzate.
IL CONTESTO INTERNAZIONALE: L’U.E.
Le vicende politiche e costituzionali italiane avvengono in un contesto internazionale per lungo
tempo segnato dalle vicende della guerra fredda e della corsa agli armamenti: insomma, segnato dal
dominio delle due grandi superpotenze – Stati Uniti ed Unione Sovietica – uscite vincitrici dal secondo
conflitto mondiale.
Un dominio al quale l’Europa ha cercato, in qualche misura, di rispondere per non restarne
schiacciata, soprattutto da un punto di vista economico. E’ proprio in ragione di questa preoccupazione che
si spiega la nascita, nel 1951, della CECA: Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio .
A questa associazione aderirono sei Paesi europei e, tra questi, l’Italia, con l’intento di praticare delle
politiche comuni in specifici settori – quelli, appunto, del carbone e dell’acciaio – all’epoca fondamentali
per la crescita e per il funzionamento dell’intero sistema economico. Si ricordi, infatti, che l’acciaio,
all’epoca, risultava essere la materia prima fondamentale in quasi tutti i settori (in seguito la plastica finì
per prendere il suo posto) ed il carbone risultava essere la fonte di energia principale per la produzione in
generale e per quella dell’acciaio nello specifico.
Attraverso la CECA, dunque, i Paesi aderenti pensavano, coalizzandosi, di poter resistere alla
fortissima concorrenza delle due grandi superpotenze e, per questa via, evitare la dipendenza economica
dalle stesse.
Evidentemente, l’esperimento avviato nel 1951 con la CECA funzionò – o sembrò funzionare –
se, nel 1957, col Trattato di Roma, gli stessi sei Paesi diedero vita alla CEE - Comunità Economica
Europea – con l’intento di allargare la collaborazione economica ed il libero scambio a tutti i
settori economici.
Progressivamente, nel tempo, ai primi sei Paesi aderenti andarono a sommarsi altri Stati: la Comunità
si allargò sul piano territoriale e si allargò anche da un punto di vista politico, dei poteri attribuiti
all’organizzazione comune, piuttosto che ai singoli Stati.
Ed infatti, l’istituzione di un’area di libero scambio in ogni settore – libero scambio delle merci, dei
servizi, del capitale e delle persone – non era immaginabile se non omologando ad una stessa normativa
tutti i settori della vita civile e sociale dei Paesi aderenti. Insomma, se, ad esempio, i prodotti agricoli
dovevano circolare liberamente in tutti i Paesi aderenti, dovunque fossero stati prodotti, be’, allora,
dovevano essere prodotti dappertutto rispettando le stesse regole: ad esempio, evitando, in ogni caso, di
utilizzare determinati pesticidi chimici ritenuti dannosi per la salute… E così anche per i prodotti industriali:
per esempio le automobili, dovunque prodotte, dovevano comunque rispettare determinati standard
comuni di sicurezza e di rispetto dell’ambiente…
Dovevano esserci, dunque, delle normative comuni a regolari le produzioni industriali e quelle
agricole.
Ma un discorso analogo valeva per le persone. La libera circolazione delle persone implicava un
sistema comune di controllo amministrativo sulle stesse che consentisse, per esempio, la cattura di un
determinato soggetto che fosse fuggito da un Paese per rifugiarsi in un altro allo scopo di sfuggire ad una
pena irrogatagli nel Paese di appartenenza. E così per quanto riguarda la circolazione delle persone allo
61
scopo di cercare lavoro. Se un italiano può decidere di andare a fare il commercialista in Germania, allora il
titolo di commercialista in Italia e quello in Germania devono essere equipollenti, cioè, sostanzialmente
equivalenti: e questo implica l’equipollenza dei percorsi di studio per diventare commercialista. Allora
occorre l’omologazione delle normative sulla scuola e sull’università in tutti i Paesi aderenti alla Comunità.
E questo vale per i commercialisti, ma anche per i ragionieri, per gli avvocati, per i medici, etc. etc. etc..
E vale anche per le aziende di servizio: per esempio, per le banche, per le assicurazioni, per gli
alberghi… Se ad un italiano deve essere liberamente consentito di aprire un ristorante in Germania, allora la
normativa relativa all’apertura di queste attività in Italia deve essere simile (o identica) a quella vigente in
Germania, e viceversa.
Insomma, ci si accorse che l’integrazione economica ed il libero scambio richiedevano
un’integrazione più generale delle normative dei Paesi aderenti: da quella fiscale e di bilancio, a quella sulla
salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza alimentare, a quella sulle scuole e sulle università, a quella sul
lavoro, etc.. E che, dunque, la comunità dei Paesi aderenti non potesse più essere una semplicemente una
Comunità Economica, ma che dovesse diventare una Comunità economica e politica.
Nel 1993, col Trattato di Maastricht, la Comunità Economica Europea divenne Unione
Europea (UE), abbandonando, anche nella denominazione, ogni riferimento specifico alla materia
economica.
Il processo di allargamento dell’Unione si è spinto fino al punto che oggi aderiscono alla stessa 27
Paesi europei: 28 fino a qualche mese fa, cioè fino all’uscita dall’Unione della Gran Bretagna.
Per effetto del processo storico che ha portato alla sua nascita e per la sua attuale conformazione
giuridica, possiamo definire l’Unione Europea come un’organizzazione sovranazionale deputata alla
realizzazione del libero scambio delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone, attraverso un
processo generalizzato di integrazione tra tutti i Paesi ad essa aderenti.
Tanto estesa è stato il processo di integrazione che, a partire dal 2001 (e dal 2002 per l’effettiva
circolazione) si è istituita la moneta unica – l’euro – in sostituzione delle monete che precedentemente
circolavano nei singoli Stati. L’insieme dei Paesi che hanno accettato di adottare l’euro come propria
moneta e, per farlo, si sono assoggettati al rispetto di determinati criteri esplicitamente previsti dal
trattato (i cosiddetti parametri di Maastricht) formano quella che si chiama zona euro, o eurozona:
attualmente essa conta 19 Paesi aderenti tra i quali, ovviamente, l’Italia.
Integrare i sistemi economici, industriali ed agricoli, i settori dei servizi, la scuola e l’università, i
sistemi fiscali … significa emanare norme giuridiche valevoli in tutti i Paesi aderenti all’Unione, e ciò
comporta il problema di darsi una struttura democraticamente legittimata a stabilirle quelle norme
giuridiche, secondo procedure determinate precedentemente ed accettate da tutti gli Stati aderenti.
Insomma, l’Unione ha dovuto dotarsi di una struttura organizzativa analoga a quella di uno Stato e
composta da organi legislativi, esecutivi e giurisdizionali. Per questo è bene dire che l’Unione Europea è
un’organizzazione sovranazionale: cioè, un’organizzazione dotata di sovranità, di potere
impositivo.
E come sempre in questi casi, la determinazione degli organi e delle procedure è rimessa
all’emanazione di una Costituzione. Una sorta di (complessa) Costituzione europea è contenuta nel
Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel dicembre del 2009.
Essa prevede che l’Unione Europea funzioni attraverso la seguente struttura, sinteticamente indicata:
62