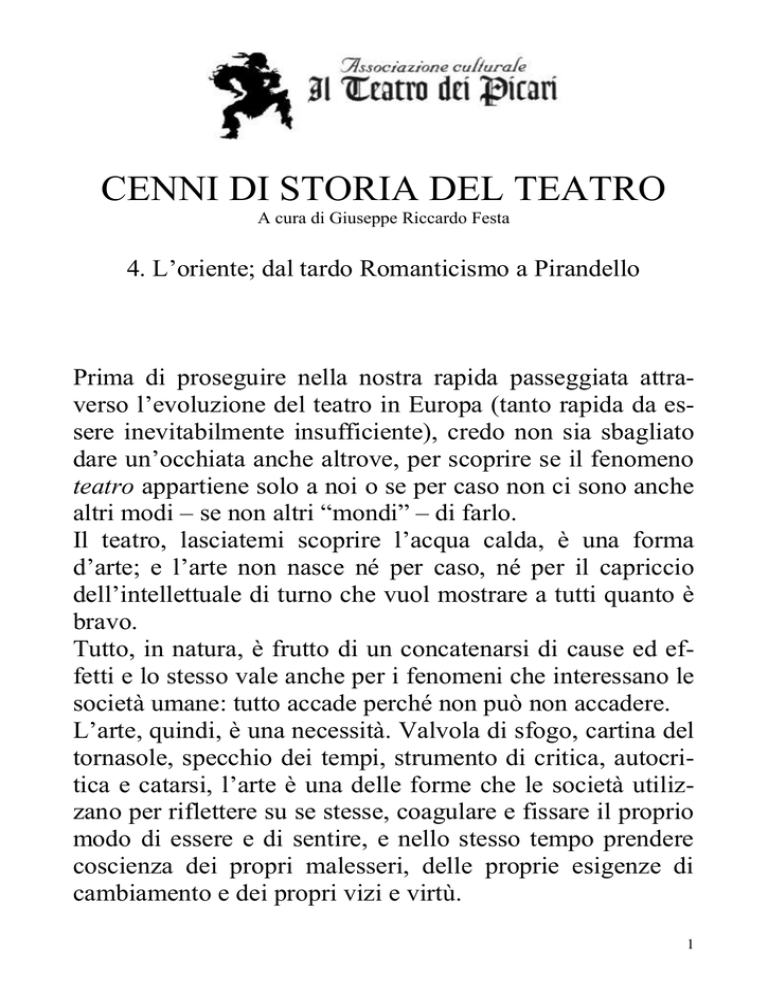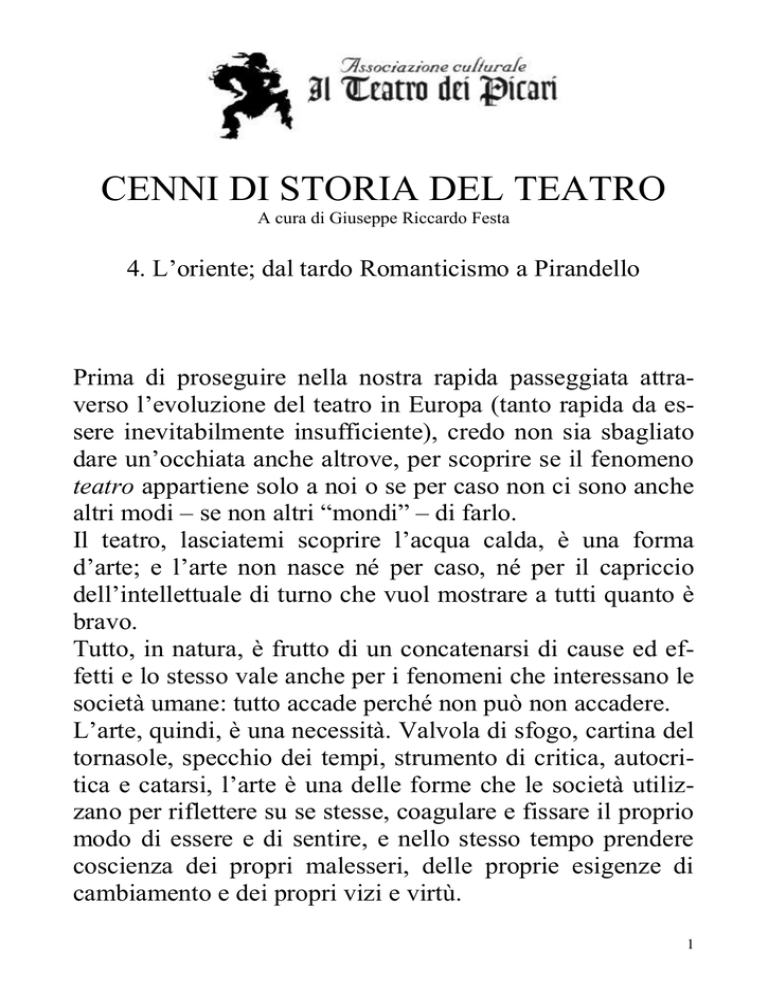
CENNI DI STORIA DEL TEATRO
A cura di Giuseppe Riccardo Festa
4. L’oriente; dal tardo Romanticismo a Pirandello
Prima di proseguire nella nostra rapida passeggiata attraverso l’evoluzione del teatro in Europa (tanto rapida da essere inevitabilmente insufficiente), credo non sia sbagliato
dare un’occhiata anche altrove, per scoprire se il fenomeno
teatro appartiene solo a noi o se per caso non ci sono anche
altri modi – se non altri “mondi” – di farlo.
Il teatro, lasciatemi scoprire l’acqua calda, è una forma
d’arte; e l’arte non nasce né per caso, né per il capriccio
dell’intellettuale di turno che vuol mostrare a tutti quanto è
bravo.
Tutto, in natura, è frutto di un concatenarsi di cause ed effetti e lo stesso vale anche per i fenomeni che interessano le
società umane: tutto accade perché non può non accadere.
L’arte, quindi, è una necessità. Valvola di sfogo, cartina del
tornasole, specchio dei tempi, strumento di critica, autocritica e catarsi, l’arte è una delle forme che le società utilizzano per riflettere su se stesse, coagulare e fissare il proprio
modo di essere e di sentire, e nello stesso tempo prendere
coscienza dei propri malesseri, delle proprie esigenze di
cambiamento e dei propri vizi e virtù.
1
L’arte, di conseguenza, è una forma di comunicazione, la
più alta delle forme di comunicazione. Si serve della parola
ma non solo; e diversamente dalla parola pura e semplice,
non ha finalità immediate e pratiche ma anzi mediate, a volte neanche consce, e perciò spesso ha conseguenze anche
sgradevoli.
In questa definizione così ampia naturalmente il teatro entra
agevolmente, più agevolmente anzi delle altre arti, che tutte
concorrono, in misura più o meno significativa, alla sua realizzazione ed alla sua genesi: la poesia in primo luogo, poi
la narrativa, la musica, e le arti figurative.
Il teatro è un punto d’arrivo: prima che esso nasca, è necessario che la società si strutturi in determinate forme; è un
gioco di società, e della società, dunque, ha bisogno per
esistere.
Si è cominciato a dipingere e scolpire ben prima di creare
società strutturate; e presumibilmente in tempi ancora più
remoti si è cominciato a fare musica.
La narrazione e la composizione poetica vengono dopo, anche se la generazione di miti – magici, religiosi o fantastici
– è anch’essa antichissima; il teatro arriva ultimo.
Per quanto riguarda l’Europa, come abbiamo visto, nasce in
Atene, circa 600 anni prima dell’Era volgare, per poi
spostarsi nella Magna Grecia, contagiare la società Romana
e attraverso questa espandersi in tutta Europa.
Che cosa succedeva nel resto del mondo?
Di molte civiltà non sappiamo nulla, su altre possiamo
congetturare.
In Egitto era difficile che potesse nascere una qualche
forma di teatro, almeno nel senso in cui si è sviluppato nella
cultura greco-romana: una cultura può produrre teatro se è
2
attenta alla vita, ma quella egizia era al contrario attenta alla
morte: gli egizi pensavano più a quel che sarebbero stati
dopo morti che a ciò che erano da vivi.
Abbiamo visto che per lo stesso motivo, grosso modo, il
teatro agonizzò nell’Europa medievale.
Delle civiltà centro e sudamericane precolombiane sappiamo poco e niente, grazie al pio fanatismo di spagnoli e portoghesi, che colonizzarono quei popoli a suon di massacri e
di distruzione sistematica di ogni segno delle loro civiltà:
ciò che non era cristiano, per loro, era diabolico.
Ma il teatro non nasce solo in Europa.
Culture ricche, complesse e articolate al punto giusto nascono anche altrove, presso società che erano anzi ricche,
complesse e articolate quando ancora noi ci vestivamo di
pelli e vivevamo in capanne di paglia.
Per esempio in India, nel VI secolo A.C. la società era evolutissima, tanto da poter produrre un principe come Siddharta che decide di abbandonare agi, famiglia e potere alla
ricerca di una diversa dimensione spirituale; ma le forme di
rappresentazione teatrale indiane si sono orientate verso la
danza, in una forma connotata da un esasperato simbolismo, nella quale le storie, i personaggi e i movimenti sono
fortemente stilizzati.
Vedremo fra poco che la stilizzazione è una cifra ricorrente
nelle forme d’arte teatrale delle culture orientali; nel caso
dell’India, la parte dominante è affidata alle espressioni del
viso ed ai movimenti degli occhi.
Anche la Cina, un’altra delle società tra le più antiche del
mondo, elabora una sua forma di rappresentazione teatrale,
che noi conosciamo sotto il nome di Opera cinese.
3
Il teatro tradizionale cinese assume una sua forma definitiva
attorno al XII secolo. È un genere in cui, più che la parola,
gli elementi centrali sono la musica e, anche qui, la danza..
Gli attori interpretano personaggi dai caratteri fissi ed utilizzano specifiche tecniche del movimento, del gesto e della
voce, e costumi e trucchi caratteristici.
Il testo per lo più è cantato, giocando sul fatto che in cinese
l’intonazione data ad una sillaba ne modifica addirittura il
significato.
A partire dal XVI secolo, sotto la mitica dinastia Ming nasce una nuova forma, il kunqu, che unifica vari stili preesistenti, originari principalmente dalla Cina meridionale. Il
kunqu, raffinato teatro aristocratico, caratterizzato da linguaggio elegante e da lentezza della melodia, della gestualità e dell’azione scenica.
Una società fortemente e rigidamente strutturata e organizzata nasce anche in Giappone, ed anche il Giappone ha le
sue forme di teatro.
Nel XIV secolo nasce il Nō, una forma di teatro che, come
il kunqu cinese, si rivolge ad un pubblico colto e di gusti
raffinati. È caratterizzato dalla lentezza, da una grazia spartana e dall’uso di maschere caratteristiche.
Cosa per noi inconcepibile, i testi del Nō lasciano allo spettatore un ampio margine di libertà interpretativa, in parte
grazie al fatto che il giapponese è ricco di omofoni, parole
di significato diverso che si pronunciano allo stesso modo.
Il teatro Nō evolse, insieme alla farsa Kyōgen, da varie forme d’arte popolari ed aristocratiche ed a sua volta influenzò
altre forme d’arte teatrale, come il Kabuki, che del Nō è una
versione popolare. Il Nō, il Kabuki ed il Kyōgen sono le tre
forme teatrali tradizionali del Giappone.
4
Fu a partire dal XVI secolo che i due generi si diversificarono: il Nō è incentrato su danza e canto ed è basato su testi
scritti, mentre il Kyōgen, partendo da canovacci, è basato
soprattutto su dialoghi e improvvisazione. Inoltre, i personaggi principali di un Nō sono esseri soprannaturali (divinità, spiriti) mentre nel Kyōgen i protagonisti sono gente
comune.
La somiglianza con la situazione europea, dove la Commedia dell’Arte si opponeva al teatro aulico nobiliare, è tutt’altro che casuale. Non nel senso che i commedianti italiani sono arrivati fin là, ma nel senso che analoghe condizioni socio-culturali producono analoghe evoluzioni socioculturali: in biologia si chiamano convergenze evolutive.
Tratti in comune fra l’Europa del XVI secolo e il Giappone
in cui nascono il teatro Kyōgen e il Nō ce ne sono: sono
società rigide, autoritarie, in cui il potere è detenuto da una
ristretta casta nobiliare e militare e la massa del popolo più
che vivere sopravvive; ai nobili piacciono la conservazione,
l’ordine, il rigore, la forma: quindi a loro va bene il Nō in
Giappone, e la Tragedia in Europa. Gli altri, più aperti e
dinamici, preferiscono rispettivamente il Kyō-gen e la
Commedia dell’Arte.
Il Nō è tuttora in vita: conta circa 1500 attori professionisti,
con cinque scuole. Ognuna ha a capo una famiglia conosciuta come Soh-ke; solo i capofamiglia hanno il diritto di
creare nuove rappresentazioni o modificare quelle esistenti.
La società degli attori Nō ha ancora carattere feudale e
protegge gelosamente le sue tradizioni.
Il Nō rappresenta bene il gusto tutto giapponese di ricercare
la bellezza nel dettaglio e nella formalità. La scena è ridotta
5
all’essenziale, costituita da un palco di cipresso giapponese
completamente vuoto a parte il kagàmi-ita, un pino dipinto
su un pannello di legno, sul fondo del palco. La spiegazione
più comune per la scelta di quest’albero è che nella religione scintoista le divinità lo usano per scendere sulla terra.
I costumi invece, soprattutto quelli dei protagonisti, sono
ricchissimi, in broccato e seta.
Protagonisti del Nō sono divinità, demoni e personaggi
mitici e mitologici trattati con movimenti stilizzati e ridotti
all’essenziale. Piccoli cenni del capo o movimenti del corpo
hanno significati ben precisi. I ruoli sono fissi e gli attori
utilizzano particolari maschere, che mutano espressione
secondo il modo in cui sono colpite dalla luce. La musica è
sempre presente, con canti che al nostro orecchio suonano
monotoni e ripetitivi e fanno sì che molti tendano erroneamente a pensare al Nō come ad un teatro d’opera.
Il teatro Kabuki utilizza forme espressive analoghe a quelle
del Nō (stilizzazione estrema, comunicazione affidata all’espressione e all’allusione più che alla chiara formulazione
verbale) ma si rivolge ad un pubblico diverso: non la colta e
rarefatta nobiltà, ma i chōnin, la popolazione urbana borghese. Anche gli argomenti che tratta, perciò, sono diversi:
il Kabuki racconta fatti, preferibilmente drammatici, realmente accaduti: è un vero e proprio strumento di cronaca.
Per capire a fondo il Kabuki (ma anche il Nō) bisogna considerare che, quando parliamo di teatro, noi pensiamo al
significato che questa espressione artistica ha in occidente,
a partire dalla Grecia.
Ma il Kabuki non segue gli schemi del teatro occidentale:
non tratta argomenti di ordine generale, questioni esistenziali o riflessioni filosofiche, per cui non ci troveremo mai
6
un monologo sulla caducità della vita umana o considerazioni su questioni di carattere politico.
Ogni pubblico produce il suo teatro: politica e massimi sistemi non rientravano nell’ordine delle cose cui i chōnin
erano abituati – o autorizzati – a pensare: erano roba per i
samurai, gli shogun e i preti shintoisti.
Dopo questa lunga trasferta in Oriente, torniamo in Europa
forti di una riflessione che mi permetto di richiamare alla
vostra attenzione: ogni pubblico crea il suo teatro.
Durante la nostra chiacchierata precedente abbiamo parlato
di zeigeist, lo spirito dei tempi, che evolve in direzioni imprevedibili e capricciose. Qui in Europa lo zeitgeist ha fatto
del Medioevo (parliamo inevitabilmente all’ingrosso) l’epoca della cupa religiosità, del Rinascimento il momento della
creatività artistica, della Riforma il tempo dell’ottusa bigotteria; poi sono nati i grandi regni dinastici, l’Illuminismo, i
movimenti irredentisti, gli Stati nazionali, le due grandi
guerre.
Ai rivolgimenti politici si sono affiancati i grandi movimenti artistici ai quali abbiamo già accennato, dal Barocco
all’Illuminismo al Romanticismo.
Non è un caso, ed è per questo che torno a parlare di zeitgeist, se il Romanticismo nasce e prospera in concomitanza
coi grandi movimenti nazionalisti che porteranno alla caduta di quasi tutte le monarchie ed alla nascita dell’Europa
come la conosciamo noi.
Fino all’illuminismo l’arte ha celebrato l’ordine, la simmetria ed il rigore che volevano tutto e - soprattutto ognuno collocato al suo posto, dove sarebbe dovuto restare per tutta
la sua esistenza. L’universo si rifletteva in questa visione,
7
con le sue brave stelle fisse ed immutabili, la Terra al centro, eccetera.
Ma poi arrivano Copernico, Galileo e Newton da una parte,
Cromwell e Robespierre dall’altra: l’ordine universale diventa meno ordinato e cadono le teste dei primi re. L’ordine
non è più così immutabile; addirittura, un certo Darwin butta là che anche l’uomo non è nato a immagine e somiglianza di Dio alle nove di mattina d’un giorno d’autunno
del 4004 A.C., ma è frutto di un processo evolutivo lunghissimo, accidentale e accidentato.
Il mondo, abituato all’immobilità, è sconvolto da tutti questi rivolgimenti. Insieme alle teste dei re cadono anche consuetudini secolari. I nobili non sono più considerati migliori
per definizione: la borghesia accampa i sui diritti, basati
sulla capacità di creare e accumulare ricchezza.
Se dapprima questa borghesia s’accontenta di imitare la nobiltà e di esserne assorbita, comincia poi a maturare una coscienza ed un orgoglio di sé che porteranno alla pretesa di
gestire non solo gli affari ma anche la politica.
Tutto questo sfocia nella Rivoluzione Francese e poi, con
una sorta di effetto domino, nei movimenti nazionali di cui
abbiamo già parlato, ma gli effetti di tutto questo, ovviamente, non si fermano alla politica.
Il Romanticismo altro non è che la manifestazione in campo
artistico delle rivendicazioni che la borghesia avanza in
campo politico. L’uomo che lotta contro tutti e prevale, o
anche se soccombe lo fa però con orgoglio; la motivazione
individuale (e quindi il sentimento) che fa premio sull’obbligo sociale, sono conseguenza di questa mutazione nel
sentire comune. Vedremo che nuovi, e ancora più profondi
8
mutamenti interverranno, con l’arrivo del XX secolo, a
causa di sconvolgenti nuove scoperte in campo scientifico.
Anche il teatro, naturalmente, vive tutte queste trasformazioni. Ne abbiamo già parlato, accennando in particolare a
Victor Hugo, che però, in campo teatrale, pur raccontando i
sentimenti dei protagonisti, parla sempre di teste coronate o
gentiluomini. Non così nella narrativa, basti pensare al titolo emblematico del romanzo I Miserabili.
Prima di una rapida carrellata sugli altri grandi autori romantici della seconda metà dell’Ottocento, è il caso di soffermarci un attimo su un’altra conseguenza dell’avvento del
romanticismo, e dell’avvento della borghesia, che investe il
modo stesso di concepire il fare teatro ed il fruirne.
Abbiamo già visto che, più o meno rigidamente, certe divisioni antichissime continuavano a persistere: esistevano due
mondi, quello del teatro serio e quello del teatro comico, la
cui definizione risaliva addirittura ad Aristotele; questa divisione era particolarmente marcata in Francia, dove il
mondo della Tragedia era nettamente contrapposto a quello
della commedia. Con la Rivoluzione questa distinzione si
attenuò, ma fu rigidamente ripristinata da Napoleone, che
decise addirittura quanti teatri potessero esistere a Parigi, e
cosa ogni teatro poteva rappresentare.
Accanto a ciò, esisteva il problema interpretativo.
È vero che la commedia dell’Arte, vivendo d’improvvisazione, concedeva qualche margine alla libera interpretazione degli attori, ma è anche vero che i personaggi erano ben
definiti in caratterizzazioni molto rigide: Arlecchino o Pulcinella non avrebbero mai potuto recitare un monologo
filosofico, il Dottore sarebbe sempre stato pomposo e saccente.
9
Nel Teatro tragico i vincoli erano ancora più rigidi. Era obbligatoria la declamazione dei versi, da imparare a memoria
e recitare senza potersi permettere la benché minima licenza.
Certamente, poi ognuno declamava a modo suo; ma in sostanza, come già abbiamo detto, il teatro era teatro d’autore.
Tutto questo apparteneva a quel gusto aristocratico e conservatore che abbiamo già visto all’opera, in Giappone, nella nascita del teatro Nō. In Francia, mutatis mutandis, quel
gusto genera Corneille, Racine e Voltaire.
Parola chiave di tutto questo è il formalismo, del quale si fa
portavoce Denis Diderot nelle sue considerazioni sulla recitazione, affermando che l’attore non deve provare le emozioni che prova il suo personaggio.
Sgomberiamo il campo da un possibile equivoco: non è che
alla tale data si smette di recitare – o scrivere, o addirittura
pensare - in un certo modo, e si passa ad un altro. Ovviamente il processo è graduale, con accelerazioni, arretramenti, ripartenze e sacche di resistenza.
Tanto per fare un esempio che col teatro c’entra indirettamente, Mozart è già un romantico quando decide di sfidare
Vienna come libero artista, senza cercare la protezione di
un nobile, ma è ancora legato al mondo rococò con quasi
tutta la sua produzione, sulla quale la sua vicenda personale
non influisce in alcun modo. Beethoven, invece, è già romantico a tutto tondo, sia nello stile di vita che nella natura,
spesso autobiografica, della sua produzione artistica.
In campo recitativo, e torniamo in Francia, accanto ad attori
che sono talmente vincolati alla recitazione aulica da perdere ogni contatto con la realtà – e quindi con la credibilità
dei testi che rappresentano, già prima della Rivoluzione alcuni cercano di svincolarsi dai lacci di una tradizione che,
10
già allora, rende assolutamente insopportabili le tragedie
francesi agli altri europei.
Anche in questo campo il romanticismo produce le sue
brave conseguenze. L’attore diventa gradualmente un elemento determinante nel modo stesso di leggere e comprendere il testo rappresentato, fino a che, come succede ora, il
testo, già intoccabile fulcro dell’opera teatrale, finisce col
diventare uno degli elementi della rappresentazione, con
dignità non superiore agli altri.
Il gusto romantico, ne abbiamo già parlato, spazza via tutto
ciò che sa di rigida conservazione, di struttura immutabile e
di inutile pompa.
I borghesi vogliono che si parli di loro, o almeno di cose a
loro vicine; e vogliono che si parli di esseri umani veri, non
di modelli fissi – l’eroe, il dio, il traditore, l’amoroso, il vile, eccetera – lontani dalla realtà, e soprattutto dalla loro
realtà.
Quale migliore esempio di questo nuovo modo di fare e godere del teatro, che i due Alexandre Dumas?
Il padre (1802-1870), amico personale di Garibaldi, grande
viaggiatore, carattere inquieto e avventuroso, è famosissimo
autore di romanzi storici, come I tre moschettieri, ma ebbe
grande successo anche come autore di drammi romantici,
come l’Enrico III.
È il figlio, però, (1824-1895) che meglio rappresenta la
rivoluzione di cui è oggetto il fare teatro.
Figlio illegittimo, originariamente non riconosciuto e poi
conteso dai genitori, Dumas figlio trasfonde le sue esperienze personali nell’opera letteraria e teatrale, privilegiando il
racconto di eventi che appartengono alla vita quotidiana: è
11
particolarmente famoso, naturalmente, il romanzo La Signora delle Camelie, poi portato sulle scene (Verdi lo musicherà, e sarà La Traviata); ma basta citare alcuni titoli della
sua produzione drammaturgica - Il Figlio naturale, Un padre prodigo, Le idee della signora Aubray, La moglie di
Claude - per percepire il cambiamento di gusto che ormai si
è impadronito del mondo del teatro.
Processi analoghi interessano i drammaturghi un po’ in tutta Europa, fino in Norvegia.
Henrik Ibsen (Skien, 20 marzo 1828 - Oslo, 1906) ebbe infanzia ed adolescenza difficili a causa di problemi economici di cui lasciò traccia nei primi componimenti lirici, raccolti in Digte (Poesie, 1871).
Scrisse la sua prima opera teatrale, Catilina, nell’inverno
tra il 1848 ed il 1849. È una tragedia in versi con influssi
del periodo risorgimentale europeo e degli eroi
shakespeariani.
Il rapporto di Ibsen col teatro non fu solo letterario: dapprima lavorò come assistente teatrale e scrittore, poi come maestro di scena al Norske Theater di Bergen; studiò scenografia a Copenaghen e Dresda fino a diventare, nel 1857,
Direttore del Kristiania Norske Theater.
La parte più significativa della sua vicenda iniziò quando,
grazie ad una borsa di studio, poté visitare città come Roma, Dresda e Monaco di Baviera e s’innamorò delle idee risorgimentali, dall’arte medievale e gotica e della scultura
barocca.
Durante il soggiorno a Roma scrisse Brand (1866), dramma
in versi intriso di simbolismo, così come è in versi Peer
Gynt (1867), opera in cui la fantasia si confonde con la realtà, e alla cui fama contribuì la musica di Edvard Grieg.
12
Dopo la fase romantica Ibsen si dedicò al teatro sociale; e la
realtà quotidiana diventò protagonista della sua produzione.
Il dramma I pilastri della società (1877) tratta lo smascheramento della menzogna e vede nella donna la protagonista
di questa operazione sociale. La donna riveste una posizione centrale anche in Casa di bambola (1879), il suo dramma forse più rappresentato, la cui protagonista non esita a
lasciare la famiglia per riacquistare una propria identità.
Dalla Norvegia scendiamo in Svezia per incontrare August
Strindberg (Stoccolma, 1849 - 1912).
Strindberg si occupò di tutti i generi letterari; per vastità e
rilevanza della produzione, affianca Ibsen all’apice della
tradizione letteraria scandinava e occupa un seggio tra i
massimi artisti letterari del mondo.
La sua vita fu tumultuosa, tessuta di esperienze complesse e
scelte radicali e contraddittorie; si applicò anche a discipline non direttamente attinenti alla sua figura di letterato,
come scultura, pittura e fotografia, chimica, alchimia e teosofia, spinto dalla necessità di uscire dagli schemi e di ricercare fonti di ispirazione e contaminazione in ambiti alternativi a quelli convenzionali.
Tentata e fallita la carriera di attore, nel 1870 Strindberg decise di iscriversi all’Università di Uppsala, iniziando a
speri-mentare la creazione letteraria; la sua condizione
economi-ca lo costrinse dopo soli due anni ad abbandonare
gli studi e a ritornare nella capitale; nel 1874 iniziò a
lavorare come giornalista e soprattutto ottenne l’impiego di
bibliotecario nella Biblioteca reale, ove rimase fino al 1882.
Nel 1877 si sposò.
L’esordio vero e proprio come drammaturgo avvenne nel
1879 con l’uscita de La Camera Rossa mentre il dramma
13
Maestro Olof, concepito già nel 1871, nel quale credeva
moltissimo, fu respinto dai teatri; fu rappresentato solo nel
1881.
Negli anni successivi compose un’opera storica, Il popolo
svedese, ed il romanzo Il nuovo regno, in stile realista e fortemente critico verso le istituzioni sociali. Fu così fortemente discusso e criticato da decidere di trasferirsi a Parigi
(1883) e, più tardi, in Svizzera.
Durante il soggiorno all’estero continuò a scrivere e pubblicare romanzi autobiografici e critici delle realtà sociali.
La prima parte della raccolta di novelle Sposarsi gli suscitò
accuse di blasfemia che alimentarono il cosiddetto Processo-Giftas. Altri lavori valsero a Strindberg l’etichetta di misogino in tutta l’Europa.
Rimase all’estero fino al 1889. Un lungo periodo durante il
quale il rapporto con la moglie giunse ad un grado di tensione paragonabile a quello provocato dai personaggi femminili delle sue opere. In seguito si risposò altre due volte
ma entrambi i matrimoni si conclusero dopo breve tempo.
Tra le sue opere teatrali più famose, ricordiamo Il padre, La
contessina Julie e Danza di morte, che potete trovare nella
biblioteca dell’Associazione.
Attraversiamo il Mare del Nord e dalla Scandinavia spostiamoci nelle isole britanniche per incontrare due personaggi
dal genio indiscusso, entrambi irlandesi, nei quali la trasformazione del teatro vede l’intelligenza e l’ironia assurgere al
ruolo di protagonista: Oscar Wilde e G.B.Shaw.
Ugualmente geniali sotto questo profilo, i due furono però
diametralmente diversi sotto tutti gli altri.
Oscar Wilde nacque a Dublino il 16 Ottobre 1854, figlio di
un famoso otorino autore anche di testi d’archeologia; la
14
madre, Jane Francesca Elgee, aveva fondato un salotto letterario, s’impegnava a favore dell’emancipazione femminile, era stata un’accesa sostenitrice dell’indipendentismo irlandese e una poetessa di successo.
Oscar, educato in casa fino a nove anni, all’inizio
s’avvicinò alla religione cattolica, ma ad Oxford, dove
completò gli studi, scandalizzò i bigotti professori con il
suo atteggia-mento irriverente nei confronti della religione.
Originale per elezione, fu il campione del dandismo.
Nel 1878 si laureò e si trasferì a Londra, dove aderì
all’Estetismo, il movimento inglese di fine ‘800 che sosteneva un’arte fine a sé stessa. Si dedicò ad un’intensa ed
affa-scinante vita mondana, conquistando la società
conformista del tempo vittoriano con le sue stravaganze, i
suoi eccessi ed i suoi scandali.
Si sposò ed ebbe anche due figli.
Scrisse fiabe e racconti: ricordiamo, in particolare, Il ritratto di Dorian Gray, carico di simbologia estetistica, pubblicato nel 1890.
La fine del suo successo e del suo matrimonio e il crollo del
suo mondo furono provocati dalla relazione omosessuale
con Lord Alfred Douglas (Bosie), un aristocratico, poeta
non mediocre, che divenne allo stesso tempo il suo grande
amore e la causa della sua rovina, costringendolo a citare in
giudizio il padre per calunnia; in tribunale le parti si
rovesciarono, e fu Wilde ad essere condannato, essendo
stata dimostrata la sua omosessualità.
Wilde divenne celebre nel mondo del teatro negli anni tra il
1892 e il 1895 con una serie di opere di grande successo. Il
ventaglio di Lady Windermere (1892) tratta di una divorziata ricattatrice che arriva a sacrificare se stessa per amore
materno. In Una donna senza importanza (1893) un figlio
15
illegittimo è diviso tra il padre e la madre. Un marito ideale
(1895) parla di ricatti, corruzione politica ed onore pubblico
e privato. L’importanza di chiamarsi Ernesto (1895) è una
satira del mondo delle classi alte. Il titolo in inglese gioca
sugli omofoni “Ernest”, Ernesto, e “Earnest” che significa
onesto, sincero.
Affascinato dall’”Erodiade” di Mallarmé e dalla
descrizione di due dipinti di Gustave Moreau, tra il 1891 e
il 1892 Wilde scrisse in francese per Sarah Bernhardt la
tragedia in un atto “Salomé”, che sarà pubblicata nel ‘93 a
Parigi e nel ‘94 a Londra, nella traduzione di Alfred
Douglas e con le illustrazioni di Aubrey Beardsley. Il testo,
che potrà essere rappresentato in pubblico soltanto nel
1935, fungerà poi da base all’opera omonima di Richard
Strauss (1905) e al film di Carmelo Bene (1972).
Wilde entra di diritto nel novero degli artisti – come Caravaggio, Benevenuto Cellini, Mozart o Edgar Allan Poe –
pervasi da genio e sregolatezza, caratteristiche inestricabili
l’una dall’altra e condizione l’una dell’altra; famoso per i
suoi aforismi paradossali, vere e proprie scintille che brillano anche nei suoi drammi teatrali, fu bruciato dalla sua
stessa fretta di vivere. Affermò che a tutto poteva resistere
tranne che alla tentazione e disse una volta ad André Gide:
«Volete sapere qual è stato il grande dramma della mia vita? È che ho messo il mio genio nella mia vita; tutto quello
che ho messo nelle mie opere è il mio talento».
George Bernard Shaw (Dublino, 26 luglio 1856 - Ayot St
Lawrence, 2 novembre 1950) drammaturgo, narratore e
saggista, frequentò varie scuole ma la sua vera istruzione
avvenne attraverso le prime letture, fra le quali la Bibbia e
William Shakespeare.
16
Nel 1876 lasciò l’Irlanda per Londra, dove approdò squattrinato ma armato di idee che avrebbero scosso le acque
stagnanti della società vittoriana. Tra il 1879 e il 1883 scrisse diversi romanzi, che apparvero tutti a puntate su giornali
e riviste ma furono puntualmente rifiutati dagli editori. La
lettura del Capitale di Karl Marx lo fece aderire al socialismo. Fra il 1885 e il 1890 fu apprezzato critico letterario e
musicale. Si dedicò poi al teatro, dapprima come critico e
poi come saggista con The quintessence of ibsenism (1891),
in cui si fece sostenitore del teatro di Henrik Ibsen e
puntualizzò la sua concezione di teatro.
Shaw fu altrettanto pungente quanto Wilde nei suoi giudizi
ed aforismi. Un nobile gli chiese se fosse vero che il padre
era stato sarto e, alla sua risposta affermativa, altezzoso gli
disse: “E allora perché non lo siete anche voi?”. Shaw replicò chiedendogli se suo padre era un gentiluomo, e quello
ovviamente disse di sì. E lui: “E allora perché non lo siete
anche voi?”. È di Shaw anche la definizione degli Stati
Uniti come “Paese passato direttamente dalla barbarie alla
decadenza”.
Ma a parte questo, Shaw è lontanissimo da Wilde quanto al
contenuto della sua opera. Laddove Wilde si compiace dell’ammirazione della bellezza, suo scopo ultimo anche nella
produzione teatrale, Shaw è tagliente, spesso sprezzante, insofferente e soprattutto, diremmo oggi, “impegnato”.
D’accordo con Ibsen circa la necessità di portare sulle scene
i problemi e i tormenti della gente reale, dopo la rappresentazione di Widowers’ Houses (1892), dove affronta il dramma degli slums londinesi, Shaw continuò a pubblicare opere
teatrali con crescente successo, tanto da conseguire nel
1925 il Premio Nobel per la letteratura, di cui però rifiutò il
premio in denaro.
17
Senza sottovalutare il suo contributo come saggista e critico, fu nel teatro che Shaw trovò la sua migliore espressione.
Constatata la crisi del teatro inglese della seconda metà
dell’800, e la necessità di dargli una nuova funzione, oltre a
difendere le idee di Ibsen lavorò per fare del dramma non
più divertimento o evasione, ma denuncia delle contraddizioni dei valori convenzionali e ipocriti della società inglese
del tempo.
Da qui i suoi tanti lavori, fra i quali Mrs Warren’s profession (1894) che affronta con franchezza il problema della
prostituzione; Arms and the man (1894); Candida (1895);
The man of destiny (1896); You never can tell (1897), The
devil’s disciple (1897), Captain Brassbound’s conversion
(1899). Quando affronta i grandi personaggi della storia,
Shaw lo fa indagando i loro risvolti umani e rimuovendo
ogni concrezione retorica dalla loro figura: ricordiamo Caesar and Cleopatra (1893) che dimostra il suo interesse per i
personaggi più importanti della storia, così come The man
of destiny su Napoleone Bonaparte e Saint Joan (Santa
Giovanna, 1923).
L’interesse di Shaw si spostò poi verso temi politici e religioso-filosofici, con opere fra i quali giova ricordare John
Bull’s other island (1904); Major Barbara (1905); The
doctor’s dilemma (1906); Pygmalion (1912); Androcles and
the lion (1913); Man and superman (1903); Back to
Matuselah (1920). Da Pigmalione fu tratto un capolavoro
cinematografico come My Fair Lady, che sottolinea il lato
giocoso dell’opera, ma non tace sulle stridenti differenze ed
ingiustizie sociali dell’Inghilterra del tempo.
18
Continuiamo a saltellare qui e là per l’Europa e rechiamoci
in Russia, per incontrare Anton Pavlovič Čechov, medico,
scrittore, filantropo e drammaturgo.
Si laurea in medicina, ma conduce una sorta di doppia vita:
mentre esercita la professione di medico, scrive novelle. Le
sue opere narrano di gente umile e anche la sua vita in questo senso è stata sempre volta all’aiuto del prossimo, soprattutto se più debole.
Era nato nel 1860 da una famiglia di umili origini. Il padre,
figlio di un ex servo della gleba, mandava avanti una piccola drogheria. Dopo il fallimento della drogheria del padre,
Anton fu costretto a guadagnare da vivere per sé e per la
numerosa famiglia che contava altri cinque fratelli.
Concluso il liceo, raggiunse nel 1879 i genitori, che tre anni
prima si erano trasferiti a Mosca.
A diciannove anni, grazie ai suoi primi lavori letterari e
giornalistici pubblicati con vari pseudonimi su riviste umoristiche, che gli assicurarono un piccolo guadagno, iniziò
gli studi di medicina. Nel 1884, anno in cui conseguì la
laurea e iniziò ad esercitare la professione di medico, riuscì
a pubblicare, sotto pseudonimo, la sua prima raccolta di novelle, Le fiabe di Melpomene, a cui seguì (con lo stesso
pseudonimo) una raccolta di “Racconti variopinti” (1886),
brevi racconti umoristici sulle vicende di impiegati statali e
piccoli borghesi.
Iniziò così per Anton l’attività di scrittore a tempo pieno.
Presto raggiunse una grande fama, tanto da divenire uno dei
più letti scrittori russi e da rivaleggiare in popolarità con
Tolstoj, del quale era amico.
Dal 1887 cominciò la stesura dei suoi più celebri racconti,
presentati finalmente col suo nome, nei quali scompare
l’umorismo che cede il passo ad un pessimistico osservare
19
lo scorrere della vita, con occasionali spiragli di speranza e
fede nel futuro.
Nel 1891 viaggiò brevemente in Europa, poi tornò in Russia, dove proseguì nelle sue attività letterarie e filantropiche e si dedicò al giardinaggio. Durante questo periodo
scrisse Il gabbiano, il suo dramma più celebre.
Malato di tubercolosi, non riprese più la professione medica
se non in caso di gravi emergenze, come l’epidemia di
colera del 1892–1893 durante la quale si adoperò per lo più
gratuitamente. Nel frattempo scrisse il terribile racconto
intitolato Mugiki (1897), sulla condizione dei contadini
russi.
Nel 1897, al peggiorare della tubercolosi, soggiornò per
diverso tempo in case di cura in varie località europee, a
Biarritz, Nizza, fino a stabilirsi nel 1899 a Yalta, nel clima
secco della Crimea.
Nel 1900 fu eletto membro onorario dell’Accademia russa
delle scienze, ma diede le dimissioni due anni dopo,
contestando l’espulsione di Maksim Gor’kij. Nel 1901, già
minato dalla malattia, sposò la celebre attrice del Teatro
d’arte di Konstantin Stanislavskij, Olga Knipper, che è stata
una delle migliori interpreti delle sue opere teatrali.
Dopo il grande successo della sua ultima commedia, Il
giardino dei ciliegi, nella speranza di una guarigione, si
recò in Germania, a Badenweiler, località della Foresta
Nera. Si spense qui il 2 luglio 1904, assistito dalla moglie.
Aveva 44 anni ed era all’apice della sua fama di scrittore e
di drammaturgo.
Le commedie di Čechov rappresentano una pietra miliare
della drammaturgia di tutti i tempi.
Fu proprio lavorando sui suoi testi che, all’inizio del XX
secolo, elaborò una nuova metodologia della recitazione,
20
per adeguare l’arte drammatica all’espressione di stati
d’ani-mo complessi, delle sfumature emozionali di
personaggi apparentemente banali ma portatori di istanze
attribuibili ad ogni essere umano.
Nessuno tra gli scrittori della vecchia Russia, ormai scomparsa, ha saputo ritrarre tutta la confusione spirituale della
vita russa (ma non solo russa), la tragedia sconfinata della
mediocrità, l’esistenza scialba e gretta senza ideali e senza
mete o al contrario con troppi ideali e troppe mete, la vita
sciupata di uomini corrosi dalla consapevolezza dell’inutilità del loro vegetare improduttivo, schiavi dell’abitudine di
vivere.
Carlo Grabher (traduttore delle opere di Cechov) afferma: I
veri eroi cecoviani soffrono di non sapere e la loro volontà,
sebbene si spezzi dinanzi all’azione e si ripieghi vinta, non
rinuncia, almeno, a un’aspirazione iniziale; essi
vorrebbero sapere, vorrebbero agire, vivere, e questo
slancio impo-tente costituisce il vero principio dinamico del
loro dram-ma. L’anima dei veri eroi cecoviani si trova in
una situa-zione spirituale di una ambiguità delicatissima:
essi non amano la loro vita, perché non sanno viverla.
Abbiamo accennato a Stanislavskij, ma non possiamo limitarci ad un accenno.
Konstantin Sergeevič Stanislavskij (Mosca 18 gennaio
1863 - 7 agosto 1938), il cui vero cognome era Alekseev, fu
attore, regista e teorico teatrale, interprete eccellente di indimenticabili rappresentazioni oltre che scrittore. È anche, e
forse soprattutto, l’ideatore del metodo di recitazione che
gli deve il nome .
Nato da una famiglia facente parte dell’illuminata cerchia
di industriali, mecenati delle arti, Konstantin ha una pre21
coce educazione teatrale e musicale. Molto giovane è fra i
fondatori di una nuova compagnia teatrale ed inizia la sua
ricerca sull’attività dell’attore e sul personaggio. Si cimenta
anche nella regia oltre che nella recitazione.
A fine secolo, dall’incontro a Mosca con lo scrittore e uomo
di teatro Vladimir Nemirovič Dančenko nasce una nuova
collaborazione fra il regista ed il suo drammaturgo.
Vengono così alla luce le basi della riforma teatrale russa
del ‘900 che durerà fino alla morte di Stanislavskij nel
1938.
I due nel 1898 fondarono il Teatro d’Arte di Mosca.
Per la formazione dell’attore, Stanislavskij, che evidentemente la pensava in modo diametralmente contrario a Diderot (ed anche a Bertolt Brecht, del quale parleremo nel prossimo incontro, che incentrava il suo approccio alla recitazione sullo straniamento), applicò un metodo che si basava
sull’approfondimento psicologico del personaggio e sulla
ri-cerca di affinità tra il suo mondo interiore e quello
dell’at-tore. Nel 1938 pubblicò Il lavoro dell’attore su se
stesso; nel 1957 uscì postumo Il lavoro dell’attore sul
personaggio.
Per ottenere la credibilità scenica Stanislavskij – sul metodo
del quale sicuramente vi hanno dato migliori delucidazioni
Francesco e Lucia - proponeva esercizi che riproponessero
le emozioni da provare andando ad analizzare in modo
profondo gli atteggiamenti non verbali e il sottotesto del
messaggio da trasmettere.
Il metodo nasce tra la fine del secolo e gli inizi del novecento dalle puntigliose annotazioni di Stanislavskij sulle
22
proprie esperienze. Egli cercò poi di trasmetterlo agli attori,
sviluppando anche l’interesse per la scuola e la pedagogia.
Si può affermare che l’importanza del metodo sta soprattutto nel fatto che per la prima volta il processo creativo
dell’attore è sottoposto ad un’analisi rigorosa da parte di un
altro attore, competente lui stesso, capace di utilizzare alcuni principi della moderna psicologia.
Due sono, per Stanislavskij, i grandi processi alla base dell’interpretazione: quello della personificazione e quello della riviviscenza.
Il processo di personificazione parte dal rilassamento muscolare per poi proseguire con lo sviluppo dell’espressività
fisica, dell’impostazione della voce, della logica e coerenza
delle azioni fisiche e della caratterizzazione esteriore.
Il processo di reviviscenza parte dalle funzioni dell’immaginazione e prosegue con la divisione del testo in sezioni,
con lo sviluppo dell’attenzione, l’eliminazione dei cliché e
l’identificazione del tempo-ritmo.
La reviviscenza è fondamentale perché tutto ciò che non è
rivissuto resta inerte, meccanico ed inespressivo. Ma non
basta che la reviviscenza sia autentica: essa deve essere in
perfetta consonanza con la personificazione. Infatti, a volte,
una reviviscenza profonda è deformata da una personificazione grossolana dovuta ad un apparato fisico non allenato
ed incapace di trasmettere all’esterno quello che l’attore
sente.
Siamo ormai nel XX secolo, e come abbiamo visto l’intera
Europa è percorsa da fremiti innovativi, subbugli emotivi e
rivoluzionari che spingono la gente di teatro a interrogarsi
sulle ragioni stesse, oltre che sui modi, di fare teatro.
Ma in Italia, intanto, che succede?
23
Dopo l’unificazione politica, l’auspicio di Massimo d’Azeglio, fatta l’Italia bisogna fare gli italiani, è ancora molto
lontano dal realizzarsi. Il paese è lacerato fra poverissimi (i
più) e benestanti, colti (pochissimi) e ignoranti, una monarchia inadeguata al compito che si è assunta, una classe politica inetta e provinciale, ambizioni imperialistiche, tasse
inique, Nord arrogante, Sud insofferente, Centro indifferente, tutti bigotti; la Chiesa ha scomunicato lo Stato, lo
Stato s’è impossessato delle chiese e dei monasteri.
Sul piano culturale, la stagnazione è la parola d’ordine.
Manzoni è una sorta di divinità intoccabile, modello di tutti
gli intellettualucci piccolo borghesi, contro i quali si scaglia
inutilmente Carducci, che a sua volta comunque è tutto
imbevuto di classicismo e di non poca retorica, ma almeno
vince un Nobel per la letteratura.
In questo ambientino non poco deprimente, nasce a Pescara, nel 1863, il fenomeno Gabriele d’Annunzio, che sceglie
questo cognome in luogo dell’originario, troppo provinciale
Rapagnetta, facendo suo quello d’uno zio che lo aveva
adottato.
D’Annunzio, per tutta la vita, ebbe di mira solo un obiettivo: coltivare il proprio mito. Tutto ciò che fece non servì a
molto d’altro, che si trattasse di scrivere una poesia, di fare
l’eroe in guerra, di realizzare le didascalie per il film Cabiria, di stendere un romanzo, trovare un nome ai magazzini
La Rinascente, o di concepire un dramma teatrale.
Il nome d’Annunzio si associa immediatamente al termine
decadentismo del quale in effetti, in campo letterario, egli
fu il massimo esponente in Italia anche se questa corrente,
ultima marea del romanticismo, nasce in realtà in Francia.
Agli inizi degli anni ‘80 e ‘90 del XIX secolo si avvertiva
oltralpe una sensazione di disfacimento, di fine d’una civil24
tà, e l’imminenza di un cambiamento epocale; alcuni intellettuali esprimevano nelle loro opere lo smarrimento della
coscienza e la crisi dei valori di fine Ottocento, sconvolti
dalla rivoluzione industriale, dalle lotte di classe, dal progressivo scatenarsi degli imperialismi. Stiamo parlando di
Baudelaire, Théophile Gautier e soprattutto Guy de Maupassant, Max Nordau e Joris-Karl Huysmans, il cui romanzo À rebours costituì il manifesto europeo dell’estetismo decadente.
La critica ufficiale, per descrivere gli atteggiamenti assunti
da questi intellettuali, usò in senso negativo il termine decadentismo ma essi ne ribaltarono il significato, arrivando a
considerarlo un privilegio spirituale a farne quasi una bandiera da esibire con orgoglio.
Il termine quindi indicava in origine un movimento letterario nato nella Parigi di fine Ottocento. Siccome all’interno
di questo movimento vi erano altre correnti che poi si
sarebbero sviluppate autonomamente, la storiografia letteraria italiana, nel Novecento, ha usato il termine per definire un intero movimento letterario di portata europea; ma
in altri paesi sono preferite diverse denominazioni, come ad
esempio quella di “Simbolismo“.
Nel Simbolismo il poeta, avvalendosi dell’intuizione, descrive l’universale attraverso il particolare, l’infinito mediante il finito e rifiuta i principi del positivismo ed ogni
spiegazione razionale e scientifica del mondo.
Il Decadentismo fa dell’estetismo la sua parola chiave; ed
esaltando il gusto del bello e dell’arte, è inevitabilmente
attratto dal Simbolismo.
Per un esteta il mondo reale è piuttosto deprimente, tanto
più se ha la mente imbottita di retorica classicheggiante. Si
25
può perciò parlare, tanto nelle opere quanto nella vita di
D’Annunzio, di una idealizzazione del mondo nella dimensione del mito. La fantasia dell’ex Rapagnetta lottò per imporre sulla realtà del presente, vissuto con disprezzo, i
valori “alti” ed “eterni” di un passato visto come modello
assoluto di vita e di bellezza.
Il conflitto tra realtà presente e ideali (ma anche tra normalità e gusto per la retorica roboante, tipico di D’Annunzio) è ben espresso in questa pagina de Le vergini delle
rocce:
Vivendo in Roma, io ero testimonio delle più ignominiose
violazioni e dei più osceni connubii che mai abbiano disonorato un luogo sacro. Come nel chiuso di una foresta
infame, i malfattori si adunavano entro la cerchia fatale
della città divina dove pareva non potesse novellamente levarsi tra gli smisurati fantasmi d’imperio se non una qualche magnifica dominazione armata d’un pensiero più fulgido di tutte le memorie [...] La cupola solitaria nella sua
lontananza transtiberina, abitata da un’anima senile ma
ferma nella consapevolezza dei suoi scopi, era pur sempre
il massimo segno, contrapposta a un’altra dimora inutilmente eccelsa dove un re di stirpe guerriera dava esempio
mirabile di pazienza adempiendo l’officio umile e stucchevole assegnatogli per decreto fatto dalla plebe.
Spregiudicatezza e narcisismo, slanci sentimentali e calcolo
furono alla base anche dei rapporti di D’Annunzio con le
numerose donne della sua vita. Quella che sicuramente più
di ogni altra rappresentò per lui un nodo intricato di affetti,
pulsioni e di artificiose opportunità fu Eleonora Duse,
l’attrice di fama internazionale cui si legò dal 1898 al 1901.
Non c’è dubbio infatti che a questo nuovo legame debba
26
essere fatto risalire il suo nuovo interesse verso il teatro e la
produzione drammaturgica, sia in prosa (Sogno di un mattino di primavera, La città morta, Sogno di un tramonto
d’autunno, La Gioconda, La gloria) e in versi (Francesca
da Rimini, La figlia di Jorio, La fiaccola sotto il moggio, La
nave e Fedra).
Spendiamo allora due parole anche su Eleonora Duse
(1858- 1924), che fu una delle più importanti attrici teatrali
italiane del tempo.
Era figlia d’arte: nata da una famiglia di attori, condusse
una vita nomade al seguito della compagnia del padre e
della madre e cominciò a recitare fin da bambina: già a
quattro anni interpretò la parte di Cosetta in una versione
teatrale de I miserabili. Nel 1878 ottenne il ruolo di prima
amorosa nella compagnia Ciotti – Belli Blanes, e appena
ventenne fu a capo di una compagnia con Giacinta Pezzana.
Alcune memorabili interpretazioni, come Teresa Raquin di
Émile Zola, le procurarono presto l’adorazione del pubblico
e l’entusiasmo della critica.
Il suo repertorio era moderno e di forte richiamo: dal verismo della Cavalleria rusticana di Giovanni Verga ai
drammi di Alexandre Dumas figlio, che facevano parte del
repertorio di Sarah Bernhardt. Fra le due attrici nacque
presto una rivalità che divise i critici teatrali.
Si sposò ed ebbe una figlia, poi lasciò il marito e si unì
segretamente ad Arrigo Boito, che adattò per lei Antonio e
Cleopatra di William Shakespeare. In questo periodo l’attrice frequentò gli ambienti della Scapigliatura, ed il suo
repertorio si arricchì anche dei drammi di Giuseppe
Giacosa, librettista di Giacomo Puccini e amico di Boito.
27
Negli anni ‘90 la Duse portò sulle scene italiane i drammi
di Ibsen Casa di bambola, La donna del mare, Hedda
Gabler e Rosmersholm.
E poi incontrò D’Annunzio. Il tempestoso legame sentimentale ed artistico che si stabilì fra i due contribuì in modo
determinante alla fama del Vate. Fu lei, già celebre ed acclamata in Europa e oltre oceano, a portare sulle scene i
drammi dannunziani, spesso finanziando le produzioni e assicurando loro il successo e l’attenzione della critica anche
fuori dall’Italia. Ciò non impedì a D’Annunzio, nel 1896, di
preferirle Sarah Bernhardt per la prima rappresentazione
francese del suo dramma La ville morte.
Eleonora Duse e Sarah Bernhardt: dive e rivali.
La Bernhardt, il cui vero nome era Henriette Rosine Bernard (1844 - 1923), soprannominata La voix d’or e La divina è forse il primo esempio di diva fatale nella storia del
teatro.
Certamente, già da lungo tempo gli autori adattavano i propri testi alle caratteristiche degli interpreti che si avvicendavano nella recitazione delle loro opere, ma ora assistiamo,
l’abbiamo visto, alla creazione di opere scritte espressamente, diremmo tagliate su misura, per il divo di turno.
Un’attività che non disdegnerà neanche l’ultimo, e forse il
più grande, degli autori dei quali ci occupiamo questa sera.
Luigi Pirandello (Agrigento, 28 giugno 1867 – Roma, 10
dicembre 1936) è stato infatti uno dei più importanti scrittori e drammaturghi italiani. La sua opera ha tracciato un
solco che ha determinato il corso della drammaturgia teatrale dell’intero XX secolo, meritandogli il Premio Nobel per
la letteratura nel 1934.
28
Non che il Premio Nobel sia poi un segnale particolarmente
qualificante di valore artistico e una garanzia di immortalità: Grazia Deledda, per dire, è ormai solo un nome nelle
storie della letteratura, non la legge praticamente nessuno,
eppure il Nobel l’ha vinto anche lei.
Pirandello è tutt’altra cosa. Rappresenta, nella storia del Teatro mondiale, un punto d’arrivo e insieme di partenza:
punto d’arrivo perché assorbe e fa sue tutte le esperienze
che lo hanno preceduto, dalla Commedia dell’Arte al Romanticismo, senza dimenticare il nuovo vento che spira sul
XX Secolo, impregnato di rivoluzioni epocali in campo
scientifico e politico, che – lo vedremo meglio nel prossimo
incontro – sconvolgono dalle fondamenta tutto il castello
del mondo culturale, in Europa prima e poi nel mondo.
Punto di partenza perché sarà impossibile, dopo di lui, fare
teatro senza subire la sua influenza.
Pirandello nacque in una località dal suggestivo e – a suo
stesso dire - emblematico nome di Caos, a pochi chilometri
dal centro di Girgenti (l’odierna Agrigento), da Stefano e da
Caterina Ricci Gramitto, in una famiglia di media borghesia.
Andrea Camilleri, nella sua Biografia del figlio scambiato,
sottolinea quanto, sulla psicologia del giovane Luigi, influirono le incomprensioni che segnarono il suo rapporto col
padre, avanzando addirittura l’ipotesi che egli sospettasse di
non essere, in realtà, figlio di Stefano, dal quale era diverso
sotto ogni profilo, sia fisico che mentale, e che il tema dominante dei due lavori più enigmatici e complessi, gli ultimi, della sua drammaturgia, La favola del figlio scambiato
29
e I giganti della Montagna, possa essere ascritto a questo
suo tarlo mentale inconfessato.
Iniziò l’università a Palermo e poi si spostò a Roma per
continuare gli studi di filologia romanza, che infine completò a Bonn. Gli studi di filologia sono sempre stati seguiti
con particolare interesse in Germania: anche Friederich
Nietzsche era uno specialista in questo campo.
Questi studi furono per Pirandello uno strumento essenziale per la stesura delle sue opere, realizzate in un italiano di
rara bellezza e purezza. Inoltre il fatto di aver vissuto in
Germania gli consentì di respirare un’atmosfera più libera
di quella provinciale e asfittica che soffocava il mondo della cultura, in Italia in generale ed in Sicilia in particolare.
Si laureò nel 1891 discutendo la tesi “Voci e suoni del dialetto di Girgenti”. Pirandello rimase sempre legato alla sua
terra – dove fra l’altro volle che le sue ceneri fossero sepolte - e scrisse molte commedie nel dialetto natale.
Il padre era proprietario di miniere di zolfo, e già in passato
aveva subito rovesci finanziari. Luigi s’era sposato da poco
quando un allagamento, in una miniera in cui lui e la sua
famiglia avevano investito il loro capitale, li ridusse sul lastrico. La notizia scatenò nella moglie Antonietta i primi
segni di un disagio mentale che l’avrebbe lentamente portata alla demenza totale.
Negli anni a cavallo fra i due secoli Sigmund Freud aveva
avviato una delle grandi rivoluzioni scientifiche del tempo
scoprendo l’enorme complessità della psiche umana, i suoi
molteplici livelli e la capacità delle pulsioni inconsce di
determinare i comportamenti dell’individuo.
Così, vivendo il dramma in prima persona, Luigi approfondì lo studio dei meccanismi della mente e della reazione
30
dell’ambiente sociale di fronte alla menomazione intellettuale.
Di questi approfondimenti c’è traccia evidente in molte
opere, come l’Enrico IV o Il berretto a sonagli, nel quale
Pi-randello indica addirittura una via per la pazzia: dire
sempre la verità, la nuda e cruda e tagliente verità,
infischiandosene dei riguardi e delle maniere, delle
ipocrisie e delle conven-zioni sociali, porta inevitabilmente
all’isolamento e, agli occhi degli altri, alla pazzia.
Il tema romantico dell’eroismo e del titanismo, associato al
senso di straniamento indotto dalle novità in campo scientifico e politico, che stravolgono tutte le antiche certezze
culturali, trova in Pirandello una soluzione insieme rivoluzionaria e geniale.
Nell’opera pirandelliana è costante il senso della solitudine
dell’eroe, la riflessione sulla lotta inutile dell’uomo contro
l’assurdità del vivere, contro l’assurdità del corso delle cose, tanto più irrazionali quanto più esse sembrano, apparentemente, essere logiche e razionali.
L’eroe pirandelliano non cerca la gloria: cerca di sopravvivere alle forze cieche e indifferenti della natura e della società, alle quali si contrappone sapendo già in partenza di
essere destinato a soccombere.
Non c’è, nel teatro pirandelliano, l’esaltazione del grande
ideale, non c’è la speranza della gloria e non c’è neppure
una speranza di riscatto attraverso una catarsi ideale: Dio,
nel mondo di Pirandello, non esiste: c’è piuttosto un continuo, tormentoso e consapevolmente inutile interrogarsi sul
perché delle cose.
l’eroe si dibatte invischiato nel “qui ed ora”, consapevole
che, oltre questo “qui ed ora”, non c’è nient’altro, e se alla
31
fine trova sollievo lo trova solo accettando l’ineluttabilità
del suo destino.
Tuttavia, anche se l’esito non è quasi mai positivo, l’eroe
raramente cede alla disperazione, grazie alla soluzione dell’ironia e dell’umorismo, che Pirandello definisce “il sentimento del contrario”. L’umorismo pirandelliano nasce
dalla riflessione.
...Vedo una vecchia signora – dice Pirandello - coi capelli
ritinti, tutti unti non si sa di qual orribile manteca, e poi
tutta goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi
metto a ridere.
Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che
una rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa espressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del
contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi
suggerisce che quella vecchia signora non prova forse
piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne
soffre e lo fa soltanto perché pietosamente, s’inganna che,
parata così, nascondendo le rughe e le canizie, riesca a
trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane di lei,
ecco che io non posso più riderne come prima, perché
appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar
oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro:
da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto
passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la
differenza tra il comico e l’umoristico.
Luigi Pirandello spiega che un comico fa ridere perché mostra situazioni che sono il contrario di quello che dovrebbero essere, e si ferma lì; l’umorista va oltre: spingendo a ri32
flettere sul motivo del contrario, passando insomma dalla
semplice constatazione dell’anomalia, che fa ridere e basta,
ingenera un sentimento quasi di compassione: non più una
risata divertita, ma un sorriso di comprensione.
Da qui tutta una serie di situazioni, apparentemente assurde,
tipiche del teatro pirandelliano: il vecchio marito che, in
Pensaci, Giacomino, fa di tutto perché il vero padre del
figlio, dal quale amerebbe essere chiamato “nonno”, non
receda dall’amore per sua moglie; l’amante che, in L’uomo,
la bestia e la virtù, fa di tutto perché la sua amata incinta di
lui, per non perdere l’onore, induca il marito indifferente a
fare l’amore con lei; il pazzesco intreccio di “onesti”
tradimenti e gravidanze procurate in Liolà, il mistero delle
figure e delle vicende dei Sei perso-naggi in cerca
d’autore. E poi titoli che già in sé rivelano il gusto amaro,
ma anche compassionevole, per l’osservazione disincantata
delle miserie umane: Il gioco delle parti, Così è se vi pare,
Non si sa come, Sogno ma forse no.
33