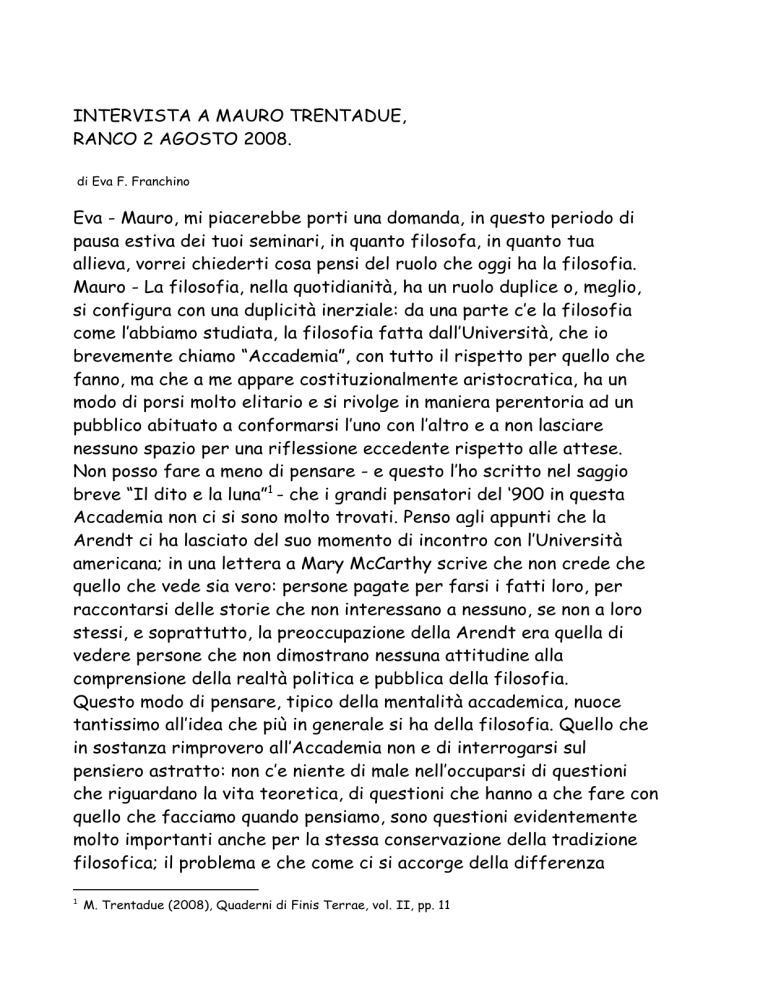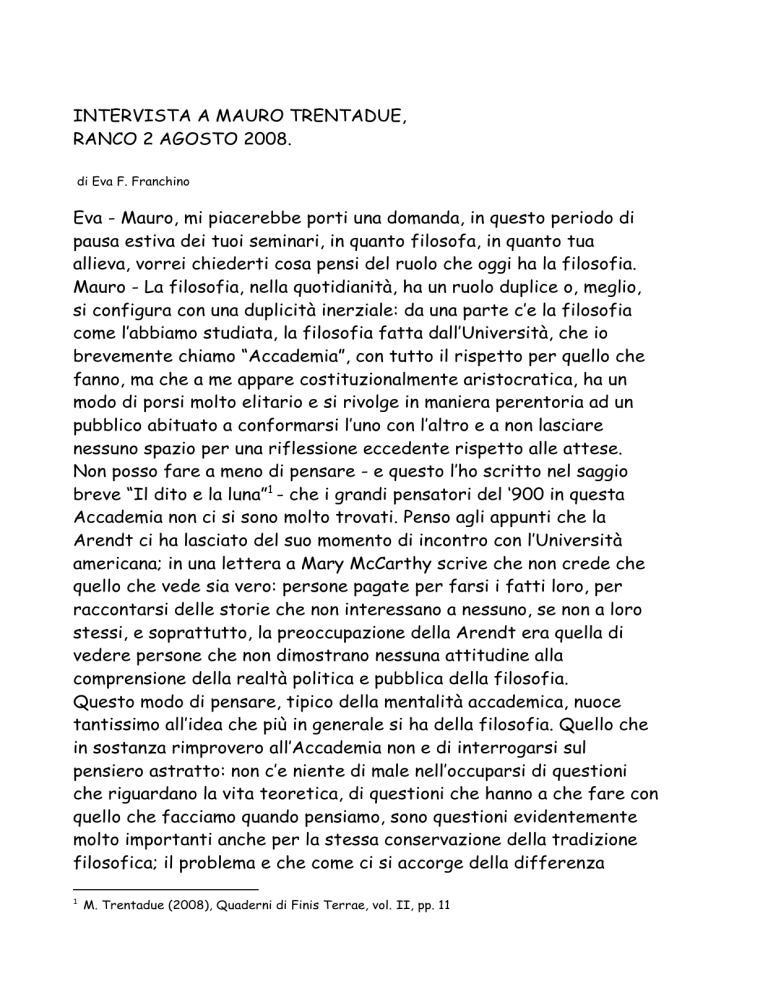
INTERVISTA A MAURO TRENTADUE,
RANCO 2 AGOSTO 2008.
di Eva F. Franchino
Eva - Mauro, mi piacerebbe porti una domanda, in questo periodo di
pausa estiva dei tuoi seminari, in quanto filosofa, in quanto tua
allieva, vorrei chiederti cosa pensi del ruolo che oggi ha la filosofia.
Mauro - La filosofia, nella quotidianità, ha un ruolo duplice o, meglio,
si configura con una duplicità inerziale: da una parte c’e la filosofia
come l’abbiamo studiata, la filosofia fatta dall’Università, che io
brevemente chiamo “Accademia”, con tutto il rispetto per quello che
fanno, ma che a me appare costituzionalmente aristocratica, ha un
modo di porsi molto elitario e si rivolge in maniera perentoria ad un
pubblico abituato a conformarsi l’uno con l’altro e a non lasciare
nessuno spazio per una riflessione eccedente rispetto alle attese.
Non posso fare a meno di pensare - e questo l’ho scritto nel saggio
breve “Il dito e la luna”1 - che i grandi pensatori del ‘900 in questa
Accademia non ci si sono molto trovati. Penso agli appunti che la
Arendt ci ha lasciato del suo momento di incontro con l’Università
americana; in una lettera a Mary McCarthy scrive che non crede che
quello che vede sia vero: persone pagate per farsi i fatti loro, per
raccontarsi delle storie che non interessano a nessuno, se non a loro
stessi, e soprattutto, la preoccupazione della Arendt era quella di
vedere persone che non dimostrano nessuna attitudine alla
comprensione della realtà politica e pubblica della filosofia.
Questo modo di pensare, tipico della mentalità accademica, nuoce
tantissimo all’idea che più in generale si ha della filosofia. Quello che
in sostanza rimprovero all’Accademia non e di interrogarsi sul
pensiero astratto: non c’e niente di male nell’occuparsi di questioni
che riguardano la vita teoretica, di questioni che hanno a che fare con
quello che facciamo quando pensiamo, sono questioni evidentemente
molto importanti anche per la stessa conservazione della tradizione
filosofica; il problema e che come ci si accorge della differenza
1
M. Trentadue (2008), Quaderni di Finis Terrae, vol. II, pp. 11
sussistente tra le mele le arance, cosi ci si dovrebbe accorgere della
differenza sussistente fra la filosofia accademica e ciò che forse
potremmo considerare semplicemente filosofia, anche se non siamo
abituati a farlo.
Noi aspettiamo che l’Accademia ci confermi nell’approcciò conoscitivo,
aspettiamo che l’Accademia ci dia un alloro definitivo e poi la
consideriamo una termine di riferimento assoluto.
In realtà la storia della filosofia stessa dimostra e racconta una cosa
molto importante: tutti i più grandi pensatori contemporanei non
sono mai stati accademici.
Questo e un dato di realtà sul quale si può ragionare.
Se guardo a cosa la filosofia contemporanea ci ha dato, non posso
non osservare che i grandi pensatori ai quali io faccio riferimento,
che considero dei maestri per la mia vita, non sono transitati se non
in rare occasioni e in momenti molto specifici, attraverso le porte
dell’Accademia.
Insisto: questo qualcosa vorrà dire, e a me dice una cosa molto
importante. In realtà la filosofia accademica e insostituibile per la
conservazione del sapere, e un’istituzione straordinariamente
importante per i fini formativi ma pensare che essa possa assumere
dei ruoli pubblici o che possa fungere da guida in momenti cupi come
questi, ad esempio, io penso francamente che sia un grosso errore.
E per questo io penso esista un altro modo di guardare alla filosofia
che non e interessato unicamente alla storia del sapere filosofico cosi
come si e concretamente e oggettivamente costruito nel suo snodarsi
attraverso i secoli. Questa conoscenza di base della storia del pensiero
e un punto di partenza, non un punto di arrivo. L’Accademia in realtà
con il suo modo di impostare la formazione, crea anche una
confusione rispetto a ciò che la filosofia è.
Questo modo di pensare che il passato sovrasti il pensiero moderno, il
pensiero nella sua effervescenza brulicante, nella sua activitas
agostiniana, e un modo in fondo molto limitante rispetto all’attività
del pensare.
Infatti Nietzsche, che a questo aveva molto pensato, fa notare che lo
studio della storia e quindi anche della storia della filosofia, ha un
effetto limitante rispetto all’emergere del nuovo perché lo fa
precipitare in un’aura, in un alone retrospettivo, nel quale tutto quello
che viene configurandosi come pensiero nuovo o atto nuovo, sembra
portarsi dietro un’ombra di già visto, già detto, già pensato e, che
rischia di far perdere l’entusiasmo per quanto di nuovo gli uomini
possono portare sotto il sole.
In realtà, si può guardare alla filosofia con un interesse diverso,
soprattutto se si parte da un punto di vista diverso.
Il punto di vista diverso secondo me, dovrebbe essere quello di
trattare il pensiero come una forma viva.
Il pensare non ha bisogno di essere museificato. Il pensiero non ha
bisogno di essere autocelebrato e in quanto tale essere acquisito come
termine artificiale, perché il pensiero pensato, subisce in questo
modo, una specie di trasformazione in artefatto.
Se ci pensi, secondo me esiste un modo diverso di pensare alla
filosofia: partire da quello che hanno detto questi grandi pensatori
significa prepararsi a levare le ancore; partire significa farsi uno scafo
e poi andare in mare aperto, altrimenti si continua a stare sulla soglia
e non si naviga mai. Penso che la filosofia debba fronteggiare delle
sfide importantissime, io credo che la contemporaneità ponga dei
problemi enormi alla filosofia, che apparentemente, se considerata
solo come meramente accademica, non e in grado di fronteggiare, in
quanto pone se stessa come luogo del sapere acquisito.
EVA - L’Accademia non pensa?
MAURO - Non so se non pensi, ma sembra muoversi dalla posizione
del sapere acquisito, pertanto nel reale non si specchia, il reale la
preoccupa.
Da qui il divorzio tra filosofia e politica, tra filosofia e realtà che ha
caratterizzato tanta parte del ‘900.
A me piace pensare che l’Accademia da una parte si possa
smuovere cioè sentire l’appello che parte dal presente.
Esaminiamo delle questioni molto urgenti, come quelle della bioetica:
sono molto deluso dal fatto che l’Accademia non sappia elaborare,
non si pronunci rispetto a questioni importantissime che sono
questioni che interrogano la filosofia. Dal reale partono degli appelli
verso la filosofia ma, da questa partono alcune voci in ordine sparso e
in questo modo si cade nell’equivoco opposto: non e che qualsiasi
gracidio di rana nel pantano possa essere considerato filosofia.
Di fronte a certe questioni che vengono poste dall’effervescenza del
quotidiano, la filosofia corre il rischio di essere tagliata fuori.
Io raccomando di ascoltare le domande che partono dalla realtà
perché se la filosofia pensa di essere un sapere professionale legato a
contenuti acquisiti una volta per tutte, diventa una sorta di tecnica,
come fosse una storia della letteratura che si può solo spiegare come
uno scioglilingua.
L’insegnamento della filosofia e importante, perché altrimenti non
emergono nuove generazioni di pensatori, si arena tutto, ma
l’equivoco dal quale vorrei che ci guardassimo e considerare che la
filosofia sia solo questo.
Se tu guardi la scena della filosofia contemporanea, in particolare in
Italia, siamo davanti ad uno scenario di una povertà agghiacciante.
La mia preoccupazione e che l’appello che parte dalla realtà in questo
momento debba essere ascoltato. Per questo dico che e necessario
pensare ad una filosofia di nuova specie. Lo penso veramente. La
filosofia di nuova specie deve partire dal passato per costruire il
presente.
Per questo e necessario confrontarsi con pensieri non cosi acquisiti,
non cosi cesellati, consegnati alla tradizione. Perché il dramma della
tradizione e che arriva dopo, quindi sistematizza il già pensato. E
questo e un passo indietro. Come giustamente dice Hegel, la filosofia
finisce per essere come la famosa nottola di Minerva perché si leva
solo sul far del tramonto: però attenzione, perché poi questo tramonto
arriva veramente.
Ne “Il dito e la luna” auspico una nuova generazione di pensatori che
sappiano guardare alla realtà mai unicamente per prenderne le
distanze, ma per potervisi tuffare. Scrivo anche che auspico ci siano
nuovi pensatori che nonostante la loro collocazione professionale,
magari ambigua, incerta, provocatoria, sappiano cogliere la novità che
c’e e cerchino di costruire spazi nuovi.
Inutile pensare di trovare una stanza in una casa che già c’e: si può
costruire una casa nuova. E la casa nuova che io penso, e anche fatta
con materiali nuovi, con pensieri nuovi. Per questo mi sento attratto
da pensatori, pensatrici che non hanno mai avuto una collocazione
tradizionale acquisita.
Magari oggi ce l’hanno, ma quando hanno scritto e pensato,
raramente si sono trovati nella casa della filosofia.
EVA - Mi verrebbe da dire che la filosofia che ora noi abbiamo non sia
veramente un pensare, e forse un acquisire conoscenza della storia
della filosofia, cosa sicuramente importante e necessaria, e la nostra
ricchezza. Ma c’e poi il pensiero? Si riflette sui filosofi? In modo non
solo storico? Non credo che la filosofia venga applicata alla vita,
all’esistenza.
MAURO - Di ottimi storici della filosofia non possiamo fare a meno,
però ne siamo pieni. C’e un equivoco molto importante riguardo alla
filosofia.
Eva - Ma scusa, in realtà questa nuova filosofia che tu auspichi e
forse la filosofia esattamente come e nata. E’ un ritornare a quello
che era veramente la filosofia, cosa che forse si e un po’ persa o,
meglio, e stata un po’ abbandonata.
MAURO - Si questo e paradossale. La filosofia e nata come un porsi
delle domande rispetto a tutto ciò che ci circonda. Sono domande che
ciascuno continua a farsi, ma spesso trova anche dei modi distorti
per non farsi più, per disfarsene.
Tornando a “Il dito e la luna”, Platone dice che la filosofia nasce come
uno stupore - θαῦμα - Platone usa il verbo θαυμαζω, “mi stupisco”.
Questo stupore e per Platone, il padre per del sapere filosofico.
C’e sicuramente una parte del pensiero che nasce dallo stupore di
fronte alle cose, stupore rispetto allo stacco che si ha dinnanzi ad
una cosa sorprendente: il mondo. Oppure si puo pensare come ho
scritto ne “Il dito e la luna”, che la filosofia sia espressione di una
irrequietezza molto umana.
La filosofia, qualsiasi cosa sia, bisognerebbe che tenesse vivo il suo
legame con l’umana irrequietezza che e una dimensione molto
vitalmente importante, oserei dire che e, dal mio punto di vista,
insieme alla coscienza - forse perché parte della coscienza - la
dimensione più interessante dell’essere umano. Perché l’irrequietezza
e quella incapacità di aderire al dato che fa si che ci si stacchi
rispetto a ciò che si ha davanti e si ricerchi qualcosa di nuovo.
L’irrequietezza non e solo una dimensione di inappagamento, e anche
una dimensione legata al desiderio: si può desiderare solo ciò che non
si ha evidentemente o ciò che non si e, perché altrimenti lo si ha o lo
si e non lo si desidera più, come molto bene ha spiegato Hegel.
Per avvicinarsi alla dimensione dell’irrequietezza in realtà io scelgo
però un’altra strada, quella percorsa da un outsider della filosofia:
Bruce Chatwin.
Molto più noto per i suoi viaggi che per i suoi pensieri.
Chatwin si e interessato tutta la vita all’ alternativa nomade; nomade
e colui che non ha fatto una scelta stanziale, che non si e legato agli
oggetti, rappresentando un’ alternativa radicale di pensiero e di
esistenza rispetto al mondo. Un’ alternativa senza compromesso: da
una parte c’e l’agricoltura che obbliga al possesso, all’obbligatorietà
del rimanere e dall’altra c’e il nomade che viaggia felice con i suoi
animali.
Chatwin rilegge la storia di Caino e Abele: Caino e l’agricoltore e
Abele e il nomade. La storia di Caino e Abele diventa per Chatwin un
ottimo modo per spiegare come la storia della civiltà sia sorta da un
assassinio: l’assassinio di Abele, il quale non aveva bisogno di essere
cattivo, insoddisfatto e infelice perché poteva sempre prendere ed
andare da un’altra parte, non essendo legato a niente.
Questo fatto di non avere un legame con le cose tanto vincolante da
trasformarsi in un obbligo costrittivo per la vita e per la sorgività del
nuovo, dunque la possibilità di considerare diversamente il possesso,
rende possibile pensare ad una alternativa sussistente: una vita
molto più frugale, molto più pensata, molto più cerebrale, molto meno
legata alla ripetitività del rituale, alla ripetitività del gesto e cosi,
probabilmente, una vita più felice.
Devo interrogare un outsider del pensiero, che mi mostri la
dimensione positiva dell’irrequietezza, per riuscire ad avere una
risposta interessante rispetto ad una questione che e sotto agli occhi
di tutti oggi.
Posso interrogare Kant, Hegel e trovarli storicamente importanti, ma
di fronte al problema della felicità dell’uomo nel mondo, devo ritornare
a Epicuro, o posso parlare dell’Esistenzialismo che e uno degli altri
miei pilastri filosofici irrinunciabili.
Ma sono tuttavia avvilito di fronte all’incapacità che l’Accademia ha di
pensare alle cose che le persone sentono come un loro problema:
come posso essere felice qui ed ora?
Perché non si può pensare ex novo a questa dimensione? Se non si
riesce a farlo perché allora non appoggiarsi a chi l’ha fatto?
L’Accademia non riesce a farlo.
Paradossalmente devo assistere ad una filosofia che si arrocca
quando li davanti agli occhi - basterebbe aprirli - ha un sacco di
persone che sarebbero interessate alle cose che potrebbe dire, solo se
scendesse dal piedistallo sul quale si e abituata a vedere le cose.
E’ orribilmente avvilente vedere che la filosofia ha perso la
dimensione più importante per la sua sopravvivenza.
Noi guardiamo solo alla storia della tradizione, come se da li
dovessero arrivare tutte le risposte. Rispetto alla vita quotidiana le
risposte alle domande che sorgono, solo in parte si trovano nel
pensiero già pensato.
Perché non si può assumere un punto di vista che attinga
direttamente al pensiero? Invece, quando sento parlare Singer, ad
esempio, mi trovo davanti ad un pensatore che certe cose le pensa, ha
il coraggio di dirle e di portarle alle logiche conseguenze.
E’ brutto che la filosofia viva in una sorta di lascito testamentario
auto-indotto soprattutto se lo scopo e quello di preservare il proprio
pensiero perché e l’unica cosa che rimarrà, per come la vedo io in una
logica laica e antitrascendente, dato non credo ci sia una vita dopo la
morte. E’ quindi molto importante quello che si fa qui e ora, anzi ha
un’ importanza decisiva. La filosofia dovrebbe uscire da questa idea
auto-indotta di essere una sorta di esecutrice testamentaria, come se
non ci fosse nulla di nuovo sotto al sole.
Mi e capitato di recente di rileggere l’ultimo scritto di Maria Zambrano
che e datato 1990, da una donna di più di ottanta anni: “Peligros de
la paz” , di fronte alla Guerra del Golfo Persico.
Maria Zambrano, straordinariamente, parla di questa necessita di
vivere nella pace e dice cose che potrebbero essere scritte oggi, per il
nostro presente, testimoniando un’incredibile vocazione
all’interrogazione del presente. Una donna prossima alla morte che ha
vissuto una vita pazzesca, caratterizzata da catastrofi epocali, non ha
perso l’interesse per il reale. Le ultime parole di Maria Zambrano sono
state orientate ad un presente che la terrorizzava e alla speranza di
un futuro aperto.
La pace e in pericolo, e in pericolo non solo il Golfo Persico, e in
pericolo un modo di pensare la vita. E dove erano, mi chiedo, tutti gli
altri grandi filosofi nel 1990? Dormivano? Facevano lezione
all’Università? E l’una cosa impedisce l’altra? Qualcuno mi dovrebbe
rispondere a questo.
Eva - Mi sovviene una riflessione ascoltando le tue parole: il filosofo
dovrebbe diventare in un certo senso nomade, abbandonare quello
che e il suo possesso, il suo sapere, quello che ha studiato, metterlo
da parte, forse non abbandonarlo del tutto.
Mauro - Metterlo nello zaino.
Eva - E poi diventare nomade nel pensiero, nel ricercare, nel vivere.
Mauro - Infatti ho voluto essere un po’ saccente quando ho dato
questo titolo : “Il dito e la luna”. Ci sono delle persone che si
soffermano a guardare il dito della mano invece della luna. In realtà
non riesco ad essere benevolo verso le persone che non sanno essere
nomadi. Nomadi col pensiero prima che con le cose, perché si fa
presto ad essere nomadi con le cose, si adotta un punto di vista
essenziale, minimale rispetto alle proprie condotte esistenziali e ci si
dedica alle cose importanti, ma, rispetto al pensiero, si fa più fatica,
ma e esattamente quello che dico, quindi tu hai colto molto bene il
senso delle cose che stavo dicendo.
Io ho dei maestri che mi hanno illuminato la strada. Ricordo ancora la
prima volta che ho letto delle riflessioni di Simone de Beauvoir; io
sono arrivato all’Esistenzialismo più attraverso Simone de Beauvoir
che attraverso Sartre: può sembrare paradossale però
l’Esistenzialismo di Simone de Beauvoir mi ha veramente aperto gli
occhi. Ero molto giovane, avevo poco più di vent’anni quando ho letto
di questa donna che ha capito che la vita terrena era tutto quello che
c’era, visto che “il vuoto del cielo disarma la collera”, la cito
testualmente. E’ incommentabile.
Se credessi in Dio potrei finire per prendermela con lui, invece
siccome sono troppo appassionato all’esistenza, come spiega Simone
de Beauvoir, non mi sfiora neanche il problema. Da una parte
continuo a pensare che siamo estremamente complessi come esseri
biologici, come esseri organici e questa complessità allude ad una
causalità. Qui c’e il piccolo scolastico che vive in ciascuno di noi;
però poi mi fermo e mi ricordo che questo e il migliore esempio di un
ragionamento antropico; siamo il frutto di un’evoluzione
plurimillenaria, diamo il tempo al tempo, non vediamo mai tutti i
sentieri interrotti. Peraltro, se anche la prospettiva teologica fosse
interessante - non lo e per me, ma se anche lo fosse - proviamo ad
ammettere che esista Dio: non riesco a pensare un Dio onnipotente.
Se io penso al fatto che tutto ciò che e sulla terra e effimero, allora, mi
dico, la paghiamo cara l’esistenza: per splendere qui qualche anno,
dobbiamo assumere la nostra mortalità pesantemente. Il confronto
con la caducità dell’esistenza e un confronto importante nel momento
in cui io mi rapporto con una prospettiva teologica.
Ed e chiaro che nel medioevo credevano molto di più: se tu hai una
vita media di vent’anni, non puoi che sperare in quella che verrà
perché quella che c’e qua, non ti accorgi neanche di averla.
Oggi, in una dimensione leggermente diversa, ci confrontiamo con la
mortalità in modo differente, probabilmente dovremmo trarre delle
conseguenze che non traiamo, ma per quanto mi riguarda la scoperta
della giovane Simone de Beauvoir che riusciva a mettere le radici nel
mondo nonostante non credesse in Dio, mi ha aperto un mondo; mi
sono detto: non sono solo.
I filosofi non parlano mai di loro stessi, ti propongono i loro pensieri
come già pensati, come fossero usciti dalla testa di Atena. La prima
cosa che fa Simone de Beauvoir e parlare di se, questo te l’avvicina
moltissimo e questo che dico, che ci sarebbe bisogno di pensare ad un
modo nuovo di pensare alla filosofia. Lo fa anche Sartre però lui e
sostato nella prossimità del mondo della filosofia. Lui non e stato
assolutamente accademico e ha risolto la sua filosofia nell’azione
pratica. Infatti e bello vederlo già anzianotto che con un microfono
parla sulle barricate del ’68 di Parigi.
Dalla realtà vengono fuori degli stimoli, la filosofia, i filosofi, che come
tutti gli esseri umani hanno bisogni materiali, non sono delle teste
che gironzolano senza corpo, sono come tutti gli altri e vivendo come
tutti gli altri possono fare delle cose come le fanno tutti gli altri,
dovrebbero confrontarsi con dei problemi terreni e trovare li delle
risposte.
Per questo io continuo a pensare che sia un grosso peccato che la
filosofia non riesca a fare questo passo verso l’essere umano.
Non so se ho risposto alla tua domanda, ho parlato di Chatwin , come
non riesco a non parlare di tutti i pensatori che mi hanno dato e detto
qualcosa, faccio fatica solo a costruire un ordine di priorità, perché li
ho incontrati in momenti diversi; sono pensatori, uomini e donne che
non hanno messo al centro dei loro interessi solo le pure esperienze di
pensiero, perché alla fine questo, lo trovo anche irritante.
Per questo motivo non riesco più ad appassionarmi per un filosofo
che dice solo cose da filosofo.
Mentre mi appassiono quando si parla di questioni che riguardano
problemi immanenti: come posso essere felice, cosa devo fare per
essere felice, cosa non devo fare per essere felice, quali sono le cose
concrete che devo fare per essere buono, giusto. In questo credo
fermamente: nell’insuperabilità della questione socratica, che poi e
anche una questione molto arendtiana, dello stare bene con se stessi.
Si può essere felici quando si sta bene con se stessi, quando si e in
armonia con se stessi, quando, io dico sempre, riesco a guardarmi
allo specchio e riesco a riconoscermi fino in fondo; questa e poi la
questione socratica per eccellenza, cioè il famoso daimon: l’altro se, e
il te che tu devi in qualche modo riconoscere. Non riesci a stare bene,
se non riesci a riconoscerti e non riesci a riconoscerti, quindi a stare
bene, se non riesci a comportarti conseguentemente rispetto a delle
questioni importantissime, vitali, come non compiere il male.
Non puoi stare bene sapendo che il tuo benessere si fonda sul
malessere altrui, e impensabile.
Dal mio punto di vista, ad esempio, la solitudine esistenziale del capo
d’industria e una condizione ovvia, una logica conseguenza del ruolo
che si e scelto. Se il tuo benessere economico si realizza a partire
dalla sottrazione di ciò che spetterebbe ad altri e evidente che non
puoi essere felice, se non per cose materiali. Riuscirai ad essere felice
solo nel momento in cui riuscirai ad essere funzionale rispetto ai tuoi
bisogni ipertrofici. Tu baratti la felicità con il possesso.
Eva - E qui posso collegare la domanda che volevo farti riguardo a
Chatwin: Chatwin lascia perdere ciò che e materiale, in questo modo
forse trova se stesso, quindi in realtà ha qualcosa, cioè ha se stesso.
Posso essere felice se invece di avere cose, avere situazioni, se lasciò
da parte i ruoli, in fondo anche i ruoli sono cose, no?
Mauro - Il ruolo e quasi come una cosa, e la fatticità agognata ma
impossibile. La coscienza mi impedisce di fare tutt’uno con me stesso
al modo delle cose.
Eva - Se riesco a mettere da parte tutto questo o almeno un po’, e
divento in un certo senso nomade, io trovo me, me stessa e questo e
forse quello che dicevi tu parlando di Socrate. Trovando me stessa,
trovo la felicità o anche solo la serenità che poi a volte vale anche più
della felicità, secondo me.
Mauro - Sono assolutamente d’accordo.
Certo trovi te stesso. Certo. Nello zaino di Bruce Chatwin
evidentemente ci sono tantissime riflessioni, lui di queste riflessioni
ha sicuramente lasciato traccia nei suoi libri: sull’autosufficienza del
possesso Chatwin secondo me ha detto delle cose definitive che non
possono essere ignorate, tralasciate. Sull’autosufficienza del possesso,
che ovviamente non c’e, non esiste, e quindi sulla relazione che
sussiste tra il possesso e il benessere.
L’ultimo libro di Chatwin “Utz”. E’ un libro che consiglio a tutti di
leggere, e un libro fulminante perché racconta proprio l’impossibilita
di questo protagonista, tutto legato alla sfera del possesso, di essere
felice.
Lo racconto brevemente: Utz e un collezionista di porcellane Meissen.
Chatwin l’ha scritto quando ormai era molto malato, dunque
perfettamente consapevole che sarebbe stato l’ultimo libro, questo lo
dico perché secondo me, le ultime cose che scrivi hanno molta
importanza, per uno che ha fatto di professione lo scrittore.
“Utz” e un libro molto breve, una storia bellissima con una morale
evidente, secondo me, un libro da leggere e rileggere diverse volte. Lo
leggi per la storia, per il suo contenuto, perché e scritto in perfetto
stile Chatwin: la forma e lessicamente essenziale, ma stupefacente.
Infatti oggi, paradossalmente, Chatwin e molto studiato nelle
Università americane per lo stile, per il suo lessico minimale e al
contempo perfetto.
Utz e un collezionista di porcellane Meissen, abita nella repubblica
Cecoslovacca, e di famiglia nobile, e ricco; con l’avvento del regime
comunista perde i titoli nobiliari e si ritrova a vivere a Praga in un
bilocale con la sua fida domestica e in compagnia delle sue amate
porcellane, che per lui sono rappresentazioni di vita. Lui ama il
colore delle porcellane, ama le loro posizioni, ama la loro eternità.
Ama il fatto che mentre la vita si corrompe le porcellane rimangono.
Mentre l’uomo invecchia, la donna invecchia, la porcellana rimane
nella sua fattezza perfetta.
Ciò qualifica Utz come il perfetto collezionista. Apro e chiudo una
parentesi: Chatwin ha lavorato da Sotheby’s in gioventù, quindi
sapeva benissimo cosa significa collezionare, chi e il collezionista e
quindi ha messo in scena nel suo ultimo atto, nel suo ultimo libro,
una cosa che conosceva benissimo: la patologia dell’avere.
Collezionare significa non solo possedere, ma possedere una serie di
cose simili che si chiama collezione. Porcellane, quelle di Utz, che
hanno una loro finezza, ma anche un loro colore, eternate nelle loro
movenze, nelle loro fattezze specifiche, delle loro peculiarità, imitano
la vita ma sono perfette, cosa che la vita non potrà mai essere. Sono
sottratte all’essere effimero che e caratteristica tipica dell’essere
umano. Utz però non e contento ne felice. Perché lui, in questa
contemplazione delle porcellane, ne desidera sempre di nuove. Ha una
parte della collezione nascosta nei sotterranei di una banca in
Svizzera e più volte nell’anno vi si reca.
Quando e a Praga sente la nostalgia dei pezzi che sono al chiuso delle
banche elvetiche, quando e in Svizzera a contemplare i suoi pezzi
nascosti - la sua seconda collezione - gli mancano i pezzi di Praga.
Per cui evidentemente vive scisso tra questi due amori che non
potranno mai essere messi insieme, quindi e il collezionista, ha il
pathos di un avere certamente non frugale, anzi; ma non e felice.
Della vita privata di Utz il romanzo ne parla pochissimo, salvo che
poi si scopre che Kaspar Utz ha sposato la domestica per avere la
possibilità di mantenere il suo bilocale; altrimenti, essendo scapolo, il
regime socialista lo avrebbe obbligato a transitare in un appartamento
più piccolo, cosa drammatica e insostenibile per lui, perché avrebbe
dovuto trovare una collocazione diversa per le sue porcellane.
Perché racconto tutto questo? Perché nel momento in cui Utz si
avvicina alla propria fine, dal momento in cui lo Stato, gli ha
permesso di possedere la sua collezione dietro alla rassicurazione
certificata, messa per iscritto, che dopo la sua morte le porcellane
sarebbero passate nelle mani dello stato cecoslovacco, vive una
grande ansia e distrugge tutte le statuette.
Ho raccontato la trama perché credo sia illuminante ed
autosufficiente ma un commento che vorrei fare e questo: credo che
sia l’ultima parola rispetto all’autosufficienza del possesso. Utz non e
mai felice: non e felice nel collezionare perché non possiede mai a
sufficienza, tanto che vuole arricchire la sua collezione sempre, e
questa, e in estrema sintesi il cuore, dell’essenza del possesso: voler
avere sempre di più.
Il testo di Chatwin contemporaneamente e la condanna di chi si lega
esageratamente alle istanze dell’avere, e un viatico - filosoficamente
parlando - per chiunque voglia pensare a che cosa significhi
possedere, avere e, rappresenta un pilastro secondo me, di uno stile
di pensiero: non e necessario scrivere un trattato, per parlare di una
precisa visione del mondo, basta scrivere un romanzo. Chatwin si e
sempre molto attenuto ad una diffidenza strutturale nei confronti del
possesso. Ha posseduto pochissime cose nella sua vita, avendo
lavorato da Sotheby’s avrebbe potuto accatastare, possedere una
grandissima quantità di oggetti, cosa che invece non ha fatto, le sue
cose essenziali erano poche.
Quindi, paradossalmente, chi e vissuto nell’ambiente del
collezionismo, ha scritto il suo ultimo romanzo sull’ insufficienza del
possesso, sul legame impossibile tra possesso e felicità. Chatwin
avrebbe potuto ammonticchiare cose, ma non l’ha fatto, ha sempre
vissuto in posti precari, molto piccoli, quando e riuscito ad avere un
appartamentino suo nel centro di Londra, era essenziale. Lo stile di
Chatwin e considerato in architettura e in storia del design, uno stile
minimale.
Il suo zaino era la ricerca; quindi rispondendo alla tua domanda, nello
zaino e importante mettere poche cose, quelle giuste, e sapere che lo
arricchirai strada facendo. Non partire con lo zaino già pieno perché
ti appesantisce e sai che strada facendo potrai trovare nuove cose da
portare con te.
Eva - Grazie Mauro, non mi resta che aspettare, sperò ancora per
poco, di leggere il tuo libro su Chatwin.