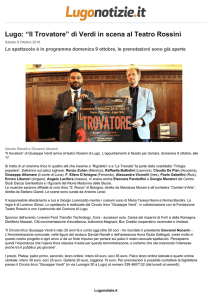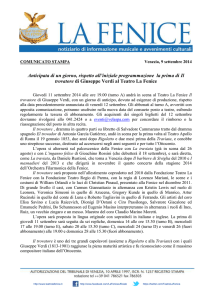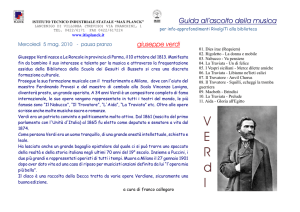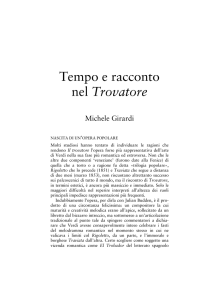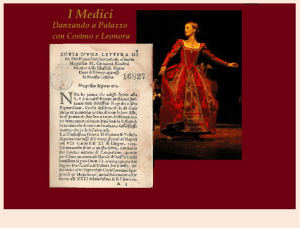Paolo Gallarati
Lettura del Trovatore
LIBRERIA STAMPATORI
TORINO
1
In copertina:
Giorgio de Chirico, Trovatore, 1938
olio su tela
Roma, Fondazione Giorgio e Isa de Chirico
Lettura del Trovatore
© Paolo Gallarati, 2002
Edizioni Libreria Stampatori,
via S. Ottavio 15
10124 Torino
E-mail: [email protected]
ISBN 88-88057-23-4
2
Indice
Premessa
Elementi di drammaturgia musicale
p.
7
Capitolo primo
La genesi del Trovatore
p.
19
Capitolo secondo
Atto primo (Parte prima: Il duello)
p.
39
Capitolo terzo
Atto secondo (Parte seconda: La gitana)
p.
63
Capitolo quarto
Atto terzo (Parte terza: Il figlio della zingara)
p.
99
Capitolo quinto
Atto quarto (Parte quarta: Il supplizio)
p. 121
3
Premessa
Elementi di drammaturgia musicale
Questa parte monografica del corso di Istituzioni di storia della musica,
ha lo scopo d’illustrare alcuni meccanismi fondamentali che regolano il
funzionamento della drammaturgia musicale e mostrare, dunque, la specificità
del melodramma, che possiede alcune caratteristiche parzialmente affini e altre
molto diverse da quelle del teatro parlato, non senza realizzare, in alcuni casi,
effetti di sinestesia e d’articolazione spazio-temporale simili a quelli del
cinematografo. Vi sono, nell’opera, molte convenzioni che costituiscono
indubbiamente un ostacolo ad un approccio immediato: ma ogni forma di
spettacolo ha le sue convenzioni (nella tragedia greca, ad esempio, esse non
sono meno imperiose di quanto non lo siano nel melodramma) che, una volta
comprese e accettate, non disturbano più e permettono al fruitore di recepire il
messaggio in tutta la complessità della sua natura.
Si potrebbe dire, approssimativamente, che, se il teatro di parola è un
teatro delle idee, quello musicale è un teatro delle passioni. Naturalmente,
questa definizione non va presa in senso assoluto, perché anche il teatro delle
idee esprime sentimenti e passioni e, attraverso la musica del melodramma,
filtrano idee e concetti. Però, l’oggetto principale della rappresentazione è da
una parte, appunto, un fatto razionale, dall’altra, emotivo, perché i mezzi
principali di cui si servono i due generi di rappresentazione drammatica sono,
da un lato la parola, capace di esprimere significati precisi, dall’altro la musica
che, anche sposata ad un testo, non perde mai il suo tasso d’ambiguità e la sua
polivalenza espressiva, e si pone come strumento ideale per evocare ciò che
sfugge al controllo della ragione, e appartiene al flusso metarazionale di
emozioni, sentimenti, passioni, vita psicologica cosciente e subcosciente. La
musica, come s’è detto, non esprime nulla di preciso. Non si può tradurre
esattamente in suoni l’affermazione «il sole splende». Però si possono
esprimere la sensazione esterna di luce e calore; il sentimento che quella
condizione ambientale suscita nei personaggi, che può variare da un semplice
senso di benessere ad una panica esaltazione, al fastidio della calura e
dell’accecamento.
L’opera è formata dall’incontro fra la musica e il testo, chiamato
«libretto» dall’antica usanza di distribuire agli spettatori un librino tascabile su
4
cui è stampato il poema drammatico. L’elaborazione musicale del testo si attua
attraverso due elementi: il canto e l’orchestra. Testo, canto e orchestra hanno
ciascuno una vita espressiva autonoma, e dall’incontro di questa triplice
espressività nasce la drammaturgia musicale.
Nel teatro recitato l’attore può variare il significato delle parole
attraverso l’intonazione della recitazione. Nell’opera questa possibilità è
enormemente potenziata perché la varietà delle melodie che si possono
applicare ad una frase verbale, ad una battuta, non ha limiti. Inoltre, il canto e
l’orchestra, indipendentemente l’uno dall’altra, possono, di volta in volta,
confermare, esaltare ma anche ignorare o, addirittura, contraddire il significato
delle parole.
Immaginiamo che, in una scena d’opera, un personaggio faccia ad un
altro una dichiarazione d’amore. Le soluzioni musicali possibili sono diverse.
Per esempio, il cantante può lanciarsi in una bella melodia affettuosa, piana,
liscia; l’orchestra la sostiene, le dà risalto, l’avvolge di timbri chiari, dolci,
morbidi. Ci sarà dunque un accordo tra il significato del testo, l’intonazione
espressiva del canto e quella dell’orchestra. Ma se, sotto quel canto lirico,
dolce, appassionato, l’orchestra scandisce, ad esempio, una pulsazione sinistra,
come un rintocco funebre, l’espressione cambia completamente e può
significare che la serenità di quell’a-more è minacciata da un presentimento
inquietante. Facciamo un altro esempio, sempre riferito alla stessa
dichiarazione d’amore; il canto, invece di essere piano, liscio, melodico, è
tormentato e contorto, ci sono degli intervalli che esprimono un senso di sforzo
innaturale; alle parole, la musica aggiunge un imprevisto senso d’insicurezza,
insinuando il dubbio che quell’amore sia tormentato in partenza, e alterando
completamente il significato letterale del testo. Oppure, sempre sulle stesse
parole, il cantante può assumere, perché no, toni grotteschi, enfatici, comici:
vorrà dire che finge, magari per far capire ad un terzo personaggio che ascolta,
o al pubblico presente in sala, che questa dichiarazione d’amore è un inganno,
o una burla scherzosa. L’opera richiede, dunque, un ascolto molto selettivo,
attento ai dislivelli espressivi creati dalla musica rispetto al testo verbale e
capace di cogliere ciò che il canto aggiunge al testo e l’orchestra al canto, nella
continua interferenza dei tre canali di comunicazione.
Consideriamo, ad esempio, il preludio strumentale che apre l’ultimo
atto del Don Carlo di Verdi, dove la protagonista, Elisabetta, disperata per il
suo amore impossibile, giunge presso la tomba di Carlo V, a pregare. Il
preludio rappresenta due situazioni contrastanti: c’è dapprima un corale
d’ottoni, molto pesante e cupo: è la rappresentazione musicale del sepolcreto.
Questo corale è però spezzato da incandescenti ventate degli archi che salgono
come grida di dolore e di passione, due, tre volte, s’innalzano, poi si ripiegano,
come spossate: è la rappresentazione del dramma che lacera l’animo di
5
Elisabetta, mentre entra in quel luogo funebre. Quindi la musica rende
tangibile il rapporto tra individuo e ambiente, esaltandone reciprocamente la
forza espressiva. Nell’a-ria che segue, il canto svolge questo conflitto tra
desolazione, paura e aspirazione all’amore impossibile.
Talvolta l’orchestra assume un andamento così indipendente dal canto
che sembra commentare le situazioni drammatiche, facendole vedere, in un
certo senso, «dall’esterno». Questo ha permesso d’individuare, nel suo
comportamento, la voce dell’au-tore, la presenza dell’io narrante che permette
di assimilare l’opera ad un racconto, secondo il titolo di un libro sulla
semiotica del melodramma1; un racconto in cui il musicista commenta i fatti,
collega i dialoghi, entra come interlocutore tra i personaggi. C’è, dunque,
nell’opera una componente narrativa inesistente nel teatro di prosa, dove
manca una voce esterna che osserva gli avvenimenti, mettendo in prospettiva
la realtà drammatica e presentandola sotto un’imprevedibile molteplicità di
apparenze.
Questo gioco d’interferenza tra significato del testo, espressione del
canto ed espressione dell’orchestra determina, dentro l’opera, una serie di
prospettive drammaturgiche specifiche. Per esempio, la musica può creare
degli effetti d’avvicinamento e allontanamento dagli eventi rappresentati,
analoghi ai mutamenti d’inquadratura utilizzati nel cinematografo quando si
passa dal primo piano alla visione totale.
Si veda l’ultimo atto della Traviata. Violetta, mortalmente malata, è
nella sua camera da letto, dopo quella che rimarrà l’ultima notte della sua vita.
La donna è ormai esangue, priva di forze. La musica scava nei suoi sentimenti
con estrema delicatezza e profonda intimità, rappresenta il suo stato fisico con
un suono diafano, quasi spettrale, mentre l’attenzione del teatro buio converge
su di lei, ingigantita in un primo piano tra i pochi oggetti – il letto, il comodino
da notte, il bicchiere d’acqua, lo specchio – che arredano l’ambiente,
musicalmente saturo di sofferenza e di dolore. Quando però Violetta, nel primo
atto, era comparsa in una festa dove gli invitati intrecciavano danze,
chiacchierando fra loro, e cantando con il coro in sonorità squillanti,
l’inquadratura musicale si era ampliata a comprendere il totale del
palcoscenico. Ma, improvvisamente, in una scena di questo tipo, può emergere
la voce di un personaggio che cova un pensiero segreto, un dramma interiore,
qualcosa da nascondere tra la gente che lo circonda (si pensi alla scena finale
di Un ballo in maschera); basta una frase musicale, una linea di canto
autonoma che esca fuori di quella massa, un restringersi della sonorità a
dimensione cameristica perché noi, immediatamente, individuiamo, al centro
Cfr. L. ZOPPELLI, L’opera come racconto.Modi narrativi nel teatro musicale
dell’Ottocento, Venezia, Marsilio, 1994, pp. 11-24.
1
6
della folla, il singolo; e quindi percepiamo un effetto di primo piano all’interno
della totalità. Insomma, la musica, come una macchina da presa, «taglia»
l’inquadratura della scena con estrema libertà e varietà.
Lo spazio, infatti, può anche dilatarsi in misura impensabile quando, ad
esempio, il compositore piazza della musica fuori scena. Si pensi ad un corteo
che passa di lontano, accompagnato da una marcia; ad un personaggio che
canta dietro le quinte, oppure ad un temporale che avanza, e che la musica fa
vivere, al di là del palcoscenico, in echi e prospettive sonore: nella nostra
immaginazione «vediamo» attraverso i suoni uno spazio che si apre oltre il
fondale e si perde, virtualmente, all’infinito. Di questa stereofonia spaziale
troveremo un esempio superbo nella scena del «Miserere» nel Trovatore,
articolata sul rapporto fra tre fonti sonore: Eleonora, che canta la sua
disperazione in primo piano perché Manrico, condannato a morte, è
prigioniero in una torre ed è prossimo all’esecuzione capitale. Sul palcoscenico
c’è la torre da cui proviene il canto del tenore; fuori scena si sente un coro
maschile che prega per i condannati alla prossima esecuzione. Così, quando
Leonora canta guardiamo lei, poi la nostra attenzione si sposta sul coro fuori
scena dove immaginiamo spazi non rappresentati visivamente, indi rimbalza,
ancora, in cima alla torre da cui proviene il canto di Manrico. Le tre fonti
sonore, attivandosi in successione prima e in sovrapposizione poi, provocano lo
stesso effetto ottenuto dal cinema con il cambiamento d’inquadratura, la
contemporaneità d’immagini diverse, la dissolvenza incrociata.
Ma, oltre a questa modulazione dello spazio, la musica applicata al
teatro può anche operare una modulazione del tempo e far rivivere fatti,
sentimenti, passioni, presentando nuovamente dei motivi che sono già risuonati
in altre situazioni. Nel primo atto della Traviata, ad esempio, c’è un duetto tra
Alfredo e Violetta in cui, per la prima volta, Alfredo canta una dichiarazione
d’amore sincero, con una melodia famosissima e bellissima sulle parole «di
quell’amor ch’è palpito | dell’universo intero». Quando, nell’ultimo atto,
Violetta, ormai alla fine, legge una lettera in cui le si promette il sospirato
ritorno di Alfredo, in orchestra risuona il tema d’amore ascoltato all’inizio
dell’opera, ridestando un cumulo di memorie, dolcezze, sofferenze passate.
Questa melodia, resa spettrale da un’orchestra diafana, senza suono, ritorna,
ancora una volta, nel momento in cui Violetta muore, come se
l’accompagnasse nel trapasso con una sorta di viatico, d’estrema unzione.
Quindi il tempo passato ritorna presente attraverso la musica; il ricordo diventa
tangibile; l’esperienza si accumula nella coscienza e affiora come fatto
interiore, attraverso i temi, ricorrenti e deformati.
In tutta l’opera di Wagner, la tecnica dei motivi conduttori determina
simili interferenze della memoria. Ci sono temi che si presentano per la prima
volta in certe situazioni, e poi ritornano, deformati ma sempre riconoscibili, a
7
distanza di pagine e pagine di partitura. L’ascoltatore percepisce, così,
attraverso la musica, una trama psicologica che gli permette di cogliere la
complessità dell’esperienza interiore accumulatasi e trasformatasi nel tempo. I
personaggi, che hanno nel frattempo vissuto, rivivono il passato attraverso il
ritorno di certe figure musicali: si creano, così, dei cortocircuiti di grande
potenza espressiva, capaci di produrre forti scosse emotive. Una cosa è, infatti,
esprimere un ricordo a parole, un’altra riascoltare un tema capace di rendere
nuovamente presente un fatto, un’immagine, un personaggio in un contesto
drammatico del tutto diverso. Si crea, in tal modo, una compresenza di conscio
e inconscio, che la musica rende bruciante nella sua immediatezza.
Oltre a questa capacità di far rivivere il ricordo, la drammaturgia
musicale sfrutta, in modo molto evidente, la possibilità di concentrare o
dilatare il tempo. Può esserci, per esempio, una situazione di terrore collettivo:
i personaggi sono in pericolo e devono fuggire. Ma il momento viene dilatato
dalla musica: tutto si blocca in una di quelle situazioni sovente derise da chi
non capisce le convenzioni del teatro d’opera perché è impossibile, sul piano
razionale, accettare il fatto che tutti si esortino a partire, pur continuando a star
fermi. In realtà, non è l’azione che si vuole rappresentare, bensì lo stato
d’animo che si crea nei personaggi nel momento in cui prendono atto del
pericolo: la musica dilata il senso di paura, d’ansia, d’angoscia, e lo
rappresenta in una forma astratta ma efficacissima sul piano emotivo. Una
musica di terrore, ad esempio, può essere lentissima, e allungare il momento
singolo in un lungo passo, sospeso fuori del tempo. La rappresentazione è
irreale, perché nella vita non succede così; ma è anche molto vera, perché quel
sentimento, così dilatato, acquista una forza d’impatto emotivo e psicologico
che non avrebbe se fosse risolto semplicemente in un grido e tutti i presenti,
subito, scappassero. Pensiamo, ancora, ai grandi momenti lirici del
melodramma in cui i personaggi, cantando, ripetono più volte le parole: alcuni
versi che, se recitati, passerebbero in pochi secondi, durano molto di più,
mentre la musica dà loro spessore e significato.
Ma, se è possibile una dilatazione del tempo, può esserci, attraverso la
musica, una sua compressione, quando, nei pezzi concertati, ci sono magari in
scena quattro, cinque, sei o più personaggi che cantano contemporaneamente
parole diverse. Nel teatro parlato queste battute sarebbero recitate una dopo
l’altra. Il musicista, invece, può sovrapporle e concentrare, così, il tempo, in un
precipitare vorticoso di frasi, parole, sillabe che s’addos-sano le une alle altre,
in una rappresentazione esclusivamente musicale della situazione drammatica.
Anche nel teatro di prosa ci può essere una concentrazione e una
dilatazione del tempo: in Shakespeare, per esempio, il passaggio fulmineo da
una scena all’altra può sottintendere intervalli di ore, giorni, mesi, o anche di
anni. Oppure ci sono monologhi in cui l’analisi poetica dilata il sentimento in
8
una dimensione irreale, ma tanto più vera. La musica, però, in questo senso,
può fare di più, e si dimostra molto più elastica della parola, ad esempio
quando porta al proscenio quattro, cinque o sei personaggi e li blocca,
sovrapponendo le loro voci, in pezzi musicali lentissimi, oppure velocissimi:
nelle opere di Rossini ci sono brani d’assieme in cui l’azione si arresta mentre i
personaggi cantano dapprima lentamente, poi un po’ più rapidamente, fino ad
arrivare ad un vortice di frasi musicali e di elementi ritmici e fonetici che si
combinano in una velocità vertiginosa; ma la scena resta ferma, e la situazione
assolutamente statica.
Dunque l’opera ci porta in un mondo irreale, in cui i mezzi naturali
della comunicazione quotidiana saltano, per il fatto stesso che i personaggi
cantano invece di parlare. Ma quel sistema fantastico creato dalla musica non è
evasione, né puro divertimento, bensì interpretazione del mondo. Ci sono,
infatti, diversi modi di fare teatro musicale e di rappresentare in musica l’uomo
e i suoi conflitti. Certo, l’opera si è evoluta e ha continuamente oscillato tra il
desiderio di piacere al pubblico, stupirlo, divertirlo, intrattenerlo, e l’esigenza
di esprimere conflitti drammatici. Le trasformazioni sono state molto notevoli
ma non vanno viste in senso evoluzionistico, per cui ciò che viene dopo è
meglio di ciò che viene prima: ogni momento vale di per sé ed ogni forma
d’arte va colta in rapporto alle sue esigenze espressive.
Detto questo, passiamo ad alcune considerazioni sulla funzione del
libretto d’opera. Negli ultimi anni c’è stata una netta rivalutazione del genere,
sovente considerato un sottoprodotto letterario in base all’abitudine, sbagliata,
di leggerlo come un dramma. Ma il libretto non è paragonabile a un dramma e
neppure a un poema drammatico perché non aspira a trasmettere un messaggio
in proprio. La sua funzione è quella di un’impalcatura, di uno scheletro
destinato a sparire sotto il corpo della musica che lo riveste. Il valore di un
libretto sta, dunque, essenzialmente nella sua funzionalità, rispetto a cui la
qualità letteraria, complessivamente maggiore nel ‘700 e nel ‘900, minore
nell’800, passa in secondo piano. Un libretto è buono se sostiene bene
l’edificio melodrammatico, e offre al compositore delle salde fondamenta su
cui poggiare le forme operistiche. Se noi leggiamo i libretti delle Nozze di
Figaro o del Don Giovanni, del Trovatore o del Don Carlos, del Barbiere di
Siviglia o della Bohème, e anche i testi di Wagner, avremo un’idea molto vaga
e imprecisa delle singole opere, perché i libretti non hanno minimamente il
peso drammatico, la qualità espressiva, la profondità che il lavoro acquista una
volta che la musica trasfigura il testo, operandone la metamorfosi. D’altra
parte, non possiamo comprendere le ragioni della riuscita di un’opera se non
partiamo dalla conoscenza della sua impalcatura strutturale. Quindi la presenza
di un buon libretto è essenziale perché possa nascere un capolavoro, e
viceversa, tutte le grandi opere musicali sono tali in quanto poggiano su libretti
9
da considerarsi dei capolavori per il solo fatto che hanno prodotto quella
musica. Evitiamo, dunque, la vecchia usanza di ironizzare sulle debolezze
letterarie dei testi di Piave, Cammarano, Solera, Ghislanzoni, Boito utilizzati
da Verdi e da altri compositori; cerchiamo invece di capire in che cosa consiste
la loro funzionalità.
La qualità letteraria del libretto, infatti, è semplicemente un valore
aggiunto; se c’è, tanto meglio, ma, se non c’è, questo non compromette
necessariamente la sua funzionalità che dipende, innanzi tutto, dalla struttura
drammatica: taglio degli atti, successione delle scene, organizzazione del
soggetto, rapporto tra le varie situazioni, per affinità o per contrasto. Il libretto
è lo schema di un’azione che deve svolgersi secondo determinati criteri di
logica, organicità, compattezza.
Un’altra qualità importante del libretto è il tipo di rapporto che in esso
s’instaura tra i versi sciolti e rimati. I versi regolari hanno una ritmica costante
che suggerisce un determinato ritmo musicale (arie, concertati); i versi sciolti,
in quanto asimmetrici, implicano, invece, un declamato aperto, in cui ci
possono essere anche occasionali melodie regolari, ma nel quale il canto si
svolge, in genere, liberamente, in un procedimento «senza forma» (recitativi).
Ora, questo contrasto tra episodi formati e episodi liberi crea una pulsazione
formale che ogni compositore regola in base alla propria estetica, ma che
trova, nel libretto ben fatto, la propria ineludibile base di articolazione. Inoltre,
ogni verso ha un ritmo e ogni ritmo suggerisce un’espressività musicale
diversa; quindi, se il compositore deve esprimere un sentimento di nostalgia,
d’abbandono, di malinconia, non chiederà al librettista un verso martellante,
bensì dolce, morbido, che gli suggerisca melodie con una determinata
intonazione espressiva.
Un terzo elemento determinante per la funzionalità melodrammatica del
testo è la presenza d’immagini riferibili al mondo esterno ed imitabili
attraverso la musica (ad esempio, il fuoco, la pioggia, il mormorio del ruscello,
il volo degli insetti, la tempesta, il mare in burrasca ecc.) oppure allusive a
sentimenti, stati d’animo, passioni. Il libretto può essere letterariamente
scadente, semplice, addirittura rozzo, ma insieme molto raffinato nell’offri-re
al compositore una sapiente alternanza d’immagini, in modo da creare un
chiaroscuro di stati d’animo, una tensione drammatica di situazioni emotive in
divenire. Naturalmente, queste qualità si scoprono solo se si tiene presente la
partitura che ci permette di verificare perché il testo è stato determinante per
produrre quella musica. L’atteggiamento giusto è quindi quello che ci porta a
concludere: «ah! ecco, certo, questo pezzo è meraviglioso perché nel testo ci
sono queste o queste altre immagini, c’è quest’al-ternanza molto precisa di
ritmi e di metrica, questa determinata successione di stati d’animo, di idee, di
pensieri, di concetti, ecc.». Verdi era esigentissimo nei confronti dei suoi
10
librettisti: dava indicazioni precise sulla costruzione delle scene, richiedeva
determinate parole, suggeriva la lunghezza dei versi, in modo che si
adattassero alle melodie e ai ritmi che aveva in mente per dare alla scena la
massima efficacia.
Il compositore d’opera, dunque, ha davanti un testo che gli offre una
serie di possibilità semantiche, fonetiche, metriche, ritmiche, melodiche, e
quindi espressive, drammatiche. Il libretto è un campo di forze in attesa di
essere sprigionate: il compositore può scegliere che cosa fare, traccia i suoi
percorsi attraverso il testo, lo interpreta come vuole, con soluzioni
imprevedibili e di cui ci renderemo conto, leggendo il libretto del Trovatore,
testo schematico, addirittura burattinesco eppure straordinariamente
funzionale, nella potenza del suo immaginario, e predisposto a lasciarsi
fecondare dalla musica che lo incarna, con meravigliosa sovrabbondanza
inventiva, dandogli senso e vita.
11
Capitolo primo
La genesi del Trovatore
1. Le fasi della produzione di Verdi.
Verdi nasce nel 1813 e muore nel 1901. La sua arte risponde
esattamente alle esigenze dei tempi. Lo dimostra, con impressionante carica
profetica, il trattatello Filosofia della musica di Giuseppe Mazzini, pubblicato
a Parigi nel 1836 e dedicato ad un «nume ignoto» il cui avvento è auspicato,
per la necessaria modernizzazione dell’opera italiana. La musica italiana,
secondo Mazzini, identificata nel genio di Rossini, è bella, brillante,
affascinante, ma un po’ superficiale: esprime con efficacia le passioni umane
ma il suo è un rappresentare «l’uomo senza Dio, le potenze individuali non
armonizzate da una legge suprema, non ordinate ad un intento, non consacrate
da una fede eterna»2. Ad essa Mazzini contrappone la musica tedesca che,
secondo lui, ha il difetto opposto: è troppo idealistica e poco umana: «l’anima
vive, ma d’una vita che non è della terra»3. Mazzini auspica dunque la nascita
d’una musica né italiana né tedesca, bensì «europea», che «non s’avrà se non
quando le due, fuse in una, si dirigeranno ad un intento sociale – se non
quando, affratellati nella coscienza dell’unità, i due elementi che formano in
oggi due mondi, si riuniranno ad animarne uno solo; e la santità della fede che
distingue la scuola germanica benedirà la potenza d’azione che freme nella
scuola italiana; e l’espressione musicale riassumerà i due termini fondamentali:
l’individualità e il pensiero dell’universo – Dio e l’uomo»4. Il melodramma di
Verdi risponde a queste esigenze: nelle sue opere il compositore sa scolpire
l’individuo, dargli il massimo rilievo, creare dei personaggi concreti,
riconoscibili, diversi fra loro, ma sa anche conferire all’azione quella
organicità, compattezza, tensione continua che nasce da un profondo intento
drammatico nutrito di un nuovo senso morale.
Il primo grande successo di Verdi fu il Nabucco (1842) che appartiene
al genere dell’opera corale, praticata da Gluck e da Rossini (il Mosè in Egitto,
nella versione francese Moïse et Pharaon, tradotta e diffusa nei teatri italiani, è
2
G. MAZZINI, Filosofia della musica, Firenze, Guaraldi, 1977, p. 56.
Ibidem, p. 56.
4
Ibidem, p. 58.
3
12
il suo antecedente immediato) in cui la collettività ha una parte importante,
almeno quanto quella del protagonista. Infatti, il pezzo più celebre del
Nabucco non è un’aria bensì il coro «Va’ pensiero». Verdi prosegue questo
filone nei Lombardi alla prima crociata (1843); poi, in Ernani (1844), trova la
sua vera strada che punta non più alla rappresentazione di conflitti generali ma
alla definizione di caratteri individuali. Nella prima fase dell’arte verdiana si
registrano risultati alterni: tra il Nabucco e Rigoletto ci sono opere buone e
opere scadenti, scritte di fretta durante i cosiddetti «anni di galera», nell’ansia
di ottemperare ad ogni commissione per la necessità di imporsi sul mercato
teatrale italiano. Lavori come I due Foscari (1844) Giovanna d’Arco (1845)
Alzira (1845) Attila (1846) I masnadieri (1847) Il corsaro (1848) La battaglia
di Legnano (1849) denotano una formidabile volontà di rinnovamento,
posseggono un ritmo drammatico incalzante e sonorità rivoluzionarie, ma
anche una stesura sovente rozza, sommaria e poco meditata che impediscono
loro di elevarsi al livello artistico del Macbeth, composto nel 1847, e
rimaneggiato nel ’65. La piena maturità è raggiunta in quella che è stata un po’
arbitrariamente definita la trilogia «romantica» (Roncaglia) o «popolare»
(Mila) formata da Rigoletto (1851), La Traviata (1853) e Il Trovatore (1853):
non di opere concepite unitariamente, infatti, si tratta, ma di tre capolavori tra
loro diversissimi in cui gli elementi di divisione sul piano drammaturgico sono
più forti di quelli che li uniscono nell’indubbia affinità di linguaggio musicale
e nella preminenza conferita alla melodia vocale che si specifica nelle tre opere
in modo molto diverso, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con la
parola.
Sin dall’inizio della sua produzione, Verdi aveva voltato le spalle al
gusto di Bellini e Donizetti che incentravano le loro opere essenzialmente sul
tema amoroso. Con Verdi gli argomenti si ampliano e toccano altri temi: il
legame tra genitori e figli, l’amor di patria, la politica, il rapporto tra stato e
individuo, lo scontro con il destino avverso che impedisce la felicità dell’uomo
ma ne irrobustisce la forza morale, la religione come prospettiva di speranza o
strumento di potere, l’ingiustizia e la sanzione, la rinuncia e il sacrificio come
atto nobilitante che permette all’individuo di affrontare con interiore serenità i
colpi tremendi che la vita gli riserva. Il tema amoroso diventa, così, uno dei
tanti, e perde la centralità che possedeva negli operisti precedenti. Verdi era di
estrazione umile, contadina, legato ad un mondo in cui dominavano i valori
della schiettezza, della semplicità, della immediatezza comunicativa. Rigoletto,
La Traviata e Il Trovatore rappresentano, in un certo senso, la sublimazione
delle radici popolari di Verdi, della sua arte in apparenza semplice, fondata su
contrasti elementari, che raggiungono, però, una straordinaria potenza di
effetti, grazie alla raffinatezza della forma musicale, troppo spesso ignorata
13
nelle esecuzioni correnti e messa in secondo piano dalla critica rispetto alla
considerazione dei valori drammatici.
Nella prima fase della sua produzione, il mezzo più importante di cui
Verdi si serve per tradurre in musica personaggi e situazioni è la melodia
vocale capace di costruire i caratteri attraverso una ricchezza di atteggiamenti
che vanno dalla melodia formata e simmetrica al recitativo quasi parlato,
attraverso una gamma di soluzioni intermedie già presenti in Rigoletto,
Trovatore e Traviata ma distribuite nelle tre opere in modo diversissimo, in
rapporto alle esigenze drammatiche di ciascuna. Verdi teorizza un
procedimento che Mozart aveva già sperimentato a suo tempo: la cosiddetta
«parola scenica», ossia l’emersione di alcune parole-chiave che si devono
percepire con chiarezza per comprendere il significato di una determinata
situazione drammatica. L’orche-stra, pur giocando un ruolo importante, è
sostanzialmente intesa come sostegno e completamento della parte vocale:
raramente acquista indipendenza e valore autonomo.
Dopo la trilogia popolare, l’arte di Verdi si apre ad una dimensione
europea. Cresce in lui l’interesse per l’ambiente che circonda i personaggi con
alcune figure secondarie, di grand’evi-denza teatrale, che appaiono e
spariscono rapidamente come, ad esempio, il paggio Oscar e i congiurati in Un
ballo in maschera. Nella Forza del Destino (1862) la presenza dell’ambiente è
ancora più marcata. In questo dramma molto avventuroso, i personaggi
passano da un paese all’altro attraverso guerre e vicende rocambolesche,
mentre la forza del destino li separa e li unisce di nuovo, a distanza di tempo,
in posti lontanissimi da quelli in cui si erano incontrati la prima volta. I soldati
inneggianti all’avven-turosa ebbrezza della vita militare; i frati che pregano; il
popolo che chiede l’elemosina costituiscono lo sfondo della vicenda su cui
spiccano, con vivacità bozzettistica, le figure minori: Mastro Trabuco, umile
venditore ambulante; Fra Melitone, che distribuisce l’elemosina tra i poveri e
moraleggia, sferzando comicamente la rilassatezza dei costumi; il solenne
Padre Guardiano che accoglie gli afflitti e li consola con manzoniana
commozione religiosa; la vivandiera Preziosilla che segue gli eserciti e allieta i
soldati con i suoi canti spensierati e scattanti, e così via. A questo
arricchimento dell’ambiente corrisponde, nella seconda fase dell’arte di Verdi,
un approfondimento della psicologia.
Paragonando il libretto del Trovatore a quello, poniamo, del Don
Carlos, notiamo un divario incolmabile: il Trovatore è un dramma
estremamente schematico, fatto di poche scene contrapposte con la volontà di
creare contrasti di sentimenti e di passioni organizzati in un una drammaturgia
schematica che la musica trasforma in una possente immediatezza di
rappresentazione. Il Don Carlos, invece, che si basa sull’omonimo dramma di
Schiller, è un lavoro di grandiosa complessità drammatica e psicologica che
14
non rappresenta passioni elementari semplicemente accostate, ma conflitti
espressi e inespressi, stati psicologici sottili, sfuggenti, ambigui, temi amorosi
accostati a temi politici, grandi scene di massa insieme a scene raccolte
nell’intimità della dimensione domestica. Così, mentre le figure della trilogia
popolare erano tratteggiate in modo molto potente ma sommario, per momenti
culminanti, nel periodo di mezzo Verdi lavora i personaggi con una nuova
attenzione per i trapassi psicologici e sentimentali che portano all’esplosione
passionale e ne registrano i riverberi, gli echi, i prolungamenti segreti. Questo
implica, naturalmente, una trasformazione dei mezzi musicali. Se la trilogia
popolare è essenzialmente basata sulla melodia vocale, nelle opere di mezzo
quali Un ballo in maschera (1859) La forza del destino (1862) Don Carlos
(1867) e Aida (1871), accanto alla voce, acquista sempre più importanza
l’orchestra. Ora Verdi è attentissimo a quello che succede fuori d’Italia;
ascolta, studia, legge le partiture dei grandi sinfonisti austro-tedeschi; i viaggi
all’estero lo mettono in contatto con la civiltà musicale europea, con la
raffinatezza strumentale dell’opera francese. L’orchestra di Verdi abbandona,
così, quella semplice funzione d’accompagnamento che aveva, per lo più, nel
primo periodo, e diventa protagonista insieme alle voci: dialoga con esse, le
sostiene, ma, molte volte, procede per andamenti autonomi, svolgendo un
discorso proprio, che può essere di sostegno, ma anche di contrasto nei
confronti del canto. Nella trilogia popolare l’orchestra è trattata per lo più con
colori netti e timbri isolati; in Don Carlos e Aida presenta impasti raffinati e
sottili sfumature, utili come mezzo di approfondimento psicologico.
Tutti questi elementi sono accompagnati da un’altra, importantissima
trasformazione: quella delle forme. Nelle prime opere si contrapponevano
recitativi, arie, cori, pezzi concertati, ben definiti nella loro struttura. Un’aria,
un recitativo del Trovatore, sono oggetti musicali perfettamente identificabili
nelle loro caratteristiche formali. Le arie del Don Carlo (ad esempio «Ella
giammai m’amò!» di Filippo II) o quelle dell’Aida («Ritorna vincitor!») sono
più articolate e complesse: il recitativo iniziale passa dal quasi parlato al
declamato arioso, si gonfia di melodia, sembra che diventi un’aria, ma non si
organizza ancora in una forma regolare, e ritorna ad essere recitativo; poi
compare un’idea melodica, ma subito si spezza; ritorna il declamato, e, solo
alla fine, la melodia formata prende il sopravvento, concludendo il pezzo con
una maggiore cantabilità. L’aria è dunque una concrezione di forme vocali che
si trasformano, fluttuano, passando continuamente da un regime all’altro.
Verdi, ora, vuole scandagliare i sentimenti dei personaggi, e l’analisi
psicologica lo induce ad ampliare le forme. Questa ricerca non termina con
Aida, ma prosegue sino alle due ultime opere che costituiscono la fase finale
della sua produzione, Otello (1887) e Falstaff (1893) su libretti di Arrigo Boito
tratti da Shakespeare. In queste opere, la trasformazione dello stile verdiano è
15
ormai giunta a compimento; lo stile acquista un grado di raffinatezza e di
complessità impensato. Le forme sono quasi completamente rotte; Verdi punta
a un declamato che si trasforma con una straordinaria duttilità, mentre
l’orchestra raggiunge sovente degli effetti che non hanno nulla da invidiare a
quelli della musica moderna. In particolare, in alcune pagine dell’Otello certe
esplosioni timbriche, di spaventosa densità sonora, certi effetti puramente
rumoristici (per esempio, nella tempesta iniziale), mostrano che il suono, di per
sé, si fa espressione, attraverso la combinazione degli strumenti, l’interferenza
dei timbri, la densità delle armonie.
In Otello e Falstaff l’antica linearità di rapporti tra recitativo e aria è
ormai abbandonata, tutto si svolge in un declamato che diventa melodico, si
effonde in frasi cantabilissime ma, una battuta dopo, ritorna simile al parlato, e
procede, così, senza regole che non siano quelle dettate dalle esigenze
espressive del testo. Certo, ci sono ancora in Otello dei pezzi individuabili
come arie, cori e strutture «chiuse», per esempio nella grande scena di
Desdemona del quarto atto quando, prima di esser uccisa, la sfortunata sposa
di Otello prega e ripensa alla sua vita passata: qui la musica si concentra in
organismi melodici ben definiti, seppur molto articolati e formalmente sfumati.
Nell’ultima fase della sua produzione Verdi partecipa, dunque, a quella che è
stata definita l’arte della transizione che, nel secondo Ottocento, trovava in
Wagner il suo grande maestro. Nelle sue opere si rappresenta la sottigliezza dei
sentimenti che trapassano gli uni negli altri, dei ricordi che si affollano alla
mente dei personaggi, dei momenti psicologici che si succedono e che talvolta
si sovrappongono in una densità straordinaria di avvenimenti interiori.
Nel corso della sua carriera Verdi è stato accusato di wag-nerismo da
parte di alcuni critici che rimasero sconcertati dinanzi alla modernità stilistica
di Aida, Otello, e Falstaff. Accusa infondata. Verdi, infatti, è arrivato a quel
tipo di teatro attraverso un’evoluzione personale, assolutamente organica che,
da un’ope-ra all’altra, coinvolge tutti gli aspetti della drammaturgia musicale.
Inoltre, l’atteggiamento dei due compositori nei confronti del proprio pubblico
è radicalmente diverso: Wagner impone allo spettatore di sintonizzarsi sulla
propria lunghezza d’onda, lasciarsi prendere dal flusso lento di una
drammaturgia che indugia sui particolari, scava nell’interiorità, esplora gli
intimi recessi della psicologia, diffondendosi in ampi monologhi, tenuti
insieme dall’intreccio dei temi conduttori che ritornano, deformati ma
riconoscibili, a costellare, con prodigiosa capacità evocativa, il flusso lento e
maestoso del divenire drammatico. Verdi, anche nelle ultime opere, non
abbandona mai il criterio fondamentale della sua drammaturgia:
concentrazione e brevità, contrasti fulminei e costante tensione teatrale. A
differenza di Wagner, il punto di vista che stabilisce il ritmo dello spettacolo
non è quello del compositore ma quello dello spettatore: preoccupazione
16
massima è che il dramma venga costruito in modo da mantenere desta la sua
attenzione, avvincerlo ad un ritmo sostenuto, trascinarlo con l’incalzare dei
fatti. In Wagner è la vita interiore che si manifesta in forma drammatica, la
psicologia che si traduce in gesto; in Verdi è il dramma che viene interiorizzato
attraverso la rappresentazione dei sentimenti e delle passioni, è il gesto che si
carica di contenuto sentimentale e psicologico. Il punto di partenza
drammaturgico è, quindi, diametralmente opposto. In Wagner la «melodia
infinita» si organizza, talvolta, in forme strofiche, e articolate concrezioni
melodiche, per scivolare nuovamente nel flusso aperto e «senza forma» del suo
stato più naturale; in Verdi è l’incastro reciproco e sempre più minuto delle
tradizionali forme melodrammatiche – recitativo, declamato aperto, melodia
strofica, aria, coro, concertato – mai realmente negate, anzi sempre sfruttate
nella loro reciproca funzione dialettica, che determina l’effetto d’apertura
formale sempre più accentuato, dal Don Carlos in poi.
Sono pochi gli artisti che hanno saputo evolversi nella misura in cui lo
ha fatto Verdi. Rossini, nel 1829, compose, a Parigi, Guillaume Tell, opera
romantica capace di dimostrare che il compositore avrebbe saputo
modernizzarsi e aggiornare la propria arte al gusto del tempo; ma, in seguito,
egli preferì rinunciare all’impegno di un rinnovamento inevitabile e visse
ancora trentanove anni senza scrivere una nota di musica teatrale. Verdi,
invece, rimase artista d’avanguardia sino all’età di ottant’anni, mostrando una
capacità di rinnovamento che lo portò a mutare completamente genere
nell’ultimo capolavoro, Falstaff, commedia brillante scritta in stile
modernissimo, capace di porsi come modello ai più moderni compositori
europei (impensabile sarebbe, ad esempio, senza il precedente di Falstaff la
figura del Barone Ochs nel Cavaliere della rosa di Strauss).
Le diverse fasi dell’arte verdiana hanno dato luogo ad interpretazioni e
giudizi contrastanti. Gabriele Baldini5, ad esempio, ritiene che Verdi abbia
dato il meglio di sé in opere come Il Trovatore e Un ballo in maschera, in cui
le forme musicali sono in sé concluse e fondate essenzialmente sulla rotondità
della melodia. Per Massimo Mila6, invece, la parte più interessante del lavoro
compositivo di Verdi consiste nella ricerca e nell’evoluzione del declamato,
cioè in quell’esaltazione musicale della parola che a poco a poco sbriciola la
forma per incarnare il dramma con sempre maggiore aderenza. Da una parte
c’è il Verdi «tutta musica» di Baldini, dall’altra il Verdi drammaturgo, maestro
della parola, esaltato da Mila. Contrapposizione che potrebbe essere superata,
oggi, attraverso la considerazione del valore drammatico che anima le melodie
5
Cfr. G. BALDINI, Abitare la battaglia. La storia di Giuseppe Verdi, Milano,
Garzanti, 2001 [1970].
6
Cfr. M. MILA, Giuseppe Verdi, Milano, Rizzoli, 2000.
17
e le forme chiuse di Verdi e di quello musicale che impregna il declamato e le
forme aperte, più esplicitamente volte alla rappresentazione del dramma. Il
libro di Baldini, studioso di letteratura inglese, e, in particolare, di
Shakespeare, non è completo: a causa della scomparsa dell’autore,
s’interrompe all’inizio del capitolo sulla Forza del destino e lascia prevedere
una possibile svalutazione d’opere come Don Carlos, Aida e Otello. Per Mila,
invece, l’opera più grande della trilogia popolare è Rigoletto, dove la ricerca
sul declamato, destinata ad approfondirsi in seguito, raggiunge i primi risultati
assoluti
La preferenza per l’una o l’altra delle fasi stilistiche verdiane è
assolutamente legittima. Pericoloso è invece accostarsi al complesso sistema
del teatro musicale di Verdi con una mentalità evoluzionistica, che tende
inevitabilmente a presentarci le singole opere come tappe successive di una
teleferica che porta progressivamente alle mete più alte di Otello e Falstaff. A
cavallo tra Otto e Novecento, sull’onda dell’infatuazione wagneriana, si
consideravano povere, rozze e irrimediabilmente invecchiate le partiture di
Rigoletto, La Traviata, Il Trovatore, svalutate, nel giudizio della critica e del
pubblico, rispetto ad Otello e Falstaff, che, aggiornate al gusto moderno,
parevano, invece, incomparabilmente più perfette, complesse e
qualitativamente superiori. Era diffusa la tendenza a giudicare l’arte di Verdi
come un fenomeno che, dalla semplicità, modestia di mezzi ed ingenuità
popolare dei primi anni si fosse progressivamente elevato alle vette della
produzione ultima.
Negli anni ’30 c’è stata la reazione a questa assurda visione teleologica.
In Germania, il movimento della Verdi-Renaissance, con contributo di critici e
scrittori (ad esempio, quello del romanziere austriaco Franz Werfel, autore di
Verdi, il romanzo dell’o-pera) operò una rivalutazione globale di tutto il teatro
verdiano: emblematico, a questo proposito, il contributo di Paul Bekker nel
capitolo su Verdi del volume dedicato alle principali figure del teatro d’opera7.
In Italia, la riscossa del primo Verdi aveva già avuto tra i suoi pionieri le
esecuzioni di Toscanini alla Scala e il libro di Gino Roncaglia 8. Ma fu
soprattutto Massimo Mila che, nel suo studio su Il melodramma di Verdi,
pubblicato da Laterza del 19339, mise in luce la grandezza delle prime opere,
7
P. BEKKER, Wandlungen der Oper, Zürich-Leipzig, Orell Füssli, 1934.
G. RONCAGLIA, Giuseppe Verdi, l’ascensione creatrice dell’arte sua, Napoli,
Perella, 1914, ripubblicato con il titolo L’ascensione creatrice di Giuseppe
Verdi, Firenze, Sansoni, 1940. Le citazioni contenute in questo volume si
riferiscono alla seconda edizione.
9
Questo studio di Mila è confluito, con altri saggi verdiani, nel recentissimo
Verdi, cit.
8
18
senza svalutare quelle successive, bensì mostrando che, anche in Rigoletto, nel
Trovatore e nella Traviata, l’arte di Verdi si era già posta a livelli altissimi,
seppure con strumenti stilistici e interessi drammatici profondamente diversi
da quelli dei capolavori successivi. L’entusiasmo per la riscoperta del primo
Verdi giunse a determinare addirittura un rovesciamento di prospettive: il
critico e scrittore Bruno Barilli, nella sua celebre raccolta di articoli Il paese
del melodramma, pubblicata nel 1930, opponeva il Trovatore «dove c’è
crepitio di genio: tanto genio che grandina» al Falstaff in cui il fuoco del primo
Verdi gli appariva solo come «cenere calda»10.
Il dibattito generato dall’effettiva varietà stilistica dell’opera verdiana è
stato sovente condizionato da un’ottica evoluzionistica che, seppure attenuatasi
col tempo, ha lasciato le sue tracce anche nella gigantesca monografia di Julian
Budden11 che distingue, ad esempio, le partiture «innovative», che aprono nuove
vie, da quelle «conservatrici» che consolidano risultati acquisiti.
La tendenza a incasellare le opere di Verdi in categorie alternative
distinguendo l’artista «conservatore» da quello «innovatore», rischia di
compromettere l’esatta comprensione della complessità del fenomeno: meglio
è considerare ciascun’opera in sé e per sé, al riparo da qualsiasi interpretazione
evoluzionistica, perché ogni capolavoro di Verdi ha le sue leggi e proporzioni
interne e mescola diverse scelte stilistiche che non sono né “innovative” né
“conservatrici”, ma solamente funzionali in rapporto alla natura del soggetto,
alla costruzione del libretto, al carattere dei personaggi ed alla specificità delle
situazioni. In ogni capolavoro che guarderebbe indietro ci sono scelte
rivoluzionarie, e viceversa, ogni partitura orientata all’impiego di forme più
libere e audaci contiene brani di struttura apparentemente tradizionale. Verdi
non è mai conservatore, guarda sempre avanti: solo che per lui l’innovazione
ha diverse strade. Così, l’impiego delle forme chiuse e l’esclusione del
declamato dal Trovatore, che fanno per lo più considerare quest’opera come
passatista, come se l’autore si fosse improvvisamente pentito e avesse
rinnegato le scelte rivoluzionarie di Rigoletto, sono dettate dalla natura del
dramma e dall’impostazione retorica del testo: rispondono, cioè, a criteri di
intrinseca necessità espressiva e drammatica. Verdi ha fatto queste scelte
perché non avrebbe potuto farne altre in base alla logica dei rapporti tra
contenuto drammatico e stile. Che cosa «conserva» Il Trovatore del
melodramma passato? Proprio nulla, perché il modo di impiegare la melodia e
le forme chiuse è talmente nuovo da portare quei mezzi stilistici ad un tipo di
espressione non meno elettrizzante, moderna e rivoluzionaria di quella fondata
sulle forme più libere e aperte dominanti nel Rigoletto o nella Traviata; dove
10
11
Cfr. B. BARILLI, Il paese del melodramma, Torino, Einaudi, 1985 [1930].
J. BUDDEN, Le opere di Verdi, 3 voll., trad. it., Torino, Edt, 1985-88.
19
peraltro non mancano pagine «conservatrici» (si vedano le parti di Gilda o di
Germont), perché così esigeva imperiosamente la natura di certi personaggi o
di specifiche situazioni; e questo non per una rinuncia all’originalità, ma per
creare una voluta, potente e originalissima frizione dialettica con le pagine
«innovatrici»; il che fa sprizzare l’energia musicale e drammatica che anima il
progetto operistico nel suo complesso: progetto nuovo, rivoluzionario, audace
come la scelta dei tre soggetti consapevolmente adottati dal compositore per la
loro dirompente originalità: «…io desidero soggetti nuovi, grandi, belli,
variati, arditi […]» scriveva Verdi, il 1° gennaio 1853, a Cesare de Sanctis «ed
arditi all’estremo punto, con forme nuove ecc. ecc., e nello stesso tempo
musicabili […] Quando mi si dice: ho fatto così perché così han fatto Romani,
Cammarano ecc., non c’intendiamo più: appunto perché così han fatto quei
grandi, io vorrei si facesse diversamente». Naturalmente, anche il Trovatore,
pur se scritto da Cammarano, è radicalmente diverso da ciò che il poeta aveva
fatto per gli altri compositori, cui Verdi pensa in questa professione di estetica
rivoluzionaria.
Sbarazzato il campo dalla tentazione di leggere il complesso dell’opera
verdiana e le singole opere alla luce della contrapposizione fasulla tra
innovazione e conservazione, è opportuno oggi guardarsi da un’altra insidia
estetica. Dietro la prudenza di Massimo Mila che, davanti al «più pazzo dei
melodrammi», esortava ad un giudizio equilibrato, per evitare di far del
Trovatore un «polemico oggetto sia di esagerato disprezzo che di esagerata
ammirazione»12, perdurava la convinzione che questo fosse il melodramma
«più lacerato fra altezze vertiginose di appassionata disperazione e abissi di
sommaria brutalità»: ossia, in pratica, un’opera spaccata nell’opposizione di
bello e brutto. Niente da stupirsi: il criterio di leggere le opere di Verdi,
distinguendo le pagine buone dai presunti errori estetici, percorre tutta la
critica verdiana sin dalla prima monografia sull’argomento, quella di Abramo
Basevi, pubblicata nel 1859 e ora disponibile per il lettore moderno in
un’edizione minutamente annotata da Ugo Piovano13. Hanslick, lo storico
viennese amico di Brahms, citato da Mila, osservava nel 1880 che «la musica
del Trovatore è a un tempo la piena espressione della rozzezza artistica di
Verdi e dell’intensità del suo talento». «E acutamente aveva osservato –
commenta Mila – che questi alti e bassi non erano tanto dovuti ad un
indebolimento dell’ispirazione, ‘come avviene spesso in Bellini’, ma piuttosto
ad una ‘voluta, dolosa ricerca del triviale’ ch’egli era tentato di definire
12
M. MILA, Verdi, cit., p. 486.
A. BASEVI, Studio sulle opere di Giuseppe Verdi, ed. critica a cura di U.
Piovano, Milano, Rugginenti, 2001.
13
20
ingegnosamente come ‘cattiva volontà estetica’»14. Hanslick, dunque, aveva
visto giusto: il dislivello qualitativo delle pagine del Trovatore è voluto; non
capiva, però, che il gioco di alti e bassi, la contrapposizione di sublimi
dilatazioni poetiche e pagine precipitose ha, come vedremo, una profonda
ragione strutturale e costituisce la pulsazione vitale che anima la drammaturgia
dell’opera, determinandone l’identità e il valore. Ma ciò che Mila e Hanslick
giudicavano triviale e brutale lo è veramente? O questi giudizi appartengono
solo alla sfera del gusto personale, condizionato da una cattiva tradizione
esecutiva, di cui il Trovatore è stato sovente vittima illustre?
Alcune esecuzioni teatrali e discografiche degli ultimi decenni hanno
rivelato, in ogni pagina del Trovatore, una scrittura accuratissima, sia nella
dinamica, mantenuta molto sovente nel piano e nel pianissimo, e quindi
lontana da quelle pesantezze che si sono incrostate, come cattive abitudini
interpretative, su di una partitura molto eseguita, sia nella strumentazione,
tanto semplice, quanto limpida, trasparente ed efficace nel fissare la tinta dei
singoli brani attraverso l’uso e i contrasti dei timbri (basti vedere che
strumentazione squisita Verdi destina ad una pagina d’immediata presa
popolare ed in sospetto di volgarità come il coro degli armigeri che apre il
terzo atto: ma va eseguita come è scritta). Non esistono nel Trovatore le
trivialità, ravvisabili, invece, nel Corsaro e nell’Alzira, nella Giovanna d’Arco
e nei Masnadieri. Esiste, invece, una contrapposizione voluta di stile alto e
stile basso, nobile e popolare, melodie che si sviluppano con imprevedibile
varietà e complessità ed altre, più semplici e regolari, stupori lirici e incalzanti
vertigini in cui la situazione precipita e si conclude con rapidità inaudita: ma
tutto è governato da una vigile coscienza formale, e nutrito da una vena
melodica al massimo del suo splendore, il che ha permesso a Verdi di
raggiungere, nel Trovatore, la qualità veramente discriminante rispetto alle
opere (brutte) degli anni di galera: l’impressività, la memorabilità, la
personalità fortissima di ogni idea melodica impiegata a scopi di
rappresentazione drammatica.
È questo il criterio di giudizio che ci può utilmente guidare in una
rilettura odierna del teatro verdiano: impressività tematica significa altissima
individualizzazione. Per raggiungerla, Verdi lavorava sodo: gli abbozzi delle
singole opere mostrano che melodie apparentemente facili sono in realtà frutto
di un’accurata elaborazione, alla ricerca di quella caratterizzazione melodica in
funzione drammatica che le rende indelebili nella nostra memoria, e
indissolubilmente legate al personaggio ed alla situazione. Pagine come la
canzone del Duca «La donna è mobile», nel Rigoletto, o l’aria di Germont «Di
14
M. MILA, Verdi, cit., p. 486.
21
Provenza il mare e il suol», con relativa cabaletta15, nella Traviata, potranno
piacere o non piacere: ciascuno giudicherà in base al proprio gusto, che a noi
interessa fino ad un certo punto. Ma sta di fatto che la loro impressività
melodica, e la loro collocazione in quel determinato punto del dramma,
colgono con icastica esattezza, da un lato la sfacciataggine libertina del duca,
dall’altra il vacuo perbenismo borghese di Germont, e la sua indifferenza di
fronte al dramma di Violetta, e alla nervosa disperazione di Alfredo.
È dunque la memorabilità tematica raggiunta nelle opere della trilogia,
divenute popolari proprio per questa caratteristica, che permette a Verdi di
sintetizzare una situazione drammatica non solo in una melodia in quanto tale,
ma anche per il contrasto che essa instaura con altre invenzioni musicali, più
semplici o più elaborate, ma ugualmente in grado, attraverso la loro personalità
melodica, di determinare un gioco di opposizioni vigorosissime, cui si deve la
pulsazione segreta della drammaturgia verdiana; la quale si svuoterebbe quasi
del tutto se fosse affidata alle melodie generiche che caratterizzano le opere dei
cosiddetti anni di galera. In Verdi, invenzioni musicali che, di per sé, non
avrebbero grande valore, acquistano un’espressività straordinaria per il
contesto in cui sono poste e che conferisce loro un’esaltante funzione
espressiva (vedasi «Amami Alfredo!» nella Traviata): solo giudicando ogni
pezzo in rapporto alla sua collocazione nel tutto, considerando l’energia
musicale e drammatica sprigionata dall’acco-stamento, molto moderno, tra
stile alto e stile basso, melodie chiuse e declamati aperti, forme strofiche e
passi del tutto liberi, musica sublime e musica “prosaica”, si comprendono la
funzione del singolo brano e le sue ragioni espressive.
Il Trovatore, dove simili contrasti sono portati all’incan-descenza, è la
partitura più “melodrammatica” di Verdi, l’emble-ma più rappresentativo della
forza passionale che divampa nel melodramma italiano dell’Ottocento e si
concretizza, qui, in un’e-ruzione di pura musica, teatralmente orientata.
L’opera richiede da parte nostra uno sforzo di superamento delle convenzioni:
ma è uno sforzo ripagato dal premio di un’eccezionale capacità di fascinazione
musicale. Forse mai più, nella sua carriera, Verdi ha trovato e inventato delle
melodie immediate come quelle del Trovatore, forse mai più Verdi ha
incarnato lo spirito melodrammatico nella sua essenza, che è appunto quella di
esprimere il dramma col melos, affidandosi al potere che la musica, nelle sue
forme autosufficienti, possiede di creare contrasti e fare teatro esclusivamente
con i propri mezzi.
15
In particolare la cabaletta «No, non udrai rimproveri», è nata da un minuto
lavoro di correzioni successive. Cfr. G. VERDI, La Traviata. Schizzi e abbozzi
autografi, a cura di F. Della Seta, Parma, Istituto di Studi Verdiani, 2000, pp.
161-65.
22
2. La genesi del Trovatore.
Il libretto del Trovatore è del poeta napoletano Salvatore Cammarano,
già autore di fortunati libretti per diversi musicisti (basti ricordare quello di
Lucia di Lammermoor di Donizetti e di Luisa Miller, per lo stesso Verdi), ed è
tratto dal dramma cavalleresco El trovador dello spagnolo García Gutiérrez,
massimo drammaturgo spagnolo dell’epoca, rappresentato a Madrid nel 1836.
L’opera fu creata a Roma, con grande successo, nel Teatro Apollo, il 19
gennaio 1853. Immediatamente, il Trovatore venne ripreso da teatri italiani e
stranieri e costituì il più grande successo mai ottenuto da Verdi che era reduce
dal trionfo del Rigoletto, rappresentato a Venezia nel 185116.
Si tratta di una vicenda a tinte molto fosche, piena di elementi
avventurosi, zingareschi, orrifici, particolarmente amati nel teatro del primo
Ottocento. La storia attraeva Verdi che, in Rigoletto, aveva messo in scena un
dramma, tratto da Le roi s’amuse di Victor Hugo, cui Gutiérrez s’avvicinava
per gusto e scelte narrative e drammatiche.
Salvatore Cammarano aveva già dato prova d’una grande capacità
d’intuire quelle che erano le esigenze del teatro d’opera: situazioni chiare,
contrasti netti, messa a fuoco di sentimenti e di situazioni con poche parole,
semplici e significative. Come succede per altre opere di Verdi, anche la
genesi del Trovatore è documentata da un carteggio, recentemente pubblicato
dall’Istituto di Studi Verdiani di Parma 17. Il 29 marzo 1851, Verdi scriveva
all’amico Cesare De Sanctis: «Sono fieramente in collera con Cammarano:
egli non considera niente il tempo che per me è una cosa estremamente
preziosa. Egli non m’ha scritto una parola su questo Trovatore: gli piace o non
gli piace?» e continua nella stessa lettera:
Non capisco cosa vogliate dire sulle difficoltà sì pel buon senso che pel
teatro!! Del resto tanto più Cammarano mi presenterà novità, libertà di
forme io farò meglio. Faccia pure tutto quello che vuole: tanto più sarà
ardito io sarò più contento. Solo abbia di mira le pretese del pubblico
Per la genesi dell’opera e i rapporti con Cammarano relativi alla stesura del
libretto cfr. la prefazione all’edizione critica della partitura a cura di David
Lawton, pubblicata da Ricordi / The University of Chicago Press nel 1993.
17
Carteggio Verdi-Cammarano (1843-1852), a cura di C. M. Mossa, Parma,
Istituto Nazionale di Studi Verdiani, 2001.
16
23
che vuole brevità. A voi dunque che siete suo amico sollecitatelo a non
perdere un minuto di tempo18.
Verdi dunque cerca il nuovo, vuol cimentarsi con qualche cosa che gli
altri non abbiano ancora fatto; inoltre, la ricerca della brevità, della
concentrazione, costituisce una legge ineludibile della sua drammaturgia.
Una lettera a Cammarano del 4 aprile 1851 ci mostra come il
compositore fosse attento ai minimi particolari del libretto:
La scena della monacazione bisogna lasciarla (è cosa troppo originale
perché io vi possa rinunciare) ed anzi bisogna cavarne tutto il partito,
tutti gli effetti possibili. Se non volete che la monaca [Leonora] fugga
volontariamente fate che il Trovatore (con molti seguaci) la rapisca
svenuta. È vero che la Gitana [Azucena] fa intendere che Manrique non
è suo figlio, ma è una parola che le sfugge nel racconto e che la ritira sì
presto che il Trovatore, lontano dal pensare cosa simile, non può
credere sia quella una verità. La Gitana non salva sé e Manrico perché
sua madre sul rogo le aveva gridato: ‘Vendicami!’. Altrove dice: ‘il
feroce fantasma, le braccia verso me tendendo, urlò: Vendicami! […] e
si lanciò tra le nubi nell’aria ripetendo: Vendicami!’ L’ultima parola del
dramma: ‘è sei vendicata’19.
E, sempre rivolto al librettista:
Voi non dite una parola se questo dramma vi piace: io ve l’ho proposto
perché pareva mi presentasse bei punti di scena, e soprattutto qualche
cosa di singolare e di originale nell’insieme. Se voi non eravate del mio
parere, perché non mi avete suggerito altro argomento?
Ma queste parole significavano poco per Cammarano, perché il suo
“programma”, quando arrivò, fu sul punto di indurre Verdi ad abbandonare il
progetto. C’è ancora una lettera in cui sembra scontento del libretto del
Trovatore:
Parmi, o m’inganno, che diverse situazioni non abbiano la forza e l’originalità di prima, e che soprattutto Azucena non conservi il suo
carattere strano e nuovo; parmi che le due passioni di questa donna,
amor filiale e amor materno, non vi sia più in tutta la loro potenza. Per
esempio non amerei che il Trovatore restasse ferito nel duello. Questo
18
19
Cit. in J. BUDDEN, Le opere di Verdi, cit., vol. II. p, 65.
Ibidem, pp. 65-67.
24
povero Trovatore ha sì poco per lui che se gli togliamo valore che cosa
gli resta? Come interessare Leonora sì alta di rango? Non mi piacerebbe
che Azucena facesse il racconto ai Zingari; che nel pezzo concertato 3 a
parte, dicesse: “Tuo figlio fu arso vivo” ecc. ecc. “ma io non v’era” ecc.
ecc.; e finalmente non la vorrei pazza in ultimo. Desidererei che
lasciaste la grand’Aria!! Eleonora non ha parte con Canto dei morti e la
Canzone del Trovatore, e mi sembra questa una delle migliori posizioni
per un’Aria.
Il carteggio tra Verdi e Cammarano va avanti con minute osservazioni
sulla composizione dell’opera che nel giugno viene funestata da un evento
inatteso e tragico: l’improvvisa morte del librettista. Questo fatto scompagina
il piano di Verdi e gli impone la necessità di cercare un altro collaboratore che
porti a termine il lavoro: lo trova in Emanuele Bardare, giovane poeta che
accetta con entusiasmo l’idea di lavorare per Verdi e rifinire il libretto del
predecessore che era, a dire il vero, praticamente concluso20.
Ma, nella composizione di un’opera, non è solo il rapporto con il
librettista che conta, è anche la disponibilità di certi interpreti. Come tutti i
grandi operisti, Verdi scrive su misura per determinati cantanti, e la figura
dell’interprete è strettamente connessa a quella dei suoi personaggi. Ci sono
casi, nell’epistolario verdiano, in cui il musicista afferma di aver in mente un
personaggio proprio per un determinato cantante, altri in cui rifiuta un cantante
perché inadatto al personaggio che sta per nascere. Ecco alcuni giudizi sui
cantanti del Trovatore, che doveva essere rappresentato al Teatro Apollo di
Roma, espressi dall’amico De Sanc-tis che, il 23 ottobre 1852, così informava
Verdi:
La Penco [prima interprete di Leonora] […] ha dei difetti ma molti
pregi […]. Ella non è soprano perfetto. Vi dirò che è molto graziosa,
attento Maestro! Vi avverto però che è un demonio! Al certo bastonerà
l’altra prima donna. Mi dicono che la Goggi [Azucena] sia una vecchia
artista; voi la ringiovanirete con la magia della vostra musica. Maestro,
tutti attendiamo un capolavoro nel Trovatore. Verdi con la sua musica
deve eternare l’ultimo lavoro del Cammarano21.
L’annotazione sull’aspetto fisico della cantante mostra che Verdi dava
grande importanza all’allestimento scenico delle sue opere che, negli anni
successivi, verrà minutamente illustrato nelle cosiddette “disposizioni
20
21
Cfr. J. BUDDEN, Le opere di Verdi, cit., vol. II, p. 68.
Ibidem, p. 68.
25
sceniche”, in cui è descritto tutto lo spettacolo: costumi, scene, azione, gesti
dei singoli e delle masse. Leggendo questi veri e propri «copioni di regia»,
muta completamente l’immagine vulgata del melodramma ottocentesco che,
nelle sue espressioni più alte, era uno spettacolo estremamente curato sul piano
scenico. Ciò che colpisce, nelle intenzioni di Verdi, è il desiderio di rendere
ogni gesto significativo, evitando pose scomposte ed esagerazioni retoriche per
far sì che l’azione e i sentimenti dei personaggi si esprimano con la massima
verità
e
naturalezza:
una
concezione
registica
assolutamente
«antimelodrammatica» e vicinissima al gusto moderno. Ecco perché la
considerazione della personalità dell’interprete, sotto il profilo scenico e
musicale, era determinante, e il rapporto diretto con l’ese-cutore, le sue
esigenze, pretese e capacità di comprendere il valore della musica a lui
destinata entrava quotidianamente nel lavoro compositivo. Lo documenta, ad
esempio, una lettera a Francesco Maria Piave del 17 aprile 1853, che riguarda
la messa in scena del Trovatore a Venezia, dove Marianna Barbieri Nini
doveva cantare la parte di Eleonora, e non amava l’aria «Tacea la notte
placida». Ecco il drastico giudizio di Verdi:
Saluterai la Barbieri e le dirai che parmi la cavatina del Trovatore
buona, che io perciò non posso né devo cambiarla. Sarebbe un suicidio!
Se mi è lecito dire la mia opinione, perché la Barbieri fa quella parte se
non ci sta bene? E volendo pur fare il Trovatore, c’è un’altra parte,
quella della Zingara. Bando alle convenienze, né si dica, è una parte
secondaria: no davvero: è prima, primissima, più bella, più drammatica,
più originale dell’altra. Se io fossi primadonna (il bell’affare!) farei
sempre nel Trovatore la parte della Zingara22.
Nella prima esecuzione del Trovatore, il 19 gennaio 1853, i cantanti erano:
Rosina Penco, nella parte di Leonora, Emilia Goggi come Azucena, Giovanni
Guicciardi, baritono, nella parte del Conte di Luna e il tenore Carlo Baucardè in
quella di Manrico.
22
Ibidem, pp. 72-73.
26
Capitolo secondo
Atto primo (Parte prima: Il duello)
N. 1 Introduzione «All’erta!» (Ferrando, Coro)23.
L’opera è divisa in quattro atti, chiamati «parti», ciascuna
contrassegnata da un titolo che indica per due volte un personaggio, e per altre
due una situazione: «Il duello», «La gitana», «Il figlio della zingara», «Il
supplizio».
Il Trovatore non possiede Ouverture. Il sipario si leva, durante la breve
introduzione strumentale, sull’«atrio del palazzo dell’Aliaferia. Da un lato
porta che mette agli appartamenti del Conte di Luna. Ferrando e molti
Familiari del Conte giacciono presso la porta: alcuni Uomini d’arme
passeggiano in fondo».
L’azione avviene parte in Biscaglia, parte in Aragona, all’inizio del
secolo XV, nel tardo medioevo spagnolo. Il Conte di Luna comanda le truppe
fedeli alla Principessa d’Aragona, nella guerra da lei condotta contro un
ribelle, il Conte d’Urgel. L’idea dell’ambiente è molto importante per Verdi.
La musica della prima scena riflette, infatti, il carattere militaresco della
fortezza medievale di Saragozza, dominata dal grigio della pietra e del ferro,
nell’oscurità della notte. Ferrando è lo scudiero del Conte di Luna; i Familiari
sono i servi accompagnati da soldati. L’opera inizia quindi con personaggi
secondari. Ferrando è un basso che, unito al coro di tenori e di bassi, conferisce
un colorito scuro all’Introduzione, aperta dall’esortazione di Ferrando ai servi
che stanno dormendo:
All’erta, all’erta! Il Conte
n’è d’uopo attender vigilando, ed egli
talor, presso i veroni
della sua cara, intere
passa le notti.
Familiari
Gelosia le fiere
23
La suddivisione della partitura in numeri è quella proposta dalla edizione
critica a cura di David Lawton, pubblicata da Ricordi / The University of
Chicago Press nel 1993.
27
serpi gli avventa in petto!
Ferrando
Nel Trovator, che dai giardini move
notturno il canto, d’un rivale a dritto
ei teme!
In questi versi c’è una densità d’informazioni che non può essere
casuale. Apprendiamo che il Conte s’apposta sotto i balconi di una donna, di
notte, e che il Trovatore lo disturba con un canto che si diffonde nei giardini.
Le immagini contengono in nuce un contrasto drammatico fra tre personaggi e
un movimento ambientale: è già un piccolo esempio di concentrazione
narrativa, tipicamente verdiana. La parte di Ferrando è una specie di mappa
dell’opera, ci dice tutto di quello che è successo, ci parla dei personaggi e dei
loro rapporti, di una donna amata da due uomini, di una zingara, dei giardini,
della notte. Subito dopo, Ferrando inizia a raccontare la storia avventurosa e
macabra del fratello del Conte di Luna. Il vecchio Conte aveva due figli:
accanto alla culla del minore, la nutrice aveva trovato, una mattina, una zingara
che era stata immediatamente cacciata. Ma il bimbo, stregato, aveva
cominciato a deperire; la zingara era stata allora condannata e arsa sul rogo. La
figlia di costei, per vendicarsi, aveva rapito il bambino: in seguito erano stati
trovati, sul luogo stesso del rogo, i resti di un bimbo bruciato. Il vecchio Conte
era morto pochi giorni dopo, facendosi promettere dal figlio maggiore che
avrebbe in ogni modo continuato le ricerche per rintracciare il fratello.
Questo racconto, con immagini al limite del grottesco, c’introduce in un
mondo d’azioni eccessive, passioni smisurate, fatti abnormi che ci possono far
sorridere, nei poveri versi del Cammarano: poveri ma non sprovveduti, perché,
come vedremo, sono assolutamente funzionali alle esigenze della musica di
Verdi, volta a destare la curiosità dello spettatore, creando una tensione
narrativa in un’atmosfera fosca, notturna, in cui albergano immagini di paura,
terrore e mistero, ma anche guizzi di zingaresca vivacità.
Verdi imprime un ordine preciso alla scena, affermando, sin dall’inizio,
il carattere molto strutturato dei brani del Trovatore che sono sempre assai
semplici come articolazione formale. Il primo episodio (fino a «ei teme») è
preceduto da una breve introduzione strumentale, con una serie di segnali che
si susseguono uno dopo l’altro, con effetto quasi spaziale: triplice rullo della
grancassa e del timpano, nel registro basso, sempre più forte; fanfara della
grande orchestra in fortissimo; appello del corno. Gli arpeggi, legati, in
pianissimo, segnano l’alzarsi del sipario che mostra Ferrando e molti servi del
Conte sdraiati e assonnati presso la porta, mentre, sullo sfondo, alcuni soldati
passeggiano: il disegno degli archi, mollemente adagiato in un gioco imitativo
e punteggiato dal triplice richiamo delle trombe, dà un senso di attesa e di
28
torpore. I servi si stanno addormentando, e Ferrando, subito dopo, li richiama
alla veglia. Ma questa successione di segnali non è solo narrativa: crea un
effetto spaziale. C’è un senso di profondità dato dal rullo iniziale che si
avvicina a poco a poco, passando dal piano al fortissimo; l’effetto di un
accecante primo piano nello squillo della fanfara militaresca a piena orchestra;
poi un’idea di lontananza nell’appello, pianissimo, del corno che sembra
provenire da chissà dove, e annuncia qualcosa di misterioso, notturno,
impreciso. Naturalmente è una spazialità immaginaria, creata in virtù della
dinamica (contrasto tra piano e forte) e dei colori timbrici: ma fissa una
dimensione «stereofonica», articola una spazialità sonora che avrà grandi
sviluppi nel corso dell’opera.
Subito attacca il canto di Ferrando, con un recitativo abbastanza
convenzionale, pausato dai commenti del coro («All’erta! All’erta!»). Alle
parole «d’un rivale a dritto ei teme», finisce la parte introduttiva: il tempo
cambia, inizia un Moderato in Sol maggiore in cui il coro chiede a Ferrando
che gli venga raccontata la vera storia di García, fratello del Conte. E Ferrando
attacca la sua ballata, che narra un fatto lontano, circondato da un’aura
misteriosa e leggendaria. Nella partitura questo pezzo è indicato come
«Racconto» che non è una definizione musicale, come «aria», «cabaletta»,
«cavatina» ma letteraria. La ballata aveva una forte circolazione nella musica
europea del tempo, specie in Germania, dove costituiva un genere ricorrente
nella produzione liederistica per canto e pianoforte. Sua caratteristica è la
forma strofica, qui molto semplice: A–B–A’–B’ corrispondente ai seguenti
versi:
A
B
A’
B’
Di due figli vivea padre beato
Abbietta zingara fosca e vegliarda
Asserì che tirar del fanciullino
La fattucchiera perseguitata
Qui le due sezioni A–B si ripetono, con pochissime varianti. La prima
sezione:«Di due figli vivea, padre beato, | il buon Conte di Luna» presenta
versi endecasillabi, alternati a settenari, mentre quelli che seguono sono
quinari doppi: «Abbietta zingara, fosca vegliarda!»: il mutamente ritmico è
riflesso dalla musica in modo evidentissimo. Il compositore avrebbe potuto
mascherarlo in una forma a sviluppo continuo, senza salti: di fronte al testo il
musicista ha sempre una gran libertà di scelta. Qui Verdi intende esaltare
proprio lo scatto energetico che si determina nel passaggio tra i due tipi di
versi che, dal punto di vista del contenuto narrativo e dell’impostazione
retorica, sono del tutto affini.
29
Il canto di Ferrando inizia in modo tranquillo, con una specie di
preambolo in cui la melodia si mette in moto a poco a poco. La voce è
accompagnata dal suono cupo di clarinetto e fagotto che creano intorno alle
prime frasi un clima di mistero:
Sul romper dell’aurora un bel mattino
ella dischiude i rai;
e chi trova d’accanto a quel bambino?…
Con quest’ultimo verso, in orchestra c’è una discesa cromatica, fosca e
presaga. Tutto il pezzo è punteggiato da frasi striscianti che sembrano uscire
dall’ombra con il loro andamento serpeggiante, oscurissimo. Si entra, poi, nel
cuore dell’argomen-to, e la musica cambia completamente.
Abbietta zingara, fosca vegliarda!...
cingeva i simboli di maliarda!
E sul fanciullo, con viso arcigno,
l’occhio affiggeva torvo, sanguigno!
D’orror compresa è la nutrice!
Acuto un grido all’aura scioglie;
ed ecco, in meno che il labbro il dice,
i servi accorrono in quelle soglie:
e fra minacce, urli e percosse
la rea discacciano, ch’entrarvì osò.
Il racconto si svolge su una musica che si ripete con caratteristiche
fisse. La tonalità di mi minore, il ritmo in 3/4 come di valzer, la sonorità in
pianissimo, il canto con appoggiature e quartine di semicrome staccate su
tempo forte, i salti di ottava con accenti sulla nota acuta, suggeriscono un
colorito avventuroso, quasi zingaresco, ma avvolto da un senso di mistero: c’è
come un suono soffocato di nacchere che crepitano nella voce del basso, se il
cantante è capace di sgranare le quartine con scattante precisione. Le
figurazioni che si susseguono acquistando tensione, scattano ritmicamente una
dopo l’altra, come una molla che s’avvita, portando avanti il discorso con
quella spinta energetica in cui sta il senso drammatico della scena. Il carattere,
tipicamente verdiano, del pezzo, consiste nel suo progressivo caricarsi
d’energia, mentre la sonorità sale da piano a forte e il coro esplode in
fortissimo, con martellante durezza ritmica:
Giusto quei petti sdegno commosse;
l’insana vecchia lo provocò!
30
La tensione momentaneamente si scarica, per riprendere subito dopo.
Ferrando ricomincia. Si noti come Verdi intona questi versi:
Coverto di pallor, languido, affranto
ei tremava la sera,
il dì traeva in lamentevol pianto...
Ammaliato egli era!
Ecco un caso evidente di parola scenica. Le parole, nel racconto di
Ferrando, non si capiscono, ma l’espressione «ammaliato egli era!» è invece
chiarissima, perché mette a fuoco la situazione insieme ad «abbietta zingara»:
due parole sceniche che fissano gli elementi essenziali del racconto: il tono
zingaresco e una fatalistica minaccia che aleggia su tutto il pezzo. Qui
l’elemento zingaresco è oggettivato attraverso il racconto di persone e fatti
lontani: vedremo, invece, l’immediatezza che Verdi gli conferirà nelle grandi
scene in cui è protagonista Azucena. Anche la paura, il terrore, sono sospinti
sullo sfondo del racconto, nelle striature sinistre delle frasi cromatiche che
compaiono qua e là; e il fatalismo è annidato nella pulsazione ritmica costante,
un meccanismo che, una volta messosi in modo, sembra difficile frenare.
La regolarità del canto di Ferrando, la sua pulsazione in tre quarti, così
ostentata, richiamano un suono d’organetto, rivelando un’evidente componente
popolare portata a livello d’arte, ossia dotata di una forte capacità di
raffigurazione evocativa. La ballata si conclude con un episodio nuovo, in cui
il declamato-recitativo di Ferrando è molto semplice, mentre gli archi
continuano a fare disegni misteriosi, di tremoli e note tenute («Brevi e tristi
giorni visse»). Come in un quadro ci possono essere ai margini, nell’oscurità,
personaggi non ben identificati, di contorno alla scena principale, così succede
nel Trovatore. Questa introduzione, difatti, non presenta un vero personaggio,
ma una voce che racconta, un ambiente dai contorni ancora imprecisi che
prende forma nel connubio tra evocazione zingaresca, vivacità pittoresca e
striature paurose che culminano alla fine, quando Ferrando ricorda la credenza
popolare secondo cui l’anima della strega aleggerebbe, di notte, in varie forme,
sul mondo che l’ha condannata. A queste affermazioni il coro commenta: «È
vero, è vero, è vero, è vero», mentre l’orchestra si ostina in un lento disegno
cromatico che va morendo, con sinistro mormorio.
Scatta qui la coda del pezzo, con l’evocazione delle apparizioni
notturne della strega appostata sull’orlo dei tetti in forma di pauroso uccello:
upupa, strige, corvo, civetta, gufo. La vide, una notte, un servo che morì di
paura nel momento in cui suonava la mezzanotte. Questo Allegro assai agitato,
estremamente piano, conclude l’introduzione in un crescendo irresistibile di
31
energia ritmica: i martellanti senari doppi sono scanditi dalla diminuzione
ritmica su tempo forte, che aveva già conferito al canto di Ferrando un
singolare scatto zingaresco, e che qui raggiunge un effetto di scossa elettrica
nelle terzine che colpiscono la seconda sillaba di ogni senario, facendola
rabbrividire: «Sull’óorlo dei tetti | alcúun l’ha veduta», terzine che fremono
come colpi di tamburello nella voce oscura del coro maschile, ridestano
l’atmosfera gitana, le conferiscono un’eccitazione motoria tanto più efficace in
quanto soffocata nel pianissimo. Il profilo della terzina diventa ascendente, con
maggior spinta propulsiva, quando entra la voce di Ferrando («Morì di
paura»), mentre il tema accumula energia, tra le parole isolate di Ferrando e i
lamenti del coro in gustoso controtempo («Morì… Ah!… Morì… Ah!…
Morì… Morì!») e, dopo una ripresa da capo, è improvvisamente interrotto dal
suono di una campana: la mezzanotte, evocata nel testo, scocca per davvero, il
coro leva un grido di terrore «Ah sia maledetta la strega infernal!», mentre il
tempo accelera in un Poco più mosso, che conclude il brano: il ritmo
zingaresco, allora, ricompare, diminuendo in pianissimo e sbriciolandosi, a
poco a poco, in frammenti, mentre i servi accorrono verso la porta per
rifugiarsi e i soldati accorrono in fondo: due mazzate in fortissimo pongono
fine allo strisciante, sinistro e pauroso decrescendo.
Alla fine del pezzo, che ha proprio il carattere di un’aria solistica, con
recitativo, tempo di attacco, recitativo e cabaletta (corale), si è dunque creato
un clima di sospensione e di spasmodica attesa. Il sipario si è richiuso, ma, nel
teatro buio, l’atmosfera vibra, ora, dell’elettricità prodotta dall’originalissima
invenzione ritmica che percorre tutta l’Introduzione.
Il Trovatore ci presenta, quindi, subito un esempio di massima
individualizzazione di un brano, attraverso melodia, ritmo, colore vocale ed
orchestrale, armonia elementare, appena “sporcata” dagli occasionali
cromatismi. Il pezzo può piacere o non piacere, ma, a differenza di tanti
numeri delle opere precedenti, si stampa nella nostra memoria con forza
indelebile. Le sue funzioni, drammatiche e musicali, sono molteplici: possiede
tutto il potere d’evocazione zingaresca e avventurosa presente nel testo; riesce
a fondere il tono di lontananza leggendaria del racconto con l’immediatezza
delle reazioni di chi vi assiste; rende presente, nel suono della campana,
l’immagine della mezzanotte che batte, contenuta nel racconto di un fatto
avvenuto; crea dunque un senso di ambigua interferenza tra passato e presente
che tornerà, enormemente ingigantito, in altre situazioni dell’opera, come una
specifica caratteristica drammatica e narrativa; e, ancora, opera un distacco
dalla scena rappresentata attraverso un ritmo oggettivo, quasi meccanico, che
non vuole essere ironico, ma esibisce, comunque, un’ebbrezza compositiva in
senso propriamente artigianale, di contagiosa, salubre vitalità.
32
La ballata di Ferrando è statica: tutto succede solo nell’im-maginazione
del racconto. La musica, però, dinamizza la situazione, facendo seguire, uno
dopo l’altro, in successione, racconto e dialogo, melodia chiusa e declamato:
uno interrompe l’altro, uno è il contrario dell’altro e, da questa successione,
nasce l’ener-gia che sale fino alla stretta finale, generando nell’ascoltatore un
senso di progressiva, spasmodica attesa in cui consiste il significato
drammatico dell’Introduzione. È dunque un primo esempio di quell’arte della
dinamizzazione musicale del pezzo statico di cui Verdi darà, nel Trovatore, i
saggi più geniali di tutta la sua carriera.
N. 2 Cavatina «Ché più t’arresti?»; «Tacea la notte placida» (Leonora,
Ines).
La scena si svolge nei «giardini del palazzo. Sulla destra, marmorea
scalinata che mette agli appartamenti. La notte è inoltrata; dense nubi coprono
la luna. Leonora ed Ines».
Tra la prima e la seconda scena del Trovatore c’è un cambiamento
molto importante di scenografia: Ferrando aveva evocato i giardini che ora si
spalancano alla vista dello spettatore. Verdi era molto attento alle didascalie
dei suoi libretti, scarne ma infallibili nell’indicare la presenza di alcuni oggetti
essenziali per definire la situazione. Il giardino, appena illuminato dalla luna, è
bordato sulla destra dalla scalinata marmorea, non di pietra, quindi bianca, in
contrasto con l’atrio grigio della prima scena. Il marmo ha riflessi diversi dalla
pietra, con evidente conseguenza sul gioco delle luci: dall’ambiente militare,
duro e aspro, si passa a quello accogliente di un elegante giardino. «Dense nubi
coprono la luna»; non si tratta, dunque, di un cielo stellato, ma di una notte che
annuncia cattivo tempo, preannuncio della tempesta di passioni che si
scatenerà di lì a poco.
Per questa scena Verdi scrive musica vaporosa, atmosferica, e sfumata
che sarebbe impensabile in un ambiente chiuso e ben illuminato. Leonora è la
dama di compagnia della Principessa d’Aragona, personaggio nobile, non
popolare come quelli che hanno aperto l’opera. Ha voce di soprano, ed entra in
scena con la sua confidente, soprano pure lei. Ines è l’unica che accompagni
Leonora nel corso della vicenda. Motivo, questo, di particolare stupore per i
contemporanei che notarono come la protagonista femminile del Trovatore
rimanesse, per tutta l’opera, praticamente sola, elemento in più d’originalità in
un libretto controcorrente rispetto alle abitudini del melodramma italiano del
primo Ottocento. Così si esprimeva, infatti, la «Gazzetta Musicale di Milano»
il 25 settembre 1853:
33
Chi è questa giovane innamorata che dispone così liberamente
del suo cuore, di sé medesima, senza un avolo, un padre, uno zio, un
parente, un qualcuno che la tuteli? Per poco, anziché un’onesta
vereconda fanciulla, non la si direbbe una spensierata e capricciosa
vedovella?24
Con spensierate e capricciose signore e signorine il melodramma
italiano del Sette-Ottocento, specialmente quello buffo, aveva avuto sempre
una gran confidenza. È chiaro, dunque, che il recensore della «Gazzetta
Musicale» nel giudicare il comportamento drammatico di Leonora, pensasse
ad una tipologia ben precisa nella definizione del personaggio e di chi le stava
intorno. Ma l’originalità delle figure del Trovatore sta, appunto, nella loro
indipendenza dalle tipologie correnti, sentite da Verdi come un ostacolo a
quella ricerca d’originalità che s’afferma con prepotenza nella sua produzione,
almeno a partire dal Macbeth. Nascono, così, le strane figure di Manrico,
poeta, trovatore, e condottiero d’eserciti, allevato da una zingara e innamorato
di un’aristo-cratica; e, soprattutto, d’Azucena, zingara e madre, rapita in un
affetto traboccante, travagliata da un’ossessione terribile.
Ines comincia la scena con un dialogo da cui s’apprende che Leonora
attende, ormai da varie notti, di vedere un uomo che ha acceso in lei un amore
pericoloso (si tratta, infatti, d’un nemico, rappresentante della fazione di Urgel
che combatte gli aragonesi); un giorno, in un torneo, lei stessa ha posto sul suo
capo la corona della vittoria. Il cavaliere sconosciuto era vestito di scuro, non
aveva stemmi sullo scudo; apparve quel giorno, poi sparì, inghiottito dalla
guerra civile. Il recitativo che racconta questi eventi s’accende d’emozione
nell’evocazione del torneo, con tremoli in orchestra, e sfocia in un Andante,
quando Eleonora evoca l’apparizione del guerriero, bello come in un sogno:
alla linea vocale del declamato che s’impregna di melodia, diventando arioso,
s’uniscono un trillo dei violini dal suono algido e dal colore lunare, mentre
flauto e clarinetto, alle parole «come d’aurato sogno» tessono un
accompagnamento d’arpeggi. È musica evidentemente basata sul potere
suggestivo del timbro degli strumenti che, in questo caso, evoca l’atmosfera
del sogno.
L’aria che segue, «Tacea la notte placida», Andante in 6/8, in bemolle
minore, è un grandissimo pezzo di sortita, una delle arie più belle di Verdi e di
tutta la storia dell’opera: «per concentrazione di lirismo poetico – scrive
Budden – ‘Tacea la notte placida’ non ha rivali in tutta la musica verdiana,
24
Cit. in G. RONCAGLIA, Giuseppe Verdi, cit., p. 193.
34
mentre come tour de force di magistrale tornitura melodica non teme nessun
possibile confronto»25.
L’aria di Leonora evoca, come in un sogno, il ricordo del felice
momento passato.
Tacea la notte placida,
e bella in ciel sereno,
la luna il viso argenteo
mostrava lieto e pieno;
La musica dapprima rappresenta l’ambiente: tutto è calmo e tranquillo,
nella tonalità di La bemolle minore. Inizia con note ribattute che creano un
senso di fissità: come una superficie acquatica liscia e piana nel silenzio della
notte, cui allude il mormorio degli accordi ribattuti in orchestra. Ma la melodia
non riposa in se stessa. Crea un clima di tensione sospesa che culmina nei versi
seguenti, « Quando suonar per l’aere | infino allor sì muto», dove succede
qualcosa di nuovo. Verdi scrive animando un poco: il canto ribatte alcune
note, come se la melodia scivolasse nel parlato, per arrestarsi in due note
tenute. Il senso d’attesa si fa così molto alto, e tanto più intenso sgorga quindi
lo sfogo melodico dei versi seguenti: «Dolci s’udiro e flebili | gli accordi d’un
liuto». Meravigliosa idea melodica che fa salire cromaticamente la voce da do
a fa, mentre l’oscurità del minore si rovescia nella chiarità del la bemolle
maggiore e l’accompagnamento acquista la dolce circolarità di un valzer: gli
archi, che si erano limitati a sostenere il canto con accordi ribattuti,
raddoppiano ora la linea vocale, e la sostengono con una calda ondata di suoni.
Dalla staticità della prima fase, dunque, la melodia si è staccata – con
espressione – evocando i suoni del liuto che hanno aperto a Leonora l’universo
dell’amore e risuonano, ora, nel suo ricordo. Verdi però non s’attarda ad
illustrare il canto del Trovatore e il pizzico del liuto, come avrebbe potuto fare:
rende, invece, l’effetto che il canto ha prodotto nell’animo della ragazza e la
sua melodia restituisce con una freschezza pari all’intensità. Ma non è finita:
queste grandi arie verdiane presentano una successione di continue sorprese.
Nei versi seguenti: «E versi melanconici | il trovator cantò» la melodia,
improvvisamente, si impenna, sale fervidamente con un ritmo di breve-lunga,
sino al si bemolle acuto cui segue un momento di riposo. L’aria è quindi
ripetuta da capo (è perciò una forma A-A’), a cominciare dalla seconda strofa
di settenari, con alcune varianti su parole che illuminano il significato del
pezzo, suggerito dagli ultimi tre versi: «Al core, al guardo estatico | La terra un
ciel sembrò!». Qui la voce, che sale irresistibile sino al do acuto, e l’orchestra
25
J.BUDDEN, Le opere di Verdi, cit., vol. II, p. 82.
35
che l’accompagna con un tremolo in poderoso crescendo spiegano la natura
dell’amore di Leonora. Questa conclusione ha qualcosa di possente e di
travolgente: l’amore diventa estasi, slancio grandioso, liberatoria esaltazione
che, come dicono i versi di Cammarano, trasforma in paradiso la vita terrena.
Per rappresentare questo panico entusiasmo, la melodia s’impenna in modo
tipicamente verdiano: così, l’espres-sione amorosa non si ripiega su se stessa
in un segreto struggimento alla Bellini, ma implica una tensione energetica,
una forza morale; quella stessa che porterà Leonora, addirittura, al sacrificio
della vita. Verdi concepisce, dunque, la melodia vocale come dialettica di
momenti tra loro contrastanti, anche sul piano fraseologico: l’aria inizia in
modo molto regolare, con frasi di 4+4 battute; ma negli ultimi due versi di
ciascuna strofa, quelli della travolgente salita in crescendo, che quasi
suggerisce alla cantante il gesto di abbracciare tutto il mondo nella sua
esaltazione amorosa, la frase melodica si allarga in sette battute (6+1) concluse
da una cadenza che suona come libero sfogo d’entusiasmo.
Da notare un particolare: se nella ripresa il testo è generalmente poco
comprensibile perché nascosto, e stirato sotto la melodia, chiarissima è invece
la pronuncia dei versi «In quella ripeteasi | un nome…il nome mio!». È
un’altra parola scenica che coglie il legame tra i due personaggi e spiega il
coinvolgimento di Leonora nel fuoco, tipicamente romantico, dell’amorepassione che va ben al di là del sentimento individuale e acquista un respiro
cosmico.
A questo punto, la scena viene interrotta dalla ripresa del dialogo con la
confidente Ines che, quasi spaventata dall’esalta-zione della sua signora, le
dice di nutrire un triste presentimento circa la presenza, nella sua vita, di
quell’«uomo arcano» appena evocato: «tenta obliarlo», le raccomanda, senza
troppa speranza di essere ascoltata. Questo dialogo viene svolto nel cosiddetto
tempo di mezzo, tipico della forma quadripartita che l’aria italiana assume
all’inizio dell’Ottocento: recitativo–cantabile–tempo di mezzo e cabaletta, dal
carattere dinamico, concentrato e fortemente energetico. È quanto succede
nell’intonazione dei settenari seguenti:
Di tale amor che dirsi
mal può dalla parola,
d’amor che intendo io sola,
il cor s’innebriò!
Il mio destino compiersi
non può che a lui dappresso…
s’io non vivrò per esso,
per esso io morirò!
36
Dopo lo straordinario Andante, Verdi prosegue nella rappresentazione
dell’amore di Leonora come esaltazione passionale che trasforma l’esistenza,
mutando la terra in cielo: nella cabaletta, Allegro giusto in la bemolle
maggiore, la voce è, infatti, trasformata in uno strumento che gorgheggia in
uno scoppiettio di note acrobatiche, da soprano leggero. Delle parole non si
capisce assolutamente nulla: solo contano i vocalizzi, i trilli, le volatine in cui
il canto si frastaglia con brillante leggerezza. Questo è un effetto tipicamente
melodrammatico: l’allontanamento dalla parola e la consegna totale alle
possibilità espressive della musica che, nella sua leggerezza, rende qui la
giovinezza del personaggio, l’ebbrezza della ragazza innamorata. Tutto
dev’essere quindi, nell’esecuzione, estremamente lieve, mordente e vitale:
come l’aria, anche la cabaletta, secondo le prescrizioni di Verdi, va cantata
quasi tutta in pianissimo.
Notiamo, qui, l’insistente presenza di un ritmo giambico di breve-lunga:
ta-tà, che già avevamo sentito in alcuni passi dell’aria precedente (proprio
nella sezione conclusiva della melodia che, sulla pulsazione di breve-lunga,
saliva «dalla terra al cielo»). Il giambo, nel suo scatto, ha un carattere
fortemente propulsivo, molto energico e può essere solenne, se eseguito lento,
oppure nervoso e sferzante in maggiore velocità. Proprio per la presenza
dominante di questo ritmo, la cabaletta dà un’ulteriore spinta energetica a
quello che abbiamo sentito prima, e conclude la scena con una serie di fuochi
d’artificio vocali che, lungi dall’essere puramente decorativi, esprimono il
sorriso di Leonora persa nella fantasticheria amorosa, lo sguardo che brilla,
l’entusiasmo che infiamma la voce e brucia le parole.
Si manifesta dunque nella scena di Leonora un atteggiamento
espressivo che caratterizza ogni personaggio del Trovatore. Nella Traviata
Verdi intende costruire un personaggio che si evolve nel tempo attraverso un
itinerario di trasformazione. Violetta, alla fine dell’opera, è un’altra persona
rispetto a quella che abbiamo conosciuto all’inizio. Così, Rigoletto vive una
vicenda che lo muta interiormente. I personaggi del Trovatore, invece, non si
trasformano, ma ogni situazione ne mostra sentimenti diversi, come una statua
che, colpita da fasci di luce provenienti, di volta in volta, da varie angolature,
rivela tratti differenti e inattesi, pur restando immutata. A differenza di
Rigoletto e della Traviata, dove il tempo vive, pulsa, scorre velocissimo o
s’arresta in rapporto allo stato psicologico dei personaggi, la drammaturgia del
Trovatore sembra uscire dal tempo, perché fondata sull’esplo-sione di
momenti passionali isolati da un continuum psicologico e cronologico.
Naturalmente, quest’atteggiamento di Verdi nei confronti del suo dramma
porta a soluzioni diverse, sul piano stilistico ed espressivo, rispetto a Rigoletto
e alla Traviata, specie per quanto riguarda il rapporto tra musica e parola.
Abbiamo già notato in queste prime scene dell’opera che la parola viene
37
sbriciolata nella musica; non si sente, non si percepisce, perché l’idea musicale
è più forte di ciò che esprime la parola col suo significante e il suo significato.
Quest’assoluta prevalenza dell’idea musicale serve per dare all’espressione
passionale la sua massima forza. Nel Rigoletto e nella Traviata, in cui
l’interesse di Verdi s’appunta sulla trasformazione psicologica dei protagonisti,
la melodia sembra sovente estratta dal suono stesso della parola e da quello che
potremmo chiamare il tono della recitazione. La prova sta nel fatto che,
quando rammentiamo le melodie della Traviata, ci vengono in mente le parole,
mentre è impossibile ricordare quelle del Trovatore perché, in realtà, non le
abbiamo mai percepite. Così, in Rigoletto, il declamato è fatto oggetto di una
ricerca costante e audacemente innovativa; nel Trovatore, in pratica, esso non
esiste, e i recitativi sono sbrigati con voluto, necessario disinteresse.
N. 3 Scena «Tace la notte», Romanza «Deserto sulla terra» e Terzetto
«Qual voce… Ah dalle tenebre» (Leonora, Manrico, Conte).
Dopo l’aria, Leonora si ritira con Ines, e la scena rimane vuota. Nella
perdurante oscurità, arriva il Conte di Luna, baritono, gentiluomo aragonese di
cui Ferrando parlava nella prima scena: anche stanotte egli s’apposta sotto i
veroni della sua dama (si noti la logica concatenazione e la stringente sintesi
narrativa del libretto). L’entrata del Conte, aperta da disegni striscianti in
orchestra, presenta un declamato abbastanza melodico che allude all’alta
temperatura erotico-passionale del personaggio, e all’«a-morosa fiamma» che,
in lui, «arde ogni fibra». Nella successione degli accordi iniziali si vede
l’ombra oscura del Conte che si muove sulla scena; la musica non è
straordinaria, ma efficacissima per rendere l’atmosfera notturna e furtiva della
situazione. Un tremolo in orchestra rende eccitata l’invocazione a Leonora,
uno sbocco melodico pieno di slancio traduce «Ah l’amorosa fiamma», con un
trasporto improvviso. Dunque, quando l’emozione sale, la melodia s’inarca,
affiora e afferma i suoi diritti; finché, nei casi estremi d’esaltazione emotiva, la
musica giunge a distruggere del tutto la parola. Tra musica e parola si crea,
perciò, una tensione continuamente elastica, utile al compositore teatrale – non
solo a Verdi – per rappresentare, col canto, il variare degli stati d’animo.
Passione amorosa e collera animano, già dalla prima apparizione, la
figura del Conte di Luna che rimarrà, per tutta l’opera, lacerato da questo
contrasto interiore. Improvvisamente, dalla profondità notturna del giardino,
salgono i suoni di un’arpa: «Il trovator! Io fremo!» commenta il Conte che
riconosce il liuto suonato dal rivale. Ignaro di essere ascoltato, Manrico,
tenore, canta quei versi malinconici di cui parlava Leonora nella sua aria: come
la campana della mezzanotte nel racconto di Ferrando, anche la voce del
Trovatore si materializza, quindi, dopo essere stata evocata: perdura dunque la
38
tecnica narrativa di tradurre l’immagine in fenomeno, in una ricorrente
oscillazione di assenza-presenza, ricordo-attualità, fantasia-realtà che
contribuisce, in modo determinante, a fissare il clima espressivo e il fervore
romantico del Trovatore.
Deserto sulla terra,
col rio destino in guerra,
è sola speme un cor
al Trovator!
Questi i versi che Manrico canta fuori scena, esprimendo solitudine e
malinconia: sola speranza per vincerle è possedere un cuore fedele che
renderebbe il Trovatore – tipico eroe romantico, esule, ribelle, vagabondo,
libero ma solo – più fortunato di un re. Il liuto che accompagna il canto manca
in orchestra: al suo posto sentiamo il suono di un’arpa che crea un effetto
particolarmente soffuso, sfumato e impreciso; il liuto, d’altronde,
nell’Ottocento, era uno strumento completamente dimenticato.
La romanza di Manrico, tenore, ha una forma semplicissima: due strofe
riprese tali e quali, senza varianti. La melodia, apparentemente semplice, è in
realtà molto elaborata, per dare l’impressione di questa solitudine malinconica
– Manrico è «a morte proscritto», come dirà, poco dopo, il Conte di Luna – e
della tensione emozionale che la caratterizza. All’inizio suona un po’ come il
rintocco di una campana negli intervalli mi bemolle-re su ritmo puntato; poi,
questo din-don lascia spazio alla rappresentazione musicale della speranza. Su
«è sola speme un cor» il malinconico mi bemolle minore si rovescia, difatti, in
mi maggiore, come una luce che s’accende nell’oscurità: la melodia sembra
arenarsi in note ribattute (procedimento già visto nell’aria di Leonora) ma,
dopo aver saltellato sul posto, prende lo slancio per una fervida salita verso
l’alto e la conclusione a tutta forza con trillo finale: «un cor al Trovator!».
All’ascolto sembra una cosa semplicissima, popolare: lo è, perché la melodia è
regolare, scandita dagli accordi dell’arpa-liuto, e caratterizzata da un
andamento tipico di canzone; ma c’è una grande finezza d’articolazione
interna che mostra quante sfumature espressive Verdi riesca ad ottenere
attraverso il percorso d’una semplice melodia accompagnata. Lo slancio verso
l’alto di melodie liriche e struggenti accomuna, dunque, il canto di Leonora e
di Manrico. Questo è l’affinità elettiva che li lega: hanno un modo molto
simile d’esprimere il loro anelito. Che cosa ha fatto innamorare Eleonora,
quando ha sentito cantare per la prima volta il Trovatore? Evidentemente, lo
slancio vitale della voce verso l’alto, che lei riproduceva nel suo canto, diverso
da quello di Manrico solo per poche note, e simile per comportamento vocale.
Ovviamente, di tutto questo, l’ascoltatore non s’avvede sul piano razionale. Ce
39
ne accorgiamo noi, che osserviamo lo spartito e notiamo queste corrispondenze
profonde che legano i due personaggi e determinano la coerenza della
caratterizzazione individuale. L’effetto prodotto da una simile logica
compositiva fa la differenza tra un’opera mediocre e un capolavoro, in cui tutto
si collega con salda coerenza strutturale.
La voce di Manrico proviene dalla profondità notturna del giardino,
arriva di lontano, sfumata dalla prospettiva. La profondità dello spazio scenico,
incarnata dalla musica, è dunque essenziale per definire questa situazione.
Verdi, infatti, non si limita a rappresentare il Conte di Luna in primo piano e
Manrico sullo sfondo. Sovrappone le due voci con i commenti del Conte: «Il
Trovator…io fremo!…Oh detti!… Oh gelosia». Così, quando si sente la voce
lontana, lo spettatore è portato a dimenticare che c’è anche un primo piano,
ma, non appena il Conte fa il suo commento, la nostra attenzione rimbalza al
proscenio, prima di essere nuovamente attratta da ciò che si sente ma non si
vede. La musica funziona quindi come una macchina da presa che inquadra
prima il Conte in primo piano, poi lo sfondo, poi di nuovo il personaggio al
proscenio, e così via, in una continua mobilità di prospettive, tipica del teatro
musicale.
Il canto del trovatore viene spazzato via da una figurazione rapida che
indica il mutare della situazione. Si va verso il terzetto dell’incontro tra
Manrico, Leonora ed il Conte. Nel frattempo, «la luna esce dalle nuvole e
lascia scorgere una persona di cui una visiera nasconde il volto». Leonora esce
dal palazzo perché ha sentito la voce del Trovatore e si butta nelle braccia del
Conte, credendo che sia Manrico. Le tenebre non permettono il riconoscimento
immediato, ma, quando l’agnizione avviene, scoppia la situazione che porta al
«duello», titolo del primo atto.
La quarta scena è brevissima. Leonora, correndo verso il conte, grida,
con una splendida effusione di melodia:
Leonora Anima mia!
Conte
(Che far?)
Leonora
Più dell’usato
È tarda l’ora!… io ne contai gli istanti
Co’ palpiti del core!... Alfin ti guida
Pietoso amor tra queste braccia...
Manrico
Infida!…
Questo è uno dei rari passi in cui Verdi, nel Trovatore, sfrutta la tecnica
del declamato melodico. È una frase molto appassionata, e rappresenta lo
slancio di Leonora verso Manrico con grande efficacia.
40
Segue il Terzetto diviso in due parti: A) Allegro agitato, 3/4, sol
maggiore, su versi settenari («Qual voce! Ah dalla tenebra»); B) Allegro assai
mosso 4/4 a cappella, re bemolle minore, su versi ottonari («Di geloso amor
sprezzato»). In questo pezzo Verdi interpreta non tanto lo stato d’animo
individuale dei singoli personaggi, quanto la concitazione generale del
momento. Le voci cantano, in pratica, solo dei frammenti di declamato, molto
brevi, senza melodia, con un profondo senso d’affanno nel martellamento delle
sillabe. L’elemento collegante sta nell’orchestra ed è costituito dal ritmo
giambico (breve-lunga) disseminato in tutto il pezzo e collegato con disegni
melodici che ascendono freneticamente, pulsando in balzi nervosi e leggeri.
La frequenza degli scatti diviene massima nella frase del Conte:
Tu!... Come!
Insano! Temerario!
D’Urgel seguace, a morte
proscritto, ardisci a volgerti
a queste regie porte?
Qui lo scatto sembra quasi impazzire, è come un mulinello che gira
sempre più vorticoso e che, ad un certo punto, si blocca in accordi molto forti,
che scuotono tutta l’orchestra. Il melodramma italiano dall’Ottocento ha
appreso da Mozart e da Rossini l’arte di ripetere un elemento, facendolo
passare in diversi contesti tematici e tonalità, in modo da rinnovarne
continuamente l’effetto, come avviene nello sviluppo della forma sonata.
Questo produce un senso di continuità e di trasformazione insieme: coglie la
permanenza, ma insieme la tensione interna che anima la situazione. Qui è il
ritmo giambico che viene sviluppato, ripetuto in varie tonalità e disposizioni
strumentali, con un effetto di straordinario impatto energetico: folle è la
concitazione della prima parte del terzetto, ma non ancora tale da non poter
aumentare nella seconda. Da notare un fatto curioso: la prima sezione del
terzetto è drammaticamente statica; tranne una brevissima sfida scambiata tra i
contendenti maschi, non succede nulla. La musica la trasforma, invece,
imprevedibilmente, in qualche cosa di esplosivo, che scorre con frenetica
velocità.
Ancora più statica è la seconda parte del terzetto, in cui la situazione si
blocca completamente. Ma il compositore riesce ad intensificare ulteriormente
la tensione. In che modo? Spacca l’azione musicale in due gruppi,
contrapponendoli. Da una parte ci sono Leonora e Manrico, dall’altra il Conte.
Il duello, che dà il titolo all’atto, non viene rappresentato, si suppone avvenga
fuori scena. Il vero duello, che Verdi mette in scena, è, invece, di tipo
musicale. Comincia il Conte con una frase che comprende tutta la sua battuta:
41
Di geloso amor sprezzato
arde in me tremendo il fuoco!
il tuo sangue, o sciagurato,
ad estinguerlo fia poco!…
(a Leonora)
Dirgli, o folle,… “io t’amo…”, ardisti! ...
ei più vivere non può.
Un accento proferisti
che a morir lo condannò!
Il profilo delle frasi dà il senso dell’aggressività, dello slancio,
gestualmente qualificato: cantando la sua melodia, scolpita con un colpo
deciso nella nota lunga che apre ogni frase, è come se il Conte sfoderasse una
spada e andasse contro gli altri due, sfidandoli. Leonora e Manrico rispondono
con una specie di fuoco di sbarramento («Un istante almen dia loco | il tuo
sdegno alla ragione» «Del superbo vana è l’ira | ei cadrà da me trafitto»): il
ritmo, martellante, fa perno su nuclei di tre note (due crome e una minima) con
accento di lunga–breve–lunga (tà-ta-tà), come qualche cosa che inciampa,
impuntandosi con ostinazione. Nella parte del Conte («Di geloso amor
sprezzato») pulsa il ritmo anapestico (ta-ta-tà), molto usato nella musica per
indicare momenti di aggressività. Il ritmo di Manrico e Leonora è invece
anfimacro (lunga-breve-lunga), molto meno comune dell’altro: applicato, alle
parole, le contorce come una fiamma che deforma gli oggetti; l’effetto è
sommamente innaturale, ma efficace nel rendere lo sconvolgimento passionale
dei due personaggi. Si può quindi parlare di duello tra due ritmi diversi, uno
aggressivo, e un altro oppositivo, duello musicale, perché in realtà i tre sono
fermi e cantano i loro versi, sovrapponendosi in polifonia. I due episodi –
proposta del Conte e risposta di Manrico e Leonora – sono ripetuti e
acquistano ulteriore energia, anche perché il Conte, la seconda volta, si
sovrappone alle due voci con un basso rampante di semiminime. Verdi, come
Mozart e più di Rossini, evita di solito le ripetizioni testuali: quando le fa, ne è
ben consapevole. Altrimenti, preferisce modificare la ripresa con effetti
d’intensifi-cazione, in questo passo evidenti.
La situazione drammatica del terzetto è dunque assolutamente statica,
riflessa nella punteggiatura del testo che è disseminata, qui e altrove, di punti
esclamativi, interrogativi, e di una miriade di puntini di sospensione. Questo
rispecchia un preciso atteggiamento retorico: il meravigliarsi, l’enfatizzare
situazioni che sono tutti momenti culminanti, e non nascono da un graduale
evolversi dei fatti.
42
È difficile dare un contenuto psicologico a questa zuffa musicale che
oppone il Conte da una parte, Leonora e Manrico dall’altra. Ma c’è
un’immagine che illumina il significato del duello musicale, espressa dai versi
di Leonora:
Io, sol io, di tanto foco
son, pur troppo, la cagione!
Leonora non dice: «sono io la causa di questo equivoco, di questa
inimicizia, di questo duello» ma «di questo foco». Il ritmo giambico che si
diffonde, incendiando tutta la prima parte del terzetto, è una scintilla
scoppiettante, che crepita come una fiamma. L’avevamo già incontrato nella
cabaletta precedente, rappresentazione dell’amore passionale che brucia
l’anima di Leonora. Dunque, alla fine di questa prima parte, già possiamo
renderci conto di come l’immagine del fuoco assuma un’importanza centrale.
Essa ricorre, infatti, con strana frequenza nel testo del primo atto. Ferrando
canta: «Fu presa, e al rogo fu condannata»; Ines: «Perigliosa fiamma | tu
nutri!.., oh come, dove | la primiera favilla | in te s’apprese?»; Il Conte: «Ah!...
l’amorosa fiamma | m’arde d’ogni fibra!»; e, nel terzetto: «Di geloso amor
spezzato | Arde in me tremendo il foco!», quando Leonora risponde nel modo
che s’è detto. La ricorrenza di questa immagine, già nel primo atto, non può
dunque essere casuale, tanto più se consideriamo quale spazio occuperà
nell’immaginario dell’atto successivo la cui prima scena si apre su di un
immenso fuoco acceso.
Così si conclude il primo atto, con la sua atmosfera scura, cupa,
ferrigna, anche dal punto di vista scenografico. Questo atto, notturno, è
dominato dalla presenza di gente armata: inizia con le sentinelle, e si conclude
con un duello, in cui i personaggi sfoderano le armi. Al centro, invece, con un
effetto di meraviglioso contrasto, prende posto il morbidissimo quadro
notturno del giardino, con l’aria di Leonora e il canto di Manrico che
attraversano il giardino con un’effusione melodica opposta alla forza ritmica
che domina l’Introduzione e il Terzetto: è musica d’aria, vaporosa e fluttuante,
come quella di Ferrando e quella del Terzetto è musica di terra, che scivola e
inciampa continuamente nel ritmo, come attratta da un forza di gravità che le
impedisce di prendere il volo. La costruzione è perfetta, come i rapporti
espressivi tra le varie parti del dramma.
43
44
Capitolo terzo
Atto secondo (Parte seconda: La gitana)
N.4 Coro di Zingari «Vedi le fosche notturne spoglie» e Canzone
«Stride la vampa!» (Azucena, Manrico, Un vecchio Zingaro, Coro).
La scena si apre su di «un diruto abituro sulle falde di un monte della
Biscaglia. Nel fondo, quasi tutto aperto, arde un gran fuoco. I primi albori.
Azucena siede presso il fuoco. Manrico le sta disteso accanto sopra una
coltrice ed avviluppato nel suo mantello; ha l’elmo ai piedi e fra le mani la
spada, su cui figge immobilmente lo sguardo. Una banda di zingari è sparsa
all’intorno.»
L’immagine del fuoco, evocata in senso proprio e metaforico nel primo
atto, si concretizza ad apertura di sipario con impressionante evidenza:
l’impianto scenografico di questa scena è, infatti, disposto attorno ad un gran
fuoco acceso, e proprio l’immagine della fiamma sarà il punto di riferimento,
non solo della situazione che va maturando, ma di tutta la vicenda interiore di
Azucena, anzi di tutta quest’opera notturna, buia, a tratti tenebrosa, illuminata
dai bagliori di una fiamma, alternativamente reale e metaforica. Comincia
quindi a delinearsi un collegamento tra i personaggi e le loro vicende, che ha
nell’immagine del fuoco il suo punto di convergenza26.
Dopo le scene notturne precedenti, questa si svolge all’alba. Neppure
ora, quindi, la luce è troppo forte. Verdi non descrive il sorgere del sole, come
aveva fatto nell’Attila: qui punta tutto sulla rappresentazione dei personaggi,
raccolti attorno al fuoco acceso, nella semioscurità del mattino nascente.
La scena inizia con un coro di Zingari che, nel Medioevo, svolgevano
anche il ruolo di fabbri. Ecco perché, qui, battono sulle incudini, segnando il
ritmo del canto, come prescrive la didascalia: «Al misurato tempestar dei
martelli cadenti sulle incudini, or uomini, or donne, e tutti in un tempo,
intonano la cantilena seguente». Dunque ferro e fuoco: elementi primordiali
che in quest’opera, fatta tutta di contrasti taglienti, acquistano una valenza
simbolica. Il coro forma l’ambiente umano – ma non paesaggistico – in cui
Una bella pagina sull’attualità di questo tema nel teatro musicale
ottocentesco con un paragone tra Il Trovatore e La Walkiria si legge in G.
BALDINI, Abitare la battaglia, cit., p. 257 sgg.
26
45
prende vita, subito dopo, il racconto d’Azu-cena, e canta musica zingaresca,
piazzata all’inizio del secondo atto per creare un quadro vivace e colorito. Le
diminuzioni ritmiche, date dalle scalpitanti terzine e quartine di semicrome che
alludono ad un suono di nacchere o di tamburelli, già sentite nel racconto di
Ferrando; le sferzanti acciaccature; la colorita contrapposizione di archi e fiati;
il suono tintinnante del triangolo sono elementi ritmici e timbrici che ricordano
vagamente quelli usati, a cavallo tra Sette e Ottocento, nella cosiddetta
«musica turca», complesso di strumenti particolarmente squillanti (fiati e
percussione) impiegato per introdurre effetti esotici, che Verdi carica qui di
un’energia nuova.
Il coro di zingari, che non esprimono sentimenti complessi ma un
semplice saluto al sole che sorge, mentre si incitano reciprocamente al lavoro,
ha una melodia molto semplice e squadrata, ma non generica, bensì
memorabile nella sua fortissima personalità: ricorda cose già sentite
nell’introduzione, ad esempio la frase di Ferrando «È credenza che dimori |
ancor nel mondo l’anima perduta | dell’empia strega», rovesciata, però, in un
effetto brillante.
Il coro a quattro voci inizia in mi minore, con tenori e bassi, poi modula
in sol maggiore e infine in do maggiore, laddove si canta «Chi del gitano i
giorni abbella? La zingarella!», su un tema molto energico cui si uniscono
anche le donne, mentre i martelli, che battono sulle incudini in tempo e in
controtempo, rafforzano il ritmo con un effetto rumoristico, molto teatrale. Il
pezzo è ripreso da capo, testualmente, quando i tenori e i bassi chiedono alle
donne di dar loro da bere e loro «mescono in rozze coppe» non si dice che
cosa: verosimilmente, non il caffè del mattino.
Il fine, perfettamente raggiunto, cui mira Verdi è di creare, ad apertura
di sipario, un forte contrasto con le scene notturne del primo atto: nella sua
brillantezza ritmica e timbrica, questo pezzo suona «chiaro» rispetto alle
oscurità della ballata di Ferrando e della scena che segue, punta sulla vigoria
popolare della melodia e sui colori vivissimi dell’orchestra, al fine di colpire
l’imma-ginazione del pubblico con elementi molto caratterizzati. L’effet-to, ad
apertura di sipario, è dirompente, proprio perché non ha nulla di
convenzionale: un coro di Zingari che canta con tale forza, questi colori
luccicanti e un ritmo così bizzarro, piroettante ed energico, non s’erano più
sentiti nell’opera italiana dopo Rossini. La musica si stampa, quindi, nella
nostra memoria dopo il primo ascolto, e non si cancella più: il salto compiuto
dall’invenzione melodica di Verdi rispetto a Giovanna d’Arco, ad Alzira o al
Corsaro è decisivo.
L’originalità trionfa nella seguente canzone di Azucena, annunciata da
una lunga pausa, necessaria, dopo il coro, per preparare l’imprevedibile e
iperbolico mutamento d’espressione. Il canto di Azucena non è un’aria, ma una
46
vera e propria canzone, cioè un pezzo di contenuto evocativo dato come un
oggetto musicale. Azucena ha voce di mezzosoprano, e possiede un timbro
totalmente diverso da quello di Leonora per il colorito oscuro che conferisce al
personaggio un carattere meditativo e introverso, carico di esperienza e di
dolore nel ricordo dei fatti terribili di cui è stato protagonista.
Argomento della canzone è, infatti, il momento in la madre di Azucena,
zingara accusata di maleficio dal Conte di Luna, padre dell’attuale Conte, fu
trascinata al supplizio del rogo. La canzone è incorniciata dal coro che
conclude la scena con la ripresa del suo scanzonato ritornello, sia pure
abbreviato: il blocco musicale ha quindi una chiara struttura tripartita.
La figura della zingara non era estranea al melodramma, soprattutto
comico, del primo Ottocento, sia come personaggio di contorno (vedi Il turco
in Italia di Rossini) che come protagonista (La Zingara di Donizetti) dai tratti
brillanti, leggeri, pittoreschi. Nel Trovatore, Azucena s’impone, invece, per
un’inedita forza tragica, e con un’incisività di caratterizzazione addirittura
superiore a quelle di Leonora e Manrico, tanto che per alcuni, ad esempio
Massimo Mila, è da considerarsi la vera protagonista dell’opera. Nella
canzone, la gitana rivela il primo aspetto della sua personalità, sconvolta dal
ricordo della madre arsa ingiustamente sul rogo che, prima di morire, le ha
chiesto di vendicarla, incidendo nell’animo della figlia un imperativo morale
vissuto ormai come un’ossessione. La memoria di questo fatto non è vaga o
generica: si concretizza nella presenza del fuoco acceso al centro della scena,
proprio dove la madre è stata bruciata. Con lo sguardo fisso sulle fiamme,
Azucena inizia la sua canzone: «Stride la vampa!» in cui evoca la scena della
folla accorsa per assistere con urla di gioia all’esecuzione della condannata,
che avanza verso il luogo del supplizio accompagnata dagli sgherri, mentre sui
volti orribili si riflette il colore della «tetra fiamma», e un urlo di gioia, che si
espande di balza in balza, riempie il mondo di orrore. Il fuoco è dunque al
centro del racconto: fuoco «tetro» e, soprattutto, fiamma che «stride». È
singolare la caratterizzazione «acustica» del fenomeno, proposta dal verso di
Cammarano: Azucena non dice, come sarebbe stato più ovvio, «rosseggia la
vampa» o «la vampa riscalda» o «la vampa brucia», bensì «stride», con
un’immagine sonora che evoca il crepitio delle fascine, reso nel lungo trillo sul
si dell’ultimo verso, immagine acustica della «la fiamma che s’alza al ciel»;
oppure il fruscio, perdurante e leggero del fuoco acceso, riflesso nella fissità di
quello che Pierluigi Petrobelli27 ha definito «l’ideogramma musicale della
fiamma», vale a dire il tema iniziale della canzone, ossessivamente costruito
attorno alla ripercussione della nota si, con un effetto di fissità quasi sibilante.
Il che conferisce alla fiamma che «stride» una forte carica evocativa.
27
P. PETROBELLI, La musica nel teatro, Torino, Edt, 1998, p. 114.
47
Verdi ha evitato di dipingere il fuoco in orchestra con i soliti tremoli,
scale, disegni rapidi e guizzanti, diffusissimi, a questo scopo, nella musica del
Sette-Ottocento. Ha scelto, invece, la strada più difficile, ma più nuova ed
efficace, della interiorizzazione del fenomeno. In questo sta la genialità del
pezzo e la sua forza evocativa. Contrariamente a ciò che lascia prevedere il
contenuto narrativo, la canzone è un pezzo assolutamente statico. Il testo
poteva suggerire al compositore un divenire drammatico: dall’accensione del
rogo, al corteo, alla morte della vittima, all’urlo della folla che l’accoglie,
gioioso e orribile e si espande, con echi sinistri, tra i monti. Ma Verdi non
raccoglie questi suggerimenti narrativi, figurativi e sonori. Punta tutto, invece,
sulla fissità: fissità della fiamma che brucia in quel momento; dello sguardo di
Azucena attratto dal magnetismo irresistibile del fuoco che ha per lei un valore
esistenziale; fissità di un’ossessione che si ripresenta periodicamente nella sua
mente non di pazza, ma di persona segnata da uno choc incancellabile. Questa
fissità è realizzata, innanzi tutto, dal ritmo orchestrale: semplice, sempre
uguale nella scansione dei 3/8, (l’orchestra è in pianissimo) quasi un ritmo di
mazurca che si rigenera in continuazione, definendo l’alveo in cui s’incanala la
melodia della canzone, nella tonalità di mi minore. Il canto parte dal si iniziale,
ripetuto quattro volte, per frastagliarsi in un disegno puntato – ossessivamente
ruotante sulla dominante della tonalità d’impianto – che procede tremolando,
guizzando, scintillando, vorrei dire, nell’evocazione, straordinariamente
pungente, della fiamma. Riconosciamo, nelle figurazioni vocali del canto di
Azucena, la presenza di quegli scatti giambici, individuati nella cabaletta di
Leonora, e nel terzetto come segno di eccitazione passionale. Ma qui, il
vocabolo ritmico acquista, dunque, un significato esplicito: è, evidentemente, il
segno del fuoco, fuoco che brucia sulla scena o divampa nelle passioni degli
animi, garanzia dell’unità che salda l’azione esterna con la vita interiore.
A mano a mano che procede, questo canto acquista qualcosa di
allucinato. La svolta in do maggiore nella parte centrale, in cui la voce
s’impenna nell’evocare gli «urli di gioia», e la melodia si contorce,
precipitando a scatti dall’acuto al basso, sul perdurante ritmo puntato, non fa
altro che accentuare l’effetto d’inesorabile fatalità collegato al ritorno del tema
iniziale sul verso «Sinistra splende sui volti orribili»: la fiamma, non la madre,
è il soggetto principale della canzone. Alla fine, quando Azucena canta: «La
tetra fiamma che s’alza al ciel», sulla parola «ciel» fa un lungo trillo, sempre
sul si: come se in quel momento vedesse il rogo avvitarsi in un’altissima
spirale di luce rossa. La potenza evocativa della canzone sta dunque nella
elaborazione fantastica, in tempo reale, di un fenomeno esterno (ricordiamo
che la fiamma sta bruciando davanti ad Azucena), ossia in quello scambio tra
realtà e possibilità, vita e sogno, oggetto e visione che ha una funzione centrale
nell’immaginario poetico e nella drammaturgia del Trovatore.
48
Dopo che Azucena ha esaurito il suo canto, si sente in orchestra una
frase lamentosa, tristissima, di oboe e clarinetto: è una specie di pietoso
commento, un’eco interiorizzata dell’emo-zione destata dalla canzone. La
seconda strofa è uguale alla prima, e termina con un lungo silenzio (pausa di
una battuta con punto coronato) che circonda la voce, con un’aura di stupore e
di mistero (se ben piazzate le pause possono essere espressive come le note).
Quando Azucena ha finito di cantare nessuno osa commentare; l’evocazione
della fiamma è stata così forte che il coro si limita a mormorare: «Mesta è la
tua canzon!». Segue l’ultimo, agghiacciante intervento di Azucena, cupo e
allargando, come prescrive Verdi: «Del pari mesta | che la storia funesta | da
cui tragge argomento!». Mentre la voce declama nel registro basso, sfruttando
il colorito cupo del contralto, l’evocazione della fiamma si spegne, come se
Azucena ne avesse ormai dimenticato l’immagine esteriore, e scendesse in se
stessa a rivivere il senso di questa catastrofe che la distrugge con il suo
imperativo non ancora soddisfatto: «Mi vendica! Mi vendica!». Queste parole
avrebbero potuto esser gridate, invece sono mormorate sommessamente, come
Verdi esplicitamente raccomanda.
Condizione perché questo pezzo straordinario sortisca tutto il suo
effetto è, naturalmente, la scrupolosa osservanza delle prescrizioni verdiane.
Quasi tutto va eseguito piano e pianissimo, in un tono di straziata intimità che
la realizzazione scenica non deve contraddire: Azucena non è una vecchia
megera, ma una figlia distrutta dal dolore; non si sbraccia in gesti enfatici, ma
si raccoglie in una visione interiore; gli zingari l’attorniano commossi, quasi
abbracciandola attorno al fuoco che arde; la canzone è indirizzata a loro, ma
anche, e soprattutto, a se stessa, in un dialogo personale col fuoco; i gesti
saranno quindi ridotti al minimo, il quadro fermo, attonito, solo animato dal
tremolio della fiamma e della sua luce rossastra: deve suggerire un ambiente
nomade, selvaggio e zingaresco, chiassoso e allegro nel coro iniziale, e quindi
tanto più sorprendente nel rivelare gli abissi di profondità che la Canzone di
Azucena, inaspettatamente, dischiude.
Chi avrà composto quella canzone? Certamente Azucena stessa, come
dicono gli zingari che gliela attribuiscono. È lei, dunque, che conosce e ha
insegnato a Manrico l’arte del canto: il nutrimento che gli ha procacciato sin da
bambino non è stato solo fisico, ma d’arte, di cultura, di popolare civiltà: da lei
Manrico ha imparato ad oggettivare nel canto l’esperienza della vita, a
comporre romanze e canzoni dove l’incandescenza del sentimento,
sedimentata nell’elaborazione artistica, svela la sua verità. Per questo si può
dire che Verdi affida al Trovatore la celebrazione più solenne dell’arte e della
cultura popolare cui, per le sue stesse origini contadine, si sentiva
costituzionalmente legato.
49
Dopo lo strano silenzio, è Manrico che sblocca la situazione,
commentando le parole della madre: «L’arcana parola ognor!»: sempre
quest’idea della vendetta! Poi uno zingaro rompe l’imbarazzo: «compagni,
avanza il giorno – dice – andiamo a procacciarci il pane nei villaggi vicini»; e
distoglie l’attenzione dalla figura di Azucena, come in un’inconscia volontà di
rimozione. La stessa che sembra animare il ritorno del coro iniziale, così
argutamente sfacciato, ma ora meno allegro di prima: intanto è solo un
frammento, poi muore in pianissimo, come un eco che si perde lontano mentre
gli zingari sgombrano la scena. L’effetto di questa musica è dunque scenico,
spaziale, ma anche psicologico: dopo la Canzone di Azucena troppa allegria
sarebbe fuori luogo, e gli zingari stessi sembrano esserne consapevoli.
Il ritratto di Azucena, incorniciato al centro del coro da due lunghe
pause, spicca, in tal modo, con gigantesca evidenza. Ma la canzone ha solo
destato la nostra curiosità: un’evocazione di questo genere non può finire qui,
deve produrre delle conseguenze ed avere necessariamente un seguito.
Dobbiamo capire chi è veramente questa strana donna, capace di evocare in
musica con tanta intensità la scena terribile sepolta nella sua memoria e
l’imma-gine della fiamma che ne compendia il significato.
N. 5 Racconto di Azucena «Soli or siam!»; «Condotta ell’era in ceppi»
(Azucena, Manrico).
Partiti gli zingari, Azucena resta sola con Manrico, dinanzi alla fiamma
che arde, e che la musica ha trasformato, ormai, nel terzo personaggio della
scena, da intendersi come una sorta di solitario dialogo col fuoco, al cospetto
di altre persone che ascoltano. Come noi spettatori, Manrico vuol saperne di
più: ha capito che c’è qualcosa di molto serio, intimo, e segreto in questa
canzone di Azucena: «Soli or siamo; deh! narra quella storia funesta». E
Azucena racconta la storia, che già conosciamo dal racconto di Ferrando. Il
dialogo con Manrico è svolto in un recitativo molto semplice, musicalmente un
po’ piatto, e appena ravvivato dalla frase di Azucena: «La incolpò superbo
conte di malefizio», dove c’è il solito tremolo che crea tensione. Ma è chiara la
volontà di Verdi di sorvolare su queste parti di raccordo per dare il massimo
rilievo ad un altro pezzo chiuso, il racconto, che inizia subito dopo.
Anche questo pezzo, dunque, non è chiamato «aria» ma «racconto», il
che sottolinea l’impostazione narrativa di molte parti del Trovatore, che
procede per ballate e per canzoni, con un’insistenza evidentemente non
casuale. Ferrando ha raccontato la storia della zingara, Leonora il primo
incontro col Trovatore («Tacea la notte placida»), Azucena ha evocato la scena
del rogo, ora racconta il supplizio della madre e il proprio tentativo di
vendicarla; il Trovatore si presenta la prima volta cantando una romanza,
50
subito dopo il racconto di Azucena si lancerà in un altro racconto. Questi
personaggi vivono dunque nella dimensione del passato o del futuro, e
oscillano tra la rievocazione di fatti avvenuti, o il presagio di cose che
accadranno. Sottratti all’urgenza della quotidianità, che incalza i protagonisti
del Rigoletto e della Traviata, i personaggi del Trovatore sono rapiti in una
dimensione fantastica ed evocativa, che esce continuamente dalla realtà del
tempo quotidiano; vivono in preda a visioni che deformano, modificano,
rimpiccioliscono o ingrandiscono i dati dell’esperienza. In tale contesto, il
racconto, la ballata, la canzone, la romanza, costituiscono «oggetti» musicali
utilissimi per «mettere in forma» l’aspirazione visionaria verso oggetti che
continuamente sfuggono, aspirazione che non potrebbe essere sempre espressa
attraverso il grido passionale colto nella sua immediatezza. L’altimetria
retorica conferisce, in tal modo, all’espressione di stati d’animo fortemente
eccitati, una profonda verità.
Il racconto di Azucena in settenari doppi, «Condotta ell’era in ceppi al
suo destin tremendo!», rievoca, nella prima parte, la stessa scena già descritta
nella canzone, ma sotto un’angolatura diversa. Se al centro della canzone stava
l’immagine distruttrice della fiamma, qui Cammarano e Verdi rappresentano la
pietà per la vittima ed il dolore tremendo della figlia che, con il bambino in
braccio, tra la folla, segue la madre al supplizio, senza riuscire a raggiungerla
per ricevere la sua benedizione. C’è, dunque, un processo d’ interiorizzazione
dell’avvenimento, rappresentato ora sotto l’aspetto degli affetti privati.
Il racconto si articola in tre parti, collegate con estrema naturalezza, in
modo che l’ascoltatore non percepisce le giunture, ma solo una progressiva
trasformazione. A differenza della canzone, infatti, questo pezzo non è fisso,
ma si evolve in un crescendo drammatico in tre tappe:
A «Condotta ell’era in ceppi»: Andante mosso in 6/8, la minore;
B «Quand’ecco agli egri spiriti»: Allegretto in 3/8, mi minore;
C «‘Mi vendica!’…La mano convulsa tendo»: Allegro agitato in 4/4,
la minore.
Alla fine, la tonalità ritorna a quella dell’inizio, mentre le tre sezioni sono
sempre più veloci.
Come la canzone, anche il racconto inizia con un accompagnamento
regolare, utile a rendere un tono di iniziale oggettività narrativa. La stranissima
figura orchestrale che accompagna il canto è formata da una doppia
acciaccatura discendente negli archi, che dà un senso di scivolata, d’inciampo,
a cui rispondono i violini primi e l’oboe, con due note fatte da un semitono
discendente, semplicissimo, eppure impressionante nell’evocazione del
lamento. È, insieme, l’immagine della vittima, che viene spinta in un corteo
51
disordinato, in cui barcolla sotto il peso dei ceppi, e quella di chi la segue con
lo sguardo, piangendo. In queste due figure semplicissime, eseguite sottovoce
dall’orchestra, si concentrano dunque, con elementare efficacia, la violenza e il
dolore, lo strattone e il gemito, l’osservato e l’osservatore, ossia la sintesi
drammatica della situazione. Tra la prima e la seconda parte della canzone si
levava il lamento doloroso dell’oboe: ora quel pianto entra, per frammenti,
all’interno del racconto e ne percorre tutta la sezione iniziale.
Il canto di Azucena è una melodia inquieta, contorta. Come quella della
canzone, insiste su di una nota, un la, tonica di la minore, e produce un senso
di fissità: lo stato psicologico di chi appunta lo sguardo interiore su di una
scena immaginaria, quasi ipnotizzato, dunque, continua, come continuano i
ritmi puntati di breve-lunga (giambo) che ricordano il guizzo della fiamma ma
qui rendono esplicitamente la fatica dell’incedere nel corteo che porta la
condannata al luogo dove sarà arsa viva.
Anche qui, come nella canzone, il rapporto tra musica e parola è
fondamentalmente sbilanciato a favore della prima: la melodia di Azucena, con
le sue contorsioni ritmiche, le accelerazioni e i rallentamenti improvvisi, gli
sbalzi di registro (l’ottava discendente su «braccia») i contrasti di piano,
pianissimo e forte, il senso di spezzatura e di singhiozzo, obnubila
completamente il suono della parola. Come la visione e il ricordo alterano e
deformano la realtà, così la parola viene deformata perché, in questo caso, essa
non serve alla comunicazione normale ma all’evo-cazione di un fatto che vive
ormai solo nell’immaginazione. E allora, quello che conta non è tanto
percepire il semantema, ma usare la parola come materiale fonetico per
costruire dei disegni musicali evocatori di immagini: prima la fiamma, ora la
vittima condotta al rogo.
In questa prima parte del racconto tutto è ancora spostato in una
dimensione di lontananza, ma qualche cosa cambia nei versi «Ché fra
bestemmie oscene, | pungendola coi ferri, | al rogo la cacciavano | gli scellerati
sgherri»: qui la parola comincia a venir fuori nel suo realismo, si capisce di
più, il canto abbandona i profili astratti della melodia per plasmarsi sugli
accenti dei versi e diventare quasi un recitativo, con le sillabe ben marcate dai
cunei su ogni nota. Anche l’accompagnamento si altera, perdendo per strada il
lamento dell’oboe. Per un attimo, dunque, l’oggettività del racconto va in
frantumi. Ma è solo un momento. Subito dopo, su «Allor con tronco accento»,
torna il tema iniziale, nella sua ritmica e fraseologia regolari; ma non resiste
per molto. «Mi vendica!» è di nuovo detto, infatti, in tono di declamato.
Insomma, il tentativo di ricostituire la forma iniziale e chiudere la prima parte
del racconto in una struttura tripartita fallisce: la melodia si sta sbriciolando. E,
nella misura in cui Azucena adotta il declamato, le parole si sentono di più, il
significato viene in primo piano, aggredisce lo spettatore con una tale
52
immediatezza da far rivivere nel momento presente il fatto narrato. Il gioco
retorico è abilissimo e vero: ad Azucena sta succedendo quello che un oratore
vive tutte le volte che inizia un discorso con pacatezza e poi, preso dal calore
delle argomentazioni, si accende d’emozione, ed è trascinato dal fervore
dell’argomento.
Infatti, di qui in poi, il pezzo subisce un’accelerazione con l’entrata di
Manrico: «La vendicasti?». E Azucena:
Manrico
Azucena
Il figlio giunsi a rapir del Conte:
lo trascinai qui meco… le fiamme ardean già pronte…
Le fiamme? o ciel!… tu forse?…
Ei distruggeasi in pianto …
Io mi sentiva il core dilaniato, infranto!…
La svolta non è solo retorica; è anche di contenuto. Azucena mostra la
sua personalità lacerata: l’obbligo di vendicare la madre la induce a rapire il
bambino del Conte; ma, nel momento di ucciderlo, non ha il coraggio, sorge in
lei la pietà per quel pianto infantile, evocato dai cromatismi discendenti del
canto e, in orchestra, dalle note ribattute del flauto e dell’ottavino, come un
gemito infantile, che ha qualche cosa d’allucinato e insieme straziante, nella
tonalità chiara di sol maggiore. Ma il ricordo del supplizio le infonde un
mostruoso ardimento:
Quand’ecco agli egri spirti come in un sogno, apparve
la vision ferale di spaventose larve!
Gli sgherri ed il supplizio!…La madre smorta in volto…
scalza, discinta!…il grido, il noto grido ascolto:
«Mi vendica!»
Il racconto entra qui (Allegretto in 3/8) in un clima visionario: nel
registro acuto degli archi risorge, infatti, con un suono scorporato e spettrale, il
tema di «Stride la vampa», vale a dire l’immagine del fuoco, attutita ma tenace
nel ricordo e, proprio per questo, ferocemente crudele. Ancora una volta la
musica di Verdi rompe i confini tra mondo esterno e realtà interiore: la fiamma
che Azucena, prima del supplizio della madre, vide ardere dinnanzi a sé, e che
sta bruciando, nello stesso luogo, davanti allo spettatore, prende la forma di
un’allucinazione psichica, nell’agi-tarsi di «spaventose larve»: come in un
gioco di specchi la realtà e l’immaginazione rimandano continuamente le
proprie immagini. Inutile sottolineare la genialità poetica e la profondità
psicologica di queste interferenze. Il ricordo degli sgherri, del supplizio, della
madre discinta e scalza, tutto è unito dal perdurante tema della vampa, reso
sottilissimo e sibilante (si vedano i tremoli dei violini secondi e delle viole,
53
senza bassi) nella sua insistenza sulla nota si. Finché il racconto porta allo
scoppio del grido fatale «Mi vendica!», finalmente in fortissimo.
Qui scatta l’ultima sezione del racconto, l’Allegro agitato in 4/4, su un
perdurante accordo di settima diminuita di do diesis minore, che tiene
l’armonia sospesa per diverse battute e, scivolando cromaticamente, porta al
momentaneo riaffermarsi del la minore (alle parole «la sospingo»), seguito,
sino alla fine del pezzo, da altri passaggi tonalmente instabili, densi di
cromatismi. Durante questo Allegro è come se il racconto precipitasse in una
voragine che distrugge forma, melodia, simmetrie, regolarità ritmiche e
fraseologiche. Azucena non canta più: in un «declamato agitatissimo»,
secondo la prescrizione di Verdi, racconta allo stupefatto Manrico d’essersi
sbagliata e d’aver gettato nel fuoco il proprio figlio, invece che quello del
Conte di Luna. L’alluci-nazione della fiamma, in quel momento fatale, le
aveva sconvolto i sensi e la mente: è quindi per lei la causa di una catastrofe
immane. Il suo periodico riaffacciarsi al ricordo sottopone quindi Azucena ad
una sofferenza continua.
La voragine che si apre nella forma è data, oltre che dalla
disarticolazione della melodia in frammenti declamati, anche dall’orchestra
che balza in ritmi selvaggi, sobbolle nei tremoli, passa dal pianissimo al
fortissimo, sale per semicrome legate due a due e precipita verso il basso in
striscianti passaggi semitonali («Ah che dici?…»): finché, dopo il tellurico
sommovimento che sostiene il punto culminante, vale a dire il quadruplice
grido: «Mio figlio! mio figlio! il figlio mio! il figlio mio avea bruciato!», la
sonorità diminuisce con una discesa nel registro basso. Solo un tremolo al
limite dell’udibile (ppp) sostiene il duplice «Quale orror!» di Manrico, e
l’ultimo verso di Azucena, pronunciato nel registro profondo del
mezzosoprano, come un lamento spossato: «Sul capo mio le chiome | sento
drizzarsi ancor». Tutto muore nel silenzio, con un effetto di solennità cupa,
mortuaria, già degno della Messa da Requiem: «Azucena ricade trambasciata
sul proprio seggio. Manrico ammutolisce colpito da orrore e di sorpresa.
Momenti di silenzio». L’orchestra conclude con un la, prolungato dalla corona:
non l’accordo di la minore, dunque, ma solo la sua nota fondamentale, come se
l’orrore del racconto avesse svuotato anche l’armonia, impedendole di
risuonare al completo.
Grazie alla potenza della musica, il personaggio di Azucena va dunque
ben al di là della semplice caratterizzazione della zingara un po’ pazza, che
vive nel ricordo della madre morta e nel desiderio di fare vendetta. Il dramma
esistenziale che la sconvolge costituisce, però, solo un aspetto della sua
personalità: l’altro, cioè la capacità di amare, di cui ci sono, nella canzone e nel
racconto, i primi accenni, verrà in primo piano nelle prossime scene. La
vicenda narrata è, se non ridicola, certo molto lontana dal gusto moderno: la
54
zingara creduta strega e condannata al rogo, l’accusa di malefizio, il bambino
bruciato per errore, appartengono per noi alla sfera del romanzo d’appendice.
Ma la musica riesce a scoprire, dentro questi eventi e grazie alla costruzione
perfetta del libretto di Cammarano, un nucleo di umanità profonda, che va ben
al di là del caso singolo, e acquista un valore molto più forte. Come dice
Gabriele Baldini, il racconto e la figura di Azucena toccano le scaturigini della
vita: «Rigoletto era soltanto lui: Azucena è piuttosto uno spiraglio per entro il
quale si può gettare uno sguardo sgomento a qualcosa che ha presieduto ai
germi della nostra origine»28.
Nel racconto di Azucena Verdi va quindi ben oltre l’illu-strazione di
una scena di genere. La musica sfiora i confini del sacro: il corteo, evocato da
quel canto, non è solo una drammatica «marcia al supplizio» come quelle di
Rossini (La gazza ladra) o di Berlioz (Sinfonia fantastica), ma si trasforma in
una dolorosa «via crucis», accompagnata da quel lamento che sgocciola
implacabilmente, in ogni battuta, intensificando la commozione, già
intensissima, della melodia cantata. Il dolore biblico espresso dal canto di
Azucena, infatti, è doppio e terribile: è la perdita contemporanea della madre e
del figlio che la taglia fuori, a monte e a valle, dalla corrente della vita. Di qui
il terrore, la ribellione, e il grido di pietà disperata che salgono dalla sua voce
nella seconda parte del pezzo: oltre il caso singolo, Verdi giunge ad esprimere
un sentimento universale, il gelo fisico, carnale, che l’uomo prova davanti al
corpo morto della madre che gli ha dato la vita, e a quello di un figlio in cui
scorreva la sua propria vita. Da «Stride la vampa» all’ultima frase, «Sul capo
mio chiome…», la musica esercita sullo spettatore un innegabile effetto di
sollecitazione fisica: dall’ardore al brivido. C’è quindi, in questa pagina, una
convergenza d’elementi drammatici, poetici, narrativi, psicologici e
antropologici che, attraverso la musica, danno luogo a quella potenza di
rappresentazione shakespeariana di cui parla Baldini, ponendo giustamente il
racconto di Azucena all’altezza di certi passi di Re Lear29.
Ma l’effetto, spiccatamente teatrale, prodotto da questa scena
straordinaria sta, in ultima analisi, nella vicenda della sua struttura: nel fatto
che la forma del racconto di Azucena non sia più così chiusa e simmetrica
come quella che caratterizzava i pezzi precedenti; nell’artificio sapientissimo
di presentare dapprima una forma regolare per poi sbriciolarla sotto l’urto
dell’espressione; nell’espediente tecnico di trasformarla, a poco a poco, da
un’«aria» in un recitativo sinfonico. E geniale è il modo in cui avviene questa
trasformazione: attraverso l’inserzione progressiva d’incisi declamati che,
gettati nella prima parte del racconto come tizzoni ardenti, sviluppano, a poco
28
29
G. BALDINI, Abitare la battaglia, cit., p. 251.
Ibidem, p. 252.
55
a poco, un incendio divoratore. Come il racconto narra una vicenda di
distruzione operata dal fuoco, così la forma melodica e strofica dell’aria,
dapprima ben conchiusa, a poco a poco si sbriciola, attraverso l’assalto
dell’«agitatissimo declamato». Questa riproduzione del contenuto narrativo e
drammatico nella vicenda della forma è il segno che contraddistingue i
massimi capolavori del melodramma, e ne determina la superiore potenza
espressiva: la forma dà un contenuto all’opera, e infonde significato ai
personaggi e alle situazioni.
N. 6 Scena «Non son tuo figlio?…» e Duetto [Azucena e Manrico]
«Mal reggendo all’aspro assalto» (Azucena, Manrico, Un Messo).
Il pezzo che segue s’intitola «Scena e Duetto», e comprende la parte
conclusiva di questo quadro. Ogni atto del Trovatore è tagliato in due quadri,
con una struttura perfettamente bilanciata e simmetrica, anche nei contenuti.
Questa «Scena e Duetto» è molto importante perché getta luce sui rapporti tra
Azucena e Manrico il quale, dopo alcuni momenti di silenzio, domanda ad
Azucena:
Non son tuo figlio? E chi sono io? Chi dunque?
Quindi il racconto è stato una rivelazione per Manrico: «Non son tuo
figlio?» domanda, infatti, stupito ad Azucena; e lei, cercando di negare ciò che,
nell’emozione, si è lasciata scappare, gli risponde perentoriamente: «Tu sei
mio figlio![…] Madre, tenera madre non mi avesti ognora?». E, per
dimostrargli il suo affetto, gli ricorda d’averlo salvato sul campo di battaglia,
quando tutti lo credevano morto; d’averlo curato, ridandogli la vita con il suo
amore. Ma per quale «strana pietà», domanda Azucena a Manrico, egli non ha
ucciso il nemico durante la battaglia? «Strana pietà!», ripete due volte fra sé,
caricando l’espressione di un senso nascosto: evidentemente intuisce che
qualche cosa ha trattenuto Manrico dall’uccidere il Conte di Luna, perché,
come lei sola sa, i due ragazzi sono fratelli. Ma su questo fatto, Azucena,
rigorosamente, tace.
Tutto il dialogo è risolto in un recitativo, non particolarmente
espressivo, se non in un punto, in cui diventa più melodico, quando Azucena
canta: «Tenera madre non m’avesti ognora». Il rapporto tra Azucena e
Manrico va comunque progressivamente chiarendosi: viene fuori l’amor filiale
di Azucena, tanto più significativo e meritorio, in quanto indirizzato verso un
figlio adottivo.
Il duetto inizia con la melodia di Manrico «Mal reggendo all’aspro
assalto», Allegro, 4/4, do maggiore, che spiega alla madre come mai non abbia
56
ucciso in battaglia il Conte di Luna: nel momento decisivo un grido interiore
gli ha detto «non ferir!». Questo intervento getta un po’ di luce sul personaggio
protagonista, rimasto sinora in ombra: il racconto dell’uccisione mancata è
radiosamente orientato all’espressione dell’affetto: è una di quelle melodie
slanciate, lineari ed espressive di giovinezza, di cui abbiamo avuto un primo
saggio nella romanza cantata dal Trovatore all’interno del giardino. Evocando
la battaglia, la voce del tenore tende a salire verso l’acuto, ma al centro,
«agitato e cupo», si ripiega nella modulazione in la minore («quando arresta un
moto arcano»), stupenda ombreggiatura malinconica che si dissolve
nell’energia melodica dei versi seguenti:
Le mie fibre acuto gelo
fa repende abbrividir!
Mentre un grido vien dal cielo
che mi dice:«non ferir!»
Qui pulsano i ritmi giambici che spingono la voce verso il «cielo», in
uno slancio meraviglioso: sono il fervore, la giovinezza, l’apertura all’ebbrezza
del sentimento, senza alcuna retorica, che colpiscono e attirano la nostra
attenzione sulle sfumature conferite dalla melodia verdiana all’espressione del
testo. Nulla è mai fisso, tutto si muove, e il protagonista acquista finezze che,
di solito, non gli sono riconosciute: oltre ad essere trovatore e guerriero,
proiettato nell’azione e volto ad estrinsecare i sentimenti nelle sue canzoni,
Manrico è un temperamento sensibile che sa prestare orecchio alle voci segrete
dell’animo, come quella che gli ha fermato la mano nell’atto di uccidere il
Conte di Luna. «Un certo non so che»: Manrico sa coglierlo e agire di
conseguenza, come vedremo nell’aria del terzo atto. Questo ragazzo, che i
tenori e i direttori d’orchestra riducono sovente ad uno scapestrato puledro,
nell’atto di mordere il freno, ausculta, palpita, trasalisce.
Il ritmo giambico di breve-lunga, che compariva anche nella romanza
cantata dietro le quinte, quando è così «melodico» segna il traboccare degli
affetti, dell’emozione e della passione; è parente di quello che animava la
melodia di Leonora nell’aria del primo atto alle parole «al core, al guardo
estatico | la terra un ciel sembrò», ma anche di quello che Azucena canterà
poco dopo, stringendosi al figlio con le parole «il tuo sangue è sangue mio».
Con la ricorrenza di determinati elementi, Verdi stabilisce, quindi, dei legami
trasversali tra i personaggi. Se si considera, poi, che il ritmo giambico, in una
versione più stretta e più scattata, è sia il ritmo del fuoco sia quello della
passione scatenata (v. il terzetto del primo atto), se ne deduce la natura
universale del suo contenuto semantico: fuoco come forza che pervade il
mondo, principio del calore che anima e distrugge.
57
In questo duetto anche Manrico racconta un fatto passato: la tecnica
della narrazione, nel Trovatore, si ripresenta quindi, puntualmente, come una
scelta voluta da Verdi e dal librettista per conferire all’opera un carattere di
ballata leggendaria e avventurosa, basata sull’esaltazione del sentimento
attraverso la fantasia che ricorda o immagina.
Al racconto di Manrico, Azucena risponde con veemente indignazione:
Ma nell’alma dell’ingrato
non parlò del cielo un detto!
E, subito dopo, quando chiede a Manrico di spingere la spada nel cuore
del fratello-nemico, la melodia ci fa capire di che natura sia il suo desiderio:
non di vendetta personale ma di giustizia. Azucena, infatti, non è cattiva: la sua
richiesta di vendetta non nasce dalla rabbia ma dalla sofferenza sincera per non
aver ancora soddisfatto la richiesta che la madre le ha fatto in punto di morte.
Nella sua etica primitiva, da zingara che vive sui monti e ragiona secondo
parametri morali di ancestrale semplicità, Azucena sente il dovere morale di
perseguire la famiglia del colpevole; tanto più che il Conte, come dirà più
avanti, è ancora più cattivo di suo padre. L’omicidio da lei compiuto nasceva
dunque dall’intento di ristabilire un ordine infranto. E se c’era una colpa in
questo, quella colpa è continuamente espiata: con il dolore per aver ucciso il
proprio figlio; con l’amore riversato sul figlio adottivo; con il patimento
generato dall’ossessione del rogo prossimo a diventare una realtà anche per lei.
Abbiamo già notato come il «mi vendica», alla fine del racconto, fosse detto a
voce bassa: non gridato ma interiorizzato, con un tono che è insieme nostalgico
e doloroso, se non disperato. Azucena non è ancora riuscita a realizzare questo
desiderio della madre: e il fallimento genera depressione, altro motivo di
espiazione. Alla luce di queste considerazioni, si comprende come il grido,
apparentemente trionfale, che accoglierà alla fine dell’opera la morte di
Manrico: «Sei vendicata o madre!», è da intendersi, ovviamente, non come un
grido di trionfo ma di sarcastica disperazione davanti ad un destino crudele.
La melodia di Azucena, in questo passo, che inizia in do maggiore e
modula in la minore, è molto gestuale ed incisiva, specie alle parole «compi o
figlio, qual d’un Dio, | compi allora il cenno mio!», scandite con note puntate e
robustamente accentate. Alla fine, le due voci si sovrappongono, scolpendo le
sillabe con martellante chiarezza, per dare incisività ritmica al canto in questa
promessa di futura giustizia.
Un suono di corno introduce Ruiz e il suo annuncio della presa di
Castellor, dove Leonora sta per ritirarsi dal mondo e prendere i voti. Attacca,
allora, un Allegro agitato e mosso, formato da frammenti di frasi declamate,
reso ansimante da veloci figurazioni orchestrali, senza particolari qualità
58
musicali, ma con quel potere di accentuare la tensione che Verdi esercita nei
punti giusti per creare nel pubblico una forte aspettativa.
Qui comincia l’ultima sezione del duetto, Velocissimo in 3/8, sol
minore, «Perigliarti ognor languente | per cammin selvaggio ed ermo!»:
Azucena si dimostra una madre apprensiva, timorosa che il figlio possa
incappare in qualche pericolo. Il tema, all’inizio, è tutto ansimante, spinto in
avanti dai ritmi puntati: sulla parola «languente» è posto un accento; poi la
donna cambia le sue argomentazioni: «No, soffrirlo non posso io»,
esprimendosi con passione e trasporto in una melodia che, mentre prima era
spezzata, adesso diventa lineare, meravigliosamente effusa. La dichiarazione
«il tuo sangue è sangue mio!» ha un che di freudiano; per ridurre la
consapevolezza che Manrico è «solo» suo figlio adottivo, ella dice con estrema
sincerità questa menzogna di fatto, che diventa, però, metafora di un affetto
assoluto.
La prima parte del Velocissimo in 3/8 rivela, in modo ormai palese,
quello che abbiamo visto apparire a tratti: l’amore di Azucena per Manrico.
Nelle frasi, corte ed agitate, del mezzosoprano, Verdi coglie con commovente
verità il tono apprensivo della madre che raccomanda al figlio di non mettersi
nei pericoli: l’andamento è affannoso ma, nella sonorità sommessa, definisce
un’intonazione tenera e confidenziale nel rapporto tra madre e figlio che
trionferà nella scena del carcere. Questa melodia in sol minore viene rovesciata
da Manrico in sol maggiore alle parole «Un momento può involarmi»;
abbiamo quindi, di nuovo, l’opposizione netta tra minore e maggiore che
caratterizza tutto il sistema tonale del Trovatore, opera basata su contrasti netti
e opposizioni drastiche. Col passaggio in maggiore, la melodia di Manrico
perde il carattere ansimante ed apprensivo che aveva prima e diventa più
battagliera e virile: il ragazzo deve correre a salvare la sua Leonora e
trattenerla dal fare un passo che la allontanerebbe per sempre da lui. Proviamo
a leggere questo duetto nell’ottica di un contrasto tra generazioni: si noterà con
quanta finezza Verdi dia ad Azucena una musica che indica esperienza vissuta,
sofferenza, carico di anni; a Manrico, invece, melodie che sono l’immagine
stessa della giovinezza spavalda, fervida, piena di passione e di slancio,
sprezzante del pericolo, ma non scapestrata; c’è in lui una vera capacità
d’amare, una sensibilità affettiva non solo verso la madre e la fidanzata ma
persino verso il fratello ignoto, cui si sente legato per un misterioso richiamo.
Manrico è caratterizzato con grande finezza nella sua dinamica affettiva, ed è
necessario, quindi, che l’interprete la metta in evidenza, cantando piano,
sfumando, esponendo le melodie con un grado di dolcezza pari alla forza che
gli sarà richiesta nelle (poche, anzi pochissime) pagine eroiche in cui si è soliti
identificare, con enorme forzatura interpretativa, l’immagine del personaggio.
59
Il duetto si conclude rapidamente, secondo il tipico procedimento
verdiano: una volta detto il necessario, il musicista conclude drasticamente,
magari in modo convenzionale, perché l’altimetria qualitativa fa parte del suo
stesso progetto drammaturgico. Verdi non è un pittore fiammingo che cura tutti i
particolari con la stessa attenzione: è un artista che punta a dare un’evidenza
folgorante alle parti principali del quadro, riservando a quelle secondarie,
talvolta, una stesura sommaria. Il che non va inteso come un difetto, ma come un
procedimento consapevole, volto a creare nell’opera d’arte zone di maggiore
densità espressiva ed altre meno impegnative, in cui anche la sommarietà
sbrigativa acquista, nel contesto, il suo significato eminentemente funzionale.
N. 7 Aria del Conte «Tutto è deserto»; «Il balen del suo sorriso»
(Conte, Ferrando Coro).
Cambia la scena. Dopo quella precedente, che si svolge di primo
mattino, torna, qui, l’oscurità. Siamo nell’«atrio interno di un luogo di ritiro in
vicinanza di Castellor. Alberi in fondo. È notte. Il Conte, Ferrando ed alcuni
seguaci, inoltrandosi cautamente avviluppati nei loro mantelli» giungono al
monastero per rapire Leonora. Anche qui, come nel primo atto, il Conte appare
come ombra furtiva partorita dalle tenebre, in preda ad una passione
divampante: nel suo recitativo ed aria, parole come «furente amore», «baleno»,
«raggio», «fulgore», «ardo», «sole», «tempesta» suggeriscono immagini di
luce (cosmica), di calore, di fiamma che, ricorrendo più volte, in modo
evidentemente non casuale, fissano, nel nostro immaginario, la presenza di
squarci luminosi che solcano l’atmosfera notturna dell’opera e le danno corpo
ed evidenza. Il libretto di Cammarano è ammirevole per coerenza e sottigliezza
di rispondenze tematiche e strutturali.
Il recitativo è breve e musicalmente un po’ sbrigativo. Tutta
l’attenzione di Verdi è concentrata sull’aria, dalla forma molto semplice e dalla
melodia avvincente nella caratterizzazione del personaggio. Il Conte di Luna è
il «cattivo», l’antagonista che giunge al monastero per rapire Leonora, nel
momento in cui sta per consacrare la sua vita a Dio. Ci sarebbero, quindi, tutte
le premesse per dare a quest’aria una caratterizzazione in negativo, additare nel
personaggio in scena colui che impedisce l’amore tra tenore e soprano con un
demonico intento di profanazione; invece Verdi, genialmente, trasforma
quest’aria nell’espressione di un cuore innamorato, rapito nella dolcezza del
proprio sogno, e ne fa un’effusione melodica tra le più rotonde, cantabili e
suadenti del Trovatore. Ciò determina anche un notevole effetto di sorpresa
drammatica, perché la scena che si apre su di un luogo buio, oscuro,
misterioso, veniva introdotta dal Conte stesso, che confida a Ferrando le
ragioni del progettato rapimento: impresa ardita, ma inevitabile per soddisfare
il suo «furente amore» e l’«irritato orgoglio», giacché, proprio quando
60
sembrava che non ci fossero più ostacoli all’unione con Leonora, data la
presunta morte di Manrico, la donna decide di ritirarsi in convento. Su questo
terreno emotivo, pieno di rabbia e di risentimento, definito dai primi versi della
scena, poteva nascere un’aria cupa, minacciosa, presaga di sventure; sboccia,
invece, un fiore melodico di grande potere seduttivo, un vero «fiore del male».
Il conte s’attarda a vagheggiare la bellezza di Leonora, che deve assolutamente
fare sua, come la sola capace di spegnere l’ardore che divampa in lui, la
tempesta che gli rugge dentro. Quest’aria non è un racconto; ma, anche qui, il
personaggio, come Leonora, Azucena e Manrico, tende verso un’immagine
della fantasia che assorbe la sua esistenza, stavolta con spasmodico desiderio.
L’aria ha un andamento regolare di frasi ben pausate in questa successione:
A
B
A’
C
«Il balen del suo sorriso» si bem+
«Ah l’amor, l’amore ond’ardo» sol –
«Sperda il sole d’un suo sguardo» si bem+
«Ah l’amor, l’amore ond’ardo»
È quindi una forma tripartita A-B-A’ con una coda C che riprende i
versi 5 e 6, con musica diversa. Nel testo, suggestivo, di Cammarano, ci sono
diverse immagini che Verdi avrebbe potuto sottolineare. Per esempio, poteva
puntare sul «sorriso» di Leonora che vince il raggio di una stella, e comporre
una musica estatica, eterea, con sonorità luminose; oppure rilevare il verso
«nuovo infonde in me coraggio!», e dare all’aria un impulso virile, qualche
cosa di vitale, aggressivo, in carattere con il personaggio che si trova in quella
situazione. Invece, l’immagine che orienta tutta l’espressione dell’aria è quella
dei famosissimi due versi «Ah! l’amor, l’amore ond’ardo | le favelli il mio
favor!», molto popolari nella loro deformazione vulgata «Ah! l’amor, l’amore
è un dardo», che è ciò che l’ascoltatore è portato normalmente a percepire nel
canto, prova incontrovertibile della misura in cui l’invenzione melodica del
Trovatore si sovrappone al suono della parola sino a trasformarla, talvolta, in
un’altra (lo stesso succede per la canzone del Duca, in Rigoletto, laddove si
tende a percepire «La donna è mobile | qual più mal vento» invece di «qual
piuma al vento»).
L’aria inizia con alcuni arpeggi in si bemolle maggiore del clarinetto
che, con il suo timbro velato e notturno, avvolge d’un alone romantico la voce
del baritono; mentre i violoncelli e contrabbassi scandiscono il ritmo con note
pizzicate, e viole, fagotti e corni rendono il suono particolarmente avvolgente,
con accordi tenuti. L’effetto è molto vaporoso, ricorda quello di alcune
serenate settecentesche da suonarsi all’aria aperta, e riflette l’ambiente
notturno: non l’atrio del convento, ma, piuttosto, quello degli alberi che
appaiono sullo sfondo. Oltre alla sonorità piano, Verdi prescrive cantabile,
61
dolcissimo, dolcissimo largo, con espansione, diminuendo, dolce. Anche la
tonalità, si bemolle maggiore, è particolarmente morbida, arrotondata, con una
modulazione in sol minore che conferisce solo un’ulteriore, malinconica
ombreggiatura all’effetto generale, ma non compromette la dolcezza
incantatoria della melodia.
Nel Conte di Luna l’ardore amoroso brucia, quindi, in modo differente
da quanto avviene in Manrico e Leonora. L’amore espresso in questa melodia
è chiaramente inteso come seduzione, non come slancio ideale; è il piacere
sensuale, dongiovannesco, del canto (Verdi conosceva molto bene l’opera di
Mozart), che non ha l’andamento rettilineo, proteso verso l’alto, delle melodie
di Manrico, ma gira su se stesso in spire melodiche sempre morbide e
arrotondate. I melismi danno un senso di abbandono e di sensuale morbidezza.
Non solo, ma, nell’ultima parte, quando il Conte riprende «Ah! l’amor,
l’amore ond’ardo», la tendenza alla carezza melodica sfocia in un vero e
proprio tempo di valzer, circolare e incantatorio. Il Conte di Luna non appare
quindi come un truce, bieco antagonista, ma come un ragazzo che sta per
compiere un’impresa delittuosa dietro l’impulso di una passione che ha il
carattere pre-morale di un fatto istintivo, naturale. Se si confronta la melodia
del Conte «Ah! l’amor, l’amore ond’ardo» con quella di Alfredo «Di
quell’amor ch’è palpito», nella Traviata, se ne constata, al di là del comune
tempo di valzer, la profonda diversità; quella della Traviata ha un carattere di
casta tenerezza, nella sua discesa, seguita dall’impennata verso l’alto di «croce
e delizia», ed è totalmente estranea all’assaporamento, un po’ narcisistico, cui
si abbandona volutamente il Conte di Luna. La prima è una fervida
dichiarazione d’amore, la seconda un avvolgente «ballabile». Sullo stesso
ritmo, Verdi costruisce espressioni amorose radicalmente diverse.
L’aria più melodica che abbiamo sentito finora è quella cantata da
Leonora, nel primo atto; paragonando le due melodie, possiamo constatare che,
tanto quella di Leonora è tesa, pura, casta nel suo andamento, tanto questa del
Conte è ridondante, sensuale, e mondana: dunque non può piacere a Leonora,
affascinata, invece, dal Trovatore idealista, artista, che la porta vicino agli
angeli, come diceva nella cavatina, slanciando la voce in rapinose impennate
verso l’alto. Si va, dunque, chiaramente delineando, nel sistema melodico del
Trovatore, una presenza di coerenze e di opposizioni su cui poggia la logica
dell’intera caratterizzazione drammatica.
Terminata l’aria del Conte, si sente il suono delle campane che proviene
dall’interno, e sfonda lo spazio, con un effetto prospettico analogo a quello
ottenuto con la romanza fuori scena di Manrico, nel primo atto. Adesso, come
allora, il suono lontano imprime una svolta all’azione. Il Conte dà ordine a
Ferrando di rapire Leonora prima che giunga all’altare e di appostarsi, con i
suoi seguaci, tra gli alberi del chiostro; il pezzo, molto breve, Allegro assai
62
mosso, è attraversato da una figurazione ostinata, che scandisce il tempo
precipitoso di questo momento di tensione, creando un contrasto con il tempo
sospeso dell’aria precedente. L’espressione del Conte «Tutto m’investe un
foco!» è pronunciata con grande energia. Le figurazioni ostinate, ripetute su
gradi diversi, sono molto usate nella musica teatrale (e già ne abbiamo vista
una, nel terzetto in cui Manrico incontra il Conte, sotto il balcone di Leonora)
per portare avanti l’azione, dando l’idea del tempo che scorre.
Dopo il breve e rapidissimo episodio di raccordo, il coro dei seguaci –
tenori e bassi – che, con Ferrando, s’apprestano a rapire Leonora, canta
sottovoce:
Ardire!... andiam… celiamoci
fra l’ombre… nel mister!
Ardire!... Andiam!... silenzio!
Si compia il suo voler!…
Questo coretto, brevissimo, che sbuca fuori improvvisamente
dall’ombra delle piante, nel suo gioco di botta e risposta fra le tre voci
(Ferrando, tenori e bassi), suona quasi comico, o almeno, per nulla tragico né
minaccioso. In realtà, non si tratta di comicità, ma di rendere con una musica
saltellante, in punta di piedi, il gesto di costoro che si muovono furtivamente
sulla scena, tra sussurri e grande circospezione: gli incastri delle voci, che si
rispondono lasciando sgocciolare in pianissimo (ppp) una pioggia di noterelle
staccate, creano l’impressione di un silenzio pieno di attesa. Dopo di che, parte
la cabaletta del baritono che rivela l’altra faccia del Conte di Luna, quella
dell’antagonista che, nel momento di accingersi all’impresa fraudolenta, si
carica psicologicamente con ritmi guerreschi, sonorità aggressive opposte a
quelle morbide dell’aria precedente. La cabaletta è in re bemolle maggiore. Il
canto scatta in ritmi giambici che sostengono la voce in una melodia rampante,
aggressiva: l’orchestra la sostiene, martellando sempre con lo stesso impulso
(tàt-ta-ta-tà), una formula diffusissima nell’opera italiana dell’Ottocento ma
caricata, qui, da Verdi di una selvaggia forza propulsiva. La gioia che il Conte
s’attende con il rapimento di Leonora non è più, ora, di tipo amoroso, ma è
una gioia rabbiosa, è l’ebbrezza della sfida contro lo stesso Iddio diventato, in
questa circostanza, suo rivale: «Invano un Dio rivale | s’oppone all’amor mio |
non può nemmeno un Dio | donna rapirti a me». È il demonismo che Verdi
affida sovente alla voce, per lui centrale, del baritono-antagonista, che muove i
fili dell’azione e determina la catastrofe, destinata a colpire gli amanti
infelici30.
30
Cfr. P. BEKKER, Wandlungen der Oper, cit., p. 115.
63
A metà della cabaletta, sorge, però, un effetto del tutto inatteso:
riappare il breve coretto dei seguaci, con il suo andamento leggero, e quasi
scherzoso. Dopo di che, la cabaletta, furibonda, riprende da capo, ma alla fine
s’intreccia, addirittura, con il coro, in un gioco di botta e risposta argutissimo
quanto imprevedibile tra il Conte, che continua a ripetere, come in un gioco
tragicomico, «Non può nemmen, nemmen un Dio, rapirti a me, rapirti a me,
no, no non può rapirti a me, no, no, no, no…» e il coro che canta «Ardir, ardir,
silenzio, ardir, ardir, celiamoci…» tutto staccato, leggero, meccanico. C’è,
nella voluttà ritmica di questi intrecci, un’evidente carica ludica, spiegabile
con la funzione di contrasto esercitata dal brano rispetto a quello che succederà
subito dopo. Ben lo ha inteso Gabriele Baldini, che parla, se non d’ironia o
comicità, almeno di un «libero senso del divertimento […] e di un
divertimento proprio per contemplare la propria fantasia creatrice che insegue
un gioco senza programma quasi un lieve delirio»31. Ma non è vero che la
musica di questo passo non abbia nulla a che fare con la situazione del libretto:
Verdi non è Rossini, e il suo gioco non si spinge sino a tagliare i ponti con la
situazione drammatica che si riflette, come s’è detto, nelle implicazioni
gestuali di questa musica.
N. 8 Finale Atto II «Ah se l’error t’ingombra» (Leonora, Ines, Manrico,
Ruiz, Conte, Ferrando, Coro).
Dopo questo intreccio di noterelle che saltellano l’una dentro l’altra, si
apre uno squarcio musicale del tutto diverso: il coro a cappella (senza
orchestra) delle religiose, soprani e contralti a quattro voci, che invitano
Leonora a considerare la vanità del mondo, e l’accolgono tra loro nella vita
contemplativa, aperta solo al dialogo con Dio. Dopo la sensualità erotica
dell’aria, e il saltellante coretto, l’improvvisa irruzione dell’elemento sacro
crea una forte svolta espressiva e drammatica. Con questo pezzo inizia il finale
del secondo atto, che dovrebbe proseguire subito con la scena seguente. Ma
Verdi ha qui una trovata imprevedibile. Il coro di monache inizia il suo canto
ieratico e puro, per accordi solenni, in pianissimo, fuori scena; ma,
nell’undicesima battuta, sbuca di nuovo fuori, dall’ombra del chiostro, il
coretto staccato e sussurrante dei complici appostati, mentre il Conte, tra loro,
ripete sottovoce a frammenti: «No, no non può nemmeno un Dio, donna,
rapirti a me».
Questa sovrapposizione apre una prospettiva spaziale tra primo piano e
sfondo mentre, nelle sonorità sommesse e lontane del coro sacro, sottolinea
31
G. BALDINI, Abitare la battaglia, cit., p. 247.
64
l’atmosfera notturna, di silenzio arcano, che avvolge la scena. Ancora più
impressionante, però, è la dialettica espressiva. In primo piano ci sono il Conte
e i suoi seguaci che borbottano, con le loro voci scure; fuori scena sale, invece,
al cielo, la melodia corale delle monache, dapprima raccolta in accordi
ribattuti, poi effusa in note lunghe, alate, di grande tensione lirica. La
sovrapposizione dei due principi sonori rende con evidenza il contrasto tra il
mondo di sentimenti sublimi e coloro che vogliono distruggerli, tra la
promessa di felicità, tranquillità e pace che emana dalla preghiera, e la
minaccia, ridotta da Verdi ad una sorta di disturbo ritmico, cioè a qualche cosa
di mondano e di profano, di meccanico e ridacchiante che s’intreccia
all’elemento sacro, in un rapporto di ambigua profanazione. Tra il coretto a
note staccate di tenori e bassi e quello di soprani e contralti, c’è anche
un’opposizione dell’elemento meccanico con quello organico, metafora
dell’opposizione tra male e bene, che sarà poi ripresa nella Traviata.
Si tratta, quindi, non tanto di una resa realistica, bensì analogica della
situazione teatrale, incentrata sull’opposizione di due mondi antagonisti. Il
tutto sospeso in un’assoluta staticità che mostra come la musica possa
realizzare non solo un teatro d’azione ma anche un dramma di stati d’animo, in
grado di tener desta l’attenzione del pubblico con lo stesso potere soggiogante
che ha una situazione piena di avvenimenti. Qui non succede nulla, se non una
sospensione del tempo drammatico: è la musica che fa teatro.
Il coretto, che attraversa tutta questa scena con un ritmo di lieve danza,
è molto indicativo per comprendere come Verdi sappia sfruttare i dislivelli
stilistici in funzione drammatica ed espressiva. Per Verdi l’accostamento tra
musica d’alta qualità e musica prosaica, semplice, schematica, non è casuale,
ma un mezzo voluto per conferire sbalzo e rilievo alle singole parti, proprio in
virtù del contrasto. Ogni elemento non va mai considerato in sé, ma in rapporto
al contesto in cui è collocato, e all’interno del quale può mutare di significato.
Quando Roncaglia osserva che nel Trovatore «nuoce soprattutto alla proprietà
dell’espres-sione l’uso troppo frequente di ritmi allegri in tempo 3/4, 6/8, 3/8
con spiccato sapore di ballabile»32, si mette in una prospettiva a posteriori,
ancora oggi non completamente superata, e giudica il Verdi del Trovatore dal
punto di vista del «dramma musicale» di matrice wagneriana, assolutizzando il
precetto secondo cui deve esserci una corrispondenza strettissima e diretta tra
il testo e la musica. Quella del Trovatore, infatti, secondo Roncaglia, «talvolta
appare eccessiva, o contrastante col testo, e certo porta il Maestro a ricadere
nel suo passato melodrammatico, e perfino nelle cadenze gorgheggiate» 33. Ma
è proprio questo che Verdi vuol fare, ponendosi in un’ottica che, nel
32
33
G. RONCAGLIA, Giuseppe Verdi, cit., pp. 194-95.
Ibidem, p. 195.
65
Trovatore, è spiccatamente melodrammatica: giocare sul contrasto tra pagine
che aderiscono strettamente ai contenuti emotivi e drammatici, e altre che
acquistano una funzione, puramente musicale, di scarica energetica, sferzante
stimolazione del ritmo teatrale, espressione di concitazione pura. D’altra parte,
lo stesso studioso, due pagine dopo, si corregge e precisa:
A proposito dei motivi a ritmo di danza, conviene però aggiungere che
per l’irruenza e il particolare pathos che il genio di Verdi vi instillò, non
è il dramma che si abbassa al livello del ballabile, ma è questo che si
eleva all’altezza del dramma. Com’è avvenuto anche per certe pagine
dell’Ernani, è la passione che lega al dramma e nobilita i ritmi irruenti,
e a volte un poco plebei. Ma il loro martellare insistente si imprime
nell’anima, vi afferra, vi scuote, e non vi lascia quasi respiro 34.
Ossia, il «ballabile» non è oziosa evasione ma diventa un accumulatore
di quell’energia drammatica da cui le pagine lente e contemplative, tragiche e
patetiche, traggono vantaggio, in quanto immerse in un sistema di tensioni e
distensioni che l’ascoltatore percepisce nella sua pulsazione incalzante. Verdi
sfrutta, quindi, a fini teatrali l’energia generata dalla frizione reciproca dei
numeri chiusi, e dal contrasto tra stile alto e stile basso; principio che non
abbandonerà mai completamente, neppure nelle ultime opere. Così, a seconda
della posizione che acquista nell’opera, un medesimo passo può mutare
radicalmente di significato, come questa scena mostra in modo lampante.
La prima comparsa del coretto, ad esempio, dopo l’aria sognante del
Conte, induce quasi al riso. L’impressione è fugace, perché si esaurisce nel giro
di sole otto battute che acquistano, però, un valore funzionale. Il coretto, infatti,
articola lo spazio nel contrasto tra primo piano e sfondo. Così meccanico e
secco, leggero e arguto, crea, inoltre, un forte un contrasto espressivo con l’aria
del Conte, che sgorgava dalla voce del baritono con spontaneità naturale, e con la
cabaletta, che esplodeva subito dopo nel suo impeto selvaggio: l’ascoltatore è
come spiazzato, incuriosito, richiamato ad un’attenzione vivissima dal suono, dal
ritmo del motivetto improvvisato. La sua qualità musicale non è eccelsa, ma
questo non importa: anzi, proprio la depressione retorica e stilistica che produce,
in rapporto alle iperboli emotive dei pezzi circostanti, ne esalta la funzione
dinamizzante in una scena statica che Verdi prolunga, virtuosisticamente, oltre
ogni prevedibilità. Alla fine della cabaletta c’è, come sappiamo, quella coda che
unisce il Conte e i seguaci in un intreccio di note borbottate e saltellanti. Qui, alla
terza comparsa del coretto, tutto sembra franare nel prosaico: il sentimento non
conta più, neppure quello incendiario del baritono, che viene ignorato. Ciò che
34
Ibidem, pp. 197-98.
66
conta, ora, è solo il gesto dei personaggi che si nascondono, acquattandosi dietro
le piante: il sommesso pulsare delle voci maschili rende in musica lo scalpiccio
dei piedi che si muovono furtivamente sul terreno, il fruscio delle armi e degli
abiti nell’oscurità della notte. Questa rappresentazione di una mera condizione
fisica assume, ancora, un'altra sfumatura espressiva quando si sovrappone al coro
femminile: ora il canto dei seguaci non fa più sorridere, ma acquista
improvvisamente un aspetto negativo, basso, profanante rispetto alla sacralità del
coro sacro, non senza una sfumatura scostante, di meccanico gelo. Il sistema
espressivo della scena si divarica, così, tra sublime e prosaico, con un effetto
molto caro all’arte romantica: quello di unire opposti inconciliabili.
Quindi tutta la scena – ripeto, assolutamente statica – va letta nel suo
complesso come un progressivo assedio delle voci femminili da parte delle
voci maschili del conte e del coro che dapprima si alleano fra loro, poi
muovono all’assalto di soprani e contralti e li stringono in una morsa leggera e
trafittiva. Così, la tensione della scena sale sempre più, per pura virtù del gioco
e delle proporzioni musicali. Questo significa fare teatro con la musica:
trasformare una situazione fissa in un nodo dinamico di contrasti in reciproca e
progressiva tensione. La vita è rappresentata in modo non realistico ma
metaforico, analogico, ideale; i fatti sono visti non come accadono, ma come
sono riflessi nell’inte-riorità della coscienza. Il mezzo di cui Verdi si serve nel
Trovatore è la forma chiusa, cioè l’aria, il coro, il concertato ben delimitato,
costruito al suo interno, con un’architettura musicale compatta, autosufficiente
e definita dalla musica indipendentemente, talvolta, dal libretto. Qui, ad
esempio, la cabaletta, il coro maschile e quello femminile sono tre pezzi
indipendenti che, nel testo, ci si aspetterebbe di ascoltare in successione. Verdi,
invece, li incastra reciprocamente l’uno nell’altro, nel modo descritto. Nasce,
così, una forma musicale unica, articolata e complessa, animata da una forza
espressiva, una compattezza e un’energia teatrale che il melodramma non
aveva ancora conosciuto.
Il risultato è molto audace, e mostra come il Trovatore, anche se
formato essenzialmente da strutture chiuse, offra soluzioni non meno originali
delle opere in cui Verdi sembra assumere una posizione più moderna, per la
duttilità con cui piega la musica alle esigenze narrative dell’azione,
sviluppando il declamato e aprendo le forme. Pari audacia e originalità
nutrono, nel Trovatore, l’invenzione delle melodie. Ma, qui, come s’è detto,
l’azione conta poco o nulla, e la tendenza che sarà fatta propria dal dramma
musicale, di far coincidere il tempo della rappresentazione con il tempo
rappresentato, è totalmente incompatibile con il soggetto, la drammaturgia del
libretto e l’impiego rivoluzionario di vecchie forme melodrammatiche cui
Verdi fa ricorso per tradurla nella musica del Trovatore.
67
Anche nella scena quarta, che conclude il secondo atto, l’azione è molto
rapida e sbrigativa, mentre il momento contemplativo è dilatato dalla musica
con effetti di tensione interna analoghi a quelli rilevati nel quadro precedente.
Terminato il coro di religiose, che sfuma nel pianissimo, compare
Leonora, che rivediamo qui per la prima volta dopo il primo atto, con Ines, la
sua confidente; poi, il Conte, Ferrando, i seguaci, indi Manrico. Leonora, che
crede morto Manrico, dice di voler lasciare il mondo perché solo nella vita di
preghiera potrà trovare conforto ad un’esistenza senza felicità, e coltivare la
speranza di ricongiungersi, un giorno, al suo «perduto bene». La scena si apre
con un Andante in mi bemolle maggiore, breve preludio strumentale con
accordi ribattuti e due incisi lamentosi del clarinetto nel silenzio orchestrale:
voci flebili, fugaci ma intense nel rappresentare l’entrata di Leonora, e il suo
stato d’animo. Il dialogo con Ines è intonato in un recitativo entro il quale
Verdi incastona una perla melodica di grandissima bellezza, vale a dire la
battuta di Leonora: «Oh dolci amiche, | un riso una speranza, un fior la terra |
non ha per me…». Il cantabile arioso in do minore sembra già nello stile del
Don Carlos e dell’Aida, in quanto frase melodiosissima, libera da qualsiasi
regolare schematismo. Questo stile di canto è poco usato nel Trovatore che
predilige forme melodiche simmetriche, arie regolari, strutture chiuse. Sotto la
voce c’è un accompagnamento molto semplice, cui un grande direttore
d’orchestra può conferire una vitalità segreta, una pulsazione fisiologica
capace di togliere ogni meccanicità, assomigliandolo ad un battito del cuore.
Sopra questo andamento si distende il meraviglioso canto di Leonora, che
sorge e si spegne come un raggio di luce. Si noti la finezza con cui sono
interpretate le singole parole: le acciaccature dolorose di «e dopo i penitenti
giorni»; lo slancio verso l’alto di «al mio perduto bene». Bastano pochi
momenti per scolpire un personaggio. Magari lo spettatore, lì per lì, non ci fa
caso, ma questi particolari, a poco a poco, si accumulano nella sua memoria e
incidono il profilo di una figura drammatica in forma indelebile. In questa
scena, dove Leonora compare pochissimo, l’arioso è così intenso che è
sufficiente per evidenziare la sua purezza sentimentale, lo slancio ideale,
l’intensità con cui vive l’amore per Manrico.
Dopo il «cantabile» di Leonora, irrompe sulla scena il Conte di Luna,
gridando (Allegro assai) che l’unico altare cui Leonora può aspirare è quello
del matrimonio con lui. Subito dopo, compare Manrico, «qual fantasma sorto
di sotterra», che tutti credevano morto. L’orchestra esplode sul grido collettivo
di spavento: inizia un quadro di stupore che ha una vecchia tradizione nel
melodramma, sin dal ‘700, quando situazioni di questo tipo si erano affermate
nell’opera francese. Qui, dopo l’improvvisa comparsa di Manrico, attacca
Leonora, che non crede ai suoi occhi: «E deggio... e posso crederlo? | Ti veggo
a me davanti! » cui fanno riscontro le battute del Conte «Dunque gli estinti
68
lasciano | di morte il regno eterno» e di Manrico «Né m’ebbe il ciel, né l’orrido
| varco infernal sentiero». Comincia così l’Andante mosso in la bemolle
maggiore, caratterizzato dal contrasto tra Leonora, da una parte, tutta presa dal
dolce stupore di rivedere Manrico, e il Conte e Manrico, dall’altra, che si
sfidano, con le loro voci di tenore e basso, alternando le battute in modo
ravvicinato.
Il canto di Leonora rende lo stupore con una frase spezzata da pause, e
le parole sbriciolate fra un inciso e l’altro. Trascrivendo, in modo un po’ buffo,
il testo suona così: «E deeg-gioepoos-socree-derloo? Tiveeg-goameed’accanto!». Parole deformate, parole distrutte, eppure quanto espressive nella
resa della melodia con il respiro mozzato dallo stupore! Su «non reggo a tanto
giubilo» Leonora s’effonde in una frase che s’inarca e poi discende. Quindi,
con un fervore analogo a quello delle melodie cantate nell’aria del primo atto,
cui viene accomunata anche dalla pulsazione del ritmo giambico, parte lo
slancio decisivo: «Sei tu dal ciel disceso | o in ciel son io con te?»,
meraviglioso razzo melodico che sale con «espansione e slancio» sino al si
bemolle acuto. Quindi lo stupore di Leonora ha due risvolti psicologici:
sorpresa da una parte, senso di liberazione dall’altra, prodotto dall’ultima frase
slanciatissima e così bella che Verdi la serberà in segreto per giocarla, ancora
una volta, più avanti, in un punto strategico. Subito dopo, le frasi del Conte e
di Manrico che esprimono, l’uno stupore, l’altro sfida, cozzano insieme in
modo battagliero, allacciandosi in un terzetto dove la voce di Leonora insinua
un senso di crescente tensione.
Il concertato prosegue, dopo una lunga pausa, con una nuova frase
musicale di Leonora che, sulle medesime parole «È questo un sogno,
un’estasi?», esprime, con un gorgheggio «leggerissimo e brillantissimo», come
scrive Verdi, la felicità provocata dall’ina-spettata comparsa di Manrico: l’effetto
di alleggerimento è singolarissimo, e necessario, anche perché il passo si
prolunga con l’aggiunta delle voci di Ines, Ferrando, dei suoi seguaci e delle
monache. Ad un certo punto, giunge Ruiz con un seguito di armati: sono poche
battute concentrate che fanno salire la tensione, fino al grido terribile del Conte:
«Ho le furie nel cor!», dopodiché tutto si ferma per lasciar posto ad un vero
colpo di scena musicale, che rovescia all’ultimo momento la situazione emotiva.
Leonora riprende la folgorante melodia di «Sei tu dal ciel disceso» dopo una
lunga pausa, nel momento di massima implosione degli elementi musicali,
quando tutto sembra precipitare in una catastrofica voragine sonora: l’effetto è
d’improvvisa liberazione, come di fuga da quest’assedio in cui il soprano e il
tenore vengono, per la seconda volta, stretti dalla presenza del Conte di Luna e
dei suoi. Quindi, tutta questa seconda parte è giocata, nella sua staticità, su un
contrasto di sentimenti e stati d’animo, piccoli e grandi colpi di scena. Verdi
sfrutta di nuovo il procedimento di riprendere un elemento a distanza per esaltare
69
un sentimento, sottolineare l’importanza di un personaggio, scegliere, tra le varie
possibilità che la situazione gli offre, l’elemento espressivo centrale su cui
focalizzare il senso della scena. Anche qui l’azione esteriore è ferma, ma quella
interiore è dinamicissima nella contrapposizione di sentimenti in caleidoscopica
successione: stupore ed estasi amorosa di Leonora; duello musicale tra tenore e
baritono; gorgheggio «leggerissimo e brillante» di Leonora, espressione di
giovinezza volatile e libera; entrata incalzante di Ruiz e compagni in cui tutto
sembra precipitare verso la frase del Conte: «Ho le furie nel cor!», detta con
«gesti di maniaco furore»; lunga pausa; ripresa della frase di Leonora: «Sei tu dal
ciel disceso» che squarcia questa tensione tremenda, se ne libera in una sorta di
volo, come un oggetto che solca il cielo con la sua traccia luminosa. È quindi di
nuovo pura drammaturgia di stati d’animo che inchioda gli spettatori ad un teatro
senza azione.
70
71
Capitolo quarto
Atto terzo (Parte terza: Il figlio della zingara)
N. 9 Coro «Or co’dadi» (Ferrando, Coro).
Mentre il secondo atto è incentrato sulla figura di Azucena, il terzo
porta in primo piano quella di Manrico. Spostare così avanti la definitiva
presentazione del protagonista rivela, da parte di Verdi, la volontà di tenere
desta l’attenzione dello spettatore e soddisfare solo a poco a poco la sua
curiosità. Questo presuppone una dosatura attentissima degli elementi
caratterizzanti, aggiunti uno sull’altro con un progressivo, sapiente effetto di
accumulo, reso possibile dalla costruzione ad hoc del libretto. La scena
rappresenta lo stesso ambiente militaresco del primo atto, ora spostato in un
accampamento, sotto la rocca di Castellor di cui Manrico è diventato
guardiano, e che l’esercito del Conte di Luna s’appre-sta ad assediare: «a
destra il padiglione del Conte di Luna, su cui sventola la bandiera in segno di
supremo comando; da lungi torreggia Castellor. Scolte di uomini dappertutto;
alcuni giocano, altri puliscono le armi, altri passeggiano, poi Ferrando dal
padiglione del Conte». Tutte le didascalie di Verdi uniscono essenzialità a
funzionalità. Non è solo una concessione decorativa la presenza, sullo sfondo
della scena, della fortezza di Castellor: raffigurarla, in qualsiasi modo,
tradizionale o moderno, figurativo o astratto, come dipinto, architettura, ombra
o proiezione luminosa, significa rendere presente agli occhi dello spettatore
qual è l’oggetto dell’impresa bellica di cui si parlerà nel primo coro. In
Castellor sono asserragliati i nemici: vedendolo sullo sfondo, si crea una
tensione drammatica, anche dal punto di vista scenografico.
«Or co’ dadi, ma fra poco | giocherem ben altro giuoco» è il primo
verso del coro introduttivo, in do maggiore, che gli armigeri cantano,
incitandosi all’assalto dell’indomani. Lo stile brillante, i ritmi di marcia, la
strumentazione accesa di colori vivi e, soprattutto, le piroettanti quartine di
semicrome su tempo forte, ricordano il coro degli zingari, all’inizio del
secondo atto, ma anche la musica del racconto di Ferrando, dove identiche
figurazioni schioccavano come nacchere o tamburelli; qui, nel preludietto
strumentale che apre il terzo atto, creano un vortice d’energia vitale che
esprime lo stato d’animo dei soldati, eccitati all’idea della prossima vittoria di
cui sono sicuri.
72
In questo pezzo brillantissimo, il coro I e coro II, entrambi a due voci di
tenori e bassi, si rispondono in punti diversi della scena, con vivace effetto
stereofonico. La musica è semplice ma indimenticabile. Inizia fortissimo, con
un ritmo scalpitante, che rompe in modo deciso l’atmosfera misteriosa,
notturna, concentrata e sospesa del quadro precedente: ha un tono popolaresco
ed insieme spensierato, non è certo profonda, ma serve a definire il colorito
pittoresco, che è una delle componenti fondamentali del Trovatore: senso
dell’avventura, del racconto popolare tratteggiato con colori vivi, e con un
affetto tutto particolare per l’espres-sione semplice, ingenua, immediata.
Subito dopo, attacca Ferrando, che incita alla battaglia i soldati, i quali
rispondono con «Squilli, echeggi la tromba guerriera», Allegro moderato
maestoso in fa maggiore, pulsante di ritmi giambici che qui alludono non al
fuoco, non alla passione, bensì all’energia militaresca, sempre, comunque, a
qualche cosa di propulsivo e vitale. Il giambo rappresenta dunque, nel
Trovatore, un principio ritmico unitario che anima situazioni statiche,
conferisce tensione alla rappresentazione delle passioni e degli affetti, collega
tra loro i vari livelli d’espressione: da quello superficiale, estroverso e
scenografico dei cori, a quello profondo delle immagini, visioni o allucinazioni
che ogni personaggio racchiude in sé, intrecciando legami, attraverso la
musica, per affinità o per contrasto, alla vita interiore degli altri.
L’andamento alla bersagliera di questa scena suona come in una marcia
di parata, allegra e festiva. Verdi aveva già scritto simili marce in opere
precedenti, ma questa si distingue per la sua spiccatissima cantabilità: tra
l’altro, è strumentata con grande fantasia, come tutta la scena, dove scintillano
le piroette dei flauti e degli ottavini, gli squilli militareschi, ma in pianissimo,
di trombe e corni quando «un grosso drappello di balestrieri traversa il
campo», gli arguti contrattempi ritmici dei fiati e degli archi pizzicati (sempre
piano) nell’Allegro moderato maestoso di «Squilli, echeggi, la tromba
guerriera», la tromba sola che, «morendo», accompagna fuori scena la marcia
di questi deliziosi soldatini di piombo. Certo, tutto va eseguito come è scritto,
in punta di penna, con mozartiana levità: pena l’involgarimento d’una scena
che non sfigurerebbe in un balletto di Čajkovskij. È innegabile, da parte di
Verdi, una presa di distanza dagli aspetti militari dell’opera, guardati con un
occhio quasi divertito per conferire alla partitura una componente leggera,
arguta, adoprata consapevolmente come elemento di contrasto nei confronti
dei grandi momenti d’intensità sentimentale, d’accensione passionale o di
tragedia.
Già il coro dei proditorii seguaci del Conte di Luna, appostati
nell’ombra del chiostro, ricordava Rossini; una reminiscenza che ritorna qui,
dove il suono rimanda a certi passi militar-pittoreschi di Semiramide. Il gioco
s’inserisce nella concezione, tipicamente italiana, dell’opera come festa, che
73
tiene sempre in considerazione le esigenze dello spettatore, e gli offre momenti
distensivi, utili perché la sua attenzione si ridesti, rinnovata, nelle scene di
grande impegno drammatico. Tutto si gioca, quindi, in un sistema di tensioni e
distensioni che, in Verdi, è calcolato al millimetro.
N. 10 Scena «In braccio al mio rival!» e Terzetto «Giorni poveri vivea»
(Azucena, Conte, Ferrando, Coro).
Dopo che i soldati se ne sono andati, rimane, solo in scena, il Conte di
Luna a sbrigare, in un recitativo, una di quelle parti di raccordo trattate con
rapidità, se non con fretta, dal Verdi del Trovatore. Il Conte è furibondo
all’idea che Leonora abbia potuto di nuovo riunirsi a Manrico. Subito dopo,
entra Ferrando che annuncia la cattura di una zingara, trascinata in scena dagli
«esploratori». La zingara, naturalmente, è Azucena che viene subito chiamata
strega dalle sentinelle che l’hanno arrestata. Il Conte la interroga
sommariamente. La scena è risolta in un Allegro agitato senza alcuna
particolare qualità melodica né ritmica e non ha altro scopo che quello di
creare un effetto di concitazione, quasi brutale. Ferrando canta solo note
ribattute. Musicalmente siamo a zero: c’è solo la volontà di creare una svolta
dopo la calma del recitativo iniziale. Quello che segue non è molto diverso;
quando arriva Azucena, e il Conte dice «Eccola...» ci sono altri frammenti di
recitativo, sostenuti da generiche figurazioni agitate. Non c’è,
provocatoriamente, alcuna volontà inventiva. Unico passo più espressivo, la
frase di Azucena, «D’una zingara è costume | mover senza disegno», cantata in
un tono molto vero, di errante malinconia: è l’immagine della vita nomade,
tradotta in musica. Si pensi che tre mesi dopo, nella Traviata, Verdi scriverà
dei declamati di una qualità espressiva notevolissima. Qui non è che sia
incapace di fare un bel recitativo, è che non vuole, perché l’arte del trapasso
psicologico che implica l’uso di questa forma, dal quasi parlato, al grande
declamato sinfonico, all’arioso, è estranea all’orizzonte del Trovatore. Ne
abbiamo conferma anche qui dove, all’attacco del terzetto «Giorni poveri vivea
| pur contenta del mio stato», un meraviglioso Andante mosso in mi minore,
Azucena comincia un altro racconto: di nuovo l’oggetto del discorso è un fatto
lontano, uno stato d’animo, una situazione evocata dal ricordo, quella della
vita povera e randagia che era, sì, confortata dalla presenza di un figlio
amatissimo, ma ora è desolata perché il ragazzo è partito e non si sa più nulla
di lui. Per cercarlo, non per spiare i militari, dunque, Azucena s’aggirava nei
dintorni dell’ac-campamento.
Il Terzetto è formato da due sezioni. La prima va dall’inizio della strofa
in ottonari, «Giorni poveri vivea», sino al verso del Conte: «Oh sorte! ...in mio
poter!»: è un Andante mosso in 3/8, in mi minore. La seconda parte, che inizia
alle parole di Azucena «Deh! rallentate o barbari», è un Allegro in 4/4, in fa
74
maggiore. La prima parte è di conversazione; la seconda, esclamativa: l’azione
si ferma e le parole vengono ripetute e sovrapposte, secondo lo stile dei
concertati statici a più voci. Chi è il protagonista di questo terzetto? Senza
dubbio Azucena, che svela qui l’amore di madre dolorosa, altro aspetto
fondamentale della sua personalità, sinora apparso solo per brevi accenni,
durante il secondo atto. Si noti come sia sapiente la dosatura con cui Verdi e
Cammarano regolano la presentazione dei personaggi, che non si trasformano,
è vero, come i protagonisti del Rigoletto e della Traviata, ma svelano a poco a
poco le varie componenti della loro vita affettiva, acquistando plasticità
davanti agli occhi dello spettatore. Certi sentimenti che, quando compaiono per
la prima volta, passano magari inosservati, sono ripresi a distanza e portati in
primo piano: si crea così un sistema di intrecci, di riferimenti, di
corrispondenze e di sviluppi che conferisce all’opera la sua unità, e ai
personaggi la loro coerenza attraverso il decorso drammatico, con logica ferrea
e infallibile senso dello spettacolo.
Per mettere a fuoco il personaggio di Azucena, Verdi punta di nuovo,
essenzialmente, sull’elemento principe del Trovatore, cioè sulla melodia, che
non è intesa come semplice sfogo canoro ma viene lavorata con finezza per
rappresentare la vita dei sentimenti nel suo dinamismo. La melodia che canta
Azucena, nella malinconica tonalità di mi minore, è una rappresentazione del
pianto che dapprima inizia, poi sgorga, indi s’asciuga. Nella frase iniziale di sette
battute, frase irregolare, e quindi tanto più espressiva d’una situazione di
squilibrio, di barcollamento interiore, il suono della lingua è deformato: «Giorni
po-vèee-ri vìii-ve-e-a». Gli accenti, grazie alla sincope della prima e seconda
battuta, sono spostati; questo conferisce alla melodia un senso di peso, di fatica e
d’inciampo. Si noti l’acciaccatura su «contenta»: un intimo singhiozzo. In «sola
speme un figlio avea» l’idea del figlio perduto è espressa con un re tenuto per
una battuta (su «avea»), doloroso come un grido. Con «mi lasciò!… m’oblia,
l’ingrato!», un inciso quasi declamato, finisce la prima sezione, già bellissima,
della melodia, che un compositore normale avrebbe certamente sfruttato ancora
nei versi seguenti. Verdi, invece, cambia radicalmente. Il suo genio melodico è
in pieno fervore, e trabocca d’invenzioni sempre nuove. Se prima Azucena
raccontava con turbamento dei suoi giorni lontani, ora, considerando la
situazione presente, piange: «Io, deserta, vado errando | di quel figlio ricercando |
di quel figlio che al mio core | pene orribili costò». Il pianto, prima appena
accennato, ora sgorga, nel passaggio cromatico discendente re–do#–do–si (su
«vado errando» e «che al mio core») ma, subito dopo, il pensiero delle pene che
Azucena ha dovuto sopportare per Manrico viene sostituito dal sentimento
d’amore: «Qual per esso provo amore | madre in terra non provò!». Semplice ma
impressionante è il passaggio da mi minore a mi maggiore e straordinaria, nel
suo effetto liberatorio, la linea melodica che sale, pulsando, con una successione
75
di lunga-breve. Qui le lacrime si asciugano, l’immagine di Manrico strappa, ad
Azucena, quasi un sorriso. Sentiamo, infatti, lo stesso slancio, anzi, lo stesso
tema che concludeva l’aria di Leonora nel primo atto (alle parole «Al core, al
guardo estatico la terra un ciel sembrò»). L’amore di donna e l’amore di madre
traboccano, entrambi, in una sorta di estasi: le due melodie partono dal basso, e
s’innalzano attraverso gli impulsi del ritmo giambico.
Verdi intende quindi l’amore come sentimento universale a sfondo etico
che annulla le differenze tra le condizioni specifiche dei personaggi, anzi dei
sessi: non c’è posto nel suo teatro per l’eros mozartiano che scorre tra l’uomo e
la donna, ponendosi come forza istintiva e trascinante del mondo. Così
Manrico è fatto oggetto di due espressioni d’amore affini per un senso comune
di elevazione spirituale e di forte tensione morale. Si potrebbe quindi avanzare
l’ipotesi scherzosa che Leonora e Azucena, suocera e nuora, sarebbero andate
perfettamente d’accordo, perché l’amore che esse nutrono per Manrico è della
stessa natura, un amore elevato, nutrito di tensione ideale. È anche, e
soprattutto, questa moralità degli affetti che distingue Verdi dai compositori
precedenti, e risponde all’esigenza di rinnovamento dell’opera italiana che
Mazzini aveva auspicato nella Filosofia della musica. Le due donne del
Trovatore, però, non duettano mai tra loro, e la natura dei loro rapporti rimane
sottaciuta.
L’«amor sacro» di Azucena e Leonora è diverso, quindi, dall’«amor
profano», sensuale e galante, del Conte di Luna, che ora cerca di capire chi è
questa zingara che gli è stata portata davanti, mentre Ferrando riconosce in lei
quella che aveva rapito il fratellino del Conte di Luna, quindici anni prima. Il
riferimento cronologico ci permette di dare un’età ai personaggi: Manrico,
Leonora e il Conte devono essere attorno ai diciott’anni, forse meno. È
essenziale, quindi, che un senso di giovinezza venga dato loro dai cantanti, dal
regista e dal direttore d’orchestra: il che vuol dire leggerezza, spontaneità,
naturalezza, agilità e freschezza, non retorica melodrammatica di stampo
verista, né eccessivo carico d’espressione che sovente invecchia
disastrosamente i personaggi, trasformandoli in troneggianti senatori del
melodramma.
L’interrogatorio di Azucena viene svolto attraverso un dialogo poco
melodico, ma la melodia continua, in orchestra, con un tema derivante dalla
frase che aveva concluso il suo precedente intervento: come se l’effusione
dell’amor filiale dilagasse irresistibile sino ad esaurirsi, a poco a poco,
nell’incalzare del dialogo e degli eventi che stano precipitando. Un tema così
non c’entra niente con quello che si dice, ma lascia perdurare, sullo sfondo, il
sentimento che continua a traboccare, come da un vaso troppo pieno,
dall’animo di Azucena: ecco un caso, rarissimo in quest’o-pera, in altre molto
più frequente, in cui l’orchestra addita all’at-tenzione del pubblico significati
76
diversi da quelli delle parole. Poi, al verso di Ferrando «Tu vedi | chi l’infame,
orribil opra | commettea», il tema melodico s’interrompe, e s’instaura un clima
agitato (Allegro in do maggiore) che porta, attraverso l’inserzione del coro
(«Ella stessa!»), alla seconda parte del terzetto.
Questa è preceduta dal grido che Azucena lancia «con disperazione»
alle parole «E tu non m’odi, | o Manrico, o figlio mio?… | Non soccorri
all’infelice | madre tua?», un grido che, dopo una lunga sospensione sulla
settima diminuita di fa minore, spezza l’andamento un po’ meccanico ed
implacabile che il terzetto stava prendendo, e scende attraverso una settima dal
sol al fa, su ansimanti pulsazioni di lunga-breve, mentre un pedale di do
sostiene varie modulazioni (in do maggiore, la minore, fa maggiore, do
maggiore) attraverso una serie di nostalgici ritardi, approdanti alla lunga
sospensione sulla settima diminuita di do che traduce lo stupore del conte: «Di
Manrico genitrice!».
Il senso drammatico della scena sta nel progressivo assedio del
personaggio di Azucena da parte degli altri, assedio dal quale lei tenta di
liberarsi con l’invocazione al figlio lontano, simile, per ritmo e melodia, al
canto che Azucena aveva usato per dire a Manrico «No, soffrirlo non poss’io |
il tuo sangue è sangue mio!», nel duetto del secondo atto. Come si vede, le
reminiscenze interne di melodie affini s’incrociano in un sistema di
corrispondenze che contribuiscono in modo decisivo a definire la personalità
dei singoli, ottenuta attraverso una potenza di caratterizzazione individuale
della linea melodica, che il melodramma italiano non aveva più conosciuto dai
tempi di Monteverdi.
In questa prima parte del terzetto si svolge una vicenda musicale analoga
a quella che abbiamo già visto nel racconto di Azucena del secondo atto: la
melodia formata che compare all’inizio, a poco a poco si sbriciola, sino a
concludersi in un grido, libero da costrizioni metrico-ritmiche. Dopo
l’invocazione al figlio, e tre battute del Conte e di Ferrando, Azucena attacca la
seconda sezione del terzetto, l’Allegro in fa maggiore «Deh, rallentate, o barbari
| le acerbe mie ritorte», con un martellare di ritmi giambici che spostano gli
accenti delle parole. In questo sobbalzare della voce che pare dibattersi senza
trovare una via d’uscita, come un animale preso in trappola, si sente bene la
parola «Trema!…», declamata con forza; è la classica «parola scenica» che ci
rivela il punto focale della situazione, l’antagonismo di Azucena nei confronti
del Conte di Luna. Il concertato prosegue con un andamento ritmico concitato,
come alla fine del terzetto del primo atto, e alla fine della scena del chiostro: la
vittima braccata non può fare altro che minacciare, senza sortire alcun risultato.
Non ci sono frasi liberatorie come quella di Leonora che abbiamo sentito nel
quadro precedente: qui Azucena è prigioniera e in quel «Trema! trema!», detto
77
due volte, c’è un’espressione di impotenza, di paura, di nervosismo, ma non di
rivincita né, tantomeno, di speranza.
C’è da notare un’analogia musicale interessante con il terzetto che
chiudeva il primo atto, quando il Conte di Luna e Manrico si sfidavano a duello
sotto il balcone di Leonora. Leonora cantava un disegno («A te credei rivolgere |
l’accento, e non a lui») molto simile a questo di Azucena («Deh, rallentate, o
barbari»). Là si era notato che questo scatto, questa specie di scintilla che
appiccava l’incendio ritmico a tutto il terzetto, si poteva anche interpretare come
immagine della fiamma: Leonora, infatti, diceva che era lei la causa di tutto quel
fuoco. In questo concertato, di nuovo, ritorna l’immagine centrale dell’opera,
con un’insistenza quasi didascalica, nella minaccia di Ferrando e del coro:
Infame pira sorgere,
ah sì, vedrai tra poco…
Né solo tuo supplizio
sarà l’orrendo foco!…
Le vampe dell’inferno
a te fian rogo eterno,
ivi penare ed ardere
l’anima tua dovrà!
Altra corrispondenza, dunque, che rafforza, in questo caso, la presa
immaginifica dell’idea centrale. A questo punto, la vicenda di Azucena si
carica di ulteriore drammaticità: tutto ciò che è successo alla madre sta per
succedere anche lei. Si crea, così, una sovrapposizione tra la figura della madre
e la situazione presente. Ciò che viveva nel ricordo si avvera, il fantasma
diviene realtà, il passato ritorna, e si avvicina, l’immaginazione acquista un
inopinato e sorprendente riscontro nel presente. La febbre emozionale del
Trovatore, resa dalla fiammeggiante agitazione della musica, non cessa, in tal
modo, di salire sempre più.
N.11 Aria di Manrico «Qual d’armi fragor»; «Ah! sì, ben mio,
coll’essere» (Leonora, Manrico, Ruiz, Coro).
Dall’accampamento, si passa ora nella sala adiacente alla cappella di
Castellor, una sacrestia «con verone nel fondo» dove Leonora e Manrico
stanno preparandosi alla celebrazione del matrimonio. La scena inizia
sommessamente, con un recitativo in cui Manrico dice a Leonora che, alle
prossime luci dell’aurora, la rocca sarà assalita dai nemici. Poi, affida a Ruiz il
comando dell’operazione militare per il tempo dovuto alla cerimonia. È un
dialogo molto semplice, quotidiano, senza grande sostanza di pensiero
78
musicale. L’Adagio «Di qual tetra luce | il nostro imen risplende!» introduce la
svolta verso l’interiorità; dalle considerazioni pratiche si passa all’espressione
dei sentimenti: un presagio di morte grava sulla felicità di Leonora e Manrico
che, l’indo-mani, deve affrontare la battaglia. Questo stato d’animo è
sviluppato nella meravigliosa aria seguente, in cui la tenerezza del momento
amoroso s’intreccia alla malinconia per l’inevitabile distacco da Leonora, che
potrebbe anche essere definitivo. «Il presagio funesto, deh, sperdi, o cara»
canta Manrico, introducendo, già nel recitativo, il clima lirico e malinconico
dell’aria in cui il contrasto tra amore e morte è rappresentato non in modo
drammatico, ma squisitamente lirico.
Questo tipo d’espressività ci sorprende perché, finora, il protagonista si
è mostrato per lo più estroverso, spavaldo, energico e sicuro. Il tenore eroico,
di cui Manrico – secondo la definizione, un po’ riduttiva e convenzionale, di
Budden – sarebbe la quintessenza, è in realtà pieno di tenerezza, malinconia,
dolcezza, suprema eleganza di canto. Questa è, infatti, un’aria melodicamente
bellissima, a torto oscurata dalla fama della cabaletta che segue; un’aria che
rivela l’affinità elettiva tra i due sposi, abituati entrambi ad esprimersi con
accenti comuni di purezza e slancio ideale, estranei alla sensualità che
trabocca, invece, dal demonismo del Conte di Luna. Qui tutto è casto, dal
punto di vista espressivo, seppure straordinariamente commosso: si tratta d’un
Adagio «cantabile con espressione», in 6/8, nella tonalità di fa minore, scura,
malinconica, sommessa.
Manrico canta piano, in alcune parti pianissimo, e solo ogni tanto
un’intensificazione dinamica porta al forte ma, subito dopo, tutto rientra nella
sonorità sottovoce. Nel canto pulsa, sin dall’inizio, quel ritmo giambico che
siamo obbligati a rilevare continuamente, sia in figurazioni veloci (dove i
giambi indicano agitazione, concitazione, passioni molto intense e momenti
drammatici), sia in momenti distesi e cantabili (dove questo ritmo conferisce al
sentimento un’espansione vitale). L’orchestra accompagna la voce con
figurazioni regolari, quasi acquatiche nel loro cullante beccheggio.
Ah! sì, ben mio, coll’essere
io tuo, tu mia consorte,
avrò più l’alma intrepida,
il braccio avrò più forte.
La melodia inizia in un tono scampanante e malinconico, su un
intervallo di terza maggiore (la bemolle-do) tipico di Manrico (lo abbiamo
trovato nella sua romanza fuori scena «Deserto sulla terra»). Ma già nel terzo
verso l’idea della fortezza è segnata da una modulazione in la bemolle
maggiore, e dall’impennarsi della voce in una fervida salita verso il la bemolle
79
acuto, cantato fortissimo. È uno sprazzo di energia virile, tosto ripiegantesi
nella seconda strofa in cui, «con dolore», Manrico intona i versi seguenti, di
nuovo in tonalità minore (la bemolle):
Ma pur se nella pagina
de’ miei destini è scritto…
Si noti qui il fluire, stupendamente levigato, della melodia, con gli
andamenti scampananti sugli intervalli do bemolle-mi bemolle, che ricordano
il tema iniziale, qui, però, totalmente trasformato. In quest’aria non c’è un
tema uguale all’altro: tutto è in continua variazione, le ombreggiature
espressive nascono dalla melodia attraverso delicatissime transizioni, come
quella che sfocia nell’espressione lacerata del distico successivo:
Ch’io resti tra le vittime
dal ferro ostil trafitto…
Qui s’avanza l’idea della morte: il canto scivola dalla melodia al
declamato, scandito «con forza», in un crescendo che decresce subito nel
piano. Le parole si capiscono bene, specie quando i versi sono ripetuti con le
note-sillabe ben scandite. Dalla malinconia, dall’affetto, nasce e muore subito
un momento di disperazione: la ribellione di Manrico alla prospettiva di poter
morire. Ma tutto è raccolto nell’intimità. Bellissimo è l’andamento delle
modulazioni: dal la bemolle minore si passa in fa bemolle maggiore, tonalità
teorica corrispondente a mi maggiore; Verdi la scrive per evitare la
modulazione enarmonica in mi maggiore, e passare in re bemolle maggiore
nell’episodio successivo «fra quegli estremi aneliti». Qui, malinconiche note
ribattute spiccano il volo verso l’alto alle parole «solo in ciel precederti», di
nuovo un forte, subito sostituito dal diminuendo dolce con piccolo melisma e
cadenza conclusiva sul trillo: un tocco settecentesco, in sintonia con il carattere
mozartiano di quest’aria, dovuto al gioco, mirabilmente fluido, di trapassi e
raccordi che collegano i vari spunti melodici; senza contare la tenerezza, la
pudica riservatezza con cui Manrico trattiene dentro di sé sentimenti di
disperazione e di dolore. Quest’aria, ovviamente, non va gridata, né cantata
con quel tono da stornellata napoletana comune ai tenori che intendono
Manrico solo come un ragazzo battagliero o un’ugola d’oro; va eseguita,
invece, con molto stile, in modo intimo, segreto: «diminuendo, dolce», come
prescrive Verdi con una dinamica, per dir così, retrattile, agile nel passare
improvvisamente al forte e al fortissimo, per rientrare subito nel tono
affettuoso della confidenza tenera e riservata. Da notare gli interventi, molto
dolci, dei clarinetti che pausano le parole durante la ripetizione di «fra questi
80
estremi aneliti»: voci affettuosamente partecipi, carezze di compassione.
Bellissimo è il finale, con il si doppio bemolle su «a me parrà», dallo
straordinario effetto malinconico.
Questo caleidoscopico fluttuare d’espressioni diverse, tra la malinconia, il
dolore, e qualche tocco di lacerato fatalismo, s’incanala in una forma ben
circoscritta, ma internamente assai libera. Non ci sono schematismi, nessuna
frase è ripetuta identica: l’aria è, invece, attraversata da assonanze, da elementi
che ritornano a distanza, dando al pezzo la sua unità, pur seguendo da vicino il
continuo fluttuare del sentimento e l’oscillazione dei pensieri. Se è vero che il
Trovatore è tutto basato sulle forme chiuse, non per questo appare meno
avanzato del Rigoletto, come tende ad affermare la critica: il lavoro di cesello per
variegare all’interno queste forme chiuse, distinguere ogni frase con tratti
individuali, metterle tra loro in relazione dialettica, rivela un’arte della melodia
drammatica che Verdi porta ad un grado di duttilità espressiva sinora
sconosciuto all’opera italiana. Per converso, Il Trovatore presenta, come s’è
visto, delle arie strofiche e regolari, per esempio la canzone «Stride la vampa», o
la successiva cabaletta «Di quella pira», dove non si tratta di rappresentare un
caleidoscopio di sentimenti in divenire, ma di mostrare il focalizzarsi
dell’interiorità su di una immagine che l’assorbe in modo esclusivo.
Una schematizzazione dell’aria di Manrico può essere utile per
comprenderne la bellezza, ossia il gioco delle proporzioni e degli interni
rapporti formali:
A «Ah sì ben mio con l’essere»
B «Ma pur se nella pagina»
C «Tra quegli estremi aneliti»
fa minore
la bemolle maggiore
la bemolle maggiore
fa bemolle minore
re bemolle maggiore
Notiamo la fluidità. Il testo è formato da tre quartine di settenari. Ogni
quartina ha musica diversa (A B C), non ci sono riprese tematiche né tonali.
Inoltre, le tonalità cambiano per conto loro, e le modulazioni non coincidono
necessariamente con l’inizio dei tre episodi musicali. «Ah sì ben mio con
l’essere» è in fa minore, ma già due versi dopo, su «Avrò più l’alma
intrepida», si passa la bemolle maggiore. Quando inizia l’episodio B, la
tonalità è già cambiata da un pezzo, e dura sino al verso «Ch’io resti tra le
vittime» per passare poi in fa bemolle minore.
Quindi il mutamento della tonalità non coincide con il mutamento
dell’episodio; solamente quando s’inserisce l’episodio C abbiamo, una tonalità
nuova, re bemolle maggiore. Questa sfasatura che si crea tra la successione
degli episodi musicali e quella delle tonalità produce un’impressione di grande
81
fluidità: il mutamento degli episodi è meno evidente, in quanto le tonalità li
collegano gli uni con gli altri, creando dei ponti, enjambements tonali tra una
strofa e l’altra. Si vede che Verdi aveva assimilato molto profondamente lo
stile mozartiano. Anche qui la struttura formale sembra riprodurre in sé i
contenuti espressivi: come l’ombra della morte si stende su questo momento
che dovrebbe essere felice, così un’ombra offusca la chiarezza degli snodi
strutturali, mentre l’aria sembra aleggiare in un’atmosfera misteriosa e presaga.
Dunque il ragazzo aitante, spavaldo e un po’ incosciente, tutto impulso
e slanci, qui si rivela di nuovo, come nel duetto con Azucena, un animo
sensibile che vive di presentimenti e di impressioni segrete. Nella
rappresentazione di questo senso di presagio, insieme vago e chiarissimo,
l’aria raggiunge – a nostro parere – per la complessità della linea melodica e
armonica, la fluidità della forma, e l’individualità dell’espressione, un livello
tra i più alti nel melodramma europeo dell’Ottocento.
Dopo che una lunga pausa segna lo spegnersi del canto di Manrico,
giunge il suono dell’organo dalla vicina cappella: altro effetto timbrico
sorprendente per il suo forte contenuto semantico. Con pochi accordi, infatti, la
voce del sacro fa di nuovo irruzione in quel mondo turbato da guerre, lotte,
ingiustizie, violenze, aspirazioni frustrate alla felicità: e lo fa con una promessa
di pace. Nel Trovatore è frequente la presenza di canti e suoni fuori scena: la
romanza del Trovatore nel primo atto, il suono del corno di Ruiz che proviene
di lontano e interrompe il duetto tra Azucena e Manrico nel secondo atto, le
campane e il coro femminile all’interno del palco, le voci che sentiremo nel
prossimo «Miserere», sono quasi tutti momenti che determinano una svolta
nell’azione e acquistano perciò un valore drammaticamente funzionale.
Leonora e Manrico salutano il suono lontano dell’organo che annuncia
il rito nuziale con una melodia imitativa, dolce e carezzevole: «L’onda de’
suoni mistici | pura discende al cor! | Vieni; ci schiude il tempio | gioie di casto
amor» (sono sempre casti gli amori dei personaggi di Verdi, che non
conoscono le seduzioni dell’eros mozartiano). Il rapporto tra musica e testo è
sempre molto libero. Qui, Verdi s’impossessa di quei quattro versi, e li dilata
in un ampio episodio in cui le voci di Leonora e di Manrico s’abbracciano con
delicatezza, come in una fotografia di nozze. «Mentre si avviano giubilanti al
tempio» (la gioia è molto intima, non gridata o sbandierata come in una marcia
nuziale, ma in accordo con l’avvio verso una dimensione di raccoglimento, di
preghiera), improvvisamente Ruiz giunge frettoloso, determinando il solito,
brevissimo effetto di rottura che nel Trovatore carica la molla per lo scatto dei
pezzi lirici, statici, ma divampanti nel furioso incendio della musica. Ruiz
annuncia che la zingara è stata arrestata nell’accampamento sottostante, ed un
rogo, che si può vedere dal balcone, già arde in attesa che venga portata al
supplizio. Manrico, sconcertato, s’accosta al verone, rivela a Leonora che lui è
82
figlio della zingara in pericolo, e ordina a Ruiz di radunare i soldati per volare,
tutti insieme, in suo soccorso.
Per la terza volta, quindi, Leonora è sorpresa, durante un momento di
felicità, da un avvenimento esterno, che la precipita nella disperazione: «Non
reggo a colpi tanto funesti… | Oh quanto meglio saria morir!» canterà, infatti,
tra la prima e seconda sezione della cabaletta di Manrico. Si noti come, nel
libretto di Cammarano, discusso a fondo con Verdi, si aprano continuamente
squarci d’intimità molto vera e profonda. La povera Leonora si era già trovata
davanti il Conte di Luna quando s’aspettava di gettarsi tra le braccia di
Manrico nella scena notturna del giardino; poi, quando stava per prendere i
voti, è stata assalita con violenza dal Conte e dai suoi sgherri, che volevano
rapirla. La sua aspirazione alla felicità è dunque frustrata dalla forza del caso,
che s’intromette continuamente, distruggendo ogni prospettiva.
Ma anche la vita di Manrico è esposta allo stesso destino: deviazioni
continue verso incombenti catastrofi. Il suo grido di rabbia, d’orrore e d’affetto
assoluto per la madre, esplode nella cabaletta «Di quella pira», la più
trascinante di tutta l’opera e la più espressiva di quello che è, in fondo, il senso
generale del Trovatore: una rassegna di sentimenti elementari – amore di
donna, di poeta, di madre, di figlio, odio, gelosia, vendetta, furore, misticismo,
paura, mistero, eroismo, sacrificio ecc. – compressi in situazioni semplicissime
e fatti deflagrare, come un fluido ad alta pressione, da una scintilla musicale
che scocca, portando tutto all’incandescenza.
Solitamente, questa cabaletta, percepita dai contemporanei come
musica patriottica atta a «richiamare alla memoria di una nazione le glorie
avite, e ad eccitarla a grandi opere»35, viene eseguita solo nella seconda parte:
si taglia la sezione centrale, con l’intervento di Leonora, per lasciare solo la
ripresa, con le frasi incalzanti del coro, giocate quasi sportivamente come un
invito al tenore perché sfidi le sonorità della massa clamante in fortissimo
«All’armi! All’armi!», e svetti su di esse, con il suo timbro vocale, luccicante
come una spada sguainata. Questa versione tagliata è, penso, più efficace,
perché è difficile che, in quella integrale, l’aria conservi sino alla fine tutto il
suo enorme potere propulsivo. Molto, però, dipende dall’esecuzione:
prestazione del cantante, impulso ritmico dato dal direttore d’orchestra che
deve scandire il rataplàn corale e strumentale, togliendogli il più possibile
qualsiasi effetto meccanico. Volgare questa cabaletta? Ciascuno decida in base
al gusto personale, che a noi non interessa molto. Sta di fatto che il pezzo
funziona, alla fine dell’atto, come meglio non si potrebbe, svettando in un
vertiginoso picco energetico. Il ritornello della cabaletta era di prammatica
35
Così la «Gazzetta Musicale di Milano» il 28 gennaio 1855 cit. in G.
RONCAGLIA, Giuseppe Verdi, cit. p. 199.
83
nelle consuetudini formali dell’Ottocento: ciò non toglie che, come accade per
i ritornelli nella forma sonata, sovente l’intensità della musica rende
pleonastica, o addirittura dannosa la ripetizione integrale di ciò che si è già
ascoltato.
La cabaletta in cui Manrico, vedendo il rogo acceso che illumina con
riverberi rossastri l’orizzonte della scena, grida di voler salvare la madre,
anche a prezzo della vita, è molto lineare: le frasi sono simmetriche, ripetute
senza varianti, e la forma mostra, quindi, una mentalità strutturale
completamente diversa da quella dell’aria precedente. Anche, e soprattutto, da
queste divaricazioni formali le opere del primo Verdi, e in particolare Rigoletto
e Il Trovatore (meno La Traviata) traggono la loro energia interna. Rispetto
all’aria, nella cabaletta il sentimento espresso è semplice, non ammette
sfumature, dominato com’è dalla visione orribile del fuoco che entra dentro
Manrico, ardendone «tutte le fibre»: se gli empi, che l’hanno acceso, non
vorranno spegnerlo, lui stesso l’estinguerà con il suo sangue, perché l’amore
che porta ad Azucena è tale da indurlo ad una scelta obbligata: o salvarla, o
morire. L’immaginario definito dalla cabaletta non potrebbe essere più
significativo: fuoco, sangue, morte, legame genetico con la madre («era già
figlio prima d’amarti»), ardore interno del corpo: anche qui, dunque,
l’immagine del fuoco non solo è dilatata paurosamente nella visione fantastica,
ma scuote l’organismo di Manrico, e dello spettatore, con una vera e propria
sollecitazione fisica.
La melodia scelta da Verdi per sintetizzare questo nodo di significati
sarebbe quasi banale se non fosse arricchita e corroborata da un elemento tanto
semplice quanto efficace: le quartine di semicrome che la “decorano” ogni due
battute (virgolette necessarie per una parola, in questo caso, quasi blasfema),
essendo quei trilli rigorosamente strutturali: «Verdi – osserva Budden – non
aveva mai usato l’artificio delle semicrome semistaccate ripetute a coppie con
un effetto più stimolante»36. In quel trillo nervoso che si accende, facendo
tremolare la melodia con scosse continue, c’è l’immagine lingueggiante della
fiamma, riassunta in un nuovo “ideogramma”, completamente diverso da
quello di Azucena, ma dotato di non minore evidenza. Qui non si tratta di
un’allucinazione che, nella sua fissità, paralizza ogni movimento; la pira
evocata da Manrico, invece di bloccare la mente e il corpo, fa venire voglia di
correre, scappare, agire e carica sempre più l’impazienza con una componente
fisica, quasi sportiva. Notiamo che i due episodi – la vampa di Azucena e la
pira di Manrico – sono disposti simmetricamente, uno all’inizio del secondo
atto, l’altro alla fine del terzo, come due pilastri su cui poggia l’intero
immaginario dell’opera.
36
J. BUDDEN, Le opere di Verdi, cit., vol. II, p. 108.
84
Ricordate le quartine di semicrome che alludevano al fuoco nel
racconto di Ferrando, alle parole «Abbietta zingara», e che acceleravano
l’andamento del canto? Là sembrava un ritmo zingaresco di nacchere, o di
tamburelli, che collegava la figura della presunta strega con il mondo gitano; e
infatti risuonava di nuovo nel coro degli zingari, all’inizio del secondo atto.
Questa cabaletta ci addita nel medesimo vocabolo anche la presenza della
fiamma, legata, peraltro, direttamente alla vita nomade degli zingari, che
vivono attorno al fuoco, ne traggono calore e alimento, portando
all’incandescenza il metallo per il lavoro di fabbri che dà loro il pane. Tutto si
collega, quindi, nella partitura del Trovatore, in una coerenza che salda
trasversalmente i vari piani – fantastico, sentimentale, fisico, antropologico –
dell’umana esistenza, ricondotta ad un solo principio generatore. Non importa
se lo spettatore non si rende conto di queste rispondenze profonde; importa
l’effetto inconscio che tale coerenza tematica e compositiva produce,
determinando il senso e l’unità del tutto.
Lo scatto propulsivo di «Di quella pira» è dovuto anche al tipo
d’accompagnamento, scalpitante e guerriero, che perdura per tutta la durata
dell’aria, simile a quello della cabaletta del Conte di Luna, una pulsazione
elementare, diffusissima nel melodramma del primo Ottocento, alla quale
Verdi conferiva una grande forza energetica. Una modulazione in do minore
compare sulle parole «Era già figlio», appena un’ombreggiatura, tosto spazzata
via dal ritorno al do maggiore in cui si sfoga l’esuberanza del tenore, «eroico»
fino ad un certo punto, perché l’esecuzione delle quartine di semicrome
richiedono un’agilità, una leggerezza e una precisione da vocalista abituato al
canto di agilità. Se vengono confuse in un’esecuzione imprecisa, che punta
solo a mettere in evidenza la forza del suono, per soddisfare la vanità di un
tenore taurino, la cabaletta perde tutto il suo mordente e può diventare
addirittura volgare.
La popolarità di quest’aria è anche determinata dal fatto che, anche se
Verdi non l’ha scritto, nella tradizione esecutiva si è usato introdurre come
ultima nota un do di petto, che conclude l’aria con un’espressione di puro
atletismo, per compiacere i gusti del pubblico. Questa nota non aggiunge nulla
al personaggio di Manrico, ma neppure rovina alcunché: dipende tutto da come
la si esegue. Budden ricorda che Verdi avrebbe risposto al tenore Tamberlick,
che gli annunciava di aver introdotto, con grande soddisfazione del pubblico, il
do di petto nella cabaletta della «Pira»: «Lungi da me l’idea di rifiutare al
pubblico quello che vuole. Mettetelo il do acuto, se volete, purché sia
buono»37.
37
Ibidem, p. 108.
85
Con questa scena si precisa dunque la figura di Manrico, protagonista
del Trovatore non solo di nome ma di fatto, in quanto orienta l’azione e la vita
affettiva degli altri personaggi. È lui che, con la sua esistenza, umanizza quella
di Azucena. Se Azucena non avesse avuto Manrico su cui riversare il suo
amore materno, espiando il delitto e rigenerandosi interiormente, sarebbe un
mostro, in preda al suo ossessivo proposito di vendetta. Manrico ha inciso
profondamente nella vita di Leonora, attraendola con quello slancio ideale che
abbiamo visto comparire nella sua prima aria fuori scena e inducendola ad un
amore che la porterà a sfidare la morte. È Manrico che sconvolge l’esistenza
del Conte di Luna, fa scattare in lui l’ira e la gelosia con le conseguenze
catastrofiche che vedremo. Quindi Manrico è personaggio protagonista per
quello che fa, ma ancor più per quello che produce nell’animo degli altri
personaggi: è un catalizzatore di affetti, positivi o negativi.
Baldini afferma che i personaggi del Trovatore sono tutti e quattro
attraversati da sentimenti di amore e di odio; ma «amore e odio» sono parole
troppo generiche: la duplicità dei personaggi si può forse precisare meglio, in
rapporto al destino di ciascuno. La scena di Manrico mostra due aspetti: da un
lato l’impeto giovanile, lo slancio baldanzoso e guerriero, già venuto alla luce
nella narrazione delle sue imprese belliche («mal reggendo all’aspro assalto»,
II, 1, melodia in do maggiore, della stessa tonalità della cabaletta); dall’altro
l’amore per le due donne della sua esistenza, e la tenerezza malinconica, data
dal presagio per un destino di morte. Anche gli altri personaggi del Trovatore
sono caratterizzati da due aspetti complementari: in Azucena ci sono, insieme,
il proposito di vendetta, l’ossessione del ricordo di ciò che è accaduto alla
madre, e lo slancio dell’amor filiale. In Leonora convivono la propensione a
coltivare il proprio sogno in una dimensione ideale, e la capacità eroica di
guardare in faccia il proprio destino e di affrontarlo col sacrificio della vita,
come vedremo nel quarto atto. Ma duplice è anche il carattere del Conte di
Luna che passa dalla sensualità amorosa all’ira ed alla gelosia che lo
tormentano e lo portano ad azioni malvagie.
Il modo di organizzare questa duplicità, che caratterizza i singoli
personaggi, è uno degli elementi più caratteristici del Trovatore: i due
sentimenti, infatti, non s’intrecciano mai contemporaneamente in un plesso
psicologico – la psicologia, ripetiamo, è estranea a quest’opera – ma sono
sempre presenti in successione. Ci sono momenti in cui Manrico esprime il
proprio slancio eroico e altri in cui s’effonde in tenera malinconia; momenti in
cui Azucena è in preda alla sua sete di vendetta dettata dall’allucinazione della
fiamma, e altri in cui esprime l’amore per Manrico; così per Leonora e così per
il Conte di Luna. Verdi non intreccia questi stati sentimentali, li oppone, il che
potrebbe conferire ai personaggi un carattere burattinesco e meccanico; ma la
musica, collegando il tutto con coerenza, trasforma le schematiche opposizioni
86
del libretto in una successione di sentimenti elementari d’una tale intensità da
trasformare i fantocci in figure drammatiche, vive e vere. Rifacendosi ai modi
della rappresentazione popolare, per la successione così ordinata e nitida degli
atti, delle situazioni, degli stati d’animo opposti con un’evidenza assoluta e
un’energia inedita, il gesto creativo di Verdi rimanda a quello del cantastorie
che, sulla pubblica piazza, gira i fogli della vicenda narrata e illustra le figure
dipinte a colori vivi, con contrasti elementari, raccontandone la «vera storia»,
come dice Ferrando, con tale convinzione da strappare le lacrime. Il Trovatore
è Manrico, ma è anche, soprattutto, Verdi che ci riempie di stupore, cantandoci
questa storia, bizzarra, irreale e umanissima, in una serie di meravigliose forme
musicali, tutte in sé conchiuse, rapinose e vibranti.
Il procedere per coppie oppositive, visibile nell’alternanza di due
sentimenti all’interno di ciascun personaggio, si riflette, a sua volta, nella
struttura complessiva dell’opera in cui l’atto primo corrisponde al quarto e il
secondo al terzo. Il primo e l’ultimo sono ambientati nel Palazzo dell’Aliaferia,
e rappresentano principalmente le vicende di Manrico, Leonora e del Conte di
Luna; il secondo e terzo sono invece gli atti centrali, imperniati sulla figura di
Azucena. Il primo e il quarto atto si svolgono di notte; il secondo e terzo atto
sono di luce più viva, illuminati dal bagliore del fuoco che s’accende all’inizio
del secondo atto, nel canto d’Azucena, e che brilla nuovamente alla fine del
terzo, nell’aria di Manrico. È lampante, dunque, un sistema di equilibri molto
ben studiati per cui, come ha notato Baldini, tutto si contrappone, creando un
rapporto di pieni e di vuoti, regolato alla perfezione.
87
Capitolo quinto
Atto quarto (Parte quarta: Il supplizio)
N. 12 Scena «Siam giunti» ed Aria di Leonora «D’amor sull’ali rosee»
(Leonora, Manrico, Ruiz, Coro).
Siamo di nuovo, come nel primo atto, in «un’ala del palazzo
dell’Aliaferia. All’angolo una torre con finestre assicurate da spranghe di
ferro». Nella «notte scurissima» entrano due persone ammantellate, come
fantasmi, irriconoscibili nelle tenebre: sono Leonora e Ruiz. Un sommesso
preludio di clarinetti e fagotti crea un clima molto oscuro, quasi minaccioso,
segnando i passi delle figure che attraversano il palcoscenico. Come quella che
accompagnava l’entrata del Conte di Luna nella scena del giardino, anche
questa è musica gestuale, ma le imitazioni tra i due clarinetti le conferiscono
una maggiore profondità: la sensazione di un momento difficile, la
rappresentazione di una stretta esistenziale, che attende i personaggi con la
severità di una prova suprema. Quest’idea di collegare una simile situazione
drammatica con il contrappunto imitativo che, nell’Ottocento, è usato sovente
per esprimere significati negativi, ha un precedente illustre: la scena del Flauto
Magico di Mozart in cui, davanti al luogo dove i protagonisti affronteranno le
prove dell’acqua e del fuoco, passeggiano due guerrieri armati. Il meraviglioso
preludietto verdiano rende, inoltre, tangibile il senso di silenzio che avvolge la
scena. «Siamo giunti; ecco la torre ove di stato gemono i prigionieri...» dice
Ruiz, e Leonora: «Vanne… Lasciami, né timor di me ti prenda...». Ruiz
s’allontana e lei rimane sola, nel buio, davanti alla prigione. È qui per tentare
di salvare Manrico, prigioniero nella torre: l’impresa di liberare Azucena è
fallita, ed entrambi sono stati arrestati. Il recitativo è più espressivo rispetto ad
altri per una maggiore cura della recitazione in musica. «Presta è la mia
difesa» dice Leonora, guardando un anello che le fregia la mano destra e nel
quale è nascosto del veleno: l’orchestra rabbrividisce momentaneamente in
uno slittamento cromatico di violoncelli e contrabbassi su tremolo degli altri
archi, immagine del veleno che s’infiltra nell’organismo, causando la morte. A
poco a poco, l’ambiente melodico si riscalda: su «Gemente aura, che intorno
spiri» la voce comincia a lievitare in disegni aerei, conclusi da un estatico e
dolcissimo vocalizzo che fa da ponte al meraviglioso Adagio seguente.
88
Quest’aria ha una lunga tradizione nel melodramma italiano del SetteOttocento. Rappresenta la tipica situazione di un personaggio, per lo più
femminile, che affida ai venti i propri pensieri d’amore affinché li portino al
cuore dell’amato: l’aria in cui trascorrono i sospiri dell’innamorato lontano è
un’immagine diffusa nella librettistica del tempo («L’aura che spira intorno |
mi sembra un tuo respir» canta, ad esempio, Giulietta nei Capuleti e Montecchi
di Bellini su libretto di Felice Romani). Anche in questo pezzo, dunque, il
personaggio è completamente assorbito dalla figura di un assente: quella di
Manrico che non c’è, non si vede, ma viene immaginato prigioniero nella torre
e vagheggiato come oggetto d’amore, pietà, desiderio. Nel Settecento, queste
arie inducevano i musicisti ad un’intonazione illustrativa: era di prammatica
far sentire, in orchestra, il fluire dei venticelli, secondo lo stile della pittura
sonora molto amato e diffuso nella produzione vocale e strumentale. In un’aria
dell’Idomeneo di Mozart, ad esempio, Ilia canta le parole: «Zeffiretti
lusinghieri | deh! volate al mio tesoro | e gli dite che l’adoro»: gli strumenti,
con tutta una serie di pittoresche imitazioni, rappresentano il volo di questi
zeffiretti in modo arcadico, miniaturistico e grazioso.
Verdi, invece, fa una cosa del tutto diversa. L’orchestra non dipinge
alcunché, ma si limita ad accompagnare il flusso della melodia vocale che
rende l’idea del volo, del librarsi senza peso verso l’alto, in un vaporare di
suoni. Le parole «ali» «sospiro» «aura» «aleggia» sono i punti di riferimento
semantici: non più il fuoco, ma l’aria, altro elemento primordiale, senza di cui
il fuoco non potrebbe bruciare, domina l’immaginario del pezzo e ne orienta
l’invenzione musicale.
«D’amor sull’ali rosee» è formata da dieci versi settenari che Verdi
fonde in una forma molto compatta, secondo quel libero svolgersi del ductus
melodico che abbiamo già visto nell’aria di Manrico del terzo atto: non ci sono
riprese, ma un andamento a sviluppo continuo, in cui quasi ad ogni verso
corrisponde un’invenzione nuova, e gli elementi di simmetria sono ridotti al
minimo: l’impressione è di un canto che nasce dal cuore di Leonora e si libera
nell’aria, fluttuando senza peso verso la torre, meta dei suoi pensieri, libero da
qualsiasi rigidezza costruttiva, sia di tipo ritmico che metrico. L’unico chiaro
snodo strutturale è il passaggio dal fa minore del primo verso al la bemolle
maggiore del quinto, «com’aura di speranza», tonalità che continua fino alla
fine e dà all’aria un carattere particolarmente dolce, carezzevole, definito
dall’accompagnamento pianissimo, in terzine legate.
Nello scatto del ritmo («D’amor sull’ali rosee»), in cui ricompare la
pulsazione di breve-lunga, c’è qualche cosa di doloroso e di inquieto,
sottolineato anche dal trillo su «rosee», come un fremito segreto; poi, il ritmo
si appiana sul verso «Del prigioniero misero», in cui la terzina che sale
dall’orchestra al canto (anche qui un piccolo moto ascensionale) conferisce
89
alle parole una dolcezza struggente, come una pietosa carezza. La melodia, nel
frattempo, sembra liberarsi a poco a poco dalla forza di gravità: all’inizio era,
per così dire, attratta verso terra, qui comincia a fluttuare. «Com’aura di
speranza», infatti, non riprende più lo scatto presente in «D’amor sull’ali
rosee», come ci aspetteremmo. Mentre la tonalità passa in la bemolle
maggiore, il canto si impossessa delle terzine dell’accompagnamento, e
diventa più circolare e lievemente roteante; un effetto esaltato dall’orchestra
che, a partire da «lo desta alle memorie», molto discretamente, assume una
pulsazione di valzer. Ora il canto vola liberamente e sembra gonfiarsi in un
bolla iridescente, e purissima. Da notare la finezza dell’enjambement melodico
tra i versi «Ma, deh! Non dirgli, improvvido, | le pene del mio cor!» che non
sono divisi, ma fusi in una frase di tre battute (le altre frasi sono di quattro
battute) la cui irregolarità favorisce l’impressione di libertà da ogni
schematismo metrico e fraseologico. La fluttuazione della melodia tende ad
innalzarsi con le sincopi struggenti e dolcissime su «improvvido» e «le pene»,
vero slancio lirico verso quella cima della torre, dove una fioca luce testimonia
la presenza del prigioniero. Inoltre, la meravigliosa melodia di «Ma, deh! non
dirgli, improvvido» viene ripetuta con una distribuzione diversa tra orchestra e
voce (la prima anticipa la seconda), il che crea un altro motivo di asimmetria
nell’apparente simmetria del tutto.
Il segreto delle grandi melodie verdiane sta tutto qui: renderle
complesse attraverso continue variazioni, ma nello stesso tempo collegare i
vari incisi con tale sapienza da produrre quel-l’impressione di naturalezza,
regolarità e simmetria che le rende «facili» e memorabili. Nell’ultima sezione,
ripetuta due volte in modo diverso, con dilatazioni melismatiche di ampi
vocalizzi su «le pene del mio cor», frastagliato e ansioso (terzine di semicrome
e quartine di biscrome), la melodia di Leonora, sostenuta dal flusso
orchestrale, e conclusa dal trillo su pigolanti accordi dei legni, raggiunge un
effetto estatico. Un’analisi più minuta di quest’aria potrebbe dimostrare che
essa non si trasforma in modo arbitrario, bensì sviluppando elementi che
vengono via via presentati, poi raccolti e ulteriormente ampliati. C’è, quindi,
un’organicità di sviluppi, e anche questo è un pregio tecnico particolare: s’è
notato, ad esempio, come le terzine dell’accompa-gnamento salgano nel canto,
collegando verticalmente voce e orchestra e, orizzontalmente, le varie fasi
melodiche con una disseminazione progressiva, graduale e organica nel senso
di una sempre maggiore liquidità del flusso melodico.
Quest’aria conferma l’immagine di Leonora apparsa nell’a-ria del
primo atto. Ma «Tacea la notte placida» tendeva ad un fervore entusiastico che
culminava nella melodia «dolci s’udiro e flebili gli accordi di un liuto»; qui,
invece, la melodia si libra ma, nello stesso tempo, si ripiega malinconicamente
su se stessa, in volute melodiche ispirate ad un senso di languore e
90
malinconico abbandono. Dice bene il Budden, notando che «le sue ali liriche
sono piegate e la sua melodia si dissolve in una serie di cadute mortali»38:
come vapori che, salendo, girano su se stessi, roteando verso il basso. Il grande
compositore sa rendere, dunque, nel medesimo personaggio, due momenti
psicologici diversi. Nel primo atto Leonora era tutta presa nell’evocazione di
quel canto, che aveva destato in lei il sentimento d’amore; qui, l’immagine di
Manrico in prigione la induce ad esprimersi in modo del tutto diverso; anche se
la sua personalità melodica di soprano lirico resta intatta. Verdi, nel Trovatore,
non descrive mai l’ambiente come paesaggio; però quest’aria, come quella del
primo atto, per la sua intimità, il suono raccolto e la tinta velata, è strettamente
collegata all’ora notturna: ma, mentre la prima notte era quella del giardino,
piena d’attesa e di slancio amoroso, questa è l’ora della prigione, e della morte
che incombe.
Appena Leonora ha finito di cantare, si sente, dall’interno, la «campana
dei morti». La scena subisce un improvviso sfondamento prospettico:
l’attenzione dell’ascoltatore è proiettata verso uno spazio invisibile da cui quel
suono proviene. Ancora una volta, l’irrompere della musica fuori scena
determina un capovolgimento di situazione: il coro maschile (monaci?
prigionieri? non è detto) canta, infatti, una preghiera per le anime dei morituri,
sopra i gelidi rintocchi della campana:
Miserere d’un’alma già vicina
alla partenza che non ha ritorno!
Miserere di lei, bontà divina,
preda non sia dell’infernal soggiorno!
Leonora è stupefatta, e rabbrividisce: il suo canto, salito, nell’oscurità,
verso i muri della prigione, li ha fatti risuonare! Il rintocco della campana a
morto rafforza l’effetto, ancora più raggelante, del coro a sei voci (due tenori
primi, due tenori secondi e due bassi), un canto accordale, omoritmico, a
cappella, in la bemolle minore, in cui tutte le voci procedono insieme, senza
sfasature. Nel suo andamento, regolare e ritmato come una marcia funebre,
sembra sospendere il tempo. L’aria di Leonora era qualcosa di vitale, organico,
pulsante. Il coro, nel suo carattere liturgico, è come pietrificato e oppone il
canto funebre alle ondate di melodia, il gelo della pietra al tepore dell’affetto,
la morte alla vita. L’effetto è stupefacente, anche per il colore dell’armonia che
passa improvvisamente da la bemolle maggiore a la bemolle minore, secondo
l’accostamento delle due modalità, sempre sfruttato, in quest’opera, da Verdi
nella sua elementare efficacia espressiva. Si noti la diversità dei due cori
38
J. BUDDEN, Le opere di Verdi, cit., vol. II, p. 109.
91
religiosi a cappella presenti nell’opera: quello delle monache, nella scena del
chiostro, in mi bemolle maggiore, era caldo, attraente, dolce. Questo ha un
tono fatalistico cui la lontananza conferisce un tratto d’immodificabile
inafferrabilità.
Già s’è notato che i suoni lontani provocano, nell’animo dei personaggi
in scena, reazioni improvvise. Leonora, che si era cullata nell’idea che i suoi
pensieri potessero volare a consolare il prigioniero amato, subisce
un’improvvisa doccia fredda che la riporta alla realtà: «Quel suon, quelle preci
solenni, funeste, | riempiron quest’aere di cupo terror!». Sono le ultime due
parole che orientano l’invenzione musicale di Verdi: il canto di Leonora è
quanto di più diverso ci possa essere da quello dell’aria precedente: duro,
aspro, paralizzato ritmicamente nella scansione dei giambi, conferisce al
personaggio un imprevisto tratto energico, virile, quasi eroico. Dopo essere
salita faticosamente verso l’alto, la voce ricade su se stessa in «contende
l’ambascia», come attratta dalla forza di gravità, e si spezza in singhiozzi di
terzine acefale («il re-spi-ro i pal-pi-ti al cor») a rappresentare un’incontenibile angoscia. L’orchestra, che taceva durante il canto del «Miserere», ora si
ridesta e continua a scandire, pianissimo, un martellante rintocco, un sussulto
sommesso e stimbrato, più simile al rumore che al suono, dal carattere cupo e
oppresso. Verdi prescrive: «questo squarcio deve essere pianissimo benché a
piena orchestra», conferendo, in tal modo, alla massa degli strumenti un effetto
quasi tellurico, di sussultorio scuotimento: è l’ora che batte, la pulsazione del
tempo che va avanti, immutabile e fatale, mentre il canto prosegue nei suoi
cupi scatti. Leonora è terrorizzata, ma, nello stesso tempo, la fermezza ritmica
del suo canto la pone all’altezza della situazione, non le toglie energia: di
fronte alla morte non trema, l’affronta a viso aperto, con coraggio. La donna
innamorata sfodera, così, una tempra eroica: dentro di sé, ha già meditato di
uccidersi per liberare Manrico. Ma la sua energia non è astratta, idealizzata: lo
dice la voce, che si rompe nel pianto durante le ultime battute del suo
intervento. L’idealismo dei personaggi di Verdi non è come quello degli eroi
mitici di Gluck: è sempre legato alla concretezza del corpo, nasce dalle
reazioni fisiche al sussulto del dolore. Ogni scena, come si vede, aggiunge
qualche cosa di nuovo ai personaggi del Trovatore che, senza trasformarsi,
mostrano diversi atteggiamenti nei confronti del loro destino.
A questo punto, sull’ultima nota del canto di Leonora, c’è un nuovo
colpo di scena. Dall’alto della torre, si leva un canto solitario: è la voce del
Trovatore che squarcia le tenebre con una luminosa melodia in la bemolle
maggiore:
Ah! che la morte ognora
è tarda nel venir
92
a chi desia morir!…
Addio, Leonora!
Manrico dà addio alla vita, ma in un modo del tutto inatteso. Il suo canto
non è disperato, né eroico, nello stile della cabaletta «Di quella pira», né modula
liberamente la sua espressione nelle sfumature dell’aria che la precedeva: invece
di esprimere il sentimento in forma diretta, lo inquadra in un ritmo di romanza,
sull’accompagnamento regolare, a chitarra, di un’arpa fuori scena. Il dramma di
Gutiérrez suggeriva a Verdi una soluzione di questo genere: l’idea di fare, anche
qui, una canzone, nello stesso stile di quella del primo atto, è un fatto denso
d’implicazioni drammatiche ed espressive. Anche qui troviamo frasi regolari,
intervalli ristretti, e il caratteristico slancio verso l’alto che, su «Leonora addio!»,
porta la voce ad impennarsi con lo stesso fervore notato in «Deserto sulla terra».
Si noti la verità di questi accenti melodici: il senso di ripiegamento dei primi due
versi, la tensione disperata di «a chi desia morir», l’affinità, già notata con la
romanza di sortita, e quindi con il melodizzare di Leonora in «Tacea la notte
placida».
Dunque, anche in questa scena il Trovatore è presentato nella qualità
che gli dà il nome, vale a dire come poeta e cantore. La trovata è geniale,
anche sul piano della caratterizzazione emotiva. Questa melodia, infatti, in
quanto oggettivata nel ritmo di romanza, toglie qualsiasi carattere lamentoso
all’addio a Leonora, sublimando il sentimento personale nella dimensione
fantastica dell’ “opera d’arte” in cui il dato negativo dell’esperienza si
trasforma in una realtà positiva, vitale. Manrico va incontro alla morte
cantando, con la spavalda incoscienza e il disprezzo per la vita proprio della
giovinezza, cioè con un tratto, tipicamente romantico, di slancio fatalistico,
irruente, generoso.
Leonora ne è schiacciata: «Sento mancarmi» bisbiglia nel silenzio,
mentre, subito dopo, riascolta il lontano «Miserere». La ripresa, qui, è testuale,
come identico al precedente è il nuovo intervento di Leonora sulle parole
«Sull’orrida torre, ah! par che la morte | con ali di tenebre librando si va», con
una differenza, però: tra una frase e l’altra, interviene il coro che ripete, in un
cupo declamato, «Miserere! Miserere!», incalzando il canto disperato del
soprano con le voci maschili, sia pure lontane. L’energia drammatica sale,
come già s’è visto nella scena del chiostro, con il progressivo intreccio dei canti
del Conte, del coro di seguaci e di quello di monache. Anche qui la situazione è
assolutamente statica. Dopo di che, Manrico ripete di nuovo la sua melodia, con
parole diverse:
Sconto col sangue mio
l’amor che posi in te!…
93
Non ti scordar di me!
Leonora, addio!
La sua voce è sempre là sulla torre, lontana, inafferrabile. La semiosi
della lontananza ha un effetto teatrale ed emotivo fortissimo. In questo modo,
la figura di Manrico è incorniciata, e quindi allontanata, due volte: dal punto di
vista prospettico-spaziale perché canta fuori scena, e da quello semiotico
perché non si esprime in prima persona, bensì attraverso una canzone. Leonora
lo sente cantare, ma non può dialogare con lui, come non può interferire sul
coro del «Miserere»: si scontra, dunque, con due oggetti musicali
assolutamente chiusi in se stessi in quanto le tre fonti sonore non dialogano tra
loro. Da questa incomunicabilità ed impotenza ad agire, che porta al massimo
la tragedia e il fatalismo della situazione, nasce lo strazio di lei, che diventa
insostenibile quando la voce del tenore si slancia nell’ultimo grido «Non ti
scordar di me! Leonora addio!».
L’imperativo accende, come una miccia, la reazione del soprano, che
ripete dieci volte la frase «Di te, di te scordarmi!», ora vocalizzata, ora
declamata, ora intervallata dal duplice «Sento mancarmi», mentre la melodia,
sempre discendente, si spezza nel pianto. Ma non basta. Mentre Leonora ripete
questa esclamazione disperata – e siamo alla coda della straordinaria scena –
Manrico continua a cantare la sua romanza, s’inebria di musica, andando
incontro alla morte sul ritmo scanzonato e, quindi, tanto più tragico dell’arpachitarra, mentre il coro, cupo e lontano, ripete incessantemente «Miserere!
Miserere!». Ora, Leonora al proscenio, Manrico sulla torre e il coro dietro le
quinte cantano tutti insieme: la vita e la morte, l’orrore e l’amore, l’addio e la
disperata professione di fedeltà, precedentemente presentati in alternanza, si
scontrano direttamente, in un dirompente effetto cumulativo, moltiplicato dalla
stereofonia dello spazio sonoro. La scena raggiunge, così, una concentrazione
dantesca nell’espressione del tragico, una shakespeariana ambivalenza tra
realtà e metafisica.
Come in tutti i testi eccelsi del teatro musicale (e non solo), anche nel
Trovatore ogni situazione getta luce retrospettiva su tutte quelle precedenti,
spiegandone il senso e irrobustendone, nella nostra memoria, l’effetto. Qui,
Manrico appare di nuovo, in modo improvviso, come folgorante proiezione
fenomenica dell’idea che vive nella mente di Leonora («Sei tu dal ciel disceso!
o in ciel son io con te?»). Ora, questa funzione, così caratteristica, del
protagonista, viene esaltata nella scena del «Miserere», con tutte le
conseguenze che l’oscillare tra presenza e assenza, realtà e sogno comporta
nell’immaginario romantico dell’opera, e nella sua stessa drammaturgia: tutte e
tre le volte, la comparsa di Manrico determina lo scaricarsi di una spaventosa
energia emozionale che, grazie alla musica, anima dall’interno situazioni
94
completamente statiche. Anche la tecnica melodrammaturgica con cui sono
montati i grandi «quadri di stupore», spettacolosi ossimori di paralisi e
agitazione, rimanda quindi all’immagine centrale dell’opera: perché non c’è
nulla che sia insieme così fisso e mobile, statico e agitato come il fuoco, nell’atto
di divampare.
Nelle due scene culminanti del Trovatore, quella d’Azucena, all’inizio
del secondo atto, e questa, del «Miserere», in capo al quarto, le due donne, che
non vengono mai a contatto tra loro, esprimono entrambe il loro rapporto con
la morte: Azucena, rievocando il supplizio della madre e l’assassinio
involontario del figlio, Leonora, sentendola ormai prossima per Manrico e per
sé. Questa è la causa dello sconvolgimento emotivo di entrambe: la morte che
ha trionfato, o sta per trionfare, sull’amore. Ma la presenza della morte,
nell’opera, non si limita alle due scene capitali: è continua, sin dalla ballata di
Ferrando che rievoca la storia della strega condannata e del bambino bruciato.
Leonora, nella scena del giardino afferma che, se non vivrà per Manrico,
morirà; Manrico e il Conte, durante il duello finale del primo atto s’augurano
reciprocamente la morte; nel secondo atto, dopo aver rievocato la morte della
madre, Azucena ordina a Manrico d’immergere la spada fino all’elsa nel cuore
del Conte; lui risponde che lo farà. La prospettiva della morte è quella che lega
Manrico al Conte, il quale non desidera altro che la sua morte. Nella scena del
chiostro, Manrico compare come un fantasma di sotterra e al Conte pare un
morto risuscitato: «Dunque gli estinti lasciano | di morte il regno eterno!». Nel
terzo atto, Azucena, catturata, viene minacciata di morte da Ferrando e dai
soldati che subito accendono il rogo; poi, nella scena dello sposalizio, Manrico
canta un’intera aria incentrata su di un presagio di morte. Tutto il quarto atto,
infine, è dominato dall’idea della morte. Molto più che non nel Rigoletto, dove
l’idea dominante è quella della maledizione, e della Traviata, che è una corsa
contro il tempo che incalza e lascia poco per amare e per vivere, l’idea della
morte attraversa l’immaginario poetico e drammatico del Trovatore con una
presenza sotterranea, meno vistosa ma non meno incisiva di quella del fuoco.
È lo sfondo nero su cui rosseggiano le fiamme.
Finito il canto del «Miserere», Leonora conclude la scena con la
cabaletta «Tu vedrai che amore in terra », non senza aver ripetuto tra sé, con
meraviglia e dolore, ancora una volta, in forma di recitativo «Di te! Di te!
Scordarmi di te!..», parola scenica d’importanza centrale perché esprime senso
del distacco, legame amoroso, consapevolezza della minaccia incombente,
timore d’incomprensione, senso d’incomunicabilità. La cabaletta sblocca
l’incertezza nella dichiarazione d’un amore totale, pronto ad affrontare e
vincere la morte: con il proprio sacrificio, liberamente accettato, la vittima
s’innalza sopra le forze negative del destino avverso, e trasforma il male in
bene:
95
Tu vedrai che amore in terra
mai del mio non fu più forte;
vinse il fato in aspra guerra,
vincerà la stessa morte.
O col prezzo di mia vita
la tua vita io salverò,
o con te per sempre unita
nella tomba io scenderò.
Questa cabaletta viene sovente tagliata, con decisione a parer nostro
inaccettabile. Il pezzo è molto faticoso per il soprano, reduce dal «Miserere» e
chiamato, di lì a poco, ad affrontare il finale dell’opera, ma è un brano
musicalmente assai pregevole che rappresenta uno snodo fondamentale nella
vicenda personale di Leonora. Tagliare questa cabaletta dopo la scena del
«Miserere» neutralizza il contrasto musicale tra buio e luce interiore, perché la
scena corale è, per lo più, in tonalità minore, mentre il canto di Leonora, in fa
maggiore, crea un improvviso effetto di «illuminazione» e si ricollega al modo
maggiore del canto di Manrico.
Durante la scena del «Miserere» la ragazza ha subìto la lacerante
impressione della morte incombente e dell’amore ormai impossibile a
realizzarsi qui, sulla terra. Nella cabaletta reagisce: da un atteggiamento
fondamentalmente passivo, ed esclamativo, passa alla decisione di restare
fedele a Manrico sino alla morte. Questo implica un tono di fervore che ricorda
i suoi temi più aperti e slanciati. L’indicazione agogica è Allegro agitato,
quella dinamica pianissimo. Siamo nella tonalità di fa maggiore, tempo di 4/4.
Anche qui è un dilagare di ritmi di breve-lunga, pulsazioni ascendenti, discesa
nel registro basso sulla parola «morte», insomma, lo stesso tipo melodico che
abbiamo trovato nella cabaletta del primo atto, fatto di slanci e di effusione
affettiva. Ogni personaggio, dunque, ha, come si vede, il proprio stile
espressivo, che perdura con coerenza di scena in scena. Parallelamente a ciò
che avviene in Manrico, anche in Leonora l’accettazione della morte non è
triste, cupa, drammatica, ma gioiosa: esprime un senso di vittoria e di
liberazione. Nessuno dei due trema davanti alla morte, ma da entrambi sorge la
voce della giovinezza, la speranza del ricongiungimento ideale con la persona
amata, a dispetto della minaccia incombente.
La ripetizione di «con te per sempre unita, sì, nella tomba scenderò»
modula in fa minore, e presenta una sfumatura affannosa; poi, nella coda,
l’esaltazione di Leonora s’esprime in un ampio vocalizzo. Si noti come la
tendenza delle melodie di Leonora a salire verso l’alto qui sia particolarmente
visibile, già nella testata della melodia, che inizia con un intervallo di sesta, poi
96
aperto in ottava, con salto della voce dal registro medio a quello acuto che
suggerisce quasi il gesto di un abbraccio. Alla fine, quando, nella coda,
Leonora canta «con te per sempre unita», la voce sale sempre di più: la
tensione verso colui che è chiuso nella prigione non è solo ideale. Leonora
guarda la torre e si proietta, anche fisicamente, tendendo le braccia verso colui
che non si vede, ma di cui s’è sentita la voce, lassù, dietro quelle sbarre, dove
tremola una fioca luce, nella notte oscurissima.
La cabaletta dovrebbe essere ripetuta da capo, ma queste ripetizioni
sono un po’ ridondanti: appartengono alle convenzioni formali dell’800, e non
sempre sono giustificabili sul piano della logica teatrale ed espressiva. Il taglio
del ritornello, qui, non è dannoso, anzi.
Questo pezzo è suscettibile di diverse intonazioni espressive da parte
del direttore d’orchestra: se l’Allegro agitato viene staccato in un tempo un po’
più lento, la cabaletta acquista un carattere più affettuoso; se il direttore,
invece, sposa la velocità, il pezzo acquista un carattere palpitante e quasi
ansimante.
N. 13 Scena «Udiste? Come albeggi» e Duetto «Qual voce!… Come!…
tu donna?…» (Leonora, Conte).
«S’apre una porta: n’escono il Conte ed alcuni seguaci. Leonora si pone
in disparte». I seguaci entrano nella torre. Il Conte, in un recitativo
accompagnato («Udite?»), pronuncia la condanna alla decapitazione per
Manrico e al rogo per Azucena. Poi ha un ripensamento: è la gelosia che gli fa
compiere quest’atto. Pensa a Leonora, che non ha più visto dopo la presa di
Castellor, la invoca: «Dove sei crudele?», e lei spunta improvvisamente dal
buio: «A te davante». Inizia il duetto, articolato in tre sezioni.
Prima sezione: «Qual voce! come!», Allegro vivo in mi bemolle
maggiore, 4/4 a cappella, fino a «È sol vendetta mio nume… va’». Tutto
questo dialogo, con battute telegrafiche, è spinto avanti da un disegno
orchestrale incalzante, pieno di anapesti (due brevi che precedono la lunga: tata-tà, in pratica un’esten-sione del giambo). È una zona di passaggio,
necessaria per capire la situazione. Leonora chiede pietà per Manrico: «Ah sì,
per esso pietà domando», cui il Conte risponde con un rifiuto. La sua frase «Io
del rival sentir pietà?» è un gesto perentorio, che suscita l’energica risposta di
Leonora. In quest’ultimo atto, Leonora cresce come personaggio dalla tempra
robusta, capace di affrontare il destino, sfidandolo ad armi pari. Qui, ad
esempio, il soprano imita lo stesso andamento discendente («Clemente nume a
te l’ispiri») il baritono che si fa aggressivo («È sol vendetta mio nume»):
allora, la richiesta di pietà si spezza in singhiozzi, con cui Leonora quasi
97
s’accascia ai piedi del Conte, come suggerisce il contenuto gestuale della
musica: «Pietà! pietà! domando pietà».
La temperatura emotiva del pezzo sale, così, mentre si arriva alla
seconda sezione, l’Andante mosso in la bemolle maggiore «Mira, di acerbe
lagrime». Cresce qui la densità melodica del canto. Prima gli ottonari erano
spezzati tra i due personaggi, adesso sia Leonora che il Conte hanno sei versi
ciascuno. Quindi la musica può articolarsi in modo più formato. Leonora «si
getta disperatamente» ai piedi del Conte e gli offre la propria vita in cambio di
quella di Manrico. Il canto s’accalora. Singolarmente, la sua richiesta disperata
di pietà non è più rotta dal pianto, anche se il testo parla di lacrime. La
melodia, in maggiore, inaspettatamente, non è triste, né oppressa: Leonora ha
ormai vinto l’ango-scia, e si lancia con sicurezza nel progetto di salvare
Manrico, che la impegna in tutto il suo essere. La sua voce sale verso l’alto,
spinta sempre dalla pulsazione dei giambi. La parola «Svenami!», ripetuta
isolatamente, mette a fuoco la forza della situazione, spezza la linea vocale
prima dell’ultimo slancio, concluso dalla quartina su « salva il Trovator», un
ricciolo scattante che dà un tono generoso, battagliero e sprezzante alla sua
richiesta.
Il Conte esprime la propria ira con un tema caratterizzato da un
accompagnamento pulsante, quasi meccanico dell’orchestra («Ah!
dell’indegno rendere | vorrei peggior la sorte») e Leonora interviene con parole
tratte dal testo precedente, molto espressive. In queste interiezioni («Mi
svena… mi svena…») la voce sale sempre di più, con tensione crescente, in
contrasto con la meccanicità del canto baritonale, che si ricollega a quella
notata nella scena del chiostro. Questo stile ricorda vagamente l’opera buffa di
Rossini. Ma, qui, buffo non è proprio. Certamente, però, questa pulsazione
energetica, quasi fine a se stessa, prende le distanze dalla bruciante
immediatezza dei contenuti ed inserisce la scena in una dimensione stilizzata;
più che la rappresentazione della gelosia, Verdi vuol rendere la concitazione
del momento, evitando di rappresentare il Conte come il cattivo. Abbiamo già
constatato, d’altronde, che nei recitativi e in alcune parti di raccordo del
Trovatore la tensione drammatica e la velocità narrativa siano più importanti
della rappresentazione dei sentimenti individuali e dei caratteri. Certo è che le
invocazioni libere, spontanee, disperate di Leonora, spiccano moltissimo nel
contrasto con la musica «meccanica» attribuita al Conte, condannato ad
un’espressione prosaica: lancinanti sono, infatti, i suoi ultimi tre interventi:
«Lo salva, lo salva!», con i semitoni di pianto e di lamento.
Finito questo canto, inizia la terza sezione del duetto, articolato in
quattro parti, di cui la prima e la terza sono le più veloci, con frasi brevi e
spezzate; la seconda e la quarta presentano episodi musicali più estesi e
costruiti. In questo Alle-gro assai vivo, che inizia alle parole «Conte!… Né
98
cessi?… Grazia!», spicca la frase di Leonora: «Lo giuro a Dio che l’anima
tutta mi vede», imperiosa, energica, con le note martellate nella fatale discesa
verso il do basso. È questo il punto culminante dell’episodio, portato avanti da
una figura strumentale ricorrente, che continua a riproporre le tre semicrome
iniziali, con quel procedimento di ripetizione di un frammento in varie
posizioni e forme che abbiamo già visto nel terzetto del primo atto. Acquista,
così, la dovuta concitazione il dialogo fulmineo in cui Leonora offre se stessa
al Conte, pur di salvare la vita di Manrico, ma gli si offre cadavere: «M’avrai,
ma fredda, esanime spoglia», parola scenica isolata nel silenzio, pronunciata
nel registro basso, subito dopo che Leonora ha bevuto, di nascosto, il veleno
dall’anello. Nonostante la drammaticità del contenuto, Verdi sorvola anche su
questo passo: ne fa un brano di raccordo, dominato da una concitazione in cui
l’espressione si risolve in modo volutamente sbrigativo. Questo conferma
quanto s’è constatato sin dall’inizio: nel Trovatore interessano più i sentimenti
che il dramma, che scorre via con grande velocità, per ondate di accelerazione
destinate ad arrestarsi nei pezzi chiusi, dove l’azione si ferma ma la musica
continua a tener alta e altissima la propria carica d’energia teatrale. Questo fa
sì che Il Trovatore ci travolga con un senso d’irresistibile velocità anche se,
nella maggior parte dei pezzi chiusi, l’azione è ferma.
Qui viene, infatti, dilatata, attraverso la musica, la quarta ed ultima
sezione del duetto, l’Allegro brillante «Vivrà! Contende il giubilo», nella
tonalità di fa maggiore. Leonora «alzando in alto gli occhi cui fanno velo
lacrime di letizia», come prescrive la partitura, esprime la gioia di morire per
l’amato. Lo stile è quello della cabaletta del primo atto: stessi gorgheggi, stessi
salti e ritmi giambici per esprimere la gioia che scoppietta come una fiamma e
lo sguardo che brilla. Il Conte canta un tema molto simile, anche lui preso
dalla gioia di possedere finalmente Leonora, espressa in un canto leggero; poi
le voci s’intrecciano. Questo pezzo ci riporta in un clima più operistico,
brillante, festoso, persino distensivo. Alla considerazione della tragicità della
situazione, Verdi antepone una speciale attenzione per la dialettica teatrale.
Dopo la scena del «Miserere», così intensa, e tragica, e prima di quella del
carcere, di straordinaria forza patetica, è necessario un momento di distensione
che faccia spiccare entrambe in virtù del contrasto; per questo, l’espressione di
giubilo è risolta in una brillantezza anche belcantistica, con una componente
virtuosistica che non è pura e semplice esibizione d’acrobazia, ma può essere
espressione di sentimenti, sempre stilizzati, ed esente da qualsiasi impegno
realistico. Scoppiettano, dunque, in questo passo, con una freschezza
immediata e ingenua, il giubilo che Leonora prova per il proprio sacrificio, il
senso di liberazione e di vittoria sul destino che incombe. Manrico vivrà per il
suo sacrificio: l’idea della vita che continua a scorrere riempie Leonora di un
99
fuoco vivificante, espresso negli scatti scintillanti dei ritmi: anche qui è un
dilagare di giambi.
N. 14 Finale Ultimo «Madre… non dormi?» (Leonora, Azucena,
Manrico, Conte).
La scena ci trasporta ora in un orrido carcere: «in un canto finestra con
inferriata. Porta nel fondo. Smorto fanale pendente dalla volta. Azucena
giacente sopra una specie di rozza coltre. Manrico seduto a lei dappresso». La
scena del carcere era un topos nell’opera a cavallo tra Sette e Ottocento. Nel
Settecento francese, un genere detto «pièce à sauvetage», che ebbe larga
diffusione nel periodo della Rivoluzione, metteva in scena l’impresa di salvare
un personaggio ingiustamente carcerato. Tipico esempio, il Fidelio di
Beethoven, che deriva da una fonte francese. Nell’opera italiana ci sono varie
scene d’ambientazione carceraria, come nel Tancredi di Rossini o in alcune
opere di Donizetti. Verdi eredita questa tradizione, ma non fa, nel Trovatore,
una semplice scena di genere, bensì un’occasione per approfondire il rapporto,
originalissimo, tra madre e figlio. Negli atti precedenti l’amore tra i due era
apparso in modo occasionale, anche se sempre più consistente: ora diventa il
soggetto esplicito di un’intera scena. Ammiriamo, dunque, in quest’opera,
l’arte di dosare gli ingredienti, accennare dapprima ai principali motivi
drammatici e sentimentali, portarli avanti con coerenza, riprenderli a distanza
ed esaurirli, infine, in situazioni che li portano ad un’evidenza suprema. Così è
per l’eroismo di Leonora e la finezza d’animo di Manrico, che appare
dapprima qua e là, per trionfare, poi, nel terzo atto ed assumere in questa
scena, alla luce dell’amor materno, un aspetto nuovo.
L’inferriata cui si fa riferimento nella didascalia, è un elemento
importante per dare il senso della prigione. Lo «smorto fanale» indica la luce
fioca che illumina l’ambiente, freddo e umido. L’atmosfera opprimente è resa
esplicita dalla musica introduttiva, e dal verso di Azucena: «No, da questa |
tomba di vivi solo fuggir vorrei, | perché sento il respiro soffocarmi!...». Per
Azucena, avvezza alla vita all’aria aperta, tra monti e valli, il carcere è
doppiamente penoso: ogni verso dello straordinario libretto di Cammarano,
come si vede, aggiunge qualche cosa al ritratto dei personaggi. La scena ha un
carattere intimo, espresso anche dalla denominazione «duettino», più breve e
raccolto del duetto; mette a fuoco i rapporti tra madre e figlio nella situazione
terribile in cui si trovano. La conversazione non ha nulla di tragico né di
enfatico: riguarda l’ora presente nella sua dimensione di tempo sospeso, la
sofferenza intima del corpo e dello spirito, il sonno che non viene, il freddo
della prigione, il senso di soffocamento che tormenta i reclusi, la presenza
incombente della morte. In questa situazione atroce si ridestano gli incubi di
100
Azucena: l’immagine del rogo ritorna nella sua memoria, e la solita angoscia,
mai sopita, l’assale; Manrico tenta di calmarla, e la conduce presso il giaciglio
della cella.
A differenza delle altre situazioni statiche del Trovatore, dinamizzate al
loro interno da una musica propulsiva e scattante, questa scena ha un decorso
lento che crea un evidente contrasto con l’eccitazione delle pagine precedenti e
di quella successiva. Ma la tensione teatrale non si spezza mai: col fiato
sospeso lo spettatore segue il dialogo intimissimo tra madre e figlio, prima che
tutto precipiti nella catastrofe conclusiva. Verdi utilizzerà lo stesso effetto nella
Traviata, dove c’è, nell’ultimo atto, un’analo-ga scena d’intimità: Violetta
attende Alfredo nella stanza da letto, rievocando il proprio passato, nel
languore di una malattia che l’ha ormai portata vicino alla morte. Poi la corsa
degli eventi riprende, e giunge rapidamente al suo esito tragico.
Il duettino è diviso in due parti, di cui la prima è un recitativo sinfonico,
la seconda, che inizia con il verso di Azucena «Sì, la stanchezza m’opprime, o
figlio...» è un Andantino, in sol minore, in 3/8. Il passaggio dal recitativo al
pezzo chiuso, nel punto in cui i versi sciolti diventano decasillabi, è
musicalmente impercettibile: le prime battute del duettino sono ancora trattate
come se fossero un recitativo, e la melodia si forma a poco a poco,
dischiudendosi appieno solo in «Riposa o madre» e, in modo perfettamente
formato, in «Ai nostri monti».
Il recitativo è il più bello e musicale di tutta l’opera. A differenza degli
altri, in cui emergeva solo qualche isolata frase melodica, questo è molto
curato, poiché la scena non rappresenta l’incalzare d’un momento pratico, di
passaggio, tra una «visione» e l’altra, ma è assunta dal compositore come
un’occasione per studiare gli stati d’animo e conferire, con gli ultimi colpi di
pollice, i tratti definitivi ai plastici ritratti dei due personaggi.
Il recitativo mostra l’abilità di Verdi nel tradurre in musica la parola, e
renderla espressiva attraverso la specificità degli intervalli, l’esattezza dei
ritmi, la dosatura sapientissima del tasso melodico che si ritrae, lasciando
spazio ad un semplice parlante, o affiora in veri e propri squarci di arioso. Nel
Rigoletto e anche, seppure in misura minore, nella Traviata, questi esempi
abbondano: nel Trovatore un declamato così espressivo è un’eccezione, perché
Verdi ha praticamente escluso questa forma dalla progettazione della partitura,
in quanto incompatibile con il carattere retorico ed espressivo delle situazioni
principali; laddove compare, il declamato sinfonico nasce dall’occasionale
frattura della forma musicale, nei punti in cui la melodia chiusa si rompe e
lascia affiorare la parola nel suo suono naturale: musica e parola, per lo più, si
escludono. Qui, invece, il recitativo dilaga, assumendo un ruolo centrale nella
composizione della scena. Queste, ed altre improvvise svolte stilistiche,
costituiscono parte integrante dell’idea, radicalmente antiwagneriana, che sta
101
alla base di tutta la drammaturgia di Verdi: creare la tensione teatrale
attraverso una rapida successione di contrasti che regola ogni livello della
struttura, da quello macroscopico del taglio scenico a quello microscopico dei
vari parametri compositivi: ritmo, armonia, melodia, agogica, dinamica. In tal
modo, la discontinuità garantisce l’attenzione dello spettatore, mentre l’unità
dell’opera è affermata attraverso un ferreo sistema di coerenze compositive.
Il senso di staticità è espresso con grande suggestione già all’inizio
della scena, attraverso una serie di nove accordi intervallati da pause e suonati
da tutta l’orchestra in pianissimo: «questo squarcio estremamente piano»
prescrive la partitura aggiungendo pppp. L’effetto è di estrema pesantezza, di
misteriosa sacralità (dato dalla cadenza plagale in fa bemolle maggiore sul
quarto e quinto accordo); una staticità pietrificata, simile a quella che renderà,
nell’ultimo atto di Aida, l’atmosfera soffocante della tomba e il peso della
pietra che si rinchiude sopra i due amanti sepolti vivi. Il recitativo, pur
iniziando in modo «secco», si carica progressivamente di melodia, mentre
l’orchestra, che all’inizio tace per alcune battute, sostiene il canto anche con
figurazioni autonome. Il dialogo tra Azucena e Manrico nasce, quindi, dal
silenzio; le parole, ponderate con lentezza e recitate con cura, sono molto più
importanti di quanto non lo fossero nelle pagine precedenti. Si noti con quale
efficacia vengono rese le espressioni interrogative: «Madre, non dormi?» e
«Ah, come?», in rapporto alle frasi affermative che, nell’originalità
dell’invenzione melodica e armonica, esaltano il contenuto emotivo del testo;
si veda il gelido arpeggio discendente sulla settima diminuita di mi bemolle
minore alle parole «Da questa tomba di vivi»; la sospensione sulla quarta e
sesta della stessa tonalità su «Far di me strazio non potranno i crudi!» che
scivola, subito dopo, nella discesa cromatica di «le sue fosche impronte»,
viscido slittamento sul pedale di si bemolle verso la parola «morte!», che
s’impianta sulla settima diminuita di si bemolle minore, e cosi via, in un
continuo trascolorare dell’armonia a rendere lo sgomento, il gelo, il brivido
della paura per i presentimenti e i fantasmi che s’affollano alla mente. E il
canto? È duttilissimo: accenna frammenti melodici come «Far di me strazio»,
oppure s’inaridisce in un terreo parlato come in «Troveranno un cadavere»;
s’impenna in grida improvvise come «anzi uno scheletro» detto con gioia
feroce cui segue una lunga pausa. Anche il silenzio si carica d’espressione.
L’orche-stra, nella prima parte del recitativo, sta acquattata nell’ombra, poi
esce in primo piano, a cominciare dalla sventagliata di sedicesimi in fortissimo
che segue «Difendi la tua madre!». Azucena si sta eccitando. A differenza di
Manrico, la morte la terrorizza: ne ha avuto esperienza violenta, crudele, tale
da segnarla per sempre in quanto collegata all’immagine indelebile del rogo
che affiora periodicamente dentro di lei e torna, infatti, qui, dove parla dei
carnefici i cui passi le pare di sentire avvicinarsi, dietro l’uscio della prigione.
102
Manrico la consola: «Alcuno, ti rassicura, alcuno qui non volge». Geniale
contrasto: all’agitazione della madre, il ragazzo oppone una calma insieme
matura e ingenua, affettuosa e distaccata: la frase, Andante in si maggiore,
sorge dal timbro luminoso del tenore come un raggio di luce, in contrasto con
la cupezza del mezzosoprano, assestato nel registro basso. Si definisce,
dunque, un nuovo, umanissimo rapporto tra la madre sofferente e il figlio che
la consola e accudisce: la giovinezza, caritatevolmente impegnata ad accudire
la vecchiaia, fragile e bisognosa di aiuto.
Ormai, però, Azucena è risucchiata dal ricordo spaventevole: «Il rogo!
il rogo! il rogo! Parola orrenda!», dice non cantando ma, per dir così, recitando
in musica. Scatta qui un Allegretto in cui flauto e clarinetto, sul tremolo degli
archi, tutto in pianissimo, suonano il tema di «Stride la vampa». L’effetto, a
tanta distanza, è dirompente: tutto il dramma di Azucena riaffiora, condensato,
nel motivo di reminiscenza. In questa dimensione spettrale, scorporata, senza
più la plastica evidenza che aveva all’inizio del secondo atto, quando il fuoco
era lì presente sulla scena e acceso in tutta la sua concretezza, l’ideogramma
della fiamma, costantemente assestato, come ha notato Petrobelli,
sull’ossessiva permanenza della nota si (siamo qui in mi minore) sorge in
corrispondenza con un’immagine atroce: quella della madre sul rogo, con i
capelli in fiamme e gli occhi che stanno per schizzar fuori dalle orbite.
Azucena la rivive, quell’immagine, dibattendosi in un declamato spezzato,
incalzato dai tremoli e dalle roulades degli archi, un canto paralizzato su note
ribattute, che salgono, a poco a poco, sino al grido «Ah! chi mi toglie a
spettacol sì atroce!», lanciato «a tutta forza» prima di ricadere «tutta convulsa
tra le braccia di Manrico». Insomma, questo recitativo non finisce di stupirci
per le invenzioni continue che sul piano ritmico, melodico e armonico, ne
fanno un saggio di forma aperta, in tutto degno dell’ultimo atto di Rigoletto.
Il comportamento di Manrico appare sempre più forte, affettuoso,
rassicurante. Si scopre, qui, un’altra componente della sua personalità: la
maturità. La sua frase «Se m’ami ancor» con cui dice alla madre ciò che si dice
ai bambini: dormi, se mi vuoi bene, è un’effusione inattesa; sale, alla fine, sino
ad un luminoso sol, per terminare con un morbido vocalizzo, come una carezza
posata sul capo della madre, affranta e spossata. Il timbro di Manrico non è
solo quello del tenore eroico: possiede qui un lirismo e una grazia che vanno
resi con la stessa eleganza richiesta al cantante nell’aria del terzo atto.
Col passaggio ai decasillabi, «Sì la stanchezza m’opprime, o figlio...»,
inizia il vero e proprio duettino, un Andantino in sol minore, in 3/8,
caratterizzato da un leggero accompagnamento degli archi pizzicati. Azucena
s’avvia verso il letto. Nel suo canto sembra di cogliere un eco, deformato, della
melodia di «stride la vampa». La somiglianza non riguarda gli intervalli, ma il
ritmo, la pulsazione interna, gli scatti di breve-lunga, che esprimono il guizzare
103
della fiamma ridotto ad un ricordo sempre più lontano, ma ancora presente
nelle sue parole e nella preghiera rivolta al ragazzo: svegliami, gli dice, se si
vede il rogo. Azucena, comunque, riesce a calmarsi, grazie alla nuova melodia
di Manrico, «Riposa, o madre», sempre più dolce, quasi setosa nel raffinato
trattamento del timbro tenorile che sale di nuovo dolcissimo sino allo stellante
sol sopra il rigo, per ripiegarsi subito verso il basso, mentre l’orchestra culla la
voce con i tremoli dei violoncelli. Anche qui la «luce» si accende, col
passaggio da sol minore a sol maggiore.
Ora la scena si fa sempre più intima. Manrico è vicino al letto su cui
riposa Azucena che, ormai calmatasi, vagheggia il ritorno alla vita tranquilla,
tra i monti, dove il Trovatore tornerà a cantare, accompagnandosi con il liuto e
lei potrà dormire, cullata da quella musica. La melodia trasognata di «Ai nostri
monti» è frutto di uno stadio intermedio «tra il sonno e la veglia», cullante
vagheggiamento di uno stato di felicità che occupa la mente con una visione
lontana: ancora una volta, l’impostazione espressiva dell’opera e del suo
immaginario si conferma in tutta la sua spiccatissima individualità. Quando
Verdi imbocca una strada lo fa con lucidità e coerenza estreme, dalla prima
all’ultima scena. Il fatto che Azucena, cantando, s’addormenti rappresenta un
topos melodrammatico. Nell’opera italiana del ’600 e ’700 esisteva un tipo di
«aria del sonno», in cui il personaggio a poco a poco si abbandonava al riposo.
Il fatto di vagheggiare la felicità in una lontananza spaziale e temporale è
invece un topos romantico cui Verdi conferisce una straordinaria plasticità in
virtù dei contrasti stilistici, espressivi, retorici e drammatici, che modellano,
attraverso sbalzi vertiginosi, il sistema teatrale di ogni singola opera rispetto a
quelle di Donizetti e Bellini: «Parigi, o cara, noi lasceremo» (La Traviata),
«Lieta poss’io precederti» (La forza del destino), «Ma lassù ci vedremo in un
mondo migliore» (Don Carlo), «Rivedrai le foreste imbalsamate», «O terra
addio, addio valle di pianti» (Aida), sono tutti momenti in cui i personaggi di
Verdi, cui la forza del destino ha sbarrato il passo verso la felicità, pensano di
poterla realizzare in un luminoso altrove, con la calma e la forza dell’uomo
che, tra le tempeste della vita, ha vissuto in pace con la propria coscienza.
Un’esplicita energia morale muta, dunque, completamente, l’espressione di
questi passi, rispetto alle dolci estasi amorose dei compositori precedenti.
La melodia, cullante, è quasi una nenia, forse una ninna nanna che
Azucena ha cantato, su altre parole, a Manrico, quando era bambino, per farlo
addormentare, oppure è un motivo di Manrico stesso che la madre spera di
riascoltare, tornando a casa. Comunque, il tipo melodico e, soprattutto, ritmico,
di «Ai nostri monti», è affine a quello della romanza di Manrico «Deserto sulla
terra»: simili i rintocchi interni dei ritmi puntati, come di campana; simile il
ritmo ternario con accompagnamento a chitarra, e il tono di melodia popolare,
perfettamente quadrata, suadente, nell’insistenza malinconica dei suoi echi
104
interni. L’affinità della tipologia melodica tra di due pezzi rafforza quindi
strettamente il legame tra madre e figlio: anche la canzone di Azucena, che
abbiamo appena risentito in orchestra, era imparentata, s’è detto, con questo
modo di cantare. Attraverso tali rimandi interni, tra le romanze, le canzoni e i
canti operistici, il legame tra Azucena e Manrico si definisce come
appartenenza ad una cultura musicale comune, che il figlio ha appreso dalla
madre: eredità più forte di quella del sangue, e capace di trasformare il
bambino adottivo in un figlio vero.
È lui, ora, che si china sul giaciglio di Azucena, che tante volte l’avrà
cullato quando era bambino: «Riposa, o madre», ti veglierò pregando, le dice
sulla stessa melodia di prima, dolcissima e leggerissima, ma anch’essa
percorsa dai ben noti rintocchi ritmici su «madre» e «cielo», che si
ripresentano quasi come un vocabolo tratto dal comune lessico familiare.
Il duettino si conclude con un tono lievemente più affannoso, mentre sei
violini divisi suonano piccoli disegni, tintinnanti come un infantile carillon.
Vicini al momento del distacco, madre e figlio riscoprono l’essenza del loro
rapporto nella regressione ad un’atmosfera d’infanzia, una dolcezza da ninna
nanna, cantata presso una culla.
Senza questa scena, il rapporto madre-figlio, così essenziale nel
Trovatore, sarebbe rimasto incompleto. Inoltre, il suo carattere di tempo
sospeso conferisce al brano una funzione drammatica essenziale: quella di
aumentare la tensione che si scaricherà subito dopo, nel precipitare degli eventi
verso la catastrofe finale. Essa si avvicina con il fremito subitaneo di un
Allegro assai vivo in sol minore: s’apre una porta ed entra Leonora, che
annuncia di poter salvare Manrico. La scena e Terzettino conclusivo è
articolata in cinque sezioni.
La prima, molto rapida e concitata, inizia con frasi spezzate, ad
eccezione di una battuta di Manrico – «Ah mi concedi, pietoso nume, | gioia sì
grande anzi ch’io mora?» – melodicamente più ampia. L’orchestra, sul
ricorrente rimo giambico, incalza le voci in modo concitato. Manrico, che
rifiuta di fuggire e dice di disprezzare la propria vita (ecco la conferma del
carattere della melodia che cantava durante la scena del «Miserere» dall’alto
della torre: i conti tornano sempre, con una logica perfetta) comprende che
Leonora si è venduta per salvarlo. L’intero episodio è volto a rendere la
concitazione generale della scena, senza particolare interesse per
l’individualità dei personaggi. Quest’ultima parte dell’opera non aggiunge più
nulla ai singoli caratteri: semplicemente, sbatte un contro l’altro Manrico,
Leonora, Azucena e, nelle ultime pagine, anche il Conte, per giungere
rapidamente alla catastrofe in un’incalzante velocità di eventi: comparsa di
Leonora, tentativo di convincere Manrico a fuggire, morte di Leonora, morte
105
di Manrico. È un seguito veloce di gesti, più che di sentimenti, ma carichi di
forza ed evidenza drammatica.
La seconda sezione, Andante in sol maggiore, s’inizia con le parole di
Manrico: «Parlar non vuoi?», e rappresenta la parte centrale della scena.
Manrico inizia il terzetto senza una melodia formata, con una serie d’invettive
scagliate contro la ragazza: come mai Leonora non vuol dire a qual prezzo ha
ottenuto la sua libertà? E risponde a se stesso: «Ha quest’infame l’amor
venduto». Lo scoppio d’ira di Manrico è preceduto dall’orchestra che suona
una scala cromatica ascendente cui segue una melodia in re maggiore molto
tesa, quasi disperata. Anche Leonora è agitatissima, e nel suo canto alterna
slanci melodici («Oh come l’ira ti rende cieco!», con andamenti discendenti
che richiamano il «Sull’orrida torre» del «Miserere») e parole concitate, in un
tono quasi di parlato, con l’insistenza di chi supplica qualcuno con disperata
ma sommessa agitazione: «T’arrendi, fuggi, o sei perduto». Poi, però,
l’atmosfera muta improvvisamente, il tempo rallenta in un Meno mosso, e il
solito passaggio in maggiore dischiude, come per incanto, l’orizzonte del
sogno: dal letto dove sta dormendo, Azucena riprende sommessamente, tra sé,
«Ai nostri monti ritorneremo». L’effetto è di nuovo straordinario, coerente con
il continuo gioco di scambio tra realtà e visione che caratterizza l’immaginario
del Trovatore. Quando avevamo sentito per la prima volta questa melodia, il
desiderio di riascoltarla era rimasto inappagato: il duettino non ci concedeva
quello che qualsiasi altro compositore, meno drammaticamente impegnato di
Verdi, non avrebbe avuto nessuna remora a concedere: l’imme-diata
ripetizione del passo. Invece lui mostra il suo gioiello melodico, ma subito lo
nasconde, per ripresentarlo, del tutto inatteso, in un altro contesto, con effetto
potenziato. Così, nel bel mezzo di una scena concitatissima, tutto si sospende e
la musica apre uno squarcio nell’interiorità. Azucena riprende la sua
dolcissima ninna nanna, ignara di ciò che attorno a lei sta succedendo; Leonora
continua a scandire, in pianissimo, su dei re, ribattuti con voce terrea «Ah
fuggi, fuggi, o sei perduto! Nemmeno il ciel salvar ti può!» con una sorta di
parlato, interrotto dal singhiozzo del salto ascendente di nona sulla parola
«cielo», come un grido soffocato: l’infanzia e la morte prossima di Manrico
sembrano saldarsi in una sintesi sgomentante. Contemporaneamente, Manrico
ripete con parole distanziate dalle pause «Ha quest’infame l’amor venduto! |
venduto un core che mio giurò!»: è così affranto che non riesce a costruire una
melodia formata, ma solo frammenti, molto espressivi, di canto disperato. Per
la prima volta, nel corso di tutta l’opera, le due donne sono
contemporaneamente in scena, ma non si parlano; Azucena, addormentata, non
s’accorge della presenza di Leonora. Considerare assurdo il fatto che Azucena
non si svegli con il canto dei due innamorati è fuori luogo, perché il
melodramma non va giudicato con un metro realistico: qui siamo fuori dal
106
tempo drammatico, fuori dalla realtà dei fatti esteriori: entriamo nella vita
interiore, e, attraverso la musica, “vediamo” direttamente nei sentimenti dei tre
personaggi, sottoposti alla dilatazione d’una lente di ingrandimento e
sovrapposti nella contemporaneità di affanno (Leonora), dolore (Manrico),
trasognata nostalgia (Azucena).
La terza sezione del terzetto, Allegro assai mosso in do minore, inizia
con la battuta di Manrico: «Ti scosta». È di nuovo un pezzo rapidissimo,
interamente fondato sullo scatto giambico, che sostiene frasi spezzate e veloci.
Manrico respinge Leonora, la maledice, ma lei, chiedendogli di pregare, gli
rivela che ha la morte in seno e sta morendo a causa del veleno: «Senti... la
mano è gelo! | Ma qui... qui foco terribil | arde!». Ancora una volta, dunque,
compare l’immagine del fuoco inteso come metafora non di passione amorosa
ma di morte. Il ritmo giambico, che non finisce di trasformarsi in mille, diverse
colorazioni, acquista ora una sfumatura cupa, mortuaria: pulsa in orchestra, sin
dall’inizio dell’Alle-gro assai mosso ma, nella strumentazione, per soli archi e
fagotto, e nell’armonia, si fa sempre più oscuro, come se perdesse vitalità, e a
poco a poco impallidisse in un suono terreo, quasi rumoristico: senso di
affanno, di rantolo, soprattutto nell’ultima, citata battuta di Leonora. Entrambi
i ragazzi non hanno mai cantato melodie in questa sezione, ma solo frammenti
di canto assolutamente non melodico: la morte incombente non solo raggela la
mano di Leonora ma inaridisce la fonte del canto.
La quarta sezione inizia con le parole di Manrico: «Che festi... oh
cielo!», ed è un Andante in mi bemolle maggiore: Leonora muore in un clima
di trasfigurazione. Quindi il concertato alterna episodi «cantati», in cui i
sentimenti vengono espressi e approfonditi dalla musica, ad altri in cui non si
ha tempo di cantare melodie, ma solo di declamare in musica, sotto l’incalzare
degli eventi. La frase «Prima che d’altri vivere… | io volli tua morir!», ripetuta
due volte, spiega il senso di questa morte: la melodia, nella tonalità luminosa
di mi bemolle maggiore, sale dal sol3 al la4 e trasforma il trapasso in un’ascesa
al cielo piena di serenità, pace, affetto verso colui cui Leonora sta per riunirsi
nell’aldilà. Lo slancio ascensionale che aveva caratterizzato le sue melodie più
belle, ritorna qui, dando al sacrificio il crisma di un amore che innalza il
personaggio sopra il suo tragico destino.
La presenza della morte, come s’è detto, aleggia su tutta l’opera. Per
Manrico e Leonora ha certo la sua terribilità però, nello stesso tempo, è il
mezzo per realizzare una felicità altrimenti impossibile. C’è quindi un’idea di
fratellanza tra amore e morte, di leopardiana memoria:
Fratelli, a un tempo stesso, Amore e Morte
ingenerò la sorte.
Cose quaggiù sì belle
107
altre il mondo non ha, non han le stelle.
Estraneo, però, al nichilismo leopardiano, Verdi accoglie la speranza, e
i suoi personaggi muoiono tranquilli, grazie alla forza che nasce dalla fedeltà ai
grandi valori morali: l’amicizia, l’amore, l’onestà, la fedeltà, la ricerca del
bene. Non c’è mai in Verdi l’attrazione distruttiva verso l’elemento negativo,
come invece c’è nella cultura e nell’arte europea, anche prima del
decadentismo.
La morte di Leonora deve essere recitata con grande intensità e
naturalezza, e senza alcun’enfasi falsamente melodrammatica. Significative
sono le didascalie: Leonora, dapprima, cade in segno di spossatezza davanti a
Manrico, poi muore «stringendogli la destra in segno di addio»: unico gesto,
intimo e commosso, che le dà forza nel momento del trapasso. Leonora ripete
due volte la sua frase melodica ascendente in cui esprime la fratellanza di
amore e morte, e, tra la prima e la seconda volta, il Conte entra in scena e
s’affaccia sulla soglia della prigione, fermandosi ad osservare ciò che sta
succedendo. Il concertato si sviluppa ancora con la frase intensa e disperata di
Manrico «Insano!... ed io quest’angelo | osava maledir!», poi è concluso da un
episodio dominato dagli incisi affannosi di Leonora, due note per volta,
striscianti per semitono, un vero seguito di singhiozzi che, quando vengono
ripetuti, acquistano un effetto abbastanza convenzionale. Ma siamo ormai alla
fine, e Verdi ha già detto tutto quanto aveva da dire: non resta che concludere,
come avviene nella quinta sezione (Allegro), che comincia con la frase del
Conte «Sia tratto al ceppo». Manrico è preso, invoca la madre, viene trascinato
fuori; Azucena, svegliatasi, domanda di lui, ma, dalla finestra, lo vede ormai
spento sul patibolo. La velocità con cui Verdi sbriga questo pezzo, tra grida e
aggressioni sonore, è quasi provocatoria: la musica fa qui precipitare gli eventi
in un ritmo surreale. Non c’è tempo, in così poche battute, di compiere le
azioni previste nel libretto: trascinare Manrico fuori della prigione, fargli
scendere le scale della torre, condurlo al luogo del supplizio e tagliargli la
testa. Ma è proprio questa altimetria dei ritmi drammatici e dei registri
espressivi, tipicamente verdiana, che fa risaltare nella nostra memoria, e
imprime nella nostra coscienza il significato delle sublimi pagine precedenti:
se Verdi non ha inventato lo straniamento brechtiano, come sostiene Luciano
Berio39, poco ci manca.
L’opera si conclude, così, con un’altra esplosione di frenesia
drammatica, culminante nell’ultima battuta di Azucena che, dopo aver gridato
al conte che Manrico era suo fratello, leva il suo grido disperato: «Sei
39
L. BERIO, Verdi?, in La vera storia, programma di sala, Milano, Teatro alla
Scala, 1982, pp. 46-51.
108
vendicata o madre!» e si accascia ai piedi della finestra. Urlo di trionfo? No, di
disperazione, sarcastica e amara, che la schiaccia a terra. Anche il figlio
adottivo, amatissimo, è stato ucciso. Azucena, ora, è completamente sola:
l’attende il rogo. La vendetta, come nel Rigoletto, si ritorce dunque su chi la
persegue, anche se in Azucena quel proposito di vendetta non era espressione
di rabbia furiosa, ma desiderio di riparare un’ingiustizia.
Manca, dunque, nel Trovatore un vero e proprio duetto tra soprano e
tenore che Verdi avrebbe potuto introdurre qui, prima della fine dell’opera,
come, per esempio, avviene nel Don Carlo e nell’Aida, quando i protagonisti si
dicono addio e rimandano la loro felicità a tempi migliori, dopo la morte
liberatrice: «Ma lassù ci vedremo in un mondo migliore» cantano Elisabetta e
Don Carlo; «Per noi si schiude il ciel» sono le parole di Aida e Radames, che
indugiano nella speranza della felicità futura. Nel Trovatore, invece,
l’aspirazione alla felicità possibile in un lontano altrove, è sorprendentemente
dirottata sulla coppia madre-figlio che acquista, quindi, un peso uguale, se non
maggiore, di quello del rapporto amoroso tra soprano e tenore. Questo
ridistribuisce completamente i rapporti drammatici ed espressivi all’interno
dell’opera, rispetto alle consuetudini dell’Ottocento.
La corrente estatica dell’emozione amorosa che unisce Leo-nora e
Manrico si manifesta, difatti, in situazioni anomale: nel primo e nell’ultimo
atto, quando lui canta le sue canzoni fuori scena e lei le ascolta in primo piano
guardando nel buio della notte da cui proviene la voce del Trovatore; quindi in
una dimensione di sostanziale incomunicabilità tra i due personaggi che
continuano a rincorrersi, e fanno a gara, prima nell’inseguirsi sulla terra, poi
nel precedersi nell’al di là. Quando Manrico e Leonora si parlano direttamente,
infatti, senza avviare veri e propri duetti, come nel «duello» del prim’atto,
nella scena del convento, in quella del matrimonio e nella prigione,
l’argomento principale non è l’amore, ma la morte incombente. L’assenza del
duetto tra soprano e tenore si spiega nell’ottica drammaturgica dell’opera, che
si propone di rappresentare situazioni mai appagate, in continua tensione verso
immagini e personaggi assenti, o inafferrabili, ma presenti alla fantasia con
allucinante evidenza grazie al potere evocatore della musica che brucia la
parola, come la fiamma brucia il carbone, per far muovere gli ingranaggi
dell’espressione e della drammaturgia nel suo complesso.
Lo scatto propulsore che anima la partitura con un ritmo diversissimo
rispetto ai calcolati indugi, alle dilatazioni temporali, ai prolungati effetti di
sospensione che rendono altrettanto spasmodico, ma in un modo diverso,
l’ascolto del Rigoletto, si radica in un sistema di antitesi che percorre il
progetto drammatico e la sua realizzazione musicale da cima a fondo:
l’opposizione tra modo maggiore e modo minore, tra forte e piano, tra melodia
e parola che non nascono l’una dall’altra, come avviene nel Rigoletto e nella
109
Traviata, ma, per lo più, si escludono reciprocamente; la contrapposizione tra
canzoni, racconti e ballate in forma strofica, e arie in continuo divenire;
l’antitesi di primo piano e sfondo, presenza e assenza; l’elaborazione fantastica
di oggetti reali (il fuoco) e l’improvviso realizzarsi di immagini della fantasia
(le epifanie di Manrico), procedimento che sale ad evidenza macroscopica
nella sovrapposizione della vicenda reale di Azucena con quella passata della
madre; la divaricazione dei due sentimenti che albergano in ciascun
personaggio; il contrasto iperbolico tra precipitose scene d’azione e dilatazioni
contemplative, a loro volta rovesciate nella più frenetica eccitazione musicale;
tra il fuoco (negli atti centrali) e la tenebra (in quelli laterali), tra rosso e nero,
luce e buio, vita-affetto-passione e morte-presagio-terrore, e così via, tutti
questi elementi contrapposti determinano un sistema di sbalzi, contrasti e
rovesciamenti, ad ogni livello percettivo, che accumula tensione in
progressione geometrica.
Elemento unificante di questo universo musicale e drammatico in
sistematica antitesi con se stesso è la permanenza di elementi musicali che
ritornano in contesti molto differenti: ad esempio, il ritmo delle nacchere, che
allude al mondo degli zingari raccolto intorno al fuoco, ma, soprattutto, il
ritmo giambico che è presente come il sangue nelle vene, e che, in diversi
contesti agogici, melodici e dinamici esprime, di volta in volta, effusione
sentimentale, immagine del fuoco, forza della passione, incalzare degli eventi,
pulsione di vita, affanno di morte. Questi elementi tematici non appartengono
né all’uno né all’altro personaggio, bensì, diversamente assortiti, un po’a tutti:
sono presenze trasversali, disseminate ovunque e collegate tra loro come i
raggi di una circonferenza che tengono insieme un sistema drammatico molto
vario, ma sottilmente strutturato in forma unitaria. Ciò trasforma un dramma
burattinesco, inverosimile, lontano dal nostro gusto, in un capolavoro
d’intramontabile forza espressiva. Ciò che a Verdi non era ancora riuscito
perfettamente nel Macbeth, riesce nel Trovatore: conferire una qualità
shakespeariana al progetto drammatico attraverso un sistema così fitto, logico
e imprevedibile di collegamenti intertestuali da determinare la profondità e la
conturbante originalità dell’opera nel suo complesso.
C’è qualche cosa di primordiale nell’immaginario del Trovatore che fa
di questo capolavoro un unicum in tutta la produzione verdiana. Viene in
mente Eraclito: il fuoco come anima del mondo, elemento che vivifica, nutre e
distrugge ogni cosa, in un’eterna vicenda di circolarità. Ma c’è anche l’aria,
l’elemento fluido che permette ai pensieri di Leonora e ai canti lontani
dell’invisibile Trovatore di trasvolare, incontrandosi, per due volte, nel buio
della notte; e c’è la terra, su cui gravitano e scalpitano i ritmi zingareschi, i cori
ritmati dall’incedere delle marce o dai colpi dei martelli, i passi leggeri dei
rapitori. Manca completamente l’acqua, altrimenti avremmo i quattro principi
110
primordiali al completo. Ma tanta acqua di tempesta era scrosciata, tra fulmini,
tuoni e folate di vento, nell’ultimo atto di Rigoletto. La Traviata, al contrario,
ignorerà completamente qualsiasi elemento naturalistico: raccolta in ambienti
chiusi, tra velluti, rasi, sete, odori di fumo e di vino, lenzuola scomposte dalla
sofferenza, e sentore di malattia, interiorizzerà l’elemento primordiale nella
coscienza del tempo che, vorticoso, ansimante e implacabile, lascia poco da
godere e da vivere («È tardi!» canta Violetta nell’ultimo atto: ma è sempre
tardi, per tutto e per tutti, nella Traviata).
Ciò che s’è detto contribuisce a fissare il carattere estremo del
Trovatore e a comprendere, sia pure parzialmente, l’eternità del suo messaggio
cui si deve il successo straordinario della partitura, la sua immensa diffusione a
livello popolare, attraverso «gli organetti a mantice e a percussione che
affliggono tutto il mondo», come scriveva Alfredo Soffredini nel 1901 40; ma
anche l’interesse che le ha riservato il Novecento. L’opera, infatti, è stata vista
da un lato come l’emblema del melodrammatico; dall’altro come qualche cosa
che, pur rappresentando, nella sua quintessenza, il teatro musicale italiano
dell’Ottocento, contemporaneamente se ne distacca: l’opera romantica si
sarebbe, infatti, rivolta alla rappresentazione dei fatti reali, all’analisi
psicologica, alla narrazione realistica seguita con forme sempre più aperte e
con scioltezza e minuzia di particolari. Questo fatto potrebbe indurre,
nonostante tutto, nella tentazione di giudicare Il Trovatore come un’opera che
guarda al passato. In realtà, proprio l’iperbole del melodrammatico, in esso
contenuta, ne fonda la modernità.
Nella misura in cui il teatro musicale del Novecento ha recuperato
l’interesse per argomenti mitici, simbolici, epici, staccati dalla quotidianità
immediata, Il Trovatore ha acquistato, infatti, una nuova attualità. Non per
nulla Luciano Berio, nel 1977-78, nell’opera La vera storia (titolo tratto dalla
prima scena di Cammarano «La vera storia ci narra di García…»), su testo di
Italo Calvino, ha ripercorso la vicenda del Trovatore come un paradigma di
40
Cfr. A. SOFFREDINI, Le opere di Verdi, Milano, Aliprandi, 1901 p. 147: «È
curioso infatti che tutti questi organetti portatili abbiano nel loro repertorio (!)
il: Mal reggendo all’aspro assalto, la cabaletta: Di quella pira, l’aria: Ah,
l’amore, l’amore ond’ardo, il patetico: Ai nostri monti ritorneremo, e il
sublime Ah che la morte ognora, del Trovatore. Queste spiccatissime
cantilene, per quel mezzo semplicissimo di riproduzione continuata, hanno
colpito su per giù gli orecchi di quasi tutti gli abitanti del globo; pure tale
insistenza non scema giammai il loro valore estetico grandissimo; le
rappresentazioni dell’opera su tutti i teatri sono anche oggidì senza
interruzione e quei canti ritrovano sempre, ad ogni nuova udizione, lo stesso
fascino dei primi tempi».
111
conflitti e sentimenti elementari, operandone una reincarnazione
melodrammatica a sfondo antropologico. Ma l’inte-resse per Il Trovatore è
dilagato anche negli altri settori della produzione artistica: si ricordi il famoso
quadro metafisico di Giorgio De Chirico che, come ha scritto Massimo Mila,
«nei riverberi rossi e verdi cupi ha qualcosa dell’arroventata aura passionale
del melodramma verdiano e nella cecità della testa ovoidale la stupefatta
assurdità della disperazione di quella ‘musica vermiglia’, come la definì
Barilli»41; la novella di Pirandello Leo-nora addio!, le citate pagine di Barilli,
appunto, nel Paese del melodramma e la poesia di Montale, contenuta in
Satura (1971), settimo componimento di «Xenia», che riporto qui nella sua
originale disposizione grafica, in cui ad un luogo tipico del Trovatore è
collegata una breve riflessione sull’esistenza umana e il suo rapporto con l’al
di là:
Pietà di sé, infinita pena e angoscia
di chi adora il quaggiù e spera e dispera
di un altro…(Chi osa dire un altro mondo?).
···
«Strana pietà…» (Azucena, atto secondo)
41
M. MILA, Verdi, cit., p. 487.
112
113
Stampa: Ideanet, Torino
Maggio 2002
114