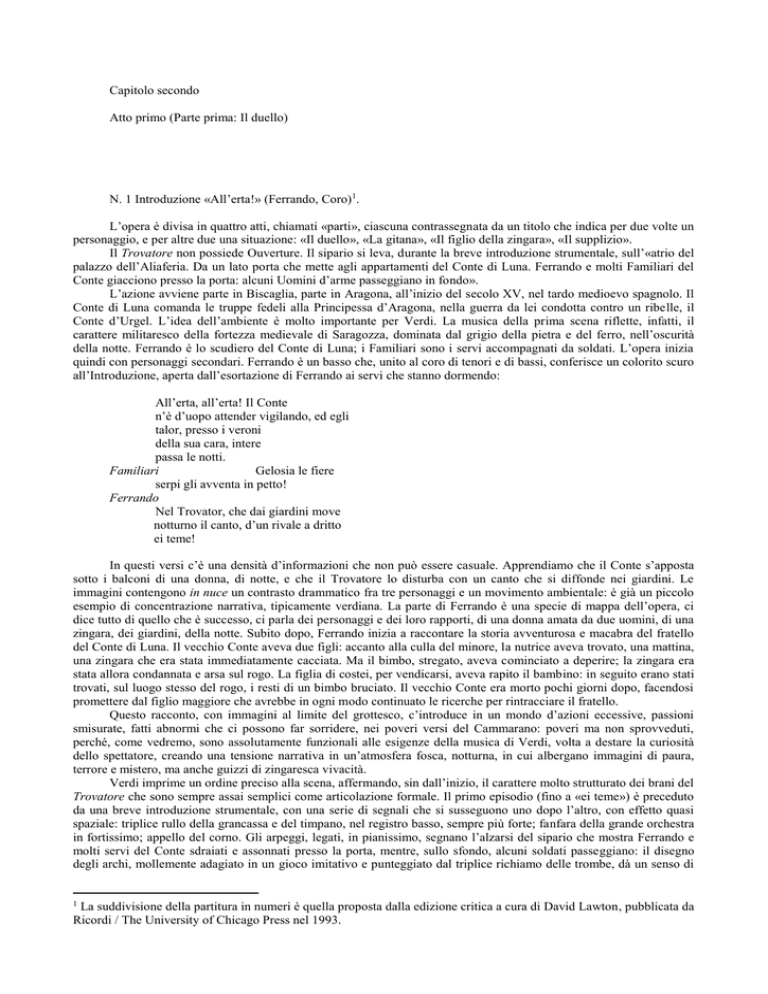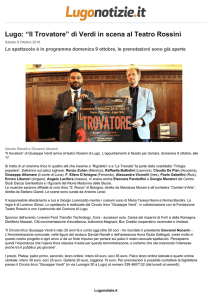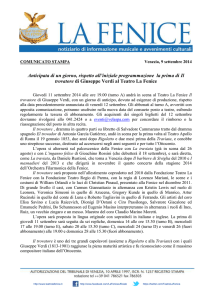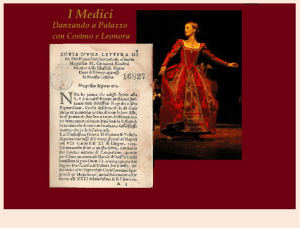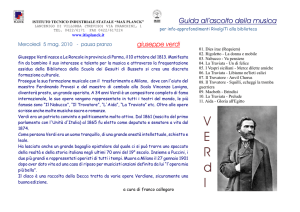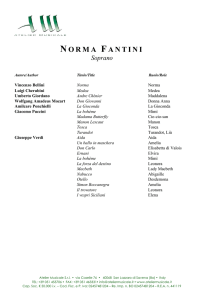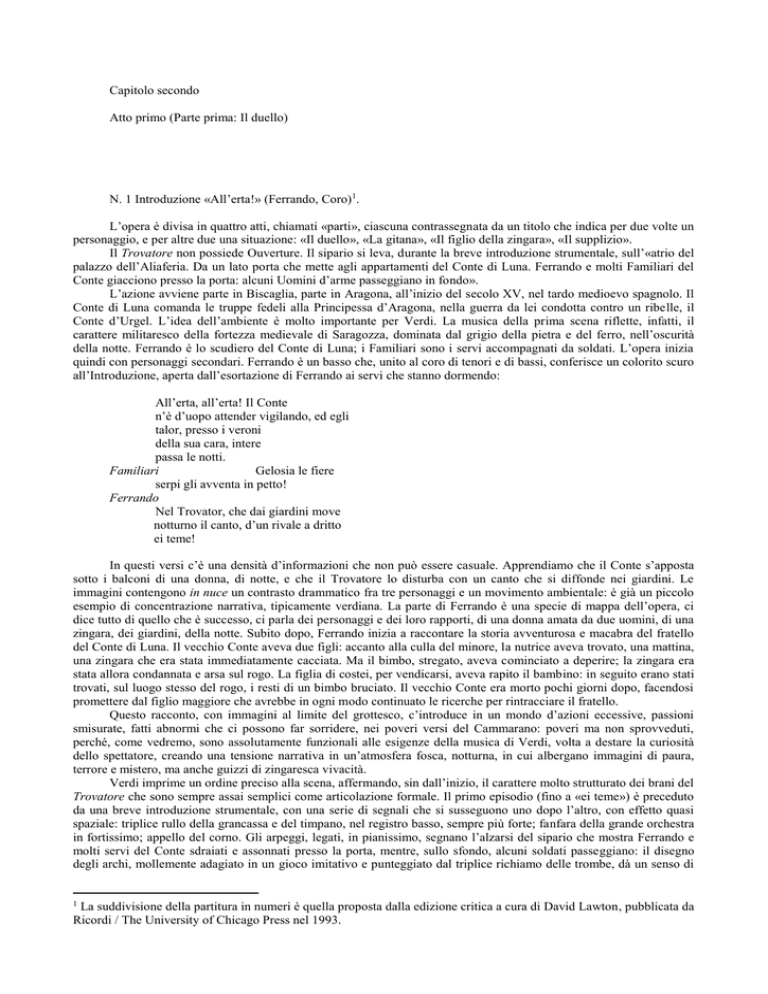
Capitolo secondo
Atto primo (Parte prima: Il duello)
N. 1 Introduzione «All’erta!» (Ferrando, Coro)1.
L’opera è divisa in quattro atti, chiamati «parti», ciascuna contrassegnata da un titolo che indica per due volte un
personaggio, e per altre due una situazione: «Il duello», «La gitana», «Il figlio della zingara», «Il supplizio».
Il Trovatore non possiede Ouverture. Il sipario si leva, durante la breve introduzione strumentale, sull’«atrio del
palazzo dell’Aliaferia. Da un lato porta che mette agli appartamenti del Conte di Luna. Ferrando e molti Familiari del
Conte giacciono presso la porta: alcuni Uomini d’arme passeggiano in fondo».
L’azione avviene parte in Biscaglia, parte in Aragona, all’inizio del secolo XV, nel tardo medioevo spagnolo. Il
Conte di Luna comanda le truppe fedeli alla Principessa d’Aragona, nella guerra da lei condotta contro un ribelle, il
Conte d’Urgel. L’idea dell’ambiente è molto importante per Verdi. La musica della prima scena riflette, infatti, il
carattere militaresco della fortezza medievale di Saragozza, dominata dal grigio della pietra e del ferro, nell’oscurità
della notte. Ferrando è lo scudiero del Conte di Luna; i Familiari sono i servi accompagnati da soldati. L’opera inizia
quindi con personaggi secondari. Ferrando è un basso che, unito al coro di tenori e di bassi, conferisce un colorito scuro
all’Introduzione, aperta dall’esortazione di Ferrando ai servi che stanno dormendo:
All’erta, all’erta! Il Conte
n’è d’uopo attender vigilando, ed egli
talor, presso i veroni
della sua cara, intere
passa le notti.
Familiari
Gelosia le fiere
serpi gli avventa in petto!
Ferrando
Nel Trovator, che dai giardini move
notturno il canto, d’un rivale a dritto
ei teme!
In questi versi c’è una densità d’informazioni che non può essere casuale. Apprendiamo che il Conte s’apposta
sotto i balconi di una donna, di notte, e che il Trovatore lo disturba con un canto che si diffonde nei giardini. Le
immagini contengono in nuce un contrasto drammatico fra tre personaggi e un movimento ambientale: è già un piccolo
esempio di concentrazione narrativa, tipicamente verdiana. La parte di Ferrando è una specie di mappa dell’opera, ci
dice tutto di quello che è successo, ci parla dei personaggi e dei loro rapporti, di una donna amata da due uomini, di una
zingara, dei giardini, della notte. Subito dopo, Ferrando inizia a raccontare la storia avventurosa e macabra del fratello
del Conte di Luna. Il vecchio Conte aveva due figli: accanto alla culla del minore, la nutrice aveva trovato, una mattina,
una zingara che era stata immediatamente cacciata. Ma il bimbo, stregato, aveva cominciato a deperire; la zingara era
stata allora condannata e arsa sul rogo. La figlia di costei, per vendicarsi, aveva rapito il bambino: in seguito erano stati
trovati, sul luogo stesso del rogo, i resti di un bimbo bruciato. Il vecchio Conte era morto pochi giorni dopo, facendosi
promettere dal figlio maggiore che avrebbe in ogni modo continuato le ricerche per rintracciare il fratello.
Questo racconto, con immagini al limite del grottesco, c’introduce in un mondo d’azioni eccessive, passioni
smisurate, fatti abnormi che ci possono far sorridere, nei poveri versi del Cammarano: poveri ma non sprovveduti,
perché, come vedremo, sono assolutamente funzionali alle esigenze della musica di Verdi, volta a destare la curiosità
dello spettatore, creando una tensione narrativa in un’atmosfera fosca, notturna, in cui albergano immagini di paura,
terrore e mistero, ma anche guizzi di zingaresca vivacità.
Verdi imprime un ordine preciso alla scena, affermando, sin dall’inizio, il carattere molto strutturato dei brani del
Trovatore che sono sempre assai semplici come articolazione formale. Il primo episodio (fino a «ei teme») è preceduto
da una breve introduzione strumentale, con una serie di segnali che si susseguono uno dopo l’altro, con effetto quasi
spaziale: triplice rullo della grancassa e del timpano, nel registro basso, sempre più forte; fanfara della grande orchestra
in fortissimo; appello del corno. Gli arpeggi, legati, in pianissimo, segnano l’alzarsi del sipario che mostra Ferrando e
molti servi del Conte sdraiati e assonnati presso la porta, mentre, sullo sfondo, alcuni soldati passeggiano: il disegno
degli archi, mollemente adagiato in un gioco imitativo e punteggiato dal triplice richiamo delle trombe, dà un senso di
1
La suddivisione della partitura in numeri è quella proposta dalla edizione critica a cura di David Lawton, pubblicata da
Ricordi / The University of Chicago Press nel 1993.
attesa e di torpore. I servi si stanno addormentando, e Ferrando, subito dopo, li richiama alla veglia. Ma questa
successione di segnali non è solo narrativa: crea un effetto spaziale. C’è un senso di profondità dato dal rullo iniziale
che si avvicina a poco a poco, passando dal piano al fortissimo; l’effetto di un accecante primo piano nello squillo della
fanfara militaresca a piena orchestra; poi un’idea di lontananza nell’appello, pianissimo, del corno che sembra provenire
da chissà dove, e annuncia qualcosa di misterioso, notturno, impreciso. Naturalmente è una spazialità immaginaria,
creata in virtù della dinamica (contrasto tra piano e forte) e dei colori timbrici: ma fissa una dimensione «stereofonica»,
articola una spazialità sonora che avrà grandi sviluppi nel corso dell’opera.
Subito attacca il canto di Ferrando, con un recitativo abbastanza convenzionale, pausato dai commenti del coro
(«All’erta! All’erta!»). Alle parole «d’un rivale a dritto ei teme», finisce la parte introduttiva: il tempo cambia, inizia un
Moderato in Sol maggiore in cui il coro chiede a Ferrando che gli venga raccontata la vera storia di García, fratello del
Conte. E Ferrando attacca la sua ballata, che narra un fatto lontano, circondato da un’aura misteriosa e leggendaria.
Nella partitura questo pezzo è indicato come «Racconto» che non è una definizione musicale, come «aria», «cabaletta»,
«cavatina» ma letteraria. La ballata aveva una forte circolazione nella musica europea del tempo, specie in Germania,
dove costituiva un genere ricorrente nella produzione liederistica per canto e pianoforte. Sua caratteristica è la forma
strofica, qui molto semplice: A–B–A’–B’ corrispondente ai seguenti versi:
A
B
A’
Di due figli vivea padre beato
Abbietta zingara fosca e vegliarda
Asserì che tirar del fanciullino
B’
La fattucchiera perseguitata
Qui le due sezioni A–B si ripetono, con pochissime varianti. La prima sezione:«Di due figli vivea,
padre beato, | il buon Conte di Luna» presenta versi endecasillabi, alternati a settenari, mentre quelli
che seguono sono quinari doppi: «Abbietta zingara, fosca vegliarda!»: il mutamente ritmico è
riflesso dalla musica in modo evidentissimo. Il compositore avrebbe potuto mascherarlo in una
forma a sviluppo continuo, senza salti: di fronte al testo il musicista ha sempre una gran libertà di
scelta. Qui Verdi intende esaltare proprio lo scatto energetico che si determina nel passaggio tra i
due tipi di versi che, dal punto di vista del contenuto narrativo e dell’impostazione retorica, sono del
tutto affini.
Il canto di Ferrando inizia in modo tranquillo, con una specie di preambolo in cui la melodia
si mette in moto a poco a poco. La voce è accompagnata dal suono cupo di clarinetto e fagotto che
creano intorno alle prime frasi un clima di mistero:
Sul romper dell’aurora un bel mattino
ella dischiude i rai;
e chi trova d’accanto a quel bambino?…
Con quest’ultimo verso, in orchestra c’è una discesa cromatica, fosca e presaga. Tutto il pezzo è punteggiato da
frasi striscianti che sembrano uscire dall’ombra con il loro andamento serpeggiante, oscurissimo. Si entra, poi, nel cuore
dell’argomen-to, e la musica cambia completamente.
Abbietta zingara, fosca vegliarda!...
cingeva i simboli di maliarda!
E sul fanciullo, con viso arcigno,
l’occhio affiggeva torvo, sanguigno!
D’orror compresa è la nutrice!
Acuto un grido all’aura scioglie;
ed ecco, in meno che il labbro il dice,
i servi accorrono in quelle soglie:
e fra minacce, urli e percosse
la rea discacciano, ch’entrarvì osò.
Il racconto si svolge su una musica che si ripete con caratteristiche fisse. La tonalità di mi
minore, il ritmo in 3/4 come di valzer, la sonorità in pianissimo, il canto con appoggiature e quartine
di semicrome staccate su tempo forte, i salti di ottava con accenti sulla nota acuta, suggeriscono un
colorito avventuroso, quasi zingaresco, ma avvolto da un senso di mistero: c’è come un suono
soffocato di nacchere che crepitano nella voce del basso, se il cantante è capace di sgranare le
quartine con scattante precisione. Le figurazioni che si susseguono acquistando tensione, scattano
ritmicamente una dopo l’altra, come una molla che s’avvita, portando avanti il discorso con quella
spinta energetica in cui sta il senso drammatico della scena. Il carattere, tipicamente verdiano, del
pezzo, consiste nel suo progressivo caricarsi d’energia, mentre la sonorità sale da piano a forte e il
coro esplode in fortissimo, con martellante durezza ritmica:
Giusto quei petti sdegno commosse;
l’insana vecchia lo provocò!
La tensione momentaneamente si scarica, per riprendere subito dopo. Ferrando ricomincia. Si
noti come Verdi intona questi versi:
Coverto di pallor, languido, affranto
ei tremava la sera,
il dì traeva in lamentevol pianto...
Ammaliato egli era!
Ecco un caso evidente di parola scenica. Le parole, nel racconto di Ferrando, non si
capiscono, ma l’espressione «ammaliato egli era!» è invece chiarissima, perché mette a fuoco la
situazione insieme ad «abbietta zingara»: due parole sceniche che fissano gli elementi essenziali del
racconto: il tono zingaresco e una fatalistica minaccia che aleggia su tutto il pezzo. Qui l’elemento
zingaresco è oggettivato attraverso il racconto di persone e fatti lontani: vedremo, invece,
l’immediatezza che Verdi gli conferirà nelle grandi scene in cui è protagonista Azucena. Anche la
paura, il terrore, sono sospinti sullo sfondo del racconto, nelle striature sinistre delle frasi
cromatiche che compaiono qua e là; e il fatalismo è annidato nella pulsazione ritmica costante, un
meccanismo che, una volta messosi in modo, sembra difficile frenare.
La regolarità del canto di Ferrando, la sua pulsazione in tre quarti, così ostentata, richiamano un suono
d’organetto, rivelando un’evidente componente popolare portata a livello d’arte, ossia dotata di una forte capacità di
raffigurazione evocativa. La ballata si conclude con un episodio nuovo, in cui il declamato-recitativo di Ferrando è
molto semplice, mentre gli archi continuano a fare disegni misteriosi, di tremoli e note tenute («Brevi e tristi giorni
visse»). Come in un quadro ci possono essere ai margini, nell’oscurità, personaggi non ben identificati, di contorno alla
scena principale, così succede nel Trovatore. Questa introduzione, difatti, non presenta un vero personaggio, ma una
voce che racconta, un ambiente dai contorni ancora imprecisi che prende forma nel connubio tra evocazione zingaresca,
vivacità pittoresca e striature paurose che culminano alla fine, quando Ferrando ricorda la credenza popolare secondo
cui l’anima della strega aleggerebbe, di notte, in varie forme, sul mondo che l’ha condannata. A queste affermazioni il
coro commenta: «È vero, è vero, è vero, è vero», mentre l’orchestra si ostina in un lento disegno cromatico che va
morendo, con sinistro mormorio.
Scatta qui la coda del pezzo, con l’evocazione delle apparizioni notturne della strega appostata sull’orlo dei tetti
in forma di pauroso uccello: upupa, strige, corvo, civetta, gufo. La vide, una notte, un servo che morì di paura nel
momento in cui suonava la mezzanotte. Questo Allegro assai agitato, estremamente piano, conclude l’introduzione in
un crescendo irresistibile di energia ritmica: i martellanti senari doppi sono scanditi dalla diminuzione ritmica su tempo
forte, che aveva già conferito al canto di Ferrando un singolare scatto zingaresco, e che qui raggiunge un effetto di
scossa elettrica nelle terzine che colpiscono la seconda sillaba di ogni senario, facendola rabbrividire: «Sull’óorlo dei
tetti | alcúun l’ha veduta», terzine che fremono come colpi di tamburello nella voce oscura del coro maschile, ridestano
l’atmosfera gitana, le conferiscono un’eccitazione motoria tanto più efficace in quanto soffocata nel pianissimo. Il
profilo della terzina diventa ascendente, con maggior spinta propulsiva, quando entra la voce di Ferrando («Morì di
paura»), mentre il tema accumula energia, tra le parole isolate di Ferrando e i lamenti del coro in gustoso controtempo
(«Morì… Ah!… Morì… Ah!… Morì… Morì!») e, dopo una ripresa da capo, è improvvisamente interrotto dal suono di
una campana: la mezzanotte, evocata nel testo, scocca per davvero, il coro leva un grido di terrore «Ah sia maledetta la
strega infernal!», mentre il tempo accelera in un Poco più mosso, che conclude il brano: il ritmo zingaresco, allora,
ricompare, diminuendo in pianissimo e sbriciolandosi, a poco a poco, in frammenti, mentre i servi accorrono verso la
porta per rifugiarsi e i soldati accorrono in fondo: due mazzate in fortissimo pongono fine allo strisciante, sinistro e
pauroso decrescendo.
Alla fine del pezzo, che ha proprio il carattere di un’aria solistica, con recitativo, tempo di attacco, recitativo e
cabaletta (corale), si è dunque creato un clima di sospensione e di spasmodica attesa. Il sipario si è richiuso, ma, nel
teatro buio, l’atmosfera vibra, ora, dell’elettricità prodotta dall’originalissima invenzione ritmica che percorre tutta
l’Introduzione.
Il Trovatore ci presenta, quindi, subito un esempio di massima individualizzazione di un brano, attraverso
melodia, ritmo, colore vocale ed orchestrale, armonia elementare, appena “sporcata” dagli occasionali cromatismi. Il
pezzo può piacere o non piacere, ma, a differenza di tanti numeri delle opere precedenti, si stampa nella nostra memoria
con forza indelebile. Le sue funzioni, drammatiche e musicali, sono molteplici: possiede tutto il potere d’evocazione
zingaresca e avventurosa presente nel testo; riesce a fondere il tono di lontananza leggendaria del racconto con
l’immediatezza delle reazioni di chi vi assiste; rende presente, nel suono della campana, l’immagine della mezzanotte
che batte, contenuta nel racconto di un fatto avvenuto; crea dunque un senso di ambigua interferenza tra passato e
presente che tornerà, enormemente ingigantito, in altre situazioni dell’opera, come una specifica caratteristica
drammatica e narrativa; e, ancora, opera un distacco dalla scena rappresentata attraverso un ritmo oggettivo, quasi
meccanico, che non vuole essere ironico, ma esibisce, comunque, un’ebbrezza compositiva in senso propriamente
artigianale, di contagiosa, salubre vitalità.
La ballata di Ferrando è statica: tutto succede solo nell’im-maginazione del racconto. La
musica, però, dinamizza la situazione, facendo seguire, uno dopo l’altro, in successione, racconto e
dialogo, melodia chiusa e declamato: uno interrompe l’altro, uno è il contrario dell’altro e, da questa
successione, nasce l’ener-gia che sale fino alla stretta finale, generando nell’ascoltatore un senso di
progressiva, spasmodica attesa in cui consiste il significato drammatico dell’Introduzione. È dunque
un primo esempio di quell’arte della dinamizzazione musicale del pezzo statico di cui Verdi darà,
nel Trovatore, i saggi più geniali di tutta la sua carriera.
N. 2 Cavatina «Ché più t’arresti?»; «Tacea la notte placida» (Leonora, Ines).
La scena si svolge nei «giardini del palazzo. Sulla destra, marmorea scalinata che mette agli appartamenti. La
notte è inoltrata; dense nubi coprono la luna. Leonora ed Ines».
Tra la prima e la seconda scena del Trovatore c’è un cambiamento molto importante di scenografia: Ferrando
aveva evocato i giardini che ora si spalancano alla vista dello spettatore. Verdi era molto attento alle didascalie dei suoi
libretti, scarne ma infallibili nell’indicare la presenza di alcuni oggetti essenziali per definire la situazione. Il giardino,
appena illuminato dalla luna, è bordato sulla destra dalla scalinata marmorea, non di pietra, quindi bianca, in contrasto
con l’atrio grigio della prima scena. Il marmo ha riflessi diversi dalla pietra, con evidente conseguenza sul gioco delle
luci: dall’ambiente militare, duro e aspro, si passa a quello accogliente di un elegante giardino. «Dense nubi coprono la
luna»; non si tratta, dunque, di un cielo stellato, ma di una notte che annuncia cattivo tempo, preannuncio della tempesta
di passioni che si scatenerà di lì a poco.
Per questa scena Verdi scrive musica vaporosa, atmosferica, e sfumata che sarebbe impensabile in un ambiente
chiuso e ben illuminato. Leonora è la dama di compagnia della Principessa d’Aragona, personaggio nobile, non
popolare come quelli che hanno aperto l’opera. Ha voce di soprano, ed entra in scena con la sua confidente, soprano
pure lei. Ines è l’unica che accompagni Leonora nel corso della vicenda. Motivo, questo, di particolare stupore per i
contemporanei che notarono come la protagonista femminile del Trovatore rimanesse, per tutta l’opera, praticamente
sola, elemento in più d’originalità in un libretto controcorrente rispetto alle abitudini del melodramma italiano del primo
Ottocento. Così si esprimeva, infatti, la «Gazzetta Musicale di Milano» il 25 settembre 1853:
Chi è questa giovane innamorata che dispone così liberamente del suo cuore, di sé medesima, senza un
avolo, un padre, uno zio, un parente, un qualcuno che la tuteli? Per poco, anziché un’onesta vereconda fanciulla,
non la si direbbe una spensierata e capricciosa vedovella?2
Con spensierate e capricciose signore e signorine il melodramma italiano del Sette-Ottocento, specialmente
quello buffo, aveva avuto sempre una gran confidenza. È chiaro, dunque, che il recensore della «Gazzetta Musicale» nel
giudicare il comportamento drammatico di Leonora, pensasse ad una tipologia ben precisa nella definizione del
personaggio e di chi le stava intorno. Ma l’originalità delle figure del Trovatore sta, appunto, nella loro indipendenza
dalle tipologie correnti, sentite da Verdi come un ostacolo a quella ricerca d’originalità che s’afferma con prepotenza
nella sua produzione, almeno a partire dal Macbeth. Nascono, così, le strane figure di Manrico, poeta, trovatore, e
condottiero d’eserciti, allevato da una zingara e innamorato di un’aristo-cratica; e, soprattutto, d’Azucena, zingara e
madre, rapita in un affetto traboccante, travagliata da un’ossessione terribile.
Ines comincia la scena con un dialogo da cui s’apprende che Leonora attende, ormai da varie notti, di vedere un
uomo che ha acceso in lei un amore pericoloso (si tratta, infatti, d’un nemico, rappresentante della fazione di Urgel che
combatte gli aragonesi); un giorno, in un torneo, lei stessa ha posto sul suo capo la corona della vittoria. Il cavaliere
2
Cit. in G. RONCAGLIA, Giuseppe Verdi, cit., p. 193.
sconosciuto era vestito di scuro, non aveva stemmi sullo scudo; apparve quel giorno, poi sparì, inghiottito dalla guerra
civile. Il recitativo che racconta questi eventi s’accende d’emozione nell’evocazione del torneo, con tremoli in
orchestra, e sfocia in un Andante, quando Eleonora evoca l’apparizione del guerriero, bello come in un sogno: alla linea
vocale del declamato che s’impregna di melodia, diventando arioso, s’uniscono un trillo dei violini dal suono algido e
dal colore lunare, mentre flauto e clarinetto, alle parole «come d’aurato sogno» tessono un accompagnamento
d’arpeggi. È musica evidentemente basata sul potere suggestivo del timbro degli strumenti che, in questo caso, evoca
l’atmosfera del sogno.
L’aria che segue, «Tacea la notte placida», Andante in 6/8, in bemolle minore, è un grandissimo pezzo di sortita,
una delle arie più belle di Verdi e di tutta la storia dell’opera: «per concentrazione di lirismo poetico – scrive Budden –
‘Tacea la notte placida’ non ha rivali in tutta la musica verdiana, mentre come tour de force di magistrale tornitura
melodica non teme nessun possibile confronto»3.
L’aria di Leonora evoca, come in un sogno, il ricordo del felice momento passato.
Tacea la notte placida,
e bella in ciel sereno,
la luna il viso argenteo
mostrava lieto e pieno;
La musica dapprima rappresenta l’ambiente: tutto è calmo e tranquillo, nella tonalità di La bemolle minore.
Inizia con note ribattute che creano un senso di fissità: come una superficie acquatica liscia e piana nel silenzio della
notte, cui allude il mormorio degli accordi ribattuti in orchestra. Ma la melodia non riposa in se stessa. Crea un clima di
tensione sospesa che culmina nei versi seguenti, « Quando suonar per l’aere | infino allor sì muto», dove succede
qualcosa di nuovo. Verdi scrive animando un poco: il canto ribatte alcune note, come se la melodia scivolasse nel
parlato, per arrestarsi in due note tenute. Il senso d’attesa si fa così molto alto, e tanto più intenso sgorga quindi lo sfogo
melodico dei versi seguenti: «Dolci s’udiro e flebili | gli accordi d’un liuto». Meravigliosa idea melodica che fa salire
cromaticamente la voce da do a fa, mentre l’oscurità del minore si rovescia nella chiarità del la bemolle maggiore e
l’accompagnamento acquista la dolce circolarità di un valzer: gli archi, che si erano limitati a sostenere il canto con
accordi ribattuti, raddoppiano ora la linea vocale, e la sostengono con una calda ondata di suoni. Dalla staticità della
prima fase, dunque, la melodia si è staccata – con espressione – evocando i suoni del liuto che hanno aperto a Leonora
l’universo dell’amore e risuonano, ora, nel suo ricordo. Verdi però non s’attarda ad illustrare il canto del Trovatore e il
pizzico del liuto, come avrebbe potuto fare: rende, invece, l’effetto che il canto ha prodotto nell’animo della ragazza e la
sua melodia restituisce con una freschezza pari all’intensità. Ma non è finita: queste grandi arie verdiane presentano una
successione di continue sorprese. Nei versi seguenti: «E versi melanconici | il trovator cantò» la melodia,
improvvisamente, si impenna, sale fervidamente con un ritmo di breve-lunga, sino al si bemolle acuto cui segue un
momento di riposo. L’aria è quindi ripetuta da capo (è perciò una forma A-A’), a cominciare dalla seconda strofa di
settenari, con alcune varianti su parole che illuminano il significato del pezzo, suggerito dagli ultimi tre versi: «Al core,
al guardo estatico | La terra un ciel sembrò!». Qui la voce, che sale irresistibile sino al do acuto, e l’orchestra che
l’accompagna con un tremolo in poderoso crescendo spiegano la natura dell’amore di Leonora. Questa conclusione ha
qualcosa di possente e di travolgente: l’amore diventa estasi, slancio grandioso, liberatoria esaltazione che, come dicono
i versi di Cammarano, trasforma in paradiso la vita terrena. Per rappresentare questo panico entusiasmo, la melodia
s’impenna in modo tipicamente verdiano: così, l’espres-sione amorosa non si ripiega su se stessa in un segreto
struggimento alla Bellini, ma implica una tensione energetica, una forza morale; quella stessa che porterà Leonora,
addirittura, al sacrificio della vita. Verdi concepisce, dunque, la melodia vocale come dialettica di momenti tra loro
contrastanti, anche sul piano fraseologico: l’aria inizia in modo molto regolare, con frasi di 4+4 battute; ma negli ultimi
due versi di ciascuna strofa, quelli della travolgente salita in crescendo, che quasi suggerisce alla cantante il gesto di
abbracciare tutto il mondo nella sua esaltazione amorosa, la frase melodica si allarga in sette battute (6+1) concluse da
una cadenza che suona come libero sfogo d’entusiasmo.
Da notare un particolare: se nella ripresa il testo è generalmente poco comprensibile perché nascosto, e stirato
sotto la melodia, chiarissima è invece la pronuncia dei versi «In quella ripeteasi | un nome…il nome mio!». È un’altra
parola scenica che coglie il legame tra i due personaggi e spiega il coinvolgimento di Leonora nel fuoco, tipicamente
romantico, dell’amore-passione che va ben al di là del sentimento individuale e acquista un respiro cosmico.
A questo punto, la scena viene interrotta dalla ripresa del dialogo con la confidente Ines che, quasi spaventata
dall’esalta-zione della sua signora, le dice di nutrire un triste presentimento circa la presenza, nella sua vita, di
quell’«uomo arcano» appena evocato: «tenta obliarlo», le raccomanda, senza troppa speranza di essere ascoltata. Questo
dialogo viene svolto nel cosiddetto tempo di mezzo, tipico della forma quadripartita che l’aria italiana assume all’inizio
dell’Ottocento: recitativo–cantabile–tempo di mezzo e cabaletta, dal carattere dinamico, concentrato e fortemente
energetico. È quanto succede nell’intonazione dei settenari seguenti:
Di tale amor che dirsi
3
J.BUDDEN, Le opere di Verdi, cit., vol. II, p. 82.
mal può dalla parola,
d’amor che intendo io sola,
il cor s’innebriò!
Il mio destino compiersi
non può che a lui dappresso…
s’io non vivrò per esso,
per esso io morirò!
Dopo lo straordinario Andante, Verdi prosegue nella rappresentazione dell’amore di Leonora come esaltazione
passionale che trasforma l’esistenza, mutando la terra in cielo: nella cabaletta, Allegro giusto in la bemolle maggiore, la
voce è, infatti, trasformata in uno strumento che gorgheggia in uno scoppiettio di note acrobatiche, da soprano leggero.
Delle parole non si capisce assolutamente nulla: solo contano i vocalizzi, i trilli, le volatine in cui il canto si frastaglia
con brillante leggerezza. Questo è un effetto tipicamente melodrammatico: l’allontanamento dalla parola e la consegna
totale alle possibilità espressive della musica che, nella sua leggerezza, rende qui la giovinezza del personaggio,
l’ebbrezza della ragazza innamorata. Tutto dev’essere quindi, nell’esecuzione, estremamente lieve, mordente e vitale:
come l’aria, anche la cabaletta, secondo le prescrizioni di Verdi, va cantata quasi tutta in pianissimo.
Notiamo, qui, l’insistente presenza di un ritmo giambico di breve-lunga: ta-tà, che già avevamo sentito in alcuni
passi dell’aria precedente (proprio nella sezione conclusiva della melodia che, sulla pulsazione di breve-lunga, saliva
«dalla terra al cielo»). Il giambo, nel suo scatto, ha un carattere fortemente propulsivo, molto energico e può essere
solenne, se eseguito lento, oppure nervoso e sferzante in maggiore velocità. Proprio per la presenza dominante di questo
ritmo, la cabaletta dà un’ulteriore spinta energetica a quello che abbiamo sentito prima, e conclude la scena con una
serie di fuochi d’artificio vocali che, lungi dall’essere puramente decorativi, esprimono il sorriso di Leonora persa nella
fantasticheria amorosa, lo sguardo che brilla, l’entusiasmo che infiamma la voce e brucia le parole.
Si manifesta dunque nella scena di Leonora un atteggiamento espressivo che caratterizza ogni personaggio del
Trovatore. Nella Traviata Verdi intende costruire un personaggio che si evolve nel tempo attraverso un itinerario di
trasformazione. Violetta, alla fine dell’opera, è un’altra persona rispetto a quella che abbiamo conosciuto all’inizio.
Così, Rigoletto vive una vicenda che lo muta interiormente. I personaggi del Trovatore, invece, non si trasformano, ma
ogni situazione ne mostra sentimenti diversi, come una statua che, colpita da fasci di luce provenienti, di volta in volta,
da varie angolature, rivela tratti differenti e inattesi, pur restando immutata. A differenza di Rigoletto e della Traviata,
dove il tempo vive, pulsa, scorre velocissimo o s’arresta in rapporto allo stato psicologico dei personaggi, la
drammaturgia del Trovatore sembra uscire dal tempo, perché fondata sull’esplo-sione di momenti passionali isolati da
un continuum psicologico e cronologico. Naturalmente, quest’atteggiamento di Verdi nei confronti del suo dramma
porta a soluzioni diverse, sul piano stilistico ed espressivo, rispetto a Rigoletto e alla Traviata, specie per quanto
riguarda il rapporto tra musica e parola. Abbiamo già notato in queste prime scene dell’opera che la parola viene
sbriciolata nella musica; non si sente, non si percepisce, perché l’idea musicale è più forte di ciò che esprime la parola
col suo significante e il suo significato. Quest’assoluta prevalenza dell’idea musicale serve per dare all’espressione
passionale la sua massima forza. Nel Rigoletto e nella Traviata, in cui l’interesse di Verdi s’appunta sulla
trasformazione psicologica dei protagonisti, la melodia sembra sovente estratta dal suono stesso della parola e da quello
che potremmo chiamare il tono della recitazione. La prova sta nel fatto che, quando rammentiamo le melodie della
Traviata, ci vengono in mente le parole, mentre è impossibile ricordare quelle del Trovatore perché, in realtà, non le
abbiamo mai percepite. Così, in Rigoletto, il declamato è fatto oggetto di una ricerca costante e audacemente
innovativa; nel Trovatore, in pratica, esso non esiste, e i recitativi sono sbrigati con voluto, necessario disinteresse.
N. 3 Scena «Tace la notte», Romanza «Deserto sulla terra» e Terzetto «Qual voce… Ah dalle tenebre» (Leonora,
Manrico, Conte).
Dopo l’aria, Leonora si ritira con Ines, e la scena rimane vuota. Nella perdurante oscurità, arriva il Conte di
Luna, baritono, gentiluomo aragonese di cui Ferrando parlava nella prima scena: anche stanotte egli s’apposta sotto i
veroni della sua dama (si noti la logica concatenazione e la stringente sintesi narrativa del libretto). L’entrata del Conte,
aperta da disegni striscianti in orchestra, presenta un declamato abbastanza melodico che allude all’alta temperatura
erotico-passionale del personaggio, e all’«a-morosa fiamma» che, in lui, «arde ogni fibra». Nella successione degli
accordi iniziali si vede l’ombra oscura del Conte che si muove sulla scena; la musica non è straordinaria, ma
efficacissima per rendere l’atmosfera notturna e furtiva della situazione. Un tremolo in orchestra rende eccitata
l’invocazione a Leonora, uno sbocco melodico pieno di slancio traduce «Ah l’amorosa fiamma», con un trasporto
improvviso. Dunque, quando l’emozione sale, la melodia s’inarca, affiora e afferma i suoi diritti; finché, nei casi
estremi d’esaltazione emotiva, la musica giunge a distruggere del tutto la parola. Tra musica e parola si crea, perciò, una
tensione continuamente elastica, utile al compositore teatrale – non solo a Verdi – per rappresentare, col canto, il variare
degli stati d’animo.
Passione amorosa e collera animano, già dalla prima apparizione, la figura del Conte di Luna che rimarrà, per
tutta l’opera, lacerato da questo contrasto interiore. Improvvisamente, dalla profondità notturna del giardino, salgono i
suoni di un’arpa: «Il trovator! Io fremo!» commenta il Conte che riconosce il liuto suonato dal rivale. Ignaro di essere
ascoltato, Manrico, tenore, canta quei versi malinconici di cui parlava Leonora nella sua aria: come la campana della
mezzanotte nel racconto di Ferrando, anche la voce del Trovatore si materializza, quindi, dopo essere stata evocata:
perdura dunque la tecnica narrativa di tradurre l’immagine in fenomeno, in una ricorrente oscillazione di assenzapresenza, ricordo-attualità, fantasia-realtà che contribuisce, in modo determinante, a fissare il clima espressivo e il
fervore romantico del Trovatore.
Deserto sulla terra,
col rio destino in guerra,
è sola speme un cor
al Trovator!
Questi i versi che Manrico canta fuori scena, esprimendo solitudine e malinconia: sola speranza per vincerle è
possedere un cuore fedele che renderebbe il Trovatore – tipico eroe romantico, esule, ribelle, vagabondo, libero ma solo
– più fortunato di un re. Il liuto che accompagna il canto manca in orchestra: al suo posto sentiamo il suono di un’arpa
che crea un effetto particolarmente soffuso, sfumato e impreciso; il liuto, d’altronde, nell’Ottocento, era uno strumento
completamente dimenticato.
La romanza di Manrico, tenore, ha una forma semplicissima: due strofe riprese tali e quali,
senza varianti. La melodia, apparentemente semplice, è in realtà molto elaborata, per dare
l’impressione di questa solitudine malinconica – Manrico è «a morte proscritto», come dirà, poco
dopo, il Conte di Luna – e della tensione emozionale che la caratterizza. All’inizio suona un po’
come il rintocco di una campana negli intervalli mi bemolle-re su ritmo puntato; poi, questo din-don
lascia spazio alla rappresentazione musicale della speranza. Su «è sola speme un cor» il
malinconico mi bemolle minore si rovescia, difatti, in mi maggiore, come una luce che s’accende
nell’oscurità: la melodia sembra arenarsi in note ribattute (procedimento già visto nell’aria di
Leonora) ma, dopo aver saltellato sul posto, prende lo slancio per una fervida salita verso l’alto e la
conclusione a tutta forza con trillo finale: «un cor al Trovator!». All’ascolto sembra una cosa
semplicissima, popolare: lo è, perché la melodia è regolare, scandita dagli accordi dell’arpa-liuto, e
caratterizzata da un andamento tipico di canzone; ma c’è una grande finezza d’articolazione interna
che mostra quante sfumature espressive Verdi riesca ad ottenere attraverso il percorso d’una
semplice melodia accompagnata. Lo slancio verso l’alto di melodie liriche e struggenti accomuna,
dunque, il canto di Leonora e di Manrico. Questo è l’affinità elettiva che li lega: hanno un modo
molto simile d’esprimere il loro anelito. Che cosa ha fatto innamorare Eleonora, quando ha sentito
cantare per la prima volta il Trovatore? Evidentemente, lo slancio vitale della voce verso l’alto, che
lei riproduceva nel suo canto, diverso da quello di Manrico solo per poche note, e simile per
comportamento vocale. Ovviamente, di tutto questo, l’ascoltatore non s’avvede sul piano razionale.
Ce ne accorgiamo noi, che osserviamo lo spartito e notiamo queste corrispondenze profonde che
legano i due personaggi e determinano la coerenza della caratterizzazione individuale. L’effetto
prodotto da una simile logica compositiva fa la differenza tra un’opera mediocre e un capolavoro, in
cui tutto si collega con salda coerenza strutturale.
La voce di Manrico proviene dalla profondità notturna del giardino, arriva di lontano, sfumata dalla prospettiva.
La profondità dello spazio scenico, incarnata dalla musica, è dunque essenziale per definire questa situazione. Verdi,
infatti, non si limita a rappresentare il Conte di Luna in primo piano e Manrico sullo sfondo. Sovrappone le due voci
con i commenti del Conte: «Il Trovator…io fremo!…Oh detti!… Oh gelosia». Così, quando si sente la voce lontana, lo
spettatore è portato a dimenticare che c’è anche un primo piano, ma, non appena il Conte fa il suo commento, la nostra
attenzione rimbalza al proscenio, prima di essere nuovamente attratta da ciò che si sente ma non si vede. La musica
funziona quindi come una macchina da presa che inquadra prima il Conte in primo piano, poi lo sfondo, poi di nuovo il
personaggio al proscenio, e così via, in una continua mobilità di prospettive, tipica del teatro musicale.
Il canto del trovatore viene spazzato via da una figurazione rapida che indica il mutare della situazione. Si va
verso il terzetto dell’incontro tra Manrico, Leonora ed il Conte. Nel frattempo, «la luna esce dalle nuvole e lascia
scorgere una persona di cui una visiera nasconde il volto». Leonora esce dal palazzo perché ha sentito la voce del
Trovatore e si butta nelle braccia del Conte, credendo che sia Manrico. Le tenebre non permettono il riconoscimento
immediato, ma, quando l’agnizione avviene, scoppia la situazione che porta al «duello», titolo del primo atto.
La quarta scena è brevissima. Leonora, correndo verso il conte, grida, con una splendida
effusione di melodia:
Leonora Anima mia!
Conte
(Che far?)
Più dell’usato
È tarda l’ora!… io ne contai gli istanti
Co’ palpiti del core!... Alfin ti guida
Pietoso amor tra queste braccia...
Manrico
Infida!…
Leonora
Questo è uno dei rari passi in cui Verdi, nel Trovatore, sfrutta la tecnica del declamato
melodico. È una frase molto appassionata, e rappresenta lo slancio di Leonora verso Manrico con
grande efficacia.
Segue il Terzetto diviso in due parti: A) Allegro agitato, 3/4, sol maggiore, su versi settenari
(«Qual voce! Ah dalla tenebra»); B) Allegro assai mosso 4/4 a cappella, re bemolle minore, su versi
ottonari («Di geloso amor sprezzato»). In questo pezzo Verdi interpreta non tanto lo stato d’animo
individuale dei singoli personaggi, quanto la concitazione generale del momento. Le voci cantano,
in pratica, solo dei frammenti di declamato, molto brevi, senza melodia, con un profondo senso
d’affanno nel martellamento delle sillabe. L’elemento collegante sta nell’orchestra ed è costituito
dal ritmo giambico (breve-lunga) disseminato in tutto il pezzo e collegato con disegni melodici che
ascendono freneticamente, pulsando in balzi nervosi e leggeri.
La frequenza degli scatti diviene massima nella frase del Conte:
Tu!... Come!
Insano! Temerario!
D’Urgel seguace, a morte
proscritto, ardisci a volgerti
a queste regie porte?
Qui lo scatto sembra quasi impazzire, è come un mulinello che gira sempre più vorticoso e
che, ad un certo punto, si blocca in accordi molto forti, che scuotono tutta l’orchestra. Il
melodramma italiano dall’Ottocento ha appreso da Mozart e da Rossini l’arte di ripetere un
elemento, facendolo passare in diversi contesti tematici e tonalità, in modo da rinnovarne
continuamente l’effetto, come avviene nello sviluppo della forma sonata. Questo produce un senso
di continuità e di trasformazione insieme: coglie la permanenza, ma insieme la tensione interna che
anima la situazione. Qui è il ritmo giambico che viene sviluppato, ripetuto in varie tonalità e
disposizioni strumentali, con un effetto di straordinario impatto energetico: folle è la concitazione
della prima parte del terzetto, ma non ancora tale da non poter aumentare nella seconda. Da notare
un fatto curioso: la prima sezione del terzetto è drammaticamente statica; tranne una brevissima
sfida scambiata tra i contendenti maschi, non succede nulla. La musica la trasforma, invece,
imprevedibilmente, in qualche cosa di esplosivo, che scorre con frenetica velocità.
Ancora più statica è la seconda parte del terzetto, in cui la situazione si blocca completamente.
Ma il compositore riesce ad intensificare ulteriormente la tensione. In che modo? Spacca l’azione
musicale in due gruppi, contrapponendoli. Da una parte ci sono Leonora e Manrico, dall’altra il
Conte. Il duello, che dà il titolo all’atto, non viene rappresentato, si suppone avvenga fuori scena. Il
vero duello, che Verdi mette in scena, è, invece, di tipo musicale. Comincia il Conte con una frase
che comprende tutta la sua battuta:
Di geloso amor sprezzato
arde in me tremendo il fuoco!
il tuo sangue, o sciagurato,
ad estinguerlo fia poco!…
(a Leonora)
Dirgli, o folle,… “io t’amo…”, ardisti! ...
ei più vivere non può.
Un accento proferisti
che a morir lo condannò!
Il profilo delle frasi dà il senso dell’aggressività, dello slancio, gestualmente qualificato:
cantando la sua melodia, scolpita con un colpo deciso nella nota lunga che apre ogni frase, è come
se il Conte sfoderasse una spada e andasse contro gli altri due, sfidandoli. Leonora e Manrico
rispondono con una specie di fuoco di sbarramento («Un istante almen dia loco | il tuo sdegno alla
ragione» «Del superbo vana è l’ira | ei cadrà da me trafitto»): il ritmo, martellante, fa perno su
nuclei di tre note (due crome e una minima) con accento di lunga–breve–lunga (tà-ta-tà), come
qualche cosa che inciampa, impuntandosi con ostinazione. Nella parte del Conte («Di geloso amor
sprezzato») pulsa il ritmo anapestico (ta-ta-tà), molto usato nella musica per indicare momenti di
aggressività. Il ritmo di Manrico e Leonora è invece anfimacro (lunga-breve-lunga), molto meno
comune dell’altro: applicato, alle parole, le contorce come una fiamma che deforma gli oggetti;
l’effetto è sommamente innaturale, ma efficace nel rendere lo sconvolgimento passionale dei due
personaggi. Si può quindi parlare di duello tra due ritmi diversi, uno aggressivo, e un altro
oppositivo, duello musicale, perché in realtà i tre sono fermi e cantano i loro versi, sovrapponendosi
in polifonia. I due episodi – proposta del Conte e risposta di Manrico e Leonora – sono ripetuti e
acquistano ulteriore energia, anche perché il Conte, la seconda volta, si sovrappone alle due voci
con un basso rampante di semiminime. Verdi, come Mozart e più di Rossini, evita di solito le
ripetizioni testuali: quando le fa, ne è ben consapevole. Altrimenti, preferisce modificare la ripresa
con effetti d’intensifi-cazione, in questo passo evidenti.
La situazione drammatica del terzetto è dunque assolutamente statica, riflessa nella
punteggiatura del testo che è disseminata, qui e altrove, di punti esclamativi, interrogativi, e di una
miriade di puntini di sospensione. Questo rispecchia un preciso atteggiamento retorico: il
meravigliarsi, l’enfatizzare situazioni che sono tutti momenti culminanti, e non nascono da un
graduale evolversi dei fatti.
È difficile dare un contenuto psicologico a questa zuffa musicale che oppone il Conte da una
parte, Leonora e Manrico dall’altra. Ma c’è un’immagine che illumina il significato del duello
musicale, espressa dai versi di Leonora:
Io, sol io, di tanto foco
son, pur troppo, la cagione!
Leonora non dice: «sono io la causa di questo equivoco, di questa inimicizia, di questo duello» ma «di questo
foco». Il ritmo giambico che si diffonde, incendiando tutta la prima parte del terzetto, è una scintilla scoppiettante, che
crepita come una fiamma. L’avevamo già incontrato nella cabaletta precedente, rappresentazione dell’amore passionale
che brucia l’anima di Leonora. Dunque, alla fine di questa prima parte, già possiamo renderci conto di come l’immagine
del fuoco assuma un’importanza centrale. Essa ricorre, infatti, con strana frequenza nel testo del primo atto. Ferrando
canta: «Fu presa, e al rogo fu condannata»; Ines: «Perigliosa fiamma | tu nutri!.., oh come, dove | la primiera favilla | in
te s’apprese?»; Il Conte: «Ah!... l’amorosa fiamma | m’arde d’ogni fibra!»; e, nel terzetto: «Di geloso amor spezzato |
Arde in me tremendo il foco!», quando Leonora risponde nel modo che s’è detto. La ricorrenza di questa immagine, già
nel primo atto, non può dunque essere casuale, tanto più se consideriamo quale spazio occuperà nell’immaginario
dell’atto successivo la cui prima scena si apre su di un immenso fuoco acceso.
Così si conclude il primo atto, con la sua atmosfera scura, cupa, ferrigna, anche dal
punto di vista scenografico. Questo atto, notturno, è dominato dalla presenza di gente
armata: inizia con le sentinelle, e si conclude con un duello, in cui i personaggi sfoderano le
armi. Al centro, invece, con un effetto di meraviglioso contrasto, prende posto il
morbidissimo quadro notturno del giardino, con l’aria di Leonora e il canto di Manrico che
attraversano il giardino con un’effusione melodica opposta alla forza ritmica che domina
l’Introduzione e il Terzetto: è musica d’aria, vaporosa e fluttuante, come quella di Ferrando
e quella del Terzetto è musica di terra, che scivola e inciampa continuamente nel ritmo,
come attratta da un forza di gravità che le impedisce di prendere il volo. La costruzione è
perfetta, come i rapporti espressivi tra le varie parti del dramma.