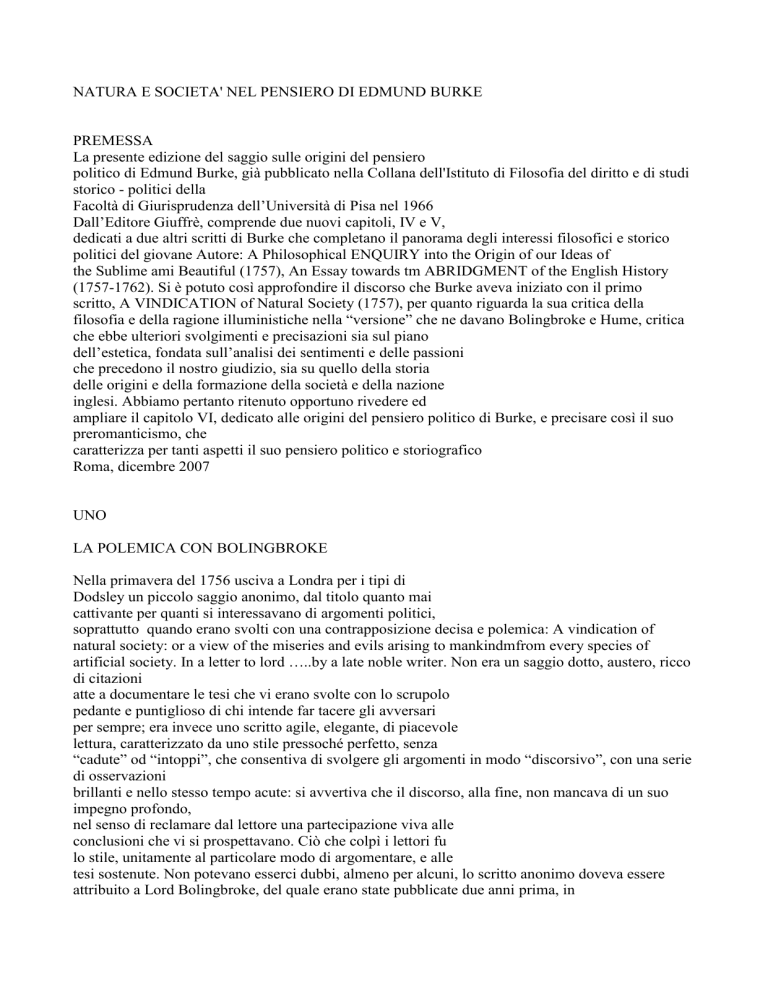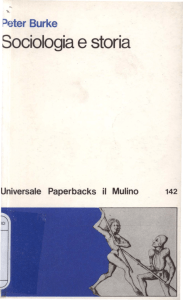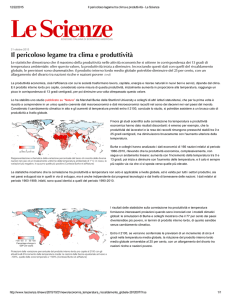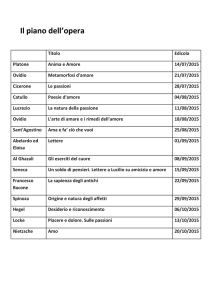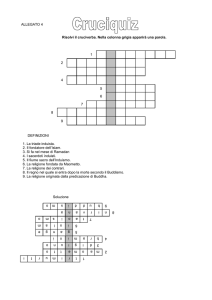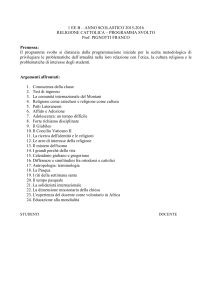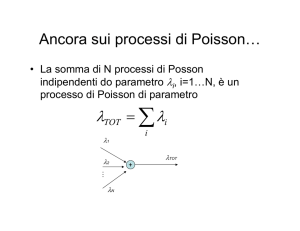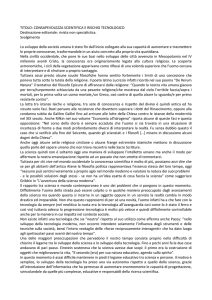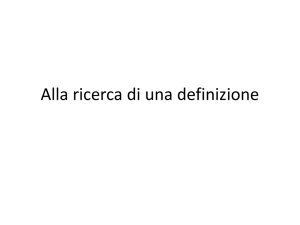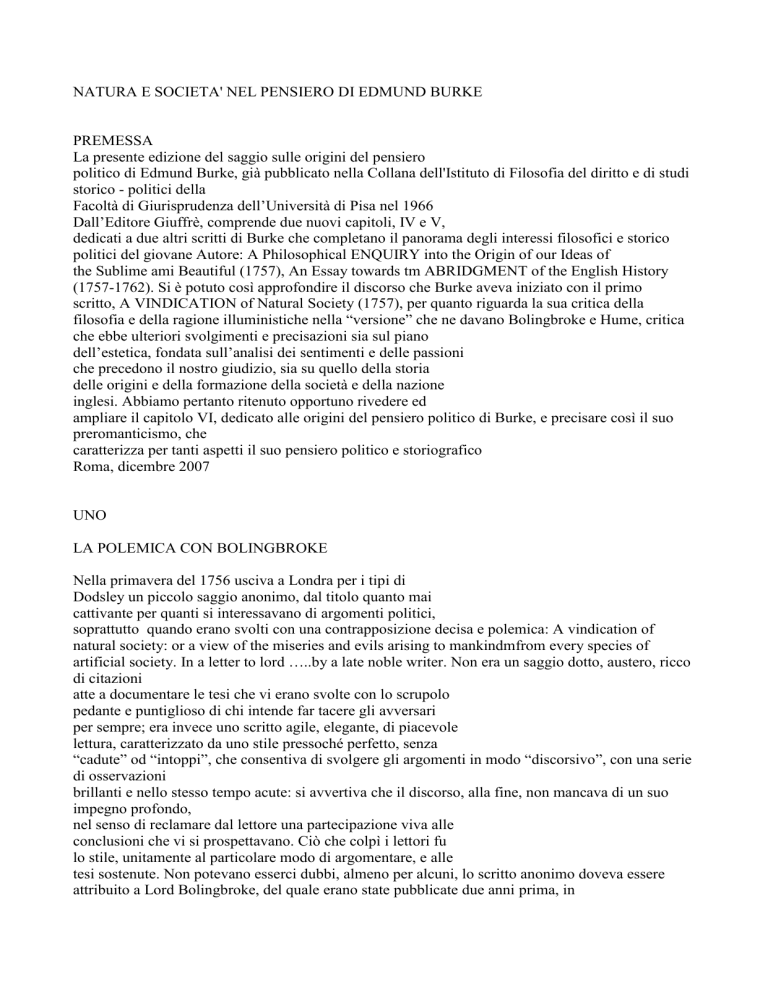
NATURA E SOCIETA' NEL PENSIERO DI EDMUND BURKE
PREMESSA
La presente edizione del saggio sulle origini del pensiero
politico di Edmund Burke, già pubblicato nella Collana dell'Istituto di Filosofia del diritto e di studi
storico - politici della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa nel 1966
Dall’Editore Giuffrè, comprende due nuovi capitoli, IV e V,
dedicati a due altri scritti di Burke che completano il panorama degli interessi filosofici e storico
politici del giovane Autore: A Philosophical ENQUIRY into the Origin of our Ideas of
the Sublime ami Beautiful (1757), An Essay towards tm ABRIDGMENT of the English History
(1757-1762). Si è potuto così approfondire il discorso che Burke aveva iniziato con il primo
scritto, A VINDICATION of Natural Society (1757), per quanto riguarda la sua critica della
filosofia e della ragione illuministiche nella “versione” che ne davano Bolingbroke e Hume, critica
che ebbe ulteriori svolgimenti e precisazioni sia sul piano
dell’estetica, fondata sull’analisi dei sentimenti e delle passioni
che precedono il nostro giudizio, sia su quello della storia
delle origini e della formazione della società e della nazione
inglesi. Abbiamo pertanto ritenuto opportuno rivedere ed
ampliare il capitolo VI, dedicato alle origini del pensiero politico di Burke, e precisare così il suo
preromanticismo, che
caratterizza per tanti aspetti il suo pensiero politico e storiografico
Roma, dicembre 2007
UNO
LA POLEMICA CON BOLINGBROKE
Nella primavera del 1756 usciva a Londra per i tipi di
Dodsley un piccolo saggio anonimo, dal titolo quanto mai
cattivante per quanti si interessavano di argomenti politici,
soprattutto quando erano svolti con una contrapposizione decisa e polemica: A vindication of
natural society: or a view of the miseries and evils arising to mankindmfrom every species of
artificial society. In a letter to lord …..by a late noble writer. Non era un saggio dotto, austero, ricco
di citazioni
atte a documentare le tesi che vi erano svolte con lo scrupolo
pedante e puntiglioso di chi intende far tacere gli avversari
per sempre; era invece uno scritto agile, elegante, di piacevole
lettura, caratterizzato da uno stile pressoché perfetto, senza
“cadute” od “intoppi”, che consentiva di svolgere gli argomenti in modo “discorsivo”, con una serie
di osservazioni
brillanti e nello stesso tempo acute: si avvertiva che il discorso, alla fine, non mancava di un suo
impegno profondo,
nel senso di reclamare dal lettore una partecipazione viva alle
conclusioni che vi si prospettavano. Ciò che colpì i lettori fu
lo stile, unitamente al particolare modo di argomentare, e alle
tesi sostenute. Non potevano esserci dubbi, almeno per alcuni, lo scritto anonimo doveva essere
attribuito a Lord Bolingbroke, del quale erano state pubblicate due anni prima, in
una “autorevole” edizione - quattro volumi in ottavo grande - le opere: evidentemente questo scritto
doveva essere sfuggito al Mallet che aveva per l’appunto curato l’edizione. L’episodio non mancò
naturalmente di suscitare perplessità e un
certo risentimento dello stesso Mallet e degli amici del Bolingbroke che avevano promosso
l’edizione delle sue opere,
tanto che, a quanto si ricorda, sentirono il bisogno di recarsi
dal Dodsley per fargli esplicita richiesta della “provenienza”
dello scritto anonimo, che a quanto risultava loro non era
compreso fra le carte del Bolingbroke.
Un vero e proprio “caso letterario” che contribuì naturalmente al successo, alla diffusione del
saggio anonimo e che si
risolse nell'anno successivo quando Dodsley pubblicò la seconda edizione: questa volta, però,
compariva il nome dell’autore, un nome sconosciuto negli ambienti letterari, mondani,
politici di Londra, un giovane irlandese, Edmund Burke.
La of natura society è il primo scritto, di un
certo impegno filosofico - politico, con il quale Burke debuttò
nel mondo politico e letterario londinese: esso sostanzialmente conclude un periodo della sua vita
caratterizzato dalla
incertezza di operare una scelta definitiva fra la sua viva vocazione di scrittore, appassionato di
problemi letterari, estetici,
filosofici e politici, in quella dimensione propria della cultura
illuministica, specialmente inglese, nella quale l’impegno “letterario” è vissuto in stretta
connessione con quello civile o più
propriamente politico, e la professione legale alla quale lo voleva destinato la volontà paterna.
Aveva studiato dal 1744 al 1750 al Trinity College di Dublino, l'università che tanto lustro doveva
ricevere dall'insegnamento di Berkeley ed era stato subito notato per la sua
passione per i classici, per la sua intelligenza viva, per la sua
parola facile, brillante, per le sue qualità oratorie, che dovevano poi renderlo famoso. I suoi interessi
culturali avevano un
chiaro orientamento umanistico-letterario che per molti
aspetti ispira e sollecita i suoi studi di storia, di filosofia e di
politica, nei quali assumono particolare rilievo gli argomenti e
le questioni dì carattere etico-religioso. A quanto è dato sapere, non amava troppo gli studi di logica
che molto probabilmente, dato il suo “temperan1ento" intellettuale, gli sembravano volti a
mortificare la spontaneità e la discorsività
del ragionamento.
Nel 1750 il padre lo aveva mandato a Londra perché iniziasse gli studi di diritto per dedicarsi poi
alla carriera forense,
ma la nuova esperienza di studio al Middle Temple, dovette
ben presto convincerlo che fra il diritto colto nella sua viva
dimensione storico-politica e il diritto dei giurisperiti, dei giudici, degli avvocati, con tutto il
complicato corredo di formule, di principi, d'eccezioni, intercorreva una profonda differenza e che il
secondo si riduceva, infine, ad un arido tecnicismo al quale si ribellava il suo temperamento, e
finiva col
contrastare con la sua precedente formazione spirituale e culturale. Il suo epistolario testimonia le
sue “perplessità”, il
contrasto fra le sue vocazioni e il desiderio di rispettare la volontà paterna. Nell’aprile del 1751
scriveva al suo caro amico
Shackleton: “ la mia salute è tollerabile, ringrazio Dio, i miei studi anche nello stesso modo, e la
mia situazione non è spiacevole”; ed ancora nell’agosto del 1751 dava notizia all'amico
dei suoi studi legali, con poco entusiasmo, e con la magra
consolazione che, alla fin fine, un mediocre “legale” vale,
nella considerazione sociale, almeno tre volte un mediocre
poeta; ma doveva constatare dì fare scarsi progressi nello studio del diritto, che certamente non
presentava alcuna difficoltà per coloro che erano disponibili ad apprenderlo, ma non
per quelli che non ne avevano alcuna intenzione.
Molto probabilmente fra il 1753-1754 Burke dovette abbandonare gli studi legali per cominciare ad
interessarsi, con
una certa continuità, di questioni letterarie in modo da poter
iniziare la carriera del pubblicista che riteneva più confacente
alle sue attitudini ed alle sue vocazioni culturali. La religione
è indubbiamente un costante punto dì riferimento nella formazione culturale del giovane Burke ed i
problemi che comporta per quanto riguarda la convivenza umana costituiscono
le premesse di fondo dei suoi interessi e dei suoi scritti di
estetica, di filosofia, di storia e di politica. La religione era un
connotato essenziale della sua tradizione di famiglia: suo padre Richard era un cattolico che si era
convertito all’Anglicanesimo per poter continuare nella professione forense; la madre era rimasta
cattolica e vi aveva educato la figlia. Il suocero
di Burke era anch’egli cattolico, ed aveva sposato una fervente
presbiteriana, che aveva educato la figlia al protestantesimo.
Burke, allevato nella confessione religiosa paterna, visse
nella sua giovinezza e nella sua maturità, soprattutto per i
vincoli parentali, un’esperienza religiosa caratterizzata da un
impegno al dialogo interconfessionale sia nel protestantesimo
sia fra questo e il cattolicesimo. E forse proprio questa esperienza di divisione religiosa, pur nella
comune convinzione
cristiana di una sola fede e di un solo battesimo, che induce
Burke a confessare al suo amico Shackleton che egli è ben
lungi dal ritenere che quanti non professano la sua confessione religiosa sono esclusi dalla salvezza
e che di conseguenza si viene presi dalla “malinconia” quando constatiamo
la diversità delle sètte e delle opinioni che sussistono fra i cristiani: gli uomini non dovrebbero per
questioni sostanzialmente poco rilevanti commettere il grande crimine di spezzare l'unità della
Chiesa, Certo, nota Burke, se lo spirito di
umiltà, che è la più grande virtù cristiana, fosse effettivamente
la nostra guida, le nostre divisioni religiose sarebbero molto
poche.
Questo forte sentimento dell’unità della fede e della
Chiesa fu molto probabilmente all’origine della simpatia per
il cattolicesimo (tanto che in quegli anni si parlò fra gli amici
di una sua conversione) e si manifestò appieno nell’impegno
con cui Burke sostenne dal 1760 la causa dell’abolizione delle
leggi discriminatorie nei confronti dei cattolici irlandesi che
negavano loro essenziali diritti civili e politici: come è stato
giustamente rilevato, Burke non fu un convertito al cattolicesimo, ma alla causa del cattolicesimo
irlandese. Nei Fragmems of Tract on the Popery Laws del 1765, in cui illustra i criteri
per la riforma delle leggi limitative delle libertà dei cattolici
irlandesi, ricorda « che questa Religione che è così perseguitata nei suoi membri, è l'antica religione
del Paese, e una voltala Religione riconosciuta dallo Stato; è proprio la stessa che
ricevette per secoli l'approvazione e la sanzione della Legge".
Per il giovane Burke si trattava di intendere il valore, il significato e il ruolo della religione << in
these enlightmed times », in cui, come avrebbe precisato negli stessi Tracts, tutti
i benpensanti rifiutavano ogni forma di persecuzione religiosa:
« nella proporzione in cui il genere umano è diventato illuminato l'idea della persecuzione religiosa,
per qualsiasi motivo,
è stata pressoché universalmente screditata dai benpensanti ».
Nelle note di Burke che si riferiscono al periodo dell’organico approfondimento dei suoi interessi
culturali dopo il
Trinity College, 1750-1756, alcune riguardano la religione e i
rapporti fra filosofia e cultura, svolte in modo organico per
più pagine sì da darci sicure indicazioni sulle convinzioni che
aveva tratto dai suoi studi su tali argomenti.
Due note si riferiscono alle caratteristiche essenziali della
religione, per precisarne l’intrinseca validità ed autonomia,
che rinviano ad un'esperienza “originaria” e fondante la morale e la personalità dell'uomo contro
ogni concezione “riduzionistica” della stessa religione, che la commisura e la accetta
sulla base del “metro razionale” o della utilità sociale. La
prima annotazione si riferisce al problema dei rapporti fra religione e politica, di particolare
interesse per quanto riguarda
le motivazioni della critica di Burke all’illuminismo di Bolingbroke, di Voltaire, di Htune, e dei
cosiddetti Free-thinkers,
che sottolineavano la connotazione essenzialmente politica
della religione come un mero strumento di governo, basato
sulle superstizioni, sulla credulità, sui timori e le paure delle plebi.
Il titolo della nota è molto significativo: “Religion of no
efficay as considered as a State engine". Per Burke la religione
non può essere considerata “una macchina dello Stato”, non
può essere ridotta ad un “mezzo” per consolidare l’unità e la
coesione sociale e per rafforzare il prestigio delle istituzioni: la
religione non può essere considerata ed usata come un comodo “strumentum” senza snaturarla e
misconoscerne la
vera essenza. Occorre riconoscere alla religione un proprio
autonomo “ambito”, definito dalla convinzione che Dio sovrintende alle nostre azioni per
remunerarle o condannarle.
La religione si rivolge agli individui e alla loro coscienza e per
il loro tramite ha un’influenza sulla società; solo la legge civile
può esercitare ur1’azione diretta sulla società, la religione agisce invece in modo del tutto indiretto.
Se consideriamo la religione non per come opera secondo i propri principi ma solamente come una
“sorta di supplemento della legge civile”,
cercando di trasformarla, contro la sua natura, in una sorta di
“macchina politica”, finiamo per privarla di ogni efficacia politica.
Ed è proprio in occasione di queste considerazioni sul valore che dobbiamo riconoscere alla
religione che Burke fa un’altra osservazione di particolare rilievo per il suo orientamento critico nei
confronti dei poteri “sovrani" si sarebbe tentati di dire “assoluti” - che l'illuminismo di Bolingbroke
le di Hume riconosceva alla ragione nei confronti della religione. Questa, osserva il Nostro, non può
essere “ricondotta” nei limiti della ragione, né essere accettata solamente se “avvolta" nel “mantello
della ragione" dato che la sola ragione non riesce ad intendere il nucleo essenziale, il proprio della
religione, che si riferisce a fini meta empirci, ultraterreni: « Pertanto come noi , restringiamo i fini
della Religione a questo mondo, naturalmente annulliamo ogni sua operazione,
tutte dipendenti dalla considerazione di un altro (mondo) ?
Dio, secondo Burke, ha concesso al genere umano un altro principio attivo di conoscenza,
“l’entusiasmo”, che supplisce le deficienze della ragione e che si “avvicina” alla « grande
e comprensiva Ragione nei suoi effetti, sebbene non secondo
il modo di operare della Ragione comune; che lavora con argomenti determinati, precisi, comuni e
perciò plausibili ».
Certo “l'entusiasmo” spesso ci induce in errore: ma lo stesso
accade', bisogna riconoscerlo, anche per la ragione: ma questa
è la condizione della nostra natura, né noi possiamo modificarla. Occorre rilevare inoltre che la
nostra azione è veramente completa solamente quando noi agiamo con tutti i poteri della nostra
anima, allorché noi ci serviamo dell’“entusiasmo” per elevare ed ampliare il nostro ragionamento e
della nostra ragione per frenare gli slanci del nostro “entusiasmo” .
La natura dell'uomo è caratterizzata, secondo Burke, dall’attività: << Dio ha fatto tutte le sue
creature attive ed in modo
particolare l’uomo >>, ed ha pertanto un particolare rilievo
l'impegno dell'uomo nel superare le difficoltà ed i pericoli che
sono spesso connessi all’adempimento delle azioni richieste
dai nostri doveri, azioni spesso condizionate dall’opinione e
dalla conoscenza che abbiamo delle cose. Solamente una
“forte” e fondata opinione. è in grado di promuovere una
azione risoluta: il dubbio e lo scetticismo non si addicono all'uomo che intende agire, che deve
essere invece risoluto e
positivo. Nessuna azione, conclude Burke, ma solamente deboli e imperfetti tentativi di agire
possono scaturire da concezioni dubbiose e da incerti principi.
Di qui l’importanza di una analisi del sentimento religioso, dei principi, dei doveri in cui esso si
esprime cui Burke
dedica una lunga nota per precisare il nesso sussistente con
l'attività e quindi la moralità dell’uomo e la sua intrinseca ragionevolezza. La religione si riferisce al
rapporto fra l'uomo e
Dio riconosciuto “creatore” e principio di tutte le cose, un
rapporto di dipendenza dall’Essere Superiore, che implica il
dovere di riconoscenza e di accettazione della sua volontà.
In questo rapporto Burke si sofferma sul rilievo centrale
che ha il sentimento nella formulazione dei precetti religiosi,
che vanno considerati nella prospettiva dell’analisi dei modi
con cui l’avvertenza e la nozione di Dio vengono vissute dall’uomo. Gli uomini secondo Burke
sono indotti dalla loro natura a “misurare” i loro doveri verso la divinità sulla base di
bisogni e di sentimenti piuttosto che su quella di astratte speculazioni. I primi non ci ingannano, i
secondi possono trarci
in errore. Le speculazioni di carattere teorico-filosofico, fondate sulla mera ragione non ci
garantiscono la “certezza” e
non possono essere assunte ad unico fondamento dei nostri
doveri. Secondo Burke confermano e rafforzano il nostro assenso solamente quando concordano
con i nostri sentimenti,
ma hanno uno scarsissimo valore quando sono contrari ad essi.
Il desiderio e l'idea dell'immortalità dell’uomo, la convinzione che le nostre azioni siano la causa
della nostra futura felicità o miseria piuttosto che le sanzioni dei nostri doveri, la
conseguente consapevolezza che la nostra vita è una preparazione della futura sono espressioni del
sentimento religioso cui corrisponde, per Burke, una “conoscenza”, o un’avvertenza di Dio, ingenita
nella natura dell’uomo: << Gli uomini hanno una qualche conoscenza di Dio... Dio ci ha dato una
conoscenza di se stesso e noi crediamo che questa conoscenza sia di qualche importanza per noi >>.
Perciò non dobbiamo “immergerci” troppo nelle cose che ci fanno ritenere
questa vita il nostro tutto, negando in certo qual modo noi
stessi, dato che l’indulgenza nei confronti dei nostri piaceri rimuove la nostra attenzione dagli altri
fini della nostra vita, ed
indebolisce il nostro impegno per essi. Le passioni che scaturiscono dall’amore di se stessi
contrastano spesso con i doveri
connessi alle relazioni fra gli uomini ed abbiamo un danno
minore quando riusciamo a limitare i nostri desideri anziché
indulgere ad essi con pregiudizio degli altri. In conclusione, lo
spirito di rinuncia fondato sull'avvertenza del limite delle passioni e dei desideri è, secondo Burke,
il secondo pilastro della
morale e quindi di una ordinata convivenza fra gli uomini.
Dio non è percepito dall’uomo solamente come Creatore
ma anche come Provvidenza, come presenza attiva e continua
in tutti gli eventi della sua vita e del mondo in cui vive: la religiosità dell’uomo, cioè la sua
dipendenza da Dio, si perfeziona e si invera nella convinzione della Provvidenza. Se Dio
fosse solo Creatore l'ordine delle cose, osserva Burke, sarebbe
caratterizzato dalla necessità, con la conseguenza che noi potremmo solamente onorarlo, ma non
amarlo e nemmeno temerlo o sperare in Lui. L’onorare si esprime mediante la lode
e la gratitudine che sono sentimenti “inerti”, incapaci cioè di
promuovere attività, perché scaturiscono dalla considerazione
di ciò che fu fatto. La speranza e il timore corrispondono invece alla nostra ingenita propensione
all’attività: promuovono
infatti ogni nostra iniziativa perché si riferiscono ad un futuro
“aperto”, non preordinato dalla necessità. Alla Provvidenza è
connessa pertanto la fiducia che la nostra attività, cioè la nostra libertà e responsabilità, ponga in
essere un mondo umano
che si inserisce nell'ordine dei fini voluto da Dio.
Gli argomenti contro la Provvidenza, secondo Burke,
sono suggeriti dalla ragione, che riscontra nella natura un ordine strutturato secondo leggi
immodificabili; nei nostri sentimenti invece non vi è nulla che la contraddica, anzi vi è una
“consonanza" fra quelli e l’idea della Provvidenza. Grazie a
questa possiamo renderci conto che << Dio ha fatto per la
massima parte gli uomini strumenti di tutto il bene che opera
per loro: infatti la maggior parte della loro forza deriva dalla
reciproca assistenza e la maggior parte del loro sapere dalla
mutua istruzione. Ciò è la prova che nell’uomo vi è un capitale di credito o di fede nei confronti del
suo simile senza del quale questa assistenza ed istruzione sarebbero impraticabili >> . La logica
della fiducia nella Provvidenza, che prescinde dalla conoscenza dei motivi o dei fini delle sue
azioni,
è la stessa della fiducia che riponiamo nei nostri simili (crediamo in loro e in ciò che faranno) senza
cui la “buona volontà” non può sussistere fra gli uomini, e la stessa società
viene dissolta.
L’azione della Provvidenza nel corso degli avvenimenti
umani può essere compresa solamente alla luce del principio
della eterogenesi dei fini, che sovrintende anche a tutti gli
eventi naturali, in quanto inseriti nell’ordine della creazione:
per Burke la “sapienza della natura" non è altro che la Provvidenza: << La sapienza della natura o
piuttosto la provvidenza è proprio degna di ammirazione in questo, come in un migliaio di altre
cose, per conseguire i suoi fini mediante mezzi
che sembrano diretti ad altri scopi >>. In conclusione la fiducia nella Provvidenza è l’essenza del
sentimento religioso, tanto che negare la Provvidenza significa negare la stessa religione: <<
Eliminare la Provvidenza significherebbe perciò eliminare la Religione >> .
Il sentimento di Dio e la corrispondente idea si “inverano” in quella conoscenza del divino che ci è
stata data da Dio: non dobbiamo ritenere impossibile, osserva Burke, che
Egli ci abbia dato una conoscenza della sua natura o del suo
volere e che non abbia trovato i mezzi adatti a comunicarci
questa conoscenza. Dobbiamo ritenere pertanto che il fatto
storico della Rivelazione, quale ci è attestato da una costante
tradizione fondata su una serie di testimonianze, è la vera
fonte della nostra conoscenza di Dio. Questa conoscenza richiede uomini incaricati di insegnarla, di
interpretarla e di trasmetterla agli altri, in modo da garantire la continuità dottrinale
dell’insegnamento delle verità religiose che non possono dipendere dalle arbitrarie interpretazioni
dei singoli. La religione, in quanto Rivelazione, è pertanto intimamente connessa con una “società
particolare” che sia al suo servizio,cioè con la Chiesa.
La religione per Burke ha una sua “originaria autonomia”, come avvertenza e sentimento di Dio,
che ha una sua “logica”, cioè un suo modo di esprimersi, distinto da quello
razionale, che “precede”, anticipa ed orienta la ragione. Sussiste, come si è visto, una
corrispondenza fra le convinzioni
religiose e i nostri sentimenti, le nostre passioni, che danno
l’orientamento e l’impulso alla nostra attività, che si genera
pertanto, compresa quella razionale, nel sentimento e nella
coscienza religiosa. La ragione, in altri termini, non genera da
se stessa, cioè non trae dalla sua razionalità l’impulso, la forza,
la presa vitale sulla realtà che le consente di assimilarla, e
quindi di spiegarla e di conoscerla. La ragione, soprattutto
quando perviene ad un altissimo grado di analisi, non riesce
mai a rappresentare compiutamente la realtà. La convinzione
che solamente il razionale ha una “vera” esistenza e consistenza è infondata, come la pretesa che la
realtà si “adegui" in tutto e per tutto al dettato razionale si che possa essere “riformata” in toto
secondo criteri del legislatore illuminato.
A scanso di eventuali fraintendimenti, occorre rilevare che
Burke non assume un atteggiamento scettico nei confronti
della ragione, nel senso di non riconoscerle alcuna sostanziale
capacità nel cogliere la verità, ma che diffida dì una ragione
che si fonda esclusivamente sull'intelletto, così come si rifiuta
dì ridurre tutto il campo del sapere a quello che può essere
conosciuto dalla ragione. Così Burke non rifiuta, ad esempio,
l’esperienza tutta intellettuale del dubbio, inteso proprio
come essenziale momento pedagogico della nostra ragione; ma nello stesso tempo non esita a
riconoscerne i limiti quando cerca di esaurire in se tutta la realtà, perché sa che in
questo caso lo stesso ragionamento finisce col vanificarsi in
raffinate sottigliezze intellettuali, che non intendono i veri
principi che informano la realtà che vogliamo conoscere,
Il criterio che deve informare l’analisi razionale è quello
della semplicità. Burke osserva a tal proposito che quanto
più la mente dell’uomo si eleva dal “volgo”, cioè della gente
comune, tanto più si avvicina alla “semplicità” del suo
aspetto, del suo linguaggio ed anche di non poche delle sue
nozioni. Questo uomo conosce bene la sua ragione, ma proprio per questo motivo ne diffida, la
considera criticamente.
Egli si affida in più di un’occasione alle sue passioni: le controlla,ima non le incatena. Il criterio
della “semplicità" si collega con quello delle “ordinary roads of life”,con l'ordinario modo di vivere
della gente comune", e quindi con il costume e le tradizione che ne costituiscono l'ispirazione dì
fondo, L’uomo che è consapevole della sua natura, cioè del
rapporto sentimento passioni ragione, diffida sempre dei ragionamenti che lo portano fuori delle
“ordinary roads of
Life". “Noi, avverte Burke, dobbiamo sempre considerare il
costume con grande deferenza, come non dobbiamo sempre
irridere le convinzioni popolari. Vi è sempre un principio di
carattere generale a produrre i costumi, che è certamente una
guida più sicura delle nostre teorie”.
Il “costume” non è la stratificazione o la istituzionalizzazione di un comportamento soprattutto
quando è un costume universale che ritrova la sua giustificazione unicamente nella
ragione dell’individuo che persegue il suo utile e benessere,
ma è costituito .da quelle norme del comportamento etico - sociale di una comunità di individui che
esprimono un principio e quindi una verità, che difficilmente la ragione riesce a
spiegare o a comprendere allorché procede con metodo squisitamente intellettualistico, e che quindi
debbono essere accolti nel loro contenuto di verità, proprio perché testimoniati
come tali dal costume stesso.
Burke insiste nel criticare la “raffinatezza razionale”: non
c’è maggior pericolo di errore, avverte, di quando persistiamo
nell'inoltrarci lungo la “road of refinement”, nella pretesa di
comprendere e di spiegare tutto: per quanto lo riguarda “diffida e sospetta sempre dei suoi
ragionamenti quando gli sembrano troppo curiosi, esatti e conclusivi”. Auspica che i nostri
ragionamenti non siano troppo “impegnati” e soprattutto che
la perniciosa attività di raffinata analisi non si eserciti << sulle
formalità e sulle cerimonie che sono usate in alcuni affari materiali come nelle più importanti
vicende della vita ». Le ritrova in tutte le nazioni e in tutti i tempi e ritiene pertanto che
siano consone alla nostra natura: non gli fa piacere sentirle
giudicate delle frivolezze.
La ragione che fa del criterio razionale il principio di tutte
le cose, non solamente misconosce il contenuto di verità del
costume e delle tradizioni, pretendendo di sostituirli con le
sue regole astratte perché prive di ogni nesso con i sentimenti
e le passioni umane, ma dissolve anche tutte le forme, i simboli, le cerimonie, le convenzioni, gli
ideali con cui gli uomini
hanno dato un senso ed un significato alla morte, al dolore e
alla miseria che l’accompagnano, al rapporto fra i sessi, all’amore, alla procreazione, alla nascita di
nuovi esseri. Tutto è
ridotto alla mera natura fisiologica dell'uomo ed alle debolezze e necessità che ad essa sono
connesse. Ma, rileva Burke,
che cosa altro si può desiderare di più se non essere uomo, il
che implica che noi accettiamo con grande reverenza la nostra
natura da desiderare di non essere privati delle sue “parti deboli”. Non dobbiamo desiderare di poter
vivere, come qualcuno sostiene, senza essere costretti a nutrirci ed a dormire,
ma dobbiamo ringraziare la Provvidenza che ha così felicemente unito la sussistenza del corpo con
la sua soddisfazione. E perciò accettando la nostra natura, dobbiamo mutare in meglio la nostra
condizione e dobbiamo tramutare le nostre
necessità, i nostri bisogni, le nostre imperfezioni in “eleganze”
e, se possibile, in virtù.
Fra il 1750 e il 1756, come si rileva dalle “note”, Burke
maturò un orientamento critico nei confronti della ragione illuministica che, negli scritti di suoi
autorevoli rappresentanti,
si caratterizzava per una critica radicale delle tradizioni, e
quindi delle idee, dei valori, in particolare religiosi, che a
quelle erano connesse. Sembrava in particolare al giovane Burke che la ragione non doveva rifiutare
il suo essenziale e vitale rapporto con la sfera del sentimento e delle passioni e che
non poteva avere, pertanto, come suo unico presupposto e
fondamento l’esperienza empirica delle sensazioni (Bolingbroke, Hume), ma la totale esperienza
umana quale si esprime
nella storia, che rappresenta la concreta prospettiva cui deve
sempre mirare la ragione. Di qui la scelta di scrivere la Vindication.
La Vindication of natural society rappresenta l’inizio della
fortunata “carriera” letteraria del Nostro e “sancisce” la decisione, maturata indubbiamente a lungo,
di non dedicarsi alla
professione legale, forse più immediatamente redditizia e certamente più tranquilla e sicura, per
scegliere invece quella del
letterato, più libera, più interessante, indubbiamente più affascinante, ma, per il giovane irlandese
privo di conoscenze e di
protezioni illustri, altolocate e sicure, in una società come
l’inglese della seconda metà del settecento che ancora si strutturava sul “patronage” delle grandi
famiglie aristocratiche, piena di “rischi” e di incertezze.
La Vindication rappresentava per Burke una scelta particolarmente felice del tema e del momento
nel quale presentarsi al pubblico londinese: l’edizione delle opere di Bolingbroke, soprattutto di
quelle filosofiche, la maggior parte delle
quali vedeva la luce per la prima volta, aveva richiamato l'attenzione del pubblico colto londinese
sulla figura, sull’attività
politica, sulla posizione nella cultura filosofico - politica inglese
dell'ex ministro della Regina Anna, di un così illustre personaggio, che tanta parte aveva avuto negli
importantissimi avvenimenti politici degli inizi del secolo in Inghilterra.
Henry Saint John, discendente da un’antica famiglia aristocratica, aveva partecipato giovanissimo
alla vita politica, tanto che a soli venticinque anni era entrato nella Camera dei
Comuni ed in breve era riuscito a diventare uno dei personaggi più cospicui del mondo politico
inglese nell’agitato periodo che doveva concludersi con la pace di Utrecht. Dotato
di uno spirito brillante, acuto, pronto a far propri gli aspetti
più vivi della cultura del tempo, s’impose all’attenzione della
Camera dei Comuni e dell'ambiente politico per le sue notevoli virtù oratorie - la sua eloquenza
rimase proverbiale - per le sue indubbie doti di leader, che ne dovevano fare in
poco tempo uno dei capi riconosciuti del partito tory. A soli
trentatre anni fu nominato segretario per la guerra, appena
agli inizi del conflitto europeo provocato dalla successione
spagnola: nel 1710 fu segretario di Stato, carica che gli consentì di partecipare attivamente alla fase
preparatoria della pace di Utrecht, che, se gli costò alcuni anni più tardi il processo di zmpeacbment
e l’esilio, deve essere indubbiamente
considerata il suo capolavoro politico. Jonathan Swift che
lo conobbe in quegli anni ci lasciò di lui un giudizio che dovette indubbiamente essergli stato
suggerito, in gran parte, dal
fascino che esercitava il giovane uomo politico: “I think Mr.
san john the greatest young man I ever knew; vit, capacity,
beauty, quickness of a piprehension, good learning, and an
excellent taste; the best orator in the House of Commons, admirable conversation, good nature and
good manners; generous and a despiser of money”.
La politica non costituì il suo unico interesse o la sua sola
passione: fu animato anche da un non comune impegno verso
la cultura letteraria e filosofica che, sostenuto dalla vivezza del
suo ingegno, richiamò attorno a lui l'attenzione e l’an1icizia di
alcuni fra i più acuti e brillanti “spiriti” del secolo. Alexander
Pope, indubbiamente il poeta più fine del Settecento inglese,
dimostrò per Bolingbroke un’ammirazione profondissima: nel
1736 così scriveva a Swift: “Nothing can depress his genius.
Whatever befalls him, he will still be the greatest man in the
world, either in his own time, or with posterity”; l'Esmy on
men è, per molti aspetti, la trascrizione poetica delle idee del
suo amico sulla natura dell'uomo. Voltaire trovò in Bolingbroke un consigliere preziosissimo,
sempre pronto ad orientarlo con suggerimenti illuminanti sulla cultura politica e filosofica inglese,
si che, dedicandogli la tragedia Brutus, gli testimoniò la sua riconoscenza in termini di altissimo
elogio: “Souffrez donc que je vous presente Brutus, quoique ecrit
dans une autre langue, docte sermonis utrfusque [ à
vous qui me donneriez des leçons de français aussi bien que
d’anglais, à vous qui m’apprendiez du moins à rendre à ma
langue cette force e cette energie qu’inspire la noble liberte de
penser; car les sentiments vigoureux de l’áme passent toujours
dans le langage; et qui pense fortement, parle de rneme”.
Bolingbroke, pertanto, seppe dare all’impegno politico la
consapevolezza di dover essere l’interprete di un’opinione
culturalmente qualificata: la fondazione del “Craftsman”, il
primo giornale politico di opposizione, costituisce indubbiamente uno dei suoi meriti: su questo
stesso giornale trattò i
problemi più vivi della costituzione inglese, che ebbe poi occasione di illustrare al suo amico
Montesquieu, durante il
soggiorno londinese di questi . Erano note d'altro canto le sue simpatie per gli atteggiamenti,
soprattutto sul piano filosofico, di decisa critica delle
tradizioni e dei valori sui quali si fondava l'autorità della
Chiesa anglicana ed in genere quella delle religioni positive,
Protestantesimo, Cattolicesimo, e quindi la sua adesione a
tutti quegli aspetti della cultura illuministica nei quali più decisamente si faceva posto ad uno
“spirito” antimetafisico, atto
a risolvere sul piano della critica razionalistica qualsiasi richiamo a valori trascendenti. La
pubblicazione delle opere,
soprattutto di quelle nelle quali si trattava ex professo il problema del fondamento meramente
razionalistico della religione e si precisava quindi il vero, significato (almeno secondo
il Nostro) che bisognava dare al deismo, alla religione di “natura”, svelava senza possibilità
d'equivoci quella che era stata
una convinzione nota a pochi amici nei confronti della religione positiva, quale causa prima di tutte
le superstizioni che
avevano ostacolato ed ostacolavano il progresso della scienza
e che aveva addirittura pervertito la società civile, fonte
quindi di disordini, di guerre, di incomprensioni, di intolleranze, di reciproci (ed inutili) odi fra gli
uomini, strumento di
oppressione e di tirannia.
Queste considerazioni polemiche non poterono non suscitare perplessità, un senso di imbarazzo in
certi ambienti politici londinesi, soprattutto in quelli del partito tory: la Chiesa
d’Inghilterra era pur sempre un valido puntello del sistema
costituzionale e delle forze sociali che si esprimevano in esso:
quell’attacco così violento, che della tradizione non salvava
nulla a parte il suo fondamento nel “merito”, era veramente
molto poco “parlamentare”, nel senso che infrangeva, sia pur
post mortem, una regola di riservatezza, di rispetto formale,
nei confronti della religione “stabilita” che gli uomini politici
inglesi più rappresentativi avevano sempre professato. Non
mancarono i giudizi polemici nei confronti dì Bolingbroke: il
più noto, che nella sua asprezza ben esprime lo sdegno di coloro che si sentirono offesi nel loro
sentimento religioso, è
quello del celebre critico e letterato Samuel Johnson, il quale, a quanto ci racconta il suo biografo,
non esitò a dichiarare:
<< Signore, egli fu un farabutto e un codardo; un farabutto per
aver caricato un fucile contro la religione e la moralità; un codardo perché non ha avuto il coraggio
di sparare lui stesso e
ha lasciato mezza corona a un mendicante scozzese per premere il grilletto dopo la sua morte >>.
Naturalmente l’ambiente ecclesiastico e quanti vi erano per vari motivi collegati,
non lasciarono passare sotto silenzio un cosìaudace attentato
ai valori sui quali si fondava l’autorità religiosa della Chiesa
Anglicana.
L’opera di Bolingbroke sembrava pertanto aver riaperto
nella cultura inglese la polemica sul deismo, che per tanti
aspetti ormai poteva considerarsi esaurita almeno in Inghilterra: riproponeva il problema dei
rapporti fra religione positiva ed ordine politico, che proprio in quel torno di tempo in
Francia,,ad opera dei “philosophes”, trovava una enunciazione ed una corrispondente soluzione
negli stessi termini polemici di Bolingbroke. La Whidication of natural society di Burke si inserisce
quindi in una polemica che investe sostanzialmente un momento essenziale del pensiero
illuministico, dal quale in sostanza dipende tutto il suo sistema concettuale, la
sua particolare sensibilità nel cogliere e valutare i comporta menti degli individui nella società, ir1
definitiva il suo particolare concetto di ragione, quello sul valore e sul significato da
riconoscere alla religione. È proprio in occasione di questa polemica che possiamo
cogliere il distacco profondo di Burke, un distacco, possiamo
dire originario, un diverso modo di sentire, di avvertire la
realtà sociale nella quale l'uomo vive, come carica di valori
che danno un senso ed un significato alla stessa attività dell’individuo e che non possono comunque
essere ridotti, o risolti sul piano del puro fare empirico nel quale si esplica l'intelletto dell’individuo.
La positività della religione, il fatto che
essa non possa essere ridotta ad una superstizione dannosa
per la società, significa per Burke riconoscere, in sostanza,
l’autonomia di un sentimento originario che precede l’agire
razionale dell'uomo, che lo orienta nelle sue scelte fondamentali. C’è in definitiva in questa sua
scelta tutta la sua personalità, nel senso che il suo pensiero politico troverà il suo centro unitario e la
sua prospettiva originale proprio nell’approfondire e motivare i significati di questo atteggiamento.
Nell'introduzione alla seconda edizione uscita nel 1757,
Burke precisava lo scopo di questo suo primo lavoro, chiarendo il suo intento polemico nei
confronti degli scritti filosofici del Bolingbroke. L'edizione delle opere del Bolingbroke intendeva
corrispondere all'interesse del pubblico colto
di conoscere finalmente, nella sua interezza, il pensiero di un
uomo` che aveva avuto tanta parte nella politica inglese ed
aveva goduto di una posizione di primo piano nella stessa
cultura inglese. Purtroppo quest'aspettativa è andata delusa:
una lettura consapevolmente critica non può non mettere in
luce le profonde contraddizioni in cui cade continuamente il
politico-filosofo, la inconsistenza delle sue argomentazioni;
quel lungo divagare fra i filosofi antichi e moderni non si riduce in sostanza che a tentare di
dimostrare che la religione,
quale noi conosciamo nelle sue manifestazioni positive, tè un
“sistema” di superstizioni le quali, naturalmente, non hanno
altra funzione che quella di assicurare il potere delle caste sacerdotali.
DUE
NATURA E SOCIETÀ IN BOLINGBROKE
Come si è accennato, nelle sue opere filosofiche Bolingbroke aveva a lungo trattato il tema del
fondamento della religione naturale, per dimostrare la falsità delle religioni positive: il suo attacco
era indirizzato principalmente contro la
teologia delle Chiese “storiche": la cattolica, anzitutto, e
quelle nate dalla Riforma. La religione naturale si riduce alla
ragione stessa di Dio quale si esprime nella natura: questa è
ordinata, o sistematicamente organizzata, secondo delle leggi
che la matematica e la fisica, attraverso una analisi sorretta
dall’esperienza, riescono ad individuare: alla stessa guisa la
natura dell'uomo è regolata da norme che la ragione, illuminata anch’essa dall’esperienza, può
individuare e comprendere nel loro sistematico connettersi. Dio è la ragione stessa
delle cose, la sua realtà si esprime tutta ed esclusivamente
nella sua “razionalità”: le religioni storiche, proprio perche si
rivelano nei loro dogmi e nelle loro teologie decisamente “irrazionali", non sono altro che
interpretazioni interessate della
sola vera religione, quella di natura, unica per tutti gli uomini,
che li unifica sul piano della comune razionalità.
Per Bolingbroke il fondamento della società politica risiede nell’amor di sé, che, sollecitato
dall’istinto del piacere,
sospinge l'uomo a formare la famiglia, come primo nucleo di
unione e quindi come inizio della società. La ragione, come
principio della natura, grazie all’aiuto dell’esperienza amplia
la prima società familiare in una comunità di famiglie, in una
società generale, In tal modo l’amor di sé mediante la ragione
diventa consapevole che può essere soddisfatto solamente grazie ad una collaborazione sincera e
durevole fra tutti i componenti della società: l’interesse del singolo individuo è strettamente
connesso a quello della società: << Gli uomini non si
trovarono mai, dato che non avrebbero mai potuto vivere, in
uno stato di assoluta individualità. L’amore' di sé, indirizzato
dall’istinto del mutuo piacere, operò l'unione dell'uomo con
la donna. L’amore di sé operò quella dei genitori e dei figli.
L'amore di sé divenne socievolezza, e la ragione, un principio
della natura umana, così come l’istinto, lo rafforzò. La ragione
lo promosse e lo estese alle relazioni più remote ed unì molte
famiglie in una sola `comunità, come l’istinto aveva unito gli
individui in una sola famiglia. La ragione ha realizzato ciò con
l’aiuto dell’esperienza; e quale è il risultato dell’esperienza?
Non è di fare qualcosa di nuovo in natura, ma di scoprire ciò
che vi era in natura, prima inosservata. Il dovere naturale di
esercitare la benevolenza, di amministrare la giustizia, di rispettare i patti, è così evidente per la
ragione umana, come il
desiderio di felicità è conforme all’istinto umano. Noi desideriamo mediante l'istinto ed otteniamo
mediante la ragione >>·
Bolingbroke insiste in modo particolare sul ruolo svolto
dall’esperienza per quanto riguarda l’educazione dell'istinto:
la critica cui sottopone la concezione hobbesiana dello stato
di natura, oltre a evidenziare il motivo che in essa non è possibile trovare la giustificazione di un
principio (Dio - legge di natura) che precede e sostiene la società civile e politica, perche realizza
l'identificazione fra la legge dì natura e quella positiva e riduce sostanzialmente la prima alla
seconda, sottolinea anche il fatto che la ragione, mediante la quale gli uomini
pongono in essere il contratto che fonda la società, è una ragione che non si ritrova allo stato di
natura, ma che è il risultato proprio dell’esperienza: << sebbene Hobbes dica, con
abbastanza infondatezza in alcune occasioni, che la retta ragione è la regola delle azioni anche
prima delle leggi civili. Ma per pensare correttamente l'uomo nel suo proprio stato, noi
dobbiamo considerarlo soggetto all'attuale direzione di tutte
le sue naturali facoltà, della sua ragione come dei suoi desideri, della sua ragione proprio sfornita di
arte e non assistita
dall'esperienza, ma non del tutto incapace, e in tutti i casi in
grado di indicargli i primi generali evidenti principi sui quali
è basata la felicità della sua specie, verso i quali è penosamente e fortemente diretto dalle necessità
della sua natura >> .
Bolingbroke ammette che la socialità possa esprimersi
come vincolo fra più individui anche al di fuori dell'interesse,
dell'utile “consapevole di sé", e quindi dell'ardor di sé. L'amicizia, ad esempio, può nascere e vivere
indipendentemente da
qualsiasi considerazione interessata: una certa simpatia intellettuale può unire indubbiamente più
individui. In definitiva
può essere accolta l'osservazione di Cicerone che l'uomo, anche se non fosse costretto dalle
necessità inerenti al suo stato
naturale, avrebbe ricercato la società con gli altri, in odio alla
solitudine e al fine di instaurare un dialogo con i suoi simili.
Ma tutto questo riguarda la socialità propria di piccoli gruppi
di individui non quella sulla quale si fonda la società politica,
la “ general sociability”: la quale, tiene a ribadire Bolingbroke,
ha un fondamento meramente utilitaristico. Si tratta di intendere il particolare modo, meglio il
meccanismo mediante il quale la natura, cioè l’istinto, perviene a
conoscere l'utile, quale principio che unifica in modo sistematico tutti i rapporti che si istituiscono
fra gli individui in società. L'istinto, nell'uomo, significa la ricerca del piacere che è
la norma del comportamento umano nelle manifestazioni elementari, di base della sua vita, naturali,
nel senso di presociali:
la ragione, invece, la seconda tendenza naturale dell’uomo, si
ricollega all’istinto ed ha la funzione di “organizzare” le sensazioni piacevoli, di collegare quelle
passate e di prevedere
quelle future ed è la guida sicura dell'uomo verso il raggiungimento della felicità, piacere
consapevole di se stesso.
Solo la felicità dura, cioè salva il piacere dalla dispersione
che lo insidia e per durare deve essere l'anima della “general sociability”. Tutte le cosiddette virtù
“morali” non sono altro
che un'ulteriore specificazione della ragione naturale quale
sopra è stata intesa: e sono, inoltre, virtù sociali, quali la benevolenza, la giustizia perché utili e
perciò necessarie a mantenere la società. Il piacere e la felicità, l'istinto e la ragione
sono manifestazioni dell’amor di sé, che è il centro unificatore
di tutte le esperienze dell’individuo.
In tal modo, secondo Bolingbroke, si realizza l'ordine fissato da Dio nella natura: ordine
naturalmente che corrisponde alla sapienza divina e che può. essere conosciuto da
tutti gli uomini, senza alcun bisogno di “intermediari”, in
virtù delle loro autonome capacità razionali: << Questa volontà
appare essere nel fatto la vera costituzione della natura
umana. Essa è il piano comprensibile della sapienza divina.
L'uomo è capace di comprenderlo e può essere indotto a seguirlo dal duplice motivo dell’interesse e
del dovere. Per quanto riguarda il primo la reale utilità e la retta ragione
coincidono. Per il secondo, dato che l’autore della nostra natura ci ha fatti per desiderare
irresistibilmente la nostra felicità
e ci ha costituiti così che il bene privato dipende da quello
pubblico e la felicità di ogni individuo da quella della società,
la pratica di tutte le virtù sociali è la legge della nostra natura
e fatta tale dalla volontà di Dio, e avendo stabilito il fine e
proporzionati i mezzi, ha voluto che noi dovessimo cercarci
gli uni con gli altri >>. Coincidenza quindi dell’interesse
privato con quello pubblico, della felicità del singolo con
quella della società, tendenza naturale ad attuare le virtù sociali poiché solo in tal modo l’uomo
realizza compiutamente
la sua personalità e perviene alla sua personale felicità: questo
è il piano “provvidenziale” predisposto da Dio, sul quale si
svolge l’attività dell'individuo.
La conseguenza più immediata dell’esistenza di un ordine
naturale, che esprime come si è visto la sapienza divina, Dio
stesso quale simbolo della ragione, è che le società politiche
dovrebbero esprimere un identico ordinamento o sistema di
leggi: invece, e Bolinghroke ricordando Montaigne non se lo
nasconde, la storia grazie all’esame degli usi, dei costumi,
delle leggi dei diversi paesi ci avverte che sono diversissimi fra
di loro. Il che per il Nostro non inficia l’esistenza dell’ordine
naturale, che deve essere correttamente compreso, seguendo
del resto Bacone, come la legge delle leggi: “The laws of nature are truly what my lord Bacon styles
his aphorisms, the
laws of laws”.
La fonte dalla quale promanano le leggi civili e politiche
è pura, ma i canali per mezzo dei quali vengono diffuse nelle
società sono sostanzialmente infetti dalle passioni, dai pregiudizi e dall’ignoranza degli uomini. Di
qui le diversità, le contraddizioni, l’assurda pretesa di far valere due diversi criteri di
giusto, l’oscurità delle stesse leggi: il che dipende anche dal
fatto che le leggi, il più delle volte, non vengono fatte tenendo
presente il riferimento alla legge di natura. Per tal motivo le
leggi civili non si riducono ad altro che alle norme arbitrarie
di una volontà assoluta, imposta agli uomini dalla forza o
dalla frode di alcuni e confermata dall'educazione é dal costume.
La riconosciuta possibilità della non coincidenza delle
leggi positive con quelle dì natura viene in sostanza ad alterare il piano provvidenziale di Dio, a
turbare l'equilibrio fra
interesse privato e pubblico, felicità privata e pubblica. Ora
per comprendere il senso della polemica di Bolingbroke nei
confronti delle passioni, dei pregiudizi e dell’ignoranza
umana, quali cause dell’infelicità dell'individuo e quindi del
suo vero male, occorre tener presente il modo con cui si costituisce la società civile. La famiglia
rappresenta la prima
forma di società naturale fondata sull’istinto, che esprime altresì la prima forma di governo, quello
paterno: questo potere
è assoluto finché 'i figli non sono in grado di provvedere ai
propri bisogni, nel senso che non sono ancora intellettualmente maturi, diventa limitato quando i
figli pervengono all’età della ragione, cessa quando i figli escono dalla famiglia
per costituirne a loro volta un'altra.
La prima forma di vita sociale dell’individuo è quella che
si attua nella famiglia, e la prima società naturale è quella che
s'istituisce fra le famiglie: per Bolingroke questo è l’ambito nel
quale si realizza la pura ragione naturale dell'individuo, che è
in grado di far fronte a tutte le esigenze di questo particolare
stato. Quando, a motivo soprattutto dell’accrescimento demografico che non consente più alla
famiglia o ai gruppi familiari
di sopperire alle esigenze dei singoli individui in un determinato territorio, si passa all’unione di più
famiglie o di più
gruppi. gentilizi, allora abbiamo una seconda forma di società,
quella che è di solito chiamata civile o politica, caratterizzata
dal fatto che essa tè in definitiva l'espressione della natura
umana quale è stata creata da Dio.
Per la prima l'uomo ritrova da se stesso, senza alcun altro
aiuto, le norme del suo comportamento: mentre per la seconda si richiede, sempre da parte
dell’uomo, un coerente
svolgimento delle esigenze fondamentali della sua natura. La
prima quindi è una società naturale che nasce da un comportamento istintivo, immediatamente
dedotto dalla natura
umana, mentre la seconda è una società “artificiale”, proprio
perché formata da un complesso di relazioni, di leggi, che ritrovano il. loro fondamento, il loro
titolo di legittimità, unicamente nel fatto di essere state individuate dalla ragione dell’uomo per
poter conseguire la felicità. << È molto diverso nel caso della società politica. In questa non siamo
lasciati a noi stessi. Non siamo liberi di scoprire, né di agire, a seguito della
scoperta, grazie alle nostre conoscenze. Noi vi siamo condotti
dalla mano di Dio, come avvenne, ed anche prima di avere il
pieno uso delle nostre conoscenze. Quando Dio fece l’uomo,
fece una creatura la cui felicità dipendeva dalla sua socievolezza con gli animali della sua specie.
Egli lo fece inoltre un animale socievole, un animale capace di percepire un immediato piacere e
vantaggio della società. La necessità della società naturale precede quella della società artificiale e
la prima, che è costituita dall'istinto, ci predispone alla seconda,
alla quale siamo condotti dalla ragione ».
Nell’analisi del fondamento della società politica acquista
pertanto in Bolingbroke un rilievo particolarmente importante la distinzione fra società naturale e
società artificiale: la
prima è caratterizzata, come si è visto, da un insieme di rapporti spontanei, e da un governo - quello
paterno - anch’esso espressione di un rapporto padre-figli, immediato, naturale; la seconda, che è
storicamente preceduta dalla prima,
si esprime invece nel vincolo delle leggi civili, che si riducono
alla natura compresa dalla ragione: le leggi civili pertanto
sono naturali-artificiali: << La vicinanza, uno scambio di buoni
uffici, in una parola la mutua convenienza possono dare inizio, mediante l'unione di più famiglie
fondata su contratti ed
accordi, a società civili. Ma la causa principale di tali artificiali
o politiche unioni, fu di diversissima natura ».
Le leggi artificiali quindi sono legittime solamente quando
sono l’interpretazione che la ragione. dà alla comune legge di
natura, senza che l’interprete si lasci fuorviare in questa sua
funzione dai pregiudizi e dalla superstizione. Purtroppo, osserva Bolingbroke, bisogna riconoscere
che l’opera della ragione è continuamente insidiata dall’ignoranza, dall'errore,
dalle tendenze irrazionali dell’uomo che prevalgono su quelle
razionali:'ma, fra tutte le cause che inceppano e finiscono col
fuorviare l'opera della ragione, la principale è indubbiamente
la superstizione. Questa nasce e si alimenta nell'ambito delle
religioni positive o artificiali, che snaturano e contraffanno la
religione “naturale”, che accomuna invece tutti gli. uomini e
che ci indica la vera essenza di Dio.
Le religioni “artificiali” furono istituite da alcuni sapienti
con l’unico scopo dì assicurare una maggiore efficacia alle
leggi civili e per rafforzare il potere politico. Esse hanno finito
col promuovere una falsa concezione di Dio, e quindi col rafforzare la superstizione, corrompendo
la socialità che unisce
gli individui: a poco a poco insinua fra gli stessi individui un
sentimento di divisione, di reciproca diffidenza che si sostituisce a quello naturale della
benevolenza, dal quale dipende per
l'appunto la socialità, vincolo che unifica gli uomini nel corpo
politico. D'altro canto, osserva Bolingbroke, bisogna riconoscere che la possibilità di istituire una
società politica che riesce ad esprimere un ordine sufficientemente stabile ed una
forza che ne assicura l’osse1·vanza è necessariamente collegata,
nella società primitiva, alla religione, nel senso che l’ordine e
il potere debbono essere legittimati come emanazione della
volontà divina.
Nell'uomo primitivo le facoltà razionali sono molto attenuate: egli vive sotto la costante
preoccupazione di dover soddisfare le necessità immediate in uno stato di continua agitazione che
gli rende impossibile quella tranquillità, quel distacco, che sono le condizioni necessarie perche
l'individuo possa razionalizzare il suo agire pratico. La superstizione, pertanto, è la forma tipica di
conoscenza degli uomini delle società primitive ed essa deriva dal fatto che l'uomo interpreta
la realtà ritenendo se stesso come il centro del mondo che lo
circonda, si avvale così dell’immediata esperienza della sua
vita e riferisce ad essa tutti i fenomeni della natura. Non c’è
sistema politico, nella primitiva antichità umana, che non è
anche sistema religioso, non c’è politica che non è anche teologia, osserva Bolingbroke, proprio
perché le menti dei rozzi
ed ignoranti primitivi non avrebbero mai compreso i dettami
della religione naturale. Questa come sappiamo coincide con
la ragione naturale, quale si manifesta nell’ordine fisico della
natura, che per essere compreso appieno richiede una necessaria depurazione degli istinti e delle
passioni e una conseguente educazione delle facoltà razionali umane, quale può
attuarsi solamente attraverso lo studio della filosofia o scienza
sperimentale.
I fondatori delle religioni storiche, secondo Bolingbroke,
sono tutti consapevoli dell'esistenza di un Dio unico, che si
identifica con l'ordine stesso della natura: essi nascondono
però questa convinzione ai popoli per sottometterli al loro
potere mediante la rappresentazione di un Dio che colpisca le
loro menti rozze, mediante le forme e i simboli del culto, dei
riti. La tradizione, la consuetudine, soprattutto attraverso
l'educazione hanno unito, quasi solidificando in un sol corpo,
le norme del comportamento politico a quelle del comportamento religioso, e ne hanno fatto un
ordinamento istituzionalizzato, che ha una sua autonoma consistenza.
Ma se la società artificiale si serve della religione “artificiale” come dello strumento necessario per
realizzare il suo
ordine politico, essa nel contempo predispone anche lo strumento più efficace di tirannia, di
dispotismo, d’intolleranza
che assoggetta, quasi fossero schiavi, gli uomini che avevano
invece dato vita alla società politica per godere di una vita felice. L’istituzionalizzazione della
religione artificiale è infatti la
premessa per sostituire alla legge di natura ed alle leggi civili
da essa derivate l’interesse particolare, e quindi l’arbitrio, del
gruppo oligarchico o del tiranno, che rompe il rapporto fra
l'utilità del singolo e quella pubblica, l’unico che consente all'individuo di poter pervenire alla
felicità.
Le religioni “artificiali", pertanto, sono tutte “false”: invece di rappresentare la religione “naturale”,
la legge di natura, ne sono una “dolosa” distorsione, che finisce con l'allontanare sempre più gli
uomini dalla verità. Delle religioni storiche, Bolingbroke ne salva solamente due, l’ebraica e la
cristiana: la Bibbia e il Vangelo nella loro autentica dottrina, si
riducono alla proclamazione della esistenza di un Dio unico,
sola ragione della natura.. Ma occorre avvertire che le interpretazioni che nell’ambito del giudaismo
e soprattutto del cristianesimo sono state date al Vecchio e al Nuovo Testamento
dalle scuole filosofiche e teologiche sono tutte da respingere:
tutte sostengono, con vari e speciosi argomenti, la sottomissione della ragione umana, incapace di
pervenire da se alla
verità, al principio d’autorità rappresentato dalle chiese, cui
spetta indicare i principi e le regole fondamentali che debbono orientare la coscienza dell’individuo.
Su questa pretesa
sostengono la subordinazione dell’ordine civile e politico a
quello religioso e cercano così di sancire il riconoscimento di
un imperium in imperio, quello della Chiesa nello Stato, una
vera e propria assurdità, dal punto di vista di una concezione
“scientifica” della politica, fonte di tutti i disordini, di tutte le
lotte civili, di tutti i dispotismi.
In effetti, a considerar bene l'ordine politico, ci si rende
conto che il suo fine è quello di assicurare alla ragione il primato su tutte le passioni ed inclinazioni
degli uomini. Si osservino inoltre le seguenti affermazioni, il vero amor di sé
coincide con l’amor sociale o con la benevolenza, l’autore
della natura ha organizzato il sistema dell’ordine civile umano
in modo che tutti gli uomini debbano coesistere in un comune sentimento di benevolenza. Possono
essere dimostrate e
possono essere condivise da qualsiasi uomo che sia in grado
di confrontare poche idee chiare e determinate. Ma ciò non
significa che l’uomo deve necessariamente comportarsi secondo principi che sono veri dal punto di
vista speculativo. Noi siamo così fatti che basta un vantaggio presente, sia pur
momentaneo, per distrarci dal perseguire un bene maggiore,
ma futuro: a volte una piacevole sensazione, sia pur passeggera, ci distoglie dal perseguire la nostra
vera utilità che solo
la ragione e la riflessione ci possono indicare,
La filosofia, come ricorda Aristotele, educa chi segue i
suoi insegnamenti a fare volontariamente quello che gli altri
sono costretti a fare con la forza. Ma i più, in effetti, non sono
filosofi, e quanti comandano o aspirano a comandare ritengono che l’unico mezzo per far agire i
molti secondo ragione
è quello di servirsi di strumenti ideologici, che si fondano tutti
sul sentimento della paura, per indurli al rispetto delle leggi
ed informare in tal modo i loro comportamenti a criteri razionali; è la stessa ragione a suggerire le
“arti" che servono ad
asservire ai suoi fini le passioni degli uomini. Per questo
motivo le religioni “artificiali”, che nel corso dell'esperienza
storica hanno reclamato prima un’autonomia e poi una supremazia che loro non spetta, debbono
essere ricondotte alla loro
funzione originaria, e rientrare nell'ambito della loro vera legittimità, debbono tornare a svolgere la
funzione discreta
della convalida e del rafforzamento presso la coscienza dei più
delle leggi, e dell’attività di governo.
In Bolingbroke la polemica contro le religioni storiche,
“artificiali', nel sottolineare i loro aspetti negativi, le conseguenze veramente disastrose per quanto
riguarda la possibilità
di pervenire da parte dell’uomo al vero, naturale scopo della
società politica, la felicità, nel denunciare l’insanabile dualismo di Chiesa e Stato, fonte di tutti i
mali, conclude con la
necessità di garantire il primato dell'ordine civile e politico,
cioè della ragione naturale e quindi della religione naturale
sulla religione artificiale, cioè sulla Chiesa. Questa proposta
d’autentica riforma della società “artificiale" può essere realizzata solo grazie ad una sempre
maggior diffusione della filosofia “sperimentale”, l’unica che consente di« poter pervenire
alla ragione naturale, e di una totale riduzione della religione
a puro strumento della ragione atto ad asservire le passioni
degli uomini ai suoi fini. Per Bolingbroke, che la religione
possa avere una sua originaria autonomia, indipendente dalla
ragione educata dall’esperienza, è una pretesa degna del “primitivismo di un Ottentotto”.
TERZO
NATURA E SOCIETÀ IN BURKE
Dopo tanto scetticismo sul piano etico-religioso e dopo
tanto pessimismo su quello politico Bolingbroke conclude,
come si è visto, con una prospettiva in cui si recupera sostanzialmente il momento positivo della
stessa società politica “artificiale”. Ora è proprio su questo particolare aspetto che s'inserisce la
critica di Burke alla filosofia politica dell’ex ministro
della Regina Anna. L’osservazione fondamentale, secondo Burke, è che questo pensiero politico è
profondamente contraddittorio. Quegli stessi argomenti, quello stesso metodo usati per risolvere
criticamente sul piano di un'analisi di tipo razionalistico i rapporti che si istituiscono nell’ambito
della società, e per dimostrare l`inconsistenza delle forme di rispetto ed ossequio nei
confronti dei valori consacrati dalla tradizione, come quel gusto tutto intellettualistico di prospettare
dubbi, di suscitare
incertezze al fine di dimostrare la radicale contraddittorietà
del “vero” codificato dalle filosofie accademiche e dalla religione rivelata, nello stesso tempo
forniscono i mezzi per “distruggere”, fzmditus, quella società politica, che invece si vorrebbe
conservare dopo averla “depurata” di tutte le scorie,
rappresentate dalla religione e dalla superstizione: << Il proposito era quello di dimostrare che
senza l’impiego di alcuna
considerevole forza le stesse macchine che furono impiegate
per la distruzione della religione possono essere impiegate
con eguale successo per la sovversione del governo; e che
quegli speciosi argomenti possono essere usati contro quelle
cose che essi, che dubitano di ogni altra cosa, non permetteranno mai che vengano messe in
questione ».
Ma c’è di più, rileva acutamente Burke: questa filosofia
che pur sembra criticare tutto, dubitare di tutto, in sostanza
nasconde accuratamente, con una certa qual raffinata astuzia
tutta intellettuale, alcuni principi che non possono essere
messi in discussione: in altri termini li dà per scontati, li accetta “acriticamente”, e sul piano
dell’operare pratico lì difende “senza esclusione di mezzi"; in effetti, ricostituisce su di
essi una nuova forma di autorità altrettanto sacra ed inviolabile, anche se priva del prestigio
riconosciuto alla “vecchia”
dalla tradizione.
Lo scopo della vindication è pertanto quello di risolvere
questa contraddizione, non del solo Bolingbroke, come si vedrà, ma del pensiero politico
illuministico che si fonda sui
presupposti filosofici illustrati dallo stesso Bolingbroke: occorre tirar fuori il deus absconditus di
questa filosofia politica,
esaminarlo, obbiettivamente, spassionatamente, senza prevenzioni di sorta, per dimostrarne la vera
natura. Per tal motivo,
tutte le argomentazioni che sono svolte nella vindication sono
condotte sul filo sottile di un’ironia “puntuta ed affilata”, che
sa “dissezionare” i concetti degli avversari con una “tecnica
indolore", e con una perizia consumata: non la polemica decisa, aperta, violenta, per abbattere e
distruggere l'avversario,
ma l’analisi delle sue ragioni svolta con garbo.
La vindication prende le mosse da un precedente dialogo
nel quale l’amico del filosofo, pur concordando con i risultati
cui si era pervenuti durante la discussione - si erano individuati i fondamenti della società politica
non si era poi sentito di continuare ulteriormente nell’esame dell'ubi consistam
della società: avvertiva che una “curiosità” di tal genere, una
volta appagata, avrebbe finito col distruggere l’intero edificio
sociale. Ma, osserva Burke nei panni di Bolingbroke, a questo
punto non ci si può tirare indietro, bisogna stare al gioco:
d’altro canto la verità non ci può arrecare alcun danno, dato
che solo l'errore costituisce la vera causa dei dolori, delle disgrazie, dei mali che l’individuo deve
sopportare.
I principi sui quali si fonda la società politica vanno esaminati in tutte le loro conseguenze con
assoluta spregiudicatezza: noi siamo abituati a considerare con riverenza, quasi
con timore, quanto ci è stato tramandato dalla tradizione, a
mantenere nei confronti delle istituzioni dei nostri antenati un
rapporto di timore riverenziale, ma la verità, ritorna a precisare Burke, esige l’i1npegno di
scandagliare a fondo tutte le opinioni ricevute, anche se il risultato di questa “operazione”
dovesse concludersi con la dimostrazione della radicale infondatezza di quanto ci sembrava essere
così stabile, giusto e
vero, e se questa stessa dimostrazione, divenuta principio di
concreto operare politico, dovesse radicalmente contrastare i
nostri stessi interessi .
Non lasciamoci sedurre, continua ad incalzare Burke, dal
vecchio ma sempre ascoltato avvertimento della tipica mentalità bigotta, che sconsiglia di
dimostrare l'infondatezza dei
pregiudizi popolari per le gravi conseguenze che potrebbero
derivarne per quanto riguarda la stabilità dell’ordine politico,
che si fonda sull'obbedienza del popolo e proprio sull'accettazione passiva dei principi e dei valori
contenuti nei “ pregiudizi”. Questa, invece, è una pretesa assurda e blasfema: la nostra felicità
dipende esclusivamente dalla pratica della virtù e
questa, a sua volta, è possibile solamente se si svolge sul piano
della verità, quanto a dire, sulla base della conoscenza di quei
rapporti eterni che Dio ha fissato quali norme che regolano la
vita degli uomini. Dobbiamo essere particolarmente accorti a
non pretendere di forzare la natura con l’imporle delle norme
“artificiali”, frutto delle nostre invenzioni: solo lo studio della
natura, condotto senza pregiudizi, ci ha consentito di conoscere alcune verità che costituiscono poi
il vero fondamento
di quel poco di libertà e di felicità di cui godiamo.
L’epoca nella quale viviamo, nota Burke, è caratterizzata
dalla lotta contro la superstizione: infatti l’edificio che si
fonda sopra di essa è stato in gran parte demolito, soprattutto
in Inghilterra. Da tempo sono state messe in luce le miserie
che la religione, - fonte prima di tutte le superstizioni - e
il governo dispotico delle chiese sui fedeli hanno provocato
all'umanità: ormai si pensa e si agisce sulla base della ragione
e della natura. Ma se questo è vero per molte persone, non
bisogna dimenticare che la maggioranza vive ancora secondo
schemi e principi frutto della superstizione: precisazione
quanto mai importante da tenere sempre presente, in quanto
è sempre possibile il pericolo che la tensione spirituale necessaria per continuare la lotta contro la
superstizione si allenti,
tanto più che, come è noto, purtroppo la fonte di tutte le superstizioni, “degli entusiasmi senza
senso, della sacra tirannia”
suscita ancora, sia pur formalmente, la riverenza e la stima
delle stesse persone illuminate: chiara allusione all'attività politica dello stesso Bolingbroke, che, in
diverse occasioni, parteggiò per la Chiesa d'Inghilterra e ne sostenne i concreti interessi temporali.
Ricordiamoci, infine, che il potere politico ritrae la sua
forza proprio dalle istituzioni ecclesiastiche che gli garantiscono di poter contare, nell'ambito della
società, su consensi
ampi ed omogenei; e che le leggi “artificiali", necessario vincolo di tutto l’ordine politico, incutono
il timore riverenziale
che le fa rispettare grazie all’avallo della religione “artificiale”.
Perciò dobbiamo tener costantemente presente che l'idea di
religione e dì governo sono intimamente connesse: accettiamo
il governo come necessario, o quantomeno utile per conseguire il nostro benessere, e siamo disposti,
anche a nostro dispetto, ad accogliere questa o quella forma di religione “artificiale”, della quale il
volgo sarà sempre schiavo, ed anche le
persone di cultura subiranno, sia pure involontariamente, la
sua influenza. Il rapporto religione-società va esaminato, quindi, con
spirito veramente illuminato, senza alcun timore delle possibili conclusioni, liberandoci in definitiva
di quel senso di rispetto, sia pur formale, verso la religione stessa, che impedisce agli uomini di
cultura di essere veramente coerenti e che
li rende partecipi, in fondo, dell'asservimento delle coscienze
operato per l’appunto dalla Chiesa. Per tal motivo, un’analisi,
sufficientemente approfondita, del modo con cui si realizza
l’ordine politico della società umana non è niente altro che la
continuazione dell'opera dì “illuminazione” delle coscienze
che il secolo sta attuando sul piano della religione.
,La società umana passa attraverso due forme fondamentali, come del resto la religione: la società
naturale e quella
“artificiale”. La prima si fonda sull’istinto sessuale e sul vincolo che lega le persone appartenenti a
questo primo gruppo:
il padre, la madre, i figli costituiscono la società naturale. I
primi uomini vissero in uno stato naturale di perfetta uguaglianza, nutrendosi dei prodotti della
natura. Ovviamente, in
questo stato l’umanità dei tempi primitivi dovette assoggettarsi a gravissime limitazioni, derivanti
sostanzialmente dalla
mancanza di una più ampia ed articolata unione d'individui,
il che voleva dire l’impossibilità di fruire dei vantaggi connessi
con il reciproco aiuto e la comune assistenza e di risolvere pacificamente le eventuali controversie
per la mancanza di un
giudice comune. Gravi inconvenienti, indubbiamente connessi con la società naturale, ma che non
impedivano all’uomo di vivere libero, in perfetta eguaglianza con i suoi simili: se l’uomo, fosse
rimasto entro i limiti “sociali" fissatigli
dalla natura, la famiglia o al massimo i parenti, la sua felicità
sarebbe stata garantita. Invece l'uomo, resosi conto dei vantaggi che ritraeva dal vivere insieme
nella famiglia, ritenne che
altri maggiori vantaggi gli sarebbero derivati da una società
più ampia, dalla riunione di più famiglie in un sol corpo politico. E poiché la natura non aveva
creato alcun vincolo “naturale’' d'unione, l’uomo supplì a questa mancanza con l'inventare le leggi:
questo è il vero fondamento della società
politica, la quale, proprio perché fondata sulle leggi, “invenzioni” degli uomini, è una società
“artificiale”. A ben considerare, la società artificiale nasce, alla fin fine,
dalla radicale incapacità dell’uomo di saper individuare il suo
limite, dal non sapersi contentare, da questa volontà che lo
anima e lo sospinge a volere sempre di più: non sappiamo mai
venire a patti con la nostra condizione, siamo sempre pronti a
perdere quello che abbiamo guadagnato pur di appagare l'insaziabile voglia di avere di più. L'uomo,
in sostanza, cede la
sua libertà ed uguaglianza naturali per un maggior benessere,
che si dimostra del tutto illusorio. Non rimane quindi che
considerare la società artificiale nei suoi vari aspetti. L’analisi
delle “conseguenze” della società artificiale per quanto riguarda la vita umana ci darà una
dimostrazione quanto mai
convincente, si che, alla fine, dovremo concludere che l'origine di tutti i mali che affliggono
l’individuo si ritrova proprio
nella società artificiale.
Lo Stato, o società politica, osserva Burke, può essere
considerato sotto diversi punti di vista: o nei rapporti fra
Stato e Stato, o nei rapporti che si istituiscono all’interno
dello Stato fra chi comanda e chi obbedisce, oppure nei rapporti che si istituiscono nell’ambito della
stessa società civile.
Se consideriamo il modo con cui si sono attuati i rapporti
fra i singoli Stati, non possiamo fare a meno di riferirci in
un'ampia prospettiva alla storia umana, per vedere di cogliere
qual è stato in definitiva il risultato di questi rapporti. Le
conclusioni che dobbiamo ricavare da un esame spassionato
degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia umana,
per lo meno dal punto di vista politico, sono del più sconsolante pessimismo: non troviamo
l'amicizia, la concordia, la
benevolenza, la comprensione nei rapporti fra gli Stati, ma il
sospetto, l'ambizione, la volontà di potenza, molte volte l'odio
e l’intolleranza, si che la guerra è il solo risultato delle relazioni che si istituiscono fra le società
“artificiali”, o gli Stati.
La storia universale si riduce, pertanto, ad una drammatica,
angosciosa, orrida descrizione di guerre, di lotte civili: la storia sembra non avere alcun altro
significato che quello di dimostrare che lo Stato e il potere sono fondati esclusivamente
sul sangue. Il riferimento a Machiavelli, a questo punto, è
quasi d’obbligo, Una considerazione del Segretario fiorentino,
consente a Burke dj osservare che la guerra costituisce l'unica
vera preoccupazione di chi detiene il potere politico: la pace
non ha altro scopo che quello di preparare la guerra.
Basta appena accennare, per avvalorare la tesi enunciata,
alla storia dei grandi imperi dell’antichità, delle società “artificiali”, delle cui gesta la storia ci ha
conservato ricordi abbastanza sicuri. Tutta l'antica civiltà egiziana sembra concentrarsi, a quanto è
tramandato, nel grande sforzo militare con
il quale Sesostri cercò di estendere i suoi domini lungo le coste del Mediterraneo orientale sino alla
Colchide. Si parla di un esercito di settecentomila uomini con cui il faraone tentò
di allargare i suoi domini. Questa operazione militare significò
la distruzione d'intere popolazioni che cercarono di difendere
la loro libertà e nello stesso tempo la morte di molti dei suoi
soldati uccisi in battaglia, e soprattutto dagli stenti e- dalle
malattie. Possiamo calcolare che circa due milioni di uomini
persero la vita nelle spedizioni militari di Sesostri e, dobbiamo
dire inutilmente, dato che, a quanto ci ricorda Giustino,
quelle conquiste furono effimere e non servirono ad altro che
a soddisfare le passioni di dominio e di conquista del faraone.
Consideriamo la storia degli Assiri, dei Babilonesi, dei
Medi, dei Persiani: è un continuo tentativo di assicurare con
la guerra la stabilità del proprio dominio, di garantire all’interno stesso della società “artificiale”
l’ordine e l’obbedienza
al potere politico. Semiramide e Nino sono ricordati come le
grandi personalità politiche di questo periodo in virtù della
loro capacità di fondare imperi: ma ciò significa guerre continue, con tutte le loro tragiche
conseguenze.
E la storia greca è anch’essa il racconto delle lotte continue fra città e città, fra le opposte fazioni
all'interno delle
stesse città, una lotta fratricida, in fondo, combattuta a volte
per il possesso di pochi ettari di terreno, dalla quale la Grecia
usci stremata di forze, per essere assoggettata dalla Macedonia. Ed anche l’impero d'Alessandro
significò, in sostanza,
una pace relativa: alla sua morte i regni di Siria e di Egitto,
quelli di Pergamoe di Macedonia si combatterono per duecento anni.
E continuando nell’analisi della storia antica, quale spettacolo di devastazioni, di massacri, di
proscrizioni, di deportazioni non offre la Sicilia prima del consolidamento del dominio romano a
causa delle guerre intestine fra i seguaci delle
opposte fazioni politiche, e delle lotte fra i Greci, i Cartaginesi, e i Romani. Infine l’affermarsi di
Roma sulle popolazioni
italiche e poi l’estendersi e il consolidarsi del suo impero suggeriscono indubbiamente l’idea di una
sorte di “catastrofe"
del mondo antico se pensiamo a quante vite furono distrutte,
quante popolazioni furono ridotte in schiavitù, quanti sacrifici
e vessazioni dovettero subirei vinti.
Ma nella storia antica c’è quella di un popolo che forse
più che ogni altra può essere importante per intendere quanto
male e quanto dolore si contenga nella società “artificiale”: è
la storia di Israele. Il suo insediamento “politico” nella terra
promessa fu possibile solo scacciando le popolazioni che vi
abitavano in precedenza, e fu difeso con ostinate lotte con i
popoli vicini sino a che i re degli Assiri e di Babilonia non ridussero in servitù l’intero popolo. La
tragedia finale del popolo ebreo, che si concluse con la distruzione di Gerusalemme, ha, ai fini della
nostra indagine, un significato ben
preciso: se un popolo così piccolo, in un territorio cosi limitato, ebbe a sopportare tanti lutti, tanti
dolori, tante traversie,
dobbiamo ovviamente ritenere che una somma maggiore di
mali debbano aver sopportato popoli di gran lunga più numerosi, il cui domir1io politico si
estendeva su un più ampio territorio. « La storia non conosce limiti ai dolori ed alle pene degli
uomini: ci sono stati periodi in cui sembrava di essere vicini
alla totale distruzione del genere umano. L’invasione dei barbari, alla fine dell’Impero romano,
devastò la Gallia, l'Italia, la
Spagna, la Grecia e l’Africa: ovunque vi furono distruzioni,
eccidi. La furia dei barbari trasformò quelle terre, una volta
popolose e fertili, in un deserto.
È certamente inutile continuare in questa noiosa cronistoria di guerre e di stragi che hanno falcidiato
il genere umano:
del resto, la storia dei tempi moderni è nota a tutti. Ma non
può essere passato sotto silenzio il fatto che la conquista delle Americhe fu attuata mediante la
distruzione d'intere popolazioni, si calcola intorno a dieci milioni di morti. Purtroppo gli
eccidi e le sopraffazioni in Africa ed in America non sono ancora terminati.
La storia umana come campo di attività delle società politicamente organizzate non si riduce ad
altro che ad un gigantesco campo di battaglia, nel quale riposano, di volta in volta,
fra i corpi martoriati dei vinti, stremati, i vincitori: allo storico
non rimane altro compito che quello di redigere il conto consuntivo di tante stragi. Il numero che si
ricava - l'indagine statistica naturalmente deve essere accolta con cautela, date le scarsissime
informazioni in nostro possesso - è tale da angosciare qualsiasi uomo dotato di un minimo senso dì
responsabilità.
Cosa insegna, in fondo, la tragica esperienza della storia
umana? La società artificiale è un meccanismo che l’uomo
non riesce a controllare. Con troppa facilità, infatti, l’uomo si
dimentica che il suo animo ha una naturale propensione per
le passioni che sono soddisfatte sul piano della forza e della
volontà di dominio: ma queste passioni hanno un ben limitato
campo d’azione, e quindi scarsissime possibilità di poter raggiungere il proprio oggetto, nell'ambito
della società “naturale”. Non così nella società “artificiale”, nella quale invece
esse hanno la possibilità di ritrovare gli strumenti più idonei
per il soddisfacimento delle loro pretese: la così detta società
civile con l’ordinato sistema delle sue istituzioni, è in grado di
unificare la forza dei singoli individui in un'unica forza sociale, e di attuare un “meccanismo
sociale" che consente ad
uno o pochi individui di servirsene. L’unica preoccupazione,
in fondo, di tutta la società politica consiste proprio nel rendere sempre più perfetta la forza sociale,
nell'aumentare il suo
potere dj offesa, vale a dire di distruzione e di morte: sotto
questo punto di vista non può negarsi che il progresso verso
“il meglio” è indubbiamente costante: << Dai primi albori della
società politica ad oggi le invenzioni degli uomini hanno affilato e perfezionato il mestiere
dell’assassinio, dai primi rudi
saggi di clave e di pietre sino alla presente perfezione di fucili, cannoni, bombarde, mine e tutte
queste specie di artificiale, colta e raffinata crudeltà, nella quale noi siamo ora così
esperti, che forma la parte principale di ciò che i politici
hanno insegnato a credere essere la nostra principale gloria ».
Nella società “naturale” invece, questa concentrazione di
forze non era assolutamente possibile: l'uomo, in ultima analisi, doveva unicamente preoccuparsi
del male che poteva provenirgli da un altro uomo, da una forza più o meno, ma sempre,
proporzionata alla sua e dotata di un potere d’offesa
estremamente limitato. L’uomo delle società “artificiali” invece si è ridotto ad essere il più feroce di
tutti gli animali proprio perché la sua forza è stata moltiplicata, tanto da convincerlo di poter
sottomettere i suoi simili alla sua volontà di dominio.
È proprio questa l’essenza del potere politico, e quindi il
vero fondamento della società “artificiale”, la causa di tutti i
nostri mali. La società politica, in ultima analisi, riposa su di
un fondamentale rapporto di subordinazione quale intercorre
fra il padrone e lo schiavo, e per tal modo l’avarizia, l'interesse, l’ambizione, l’orgoglio di un uomo
di governo sono
leggi per quanti non hanno alcun proprio fondato convincimento. La politica è ormai considerata
come immediatamente
collegata con la malvagità dell’uomo: quella parola suscita, bisogna riconoscerlo, un senso di
ripulsa in quanto ci richiama,
si può dire automaticamente, un comportamento completamente distaccato da qualsiasi
considerazione etica. D'altro
canto non c’è scrittore politico il quale non riconosce che il
governo dello Stato è necessariamente connesso con la violazione della giustizia: la famosa “ragion
di Stato” indica per
l’appunto quella suprema necessità politica che consente ai
governanti di violare in alcuni casi quelle norme etiche su cui
si fonda la giustizia e che costituiscono la vera garanzia di libertà per l’individuo.
Queste brevi osservazioni sulla natura della politica ci
consentono, secondo Burke, di poter esaminare nella loro
“verità effettuale” gli ordinamenti formali mediante i quali il
potere politico realizza la sua funzione di governo delle società umane. Dobbiamo innanzitutto
osservare che tutte le
costituzioni possono essere ricondotte ad una sola, la più semplice: quella dispotica. Il dispotismo
sembra corrispondere
alla vera natura del potere politico “artificiale”, nel senso che un’analisi oggettiva, spassionata, non
condizionata da timori
reverenziali, dei presunti valori rappresentati dall’autorità fondata sulla tradizione, ci dimostra,
senza possibilità di equivoci,
che il complicato meccanismo delle costituzioni politiche non
ha altro scopo che quello di nascondere il fondamentale rapporto di sudditanza, proprio del governo
dispotico, che lega
la massa dei governati ai governanti.
Per dispotismo dobbiamo intendere la forma di governo
nella quale tutti i centri di potere dipendono unicamente dalla
volontà del potere supremo: svuotati dì qualsiasi autonomia
sono governati tutti nello stesso modo, esclusivamente dalla
volontà “occasionale” di colui che impersona il supremo potere. È proprio il felice aggettivo che
Burke usa, “occasional”, a denotare la caratteristica fondamentale del dispotismo: il
fatto cioè della sua radicale incapacità ad esprimere una volontà coerente ed organica, tale cioè da
garantire il conseguimento del bene pubblico.
Il dispotismo è indubbiamente la forma più semplice di
governo, e quindi quella più diffusa: poche sono le società
politiche che riescono a darsi una costituzione diversa da
quella dispotica, ma anche queste sono continuamente insidiate dal dispotismo. Consideriamo le
manifestazioni tipiche
della costituzione che s’informa a tale principio: la volontà del
supremo reggitore, per realizzarsi nella sua pienezza e nella
sua assolutezza, deve necessariamente porre in atto una serie
di accorgimenti che finiscono con l’annullare qualsiasi possibilità di vita autonoma e libera da parte
dei singoli individui
e quindi con il corrompere ed alla fine disgregare il tessuto
delle relazioni sociali, in modo da lasciare l’individuo solo,
senza possibilità di aiuto, di fronte alla assolutezza del potere
politico.
La volontà assoluta, quale si esprime nel dispotismo, è in
sostanza volontà essenzialmente "capricciosa”, pronta a seguire i consigli di chi con più abilità e
con più accortezza sa
lusingarla ed orientarla verso quei provvedimenti volti a realizzare quanto sembra soddisfare i suoi
“appetiti”. Per tal motivo il potere politico deve necessariamente asservire tutto e
tutti ai suoi fini, con i quali a poco a poco debbono identificarsi quelli della società: l'obbedienza
più cieca è il risultato
di questo metodo di governo e nello stesso tempo la condizione perché possa continuare ad operare.
Così si pongono le
necessarie premesse perché il potere politico possa pretendere
di indagare, di scrutare la coscienza stessa dei sudditi per assicurarsi che ci sia un’effettiva
coincidenza fra la sua volontà
e quella dei sudditi, e l'individuo viene, in tal modo, privato
di quello che è il suo bene più prezioso, l’interiore libertà,
cioè la determinazione autonoma dei fini delle sue azioni, e,
quindi, ridotto al rango di uno schiavo,.
Libera da qualsiasi vincolo, la volontà assoluta del reggitore è dominata da un insaziabile desiderio,
una vera e propria “concupiscenza”, di avere sempre di più e di diverso.
Nulla riesce ad appagarla completamente: essa nella sua
azione di governo deve continuamente volere, qualcosa di
nuovo. Dietro l’apparente stabilità, il governo dispotico nasconde sostanzialmente una profonda
instabilità che è data,
per l'appunto, dalla essenziale mutevolezza dei fini che si propone la volontà politica.
Questo governo si realizza solo a patto di asservire tutti
gli individui ai suoi voleri per mezzo della forza, che la stessa
società ha messo a sua disposizione, e per mezzo della corruzione, della frode, della paura.
L’oppressione che si esercita
sulla massa degli individui che compongono la società politica
diventa nel governo dispotico sempre più pesante: in effetti, il
principe governa per mezzo dei suoi favoriti, di quei consiglieri che riescono a cattivarsi la sua
simpatia e la sua benevolenza, i quali, osserva Burke, rendendosi conto che la benevolenza del loro
signore è di breve durata, cercano di realizzare
quanto più possono finché dura il “loro” potere. Due “corti",
quella del principe e quella del favorito, costituiscono la caratteristica del dispotismo, quella del
potere legale e quella
del potere “di fatto", l’una contro l’altra armata con le insidiose e velenose armi della calunnia più o
meno nascosta,
della frode, della corruzione, talché la fede pubblica e privata,
che costituisce uno dei vincoli fondamentali della società, non
più può essere considerata come un valore centrale per la stabilità delle relazioni sociali.
In un regime dispotico ogni individuo deve fare unicamente affidamento sulle qualità peggiori del
suo carattere: gli ingenui, gli onesti, i “poveri di spirito" sono facile preda degli astuti e dei violenti.
Questa forma d’oppressione. genera un
diffuso senso di scoraggiamento, di profonda apatia che finisce col togliere alla società qualsiasi
interesse per tutte quelle
iniziative che richiedono la collaborazione degli individui sul
piano sociale e che sono tanto necessarie per perseguire il
progresso civile e sociale. È forse proprio per questo motivo
che il dispotismo finisce per causare una diffusa indigenza che
colpisce le società soggette ad una tal forma di governo.
Possiamo considerare ora in sintesi quali i “benefici” effetti della forma più semplice della società
“artificiale”: la mancanza assoluta di libertà sia nelle espressioni della vita
pubblica che in quelle della vita privata, la coartazione e il
progressivo svuotamento della coscienza del singolo, l'oppressione di uno o di pochi attuata al solo
scopo di soddisfare la
smodata ambizione di chi comanda, la disgregazione dei valori fondamentali sui quali si fonda il
costume sociale, la corruzione della vita pubblica e privata, l'assoluta insicurezza
nella vita e nei beni, lo sfruttamento e la conseguente miseria
ed abbrutimento della stragrande maggioranza degli individui. Perciò, osserva Burke, questa prima
“costituzione”, o modo di organizzare il potere o la forza sociale, non corrisponde alle attese di
benessere e di felicità, di maggiore autonomia e libertà che si sono ripromessi gli individui
costituendo la “società artificiale": abbiamo visto quali ne sono
stati i concreti risultati. In questa forma di governo la natura
umana è degradata alla brutalità delle bestie e, come osserva
giustamente Locke, essa è peggiore dell’anarchia: è indubbiamente meglio vivere nella società di
natura, affrontando tutti
i rischi che questa comporta, anziché avvalersi del presunto
ordine e della presunta tranquillità che offre il governo dispotico.
Si osserverà, continua Burke, che se la forma di governo
dispotica, la più diffusa sulla terra perché la più semplice, è la
causa di tanti mali per gli individui, lo stesso non può dirsi
per altre costituzioni, che sono state elaborate proprio per ovviare ai gravissimi inconvenienti della
prima. Le costituzioni
aristocratica, democratica e soprattutto mista, nella quale si
contemperano i principi delle tre costituzioni tipiche, secondo
quanto affermano la maggior parte degli scrittori politici, in
effetti garantirebbero, soprattutto l’ultima, il raggiungimento
di quella libertà, sicurezza e tranquillità cui aspira l’uomo con
la formazione della società “artificiale”. Purtroppo uno studio
attento, condotto con animo disincantato che non si lasci
commuovere dall’apparente autorità di alcuni principi o valori fondati sulla tradizione o sul costume
ci dimostra che
queste altre forme di governo, in definitiva, non fanno che accentuare i malanni insiti nel
dispotismo. E indubbiamente una conclusione paradossale, almeno ad una prima considerazione,
ma che alla fine deve essere accettata in tutta la sua verità, non appena ci rendiamo conto del
concreto meccanismo
delle stesse costituzioni.
Nel corso dell’esperienza storica il primo tentativo, ingenuo del resto, di eliminare il dispotismo
deve essere stato
quello che si ridusse a cambiare la persona di chi governa:
questa sostituzione, cui si pervenne di solito dopo atroci lotte
civili, servì a ben poco. Il nuovo principe per un breve periodo di tempo informò il suo governo ai
principi del pubblico interesse, poi, a poco a poco, instaurò di nuovo la costituzione dispotica: in
fondo è nella natura stessa del potere
politico realizzarsi nella sua forma più assoluta. Ammaestrati
da successive esperienze gli individui ritennero, allora, che affidando il potere ad un numero
ristretto di persone dotate di
virtù riconosciute da tutti i cittadini, avrebbero avuto un governo efficiente e nello stesso tempo
rispettoso dei diritti di
tutti i consociati, anche perche i nuovi governanti, dotati di
un patrimonio ragguardevole, non avrebbero avuto alcuna
sollecitazione ad arricchirsi a spese dei concittadini.
Ma anche in questo caso si tratta di un'illusione: in effetti,
l’esperienza stessa si incarica di dimostrare che il governo aristocratico si distingue solo
formalmente da quello dispotico,
dato che quando il popolo viene escluso dal potere legislativo
esso diventa automaticamente schiavo della classe aristocratica, così come lo era stato del principe:
anzi, la tirannia che
deve sopportare è più pesante, in quanto ogni nobile ha di
solito l’alterigia di un sultano e la sua azione di governo risulta infine ispirata alla gelosa custodia
dei propri averi
molto spesso confinante con l’avarizia , all’orgoglio connesso con le proprie tradizioni familiari,
alla paura dì perdere
un potere che in definitiva non ha alcuna corrispondenza nei
concreti e reali interessi della società. Consideriamo, ad esempio, le repubbliche di Genova e di
Venezia: il loro governo
non è altro che un dispotismo mascherato. La “ragion di
stato” di queste repubbliche è sostanzialmente il sospetto, con
tutte le relative conseguenze che finiscono col corrompere lo
spirito pubblico e col fondare la costituzione su di un rapporto di soggezione che sottomette il
popolo all’aristocrazia .
D'altro canto, che la costituzione aristocratica renda ancor più pesante il potere dispotico di cui
dispone è comprovato da una considerazione di cui non si tiene il debito conto:
l'aristocrazia, come corpo politico, tende a rendere omogenea
l’azione politica di coloro che vi appartengono, e, gelosa delle
sue prerogative e tradizioni, cerca di mantenersi come un ordine chiuso che si perpetua nel tempo,
conservando inalterati
i suoi principi di governo e non consentendo alcuna modificazione o innovazione nel modo di
governare gli affari pubblici. Per tal motivo, osserva acutamente Burke, nella forma
del dispotismo “puro”, nella quale il potere è affidato ad una
sola persona, c’è sempre un periodo di tempo, sia pur breve,
nel quale il dispotismo si attenua dì molto o addirittura sparisce (anche se i casi sono certamente
rari) in occasione della
successione o sostituzione del principe: basta ricordare a questo proposito Tito, Vespasiano,
Antonino Pio, Marco Aurelio.
La possibilità, invece, che il governo dispotico sia notevolmente ridotto oppure sostituito con una
forma di governo
monarchico rispettoso della dignità e della Libertà dei cittadini, è esclusa nelle forme aristocratiche
di governo, in quanto
in esse non gli individui ma il corpo politico esercita in effetti
il potere politico. Consideriamo, ad esempio, il caso della
repubblica di Venezia, che sembra avere un governo sufficientemente moderato: essa nasconde un
regime dei più tirannici,
che si manifesta nella particolare cura con cui l’aristocrazia
persegue il fermo proposito di mantenere il popolo in uno
stato di generale apatia, mediante quegli accorgimenti atti a
provocare il suo disinteresse per tutto quello che riguarda la
cosa pubblica. La profonda corruzione civile, che soffoca
qualsiasi tentativo di dare al popolo, alla maggioranza dei cittadini, una propria dignità ed una sua
autonoma funzione
nell'ambito della costituzione, è in definitiva la conseguenza
della politica perseguita con tenacia dall’aristocrazia di privare
il popolo di qualsiasi forma di libertà, col tenerlo costantemente sottomesso mediante il timore di
un’implacabile inquisizione di Stato. Così, anche questa volta, bisogna dire che la
seconda forma di governo, escogitata per garantire alla “società artificiale” il conseguimento del
benessere collettivo e
della libertà di tutti, non corrisponde agli scopi prefissi, anzi
essa non fa che rendere ancora più dura e più stabile l’oppressione propria del dispotismo: « In
breve i regolari e metodici
procedimenti di un'aristocrazia sono più intollerabili degli eccessi propri di un dispotismomo, e, in
generale, più lontani da
ogni rimedio ».
La terza forma dj governo, costituita per sottrarsi alla tirannia della classe aristocratica, è quella
democratica, nella
quale il popolo diventa l'unico soggetto attivo del potere sovrano. Potrebbe sembrare, e molti lo
hanno sostenuto, che la
democrazia assicuri finalmente alla società politica il godimento di quei beni per i quali è stata
costituita: ma ancora
una volta bisognerà dire che anche questa nuova costituzione,
e forse più delle precedenti, realizza un tipo di governo che si
fonda sul più spietato, assurdo assolutismo. Come già nelle
altre due costituzioni, quella monarchica e aristocratica, l’esercizio del potere da parte del popolo,
non limitato da altra istituzione od ordine politico, ricrea le stesse condizioni che determinarono
l’instaurarsi del dispotismo.
Il “meccanismo” mediante il quale si corrompe, a poco a
poco, o per dir meglio è “consumato”, l’insieme dei valori che
costituiscono la trama essenziale del costume sociale, è sostanzialmente identico a quello delle altre
costituzioni: anche il
popolo viene a poco a poco corrotto dall'esercizio del potere
sovrano; la sua volontà non si determina sul piano della consapevolezza razionale, ma su quello
delle passioni, dei sentimentalismi. Anche il popolo, più del monarca, è sensibile alle
lusinghe, al fascino dei demagoghi che sanno blandirlo, commuoverlo, suscitare la sua ira e il suo
furore, il suo sdegno,
trovare con arte sottile la strada giusta per pervenire al suo
cuore e servirsi delle sue stesse passioni più nobili per convincerlo della sua assolutezza, del fatto
che la sua volontà è sopra la stessa legge,
La storia della democrazia per eccellenza, quella d’Atene,
ci fornisce ammaestramenti utili sul rapido processo di degenerazione del sistema democratico e su
come il potere del popolo si trasformi nella più spietata delle tirannie. Si comincia
con l’allontanare a poco a poco dal governo gli uomini più illustri e più capaci, che non sanno
indulgere a favorire o a blandire le passioni del popolo: il principio della assoluta
eguaglianza di tutti i cittadini trova in tal modo una prima
applicazione, per ispirare poi tutte le istituzioni politiche del
regime democratico, con l’unico risultato di eliminare dalla
vita politica quanti con la loro personalità, o con la loro posizione sociale, possono elevarsi al di
sopra della media dei cittadini. L’ostracismo è l’istituto che, più d’ogni altro, esprime
lo spirito egualitario che anima le democrazie, che finisce con
l’allontanare i migliori dalla vita politica e col dividere il popolo in contrapposte fazioni, ognuna
delle quali convinta di
perseguire il bene della collettività. La volontà del popolo, come quella del tiranno, non trova
più una sua interna e coerente stabilità, ma credendo d’interpretare sempre e comunque il giusto e
l'onesto, muta a seconda delle situazioni, e soprattutto delle suggestioni, finendo
col perseguire unicamente il particolare interesse della maggioranza dei cittadini che formalmente la
esprime. La storia d’Atene ci ricorda provvedimenti della più palese ingiustizia,
in cui vennero obliate le più elementari norme della convivenza civile: come non rammentare,
questo proposito, il provvedimento dell'assemblea ateniese, durante la prima fase
della guerra peloponnesiaca, con il quale, onde escludere una
parte del popolo dalla distribuzione del grano inviato dal re
di Egitto durante il periodo della carestia, tolse a cinquemila
Ateniesi il diritto di cittadini, confiscando i loro patrimoni e
disponendo nel contempo, cosa ancora più abominevole, che
fossero venduti come schiavi?
Non può negarsi certo che la stravaganza, il capriccio,
l’ira, il furore, la persecuzione ingiusta e malvagia, la prevaricazione a danno dei singoli e delle
minoranze sono continuamente presenti nella storia della democrazia ateniese e ci ammoniscono
che il popolo può essere, a volte, più tiranno dello
stesso Nerone. Le vicende politiche ateniesi dimostrano inoltre che la democrazia non riesce a
garantire la tranquillità, la
sicurezza, la libertà dei singoli cittadini: anzi il principio della
sovranità del popolo non conduce ad altro risultato che a
quello di legittimare le fazioni e le loro lotte, al cui termine il
vincitore di turno aveva il diritto dì opprimere, esiliare, bandire, a volte condannare a morte i suoi
avversari. La vita,
l’onore, gli averi di un cittadino erano garantiti unicamente da
un'incerta, effimera maggioranza che sosteneva la fazione cui
apparteneva o che lo annoverava fra i suoi seguaci: Atene è la
città che bandi Temistocle, che ostracizzò Aristide, che costrinse all'esilio Milziade, che allontanò
Anassagora e che uccise con il veleno Socrate.
Il governo democratico era incapace di esprimere una volontà politica unitaria ed omogenea, in
grado dì realizzare in
concreto il benessere collettivo, proprio perché si fondava su
di una fiducia popolare “fragile”, e quindi variabile, a motivo
del sospetto con il quale il popolo riguardava sempre i governanti per il timore di essere sminuito
nella sua autorità o addirittura di essere privato della sua potestà sovrana. È questa,
in sostanza, la profonda antinomia della costituzione democratica, una volontà che diffida di se
stessa, una volontà in sostanza sterile, che non riesce a tradursi in atto, proprio perché
sottopone ad un continuo controllo gli strumenti del suo volere e tende a renderli poco efficienti. In
questo regime un
generale non poteva né vincere né perdere una battaglia, un
filosofo non poteva usare di quella libertà della quale godevano invece tutti gli altri cittadini: la
libertà politica, paradosso del regime democratico, non ammetteva la libertà di
pensiero.
L’instabilità, in sostanza, è la caratteristica fondamentale
del regime democratico: la politica si riduce ben presto alla
lotta delle opposte fazioni per assicurarsi il potere, conquista
sempre effimera; ir1 questa costituzione, di volta in volta, si
succedono, come è stato acutamente notato sin dall’antichità,
il governo monarchico, del demagogo cioè che riesce a concentrare su di sè il favore popolare,
quello aristocratico del
ristretto gruppo che riesce a orientare le decisioni dell’assemblea ed a farsi nominare ai posti di
comando infine quello
popolare, quando in alcune occasioni il governo, cioè gli atti
che gli competono, vengono direttamente assunti dall'assemblea stessa. La costituzione democratica
è un caotico alternarsi di forme di governo in una lotta spossante che finisce
con lo stremare e col ridurre all'indigenza la società politica:
<< Siccome vi è un perpetuo mutamento, uno che si innalza e
l'altro che decade, voi avrete tutta la violenza e una politica
malvagia, con cui un potere che nasce deve sempre acquistare
la sua forza, e tutta la debolezza dalla quale gli Stati che decadono sono portati alla completa
distruzione >>.
Si è dimostrato in tal modo che le tre forme tipiche di governo, monarchica, aristocratica,
democratica, non sono che
tre diversi aspetti dell'unica fondamentale forma di governo,
il dispotismo: pure, osserva Burke, al fine di eliminare qualsiasi eventuale perplessità, possiamo
ammettere chele tre
forme di governo di cui si è parlato abbiano realizzato nel
corso dell’esperienza storica, e tuttora realizzino, un certo
grado di libertà, di sicurezza, di tranquillità per i cittadini. Ma
anche questa concessione alla tesi degli avversari serve a ben
poco, allorché intendiamo considerare la questione nella sua
interezza, se la società “artificiale” è un bene o un male per
gli individui che la costituiscono.
Occorre tener conto che le tre forme di governo di cui si
è trattato garantiscono, nella migliore delle ipotesi, la libertà
politica ad un ristrettissimo numero d'individui: ad Atene il
numero dei cittadini oscillava fra i diecimila e i trentamila, ma
gli schiavi ammontavano a circa quattrocentomila, e in determinati periodi superarono anche questo
numero. A Sparta il numero dei cittadini liberi era, proporzionalmente agli schiavi
e agli Iloti, molto inferiore a quello d'Atene. Queste osservazioni possono essere fatte a tutti gli
ordinamenti politici dell’antichità, e come vedremo, alla maggior parte di quelli moderni.
Se si tiene conto che gli Stati che hanno informato il loro
ordinamento politico a principi, sia pur formali, di libertà
sono un’esigua minoranza rispetto agli altri, e che all’interno
di questi stessi Stati i liberi sono un'altra esigua minoranza,
dobbiamo necessariamente ritenere dopo quanto si è detto nel corso dell’esame delle singole forme
di governo, che la società “artificiale” non è assolutamente in grado di assicurare
agli uomini il godimento di quei diritti e di quel benessere per
i quali sarebbero state costituite. L’ordine politico “artificiale”, considerato nelle sue manifestazioni
tipiche e con riferimento non a questa o quella singola esperienza storica, ma a
tutto il genere umano, non si riduce ad altro che ad una
ristretta oligarchia che si mantiene al potere mediante l’uso
spietato della forza: il governo popolare, pertanto, è un puro
nome, che non ha alcun riscontro con la concreta realtà istituzionale della società politica.
Come si è visto la monarchia, l’aristocrazia e la democrazia non corrispondono ai fini per i quali è
stata fondata la società “artificiale”: ma, si dirà, le forme di governo non sono
esaurite, gli uomini nella loro secolare esperienza, ammaestrati
dai mali subiti dalle precedenti costituzioni, hanno cercato di
ovviare agli inconvenienti, mediante la fusione delle tre forme
di governo in una sola costituzione, la quale, conservando i
principi della monarchia, dell’aristocrazia e della democrazia,
riuscisse nello stesso tempo ad eliminare i gravi difetti di ciascuna. È la costituzione “mista" o
governo “misto", che per
molti scrittori politici sembra aver finalmente garantito alla
società la stabilità dell’ordine politico nel rispetto dei diritti e
della libertà dei membri della società.
La costituzione mista, se esaminata con animo veramente
critico e spoglio di pregiudizi, rivela ben presto la sua inconsistenza, la sua incapacità a realizzare
gli scopi che le sono
prefissi, dato che la pretesa di attuare un reciproco controllo
ed un bilanciamento fra le forze sociali, che si esprimono politicamente nella monarchia,
nell’aristocrazia e nella democrazia, è irrealizzabile e, all'atto pratico, pone in essere una
costituzione così macchinosa da generare, nella società, degli stati
di tensione politica fra i diversi ordini che costituiscono una
continua minaccia all’unità stessa dello Stato. Sono proprio le
osservazioni sulla costituzione mista e quelle che seguono, a
proposito delle fondamentali istituzioni civili sulle quali si
regge l’organizzazione della stessa società, che consentono di
rilevare come la critica di Burke si riferisce, a volte in modo
palese, alla vita politica inglese della prima metà del settecento, e cosa ancor più interessante, alla
situazione sociale,
che sembrava riprodurre in Inghilterra l'antica distinzione
dello Stato classico fra liberi e schiavi.
Non possiamo nasconderci, precisa Burke che le diverse
“parti" che costituiscono la costituzione mista, hanno, o per
lo meno rivendicano, ciascuna una propria autonomia e distinta funzione, che non sono però
specificate con regole precise. I loro diritti sono quanto mai vaghi sì che quando si
pongono questioni che per essere risolte richiedono condivise
interpretazioni e concordi accertamenti di responsabilità, si
hanno invece discussioni, controversie che hanno come unico
scopo quello dì lasciare impuniti gli abusi che sono commessi
nell’esercizio delle pubbliche funzioni. In tal modo, quel controllo che la costituzione mista
dovrebbe garantire su quanti
sono incaricati della cosa pubblica viene sostanzialmente a
mancare, onde, a poco a poco, gli abusi stessi sono prima tollerati e poi legittimati: la pratica,
quindi, dell’esercizio di poteri di fatto, non previsti dalle leggi, diventa sempre più diffusa e finisce
nel tempo col modificare il costume civile e politico, affermando il principio dell’assoluta impunità
per tutti
quelli che partecipano al governo della cosa pubblica.
L’inconveniente più grave, che provoca delle conseguenze
dannosissime, è indubbiamente quello che si riferisce ai rapporti dei tre ordini, il monarchico,
l'aristocratico, il democratico. Benché uniti nella stessa costituzione, ciascuno di loro
serba intatto, se così possiamo dire, il proprio spirito di
corpo, e costituiscono tre parti separate e distinte, ciascuna
gelosissima delle sue attribuzioni, delle sue prerogative, delle
sue tradizioni, onde le relazioni che si istituiscono fra di esse
sono improntate alla reciproca diffidenza: il re ambizioso, la
nobiltà orgogliosa, il popolaccio sempre tumultuoso, pronto
alla rivolta e ingovernabile.
Formalmente ogni “parte” sembra voler convivere pacificamente con le altre, ma il suo costante, se
pur segreto, proposito rimane quello di “insidiare” le posizioni delle altre, di
diminuirne il prestigio e il potere, onde accade che nelle questioni di una qualche importanza sia
che riguardino gli affari
interni che quelli esterni, si considerano i provvedimenti da
assumere più per quanto attiene agli eventuali vantaggi che
possono provenire a questa o quella parte, che per la bontà
intrinseca degli stessi provvedimenti e ci si preoccupa di vedere se le leggi richieste aumentano o
diminuiscono i poteri
della Corona, se restringono od allargano i diritti dei cittadini. Così i più urgenti e gravi problemi
della società sono
normalmente risolti senza alcuna particolare considerazione
per quanto riguarda la garanzia del bene pubblico, ma unicamente in vista degli interessi particolari
di questo o quel partito, con l’ovvia conseguenza che la famosa e tanto vantata
“bilancia” dei poteri non è mai in equilibrio ma in effetti
pende sempre o da una parte o dall'altra, con “oscillazioni”
che turbano profondamente l’ordine politico e civile della
stessa società.
Per tal motivo, il governo, nella costituzione mista o “bilanciata”, si riduce di volta in volta ad
essere l'espressione di
uno solo, del monarca, che si serve del potere politico a suo
esclusivo arbitrio, o di un’astuta “confederazione” di pochi
avente lo scopo di ingannare il principe e di opprimere il popolo, oppure di una frenetica ed
ingovernabile moltitudine. Si
tenga inoltre presente, dopo quanto si è detto, che l’anima
della costituzione mista è il partito, e che lo spirito che accomuna tutti i partiti e che li determina
nella loro azione politica è quello dell'ambizione, degli interessi particolaristici: il
partito si sostituisce, a poco a poco, alle istituzioni politiche,
onde tutti i valori ed i principi del costume pubblico vengono
rapportati unicamente agli interessi partitici.
Ed è proprio questo spirito, osserva Burke, che alla fine
distrugge tutti i principi che una natura benevola ha posto in
noi, che finisce con l’annullare qualsiasi sentimento d’onestà,
di `giustizia, che vanifica molte volte perfino i legami della società naturale, cioè l’affetto che
unisce i componenti di una
stessa famiglia. Così l’esperienza della vita politica, quale si
svolge nell'ambito della costituzione mista, ci rende chiaro
che il governo che si esercita per il tramite dei partiti si riduce
di solito ad una vera e propria oppressione simile a quella del
dispotismo, e a volte del tutto uguale ad una vera e propria
tirannia.
Il peggio è che l’opinione pubblica in fondo finisce con
l’accettare questo stato di cose, proprio. perché siamo abituati
a vedere che i più sacrosanti diritti sui quali si fonda l’ordine
della società diventano oggetto di quotidiani compromessi,
senza alcuna preoccupazione di giustificarli, salvando almeno
le forme apparenti della giustizia. Ebbene, osserva Burke, noi
consideriamo tutto questo senza la benché minima emozione,
proprio perché siamo cresciuti in questa pratica: non ci sorprendiamo affatto che si richieda ad un
uomo dì essere un
impostore o un traditore con la stessa semplicità con la quale
gli si domanda di solito un favore, e siamo infine abituati a
vedere rifiutate queste richieste, non perché contrastano con i
più elementari principi della giustizia e della morale, ma perché l’interessato ha già aderito ad
analoghe profferte formulate da altro partito.
Tutte queste osservazioni potrebbero essere ulteriormente
illustrate con altri argomenti, desunti dalla ricca “fenomenologia” della vita politica propria della
costituzione mista: non
rimarrebbe che l’imbarazzo della scelta. Basterà accennarne
solamente alcuni. Si esalta ad esempio la tolleranza che è possibile attuare solamente nella
costituzione mista: certo noi
siamo liberissimi di criticare la costituzione cinese o di condannare, tanto per fare un esempio, i
trucchi e l’assurda bigotteria dei bonzi, ma non appena queste critiche sono mosse
al costume politico inglese ed alla religione da noi in auge si
viene immediatamente tacciati di ateismo e di tradimento, con
tutte le relative conseguenze. La storia politica inglese, d'altro
canto, ci consente di rilevare che lo stesso partito dapprima
ha sostenuto la legittimità della resistenza armata del popolo
contro la monarchia e poi non ha esitato a giustificare una
prerogativa regia così estesa da confinare con il più rigido degli assolutismi. Sempre la storia
inglese non ci avverte che non abbiamo
mai avuto un parlamento, il quale mentre si preoccupava di fissare dei limiti alla prerogativa regia,
nello stesso tempo cercava di porre dei limiti a se stesso? Non sono mancati i Re che
per mezzo della violenza o della frode hanno tentato di violare la costituzione? I tentativi di
riformare i gravissimi difetti
della nostra costituzione, più e più volte denunciati, non
hanno fatto altro che aggravare i mali lamentati? E così la nostra tanto vantata libertà a volte è
addirittura calpestata, a
volte è portata vertiginosamente in alto, sì che essa ha un’esistenza del tutto precaria, condizionata
dalle contese, dalle
guerre, dai complotti. Non c’è nessun altro paese d’Europa in
cui il patibolo è stato così spesso arrossato dal sangue dei nobili: confische, esili, processi,
esecuzioni ricorrono continuamente nella storia delle famiglie aristocratiche, molte delle
quali furono distrutte. Certo la vita politica non è caratterizzata più da quegli episodi di ferocia e di
sangue: bisogna riconoscere che l’esperienza politica è riuscita a trovare altri
mezzi di governo diversi da quelli che si fondavano sulla
spada. Bisogna anche ammettere che, in definitiva, sono forse
preferibili i vecchi, spietati, ma leali mezzi di governo, ai
nuovi che si fondano sulla corruzione e sul tradimento.
L’esame della società “artificiale” non deve limitarsi, per
Burke, alla costituzione, al modo con cui è regolato l'esercizio
del potere politico, ma deve essere anche esteso a quelli che
sono gli “strumenti” essenziali della vita “civile” e sociale dell’individuo, alle istituzioni
fondamentali, alle reali condizioni
di vita della maggioranza degli individui nella società “artificiale". In questo caso Burke riprende le
critiche rivolte alle
condizioni della società inglese del suo tempo e che il pensiero politico illuministico, in particolare
quello di Bolingbroke, non prendeva in alcuna considerazione.
È stato da molti osservato, anche Locke lo ha detto, che
uno dei più grandi inconvenienti della società naturale è che
ogni individuo, qualora gli sia stato fatto un torto, debba essere giudice della sua stessa causa. Per
tal motivo una delle
istituzioni fondamentali della società “artificiale”, forse quella
che la caratterizza, deve ravvisarsi nel fatto di affidare ad un
terzo, estraneo agli interessi dei contendenti, la soluzione
della controversia. Ben presto però ci si accorse che la garanzia della vita, degli averi, dell’onore
degli individui era affidata
ad una volontà, quella del giudice, del tutto arbitraria, perché
non soggetta ad alcun controllo: invece di garantire la libertà
degli individui mediante un giudizio imparziale e disinteressato si erano sottoposti gli individui
stessi ad un potere che si
rivelò ben presto insopportabile. Si pensò allora di limitare la
volontà del giudice mediante le leggi, che avrebbero dovuto
garantire un giudizio obiettivo, e quindi giusto.
Introdotte le leggi, ci si rese conto che le stesse, nella loro
semplicità e. brevità lasciavano ancora troppa libertà al giudice: occorreva aggiungere alle vecchie,
nuove leggi, che precisassero ed integrassero le prime. Si riscontrarono nuove,
gravi difficoltà, che resero macchinosa e complessa l’amministrazione della giustizia. Le nuove
leggi ponevano difficili problemi interpretativi per quanto riguardava i rapporti con le
vecchie: la terminologia giuridica era diventata complessa, per
cui la necessità di ricorrere ai commenti, alle glosse, alle relazioni, ai rerponsa prudentum. Gli
uomini, che avevano inventato le leggi per regolare i loro rapporti, erano diventati poco
a poco prigionieri delle loro stesse leggi, trasformate in uno
dei più validi strumenti di soggezione e di oppressione.
A motivo dell'interpretazione il diritto è diventato una
scienza complessa, appresa da una ristretta categoria di persone, che detiene il monopolio della
conoscenza e dell’applicazione delle leggi, le quali, peraltro, erano state inventate affinché ogni
individuo potesse sapere con certezza quali fossero i suoi diritti e quali le relative garanzie. La
certezza del
diritto è in sostanza una pura illusione: chi consideri la complessa macchina dell'amministrazione
della giustizia dovrà
convenire che sono proprio le leggi a rendere incerti, confusi,
aggrovigliati i rapporti degli individui nella società. “La confusione cresce, la nebbia si fa più
spessa, sèno al punto che
non si è più in grado di stabilire quello che è permesso o
quello che è proibito, quali sono le cose di nostra proprietà della comunità. In tale incertezza
(incertezza per uno
specialista, ma vera oscurità simile a quella che nasconde la
lingua egiziana all'umanità) le parti che si costituiscono in
giudizio sono rovinate più per la lunghezza dello stesso giudizio che per l'ingiustizia di una
qualsiasi decisione. Le nostre
eredità sono ormai diventate il prezzo delle dispute giudiziarie e queste diventano la nostra eredità”.
Si tenga inoltre presente, continua Burke, che i professori
della legge “artificiale” sono sempre intimamente legati a
quelli della teologia “artificiale'‘. In fondo il loro scopo è
identico: essi hanno, ciascuno nel suo campo, elaborato le rispettive dottrine in modo da
“confondere la ragione dell’uomo e da incatenare la sua libertà naturale". I teologi non
esitano a scagliare i loro anatemi contro chi osa venir meno ai
doveri sanciti dalle leggi artificiali e dal canto loro gli uomini
di legge professano verso il diritto una venerazione di tipo religioso, che si esprime nel rigido e
solenne formalismo, con il
quale hanno rivestito tutti i rapporti che si costituiscono fra le
persone ne a società.
La conseguenza dell'intimo nesso che è stato stabilito fra
la legge “artificiale" e la teologia “artificiale” si rende evidente
non appena noi ci rivolgiamo al giudice affinché venga garantito un nostro diritto: non si discute
sulla “cosa” che interessa
chi promuove il giudizio, ma sulle forme che sono state usate,
o che si sarebbero dovute usare per quel determinato diritto
e in quella determinata vertenza: l’oggetto principale della lite
viene immediatamente perso di vista e tutta la sapienza si
esercita unicamente sulle parole, sulle formule, la cui presenza
o la cui assenza può decidere del patrimonio, dell’onore, a
volte della vita di un individuo.
La proprietà, è stato detto, è la prima e vera garanzia della
tranquillità, della sicurezza, della libertà dell'individuo e di
conseguenza la tutela della proprietà è la condizione essenziale perché siano garantiti l’ordine e la
pace, senza le quali
non può esistere alcuna società politica. Orbene, non appena
una persona si rivolge al giudice, deve rendersi conto a sue
spese che la tutela che le leggi dovrebbero garantirgli è una
parola vana: L’amministrazione della giustizia è cosi complessa, cosi macchinosa, la procedura cosi
complicata, che a
causa delle spese del processo rischia di perdere prima che sia
decisa la causa. E quando dopo tante fatiche, dopo tanti affanni, ottiene una sentenza favorevole, la
vittoria è spesso
vana: l’avversario riesce sempre a trovare un errore commesso
nel corso del giudizio che giustifica il proseguimento della
causa presso un’altra corte: << La mia causa, che due agricoltori avrebbero deciso in mezz’ora,
impegna invece la corte per
vent’anni. Quando arrivo alla fine della mia fatica ed ottengo
in compenso del mio lavoro e delle vessazioni subite una decisione favorevole, un astuto
comandante del campo avversario trova un errore nella procedura seguita: il mio trionfo si
trasforma automaticamente in lutto. Si scopre che ho usato
“o” invece di “e”, o qualche altro errore: rinnovo così la mia
causa, vado di corte in corte, passo da quella d’equità a quella
di “state law" e un'eguale incertezza mi attende ovunque; in
tal modo un errore al quale io non ho partecipato decide improvvisamente della mia libertà e della
mia proprietà, inviandomi dal tribunale alla prigione e trascinando la mia famiglia
nella povertà e nella fame. Signori, io sono del tutto innocente
dell’oscurità e dell'incertezza della vostra scienza. Io non ho
reso oscura questa scienza con nozioni assurde e contraddittorie, né l'ho confusa con l’inganno e
con i sofismi. Voi mi
avete escluso in tutti i modi dalla condotta della mia causa
con il motivo che la scienza era troppo profonda per le mie
cognizioni, il che riconosco: ma era troppo profonda anche
per voi, e avete reso la via così intricata, si che alla fine vi ci
siete perduti voi stessi, La conclusione di tutto questo è che
voi sbagliate e poi punite me per i vostri errori ».
Né può essere sottaciuta un’altra grave incongruenza del
sistema giudiziario e processuale: per quanto è tarda e lenta la
giustizia allorché tratta di questioni attinenti al patrimonio
delle persone, altrettanto è sollecita, rapida quando è investita
di questioni la cui definizione implica la vita o la morte di un
individuo: riesce veramente incomprensibile comprendere
come mai quando sono in gioco interessi, indubbiamente importanti, ma non essenziali, la giustizia
si circondi di tante
cautele e proceda con una circospezione così eccessiva da ingenerare gli inconvenienti che si sono
lamentati, ed invece
quando si deve decidere su interessi essenziali, quali la vita,
l'onore, la libertà della persona, quegli accorgimenti, tanto necessari per garantire i beni supremi
dell’individuo, sono invece del tutto omessi.
I “politici” hanno sempre sostenuto che lo scopo fondamentale delle leggi, come si è già ricordato, è
quello di garantire la sicurezza, la tranquillità, la vita, l'onore, il patrimonio
di tutti gli, individui che costituiscono la società, di assicurare
la giustizia a tutti al fine di difendere il povero e il debole
dalle sopraffazioni del ricco e del potente. Ma, ancora una
volta il richiamo ai reali e concreti rapporti di fatto consente
di dimostrare quanto tale affermazione è, in sostanza, astratta:
in un sistema giudiziario il cui costo è altissimo, la giustizia è
riservata esclusivamente ai ricchi ed i poveri, di fatto, sono
esclusi da quelle garanzie, da quella tutela e difesa dei loro interessi e diritti, per le quali fu invece
costituita la società “artificiale". Nella società naturale l'individuo poteva sempre difendersi contro
le sopraffazioni del suo simile più forte, aveva
sempre il diritto di soddisfarsi del torto subito esercitando
un’azione di rappresaglia mediante la sorpresa o l'astuzia:
<< invece nella società politica “artificiale” il ricco può derubarmi in mille modi, né io posso
difendermi, dato che il denaro è l'unico mezzo mediante il quale io sia autorizzato a
combattere, E se io oso vendicarmi l’intera forza di quella è
pronta a completare la mia rovina ».
L’esame della società “artificiale” non può dirsi completo
se non prendiamo in considerazione, nel suo vero ed autentico significato, la distinzione cui si è
accennato fra ricco e
povero, su cui, in ultima analisi, riposa l'intero ordine politico
e sociale della società. I ricchi sono pochi e i poveri costituiscono la stragrande maggioranza della
società “artificiale”: il
sistema è organizzato in modo tale che ai poveri è imposto
l’onere di fornire i mezzi che consentano ai ricchi di vivere
nell’ozio e nel lusso, e che i ricchi hanno l’unica preoccupazione di escogitare i mezzi migliori onde
mantenere i poveri
nella schiavitù. La soggezione che sottomette il povero al
ricco, questo è il rapporto fondamentale su cui si fonda il
complesso meccanismo dei comandi e delle obbedienze che
consente il “funzionamento” della società “artificiale”.
Certo nella società di natura una delle leggi fondamentali,
se non la prima, è quella che sancisce che i nostri acquisti
debbano essere in proporzione del nostro lavoro: ma nella società politica questa stessa legge è
capovolta: chi lavora ha
poco o niente e chi non lavora gode, invece, dei benefici e dei
vantaggi derivanti delle fatiche altrui. Noi, in verità, non
Siamo abituati a considerare. tale aspetto della nostra società,
benché, quotidianamente, ci cadano sott’occhio moltissimi
episodi che vi si riferiscono direttamente.
Nella sola Inghilterra, ad esempio, più di centomila persone lavorano nelle miniere per le industrie
tanto necessarie alle nostre esigenze “civili": << Queste persone infelici appena
vedono la luce del giorno, esse sono seppellite nelle viscere
della terra, ove lavorano in un durissimo e spaventoso mestiere senza la minima prospettiva di
potersene un giorno liberare; si nutrono del peggior vitto, la loro salute si deteriora
miserabilmente, la loro vita è notevolmente accorciata dal
fatto di trovarsi continuamente confinati fra i dannosi vapori
di questi minerali. Altre centinaia di migliaia di persone sono
torturate senza remissione dal fimo soffocante, dal fuoco intenso e dalla continua fatica necessaria
per manipolare, e raffinare i prodotti delle miniere >>.
Questo è quanto possiamo dire dell'Inghilterra: ma è ben
poca cosa se estendiamo la nostra analisi agli altri Stati ed alle
altre collettività sparse nel mondo. Allora possiamo dire senza
correre il rischio di. essere smentiti che << milioni di uomini
ogni giorno fanno il bagno nei velenosi vapori e nei distruttivi
effluvi del piombo, dell'argento, del rame, dell'arsenico. Per
non parlare di altri lavori, pieni di miseria e di disprezzo, nei
quali la società civile ha sistemato i numerosi enfant perda:
della sua armata >>. Così la società “artificiale" nasconde accortamente nel suo seno una schiavitù
forse più intollerabile
dell’antica: essa in sostanza è un meccanismo che rende possibile l'oppressione, lo sfruttamento dì
pochi nei confronti
della stragrande maggioranza.
Pure, si dirà, tutto questo è necessario, non può che essere così, affinché almeno pochi, i ricchi,
possano essere felici:
ma anche questa è un'illusione, l'ultima, di quanti credono
nella positività della società “artificiale”. I ricchi, infatti, possono essere distinti in due categorie:
quelli che s’interessano
della cosa pubblica e che si dedicano quindi all’attività politica e quelli che vivono nell’ozio, dediti
unicamente ai piaceri
ed a consumare le ricchezze prodotte da altri. Per i primi la
vita si trasforma ben presto in una serie di continui affanni, di
dolori, d’amarezze, di cocenti delusioni, di roventi gelosie, di
preoccupazioni, tormentati continuamente da un’ambizione
che non viene mai soddisfatta. La politica a poco a poco li
trasforma, indurisce il loro cuore, li rende incapaci di sentire
qualsiasi affetto, di godere l'amicizia; il loro animo si fa gelido, lì rende veramente insensibili a
quanto alimenta e costituisce l’umanità dell'uomo, ed alla fine li lascia stanchi, disillusi, amareggiati
per non aver potuto conseguire il sogno di
grandezza: in una parola, infelici.
Consideriamo ora l'altra “specie" dei ricchi, “quelli che
dedicano il loro tempo e le loro fortune all'ozio e al piacere".
In fondo anche questi sono degli infelici. Si tenga presente a
tal proposito che i piaceri che procurano reali e durevoli soddisfazioni sono quelli naturali, e quindi
comuni a tutti gli individui, ricchi e poveri. I piaceri invece che derivano dalle arti
e dalle invenzioni umane non ottengono mai il loro scopo: essi
richiedono una raffinatezza sempre più sottile e nello stesso
tempo più complessa, onde impegnano l’individuo in una ricerca di nuove esperienze in grado di
sostituire le vecchie, ormai esaurite, che si fa a poco a poco più laboriosa, più pesante, finché
finisce, con la fatica che comporta, con lo stancare chi la persegue. Il piacere alla fine si distrugge e
lascia al
suo posto uno stato d'incontentabilità, tanto più acuta quanto
più intensa e più lunga è stata la ricerca del piacere stesso.
Si tenga inoltre presente che in questa spasmodica ricerca
del piacere la mente perde gradatamente il suo vigore intellettuale e non riesce più ad intendere la
verità e con ciò stesso
non è in grado di riconoscere la felicità. In fondo la società
artificiale parifica il povero e il ricco per quanto riguarda
l’impossibilità perle due categorie di pervenire alla felicità:
<< I poveri per il lavoro eccessivo e i ricchi per l’eccessiva lussuria sono messi allo stesso livello,
sono resi egualmente ignoranti di quel sapere che può condurli alla felicità. Una vista
ben miserevole della vita ir1terna d’ogni società civile! La
classe più umile è angariata ed abbrutita dalle più crudeli
delle oppressioni, e i ricchi con il loro artificiale metodo di
vita si procurano i peggiori dei mali, quegli stessi mali che con
la loro tirannia infliggono alle persone sottomesse al loro potere >>.
Infine, l'ultimo argomento in difesa della società “artificiale”, che l’ineguaglianza sociale cui si è
accennato, con tutte
le conseguenze, è necessaria onde consentire la nascita e l’affermarsi delle “arti”, senza le 'quali non
è possibile la vita civile, dopo tutto quello che si è detto mostra chiaramente la
sua radicale ir1consistenza, si risolve cioè in una petizione di
principio. La società “artificiale” è necessaria per l'esistenza
delle arti, e queste sono necessarie perche possa sussistere la
società: un argomento che in realtà non spiega nulla, e dimostra solamente che quando noi
cerchiamo di dare una spiegazione plausibile, una giustificazione alla società “artificiale”,
in realtà ci rinchiudiamo in un circolo vizioso dal quale non
siamo poi più in grado di uscire.
Burke è così giunto alla fine della sua analisi della società
“artificiale” e può riassumere i risultati del suo esame, che
come ha precisato all’inizio è stato condotto attenendosi allo
stesso metodo con il quale Bolingbroke aveva studiato i rapporti fra la religione naturale e
l'artificiale: essi sono decisamente negativi. La società civile è la causa di tutti i mali di cui
soffrono gli individui, tutti, come abbiamo visto, ricchi e poveri. Il genere umano, organizzatosi
politicamente nelle società “artificiali”, si è diviso in tante collettività particolari,
ciascuna animata da odio, da intolleranza nei confronti delle
altre, che si sono nel corso della storia distrutte a vicenda: la
storia Lunana, a motivo della presenza della società “artificiale” che concentra nelle mani di pochi
un immenso potere
di distruzione al servizio delle passioni più abbiette, frutto
anch’esse della stessa società e sconosciute in quella di natura,
si riduce ad un bellum omzzium comm omnes, ad una pura
lotta per il predominio, nella quale gli uomini finiscono col
distruggere se stessi. L'ordine politico costituzionale, in qualsiasi forma è considerato, si riduce ad
un dispotismo più o
meno nascosto, più o meno giustificato dal punto di vista formale; il rapporto di soggezione su cui
si fonda il potere politico è connaturato con la prima relazione che si istituisce fra
gli uomini, basata sull'assoggettan1ento del povero al ricco,
sulla quale si struttura tutta la vita della società.
<< Considerate, osserva infine Burke, ancora una volta il labirinto delle leggi, la iniquità connessa
con la loro oscurità. Considerate le malvagità commesse nel seno di tutte le collettività
dall’ambizione, dall’avarizia, dall’invidia, dalla frode, dall'aperta
ingiustizia e dalla pretesa amicizia: vizi i quali trovano scarsa
possibilità di affermarsi, nella società di natura, ma che fioriscono e prosperano nella società
artificiale. Considerate tutto il
nostro discorso: aggiungete tutte quelle riflessioni che vi possono essere suggerite dal vostro
intelletto e fate uno sforzo per
sollevarvi sopra la filosofia volgare, onde confessare che la causa
della società artificiale è impossibile come quella della religione
artificiale, che essa in fondo costituisce una deroga all’onore del
nostro Creatore, così come sovverte la ragione umana e produce
un male senza fondo per il genere umano >> .
QUARTO CAPITOLO
LA CONCEZIONE DELLA SOCIETÀ
NELLA PHILOSOPHICAL ENQUIRY
Ai fini dello studio delle origini del pensiero politico di
Burke, i problemi posti dalla vindication debbono essere ulteriormente approfonditi e considerati
alla luce degli altri due
più importanti scritti del primo periodo dell'attività letteraria
del Nostro fra il 1756 e il 1760, A Philosophical Enquiry into
the origin of our ideax of the Sublime and Beatzful, pubblicato per la prima volta nel 1757, e An
Esmy towards un Abridgment of English History, che scrisse, per conto dell’editore
Dodsley fra il 1757 e il 1762 e che fu pubblicato postumo nel
1815. Il primo è un_ saggio d’estetica che impegna Burke ad
un’analisi dei rapporti fra la ragione e le passioni, cioè fra la
ragione e la sfera del_ sentimento e dell’immaginazione e
quindi ad un più diretto confronto, anche se non formalmente esplicitato, con la filosofia dì Hurne.
Il secondo è una
sintesi della storia inglese, che si riferisce alla formazione della
nazione e del suo ordinamento politico dalla dominazione romana al regno di Giovanni senza terra e
alla concessione della
Magna Carta (1216), con cui furono per la prima volta sancire
le libertà inglesi. Il pensiero di Burke si orienta quindi verso una concezione della politica che,
grazie ad una analisi delle
passioni e dei sentimenti degli uomini, sia in grado di rendersi
conto del ruolo che le stesse passioni hanno nella formazione
e nella dinamica della società politica, che trova poi nella storia la sua ulteriore e più compiuta
determinazione.
Della produzione burkiana del primo periodo lo scritto
più noto e di maggior successo è indubbiamente l’Enquiry, di
cui Burke curò una seconda edizione nel 1759 con varianti ed
aggiunte, fra cui la più importante è 1"Introduzione" dedicata
alla definizione ed analisi del concetto di “gusto”, scritta in
“risposta” all’analogo saggio di Hume, di cui Burke non aveva
potuto tener conto, essendo stato pubblicato pochi mesi prima. La distinzione fra l'idea del bello e
quella del sublime
impegna Burke nell’analisi delle passioni, considerate come
<< organi della ragione », e da un punto di vista più generale,
di ciò che attiene alla sfera del sentimento, soprattutto per
quanto riguarda la sua capacità di saper percepire ed anticipare le conoscenze della ragione. Si tratta
di rendersi conto di
ciò che viene prima della ragione, di ciò che la promuove e la
orienta, di ciò che le consente di potersi “impadronire” della
realtà che intende conoscere.
Il sentimento, le passioni, rappresentano l’unione “vitale"
fra il soggetto e la “cosa” oggetto della passione: il sentimento
si manifesta così come esperienza “vissuta”, che deve essere
analizzata per poter comprendere il fine specifico cui tende.
Questa indagine ha un rilievo anche per la politica, dato che
fra le passioni che sono proprie dell’animo del singolo individuo vi sono quelle che si riferiscono
alla << più generale società
che ci unisce agli uomini e agli altri animali e che possiamo in
un certo senso dire ci unisca anche col mondo) inanimato >>. Per Burke la società è un “mondo
umano", è una
“totalità” che è il risultato di tutte le attività dell’uomo. Si
tratta pertanto di “superare” il razionalismo proprio di una
conoscenza meramente (perché rigorosamente) empirica, che
produce solamente verità aride e prive di vita, per far valere
esigenze che scaturiscono dai nostri più veri ed autentici sentimenti. Si pongono così le premesse di
una critica della filosofia di Hume, in particolare del suo scetticismo accademico,
per i suoi effetti negativi non solo sul sentimento religioso, ma
anche per la coerenza e costanza degli uomini nell'assolvere ai
loro impegni sia privati che pubblici, rilievo cui già si accenna
nelle “Note sulla religione”.
Occorre riconoscere la specifica autonomia ed originarietà della religione, quale si coglie
nell’esperienza religiosa,
tramite la fede, il sentimento e la ragione. Come sappiamo,
l'unione della fede e del sentimento si manifesta, per Burke,
come “entusiasmo”, la nobile passione per i grandi ideali della
religione, che occorre riconoscere come tali, nella consapevolezza che l’entusiasmo` nei suoi effetti
è più vicino alla “grande e comprensiva ragione" che non la “comune ragione” che
opera secondo le regole dei luoghi comuni. Sussiste pertanto
la possibilità di una comprensione più profonda dell’esperienza, in sostanza della nostra vita,
mediante l’armonico contemperamento di entusiasmo e ragione.
L’entusiasmo eleva la ragione e le apre nuovi orizzonti e
la ragione, a sua volta, controlla gli slanci dell’entusiasmo. La
ricerca filosofica non può che informarsi al criterio di un armonico contemperamento della ragione
e del sentimento e riconoscere che la conclusione delle sue indagini sta nel riconoscimento della
saggezza divina come fondamento dei nessi e
dei rapporti delle relazioni, in ultima analisi dell’ordine che si
rinviene nella natura dell'uomo. Il fine degli studi è l'elevazione della mente: << Con quanta
maggior cura osserviamo la
mente umana, più forti, più vive tracce troviamo ovunque
della saggezza di Colui che la creò. Se la dissertazione sull’utilità delle parti del corpo si può
considerare come un inno al
Creatore, l’utilità delle passioni che sono gli organi della
mente, non può essere priva di lodi a Lui, né incapace di destare in noi quella nobile e singolare
unione di scienza e dì
ammirazione, che solo una contemplazione delle opere della
infinita sapienza può dare ad una mente razionale; mentre riferendo a Dio tutto ciò che troviamo di
giusto, di buono e di
bello in sé stesso scoprendo la sua forza e la sua sapienza anche nella nostra debolezza ed
imperfezione, onorando quelle
là dove noi chiaramente le scopriamo e adorando la loro profondità là dove noi ci perdiamo nella
nostra ricerca, noi possiamo essere indagatori senza impertinenza, ed elevarci senza
inorgoglirci; possiamo essere ammessi, se cosi possiamo dire,
nel consesso dell'onnipotente, attraverso una mediazione
delle sue opere. L’elevazione della mente deve essere il principale scopo di tutti i nostri studi,
poiché se essi non la conseguono in qualche misura, sono di scarsissima utilità per
noi >>. Questo sentimento religioso costituisce l’ispirazione
di fondo dell'Enquiry: la conoscenza, che si basa certamente
sui dati fornitici dall'esperienza quindi sulle nostre sensazioni,
è promossa e sollecitata dai nostri sentimenti, e si avvale di
principi costanti, validi per tutti gli uomini, che la sottraggono
ai condizionamenti ed alle incertezze dello scetticismo.
La verità di Dio costituisce in Burke il presupposto che
consente alla ragione umana di pervenire ad un risultato positivo: la ragione non ha il suo
fondamento solamente nei
principi e nel metodo mediante i quali elaborare i dati dell’esperienza sensibile, liberandosi in tal
modo dal condizionamento delle emozioni e delle passioni, ma anche nell'avvertenza e quindi nel
riconoscimento del sentimento religioso
che la rende immediatamente partecipe della realtà di Dio.
Per tal motivo la ragione acquisisce un’“apertura”, una “prospettiva” che le consentono di osservare
e comprendere le articolate e complesse manifestazioni della natura umana, senza
rinchiudersi in un astratto e arido intellettualismo che le impedisce un reale contatto con il mondo
umano.
Nell'introduzione dedicata al “Gusto", scritta con un sottinteso riferimento alle tesi sostenute da
Hume nell'analogo
scritto, possiamo cogliere le riserve che Burke formula nei
confronti dell’empirismo filosofico humiano e della connessa
concezione della razionalità. L’introduzione si richiama esplicitamente ad una ragione, fondata sulla
comune natura
umana, che consegue risultati sicuri e fornisce pertanto principi obiettivi all'attività dell’uomo <<I
poteri naturali dell'uomo a me noti, che sono in rapporto con gli oggetti esterni,
sono i sensi, l’immaginazione e il giudizio. Noi crediamo e
dobbiamo credere che, come la conformazione dei vari organi
è del tutto o quasi la medesima in tutti gli uomini, così
modo di percepire gli oggetti esterni è in tutti gli uomini lo
stesso o lievemente diverso >>. Se invece riteniamo che << i sensi
offrano ai diversi uomini immaginazioni diverse delle cose,
questo scetticismo renderà vano e insignificante ogni sorta di
ragionamento su ogni soggetto, persino quello stesso ragionamento scettico che ci ha indotto a
formulare un dubbio circa
l’accordo delle nostre percezioni >>.
Non dobbiamo lasciarci trarre in inganno dalle differenze
che notiamo fra i pensieri, i sentimenti, i piaceri ed i gusti degli uomini: infatti << nonostante questa
differenza, che ritengo
più apparente che reale, è probabile che la ragione e il gusto
abbiano in tutte le creature umane le stesse caratteristiche.
Poiché, se non vi fossero principi di giudizio, così come di
sentimento, comuni a tutti gli uomini, non si potrebbe fare
nessun affidamento sulla loro ragione e sulle loro passioni,
tale da permettere l’ordinario rapporto di vita >>. Burke
può affermare di conseguenza che lo scopo della sua “ricerca
filosofica” << è di trovare se vi sono dei principi in base ai
quali l’immaginazione è colpita, così generali, così fondati e
certi, da fornire i mezzi per ragionare in modo soddisfacente
intorno ad essi E tali principi del gusto io ritengo vi siano:
per quanto paradossale ciò possa sembrare a coloro che, da
un punto di vista superficiale, ritengono vi sia tanta diversità
di gusti, sia nel genere, sia nel grado che nulla possa essere di
più indeterminato >>.
Secondo Burke la validità delle conclusioni frutto dell’analisi delle nostre sensazioni si fonda su
principi intrinseci
alla esperienza, intesa come esplicazione dei “poteri naturali"
dell'uomo. Fra i sensi, l'immaginazione e le idee sussistono
rapporti fondati su principi costanti, che ci consentono di
comprendere non solo il nesso fra i sentimenti e l'attività razionale, ma anche di formulare
conclusioni valide e convincenti. Attenendosi alla “logica” lockiana Burke nella sua analisi ritiene
valido il rapporto causa effetto, rifiutandone la critica humiana: tiene a precisare che i principi con i
quali analizziamo e valutiamo l’esperienza non sono << derivati da abitudini o da interessi >>,
assumendo così, sia pure implicitamente, una posizione decisamente critica nei confronti della
concezione di Hume che fonda la validità delle conclusioni
tratte dall’esperienza sulla consuetudine; << E queste cause agiscono quasi uniformemente su tutti
gli uomini perché agiscono in base a principi esistenti in natura, e non derivati da
abitudini ed interessi. Amore, dolore, timore, ira, gioia, tutte
queste passioni hanno a turno colpito l’animo d’ognuno, e
non in modo arbitrario e casuale, ma secondo principi certi
naturali e costanti ».
Fra i poteri naturali dell’uomo, come sappiamo, vi è l’immaginazione, alla quale Burke riconosce
un ruolo rilevante
nell’ambito delle passioni e nella formazione delle idee. Ma
l’immaginazione non è quella di cui ci parla Hume, la libera e
in sostanza arbitraria capacità di invenzione dell'uomo << con
tutta l’apparenza della realtà >>, che deve essere controllata
mediante la “credenza” (la convinzione convalidata dalla consuetudine): è invece il "potere creatore
della mente" che è
"affetta" da << principi così generali, così fondati e certi, da
fornire i mezzi per ragionare in modo soddisfacente intorno
ad essi ». L’immaginazione, per Burke, non rappresenta
l’insidia dell’irrazionale, ma è il vero centro motore delle passioni, dei sentimenti e dei pensieri
dell’uomo: dall’immaginazione dipendono in sostanza l’esperienza del bello e del sublime e da essa
promanano le passioni che si riferiscono alla
costituzione e alla vita della società. Le idee non solo derivano
dalle sensazioni, ma sono anche “create” dall’immaginazione
e sono altrettanto importanti ai fini dell’attività umana quanto
le prime. All’immaginazione << appartiene tutto ciò che si
chiama intelletto, fantasia, invenzione », sì che deve essere
considerata come << il più esteso campo del piacere e del dolore il campo dei nostri timori e delle
nostre speranze e di
tutte le speranze ad esse connesse ».
Il compito della ragione è quello di analizzare, suddividere, individuare le differenze fra due
oggetti, fra le parti o gli
elementi di un tutto, quello dell’immaginazione intesa
come “spirito”, fantasia, invenzione è di riconoscere le somiglianze, ciò che accomuna, che unifica.
Questa operazione
è più gratificante per la mente di quella dell’analisi, perché
« rilevando le somiglianze noi produciamo nuove immagini,
coordiniamo, allarghiamo la nostra esperienza », mentre
quando facciamo << distinzioni non offriamo alcun elemento
all’immaginazione; il compito stesso è più severo e noioso »
L'esperienza non è più una serie di dati di fatto, che la ragione conosce nella loro determinazione
empirica, ma diventa
essenzialmente “esperienza vissuta”, la “nostra” esperienza,
arricchita, allargata dall’immaginazione, sì che essa comprende a pieno titolo anche il bello e il
sublime, che consentono di conoscere momenti ed aspetti particolarmente importanti
dell’esperienza degli uomini. Di qui il valore di concretezza che Burke riconosce alla << pratica >>
nei confronti della
teoria, al sentimento_ nei confronti della ragione, anche se ciò
non significa sminuire l'importanza dell’analisi razionale e
della sua incidenza sulla “pratica”: << Ritengo sia comune
l'aver torto in teoria e ragione in pratica: e siamo ben lieti che
sia così. Gli uomini sovente agiscono bene se seguono il loro
sentimento, ma ragionano poi male su di esso per i loro principi; ma dal momento che è impossibile
evitare un tentativo
di ragionamento ed è ugualmente impossibile prevenire il
fatto che esso eserciti un influsso sulla pratica, vale certo la
pena, affrontando pure qualche sofferenza di averlo esatto e
fondato sulla base di una sicura esperienza ».
Il riconoscimento del ruolo primario della fantasia o dell’invenzione nell’attività di “ideazione”
della mente ridimensiona la concezione illuministica della razionalità nella sua
pretesa di ridurre la realtà ai criteri meramente empirici. La
ragione, avverte Burke, non riesce mai a comprendere ed a
definire in modo esaustivo la realtà, che per la sua complessità sfugge sempre ad una compiuta
“presa di possesso" razionale La ragione illuministica, proprio perché è sicura dei suoi
risultati conseguiti secondo una procedura rigorosamente razionale, finisce per rinchiudersi in se
stessa, con il risultato di
proporre una conoscenza limitata ed a volte astratta delle
cose. Di qui la diffidenza di Burke nei confronti del primato
della definizione, « il celebrato rimedio » contro l’incertezza e
la confusione; La definizione restringe l’orizzonte della nostra
ragione nell’ambito dei termini di cui ci serviamo per le nostre analisi, mentre la natura, la realtà, è
di gran lunga più ricca, più articolata e complessa. Perciò, osserva Burke, vi
possono essere « definizioni esattissime, eppure esprimono
solo approssimativamente la natura della cosa ».
Le definizioni pertanto, più che acquisizioni di verità sicure e compiute, debbono essere considerate
come le conclusioni di una ricerca di cui interessa analizzare con cura il
“percorso” compiuto per pervenire ad esse. Al metodo d’insegnamento basato sulle definizioni, che
ci offre << poche verità aride e prive di vita », Burke ritiene si debba sostituire
quello della ricerca, per rendere consapevole l’allievo del
modo con cui si è pervenuti alla scoperta della verità: << ma da parte mia sono convinto che il
metodo di insegnamento che più si avvicina al metodo di ricerca è incomparabilmente il migliore;
dal momento che insoddisfatto di dare poche verità aride e prive di vita esso conduce alla loro
genesi e tende a porre il lettore sulla traccia dell’invenzione e a dirigerlo verso quei sentieri che
l’autore ha percorso per giungere alle sue scoperte ».
l’avvertenza che non bisogna proporre verità “aride e
prive di vita" significa per Burke che la ragione non deve stabilire una distinzione netta, una vera e
propria separazione contrapposizione, con l’immaginazione, ma deve cercare di comprendere il
rapporto che intercorre fra la sua “logica” e
quella dell’immaginazione, per una conoscenza più profonda
e più reale della natura dell’uomo. Anche l’immaginazione,
grazie all’invenzione, alla fantasia che alimentano l'attività artistica in tutte le sue forme, esprime le
verità della vita, e con maggiore immediatezza ed efficacia, anche se con minore
esattezza dal punto di vista della definizione logico concettuale. La cultura delle nazioni “più
ignoranti e barbare”, secondo il criterio della ragione riflettente ed intellettualizzata, si esprime per
Burke proprio nell’ambito dell’immaginazione: queste nazioni se << sono state deboli e retrograde
nel distinguere e nell’ordinare le loro idee, spesso hanno facilità nelle similitudini, paragoni, nelle
metafore e nelle allegorie >>, con cui manifestano e “definiscono” mediante la loro produzione
artistica le loro “verità di vita”.
Esse esprimono proprie originarie culture e civiltà, che certamente non rientrano nei canoni
dell’estetica e del gusto proposti dalla ragione illuministica, ma che rappresentano manifestazioni
significative ed importanti dei diversi modi con cui
si manifesta, in diverse situazioni ambientali e storiche, la comune natura umana.
In questa prospettiva volta ad evidenziare la funzione
della immaginazione nel processo cognitivo, Burke tende a
mettere in risalto la funzione che esercitano le passioni nella
conoscenza stessa, cercando di istituire fra la ragione e le passioni un rapporto dinamico contro la
concezione associazionistica e meccanicistica di Hume. L’attività dell’ani1no umano è
caratterizzata dalle passioni, « gli organi della mente » secondo l’espressione burkiana, nel senso
cioè che il processo
mediante il quale la mente attua le sue facoltà si origina, è
promosso e sostenuto dalle passioni. La conoscenza inizia con
la prima e semplice “emozione” dell'animo, la curiosità, suscitata dalla novità. Ma la curiosità si
esaurisce presto perché
“consuma” rapidamente le novità che la suscitano; di qui la
necessità di rinnovare l’interesse dell’uomo con altre passioni
che lo impegnino con maggiore forza e per un maggior lasso
di tempo che, per Burke, sono il dolore e il piacere, e le passioni che da essi derivano.
Queste due passioni non costituiscono per Burke la
somma di tutte le altre, sia sgradevoli che gradevoli, nel senso
che queste possono essere definite come successive gradazioni, o come diversa composizione delle
due stesse passioni
fondamentali: in effetti il dolore e il piacere sono due esperienze primarie e originarie, l’una distinta
dall’altra, tanto che
non possono reciprocamente influenzarsi. Ciò significa che
Burke ha sostanzialmente abbandonato il metodo della psicologia associazionistica proprio
dell’empirismo humiano per un
metodo che privilegia la descrizione delle diverse fondamentali esperienze emozionali ,e passionali
dell’animo umano che riesca a coglierne il momento genetico e ad individuarne la
specifica funzione per quanto riguarda la riflessione, la conoscenza e il comportamento dell’uomo.
Ciò consente di ottenere << un’analisi razionale delle nostre passioni necessaria per
tutti coloro che vogliono comprenderle in base a principi solidi e sicuri >>, evitando così le
incertezze e i dubbi di un’analisi meramente empirica. A tal proposito occorre avvertire che
non bisogna limitarsi ad una conoscenza “generale" delle passioni: « per penetrarle sottilmente o
per giudicare con proprietà un'opera intesa a penetrarle, dovremmo conoscere i limiti esatti del
campo in cui agisce ciascuna di esse, seguirle
nella varietà di tutti i loro aspetti, e penetrare in profondo in
quelle parti della nostra natura che possono sembrare inaccessibili >>.
In questa prospettiva lo “stato di quiete” della nostra
mente (una sorta di “disincanto” nei confronti delle passioni),
al quale fa riferimento Hume per garantire alla ragione di riflettere e di analizzare le idee, assume
per Burke una valenza
negativa. La quiete dell'animo, il distacco concepito come assenza di dolore e di piacere è per Burke
anche la “quiete” della ragione: la riflessione, il ragionamento, la razionalità scaturisce dalla
tensione creata dall’esercizio e dal lavoro: « Il miglior rimedio per tutti questi mali è l’esercizio e il
lavoro: e il lavoro è un superamento di difficoltà, è uno sforzo del potere di contrazione dei muscoli
e come tale assomiglia in tutto, tranne che nel grado, al dolore, che consiste nella tensione e nella
contrazione. Il lavoro non è soltanto necessario
per mantenere gli organi meno delicati in uno stato adatto alle
loro funzioni; ma è pure necessario agli organi più fini e delicati per mezzo dei quali agiscono
l’immaginazione e forse le altre facoltà intellettuali più delicate del sistema ».
Le passioni hanno un ruolo rilevante per quanto riguarda
la concezione della società e il ruolo degli individui nella sua
formazione. A tal fine Burke distingue le passioni in due
grandi categorie, quelle che si riferiscono all’individuo come
singolo e quelle che attengono alla società, con l’avvertenza
che tutte le nostre passioni sono finalizzate o all’uno o all’altra: << La maggior parte delle idee
capaci di produrre una forte
impressione nella mente, sia semplicemente idee di dolore o
di piacere o idee della modificazione di questi, può essere ridotta con una certa approssimazione a
queste due principali
idee, la preservazione di se stessi e la società; ai fini dell'una
o dell'altra delle quali si calcola rispondano tutte le nostre
passioni ».
Intanto l’individuo e la società sono due “fatti originari"
nel senso che la loro sussistenza si fonda sul processo mediante il quale si esprimono le passioni che
sono proprie dell’uno e dell’altra. La conservazione di se stessi non corrisponde all’analogo
principio considerato come norma fondamentale del comportamento dell’individuo in Hobbes,
Locke e Hume, perché secondo Burke è intimamente connesso con
le emozioni più forti, o impressioni che può provare l’animo
umano e quindi con le idee di dolore, dì morte, di pericolo,
dato che le idee di vita e di salute, benché producano piacere
e gioia, non arrivano mai a provocare un’'impressione così intensa come le prime due. Così se per
l'empirismo inglese
l’istinto di autoconservazione esprime in ultima analisi il criterio dell'utile che a poco a poco con il
progresso della ragione diventa la norma riconosciuta del comportamento etico sociale
dell'individuo e pertanto fondamento della giustizia,
del diritto, della proprietà, dell’ordine sociale, nonché della
stessa religione positiva, per Burke, invece, questo istinto è
intimamente connesso al sentimento del dolore o del pericolo,
che per essere << le più forti di tutte le passioni >> producono
nell’individuo « la più forte emozione che l’animo sia capace
di sentire », che lo libera dai determinismi dell’esperienza sensibile e gli manifesta la sua
sostanziale individualità. In queste emozione consiste l’esperienza del “sublime”.
Per Burke il connotato essenziale dell’individuo non è la
“razionalità” cui si riferiscono Hobbes, Locke e Hume, ma la
coscienza del significato e del valore del suo esistere, acquisita
con l’esperienza fondante della sua “individualità”,'che è anche la più forte emozione che l’animo
umano possa sentire,
quella del “sublime”. Tramite questa “passione” l’uomo scopre il suo se stesso originario, acquista
cioè coscienza della
sua esistenza, si distacca completamente dalla natura ed avverte l’esistenza di un Essere che lo
domina, infinitamente superiore, dinanzi al quale l’uomo si sente come annullato, ma
nello stesso tempo si percepisce come il soggetto di questa
esperienza che lo costituisce nella sua originarietà, cioè come
un’esistenza sua propria, completamente distinta dalla realtà
che lo circonda.
Nel sublime l'individuo, come ha giustamente rilevato
Cassirer, ritrova la sua originarietà, riconosce un se stesso non
deducibile da qualsiasi altro tipo di esperienza, non più mero
“registro” ed attento “organizzatore” del materiale che riceve
dalla realtà esterna, ma attività creatrice di nuove idee, di
nuovi valori. Il concetto di passione è così radicalmente
capovolto rispetto a quello di Hume, il quale non avrebbe mai
potuto accettare la tesi burkiana che la passione più forte,
l’emozione totalmente “possessiva" del sublime costituisca
l’origine della ragione dell’uomo,' sia l'esperienza vitale mediante la quale l’individuo si appropria,
assimila la realtà che lo circonda e comincia a pensarla. Per Burke la tensione
dell’animo che si esprime nell’esperienza del sublime opera
una immedesimazione del soggetto con il dato della realtà,
dalla quale risulta un tipo di conoscenza “vissuta”, che anticipa, ispira ed orienta la conoscenza
riflessa, la ragione: << La
passione causata da ciò che è grande e sublime in natura,
quando le cause operano con il loro maggiore potere, è lo stupore: e lo stupore è quello stato
d’animo in cui ogni moto
sospeso, regna un certo grado di orrore. In questo caso
l'anima è così assorta nel suo oggetto, che non può pensarne
un altro, e per conseguenza non può ragionare sull’oggetto
che la occupa. Di qui nasce il potere del sublime che lungi
dall'essere prodotto dai nostri ragionamenti li previene e ci
sospinge innanzi con una forza irresistibile ».
Dio, per Burke, è una verità di ragione, che trova una
corrispondenza nel sentimento, nell’immaginazione. A questa
premessa si connette il problema dell'origine del rapporto uomo-Dio, del modo con cui viene
avvertito, vissuto e pertanto
conosciuto; solo se riusciamo ad acquisire il valore e il significato dell’originaria esperienza
religiosa, possiamo comprendere il valore autentico della religione e renderci in tal modo
conto di come la “verità" di Dio costituisca il primo e sicuro
punto di riferimento della ragione e la “società” dell'uomo
con Dio il presupposto e il fondamento della società degli uomini. Si tratta pertanto di indicare
quale particolare esperienza ci consente di pervenire a queste conclusioni muovendo da un'accurata
analisi delle passioni che si riferiscono
al bello ed al sublime. Per Burke il Dio della ragione ha una sicura “testimonianza", una conferma,
nella più significativa esperienza vissuta dell'individuo, quella del sublime: la religiosità della
quale parla Burke attinge i suoi connotati essenziali e caratteristici, la sua inconfondibile tipicità per
la quale non può essere risolta in altre manifestazioni od esigenze dell’animo
umano (Hume), proprio dall’esperienza pre razionale del sublime. Il Dio della ragione, definito
secondo le qualità e gli
attributi che Gli riconosce la ragione, rimane lontano e distaccato dall'uomo, una “astratta verità” di
ragione, che non impegna l’immaginazione << Affermi dunque che mentre consideriamo la
Divinità puramente come oggetto di conoscenza,
in quanto costituisce un'idea complessa di potere, di sapienza,
giustizia, bontà, qualità tutte elevate a un grado che va molto
al di là dei limiti della nostra comprensione, mentre consideriamo la Divinità sotto questo aspetto
raffinato ed astratto
l'immaginazione e le passioni sono poco o per nulla affatto
impressionare >>.
Ma ben altro significato e valore si riconoscono a Dio allorché non viene considerato. come puro
concetto della
mente, ed è invece presente al nostro animo, grazie alla nostra
immaginazione, nella sua espressione originaria di potenza infinita. In questo caso l’individuo
partecipa dell’esperienza del
sublime, in cui si sente come annullato di fronte alla potenza
infinita di Dio, dominato da un timore sacrale che nasce dal
manifestarsi della maestà divina: « Ora sebbene in una esatta idea della Divinità nessuno dei suoi
attributi sia forse predominante, pure per la nostra immaginazione la sua potenza è di
gran lunga più notevole. Una riflessione, un confronto è necessario per convincersi della sua
sapienza, giustizia, bontà.
Per essere colpiti dal suo potere è solo necessario che noi
apriamo gli occhi; ma mentre contempliamo un essere così
vasto, come se fossimo sotto il braccio della sua onnipotenza,
ci rannicchiamo nella piccolezza della nostra natura e ci sentiamo in certo senso annichiliti dinanzi
a lui. E sebbene la
considerazione degli altri suoi attributi possa alleviare in un
certo senso le nostre apprensioni pure nessuna convinzione
della giustizia con cui è esercitata; né dalla misericordia da cui
è mitigata, può completamente allontanare il terrore che nasce naturalmente da una considerazione
di una forza cui nulla
può resistere. Se noi gioiamo, gioiamo con tremore, e persino
nel momento in cui riceviamo un beneficio, non possiamo
fare a meno di rabbrividire dinanzi a una potenza che può distribuire benefici di tanta importanza.
Quando il profeta Davide contempla i miracoli dì saggezza e di potenza che sono
evidenti nella costituzione dell’uomo, sembra colpito da una
specie dì orrore divino e grida: “In modo terribile e meraviglioso io sono stato creato! ”... Ma solo
la Sacra Scrittura può
offrire idee conformi alla maestà di questo soggetto. Nella Sacra Scrittura, dovunque Dio è
rappresentato mentre appare o
'parla, tutto ciò che vi è di terribile in natura è chiamato a raccolta per rafforzare il senso di timoroso
rispetto e di solennità
che la divina presenza suscita. I salmi e i libri dei profeti sono
densi di esempi di questo genere: “La terrà tremò, dice il salmista, il cielo pure si riversò alla
presenza del Signore" >> .
La religione in Burke si esprime sostanzialmente come
originaria esperienza di Dio, come il primo modo con cui Dio
appare all’uomo e nel contempo l'uomo avverte la sua presenza, si rende conto della sua esistenza.
La conoscenza di
Dio si richiama nella sua originarietà ad un’esperienza che
non può essere risolta nei principi e nei concetti della ragione
filosofica: la religione non può essere ridotta alla filosofia. Per
l'esperienza religiosa Dio non è un'idea “chiara e distinta”: è
l'infinita potenza che si manifesta all'uomo nell’assoluta indeterminazione visiva, nell'oscurità,
come un Essere avvolto nel
mistero, che suscita stupore attonito, terrore sacrale cioè la
massima tensione dell'animo, dalla quale l'uomo cerca di fuggire ma verso la quale si sente
irresistibilmente attratto, partecipando così alla sua “verità". Il nucleo essenziale della religiosità
appare cosi a Burke come manifestazione del sublime
e quindi si esprime nella dimensione del tremendum, del misterium, del fascinans, del luminoso; di
qui l'insistito richiamo
alla religiosità del Vecchio Testamento in particolare all’episodio di Giobbe che indica in modo
emblematico come si
esprima l’originario rapporto dell’uomo con Dio: << Vi è un
passo del Libro di Giobbe stupendamente sublime e questa
sublimità è dovuta principalmente alla terribile incertezza
della cosa descritta. “Nei pensieri derivati dalle visioni della
notte, quando il sonno profondo cade sugli uomini, un timore
mi assalì e un fremito mi scosse tutte le ossa. Allora uno spirito passò davanti al mio viso. I peli del
mio corpo si rizzarono. Rimasi fermo ma non potei discernere la forma; un’immagine era davanti ai
miei occhi; v'era silenzio ed io udii una
voce: Deve un mortale essere più giusto di Dio?" ».
Che il sublime sia inizialmente connesso alla fondamentale esperienza del sacro è comprovato,
secondo Burke, dalla
constatazione degli stretti rapporti dj colleganza di significati
fra alcune parole, terrore, stupore, ammirazione, reverenza,
rispetto: << Lo stupore,,come ho detto, è l’effetto del sublime
nel più alto grado: gli effetti inferiori sono l’ammirazione, la
reverenza, il rispetto... Varie lingue possono essere testimoni
dell’affinità di tali `idee. Esse spesso usano la stessa parola per
indicare indifferentemente gli aspetti dello stupore, dell’ammirazione e del terrore. €·)étu[3og è in
greco timore e stupore;
òewoç significa terribile e rispettabile; otìòéw significa venerare o temere. Vereor è in latino quello
che è otìoéw in greco.
I Romani usavano il verbo stupeo, un termine che indica con
forza lo stato di una mente stupita, per esprimere l’effetto o
di un semplice timore, o dello stupore; la parola czttorzzfus
(colpito dal tuono) esprime anch’essa l’affinità di tale
idea >>.
Anche la società ha una propria realtà, si avvale di una
“autonoma” struttura nella quale l'individuo è inserito non
già per il suo consenso finalizzato alla ricerca dell'utile ma per
l’impulso di << tutte le nostre passioni >>. Burke riconosce due
tipi di società: “la società dei sessi” e la “società generale”. La prima, costituita dall’unione
dell’uomo e della
donna, ha come scopo la propagazione della specie: non è determinata solamente dall'istinto, ma è
promossa e sostenuta
dal sentimento della bellezza, che orienta l’uomo e la donna
nelle loro scelte e che è l’oggetto di quella passione complessa
indicata con il termine di amore: << Chiamo la bellezza una
qualità sociale; perché quando gli uomini e le donne, e non
solo essi, ma anche gli altri animali, ci danno un senso di gioia
e di piacere nel guardarli..., ci ispirano sentimenti di tenerezza
e di affetto verso le loro persone; ci piace allora vederli vicino,
ed entriamo volentieri in rapporto con loro, a meno che non
abbiamo forti ragioni per fare il contrario >>.
La famiglia e i gruppi parentali costituiscono il presupposto della “società generale” che << ci
unisce agli uomini e agli
altri animali, e che possiamo in un certo senso dire che ci unisca anche con il mondo inanimato >>.
La società generale
pertanto, è una unità-totalità, nel senso che per il suo tramite
le vite dei singoli si integrano fra di loro, talché non possono
più sussistere se non nell'articolato sistema dei rapporti reso
possibile dalla società, che tramuta anche il dato materiale
dell’insediamento territoriale in un rapporto di unione cioè in
un sentimento affettivo che ci lega ai luoghi nativi. La società
generale offre all’individuo numerose occasioni di istituire
"società particolari” dalle quali può trarre un “ particolare piacere": « Una buona compagnia, una
conversazione animata e
l’affetto di un’amicizia riempiono l'anima di grande piacere >>;
ma il vivere in società non implica che un temporaneo isolamento non sia << per se stesso piacevole
», mentre << l’assoluta
e completa solitudine, cioè la totale e continua esclusione da
ogni società è un dolore tanto grande che a stento possiamo
immaginarlo ». Il rapporto individuo - società non deve
essere inteso in modo “totalizzante", nel senso che all’individuo non venga riconosciuto un ambito
di propria autonomia;
il “temporaneo isolamento” ci consente di sottrarci agli impegni della società e di attendere ad
esigenze di carattere contemplativo: la virtù dell’individuo sociale in Burke si esprime
aristotelicamente nell'intimo nesso fra azione (pratica) e contemplazione (teoria): << Questo può
forse provare che noi
siamo creature nate tanto per la contemplazione che per
l'azione dal momento che l’isolamento ha i suoi piaceri, così
come li ha la società >>.
La società generale si presenta così come un sistema
molto articolato di relazioni che si fondano sulle passioni degli uomini tutte necessarie perché la
società pervenga ai fini
che le sono propri; per Burke possono essere ricondotte a tre
passioni fondamentali: << Sotto questa denominazione di società rientrano passioni di un genere
complicato, che si suddividono in varie forme, adatte a quella varietà di fini a cui
devono servire nella lunga catena della società. I tre principali
anelli di questa catena sono la “simpatia”, l'“imitazione” e
l'ambizione >>.
La simpatia è la più importante delle passioni sociali, per
mezzo di essa si forma il primo reale e sostanziale vincolo fra
gli individui che li fa sussistere come società. Mediante la
simpatia l’individuo partecipa ai sentimenti e all'attività dei
suoi simili, perché grazie a questa passione ci immedesimiamo
negli altri in una reale “partecipazione di vita”: ne consegue
che le considerazioni e le scelte degli individui non sono tanto
il frutto di una distaccata e tranquilla riflessione ma sono di
solito promosse ed orientate dalla simpatia, cioè dalle vicende
e dalle passioni delle persone con le quali si sono istituite relazioni: « Sotto l’impulso della prima di
queste passioni siamo
portati ad interessarci degli altri, siamo toccati da ciò che lì
tocca, non possiamo rimanere più spettatori indifferenti di alcuna cosa che gli uomini possono fare
o subire. infatti la simpatia deve essere considerata come una specie di sostituzione,
per cui ci mettiamo al posto di un altro uomo e siamo colpiti,
sotto molti aspetti, da ciò che colpisce lui; cosicché questa
passione può o partecipare della natura di quelle che si riferiscono alla preservazione dì se stessi e
improntandosi al dolore, può essere una causa del sublime, oppure rivolgersi ad
idee di piacere, e allora tutto ciò che è stato detto degli effetti
sociali, sia che essi si riferiscano alla società in generale, o soltanto ad alcune forme di esse, può
essere qui applicato ».
Per Burke la maggior parte delle nostre passioni è provocata dalla partecipazione “simpatetica” alle
passioni degli altri, o ad avvenimenti, o a situazioni, quindi a fatti sociali in
grado di suscitare in noi quelle determinate passioni. Una
partecipazione si noti che non è promossa dalla ragione, proprio perché essa si manifesta come una
specie di impulso e
quindi con una immediatezza che “anticipano” la ragione
stessa, che, del resto, ha uno scarso potere nel suscitare le
passioni: << Temo che sia un metodo troppo comune nelle ricerche di questo genere attribuire la
causa dì sentimenti che
nascono semplicemente dalla struttura meccanica dei nostri
corpi o dalla naturale costituzione delle anime nostre, a certe
conclusioni della ragione sugli oggetti che ci vengono presentati; poiché sono propenso e credere
che l'influsso della ragione nel destare le nostre passioni non sia affatto così esteso
come comunemente si crede>>.
Accanto alla simpatia l'altra fondamentale passione sociale è l'imitazione, per cui l’individuo è
portato a ripetere
quanto fanno i suoi simili. Essa esprime la naturale condiscendenza dell’uomo verso i suoi simili e
presiede, per Burke, alla
“cultura di base” di ciascun individuo, che per essere il risultato della reciproca imitazione dei
comportamenti degli associati, si riferisce ad una comune cultura che, essendo frutto di
comportamenti, di abitudini e di consuetudini comuni, realizza e rafforza il vincolo sociale. Da
questo punto di vista la
società ha una forte valenza pedagogica, che investe l’intera
personalità dell'individuo: « E per via dell'imitazione, molto
più che per l'insegnamento, che noi impariamo; e ciò che apprendiamo per tale mezzo non solo lo
apprendiamo in una forma più pratica, ma anche più piacevole. Così si formano le
nostre abitudini, le nostre opinioni, le nostre vite. Limitazione
è uno dei più forti vincoli della società; è una specie di reciproca condiscendenza che gli uomini
hanno l'uno per l’altro.
spontaneamente, e che è lusinghiera per tutti >>.
La terza passione sociale è l’ambizione, l’impulso che sospinge l’individuo a distinguersi dagli altri,
ad affermare la sua
“diversità” e la sua superiorità, e quindi ad innovare a volte
radicalmente le convinzioni comuni e gli assetti sociali consolidati. Se la società si fondasse
unicamente sulla simpatia e
sull’imitazione sarebbe condannata ad una piatta uniformità a
motivo della monotona ripetizione di comportamenti completamente omologati, e, di conseguenza,
ad essere governata secondo i principi di un tirannico conformismo: « tuttavia se
gli uomini. si dessero unicamente all'imitazione e ognuno seguisse l'altro, e così via, in ciclo
continuo, è facile osservare
come non potrebbe mai esservi progresso fra di loro. Gli uomini, come i bruti, rimarrebbero alla
fine identici a quello che
sono oggi e che erano all’inizio del mondo. Per impedire ciò,
Dio ha posto nell’uomo un senso di ambizione e una soddisfazione che nasce dalla vista della sua
superiorità sui propri simili in qualcosa cui essi attribuiscono valore >>. L'ambizione rappresenta,
pertanto, il principio dell’individualismo
come innovazione, come impulso a superare il proprio simile
e quindi a non ripetere passivamente ma a fare di più e meglio: da questo punto di vista essa è anche
il principio del
“movimento” della società e del suo progresso. L'ambizione
sollecita infine la dialettica delle passioni sociali, che costituisce la dinamica dell'articolato e
complesso sistema delle relazioni sociali sul quale si fonda l'ordine politico della società.
'La società generale, che comprende gli uomini, le loro
cose e l’ambiente in cui vivono, è un vero e proprio “mondo
umano" (secondo l'espressione vichiana) che affonda le sue
radici nella struttura più profonda della natura umana. Ha un
autonomo fondamento essendo la necessaria “espressione”
delle passioni dell’uomo, che la formano e la fanno sussistere
come una unità-totalità, che include in sé tutte le manifestazioni della vita degli individui. Per tal
motivo l’ordine politico
e la corrispondente organizzazione politica sono intimamente connessi, possiamo dire “vitalmente”
connessi con la società
generale, ne sono una essenziale espressione. Di qui il rifiuto
di Burke di ridurre la politica al momento dell’utile, alla razionalità utilitaristicamente intesa, infine
alla civiltà come
espressione della sola ragione, che si è finalmente affrancata
dalle passioni e che sa quindi porsi come obiettivo l’utile sociale. Ma in questo caso la ragione si
separa dalla vita, dalla
concreta realtà umana, mentre la politica e in particolare il
potere debbono invece continuamente confrontarsi, “convivere" con quella realtà che è, come si è
visto, caratterizzata
proprio dalla dialettica di quelle passioni che la ragione dovrebbe mettere fra parentesi prima di
esprimere il suo giudizio.
Il potere, proprio perché rappresenta l'esigenza che l'ordine politico sussista nella sua effettività,
prima di essere
un’istituzione positiva che si fonda sull’ordinamento politico
e sugli interessi sociali che tutela, esiste come “entità” che si
legittima mediante le passioni connesse al “sublime", il timore, la reverenza, il rispetto: « In realtà è
così naturale questa timidezza nei riguardi del potere ed è così fortemente
connaturata in noi, che pochissimi sono capaci di vincerla, se
non col mischiarsi molto negli affari del gran mondo, o con
l’usare non poca violenza alle loro naturali disposizioni ».
Il potere si esprime inizialmente, originariamente, nella sfera
del sacro, cioè nell’esperienza delle passioni e dei sentimenti
che sono connessi e derivati dal “sublime”, di qui la maestà e
l’assolutezza del Supremo reggitore come manifestazione di
quel sacro che lo legittima a decidere della vita e del destino
dei singoli e della comunità.
La politica è “all'inizio” strettamente connessa con la religione, per certi aspetti deriva dalla
religione: la distinzione e
la dialettica contrapposizione fra religione e politica propria
dell'esperienza cristiana nell’illuminismo di Bolingbroke, di
Voltaire e di Hume è risolta sul piano di una razionalità che
costituisce e legittima il potere e che riduce la religione ad un
mezzo di governo trasformandola in un'utile “macchina politica", In tal modo il potere è del tutto
scisso e in sostanza
contrapposto al “sacro”, la cui esperienza è considerata la
fonte delle superstizioni che rendono così difficile il progresso
civile degli uomini. Ma in questo caso la sfera del “sacro”,
come esigenza di avvertire e concepire l’assoluta grandezza da
cui dipende l’ordine delle cose e degli uomini, si ricostituisce
all’interno del potere, che rivendica una propria autonoma
forza ed energia che rendano effettive le sue decisioni e i suoi
comandi senza i quali la società si disarticola in una caotica
moltitudine di gruppi e d’individui in continua lotta fra di
loro. Così quando la ragione intellettualistica, di solito occupata << nel riscontrare motivi di errore
sulla via dell’immaginazione, nel dissipare le scene del suo incanto », dissolve con la
sua critica le passioni e i sentimenti che attengono alla sfera
del potere, per renderlo un'istituzione di pura ragione, in
realtà lo riporta alla sua originaria manifestazione di onnipotenza, con l’aggravante della
convinzione che le sue decisioni
e i suoi comandi corrispondono in tutto e per tutto alla vera
ragione e al bene della comunità. Disconosciuti i limiti del
potere posti dal sacro, vengono a cadere quelli posti dall'etica
e dalla ragione a motivo dell’identificazione di potere e ragione, per cui il primo non può non volere
che il vero e il bene. Di qui l’in1portanza secondo Burke dei modi con cui si
“rappresenta", e nello stesso tempo si “circoscrive” la “potenza” del potere, cioè i simboli e il
cerimoniale, che secondo
Burke appartengono all'“estetica” del potere e promuovono
in noi con immediatezza quei sentimenti che sono il presupposto dei limiti del potere.
Nella P/ozlosop/vical Erzquiry Burke, pur avvalendosi della terminologia filosofica e della
gnoseologia dell’empirismo di Locke, finisce poi col “tramutare” 'l’esperienza empirica
nell'esperienza della vita dell'individuo e della società, sul modello dell’esperienza estetica del
sublime e del bello. Va rilevato a tal proposito che in Burke la passione non indica tanto una mera
sensazione non depurata della sua forza e vivacità iniziali, non intellettualizzata, quanto l’unione
“vitale” dell’individuo con la
realtà che lo circonda, una vera e propria presa di possesso di questa realtà, che si tramuta
nell'individuo in forza ed attività creatrice, che risolve in sé, unificandoli in modo originale, tutti
i dati forniti dalle sensazioni. La politica può guardare ormai al “tutto” della società, considerata
nella dinamica delle passioni che la fanno sussistere e quindi delle “forze” che la costituiscono e la
promuovono nel corso di un lungo processo storico.
La politica “riscopre” cosi la storia come la dimensione in cui è possibile cogliere il valore e il
significato della sua attività.
CAPITOLO QUINTO
STORIA E POLITICA
Negli anni immediatamente seguenti alla Vindication e all’Enqury Burke si dedico, come si e
accennato, alla composizione di un’opera di carattere storico, An Essay towards an Abridgment of
English History, che secondo gli accordi con l’editore Dodsley avrebbe dovuto comprendere
l’intera storia inglese dalle origini sino alla regina Anna. L’Abridgment non corrispondeva
solamente al vivo interesse per gli studi storici che aveva caratterizzato la sua formazione culturale;
riprendeva e per molti aspetti continuava il discorso che aveva iniziato con la Vindication, cioè con
la concezione del rapporto fra religione, filosofia, politica e storia, quale era stato proposto da
Bolingbroke, alla cui opera si richiamavano gli autori che avevano espresso gli orientamenti più
significativi della storiografia dell’ultimo ventennio, Voltaire, Montesquieu, Hume. L’Abridgment
doveva tener conto non solamente dei nuovi orientamenti storiografici, ma anche della tradizione
della storiografia erudita, di Rapin Thoyras, la cui opera, nonostante le riserve di Burke, offriva un
insostituibile punto di riferimento per un’informazione approfondita sulla storia inglese basata su
un’attenta ricognizione delle fonti. Il lavoro dovette rivelarsi ben più impegnativo di quello
previsto: si trattava di approfondire gli studi per il periodo delle origini e del medioevo, sul quale
gravavano incomprensioni e decise condanne da riconsiderare criticamente, mentre sino a quel
momento i suoi interessi di storia inglese si erano concentrati sul periodo moderno, con particolare
riguardo alla storia irlandese. Nel 1759 aveva avuto proprio con Hume una vivace discussione sulla
tradizionale condanna da parte degli storici inglesi dell’insurrezione irlandese del 1641. Lo studio
delle origini e dell’età medievale sino a Govanni senza terra e la relativa redazione della storia
occuparono Burke dal 1757 sino al 1762. Molto probabilmente i nuovi impegni connessi con
l’inizio della sua promettente carriera
politica che lo induceva a dedicarsi alla pubblicistica politica
contemporanea (il saggio sulla Popery Law) lo convinsero ad
interrompere definitivamente il suo lavoro: rimasto inedito, fu
pubblicato postumo nel 1815. Va inoltre rilevato che il periodo storico trattato nell' Abridgment
aveva in sostanza esaurito gli interessi storiografici di Burke, concentrati sul problema dei rapporti
fra giustizia, diritto e storia con riferimento alle origini e alla formazione storica delle leggi e delle
istituzioni politiche inglesi, considerate in una prospettiva
montesquiviana e con una visione preromantica della storia
medioevale inglese.
L' Abridgment inizia con il periodo della dominazione romana, si sofferma sull’insediamento
sassone, sulla diffusione
del cristianesimo e del monachesimo, sulle leggi ed istituzioni
sassoni, sulla serie dei re sassoni; tratta poi dell’insediamento
dei Normanni e della monarchia normanna, da Guglielmo il
conquistatore sino a Giovanni senza terra, prestando particolare attenzione per questo ultimo
periodo ai contrasti e agli
scontri fra monarchia, aristocrazia, chiesa e popolo delle città,
che si sarebbero poi conclusi, dal punto visto politico-costituzionale, con la concessione della
Magna Carta, il primo riconoscimento delle fondamentali libertà inglesi. La storia dell'Inghilterra,
come storia della nazione e dello Stato inglesi, è
vista in stretta connessione con la storia della formazione dell’Europa come repubblica cristiana (la
diffusione del cristianesimo), per gli essenziali rapporti con gli eventi storici europei, in particolare
quelli del nord Europa (i Sassoni, i Danesi,
i Normanni), per la dialettica fra potere temporale e spirituale
- l’impero e il Papato - che si riflette a volte in modo determinante nella politica inglese; per
l’importanza che rivestono le crociate che coinvolsero tante nazioni europee, compresa l’Inghilterra;
per le comuni leggi ed istituzioni feudali.
Ciò che colpisce chi legge Abridgment è proprio la consapevole affermazione da parte di Burke
della dimensione europea
della storia relativa alla formazione della nazione e dello Stato
inglesi.
La premessa all’indagine storica svolta nell’ Abridgment ‘ è
data da un “Frammento”, dedicato a un saggio sule leggi Inglesi, in cui si indicano i criteri
storiografici seguiti e si sottolinea, con un implicito richiamo ai capitoli trentesimo e trentunesimo
dello Spirito delle legge, il decisivo contributo della ricerca storico-giuridica per la storia dei “tempi
oscuri” (le origini) dell’Inghilterra. Si tratta di rendersi conto
delle fasi del processo di formazione delle leggi inglesi, che
vanno considerate in stretta connessione con gli eventi storici,
secondo l’avvertenza montesquiviana che << bisogna illuminare
la storia con le leggi e le leggi con la storia ».
<< Fra gli oggetti della nostra curiosità - nota Burke - nulla di più razionale delle origini, dei
progressi e delle rivoluzioni delle leggi umane, Gli eventi politici e militari sono
caratterizzati dall'ambizione e dalla violenza; la storia delle
leggi invece è la storia della giustizia. Non vi è indagine più
gratificante di quella che cerca di tracciare i progressi degli
uomini nel tentativo di imitare il Supremo Reggitore in uno
dei suoi più gloriosi attributi; e di considerarli nell’esercizio di
una prerogativa che desta meraviglia sia affidata alla gestione
di un essere così debole. Nel corso di questa ricerca incontriamo spesso prove di questa “fragilità”,
ma nello stesso
tempo riscontriamo tali nobili sforzi di saggezza e di equità,
da giustificare pienamente la ragionevolezza di quella straordinaria disposizione, per cui gli uomini,
in un modo o nell'altro, si sono sempre posti sotto il dominio di persone simili a
loro. Che cosa di più istruttivo che rintracciare le prime e nascoste fonti di quella giurisprudenza,
che oggi “irriga”ed arricchisce intere nazioni con così copiose inondazioni; che osservare il
manifestarsi dei primi principi del DIRITTO, involti
nella superstizione e contaminati dalla violenza, finché con il
passare del tempo ed a seguito di circostanze favorevoli essi
hanno potuto farsi valere in modo chiaro; le leggi, talvolta
perdute e seppellite nella confusione delle guerre, dei tumulti;
e talvolta soverchiate dalla mano del potere; poi, vittoriose
sulla tirannia; diventando più forti, più certe, più ferme per la
violenza che hanno sofferto; arricchite proprio da quelle conquiste straniere che cercarono di
distruggerle; dirozzate e mitigate dalla pace e dalla Religione; promosse ed esaltare dal
commercio, dalla vita civile e da quella scienza sincera che
apre le menti? >>.
Il diritto, le leggi e la giustizia non sono per Burke la mera
espressione del loro contesto storico, ma scaturiscono da
un’esigenza costitutiva dell’umanità dell’uomo che trova fondamento nella sua connaturata
religiosità, << in an attempt to
imitate the Supreme Ruler in one ot the most glorious of his
attributes >>. Ed è proprio l'insopprimibile esigenza di giustizia che costituisce il principio
dinamico del diritto e che ha
insieme alle altre esigenze e passioni degli uomini una parte
determinante nella generale dinamica della storia.
Burke polemizza contro i fautori della concezione di
un’originaria e perfetta legge inglese che si sarebbe conservata
inalterata per tanti secoli; contro le concezioni politico-partitiche della legge sostenute dai Tories e
dai Wighs (per i primi la legge deriverebbe unicamente dalla volontà del re, per i secondi da precise
istanze e richieste del popolo); infine contro
i teorici di un sistema di leggi originariamente e tipicamente
inglese cresciuto su se stesso, senza alcun apporto di leggi
straniere, che sarebbero state sempre espunte dalla legislazione inglese ogni qual volta si tentò di
inserirle.
Tutte queste interpretazioni sono sostanzialmente astratte
nel senso che non tengono conto della realtà, cioè della sua
concreta dinamica, che può essere compresa solamente nella
dimensione storica: lusingano la vanità nazionale e la grettezza
professionale, espongono i loro sostenitori a << macroscopiche
contraddizioni >>, a tali << assurdità che sarebbe ridicolo menzionarle >>.
Il corpo delle leggi inglesi sino al periodo normanno l’originario nucleo storico - si riferisce a tre
fonti principali:
gli antichi, tradizionali costumi delle genti del Nord Europa,
che furono diffusi con le conquiste a‘ seguito delle invasioni
barbariche e che essendo conformi al << genio >> del popolo
formarono << il grande corpo e il principale flusso delle leggi
sassoni »; i canoni della Chiesa, che se non erano ancora stati
ricondotti a criteri uniformi di interpretazione, contribuirono
a correggere, mitigare e perfezionare le rozze istituzioni dei
popoli del Nord; alcune parti del diritto romano e le consuetudini della altre nazioni germaniche. i
Il problema della formazione storica della società inglese,
delle sue leggi ed istituzioni, induce Burke ad una riflessione
sulla “originaria” società britannica sulla base delle fonti antiche, greco-romane, delle nuove
acquisizioni degli “antiquari”,
degli usi, delle tradizioni, dei “monumenti” dei popoli di
quelle età, di una maggiore consapevolezza dell’influenza che
la collocazione geografica e le condizioni ambientali ebbero
sulla vita di quelle antiche popolazioni. Basti accennare che
Burke dedica il primo libro dell’ Abridgment alle origini della
società britannica ed alla dominazione romana, soffermandosi
in modo particolare sui costumi, sulle tradizioni e le istituzioni religiose di quella società per
rilevarne le essenziali caratteristiche e per illustrare poi i criteri cui si informò l'amministrazione
romana della Britannia, in particolare nel periodo
del tardo Impero.
Secondo le notizie tramandateci da Cesare nel De bello
Gallico le primitive popolazioni britanniche provennero dalla
vicina Gallia: i Celti, i Belgi e gli Aquitani, che si insediarono
rispettivamente nel centro, nel nord e nel sud dell’isola. I
primi, dediti alla caccia e alla pastorizia, furono spinti verso
l’interno dai Belgi, che poterono realizzare stabili insediamenti sulle zone costiere, grazie
all’agricoltura che costituiva
la loro principale attività. I costumi e i caratteri erano sostanzialmente quelli delle popolazioni della
Gallia descrittici da
Cesare, << impazienti, fieri, incostanti, vanitosi, vanagloriosig
amanti delle novità e come tutti i barbari, fieri, infidi e crudeli ». L’arte militare era sostanzialmente
inesistente: erano
temibili solamente per la destrezza nel predisporre imboscate.
Fra i Britanni, come del resto fra tutte le altre nazioni primitive, erano del tutto inesistenti vincoli di
carattere “politico” o “civile”: l’unica forma di “autorità” cui facevano capo
le relazioni dei gruppi parentali era quella del padre di famiglia, al quale era riconosciuto il potere di
vita e di morte su
tutti i componenti della stessa famiglia che comprendevano i
liberi e i servi. A1 di sopra dell’autorità paterna era riconosciuta quella dei sacerdoti, i Druidi, che,
oltre ad amministrare il culto con cui si sancivano le più importanti deliberazioni comuni,
esercitavano tutti i poteri di suprema giurisdizione sui liberi e sulle famiglie: la religione esprimeva
così le
convinzioni comuni dei Britanni necessarie a rinsaldare il sentimento di appartenenza ad una
comunità politica. Burke si
sofferma sulla teologia dei Druidi, fondata sull’immortalità
dell’anima, sulla metempsicosi, sulle loro conoscenze astronomiche, geografiche, di matematica e
di medicina mista a pratiche magiche, sulla loro capacità di celebrare con canti
eroi della comunità e di tradurre il loro sapere in massime redatte in versi, sulla loro arte divinatoria.
Era una religione che
divinizzava la natura, i fondamentali elementi naturali il
fuoco, il sole, la luna, i pianeti, l'acqua; teneva in particolare
venerazione le querce e le foreste.
La religione non è una “superstizione” che alimenta il terrore o le assurde fantasie degli uomini, e
quindi l'efficace
strumento per realizzare la tirannia della casta sacerdotale, ma
è la prima forma di sapere dei popoli primitivi, compresi
quelli più “acculturati”, i Greci e i Romani; è quella concezione della vita e del mondo che, tradotta
nei simboli e nelle
forme del culto, rende possibile la prima forma di ordine civile e politico della società: « The first
openings of civility
have been every where made by religion: amongst the Romans, the custody and interpretation of the
laws continued
solely in the college_ of the pontifs for above a century >>.
Essa pertanto rappresenta il principio d’identità di quella società primitiva, ciò che le consente di
riconoscersi come
un'unità di intenti, finalizzata soprattutto alla difesa contro gli
invasori o a sostenere la ribellione contro gli oppressori: Burke ricorda la crudele strage dei Druidi
ordinata dal comandante romano Paulino, per privare i Britanni dei loro capi
“spirituali” che promuovevano e sostenevano la resistenza
contro l’invasore.
Il progetto di estendere a consolidare il dominio romano
sulla Britannia fu ripreso nel 42 d.C. da Claudio e le operazioni militari, a causa della strenua
resistenza delle popolazioni britanniche, si protrassero per circa trent’anni prima che
il dominio romano, durante l’impero di Vespasiano, grazie
alla saggia condotta militare di Agricola, potesse stabilmente
insediarsi. Agricola sa che la forza militare da sola non riesce
a sottomettere i popoli: la conquista per essere duratura non
deve essere l'occasione per instaurare una tirannia. Il dominio pertanto deve essere temperato e
legittimato dalla partecipazione dei dominati alla civiltà dei vincitori e da un rapporto
di collaborazione ad intenti comuni. Agricola riuscì a “riconciliare” i Britanni ai Romani,
proponendo ai Britanni tutti i
vantaggi della civiltà dei Romani. Egli sottomise i Britanni
rendendoli civili e li indusse a scambiare una << selvaggia libertà » con una << civile e lieve >>
sottomissione. << La sua condotta, conclude Burke, è il modello perfetto per coloro cui è
affidato l’infelice ma necessario incarico di sottomettere un
rozzo ma libero popolo >>.
Burke si sofferma in dettaglio sulle vicende dell’amministrazione romana nella Britannia da
Adriano (171) sino ad
Onorio (432), quando l’isola fu di fatto abbandonata dalle
forze romane, per sottolineare gli eventi e gli episodi in cui è
dato riscontrare un certo ruolo che la Britannia ebbe nella
fase del tentativo di consolidamento dell’Impero e poi nel periodo della decadenza e della fine. La
dominazione romana,
protrattasi per circa quattrocento anni, non riuscì a promuovere nella Britannia una stabile
organizzazione politico-amministrativa in grado di poter contrapporre una valida difesa
dell’isola dalle incursioni dei suoi nemici. Per questi motivi,
quando i Romani abbandonarono l"isola (432), i Britanni non
riuscirono ad esprimere un governo in grado di far fronte agli
attacchi degli invasori.
L’intesa raggiunta di riconoscere un re, garanti per un
certo periodo la pace interna e consentì di organizzare la difesa nei confronto dei Pizi. Nel 447 i
Britanni, constatata
l’impossibilità dì continuare a far fronte agli attacchi dei nemici, avendo perso ogni fiducia nel loro
re e in fondo in se
stessi, decisero nell'assemblea nazionale di chiamare in aiuto i
Sassoni, una popolazione del nord della Germania, nota per
la sua forza e per il suo valore militare. L'aiuto si trasformò in
breve volgere di tempo in una vera e propria invasione, che si
concluse con lo stabile insediamento dei Sassoni e dei loro alleati, gli Angli, nella Britannia e con il
totale assoggettamento
dei Britanni, che se non furono ridotti in schiavitù, come sostengono alcuni storici (Hunie), furono
privati di ogni diritto
politico, “degradati" precisa Burke, una specie di capzìzlv demizmtzo: in effetti furono dissolti
come “nazione”, la loro religione e la loro lingua furono cancellate, e furono assorbiti dai
nuovi dominatori, gli Anglo-Sassoni.
La storia degli Anglo-Sassoni dai loro primi insediamenti
sino alla costituzione della monarchia è caratterizzata dalla
mancanza di fonti storiche attendibili: le cronache di quel periodo non sono altro che una
rappresentazione fantastica delle
gesta dei personaggi leggendari di quei tempi. Sono narrazioni, osserva Burke, che offrono tanti
spunti per i poeti e suscitano invece tante perplessità negli storici: in effetti è il
“tempo" mitico ed eroico della nostra nazione.
L’Inghilterra anglosassone esce da questo periodo
“oscuro" con la diffusione del cristianesimo a seguito della
missione del priore del monastero di S. Andrea, Agostino,
promossa dal papa Gregorio Magno, e della conversione di
Ethelbert, re del Kent, e della sua nobiltà: secondo Burke, fu
la “rivoluzione” più rilevante della storia inglese: << nor is
there indeed any revolution so remarkable in the English History >>. L’importanza del
cristianesimo nel processo di
formazione della società civile e politica inglese durante il
medioevo è sottolineata da Burke nel capitolo secondo del
terzo libro dedicato allo « Stabilimento del Cristianesimo,
delle istituzioni monastiche e dei loro effetti >>.
I successi dello zelo missionario dei monaci nell’opera di
conversione del popolo furono dovuti non solamente alla loro
vita pia ed austera ma anche al fatto che cercavano di istruire
il popolo nelle attività necessarie a soddisfare bisogni primari
della vita civile: Burke ricorda l’iniziativa del vescovo Wilfrid
volta a diffondere fra le popolazioni della costa del Sussex
l’arte della pesca, da loro prima non praticata, offrendo così
ad esse la possibilità di affrancarsi da una situazione di totale
miseria, che spingeva molti al suicidio. L’attività dei monasteri
era in sostanza ispirata alla costante preoccupazione di conseguire il bene` del popolo. `Quando i re
donavano alle chiese
terre che erano state conquistate ai loro nemici pagani, il clero
battezzava e liberava da ogni peso i nuovi vassalli; si avvalevano della benevolenza dei dotti e dei
consiglieri per indurli a
mitigare il rigore della legge di conquista: << essi gioivano nel
vedere la religione e la libertà avanzare con un uguale progresso >>.
Per Burke nulla merita maggiore lode che lo zelo dei monaci per la libertà delle persone: nei loro
canoni, come nelle
transazioni stipulate con i grandi proprietari, era sempre inserito un preciso richiamo a favore della
libertà. Le penitenze
erano finalizzate ad atti di beneficenza, per cercare dì trarre
dalle azioni malvagie occasioni per operare il bene; il (grande
feudatario penitente era sollecitato a liberare i propri schiavi
ed a redimere quelli degli altri, oppure gli si suggeriva di riparare le strade, di costruire chiese, ponti
e di provvedere ad
altre opere di pubblica utilità. I monasteri erano le uniche organizzazioni con carattere di perenne
continuità, ai quali si rivolgeva chi desiderava istituire lasciti patrimoniali per soccorre i poveri,
sicché essi rappresentavano l'unico canale attraverso cui la liberalità dei ricchi passava in un
continuo
flusso ai poveri, che potevano sempre contare sul soccorso
delle istituzioni monastiche.
La confidenza che il monachesimo aveva suscitato in tutte
le classi sociali per le sue austere regole di vita, ben lontane
dall’avarizia e dal desiderio di ricchezza che lo caratterizzò nel
secolo successivo, promosse la crescita dei monasteri. Essi
trasformarono, mediante bonifiche e dissodamento di terre
incolte, i siti sperduti in cui si erano insediati e costruirono
splendide abbazie, che non furono solamente centri di vita
religiosa, ma ebbero anche un ruolo rilevante nella vita civile
e politica. I monasteri e le abbazie rappresentarono in quei
tempi di ricorrente anarchia politica, caratterizzati da guerre
continue, un luogo di sicuro rifugio per re, principi, conti,
grandi feudatari, rispettato di solito da tutti i contendenti. Da
questo fatto nasce il diritto di immunità che fu poi riconosciuto ufficialmente ai monasteri ed alle
terre di loro proprietà, il che consentì di allargare la possibilità di rifugio a
tutte le classi sociali, in particolare al popolo minuto, maggiormente esposto alle vessazioni dei
feudatari. In tal modo i
monasteri esercitavano un importante ruolo volto a contenere
la feroce lotta politica ed a proteggere le classi meno abbienti:
grazie alla loro influenza L’interpretazione delle “barbare”
consuetudini e leggi cominciò ad essere informata a criteri di
equità e di umana considerazione.
I monasteri furono anche gli unici centri di attività culturale e di diffusione di “sapere civile": se lo
spirito del monachesimo, come si suol ritenere, contribuì alla decadenza delle
scienze nell’Impero romano è certo però che la diffusione
della cultura e della civiltà nel Nord Europa fu merito esclusivo dell'iniziativa e dell’impegno dei
monaci. Si noti a tal
proposito che la spiegazione e l’approfondimento dei testi sacri richiedeva una cultura che si
riferiva alle scienze, alle lettere, alle arti delle civiltà latina e greca: la conoscenza della
lingua latina necessaria per tutte le funzioni del culto, per il
“governo” delle istituzioni ecclesiastiche e per le loro relazioni
in Inghilterra e con Roma, implicava naturalmente lo studio
degli autori classici, che erano stati salvati dal naufragio della
letteratura antica. Grazie a quelle esigenze ed a quegli interessi di carattere religioso-culturale
furono trasmessi sino ai
nostri giorni quegli inestimabili “monumenti” della letteratura
e della scienza classica, che sarebbero certamente stati distrutti in occasione dei saccheggi, delle
rapine, delle stragi che
caratterizzarono quei tempi dell’alto medioevo.
Burke rileva inoltre l’importanza dei pellegrinaggi, promossi dalla religiosità cristiana diffusa ed
alimentata dal monachesimo, che, se possono essere oggetto di riserve e critiche, risultarono di
sicuro vantaggio per la cultura. Le loro
mete erano Roma, che ancora conservava il poco che si era
salvato dalla rovina dell’Impero; Gerusalemme, che li portava
nel cuore dell’impero greco, ove erano vivi gli antichi studi,
cui si aggiungevano nuove conoscenze nell’ambito delle arti.
Quando gli Arabi occuparono la Palestina i pellegrini ebbero
l'occasione di apprendere le nuove scoperte di “quel popolo
laborioso". Essi stabilirono pertanto, in quei tempi così avversi, contatti fra l’isola e tante altre
nazioni di cui si sarebbe
appena avuto notizia, portando in patria tante informazioni
che non si riferivano solamente ai miracoli e alle leggende, ma
anche a nuove conoscenze utili per le esigenze della loro vita.
I pellegrinaggi in tal modo preservarono, rileva Burke, quello
scambio di relazioni proprio del genere umano, che nell’età
moderna è garantito dalla politica, dal commercio e dalla “curiosità colta".
Proprio quei viaggi portarono in Inghilterra i semi del sapere e del progresso, che furono coltivati
nella tranquillità e
nel rifugio dei monasteri, le uniche istituzioni che potevano
assolvere a tale compito che richiedeva una categoria di persone che fosse libera dal
condizionamento degli impegni della
vita quotidiana e che, dati i tempi, non fosse assillata dalla totale incertezza del domani, dal timore
di un'incombente miseria e di imminenti pericoli di vita. In effetti, osserva Burke, la
conservazione e la diffusione del sapere furono rese possibili
dal fatto che la vita contemplativa era stata distinta e separata
dal resto della comunità, garantendole uno status particolare,
come condizione necessaria per poter svolgere il suo ruolo di
conservare ed alimentare la fede ed il sapere, che avrebbero
dato un contributo essenziale alla “civilizzazione” della società inglese e del nord Europa. C'è in
queste considerazioni di Burke l’implicita affermazione del primato della vita “contemplativa” su
quella pratico-operativa, della conoscenza teologico - religiosa, filosofica, letteraria, su quella delle
arti e dei mestieri, come necessaria premessa storica di quella civiltà del
sapere che rende possibile e continuamente promuove le conoscenze utili all'uomo e alla società: in
altri termini il ,bios ..... presuppone per quanto riguarda la nascita dei
nuovi popoli e delle nuova società europee il ,bios ..... intimamente connesso, come la storia ci
ricorda, al sentimento religioso. Né va dimenticato che un contributo notevole alla cultura
inglese fu dato dai prelati stranieri nominati dal Papa per meriti religiosi e vasta dottrina alla più alta
carica ecclesiastica
inglese. Fra questi Burke ricorda il settimo arcivescovo di
Canterbury, il greco Teodoro, che introdusse intorno al 669 lo
studio della lingua greca in Inghilterra, creando a tal fine una
scuola presso la cattedrale, dotandola di preziosi manoscritti
greci fra i quali un “magnifico codice contenente i poemi
omerici: << and thus the other great fountain of knowledge,
the Greek tongue, was opened in Englandu. >>. Se il sud della
Inghilterra si giovò del diretto “canale" con Roma per promuovere e diffondere la cultura; nel nord
dell'Inghilterra tale
esigenza fu assolta da due monasteri, quello di Hii e quello di
Durham che furono riconosciuti con giudizio concorde come
autorevoli centri di dottrina religiosa e di sapere “profano".
Nell’opera del << venerabile >> Beda, il più dotto religioso
di quel periodo, si esprime, a giudizio di Burke, l’impegno
della cultura ecclesiastica di connettere le esigenze di un approfondimento della dottrina religiosa
con una esposizione sistematica delle conoscenze che si riferivano alle discipline e
alle arti tramandate dal mondo classico. Di Beda, oltre agli
scritti di commento alle Sacre Scritture, ad argomenti di filosofia naturale, dì grammatica, di
retorica, di etica, vanno ricordati gli scritti storici, in particolare la sua Historia ecclesiastica, che
rimane, nonostante un certo disordine nella distribuzione della materia e certe ingenuità per le
interpretazioni
decisamente miracolistiche di alcuni avvenimenti, una fonte
preziosa per la storia di quei tempi.
Nel giudizio sulle opere di Beda non bisogna soffermarsi
solamente sulle ingenuità e le concezioni erronee dettate da
superstizioni e da pregiudizi religiosi, ma mettere in risalto,
con una giusta valutazione storica, il valore positivo che ebbero per la società del loro tempo nel
promuovere un significativo progresso culturale e scientifico. Esse educarono le
menti ad avere una concezione sistematica della realtà, a concepire i rapporti e gli interessi derivanti
dalla comune vita sociale secondo un determinato ordine ed a disciplinare e controllare gli impulsi
delle passioni con i valori della religione e
i principi della morale. E, cosa particolarmente importante,
l’interesse dimostrato per la lingua inglese della quale si cominciò a perfezionare e ad arricchire le
sue capacità “espressive” sul modello delle lingue e della cultura classiche. Di qui
l'alto apprezzamento di Burke dell'opera di Beda, « this father of the English learning >>, al quale è
impossibile rifiutare
« the praise of an incredible industry and a generous thirst of
knowledge >>. Va altresì riconosciuto che nessun'altra nazione,
tranne quella inglese, che aveva cominciato ad uscire da una
“totale” barbarie solamente cinquant'anni prima, riuscì ad
esprimere in così poco tempo un fiorente centro di cultura ed
un così eminente maestro.
La diffusione del cristianesimo nell’Inghilterra rese più
“civili” i costumi barbari delle popolazioni, attenuando la loro
ferocia e rozzezza, e favorì il consolidarsi fra quelle popolazioni di una serie di rapporti e di
relazioni che consentirono
una prima forma di unione fra i cinque regni costituitisi all’indomani della conquista anglosassone:
il Wessex, la Mercia, il
Northumberland, il Kent e l’Essex. L’impulso a questo primo
tentativo di unificazione politica dell’Inghilterra provenne
dall'esempio offerto dalla politica di unificazione imperiale di
Carlo Magno, alla cui corte era stato ospitato Egbert re del
Wessex, che nell’827 riuscì a realizzare l'unione dei cinque regni.
L’autorità e il potere della monarchia in effetti erano
molto fragili: la mancanza di vincoli e rapporti (istituzionali
definiti e precisi poneva la monarchia alla merce della grande
aristocrazia, che di fatto era sovrana nelle sue vastissime proprietà. Si aggiunga che la successione
al trono era spesso l'occasione di gravi conflitti fra i pretendenti: non vi erano norme
precise che la regolassero e doveva essere confermata dall'elezione degli ordini. La stabilità e la
durata del potere monarchico erano pertanto affidate unicamente alle capacità e alla
personalità del monarca. Se Egbert riuscì a mantenere con
autorità il suo potere ed a respingere gli assalti dei Danesi,
che cercavano di insediarsi nell'isola, il suo successore
Ethelwolf, mite, devoto, interessato più alle pratiche di pietà
religiosa che agli affari di governo, fu del tutto incapace di
contrastare validamente i loro attacchi. I suoi successori
Ethelbert ed Ethelred non riuscirono ad arrestare il processo
di disarticolazione della monarchia. Il regno sassone era tale
solo di nome, di fatto si era dissolto e le “parti" che lo costituivano erano ritornate alla loro antica
indipendenza, favorita
dalla situazione di anarchia determinata dagli attacchi e dagli
insediamenti dei Danesi.
La ricostituzione dell’unità del regno sassone fu dovuta
all'energia, alle capacità militari e di governo del nuovo re Alfredo, che, dopo alterne vicende, riuscì
a scacciare i Danesi
dal Wessex, dalla Mercia e dal Northumberland e ad obbligarli ad un tributo nell'Est Anglia,
conseguendo, questa volta,
una durevole pace. Oltre che alla difesa e alla “restaurazione” dell’unità politica del regno sassone
Alfredo provvide
ad una organica riorganizzazione legislativa ed amministrativa
dei suoi domini, che ne garantisse l'ordine e la tranquillità,
talché egli è ricordato con onore come << the founder of our
Laws and Constitution >>. Le contee furono suddivise in cento
“distretti”, ripartiti- in “tythings" delle quali dovevano far
parte gli uomini liberi, vincolati dal mutuo impegno di preservare la pace e di evitare il furto e la
rapina. Particolare attenzione fu rivolta all’amministrazione della giustizia, al fine di
migliorare la preparazione dei giudici, che dati i tempi erano
sforniti di una adeguata cultura giuridica, e di garantire una
giustizia obbiettiva con severe condanne nei confronti dei frequenti casi di corruzione. Fu promossa
inoltre un’organica
raccolta delle leggi, degli usi, delle consuetudini, nella quale
furono inseriti diversi commenti come orientamento per i giudici al fine di assicurare la certezza del
diritto e garantire una
corretta applicazione delle leggi.
Dopo la morte di Alfredo i suoi successori furono di
nuovo impegnati nella lotta con il nemico di sempre, i Danesi,
senza peraltro riuscire ad incidere efficacemente sulle loro capacità offensive. La guerra contro i
Danesi, che nel frattempo
erano riusciti ad insediarsi stabilmente nell'isola, continuò fra
alterne vicende ed impegnò i monarchi sassoni dal 900 sino al
1016, quando il re dei Danesi Canuto, alla morte di Edmund,
l'ultimo dei successori di Alfredo, riuscì a farsi designare dall’assemblea degli ordini re
d’Inghilterra. La monarchia danese
non durò a lungo, per l’incapacità dei successori di Canuto e
per la forte opposizione dell’aristocrazia anglosassone: alla
morte di Hardicanute, l'ultimo re danese, appena trentatré
anni dopo l’avvento al trono di Canuto l'assemblea del regno
ricostituiva con voto unanime la monarchia sassone nell’ultimo discendente Edward il confessore,
che si era rifugiato in
quegli anni nel ducato di Normandia.
Edward disilluse ben presto l'aristocrazia sassone che lo
aveva sostenuto con la sua politica dichiaratamente favorevole
ai suoi amici normanni che si concluse con lo scontro aperto
con Godwin, conte di Kent, capo del “partito” sassone. Si
erano costituite cosi le premesse per l’intervento dell'assemblea del regno in occasione della morte
dì Edward, che non
aveva lasciato eredi diretti. Fu eletto al posto del pronipote di
Edward, Edgar Atheling, legittimo erede, il figlio di Godwin,
Harold II, sancendo così il principio elettivo per la successione al trono d’Inghilterra. Ma
l'esclusione del successore legittimo e la designazione al trono di un estraneo alla
famiglia, reale consentirono a Guglielmo duca di Normandia
di disconoscere la nomina per far valere la sua pretesa alla
Corona, fondata sulle promesse del re defunto.
Fu l'ir1izio di un conflitto che si concluse con lo sbarco in
Inghilterra dell’esercito normanno e con la sconfitta e la
morte di Harold II nella battaglia di Hastings. La nobiltà sassone, insieme alla città di Londra, « che
nota Burke
persino a quel tempo era molto potente >>, tentò di organizzare la resistenza riconoscendo come re
il legittimo successore
Edgar Atheling. Ma ben presto si manifestò l'inconsistenza
del tentativo, per la mancanza di fiducia nel nuovo re, per i reciproci sospetti che dividevano gli
aristocratici, per la paura e
la confusione che dominava nell’assemblea costituita da rappresentanti di ordini in contrasto fra di
loro. Quando Guglielmo, dopo aver passato il Tamigi si avvicinò a Londra, << il clero, i cittadini, la
gran parte dei nobili - conclude Burke -, che avevano di recente messo la Corona sulla testa di
Edgar, gli andarono incontro per fargli atto di sottomissione,
per accompagnarlo poi in trionfo a Westmmster, ove fu solennemente incoronato re d’Inghilterra.
Tutta la nazione seguì
l'esempio dj Londra: una sola battaglia concesse l'Inghilterra
ai Normanni, la cui conquista era costata tanto tempo e tanto
sangue ai Romani, ai Sassoni e ai Danesi ».
Secondo Burke la sconfitta dell'esercito anglosassone
nella battaglia di Hastings non fu la causa della fine del regno
anglosassone (come ritengono alcuni storici, fra i quali Hume)
ma fu l’episodio finale della lunga crisi che minò ogni possibilità di efficace resistenza del regno.
Per Burke il processo
d'unificazione politica avviato da Egoberto e che aveva trovato nell'opera di Alfredo la sua
espressione più organica e
coerente non era riuscito a conferire un'effettiva stabilità al
nuovo ordinamento politico. Intanto la legge che obbligava
ogni individuo ad appartenere ad una Tything Court aveva
rinchiuso la società anglosassone in una rigida struttura che fu
la prima causa della mancata integrazione fra le due popolazioni, l’originaria britannica e quella
anglosassone, e che non
consentì alcuno sviluppo delle energie sociali, finendo per
isterilirle e provocando cosi la decadenza della nazione anglosassone. D’altro canto due secoli di
guerre contro i Danesi
avevano praticamente dato fondo a tutte le risorse, mentre le
capacità, di difesa e di recupero erano sostanzialmente molto
limitate: non esistevano città costruite in mattoni, né si era in
grado di poter costruire posti fortificati con muratura in cui
poter concentrare e riorganizzare la difesa, in modo da poter
affrontare in condizioni di vantaggio l'esercito invasore. La
loro tecnica militare era elementare ed arretrata, come la loro
civiltà, rispetto a quella dei Normanni.
Dal punto di vista dell’organizzazione politica la crisi si
manifestava con il progressivo indebolimento del potere regio. Le lotte continue contro i Danesi
avevano offerto l’occasione perché il potere degli Alderman aumentasse ogni giorno
di più a scapito di quello regio (« too great to obey, and too
little to protect >>) mentre l'aristocrazia “regia”,che costituiva
la struttura portante del regno e il nerbo della nazione, sempre a motivo delle guerre, si era ridotta a
un numero veramente esiguo di famiglie. Si aggiunga che per l'istituto del
Galvelkind che ammetteva alla successione delle terre “nobili" tutti i figli maschi in parti uguali e
ir1 mancanza di questi anche le figlie, la proprietà si era suddivisa, con il risultato
di determinare un continuo cambiamento nella titolarità – e relativa riduzione - dei poteri connessi
con quelle proprietà:
il governo anglosassone entrò cosi in uno stato di “continua
fluttuazione”. In quella situazione il potere tendeva a concentrarsi in pochi gruppi, ostili fra di loro:
le famiglie aristocratiche più rappresentative, aspirando tutte alla corona d'Inghilterra, rendevano
sempre più incerti i diritti dei legittimi successori. Tutto ciò si rifletteva nelle assemblee del regno,
nelle
riunioni del “parlamento” anglosassone, che era praticamente
diviso fra le opposte fazioni delle grandi famiglie che aspiravano al trono, e quindi incapace di
promuovere una valida resistenza, perché senza una guida, senza un preciso indirizzo
politico; alla fine i Grandi preferirono sottomettersi ad un
principe straniero, anziché a chi ritenevano un loro eguale e
nemico.
Secondo Burke non possiamo avere una piena comprensione della storia della monarchia
anglosassone se non ci rendiamo conto del nesso sussistente fra le sue leggi ed istituzioni
e la sua attività politica: si tratta, come aveva suggerito Montesquieu, di << illuminare la storia con
le leggi e leggi con la
storia ». Anche per Burke, come per Montesquieu, le leggi
sono intimamente connesse con l'ambiente, con il carattere,
con l’indole, con il grado dì cultura, con il generale sistema di
vita: lo “spirito delle leggi” è il principio unificatore di tutti
questi fattori, che debbono essere considerati come parti di
un tutto che si articola e si specifica in un processo storico. Le
condizioni di vita dei Sassoni e lo stato della loro cultura sono
i primi dati che dobbiamo tener presente per comprendere lo
“spirito” delle loro leggi.
Un popolo barbaro, la cui unica occupazione era- la
guerra, senza arti, senza “industrie”, aveva vincoli politici
estremamente labili, per la mancanza di quella trama di- rapporti e di relazioni propria delle società
civili, che consente di
concentrare la forza sociale in un unico potere e di realizzarne
le deliberazioni per il conseguimento dei fini comuni. Altra
caratteristica tipica di quei popoli era la mancanza di una distinzione fra legge e costume: le leggi
dei Sassoni si identificavano con il costume, erano l’espressione delle consolidate
_convinzioni collettive. Fra queste la più radicata, che esprimeva lo spirito di quell’elementare
ordine sociale e politico,
stabiliva la regola che le deliberazioni che riguardavano il
comportamento di tutti i membri della comunità dovevano
essere approvate dall’assemblea di tutti gli uomini liberi. Più
precisamente, nota Burke, i popoli di razza germanica, secondo quanto attesta Tacito, consentivano
che i loro capi
avessero un pieno potere nel decidere le “ cose minori”, come
le controversie che si verificavano fra i singoli, ma non le questioni che riguardavano l’intera
comunità: si riconosceva ai
loro principi e re il potere giudiziario, ma non quello legislativo, che apparteneva all’assemblea.
Burke, se partecipa con Montesquieu alla convinzione che
il principio ispiratore dei governi liberi è proprio delle popolazioni di razza germanica, non si lascia
trascinare dall’entusiasmo per questa costituzione primitiva, quasi fosse il modello, indubbiamente
semplice ma compiuto, del sistema costituzionale inglese. Quella “costituzione” è l’espressione
delle
scarse relazioni comunitarie proprie di un popolo primitivo e
barbaro, prive di qualsiasi incentivo atto ad incrementarle,
che avrebbero mantenuto i Germani in quelle condizioni di
vita primitiva. Se il “sistema costituzionale", come vuole Montesquieu, è .stato inventato nella
foreste della Germania, bisogna anche considerare, avverte Burke, che finché rimase in
quelle foreste ed anche per lungo tempo dopo, fu ben lontano
dall’essere un buon sistema; in effetti fu un tentativo molto
imperfetto di fare un governo. Era un sistema per un popolo
rozzo e barbaro, calcolato per mantenerlo nella sua barbarie.
L’ordinamento politico della società anglosassone si basa
sul rapporto di subordinazione che vincola il libero che riceve
le armi dal signore il quale gliele consegna e che impegna il
primo a porsi al servizio del suo signore: è questo un obbligo
che riguarda tutti i liberi atti alle armi, che possono scegliersi
il signore cui affidarsi. Questo rapporto, secondo Burke, si
basa su i due fondamentali sentimenti della natura umana:
l’ambizione, che spinge un uomo, anche a costo di qualsiasi
rischio e sacrificio, ad assumere la guida degli altri; e l’ammirazione, che induce gli altri a seguirlo
per il mero piacere di
appagare questo sentimento, cui si accompagna una specie di
“secondaria” ambizione, fra le più diffuse fra gli uomini; questi due principi creano una volontaria
ineguaglianza e dipendenza fra gli uomini. Ma fra gli uguali, fra i signori, non poteva che sussistere
un vincolo di tipo confederale: essi sono
ricordati nelle leggi sassoni con il titolo di Seniore e di Cavaliere ed i loro subordinati con il termine
di “fratelli alleati”,
con il compito di sostenere il reame e la monarchia. Infine il rapporto di subordinazione implicava
che il signore
provvedesse al mantenimento dei subordinati a ricompensa
dei loro servizi.
A Questi principi individuano una categoria di persone, che
costituisce la “struttura portante” dell'organizzazione politica
anglosassone: l'aristocrazia militare. L'ereditarietà del ruolo
politico che fini poi per caratterizzare questa classe o “ordine" è, secondo Burke, il risultato della
trasformazione di un
rapporto di carattere squisitamente personale fondato sulla libera scelta, e' quindi precario perché
soggetto- al mutevole
comportamento di individui leali ma violenti, in uno di carattere istituzionale, garantito dal diritto.
L’ereditarietà dello status di “signore” era l’unico modo per dare stabilità e continuità ai rapporti di
carattere politico fra il “signore” e subordinati, garantendo in tal modo la sicurezza e la pace
dell’intera comunità. A queste imprescindibili esigenze di stabilità
occorreva provvedere in occasione della morte del re e dei
grandi feudatari, mediante il riconoscimento dei “diritti del
sangue" garantiti dalla successione ereditaria, che in determinate occasioni erano riconosciuti
dall’assemblea della comunità mediante l'elezione.
L'ordine politico della società, basato sul rapporto di natura clientelare, si strutturava sulle categorie
sociali in cui era` divisa la società anglosassone: nobili, vassalli, liberi e schiavi che facevano capo
alla famiglia gentilizia sulla quale si fondava la rudimentale organizzazione
Giuridico - amministrativa.
La costituzione anglosassone riconosceva un ruolo eminente alla nobiltà che era al servizio del
monarca, alla quale era assegnato, per le spese dei dipendenti e degli armati, un vasto territorio con
piena giurisdizione sui suoi abitanti). La ripartizione amministrativa del regno si fondava sulla
Tything Court, formata da dieci capi famiglia liberi e di “qualche considerazione", che deliberava
sulle questioni e sulle controversie che potessero turbare la concordia della comunità: il fine della
Tything era proprio quello di garantire la reciproca fiducia fra i suoi componenti; ogni uomo del
regno, in quanto sottoposto ad ur1a Corte signorile, era obbligato a far parte dì una Tything. Dieci
di queste costituivano una Hundred Court, che si riuniva una volta al mese per decidere sui reati
minori. Le questioni più importanti, compreso l’atto di fedeltà al re, erano trattate e decise dalla
County o Shire Court, la ripartizione amministrativa più grande del regno, presieduta da un nobile
di grande prestigio denominato Ealdorman, sempre affiancato dal vescovo, per le questioni che si
riferivano all'ordine ecclesiastico. In effetti, tiene a precisare Burke, il rispetto che si portava al
clero e la cultura superiore del vescovo, ne facevano il presidente di fatto della Corte e l’ispiratore
delle sue decisioni, consentendogli in tal modo di temperare la rigidità e la severità delle leggi
anglosassoni. L’assemblea del regno denominata Wittenagemote, il “parlamento” anglosassone, era
considerata superiore a tutte le altre corti perché era formata dai membri più influenti degli ordini
del regno, aristocrazia e clero, e dagli alti ufficiali di Corte. Ogni persona di qualsiasi rango sociale
poteva assistere al Wittenagemote, per essere informata del risultato dei suoi
lavori. Ma ciò non significa, avverte Burke, che essa possa essere considerata una sorta di
assemblea rappresentativa delle contee e delle città, come fu poi la Camera dei Comuni: l’idea
di rappresentanza era troppo complessa per le menti semplici
degli Anglo Sassoni, che fra l'altro disprezzavano le attività
connesse all’esercizio delle arti e del commercio, che costituirono il presupposto di quegli interessi,
di quelle esigenze e di quelle relazioni che ebbero poi un riconoscimento mediante
la loro rappresentanza politica nei Comuni. La composizione del parlamento sassone, secondo
Burke, non era stabilita con certezza. Si può ritenere che allorché si
rendeva necessario assumere provvedimenti di carattere legislativo, che riguardassero tutti i sudditi,
il re convocava il Wittenagemote e riuniva nel luogo della sua corte i vescovi e
tutte le altre persone che riteneva più opportune, Conti e grandi feudatari. Le leggi, dopo essere
state approvate, erano comunicate per la loro esecuzione alle Corti dei “borghi”, circoscrizioni
comprendenti più città e villaggi, nelle quali il popolo si impegnava ad osservarle e ad unirsi per
perseguire quanti l’avessero violate. In tal modo, secondo `Burke, la forma di governo del periodo
anglosassone era in sostanza una confederazione, che era continuamente rinnovata, in occasione
dell’impegno ad eseguire le leggi espresso dalle Corti dei “borghi” . Altrettanto incerti erano i poteri
che il re esercitava nell'assemblea: la legge, proclamata in nome del re,
era proposta dalla persona incaricata di redigerla, ed era considerata l’espressione del consenso
unanime dell’assemblea più che la manifestazione della volontà di un legislatore che la
stabiliva di propria autorità. Di nuovo Burke rileva quanto sia
errato ritenere che l’ordinamento costituzionale inglese risalga
a quei tempi remoti, senza rendersi conto << che così forti
cambiamenti nei costumi, nel corso di tante età, debbono
produrre sempre un considerevole cambiamento nelle leggi, e
nelle forme come nei poteri di tutti i governi >>.
La stessa osservazione vale per le leggi anglosassoni, che
riflettono il carattere di quelle popolazioni, la loro semplicità
e rozzezza: esse erano finalizzate ad assicurare la pace fra i
vari clan familiari ed a fissare pertanto, con riferimento alle
diverse categorie sociali, l'importo dell’indennizzo che l'offensore avrebbe dovuto pagare all’offeso:
leggi “imperfette”,
prive dì alcun criterio di coordinamento, che sancivano consuetudini dei clan familiari fra loro
diverse e contrastanti.
Esse pertanto sono ben lontane da quella perfezione che attribuiscono loro i soliti panegiristi delle
istituzioni e delle leggi
anglosassoni. Altrettanto semplici i principi sui quali si basava
il processo, in particolare quello penale. Ogni controversia era
decisa o sulla base del giudizio e dell’intesa delle parti, oppure sulla base dell’opinione della
comunità, oppure con l’appello al giudizio di Dio, denominato ordàlia, che si sarebbe
manifestato mediante le prove dell’acqua bollente o del ferro
rovente: chi le avesse superate, doveva essere considerato innocente.
Al fine di evitare per quanto era possibile la severa procedura dell’ordàlia e nello stesso tempo per
non lasciare adito allo spergiuro, si ammise nella pratica giudiziaria il principio
della prova e del giudizio sulla base dell’affidamento e della
conoscenza dei vicini, della comunità. L'imputato che fosse
assistito in giudizio da dodici “compurgatori”, che attestavano
che il suo giuramento era conforme al vero, era prosciolto
dall’imputazione: se l’opinione di alcune persone legittimava
1’accusa, l’opinione di dodici persone stimate valeva a liberarlo dalla stessa accusa: << If opinion
supports all government, it not only supported in the general sense, but it directed every minute
part, in the Saxon polìty >>.
A quei principi fu ispirato il giudizio basato sulla giuria,
Trial by the Country, cioè di affidarsi per ogni questione dubbia al giudizio di persone del luogo,
che conoscessero le persone e i fatti. La giuria non era vincolata, tranne un caso particolare previsto
da uno specifico statuto, ad alcuna regola
processuale predeterminata ma era libera di giudicare sulla
base delle sue informazioni e presunzioni. La legislazione penale anglosassone era molto moderata.
La pena di morte era
rarissima e non era contemplata la tortura: essa era sostanzialmente finalizzata alla composizione
delle reazioni che suscitavano i reati gravi che avrebbero certamente turbato la pace
della comunità; era ispirata pertanto al principio di mirare alla
compensazione dell’offesa e del danno ricevuti. Il governo
sassone si limitava ad esercitare la funzione d'arbitro fra le
due parti contendenti, fissando l’entità della composizione e
garantendone l'esecuzione.
' Burke si sofferma sul rilievo che ha la proprietà della terra
nell’ordinamento politico della società anglosassone. Secondo
la consuetudine sassone, propria di tutti i popoli germanici, le
terre erano ridistribuire annualmente fra le famiglie e i gruppi
gentilizi; dopo l’insediamento nell’isola britannica si provvide
invece all’assegnazione di vasti territori ai capi dei clan gentilizi per la difesa della “conquista”. Il
possesso a vita riconosciuto a chi aveva ricevuto tale assegnazione, questa prima
forma storica di proprietà, ebbe come scopo quello di rendere
stabile una serie di rapporti che si costituivano fra il titolare
del possesso ed i suoi dipendenti, in particolare il rapporto
clientelare che legava i secondi al primo, e quello di soggezione che vincolava schiavi e semiliberi
alla coltivazione della
terra che era stata concessa.
Questa forma di possesso, proprio perché univa per tutta
la vita l’uomo e la sua famiglia ad un determinato territorio,
si trasformò a poco a poco in un vero e proprio diritto cui
venne riconosciuto il carattere dell’ereditarietà, affinché
quella stabilità dei rapporti sociali che era a fondamento della
concessione a vita delle terre fosse ulteriormente garantita e
rafforzata dal perdurare del possesso nella stessa famiglia, che,
secondo l’espressione di Burke, era di fatto “murata” nei suoi
possedimenti dalle “proprietà" confinanti di altre famiglie
concessionarie. Già al tempo del re Alfredo (871-897) questi
grandi possessi si trasmettevano per successione nella stessa
famiglia,
Accanto a queste “proprietà” denominate Bookland, era
riconosciuta un'altra forma di proprietà, normalmente più
piccola e quindi politicamente meno importante, il cui titolo
non si fondava sulla concessione reale, ma sulla prescrizione,
sul possesso mantenuto per un lungo periodo di tempo, la
Folkland. Queste terre erano libere dai vincoli di concessione, potevano essere lasciate in eredità sia
ai figli maschi che
femmine e potevano essere liberamente alienate. Dopo questi
due tipi di proprietà vi erano le concessioni di terra date dal
re in vista di servizi particolari, per certi aspetti simili ai feudi,
introdotti più tardi, a seguito della conquista normanna.
La conquista normanna ha per Burke il merito storico di
aver finalmente inserito l'isola britannica nella più ampia società politica europea, rendendola
partecipe di una forma superiore di civiltà grazie alla possibilità di costanti, proficui
contatti con gli altri Stati europei, che avrebbero così, sia pure
indirettamente, contribuito al processo di incivilimento della
società inglese. La specifica connotazione della storia inglese, data dal suo “sistema politico" che si
organizza a poco
a poco intorno alla monarchia e i cui principi saranno definiti
con la Magna Carta, non deve farci dimenticare - avverte
Burke - che essa si svolge in parallelo con quella europea per
gli stretti nessi fra la politica inglese e quella dei ducati del
Nord Europa, della Francia e dell’impero, peri continui rapporti di carattere religioso e culturale con
la Francia del Nord
(il ducato di Normandia) e in particolare con la Chiesa di
Roma. Basti accennare all’importanza che le Crociate ebbero
nella politica della monarchia normanna ed ai riflessi della
lotta per le investiture fra Impero e Chiesa sulla politica ecclesiastica della stessa monarchia,
impegnata a garantire la sua
piena sovranità temporale nei confronti di Roma. La storia inglese del periodo della monarchia
normanna deve essere studiata, secondo Burke, con riferimento al quadro storico dell’Europa fra
l’ottocento e il mille, nel cui ambito si espressero le due
istituzioni a carattere universale, l'Impero e la Chiesa, che caratterizzano la storia medioevale.
La società europea dell’alto medioevo si costituisce a seguito dell’insediamento dei popoli di razza
germanica nei territori dell’ex Impero romano con forme di organizzazione politica assai
rudimentali. I tempi oscuri della società europea
corrispondono a questo primo periodo, caratterizzato da una
ricorrente instabilità politica, dalla estrema difficoltà di superare il particolarismo delle aggregazioni
politiche tribali - familiari, dalle continue guerre di rapine e di conquista, tali da
darci l’impressione di un disordine totale e di una permanente
anarchia. Si aggiunga inoltre che proprio in questo periodo
l'invasione degli Arabi e le loro rapide conquiste sembrarono
destinate ad aver facile ragione di una società disgregata da
lotte e conflitti continui. Ciononostante in questa stessa società, osserva Burke, si erano già espressi
quegli ideali e quei
principi di una superiore unità dei popoli e delle nazioni europee, che le avrebbero consentito di dar
vita ad ordinamenti
politici garanti di quel tanto di stabilità e di ordine necessari
ad avviare un lento ma continuo progresso civile.
Il rapporto di colleganza fra i regni, i principati e le entità
politiche minori europee era rappresentato dalle due istituzioni a carattere universale, l’Impero e la
Chiesa, che garantirono il processo di formazione della società europea. Anche
in questo caso Burke afferma la sua convinzione sul ruolo essenziale del cristianesimo e della
Chiesa nel creare dei vincoli
di carattere religioso, spirituale e culturale, nel proporre cioè
una concezione della vita che consentì all’Europa “barbarica”
di uscire da una situazione di anarchia e di stabilire al suo interno una serie di rapporti e di relazioni,
che formarono la
trama che rese partecipe la società europea di comuni ideali e
valori. La religione cristiana appare quindi a Burke come la
forza spirituale che salvò l’Europa dalla dispersione e dall’anarchia, mentre la politica della Chiesa
seppe con grande
saggezza costruire un potere fondato esclusivamente sull’opinione, sfruttando tutte le occasioni
favorevoli per consolidare
il suo potere spirituale su quello politico temporale, per sottrarsi alla soggezione di quest’ultin1o e
per affermare alla fine
la sua autonomia ed indipendenza.
Burke riconosce al Papato una grandissima arte politico diplomatica. I Papi seppero “servirsi” sia
delle virtù che dei
crimini dei grandi: favorirono la brama dei re per un'autorità
assoluta e il desiderio di libertà dei sudditi: provocarono la
guerra e si adoperarono per la pace ed ogni volta riuscirono a
crescere nell'opinione e nella considerazione generale. Il loro
potere poté così estendersi dalla sfera ecclesiastica a quella politica, passare dalla sottomissione
all’indipendenza ed assumere così i caratteri di un potere universale, analogo a quello
dell’Impero.
La premessa storica dell'Impero fu la costituzione in
Francia di una forte monarchia alleata della Chiesa, l’unica
istituzione che poteva sancire la legittimità della monarchia,
riconoscendole il ruolo di garante della giustizia e del diritto,
e quindi dell’ordine e della pace temporali, contro ogni tentativo di violenza e di sopraffazione. La
politica di Pipino e
quella di Carlo Magno ebbero il loro pieno riconoscimento
con l’incoronazione di Carlo Magno quale Imperatore dei Romani. La società politica medioevale
poteva avere un costante
punto di riferimento, che dava coerenza e continuità ai rapporti che si stabilivano fra le diverse
entità politiche, regni,
principati, contee, città e comuni. La storia medioevale, per
Burke, è caratterizzata dai rapporti fra Impero e Chiesa, fra
potere spirituale e temporale, dal reciproco tentativo di affermare e consolidare la propria
superiorità. Né sfugge a Burke
come proprio nel conflitto fra Impero e Chiesa, che ebbe
come principale teatro di combattimento l’Italia, si inserisce
una nuova forza politica, rappresentata dalle entità politiche
minori, i regimi cittadini, in particolare le città marinare e i
comuni italiani, che, avvalendosi delle libertà e dell’autonomie
riconosciute loro dalla Chiesa e dall’Impero, si dedicarono
alle attività commerciali, pervenendo in breve ad un rilevante
grado di potenza e di civiltà. Il quadro storico dell'Europa è
completato infine dai Normanni per la costituzione del ducato dì Normandia nella Francia e dei
regni normanni a Napoli, in Sicilia e in Inghilterra.
La politica della monarchia normanna fu rivolta innanzitutto al consolidamento del potere regio
sulla base della riorganizzazione rigorosamente feudale del regno, della repressione delle pretese e
dei comportamenti di piena autonomia
dei grandi feudatari, di un controllo dell’ordine ecclesiastico
affinché la sua giurisdizione e le sue decisioni non invadessero
e non contrastassero la giustizia e la politica del regno. La
prima fase dell’insediamento della monarchia normanna in
Inghilterra fu caratterizzata dalla politica di Guglielmo di cercare un'intesa con gli Inglesi, con la
nobiltà e con l’ordine ecclesiastico, con le città, in sostanza con il “partito anglosassone”, al fine di
unire le due nazioni. Confermo alla città di
Londra la carta delle libertà che era stata concessa dai re anglosassoni. Rispettò le proprietà degli
Inglesi che non avevano
preso le armi contro di lui e per le concessioni di terre ai suoi
seguaci si avvalse dei patrimoni dei suoi nemici dichiarati,
delle terre demaniali e di quelle “ecclesiastiche” di cui poteva
disporre. Per consolidare ulteriormente il suo potere cercò di
favorire, in nome delle comuni origini, l’integrazione fra i
Normanni e i Danesi che si erano insediati nell'isola al tempo
di Canuto ed erano rimasti in rapporti di inimicizia con gli
Anglo-Sassoni.
Con questi provvedimenti Gugliemo ritenne di aver pacificato i suoi nuovi domini e di potere
allontanarsi dall'Inghilterra per un breve ritorno in Normandia. Ma il suo viaggio fu
l’occasione che consentì agli oppositori del regime normanno
di tentare una insurrezione, che Gugliemo, ritornato in Inghilterra, riuscì a domare. Fu l’inizio di
una politica di dura repressione ed oppressione della nobiltà e del popolo anglosassone, che
coinvolse anche l'ordine ecclesiastico a motivo della
decisione di deporre tutti i vescovi anglosassoni per sostituirli
con ecclesiastici normanni. Nel corso di questi provvedimenti
i capi del partito anglosassone, fra i quali Edgar Atheling,
l’ultin1o discendente dell’antica monarchia, riuscirono a rifugiarsi in Scozia e ad ottenere l'aiuto
dell'esercito del re. Questa volta l’insurrezione, per l’intervento della Scozia, per
l’aiuto della Danimarca e per la convergenza delle forze di
coloro che si erano ribellati ai Normanni in diverse regioni
dell’Inghilterra del nord, assunse le caratteristiche di una
guerra organizzata, che sconvolse l’Inghilterra per circa due
anni. In quell’occasione si manifestarono il coraggio e le capacità militari di Gugliemo, che riuscì a
distogliere i Danesi dall'alleanza con gli`Scozzesi ed a sconfiggere successivamente i
suoi avversari. Dopo questa vittoria definitiva sui suoi nemici,
sancita da una seconda solenne cerimonia di incoronazione
nella cattedrale di Wmchester, Guglielmo poté assumere quei
provvedimenti atti a dare al suo regno uno stabile e sicuro
fondamento.
La monarchia normanna basava il suo potere su un ordinamento rigidamente feudale, cioè su un
rapporto di “vassallaggio”, che promanava dal re e che, per successive concessioni, dai vassalli del
re a quelli di minore rango, si estendeva
a tutto il regno. Il feudo era finalizzato soprattutto all'organizzazione e al reclutamento dell'esercito
che faceva carico soprattutto ai grandi feudatari, i “vassalli del re”, che, secondo
Burke, erano pochi, si da avere una grande posizione ed un
grande rilievo politico agli occhi del popolo, con il risultato di
costituire una specie di diaframma fra il popolo e il monarca,
sminuendone in tal modo l’immagine e l'autorità, come gli
avvenimenti successivi avrebbero dimostrato. All’inizio
dell'impresa militare il re appariva formidabile alla testa dei
suoi numerosi vassalli, perché il giuramento feudale li obbligava a seguirlo in guerra, ed essi
adempivano a quest'obbligo
con piacere. Ma quell'esercito che incuteva tanto timore poteva dissolversi come un sogno, perché
quel “popolo” fiero ed
indisciplinato non aveva costanza e il servizio feudale era contenuto in limiti molto ristretti.
Le regole feudali riconoscevano al cavaliere che si era dedicato alla professione delle armi la facoltà
di scegliere il signore al quale prestare i suoi servizi, ma era un obbligo di
durata limitata, dopo il quale il cavaliere era libero 'di cercarsi
un altro signore, Questa libertà si basava sulla professione militare che istituiva un rapporto di
uguaglianza fra coloro che
la esercitavano. Un cavaliere era un pari del re: ambedue fondavano il loro ruolo sulle loro capacità
militari. Era perciò facile trovare un certo numero di persone sempre pronte a seguire ogni bandiera,
ma era difficile portare a termine una
iniziativa che richiedeva un’azione regolare e continua. Era
proprio questa l'intrinseca debolezza della monarchia feudale,
essendo fondata su un principio che non solamente la limitava, ma minacciava di vanificare il suo
potere e dì determinare nel regno una situazione di sostanziale anarchia, come
avrebbe sperimentato a suo spese il terzo re della monarchia
normanna, Stefano.
Particolare attenzione Guglielmo rivolse alla politica ecclesiastica sostanzialmente ispirata, secondo
Burke, alla preoccupazione che la “macchina” dell’organizzazione ecclesiastica,
che tanto lo aveva sostenuto nella conquista del potere, non
potesse essere impiegata contro dì lui. Cominciò con l'assoggettare le vastissime proprietà della
Chiesa agli obblighi previsti dalle leggi feudali a favore della Corona e del fisco. Dei
sessantamila feudi esistenti in Inghilterra circa ventottomila
appartenevano alla Chiesa inglese, liberi dagli oneri feudali di
fornire un certo numero dì armati e dal pagamento delle
tasse: con una serie di provvedimenti Guglielmo abolì quei
privilegi e pretese dalle autorità ecclesiastiche le prestazioni
previste per i feudi di cui erano titolari. Stabili che fra le sue
prerogative sovrane vi era anche quella di sovrintendere ai
rapporti fra la Chiesa d'Inghilterra e Roma: le “comunicazioni” fra la Chiesa inglese e il Papa
dovevano avvenire con la
preventiva informazione e con il consenso del re e per quanto
riguardava le nomine pontificie nella Chiesa inglese sancì il
principio che i sudditi dovevano prestare obbedienza solamente agli ecclesiastici la cui nomina
fosse stata convalidata
dall’approvazione regia.
L’esercizio del potere nella società feudale si può comprendere nelle sue caratteristiche di dominio
e di oppressione
se consideriamo con attenzione il sistema tributario del regno
normanno: la finanza pubblica, avverte Burke, esercita la sua
“influenza” ed incide su quasi tutte le attività sociali degli individui, sì che la sua organizzazione ci
consente di comprendere non solamente la dinamica e il conflitto di interessi fra
chi detiene il potere ed i suoi soggetti, ma anche la forma e i
poteri del governo in ogni tempo. Solamente se teniamo presente il sistema tributario feudale come
fu posto in atto da
Guglielmo possiamo renderci conto della particolare forma
storica che assunse a poco a poco il conflitto fra la nobiltà, la
Chiesa, il popolo delle città e la monarchia normanna e come
si arrivò all’“alleanza" fra i tre ordini che impose la concessione della Magna Carta. Il re era titolare
di un diritto d’imposizione tributaria sostanzialmente assoluto, di cui si serviva
contro i feudatari sospettati di essere suoi nemici, e che favoriva la corruzione e le malversazioni
dei funzionari che amministravano la riscossione, informata il più delle volte alla procedura della
requisizione militare. Il fisco era particolarmente
oppressivo e rapace nei confronti del “popolo”, cioè dei liberi
abitanti nelle città e nei “borghi”, che, nota Burke, sino al regno di,Enrico II vivevano in una
condizione non molto lontana dalla schiavitù.
L'unico temperamento alla politica dura ed oppressiva di
Gugliemo fu dovuto all’azione di Lanfranco, un ecclesiastico
italiano di grande cultura e di straordinaria pietà, arcivescovo
di Canterbury, che come consigliere del re riuscì a far valere
con indipendenza e libertà di giudizio una politica di moderazione nelle più importanti questioni di
governo. Così gli inglesi, rileva Burke, dovettero alla virtù di uno straniero e all'influenza che ebbe
sul re, quel poco dì libertà di cui potettero godere.
Anche la monarchia normanna, come già l'anglosassone,
non riuscì a “sottrarsi” ai gravi conflitti che seguirono alla
successione al trono fra i pretendenti alla Corona. Alla morte
di Guglielmo, che negli ultimi anni del suo regno era stato
costretto ad intervenire in Normandia contro il primogenito
Roberto, la successione del secondogenito Guglielmo II era
stata impugnata proprio da Roberto con l’aiuto del re di Francia. Il conflitto si era risolto, con un.
accordo. fra i fratelli favorito dalla decisione di Roberto di partecipare alla prima crociata bandita
proprio in quel torno di tempo da Urbano II e
che aveva suscitato un generale entusiasmo ed universale
partecipazione al messaggio di liberazione dei luoghi sacri per
la tradizione cristiana.
Alla morte dj Guglielmo II la successione al trono fu occasione di profondi contrasti (premessa di
futuri conflitti) fra
la nobiltà, la Chiesa favorevole a Roberto (anche se assente) e
il terzogenito del Conquistatore, Enrico. Ma proprio questo
contrasto, secondo Burke, apre un primo sostanziale spazio di
libertà per il “popolo delle città e dei borghi”. Enrico per
vincere la resistenza della nobiltà e della Chiesa, sollecito il
consenso del “popolo" e richiese il suo “aiuto”, sulla base
della promessa di un governo più mite di quello duro e tirannico del padre e del fratello e di un
programma che avrebbe
restituito alla Chiesa il godimento delle sue immunità, al popolo le sue libertà, ai nobili i loro
privilegi ed abolito la legislazione sulle foreste e l’odiosa distinzione “politica” fra inglese e
normanno. La conferma e la concessione d’ulteriori
privilegi alla città di Londra e di una “carta” che riguardava
tutti i suoi sudditi con cui si sancivano le promesse di libertà
rappresentano per Burke l’inizio di una prassi che avrebbe
avuto il suo pieno riscontro con la concessione della Magna
Carta.
Enrico cercò innanzitutto di stabilizzare l'autorità e il potere della monarchia. Trasferitosi nei suoi
domini francesi riuscì a sconfiggere l’esercito di Roberto, che, ritornato dalla Palestina, aveva
manifestato l’intenzione di riproporre le sue
pretese al trono. Pacificata la Normandia con la “reclusione”
di Roberto che durò sino alla sua morte, indirizzo la sua attività di governo a ridurre i grossi abusi
presenti nell’amministrazione civile; a umiliare i grandi baroni; a contenere lo spirito ambizioso del
clero per restituire alla monarchia quel potere di direzione della politica del regno che le veniva
disconosciuto o notevolmente limitato dai grandi feudatari e dai
dignitari della Chiesa. Il re non adempì gli obblighi sanciti
dalla “carta” che aveva concesso; le foreste, possesso della
Corona sottratto ad ogni disciplina delle leggi e ad ogni controllo della giustizia, furono mantenute,
incrementate ed “amministrate” con maggior rigore di prima. Le tasse furono aumentate e
distribuite ad arbitrio del sovrano: un atto di vera
e propria tirannia, che se aveva oppresso la nazione, commenta Burke, non l’aveva offesa, perché i
grandi erano tenuti
nella dovuta soggezione e la giustizia era amministrata con regolarità.
Il contrasto fra il re e la Chiesa, il più ostinato e pericoloso di tutti quelli che Enrico aveva dovuto
affrontare in quegli anni, si riferiva alla questione delle investiture che contrapponeva l’impero al
Papato e che interessava tutti i regni d'Europa. Burke nell’analisi delle origini storiche dell’autorità
vescovile (necessaria a suo giudizio per intendere i motivi della
questione) si dichiara sostanzialmente favorevole alla tesi imperiale, nel senso che ritiene giusto ed
opportuno che fra i vescovi e il re sussistano dei “legami” che consentano a quest’ultimo di
sovrintendere alle questioni di carattere temporale e
politico, affinché la Chiesa inglese non abbia un rapporto di
diretta ed assoluta dipendenza dal Papa.
Peraltro Burke riconosce che la condanna del concilio di
Roma (1099) dell’investitura laica del vescovo non fu “impopolare”, ebbe un largo consenso perche
denunciò i gravissimi
abusi cui si prestava l’investitura laica, abusi che si verificarono in Inghilterra (anche durante il
regno di Enrico) in numerose sedi vescovili, mantenute a lungo vacanti per volere
del re per essere poi conferite con grande scandalo al miglior
offerente. Nonostante le vivacissime rimostranze della Chiesa
Enrico mantenne le prerogative della Corona. Il suo più fiero
oppositore fu Anselmo d’Aosta, arcivescovo dì Canterbury
« a man of Lmblameable life and of learning for his time >>, che si rifiutò di consacrare vescovi gli
ecclesiastici che erano stati
precedentemente investiti della loro sede dal re e fu pertanto
costretto a lasciare l’Inghilterra. Alla fine si arrivò ad un’intesa
fra il re e il Papa, nel senso che i vescovi nell’atto della loro
nomina dovevano prestare “omaggio e fedeltà' al sovrano che
rinunciava al diritto di investitura.
Alla morte di Enrico, l’assemblea del clero e della nobiltà,
avendo constatato che il re era morto lontano dal regno e che
la figlia Matilde era anch’essa lontana, elesse al trono d’Inghilterra Stefano, nipote per parte di
madre di Guglielmo il conquistatore. Anche Stefano, per consolidare le ragioni della sua
successione,fu costretto a seguire la politica del suo predecessore ed a confermare i privilegi già
concessi da Enrico, rinnovando la solenne rinuncia alle foreste. Ma i privilegi confermati alla
nobiltà finirono per legittimare la moltiplicazione dei
castelli che trasformò i grandi feudi in tante signorie locali
sottratte alle leggi ed alla giustizia del regno, le une contro le
altre armate, ma quasi tutte impegnate a rapinare quanti viaggiavano per le strade di cui avevano il
controllo. Il tentativo
di Stefano di porre fine a queste situazione d'anarchia e di rapine “legalizzate” fu l'inizio di una
lunga e sanguinosa guerra
civile, provocata dall'intervento del partito favorevole alla successione al trono di Matilde sostenuta
dal re dì Scozia, che
dopo alterne vicende, si concluse con il trattato di Vallingford con il quale si stabiliva, fra l’altro, di
riconoscere come erede al trono Enrico, nipote di Enrico I, nella cui persona si
riunivano la discendenza dei re normanni e quella dei re anglosassoni.
Alla morte di Stefano (1154) Enrico II successe al trono
per la prima volta dopo Edoardo il Confessore in modo pacifico senza alcuna contestazione:
essendo discendente sia di
Guglielmo il conquistatore che degli antichi re inglesi ed essendo stato adottato da Stefano e
riconosciuto dai baroni,
possedeva in effetti tutti i titoli per regnare. E poiché si era
ormai consolidata la prassi che, il re in occasione della sua incoronazione concedesse una carta delle
libertà, anche Enrico
II deliberò un analogo “provvedimento”, ma, nota Burke,
nella forma e nella sostanza differente dalle prime “concessioni”: non era un documento dettagliato
in cui si precisavano
i diritti dei sudditi, nobili, ecclesiastici e popolo, ma una semplice dichiarazione di carattere
generale, quindi un “dono”
del re, non un impegno sancito in modo solenne. Fu un “segnale” della ferma volontà politica di
Enrico II di garantire
alla monarchia una piena autonomia ed indipendenza, in particolare nei confronti dell’ordine
ecclesiastico: occorreva riportare la giurisdizione ecclesiastica nei suoi giusti limiti sulla
base del principio che la giustizia laica, per tutte le questioni
di carattere “temporale”, doveva considerarsi sopraordinata a
quella ecclesiastica. L’ex cancelliere del regno Tommaso Becket, che su indicazione regia era stato
eletto e consacrato arcivescovo di Canterbury avrebbe dovuto favorire il proposito
di riforma del re. Sennonché Becket, ordinato sacerdote ed
eletto vescovo, non solamente ispirò la sua condotta ad un rigido impegno religioso ma si manifestò
anche strenuo difensore delle immunità ecclesiastiche e della piena indipendenza
dell’ordine ecclesiastico.
Burke tiene a precisare che la valutazione storica dell’intera vicenda deve tener conto innanzitutto
del fatto che l’autorità, l’autonomia e l’indipendenza rivendicate dalla Chiesa
nei confronti del potere del re, si erano affermate ed erano
state riconosciute nel corso di un lungo processo storico, che
caratterizza la formazione della nazione inglese, delle sue leggi
ed istituzioni. Non possiamo valutare quegli avvenimenti con
le nostre convinzioni che si sono formate quasi sei secoli
dopo: dobbiamo invece tener presenti le ragioni storiche che
consentirono alla Chiesa di far valere le sue pretese, senza dimenticare che la grandissima autorità
della Chiesa era di carattere spirituale e culturale, un potere fondato sulla convinzione e
sull'opinione.
L’occasione che radicalizzò i rapporti fra il re e Becket
fu data da un conflitto di carattere giurisdizionale, determinato dal rifiuto dell'arcivescovo di
sottoporre al giudizio del
tribunale del re un sacerdote che era stato già giudicato e
condannato da un tribunale ecclesiastico. Per risolvere la
questione che proponeva il principio della piena sovranità
della monarchia nei confronti della Chiesa per quanto riguardava l’ordine temporale, fu convocato a
Clarendon un
grande Consiglio di tutti gli ordini del regno, nel quale,
nota Burke, i vescovi e gli abati ebbero una vasta rappresentanza ed una parte di rilievo. Gli
ecclesiastici non si opposero né formularono alcuna riserva alla legge con cui si limitava la loro
giurisdizione anzi sembrarono favorirla. A
Clarendon si decise che tutte le cause di carattere penale e
civile dovevano essere giudicate dai tribunali del re; qualora
l'imputato fosse stato un ecclesiastico la giurisdizione sarebbe stata definita dalla corte suprema del
re, che avrebbe
nominato un giudice per assistere al processo se fosse stato
assegnato ad un tribunale ecclesiastico; nessun magistrato o
ufficiale del re poteva essere scomunicato senza il consenso
del re; nessun ecclesiastico poteva lasciare il regno senza
dare piena garanzia che non avrebbe fatto nulla che fosse di
pregiudizio per il re o per la nazione.
Le costituzioni di Clarendon, considerate da Burke « famose per essere state il primo freno legale al
potere del clero
in Inghilterra >>, non ottennero l’approvazione del papa Alessandro III, che le considerò contrarie
al diritto canonico; Becket, che le aveva accettate con grande riluttanza, si pentì
della sua acquiescenza e decise di opporsi con il massimo
zelo. Fu l'inizio di un conflitto con il re durato sette anni, con
alterne vicende e che divise profondamente l’Inghilterra e
coinvolse il re di Francia l'Impero e il Papato: l’episodio più
drammatico fu indubbiamente l’assassinio di Beoket, commesso nella cattedrale da quattro cavalieri
della corte del re.
L'orrore per il barbaro assassinio suscitò un generale odio
nei confronti del re: con estrema difficoltà Enrico II riuscì a
"districarsi" dalle gravissime responsabilità che gli furono addebitate e che lo mantennero in una
sorta di “lazzaretto" politico per circa due anni, finché non venne riammesso nella
società dei monarchi europei, dopo aver “espiato” le sue
colpe e soprattutto dopo aver rinunciato alle “costituzioni" di
Clarendon. Secondo Burke, Becker può essere giustificato
ed anche lodato per la sua difesa dei diritti e delle immunità ecclesiastiche che garantivano
l’autonomia e l’indipendenza della Chiesa: lo storico però deve rilevare che le sue
pretese erano sostanzialmente eversive di uno stabile ordinamento politico e che per le sue
“stravaganti" convinzioni
(l’“esorbitante” potere della Chiesa e del Papato), per il suo
spirito inflessibile - che le sue virtù rendevano sempre più
pericoloso - la sua morte risultò di vantaggio per la composizione del conflitto. Ma essa fu
certamente << sacrilega e detestabile ».
Dopo il drammatico episodio dì Becker la politica di Enrico II fu indirizzata verso iniziative miranti
a ristabilire rapporti di concorde intesa con la Chiesa. La conquista del1’Irlanda, che agli inizi del
regno era stata già “approvata” da una
bolla di Adriano IV servì a ristabilire i contatti con Roma.
Dopo l'esito vittorioso dell’impresa irlandese, dopo la conclusione anch’essa vittoriosa della guerra
civile suscitata da suoi
figli (la monarchia non era ancora riusciva a sottrarsi alla rovinosa anarchia insita nell'ordinamento
feudale) e la riconquista
della Normandia, Enrico II cercò di rafforzare l'autorità reale
e contenere il potere dei grandi feudatari mediante l’istituzione di giudici itineranti ed il
rafforzamento della giurisdizione
degli sceriffi; concesse inoltre l'uso delle armi al popolo che
era raro severamente vietato dopo la conquista normanna.
Questo provvedimento rese possibile, secondo Burke, la
formazione di una milizia ai diretti ordini del re, reclutata
sulla base di un rapporto di dipendenza “politica” e non più
feudale, al fine di poter controbilanciare le forze militari che
facevano capo ai grandi feudatari. Per contenere il potere dell’aristocrazia e riportarlo nell’ambito
delle leggi del regno Enrico II si avvalse questa volta dell'appoggio della Chiesa:
aveva appreso a sue spese che non conveniva combattere contro due avversari, ma che doveva
allearsi con quello che aveva
maggior peso nelle convinzioni e nelle opinioni e la cui autorità era sancita da una lunga tradizione.
Nonostante questi “saggi” provvedimenti, che sembravano garantire al regno un periodo di
tranquillità, di nuovo le
ambizioni e le gelosie dei figli del re furono all’origine di divisioni e di cospirazioni che afflissero
Enrico II nei suoi ultimi
anni di regno. La situazione si aggravò con la successione di
Riccardo I, la cui passione guerriera lo aveva portato per
molti anni fuori della patria, quale comandante di un esercito
con il quale aveva partecipato alla terza crociata, che continuava a costituire un evento centrale
nella vita politica europea. La lunga assenza del nuovo re determinò un “affievolimento” del potere
monarchico, che indusse l'aristocrazia e la
Chiesa a cercare di assumere un ruolo nel governo dell'isola,
che si sarebbe manifestato durante il successivo regno di Giovanni senza terra.
Il regno di Giovanni è, secondo Burke, uno dei periodi
più interessanti della storia d’Inghilterra, perché la società politica inglese riuscì a fissare i principi
costituzionali per comporre i conflitti e i contrastanti interessi fra monarchia, aristocrazia, Chiesa e
popolo, per determinare le prerogative sovrane e per garantire le essenziali libertà degli Inglesi.
Tutte le "rivoluzioni" che nel corso di seicento anni sembrarono essere determinate da motivi
occasionali, arbitrari, o dallo “spirito" di conquista, dalla volontà di dominio, dall’ambizione
del potere, erano state in effetti l'espressione di un vero e
proprio processo storico ed avevano contribuito a formare
una società politica che riuscì ad attuare la “grande rivoluzione in favore della libertà”.
In occasione della morte di Riccardo I, nonostante il re
avesse indicato come erede al trono suo fratello Giovanni, si
rir1novarono le questioni e i contrasti relativi ai criteri da seguire nella designazione del successore:
in particolare si trattava di decidere se la designazione da parte degli ordini del
regno implicasse una vera e propria elezione. A favore di
Giovanni si erano dichiarati Uberto, arcivescovo di Canterbury, e Glaville, il supremo giudice del
regno, praticamente
l'ordine ecclesiastico e la magistratura del regno. Sosteneva
Giovanni un’altra forza politica, il popolo delle città che aveva
“approfittato” dello “spazio politico” che si era aperto per i
periodi di “vacanza” del potere monarchico e per i contrasti
e le lotte fra i feudatari per crescere economicamente, acquisire una certa autonomia
amministrativa, e far valere la sua
presenza politica.
La nobiltà che si era vista sopravanzata dalla Chiesa, dalla
magistratura e dal popolo non aveva assunto alcuna iniziativa,
né alcuna decisione; non le rimaneva altro da fare che concorrere alla nomina di Giovanni, che
conosceva ed odiava. Ma la
nobiltà, se non era in grado di escludere Giovanni dalla successione al trono, era però tanto forte da
obbligarlo a promettere in modo solenne che avrebbe riconfermato gli antichi diritti e privilegi che
essa proclamava di aver sempre avuto, anche se (nota con ironia Burke) non li aveva mai
pienamente
goduti e non ne aveva inteso il valore. Secondo Burke, Giovanni accettò una “sovranità”
sostanzialmente “dimezzata”
proprio da coloro che gliela concedevano, nella sostanza egli
“si sottomise ai tempi”.
La politica del re fu dettata unicamente dal suo carattere
incline alla tirannia, alla dissolutezza, alla crudeltà, che lo rendeva incapace di perseguire un
organico disegno politico che
avesse di mira l’autorità e la stabilità della monarchia. Nei
suoi interventi militari in Normandia non si rese conto del disegno politico del suo “vero” nemico, il
re di Francia Filippo
Augusto, che mirava a privare i grandi feudatari del suo regno
dei loro domini e quindi ad estrometterlo proprio dalla Normandia. Accettò in un primo momento le
proposte di pace di
Filippo rompendo l'alleanza con l`Imperatore e con il Conte
delle Fiandre che garantiva i suoi possessi francesi, consentendo cosi a suo nipote Arturo, subornato
dal re di Francia,
di tentare la conquista di parte dei suoi domini. Trasferitosi in
Francia riuscì a sconfiggere i suoi nemici, ma non seppe trarre
frutto dalla sua vittoria: si lasciò trascinare dal suo carattere
feroce e vendicativo, facendo assassinare suo nipote, che era
suo prigioniero.
Il fatto suscitò l’indignazione generale; Filippo colse l'occasione per intimare a Giovanni, in qualità
di vassallo del regno di Francia di presentarsi alla Corte dei Pari a Parigi, per
aver fatto uccidere un vassallo del regno: al rifiuto del re inglese si mosse con un grosso esercito
alla volta della Normandia. Giovanni assistette inerte alla conquista del ducato dal
quale la sua famiglia aveva tratto le sue origini e la sua potenza; lasciò che Rouen, la città a lui
favorevole, fosse presa
d’assedio senza portarle alcun aiuto. I baroni, che lo avevano
seguito nella sua spedizione militare, sdegnati dalla sua ignavia abbandonarono l’esercito regio e
ritornarono in Inghilterra. Giovanni approfittò dell'occasione per imporre ai baroni la cessione di un
settimo dei loro beni mobili come pena
per l'abbandono del suo esercito e per pretendere un'identica
imposizione sulla proprietà ecclesiastica, senza preoccuparsi
di darne alcuna giustificazione.
Questi provvedimenti e le violenze perpetrare contro i
privati per soddisfare i suoi vizi finirono per determinare un
diffuso sentimento di disprezzo, di rancore e di odio nei confronti di Giovanni, che si manifestò in
occasione del conflitto
con la Chiesa. L'elezione del nuovo arcivescovo di Canterbury
avvenuta all’insaputa del re e con una procedura irregolare
per favorire l’elezione,del vice priore dell’abbazia di S. Agostino, determinò la reazione di
Giovanni che impose una
nuova elezione nella persona da lui designata; La questione
naturalmente fu deferita al giudizio del Papa, Innocenzo III.
Fu l’inizio dell’intervento di Roma e della Chiesa inglese che
avrebbe determinato la serie degli eventi politici che si conclusero con la concessione della Magna
Carta.
Innocenzo III, che mirava a cogliere ogni occasione per
consolidare ed ampliare la giurisdizione papale, giudicò irregolari sia la prima che la seconda
elezione ed in virtù della sua plerzzludo potestatzk ordinò che si ripetessero le elezioni, indicando
come candidato il suo amico cardinale Stefano Langton, che fu il deus ex macchina della
concessione della Magna
Carta. Il rifiuto di Giovanni di accettare il giudizio del Papa
provocò prima l'interdetto contro il regno inglese e poi, persistendo la resistenza del re, la
scomunica che scioglieva i
sudditi dal vincolo di fedeltà ed invitava il re di Francia a
prendere possesso della corona “vacante”. I provvedimenti
papali e la minaccia dell’intervento diretto sul territorio inglese da parte del re dì Francia, che
disponeva di grandi forze,
costrinsero Giovanni ad accettare la mediazione dei legati del
Papa ed a subire l’estrema umiliazione di fare omaggio della
corona d'Inghilterra agli stessi legati per poterla ricevere “purificata”, quale concessione del Papa.
Nessuno, commenta Burke, protestò per l’atto di “soggezione” del re che colpiva in fondo tutta la
nazione; il contrasto dei partiti era tale che tutti erano d’accordo non solo nel
rendere omaggio alla sede romana, ma anche nell'adempiere
al formale riconoscimento del rapporto di vassallaggio con la
Chiesa di Roma. Gli amici del re perché speravano che in tal
modo potesse riconquistare il potere e i suoi nemici che vedevano la sua umiliazione con piacere,
perché ritenevano che
avrebbe finito per condizionare il suo potere a loro favore; il
clero che vedeva aumentati il suo prestigio e la sua influenza.
L'assoluzione dalla scomunica pose, inaspettatamente, Giovanni di fronte all’obbligo di rispettare
alcuni principi di
condotta politica che limitavano il suo potere sovrano, che
pensava di potere “riavere” integro. Ed a ricordargli quei limiti era l'arcivescovo di Canterbury,
proprio quando a nome
del Papa lo assolveva dalla scomunica. Gli ricordò non solamente i doveri religiosi ma anche quelli
di sovrano di non
pretendere alcun tributo senza l'approvazione del gran consiglio e di non punire alcun individuo se
non dopo un giudizio
delle corti di giustizia; in due principi, osserva Burke, era sintetizzata l'intera Magna Carta.
Il re doveva imparare a sue spese che il'aver fatto atto
d'ossequio alla suprema autorità spirituale e pubblica ammenda dei suoi errori non serviva a
garantirgli il vecchio potere, libero da ogni vincolo e da ogni controllo. Quando si accinse ad
intraprendere la guerra contro Filippo II incontrò la
decisa resistenza di parte della nobiltà che si rifiutò di seguirlo, né poté ricorrere ai vecchi mezzi
repressivi nei loro
confronti perché ne venne “trattenuto" dall’arcivescovo che
gli ricordò la promessa fatta di rispettare le leggi e lo ammonì
che qualora avesse disposto confische ed arresti senza l’espletamento dei giudizi previsti sarebbe di
nuovo incorso nella
scomunica.
L’arcivescovo non si limitò a frenare il re, assunse un’iniziativa ben più importante, quella di
spiegare ai baroni il valore e il significato legale e costituzionale della loro resistenza
ed in qual modo l’aspirazione di vedere garantite le loro libertà e i loro privilegi potesse ottenere un
riconoscimento
nel l’ambito dell’ordinamento del regno. In occasione di un sinodo che si teneva nella chiesa di S.
Paolo a Londra, Langton
incontrò privatamente alcuni dei maggiori baroni ai quali,
dopo aver ricordato e descritta, la miserevole situazione del
regno ed averne indicate le cause, commento la- carta dei diritti e dei privilegi, concessa da Enrico
I, precisando che le rimostranze alte dovevano essere presentate dall’intero ordine
della nobiltà al fine di ottenere una permanente garanzia
delle loro libertà. Occorreva pertanto che i presenti alla riunione si facessero promotori di un'intesa,
una specie di “confederazione", con gli altri baroni per realizzare quell'unità di
intenti, necessaria per il riconoscimento dei loro diritti. I presenti accolsero con entusiasmo le
indicazioni e le esortazioni
dell’arcivescovo: potevano richiamarsi ad un precedente autorevole e conferire così alle loro
rimostranze una piena legalità. Il re si rese ben presto conto che gli incontri fra i baroni
erano finalizzati ad un “complotto” contro la sua autorità. Nel
timore che si realizzasse un’intesa fra i due ordini, che gli
avrebbe precluso qualsiasi possibilità di resistenza, ritenne opportuno ricorrere di nuovo all’aiuto
del Papa, riconoscendo
ancora una volta la sua giurisdizione. Ma, contrariamente alle
sue attese, l’intervento del Papa ottenne l'effetto opposto: invece di dividere, unì i due ordini, la
nobiltà e gli ecclesiastici:
Langton oppose un’efficace resistenza passiva al nuovo intervento del Papa, protestando
pubblicamente contro l'atto di
sottomissione del re, formalizzato con la “cessione” della Corona inglese al Pontefice. I baroni
invece mantennero un
atteggiamento passivo nei confronti del re, probabilmente
perché turbati dall’intervento del Papa e perche il loro proponimento politico non era ancora
pienamente maturato.
Approfittando dell’atteggiamento remissivo dei suoi
vassalli, Giovanni tentò ancora una volta di riacquistare la
sua autorità: organizzò un esercito per riprendere la guerra
in Francia e cercare di ottenere una vittoria decisiva. Agli
inizi sembrava che l’impresa dovesse essere coronata da
successo, ma nella battaglia di Bovines gli eserciti di Giovanni e dell’Imperatore furono duramente
sconfitti dai
Francesi. Non c’era altro da fare per il re d'Inghilterra che
chiedere, tramite il legato del Papa, un lungo armistizio e
ritornare nel suo regno. Ma questa volta i baroni approfittando dell'assenza del re, avevano portato a
termine le loro
intese, la loro “confederazione”, avevano maturato il proposito politico di una ferma azione
comune. Dopo l’arrivo del
re a Londra una delegazione della nobiltà, a nome dell’intero
ordine, gli presentò una petizione molto “ossequiosa" nella
forma, ma “dura” nella sostanza, nella quale si dichiaravano le
loro libertà e si chiedeva che esse fossero riconosciute e garantite dall’autorità del re.
Giovanni cercò di eludere la richiesta precisando che
aveva bisogno di tempo per valutarla, in realtà per cercare i
"mezzi" che gli consentissero di rifiutarla. Assunse dapprima
il solenne impegno di partecipare alla crociata poi pretese un
nuovo giuramento di fedeltà da parte del popolo, infine richiese di nuovo aiuto al Papa. Forte di
questi “puntelli” della
sua autorità oppose un deciso rifiuto alla richiesta dei baroni
quando fu rinnovata, « che egli non avrebbe mai garantito tali
libertà che lo avrebbero fatto uno schiavo di se stesso >>.
Questa volta i baroni ricorsero alle armi; grazie alle loro intese
raccolsero in breve un esercito e ben consapevoli che nessuna
iniziativa che riguardava tutto il popolo poteva essere presa se
non con l'avallo della religione, nominarono il loro comandante << Maresciallo dell'esercito di Dio
e della santa Chiesa >>,
per sancire l’intesa fra nobiltà, Chiesa e popolo. Londra, la
città il cui favore era ormai decisivo nelle contese civili, dichiarò il suo pieno sostegno all’azione
dell’aristocrazia nei
confronti del re.
Giovanni si trovò così completamente isolato, di fatto prigioniero nella Torre di Londra una volta
roccaforte del suo
potere, senza la possibilità di ricevere alcun aiuto dai suoi ex alleati. Non gli rimase che accettare le
richieste dei baroni; il
15 giugno del 1215 firmò i due documenti in cui erano precisate in distinti articoli le richieste dei
baroni e del popolo, la
Magna Carta e la Carta delle foreste, con le quali furono delimitate, per la prima volta, le
prerogative della monarchia,
prima ritenute senza alcun limite, e furono poste le basi delle
libertà inglesi: << il re Giovanni... firmò quei due memorabili
documenti che per la prima volta disarmarono la Corona delle
sue illimitate prerogative, e posero il fondamento della libertà
inglese >>. Burke ricorda che le due Carte furono redatte
per quanto riguarda il loro preambolo con la formula delle
donazioni disposte a favore dei monasteri, « per il bene dell’anima del re e per quelle dei suoi
successori», quasi a voler
sottolineare il contributo determinante dato dalla cultura ecclesiastica alla prima dichiarazione delle
libertà inglesi.
Per garantire l'osservanza delle due Carte i baroni ottennero inoltre che venisse riconosciuto un
consiglio formato da
venticinque baroni, scelti dall'ordine nobiliare senza alcun intervento da parte del re, con il compito
di fungere da tribunale per giudicare tutte le violazioni degli articoli delle due
Carte. Quest’ultima concessione aveva dì fatto “detronizzato”
il re: Giovanni si vide privato della sua stessa autorità “regale”, Tentò di nuovo di riacquistare le sue
prerogative sovrane, questa volta con una “riconquista” dell’Inghilterra, per
sconfiggere definitivamente la nobiltà e sottomettere l’ordine
ecclesiastico. Si rivolse inizialmente al Papa, ma i baroni, sostenuti dall’Arcivescovo, non furono
intimoriti dai provvedimenti di condanna emanati da Roma; risolse allora di reclutare un esercito
nelle Fiandre e in Germania, fidando nello
spirito di avventura della nobiltà cadetta di quelle nazioni, e
riuscì a formare due armate che avrebbero dovuto invadere
l’Inghilterra dal nord e dal sud.
I baroni rimasti privi del consiglio politico dell’Arcivescovo, che aveva dovuto abbandonare
l'Inghilterra a motivo dell’interdetto, nella loro “rude” imprevidenza non si erano
resi conto delle macchinazioni del re: quando ebbero notizia
dell’imminenza dell’invasione, ricorsero per aiuto al re .di
Francia ed accettarono come loro re suo figlio Luigi. L'intervento del re di Francia muto
radicalmente la situazione: gli
eserciti di Giovanni, senza disciplina e disorganizzati non ressero il confronto con le forze inglesi
sostenute dai francesi e
furono rapidamente sbaragliati. Luigi poté entrare a Londra e
ricevere l’omaggio di tutti gli ordini. Né valsero le nuove condanne del Papa a fiaccare la resistenza
inglese e ad indurre il
re di Francia a desistere dal suo intervento; l’Arcivescovo, che
era stato reintegrato nella sua sede di Canterbury, rimase fedele alla sua politica di sostegno dei
baroni e delle libertà inglesi e di fatto vanificò l’interdetto papale continuando nell'esercizio del
culto divino. Il re abbandonato da tutti, distrutto nel suo prestigio, affaticato dalle continue fughe
per sfuggire ai suoi nemici, morì in quello stesso anno dopo diciotto anni di regno, o piuttosto di
lotta per conservare il regno, << il più turbolento e il più calamitoso sia per il re che per
il popolo di quelli che sono ricordati nella storia inglese ».
Secondo Burke le due Carte devono essere valutate storicamente al fine di interpretarne il contenuto
secondo le esigenze e lo stato della società inglese, e quindi secondo le consuetudini e le leggi del
tempo: occorre osservare a tal proposito che le istanze di libertà si precisano riferimento ai diritti
“positivi" che le interpretano e le garantiscono in quel
contesto storico. In questa prospettiva ha un particolare rilievo, secondo Burke, la Carta delle
foreste, la meno famosa,
perché essa rispecchia una realtà sociale che ci consente di intendere i “diritti di libertà” che furono
garantiti alle categorie
sociali minori, che formavano la maggioranza del popolo,
contro i soprusi e le vessazioni del potere regio e dei signori
feudali. Le foreste si estendevano su vastissimi territori che appartenevano al demanio reale ed
erano amministrare secondo
leggi particolari completamente distinte da quelle che facevano capo alla giurisdizione ecclesiastica
ed alla “common law". Esse risalivano all’insediamento delle popolazioni del
nord in Inghilterra per le quali la caccia rappresentava una
delle primarie fonti di alimentazione e che con i Normanni
divenne una delle attività preferite, una vera e propria passione dei re e dell'alta aristocrazia. Agli
inizi del 1200 si contavano sessantotto foreste reali alcune di vastissima estensione: esse non erano
incluse in alcuna ripartizione giuridico amministrativa, nel loro ambito non avevano vigore né la
legislazione ecclesiastica né la common law e le relative giurisdizioni. Per tal motivo le leggi delle
foreste, che prevedevano
pene severissime, legittimavano una giurisdizione penale arbitraria e sottratta ad ogni forma di
controllo. “L’ordinamento”
delle foreste consentiva una delle forme più dure di oppressione nei confronti delle classi più umili,
che erano soggette,
quando rientravano nella loro giurisdizione, ad ogni forma di
vessazione: la minima infrazione di queste “leggi” 'era considerata reato di alto tradimento nei
confronti del re, il che
comportava pene molto crudeli, senza quelle garanzie di giudizio che erano previste dalla legge
ecclesiastica e dalla “common law”.
Questo tipo di “governo” delle foreste aveva effetti del
tutto negativi anche dal punto di vista economico-sociale, nel
senso che era la causa prima della “desolazione” che affliggeva vastissime zone di territorio, in
quanto incideva in modo
gravissimo su ogni forma di attività economica del popolo, col
rendere estremamente difficili le comunicazioni e i commerci,
bloccando in tal modo ogni tentativo di sviluppo e progresso
economico. Si aggiunga inoltre che l'uso invalso da parte del
demanio reale e dei grandi feudatari di aggregare altre terre
alle foreste, aveva dì fatto consentito la spoliazione dei proprietari confinanti, che non potevano
contare su alcun rimedio giuridico contro tali provvedimenti. La Carta delle foreste, proprio perché
era finalizzata all’abolizione di molte foreste, a vietare la pratica del loro incremento abusivo, a
mitigare
e ad “accertare” le pene, rappresentava per la società inglese
del tempo una fondamentale garanzia di libertà civile, premessa dì quella politica.
Per quanto riguarda la Magna Carta possiamo parlare di
una prima garanzia di libertà politica, ma con alcune essenziali precisazioni. Il documento deve
essere ir1terpretato sulla
base della common law, quale ordinamento che si formò in
Inghilterra mediante la “fusione” delle consuetudini anglosassoni con le norme e gli istituti del
feudalesimo introdotto in
Inghilterra dai Normanni enon si può sostenere, osserva Burke, come vorrebbero invece i nostri
storici e i nostri giuristi,
che sia un “rinnovo” di leggi sassoni o di leggi di S. Edoardo.
Il fine della Magna Carta è il temperamento del sistema feudale quale fu instaurato in Inghilterra dai
Normanni. Né
si rinviene in quel documento alcuna disposizione che possa
essere interpretata con riferimento alla proprietà intesa come
fondamentale e originario diritto dell’individuo e ai privilegi,
considerati come diritti di libertà che appartengono originariamente all'individuo; proprietà e
privilegi derivano dalla concessione del re per loro e per i loro eredi che è l’unica fonte
di legittimazione dei diritti e dei privilegi.
Fatta salva questa premessa si rendeva meno gravosa una
serie d'obblighi cui era tenuto il possessore dei feudi nei confronti del re: furono così ridotte le
altissime prestazioni in denaro che l’erede del feudo doveva versare all’amministrazione
reale in occasione della immissione nel possesso del feudo, a
titolo di riconoscimento della dipendenza feudale dal sovrano
ma che in effetti si riduceva ad un vero e proprio riscatto dell'intera proprietà. Furono anche
eliminati gli oneri che gravavano sui matrimoni dei feudatari di cui il re si serviva per imporli o per
impedirli al fine di prevenire un ignobile mercato
delle persone degli eredi.
Se queste norme attenuarono la dipendenza feudale dell’aristocrazia dalla Corona, quelle che
riguardarono l'amministrazione della giustizia ebbero una più vasta portata perché
garantirono dall’uso arbitrario del potere la generalità del popolo. Le ammende da pagare per la
definizione dei giudizi
non erano più lasciate alla discrezionalità del giudice, che,
come funzionario del re, fissava spesso un ammontare che
equivaleva di fatto alla confisca del patrimonio del condannato a beneficio del demanio reale, ma
doveva essere commisurato al reato e alla condizione sociale del condannato. Furono istituiti
tribunali “fissi”, Common pleas, per le vertenze
civili, distinti e sottratti alla giustizia “itinerante" del re, fonte
di gravissimi inconvenienti ed abusi: si introdusse in tal modo
il principio che la giustizia dovesse essere amministrata da un
corpo di giudici costituito per legge e sottratto alla diretta influenza del re: << Ma anche questa
(disposizione) può essere
considerata come una grande rivoluzione. Fu costituito un
tribunale, una “creatura" della sola legge, ir1dipendente da un
potere personale, e questa separazione dell'autorità del Re
dalla sua persona fu un fatto di vaste conseguenze nella promozione delle idee di Libertà e nel
confermare la sacralità e la
maestà della legge >>. Si stabili infine la norma che nessuno
poteva essere condannato se non in base ad un giudizio dei
suoi pari: questo per Burke è << il grande articolo che cementa
tutte le parti dell’edificio della libertà ».
Con il penultimo articolo ogni feudatario fu tenuto ad attuare nel suo feudo le norme sancite dalla
Carta, che furono in
tal modo estese all’intera nazione inglese. I “privilegi” richiesti e
concessi con la Magna Carta ebbero l’effetto “rivoluzionario” di
incidere sulla rigida e chiusa struttura feudale e di rendere possibili rapporti di intesa e di
collaborazione fra l’aristocrazia e gli
altri due ordini, aprendo spazi di autonomia e libertà al popolo.
I grandi aristocratici facevano stabilmente parte del governo
della nazione inglese, consapevoli ormai della necessità di agire
come ordine e di mantenersi uniti Fine di garantire l’osservanza dei “privilegi” sanciti nella Magna
Carta. Con l'ultimo articolo veniva istituito un consiglio di venticinque baroni, scelti
dai propri pari senza alcun intervento del re, che avrebbe dovuto giudicare di tutte le infrazioni
commesse contro le norme
sancite dalla Carta: le sue decisioni dovevano considerarsi, per
esplicita dichiarazione del re, immediatamente esecutive. Il potere del re riconosceva cosi un limite
di carattere legislativo ed
istituzionale, che avrebbe costituito il presupposto del sistema
costituzionale inglese.
Nel regno di Giovanni i contrasti, i conflitti fra monarchia, aristocrazia, Chiesa e popolo che
avevano caratterizzato
la monarchia normanna ma che risalivano per molti aspetti a
quella anglosassone, trovano alla fine una loro storica conclusione nella << grande rivoluzione in
favore della libertà >> che consente di considerare la storia inglese in una precisa prospettiva.
Possiamo così comprendere il processo di formazione storica della società e dello Stato inglesi,
quali le forze, e
le istituzioni che agirono in quel processo e le ragioni specifiche per cui la dinamica dei conflitti
politici fra monarchia,
aristocrazia, Chiesa e popolo ebbe come risultato istituzionale
la Magna Carta. La continua “lotta" della Chiesa per il riconoscimento delle sue “libertà” fu la
premessa perché il popolo
potesse ottenere le proprie “libertà”, che furono sostenute
dalla Chiesa in quanto finivano per _consolidare quelle di cui
essa già godeva. La mente politica della resistenza a Giovanni,
dell'intesa fra Chiesa,.aristocrazia e popolo, non poteva essere
che il cardinale Langton, che si era reso conto che la libertà
della Chiesa poteva essere garantita dalle indebite ingerenze
del potere reale solamente se avesse fatto parte delle libertà
degli altri due ordini, la nobiltà e il popolo, rappresentato
dalle città e dalle altre comunità minori. Con la Magna Carta
le forze politiche della società inglese entrano in un rapporto
di reciproca connessione ed interdipendenza e danno vita a
un “sistema politico", a un ordine costituzionale, con cui il
diritto comincia a regolare e disciplinare le prerogative sovrane
del potere del monarca.
CAPITOLO SESTO
LE ORIGINI DEL PENSIERO POLITICO DI BURKE
Il pensiero politico di Burke ha tre iniziali punti di riferimento: problema dei rapporti fra religione
e società, Vindication, quello dei rapporti fra passioni e società, Enquzŕy, e
quello dei rapporti fra storia e società, Abrzldgment, con riferimento alla filosofia illuministica di
Bolingbroke e di Hume.
La Vindication intende dimostrare che il rapporto posto
da Bolingbroke fra religione naturale e religione artificiale con
le sue relative conseguenze vale anche per il successivo rapporto, società naturale - società
artificiale, intendendosi per
quest'ultìn1a la società “storica", politicamente organizzata,
così come aveva precisato Bolingbroke . La tesi, come si
visto, è svolta sul piano di un argomentare che è continuamente animato da un'ironia discreta, quasi
nascosta, ma sottile, che sottintende una meditata maturazione dei problemi
che vengono trattati, e che si compiace di riferirsi ai concetti,
ai principi, alle tesi sostenute nelle opere di Bolingbroke, per
coglierne la sostanziale contraddittorietà. Bisogna riconoscere
che nella sua critica Burke ha buon gioco, che l'ex ministro
della regina Anna, come è stato rilevato, troppe volte porta
nei suoi scritti filosofici l’animosità e l’“abito” dell’uomo politico che svolge tesi ed usa argomenti
a seconda degli interessi del momento, senza darsi eccessiva preoccupazione di
organizzare in una concezione armonica e coerente le tesi e gli
argomenti via via sostenuti. Perciò, a volte, il discorso che
Burke svolge nella Vindication si avvale di affermazioni brillanti ma un po' paradossali e sotto un
certo punto di vista in
parte scontate, dato che lo scrittore irlandese in tutto il breve
saggio mantiene costante la sua punta polemica nei confronti
del pensiero di Bolingbroke.
In altri termini non è una critica che individua e svolge
nuovi principi o nuove posizioni di pensiero politico, quanto
una critica che si muove all'interno delle argomentazioni dell'avversario, che usa il suo stesso
metodo, nel senso che
continua il suo ragionamento e lo porta alle sue ultime conseguenze, che non possono non
esprimersi, a volte, se non sul
piano del paradosso. L’importanza della Vindication per
quanto riguarda le origini del pensiero politico di Burke, risiede nella sua decisa presa di posizione
nei confronti del
pensiero politico di Bolingbroke, strettamente connesso con i
principi e i valori della filosofia illuministica: tale proposito ci
consente di individuare, al di sotto del discorso critico, alcune
convinzioni profonde che costituiscono, in sostanza, il punto
di partenza per la successiva speculazione politica burkiana.
Occorre rilevare, al fine di evidenziare il vero e profondo
significato della polemica burkiana, che la Vindication non si
riferisce solamente a Bolingbroke: certo i riferimenti testuali,
soprattutto la prefazione alla seconda edizione nella quale,
come si è accennato, l’autore dichiara esplicitamente il suo intento onde dissipare fra l’altro i dubbi
che erano sorti sulla
paternità del saggio, sono quanto mai precisi. Bolingbroke,
infatti, non era il solo che avesse teorizzato, in una prospettiva illuministica, la società politica come
società “artificiale”.
Bolingbroke si avvale del termine “artificiale” per precisare
che le leggi e le istituzioni che consentono l’unione di una
moltitudine di individui su un vasto territorio sono “inventate” dagli uomini, sono i “mezzi", gli
“strumenti” fatti dagli
uomini che si sono educati alla razionalità per il tramite dell’esperienza, si che le leggi politiche, in
quanto artificiali, non
hanno alcun fondamento in valori e principi meta empirici. La
società “artificiale” è, in definitiva, l’espressione dell’amor di
se, che ispira tutte le azioni dell'individuo, che si manifesta
inizialmente nella ricerca del proprio interesse, e che acquista
consapevolezza di se stesso allorché si rende conto della coincidenza con l’interesse pubblico: la
conclusione è che l’amor
di sé ha la sua completa esplicazione e la sua chiara espressione “razionale" solamente nell’ambito
della società “artificiale”.
Non mancano nei frammenti filosofici di Bolingbroke riferimenti ad una teoria della società
“artificiale. Ma chi in
quegli anni propose una compiuta, organica e coerente giustificazione dal punto di vista filosofico
della società politica
come società “artificiale” è indubbiamente Hume, amico ed
estimatore di Bolingbroke e per tanti aspetti compartecipe
degli orientamenti culturali del visconte. Non è qui il caso
di dare una compiuta esposizione del pensiero di Hume sull'argomento che è, come è noto, uno dei
più interessanti e più
importanti del suo pensiero politico: basterà richiamare per i
nostri fini alcuni concetti, alcune argomentazioni che possano}
mettere in evidenza certe consonanze e a volte alcune identità
di posizione fra Bolingbroke e Hume.
Nel volume terzo del suo Trattato della natura umana e
più precisamente nella parte seconda, Hume esamina il concetto di giustizia e l’indagine prende le
mosse proprio dal
quesito se la giustizia sia una virtù “naturale” o “artificiale”,
“Justice, whether a natural or artificial virtue”, per affermare e dimostrare che: << we must allow,
that the sense of
justice and injustice is not derived from nature, but arises artificial, tho necessarily from educations
and human conventions >>. Sempre nella seconda parte, soprattutto nella sezione sesta, Hume si
preoccupa di chiarire il significato di
questa sua affermazione, ribadendo in termini ancora più precisi il suo concetto. Dopo aver
ricordato che la stabilità dei
possessi, la possibilità di trasferirli mediante il consenso e il
rispetto delle promesse costituiscono le tre fondamentali leggi
di natura sulle quali si costituisce la società politica e si garantisce la pace e la sicurezza; che la
società è l’unico mezzo per
realizzare il benessere, cioè la felicità degli uomini, e che questo benessere è il reale fondamento
delle società; che se le
leggi di natura hanno imposto una disciplina alle passioni degli uomini, queste stesse leggi sono i
mezzi più elaborati e più
idonei per soddisfare le passioni, Hume termina le sue considerazioni precisando l'essenza
meramente “artificiale" della
società: << La natura ha inoltre affidato questo compito interamente alla condotta degli uomini, e
non ha posto nella mente
alcun particolare originale principio per determinarci ad un
complesso di azioni, verso le quali sono sufficienti a guidarci
gli altri principi del nostro umore e della nostra costituzione.
E per convincerci più compiutamente di questa verità, possiamo formulare nuovi argomenti per
provare che quelle
leggi, quantunque necessarie, sono completamente artificiali e
un’invenzione umana; conseguentemente la giustizia è una
virtù artificiale e non naturale ».
In Bolingbroke e in Hume si ritrovano altre coincidenze;
ad esempio anche in Bolingbroke la società politica ha come
sua giustificazione primaria il fatto che solamente in essa è
possibile operare una scelta fra i bisogni presenti e quelli futuri, anticipare le necessità future e
raffrontarle con quelle
presenti: una tesi che, come è noto, ha particolare rilievo nel
pensiero politico di Hume. Altri temi comuni si riferiscono
alla società “naturale” fondata sull'istinto sessuale e alla società “artificiale” fondata sulla ragione
educata dall’esperienza; alla benevolenza, alla giustizia intese come virtù sociali, e quindi
“artificiali”; al ruolo fondamentale dell'amor di
sé nella formazione della società, all'educazione ed al costume
per quanto riguarda l’istituzionalizzazione dei comportamenti
sociali degli individui; ed infine al comune impegno (filosoficamente di gran lunga più maturo e più
consapevole in
Hume) di respingere qualsiasi connessione fra la politica e
prir1cipi o valori trascendenti che dovessero giustificarsi o sul
piano metafisico o su quello della religione.
Per questi motivi la critica mossa a Bolingbroke nella Vindication si riferisce anche alle identiche
tesi, sostenute con ben
altro rigore filosofico, di Hume. E molto improbabile che Burke, avendo maturato la decisione di
dedicarsi alla carriera
letteraria ed avendo scelto, come primo, un argomento relativo ai problemi più vivi del pensiero
filosofico-politico inglese di quegli anni, non si fosse preoccupato di conoscere gli
scritti pubblicati in materia che avevano contribuito e contribuivano ad alimentare l'interesse ed a
ravvivare il dibattito su
quegli stessi problemi; né poteva sfuggirgli il fatto che Hume
apparteneva, in fondo, allo stesso ambiente culturale di Bolingbroke. Del resto non mancano nella
Vindication delle osservazioni che possono essere puntualmente riferite a passi del
Trattato, dei Saggi e dei Discorsi ci sembra difficile che possa
trattarsi di una mera coincidenza casuale.
La Vindication presuppone pertanto i problemi dell'illuminismo inglese quali erano stati svolti da
Bolingbroke e da
Hume: ir1 questa prospettiva possiamo cogliere, a quanto ci
sembra, la premessa delle considerazioni svolte da Burke in
questo suo primo scritto. A tal fine occorre soffermarsi sull'affermazione conclusiva che l’ordine
politico considerato sotto
l'aspetto con cui si organizza e si amministra il potere politico
(costituzione) e l’ordine civile e, sociale, in altri termini la società “artificiale”, non riesce a
garantire all’ir1dividuo la libertà, la sicurezza, la tranquillità, anzi è la fonte di tutti i mali
di cui soffre l'individuo. La società politica significa, in definitiva, forza, soggezione, oppressione,
sfruttamento, miseria,
dolore, ignoranza, perversione, noia, disperazione, infelicità:
la storia si riduce al racconto del “tempo” passato dagli uomini ad uccidere e sottomettere i propri
simili.
Con questa conclusione di un cosi radicale pessimismo
Burke riprende, in sostanza, un “vecchio”, ma sempre attuale,
discorso che era stato fatto agli inizi della speculazione filosofico - politica da Platone. Il filosofo
aveva avvertito che la riduzione del mondo venerato e sacro delle leggi, della giustizia,
ad un principio empirico, all’utile, ad un principio fondato
sulla “doxa” e non sull'“episteme”, porta fatalmente il mondo
politico alla disgregazione, alla lotta delle fazioni, alla lotta
fratricida fra polis e polis e ad accettare quale unico principio
di coesione quello della forza. In altri termini l'ordine e la
stabilità politiche presuppongono che sia mantenuto attuoso
l’intimo nesso che fa partecipe l'individuo di un ordine meta empirico, dell'idea del sommo bene.
Una volta che si sia negata questa realtà, la vera, e che tutto sia ricondotto all’individuo empirico, al
fare, quale si esprime e si coglie nella immediata sensazione, si sarebbe a poco a poco disgregato il
delicato sistema delle norme etico - religiose che costituiscono il
fondamento di quella autorità che,unica, legittima il potere
politico e ne costituisce il principio che dall'interno, nel solo
modo sostanziale, lo mantiene in quei limiti che garantiscono
la stabilità dell'ordine politico e l'attuazione della giustizia.
Nei confronti del pensiero politico illuministico, con particolare riferimento a Bolingbroke e ad
Hurne, Burke avverte
lo stesso problema: la sua polemica, che prende l'avvio dal
valore e dal significato da attribuire alla religione, ha un immediato esito politico, proprio perché il
giovane scrittore irlandese (aveva ventisette anni quando scrisse la Vindication)
avverte, sia pur non con quella consapevolezza delle opere
della maturità, che la società politica reclama una giustificazione che trascenda la realtà propria del
limitato sapere e fare
empirici dell'individuo, ai quali sono riportati non solamente
la verità ma soprattutto la moralità.
La pretesa di razionalizzare tutti i valori, i principi, le
istituzioni, i comportamenti degli individui nella società, di
usare come unico metro nell'esame di tutte le questioni la ragione intellettualisticamente
determinata, di ridurre la religione nelle sue manifestazioni storiche ad una superstizione
(anche la giustizia per Hume è una superstizione, ma è utile
alla società) ed infine di dare alla morale un fondamento edonistico-utilitaristico, significa per
Burke privare la società politica del suo vero centro unificatore, il principio religioso, cui
deve essere riconosciuta una sua realtà autonoma, che dà un
significato ultimo e un fondamento all’ordine della società
politica e all’agire dell’individuo. Si vanifica la religione nelle
sue manifestazioni del culto e nella sua espressione teologica
e poi si pretende che la stessa religione serva a rafforzare ed
a legittimare il vincolo costituito dalle leggi civili: evidentemente non ci si rende conto che una
volta criticato il sentimento religioso non è più possibile, almeno nell’ambito della
ragione come sopra determinata, la pari dignità etico - spirituale di ogni uomo.
Proprio perché si è risolto sul piano della critica intellettuale il vero centro dell'ordine politico
sociale, la società politica non può essere, coerentemente, che ridotta ad un meccanismo che riceve
l’impulso e continua a funzionare grazie
ad una forza il cui unico fine è di conservarsi, “riproducendosi” sempre identica a se stessa. Perciò
la storia dell’umanità
si riduce ad una storia di guerre, senza alcun altro contenuto,
si che non è possibile riscattarla nemmeno sul piano della civiltà. Perciò tutte le costituzioni, la
monarchica, l’aristocratica, la democratica, compresa la tanto celebrata costituzione
mista, non riescono a mantenere il potere o la forza politica
nei suoi limiti e quindi a garantire la libertà il benessere, la felicità degli individui, sì che l’unica
vera forma di governo è
quella dispotica.
Ne è possibile salvarsi dal dispotismo, dato che la ragione
stessa, che è l'unica legittimazione, nella concezione razionalistica della società, del potere politico,
non offre in effetti altra
scelta: si dice che gli uomini sono animati e sollecitati da passioni ingovernabili che li sospingono
gli uni contro gli altri e
che, al fine di sottrarre gli uomini a questo stato di anarchia e
di disordine, viene costituito un governo che li mantenga nella
pace e nell'ordine. Ma tè una soluzione solo apparente. Anche
il governo è costituito da uomini che continuano ad essere
sollecitati da quelle stesse passioni, né è stata ancora data
un’esauriente dimostrazione che l'uomo, per il fatto stesso di
essere stato incaricato di governare, perda la sua “natura lupesca” e diventi seguace di virtù e
giustizia. Si rinnova cosi il
vecchio quesito: “Quis custodiet ipsos custodes?”. E a questa
domanda non si può rispondere se non con la considerazione
che, date le premesse, la “custodia dei custodi" non è realizzabile, sì che l’individuo è praticamente
alla mercé del potere
che lui stesso ha contribuito a costituire.
Alla stessa conclusione dobbiamo pervenire quando esaminiamo la società dal punto di vista civile
e sociale: è indubbiamente questa la critica più interessante della Vendication
con la quale Burke coglie i limiti della concezione illuministica proposta da Bolingbroke .e da
Hume. Il sistema delle
leggi civili, invece di assolvere all’esigenza fondamentale di
garantire la stabilità dei possessi e soprattutto della proprietà,
il godimento della proprietà e la sua trasmissione pacifica fra
gli individui, il rispetto della parola data e quindi l’obbligatorietà dei contratti, sottopone la società
civile, cioè i concreti
rapporti degli individui, a quello stesso dis otismo, a quella
stessa oppressione che caratterizzano la politica. Agli individui è in sostanza sottratta
l'amministrazione dei propri interessi, affidata ad una ristretta categoria di persone, avvocati e
giudici che detengono il monopolio della conoscenza delle
leggi, che, peraltro, sono talmente complesse e “inviluppate”
in un formalismo così rigoroso ed astruso da vanificare la certezza che dovrebbe caratterizzare i
rapporti fondati sulle
stesse leggi, rendendo così illusoria la stabilità dei possessi, la
garanzia e la tutela della proprietà e l’obbligatorietà dei contratti.
Occorre inoltre considerare che il sistema delle leggi civili
che si fonda sull’istituto della proprietà sancisce, di fatto, una
gravissima limitazione della garanzia di cui dovrebbero godere tutti gli individui, quella cioè di
richiedere l’intervento
della giustizia a tutela dei propri diritti. Dato l’altissimo costo
della giustizia questa possibilità è praticamente consentita solamente ai ricchi, si che le leggi
finiscono per sancire l’innaturale distinzione fra ricchi e poveri e la stessa giustizia viene
trasformata in uno “strumento” del ricco per opprimere il
povero, al quale viene tolta di fatto ogni possibilità di difesa,
dato che la società non esiterebbe ad intervenire contro il povero che intendesse ribellarsi a questo
stato di cose.
Questa stessa situazione si manifesta in tutta la sua cruda
realtà allorché noi consideriamo la “genesi” della proprietà,
come nasce e come si “legittima". La proprietà è l’istituzione
tipica della società artificiale, che si costituisce mediante la
negazione del principio sul quale si fonda la società di “natura”, che l'individuo tanto possiede per
quanto lavora e che tutto il frutto del suo lavoro gli appartiene, per affermare invece la regola che il
prodotto del lavoro della stragrande maggioranza degli individui possa concentrarsi nelle mani di
pochi. Questa è l’essenza della proprietà: essa si fonda su una
appropriazione indebita e sullo sfruttamento e ribadisce pertanto, sul piano sociale, quella stessa
soggezione ad un potere
dispotico che caratterizza, come si è visto, la società politica.
La proprietà sancisce la schiavitù di tanti uomini, condannati ad un lavoro abbrutente nelle miniere,
nelle fabbriche,
ove si trasformano le materie prime, in condizioni che li disumanizza e li riduce al rango di bestie. Il
sistema delle leggi civili (ir1 particolare la proprietà) presuppone (ma li nasconde)
la miseria, il dolore, il sacrificio, L’avvilimento, lo sfruttamento
di tanti uomini - forse la maggioranza della società in definitiva lo stato di oppressione da parte di
pochi su molti che
rende ancora più forte e “penetrante” il dispotismo che caratterizza l’ordina mento politico.
Burke riprende i motivi di una polemica svoltasi nel pensiero politico inglese al tempo della
rivoluzione puritana, dai
Livellatori e successivamente dagli Zappatori, che sottolineava
proprio la contraddittorietà delle leggi naturali con quelle artificiali sulle quali si fonda la società :
in questo caso, a
quanto ci sembra, la sua critica e il suo intento polemico sono
rivolti anche nei confronti di Hurne, che non aveva esitato a
stigmatizzare le pretese sostenute proprio durante la rivoluzione puritana, che tendevano a
scardinare la posizione egemonica della proprietà privata nell’ordinamento politico inglese, ed a
giustificare l’opera di repressione del magistrato
nei confronti di quegli “esaltati". Oltre gli intenti puramente polemici, le osservazioni di Burke
dimostrano una sensibilità ed una “apertura” di carattere politico e sociale nei
confronti dei problemi connessi all'incipiente processo di industrializzazione inglese, anticipando
considerazioni che saranno formulate solamente dopo circa un cinquantennio. Una
sensibilità completamente assente nei teorici della società “artificiale”.
Bolingbroke e Hume secondo Burke propongono, in definitiva, una società che intende essere
l’espressione dell’esperienza empirica degli individui, basata quindi sulla “concretezza” dei fatti
convalidati da quella stessa esperienza; ma
questa società si risolve invece in una “finzione” che ignora le
situazioni reali presupposto della società e dell'ordine politico
e che in effetti legittima lo “stato di fatto", una società rigidamente aristocratica, in cui la
“cittadinanza” è riconosciuta ad
una ristretta categoria di persone. Fuori di questa società ci
sono gli “'altri”, il popolo, “populace”, i molti, animati di volta
in volta, a seconda delle situazioni, o dall’entusiasmo o dalla
superstizione, e che, benché tenuti a freno dalle leggi della
società, potrebbero alla fine prevalere se non venissero per
tempo sottomessi ad un potere assoluto.
Come si è accennato la società “artificiale” non riesce a
far valere un principio che garantisce la stabilità dell’ordine
politico, che oscilla continuamente fra due tipi di assolutismo,
o quello della moltitudine o quello del monarca: Hume in un
saggio politico del 1741, intitolato significativamente: Se il governo britannico inclini più verso la
monarchia assoluta oppure verso la repubblica sembrava aver teorizzato proprio
quella conclusione, dichiarando di scegliere fra i due mali il
minore, quello di una monarchia assoluta ir1 grado di garantire l’ordine e la pace contro la tirannide
della moltitudine:
« La cosa va perciò rimessa all’opera dello sviluppo naturale;
e la Camera dei Comuni conformemente alla sua attuale costituzione deve essere l’unico corpo
legislativo di questo governo popolare. Ma gli inconvenienti che accompagnano un
simile stato di cose si presentano a migliaia. Se la Camera dei
Comuni, in questo caso specifico, si scioglie, cosa che non è
da attendersi, dovremmo sopportare tutta la tirannia di una
nuova fazione suddivisa in nuove. E poiché un governo violento di questo genere non può durare a
lungo, alla fine, dopo
molte convulsioni e guerre civili, troveremo riposo nella monarchia assoluta, che sarebbe stato
meglio per noi aver instaurata pacificamente fin dal principio. La monarchia assoluta,
perciò, è la migliore morte, la vera eutcmaszá della costituzione
inglese ». Le conclusioni dell’esame condotto nella Whdztatzbn ci richiamano a quanto aveva'
sostenuto Hume a proposito dell’esito ultimo del sistema costituzionale inglese: la ragione
scettica non solamente dissolve le religioni storiche e le culture che ad esse si richiamano
confinandole fra le superstizioni, ma finisce per “disarticolare” anche quell’ordine politico che si
sarebbe voluto salvare in nome della libertà. Ora
proprio questa conclusione mette in forse concetto di civiltà
su cui l’illuminismo tanto insiste: quale significato hanno la
civiltà, le arti e le scienze che contribuiscono a formarla, se
alla fine viene a mancare la libertà che ne è il presupposto necessario e lo spirito animatore? E poi
ha un valore umano
questa civiltà da cui è esclusa la stragrande maggioranza degli
uomini? Riesce ad unire con ideali e valori comuni tutti gli
individui che costituiscono la società che l'ha promossa?
La risposta non può che essere negativa, proprio perché
la ragione ha scavato un abisso fra i pochi e i molti, impedendo loro qualsiasi rapporto di vera
collaborazione ed ha
tolto alla società ogni contenuto che potesse costituire un comune punto di riferimento dei pochi e
dei molti. Perciò la società artificiale si riduce, come si è detto, alla pura forza,
l’unico mezzo per mantenerla unita, e perciò la forza è il solo
“personaggio" della storia dell’umanità, che non può, registrare altro se non gli avvenimenti e gli
episodi collegati all'uso della forza, cioè le guerre. Riferita alla società “artificiale" la civiltà sembra
perdere qualsiasi consistenza e significato. D'altro canto la distinzione fra i pochi e i molti, proprio
perché si realizza nella concreta esperienza sociale come distinzione fra ricchi e poveri, finisce per
disumanizzare tutti gli
individui che appartengono alle due categorie - gli uni perché resi aridi dal tormento di una
insaziabile voglia di dominio o da una sfibrante ricerca di un piacere sempre più raffinato che alla
fine non dà più alcuna soddisfazione, gli altri
perché istupiditi o imbestialiti da una fatica che non conosce
soste. È vanificato in tal modo ogni principio e valore etico morale. Questa conclusione con la quale
Burke pronuncia la condanna definitiva della società “artificiale" ci richiama a
quanto, all’incirca due anni prima, Rousseau aveva sostenuto
nel Discorso sulla disuguaglianza, scritto che quasi certamente
il giovane scrittore irlandese conobbe e dovette tener presente
nella redazione della sua lG7’ZdZ‘CáŕiO7’l. Già in Rousseau, come
è noto, il mondo della società “artificiale" era stato radicalmente condannato, ed esaltato quello
semplice e spontaneo
della natura, proprio perché il processo di formazione dell'ordine politico, che ha come suo istituto
costitutivo quello della
proprietà, mette capo necessariamente al dispotismo che finisce per disumanizzare l’uomo e col
pervertire l'ordine dei
principi e dei valori sui quali si fonda la moralità dell'individuo. Le analogie che si riscontrano fra la
Vindication e il Discorso sulla diseguaglianza attestano che Burke si rende
conto come la contrapposizione fra società naturale e società
artificiale scaturisce per così dire all'interno della concezione
illuministica come primato della ragione fondato sul continuo
progresso delle scienze e delle arti, un primato che dissolve la
vera, naturale umanità dell'uomo per formare, mediante l’invenzione della società politica, un uomo
del tutto “artificiale”.
E questo secondo Rousseau il risultato della fondazione e del
continuo “perfezionamento” della società politica: <<In una
parola egli spiegherà come l’anima e le passioni umane alterandosi insensibilmente cangino per così
dire di natura; perché i nostri piaceri ed oggetti cambino a lungo andare di oggetto, perché svanendo
l’uomo originario a gradi, la società
non offra più, agli occhi del saggio che un'accolta di uomini
artificiali e di passioni fittizie, che sono il prodotto di tutte
queste relazioni nuove, e non hanno alcun vero fondamento
nella natura ». In questa prospettiva la cultura della ragione illuminista
pone le premesse per una lenta ma progressiva e fatale corruzione e disintegrazione della società
artificiale, divisa al suo
interno dal contrasto degli interessi, dalle diffidenze e dagli
odi di classe, fautori di disordini, di lotte e di rivoluzioni, che
si concluderanno con l’affermazione del dispotismo, << in cui
tutto si riporta - nota Rousseau - alla sola legge del più
forte e in conseguenza a nuovo stato di natura differente da
quello da cui abbiamo preso le mosse, in quanto quello è uno
stato di natura nella sua purezza, e quest’ultimo è il prodotto
di un eccesso di collusione >>. Ma il dispotismo o la monarchia assoluta, avverte Rousseau, non
risolve i problemi
della stabilità e dell'ordine politico, come riteneva Hume,
dato che la legge del più forte implica che si succedano al potere tutti quelli che, di volta in volta,
nelle continue mutevoli
situazioni proprie delle società corrotte, risultano i più forti. Le critiche della società “artificiale”
che per certi aspetti
ricollegano la Vindication al Discorso sulla diseguaglianza non
corrispondono ad un uguale intento e non si collocano in una
comune prospettiva. Burke critica la ragione illuministica
nella sua pretesa di assolutizzarsi cioè di riportare nel suo ambito tutto il complesso mondo delle
passioni e dei sentimenti
che finisce per proporre un tipo di convivenza umana del
tutto convenzionale, “artificiale”, che non trova un principio
di reale aggregazione e coesione, e si pone nel contempo il
problema di individuare il vero rapporto che deve sussistere
fra le passioni, i sentimenti e la ragione: di qui la sua polemica
nei confronti della ragione astratta e di conseguenza della società artificiale.
Rousseau invece vede nella ragione e soprattutto nel
modo con cui viene concepita dai teorici del primato delle
scienze e delle arti, della civiltà dei lumi, da Voltaire, Diderot,
d’Alembert, l’espressione dell’amor proprio cioè dell’originario principio della disuguaglianza, che
distingue, diversifica,
promuove l'utile, l'interesse, che è sempre il proprio utile, il
proprio interesse, il progresso delle arti e delle scienze, il raffinamento del gusto e delle convenzioni
sociali. La ragione distrugge la moralità originaria dell'uomo, i sentimenti di
umana solidarietà, di libertà e di uguaglianza e la sostituisce
con una morale meramente convenzionale adeguata all’uomo
“artificiale", discendente diretto di questa stessa ragione:
« Quella che genera l’amor proprio è la ragione, quella che lo
fortifica è la riflessione, essa ripiega l'uomo su se stesso, essa
lo separa da tutto ciò che lo molesta, e lo affligge. Quello che
lo isola è la filosofia: per via di essa egli dice in segreto, al vedere un uomo che soffre: Muori se
vuoi, io sono al sicuro >>. Al primato della ragione filosofica dei “philosophes" Rousseau
contrappone quello della volontà, della moralità, che rigenerano la società “artificiale”
ricostituendola ex
uovo per restituire all’uomo la sua originaria natura in una
comunità in cui si realizzino gli indissolubili rapporti di
umana solidarietà, di libertà, di uguaglianza. Ma per Burke
anche il primato della volontà e della moralità proposto da
Rousseau rimane, come la ragione dei “philosophes”, nell’ambito della società “artificiale”, perché
finisce per proporre una
volontà ed una moralità astratte che escludono la concreta
realtà e dinamica dei sentimenti e delle passioni umane.
La Vindication è la risoluzione critica del concetto di società artificiale e della contrapposizione
illuministica fra questa e la società naturale: si poneva pertanto per Burke il problema di individuare
il fondamento della società umana, sì da
comprendere il rapporto sussistente fra ciò che viene prima
della ragione e la ragione stessa, cioè fra i sentimenti, le passioni che forniscono i dati della
conoscenza, orientano e sollecitano la ragione affinché si traduca in attività pratica. La
società umana è il risultato dell’attività pratica, che promana
da un rapporto di “continuità” fra passioni, sentimenti, ragione, ed è perciò fatta da tutti, illetterati e
letterati, “incolti”
e “colti”, ed ha una “consistenza reale", non è un “artificio”
una “convenzione” della ragione. Questo problema è affrontato nel secondo scritto di Burke A
Philorophical Eriquiry into
the Origin of our Ideas of the Suhlime and Beautiful.
i llEr1quz`r rivela la preoccupazione di Burke di “calare” la
ragione nel mondo umano dei sentimenti e delle passioni, per
studiare il rapporto che sussiste fra il pre razionale, ciò che
viene prima della ragione e la ragione stessa, per riconoscere
il ruolo che svolge soprattutto nell’attività pratica dell’individuo ed individuare i principi che le
consentono di essere consapevole della corrispondenza della sua analisi e dei suoi giudizi alla
realtà, al concreto. Burke si richiama nel suo
saggio soprattutto a Locke, ed anche a Hume, come si è visto, per precisare giudizi e considerazioni
sul concetto di gusto. La gnoseologia lockiana, con la sua proposta della conoscenza fondata sulle
sensazioni, lasciava sostanzialmente impregiudicato il problema di una natura che rifletteva in sé
l'ordine della creazione e quindi del riferimento alla ragione e
alla volontà divine come garanzie di principi e valori meta empirici che costituivano il presupposto
delle norme morali. Va
ricordato a tal proposito che nel Trattato sulla tolleranza
Locke ritiene che questa non si riferisce né ai cattolici, a suo
giudizio intolleranti e decisi avversari della libertà religiosa, né
agli atei, perché negare l’esistenza di Dio significa negare il
presupposto essenziale sul quale si fonda il principio di buona
fede, regola fondamentale di ogni società politica,
L’empirismo dì Hume è certamente un’interpretazione' rigorosa e coerente del sensismo di Locke,
che risolve sul piano
gnoseologico qualsiasi nesso o riferimento ad una istanza di
carattere metafisico 'o trascendente ed in questo ambito rientra la critica delle religioni storiche, le
cui origini ne mostrano
l’essenza superstiziosa; per quanto riguarda invece il problema della religione intesa come esigenza
di principi ed
ideali meta empirici con riferimento all’esistenza della Divinità, l'unica soluzione è quella di una
sospensione di giudizio,
non possiamo né affermare né negare. Possiamo così intendere perché nell'Enqz¢iry Burke si
richiami più di una volta
a Locke a conforto della sua analisi sul rapporto ragione – sensazioni - passioni e svolga invece una
critica delle considerazioni relativiste in materia di “gusto” di Hume, insistendo
sulle connessioni dì carattere oggettivo che sussistono fra le
sensazioni, le percezioni e le “passioni” degli individui, che
sono pertanto il presupposto di un comune giudizio di verità
sulle qualità essenziali delle cose ai fini della loro valutazione
estetica. Burke con il termine “natura” intende una realtà, comprendente anche l'uomo in quanto
“organismo vivente”, che,
in virtù di un principio teologico - religioso (per essere stata
creata da Dio), ha una intrinseca razionalità, per cui può essere conosciuta dalla ragione umana, ed è
il presupposto di
quelle conoscenze di carattere scientifico che consentono di
conoscere sempre di più le leggi fisiche della natura. In questa prospettiva più di una volta Burke si
richiama alla sapienza
divina, alla Provvidenza, e non manca dì rilevare che il fine
ultimo della conoscenza è il riconoscimento proprio della sapienza divina, come suprema e vera
garanzia dell’ordine razionale del creato. La conoscenza della ragione nella prospettiva illuministica
significa conoscere sempre di più perfezionando nel contempo le conoscenze già acquisite: è una
convinzione alla
quale Burke aderisce, ma con una duplice avvertenza. La razionalità della ragione non risolve in sè
la natura: ciò significa
che la conoscenza razionale non riesce a pervenire alla ragione
ultima dei fenomeni che indaga, Ogni nuova scoperta allarga
certamente l’orizzonte del nostro sapere, ma nel contempo ci
rende sempre più consapevoli dell’estrema, complessità delle
interrelazioni che sussistono nella serie infinita della cause naturali, e ci richiama pertanto ai limiti
della ragione umana, la
cui avvertenza, per Burke, è strettamente collegata al sentimento religioso dell`infinita sapienza cli
Dio. Questo non significa dichiarare il “fallimento” della ragione, o assumere un
atteggiamento “scettico" nei suoi confronti, ma riconoscerle la
capacità di pervenire a risultati oggettivi ‘e veritieri nell’ambito
dei limiti che le sono propri. Né la ragione si dichiara paga
dei risultati che consegue ma è sempre animata e sollecitata
ad allargare il campo delle sue conoscenze dalle passioni pre razionali, lo stupore, la meraviglia, la
curiosità, che alimentano il desiderio di conoscenza. Questo si traduce nell’amore
della verità, che di nuovo rinvia a principi e valori meta empirici garanti della continuità e del
progresso dell’attività razionale. L’uomo fa parte della natura, di un “tutto” organico e vivente, ma
nello stesso tempo è totalmente altro dalla natura, è
una “coscienza originaria” che diventa consapevole di se
stessa nell’esperienza della più alta emozione che può provare, quella del sublime, alla quale è
connessa l'avvertenza
dell’esistenza-presenza di Dio, del sentimento religioso che
per Burke svela il significato di verità della nostra esperienza
ed attività. Ed è proprio quest’ultima che acquista una particolare rilevanza nei confronti della
ragione, nel senso che l’attività pratica perviene secondo Burke ad una comprensione
“reale”, concreta, della realtà e non formale, astratta come
quella della ragione “illuministica” che identifica la realtà con
la sua razionalità, mentre l’esperienza insegna, avverte Burke,
che si “ha ragione in teoria e torto in pratica".
In questa prospettiva Burke avverte l’esigenza di intendere il nesso “vitale” che intercorre fra le
passioni, i sentimenti e la ragione che consente una conoscenza non formale,
astratta della realtà, ma concreta, che stabilisca un rapporto
“vero” diretto con le cose, con la complessa ed articolata
realtà della società umana. Questa ha il suo fondamento nelle
passioni e nei sentimenti e non nella consapevolezza tutta razionale dell'utile degli individui: sia le
due società cosiddette
“naturali" perché fondate sul vincolo di sangue, la società dei
sessi - la famiglia, il gruppo parentale - sia la società generale si richiamano al sentimento estetico
per cui siamo portati
ad istituire forme di “convivenza” con le persone e le cose
belle e gradevoli, cui si connettono le altre due passioni, la
simpatia e limitazione, che stabiliscono vincoli di carattere
affettivo fondati su una reale '“partecipazione dj vita con vita"
fra tutti gli associati. L’articolazione dei rapporti della società,
che potrebbe risultare uniformemente omogenea se promossa
e sostenuta solamente dalla simpatia e dall'imitazione, è garantita dall’ambizione che sollecita il
senso della “diversità”,
del valore e del ruolo dei meriti e della capacità.
L’organizzazione politica che si esprime nel potere, come
centro di unificazione dei comandi e delle obbedienze necessari alla vita e al governo della società,
affonda le sue radici
nelle passioni degli uomini, nel senso che il potere, prima
della sua legittimazione di carattere razionale, sussiste con una
propria autonomia basata sulle passioni derivate dall’esperienza del sublime: il timore, la reverenza,
il rispetto, che sono
L’insostituibile premessa dell’efficacia dei suoi comandi. La
società generale proprio perché comprende non solamente gli
uomini, ma anche le “cose" con cui gli uomini “entrar1o in
società" per vivere insieme, compreso il territorio e l’ambiente, i luoghi della memoria che
conservano i nostri ricordi, è una totalità che continuamente si “compie", un
mondo umano che alimenta il sentimento della nostra individualità. Perciò, secondo Burke, l’ipotesi
di una completa, continua esclusione dalla società suscita nell’uomo un dolore insopportabile, anche
se non manca dì riconoscere all’individuo
il diritto al “temporaneo isola mento” per poter corrispondere
alle esigenze della “vita contemplativa”, come momento di
necessario raccoglimento per lo studio e la ricerca. .
La società generale come totalità vivente significa per Burke che le manifestazioni dell’attività,
dell’ingegno, della fantasia, dell’immaginazione, dell’arte, dei sentimenti e delle passioni degli
uomini riuniti in società sono connesse fra di loro: per studiarle meglio dobbiamo considerarle
separate l’una
dall’altra, ma nella concretezza della vita pratica sono in vitale
rapporto fra di loro. La società generale è pertanto un'unità
vivente, che ha una continuità che si prospetta nel futuro e
che si "estende" non solamente nello spazio ma anche nel
tempo. La vita della società si esprime pertanto nella storia,
anzi, per certi aspetti tende a coincidere con la storia. L’ Abridgment of English history continua in
sostanza il discorso sulla
società generale-politica, che Burke aveva svolto nella Abridgment e nell'Enquiry per rendersi
conto del processo di formazione storica di quella società con particolare riferimento
alla società inglese. I giovanili interessi per gli studi storici di Burke si erano
ulteriormente precisati ed approfonditi negli anni della preparazione e della stesura della
Vindication, naturalmente con riferimento agli scritti di Bolingbroke, alla sua concezione dei
rapporti fra politica e storia; dobbiamo ritenere inoltre che a esse seguito con particolare attenzione
il dibattito suscitato
dalla pubblicazione della History of England di Hume che rifletteva gli orientamenti politici dei
whigs e dei tories nella interpretazione della storia politico costituzionale inglese.
Questi interessi per Burke non potevano essere disgiunti dalla
considerazione del problema della storia quale era stato proposto dalle due opere più importanti
sull'argomento che
erano uscite proprio in quegli anni l’Esprit des lois di Montesquieu (1749) e l’Essai sur l'hz`stoire
généml et sur les nzoeurs
et l'esprit des nations dì Voltaire (1756).
La prima sostiene L’interdipendenza e la reciproca connessione fra lo Stato, le leggi, le istituzioni,
in sostanza la politica,
e la storia: << Per Montesquieu gli eventi politici sono il centro
del mondo storico; lo Stato è il vero anzi è l’unico soggetto
della storia universale. Lo spirito della storia coincide con lo
“spirito delle leggi” >>. La seconda invece “marginalizza” polemicamente gli avvenimenti politici,
le imprese e la politica
dei re e dei principi, e ritiene che lo scopo precipuo della
storia è quello di tracciare le linee del progresso dello spirito
umano grazie ad un’accurata selezione dei fatti più importanti
al fine di « offrire al lettore un filo direttivo e metterlo in
grado di farsi da sé un giudizio dell’estinzione, della rinascita
e dei progressi dello spirito umano e per fargli vedere il carattere dei popoli e dei loro costumi ». Di
qui l’affermazione del
primato della ragione che finisce per diventare il “deus ex
macchina della storia”, una specie di letto di Prouste per il
fatto storico: giustamente Cassirer osserva: « così questo
(Voltaire) applica con disinvoltura la sua misura razionale al
passato >>. Burke non poteva pertanto che far proprio
l’orientan1ento storiografico di Montesquieu che in effetti offriva i criteri metodologici per la
corretta determinazione storica degli eventi, senza correre il rischio di ignorarli o di svisarli sulla
base di una valutazione razionale sostanzialmente
astratta. Nell'Abridgment Burke definisce Montesquieu << The greatest genius, which has
enlightened this age >> che indica i criteri per interpretare il processo storico di formazione e di
successiva lenta trasformazione delle istituzioni e delle leggi feudali, fra i quali ha particolare
rilevanza il rapporto fra la società feudale - i suoi usi, costumi, le sue originarie tradizioni, la sua
“cultura” - e le sue leggi ed istituzioni. Secondo Montesquieu, bisogna rendersi conto della
“maniera di pensare dei nostri padri” nelle sue espressioni rozze, primitive e superstiziose spesso
ritenute di nessun valore storico: è invece la testimonianza di una razionalità intrinseca ai costumi,
alle esigenze, agli “stili di vita" della società di quei tempi.
Non possiamo tralasciare le fonti di parte ecclesiastica,
come ad esempio le vite dei santi, sulla base del giudizio che
sono un mero racconto di miracoli frutto di esaltare fantasie
religiose, perché sono testimonianze preziosissime degli usi e
dei costumi di quei tempi, il necessario presupposto di quelle
leggi e di quelle istituzioni di cui intendiamo comprendere i
fini. Né dobbiamo scoraggiarci, avverte Montesquieu, se le
fonti della storia medievale possono dare l’impressione di un
mare sconfinato senza riva: dobbiamo invece impegnarci in
una loro accurata lettura ed analisi, se vogliamo intendere la
storia di quei tempi: << Tutti questi scritti freddi, aridi, insipidi
e duri, bisogna leggerli, bisogna divorarli, come la leggenda
dice che Saturno divorò le pietre » .
Alla luce di queste premesse il primo criterio che esprime
l’esigenza di una corretta interpretazione storica è la raccomandazione di non valutare le istituzioni,
le leggi, le tradizioni
del passato alla stregua dei principi e delle esigenze del presente << Trasferire in secoli lontani tutti
i principi di quello nel
quale si vive - avverte Montesquieu - è tra le fonti di errori
la più feconda, A chi vuol rendere moderni i secoli antichi,
dirò ciò che i sacerdoti egiziani dissero a Solone: “© Ateniesi
voi non siete che dei fanciulli” ». Un criterio che Burke
fa proprio, come esplicitamente dichiara a proposito del giudizio sulle controversie relative alle
immunità e alla giurisdizione ecclesiastiche: << and not judge, as some have inconsiderately done,
of the affaire of those times by ideas taken from
the present manners and opinions ».
Da Montesquieu Burke deriva l’idea che la società politica, lo Stato è il risultato di un lungo
processo storico; che
nello Stato si esprime e continua a vivere il principio di identità che realizza l’intima connessione
fra tutte le parti che lo
costituiscono. Lo Stato, per richiamare la metafora montesquiviana a proposito delle leggi feudali, è
simile ad una
<< quercia antica. l’occhio ne scorge di lontano il fogliame: ci
si avvicina se ne vede il tronco ma non le radici: bisogna scavare per trovarle ». Solo la storia ci
consente di trovare le
radici e di comprendere il processo di formazione della comunità politica nella quale viviamo, come
di quelle con cui siamo
in rapporti di amicizia o di conflitto: la storia è molto di più
di una naturale curiosità, attiene in ultima analisi alla consapevolezza dei principi e dei valori della
società nella quale viviamo, dei diritti e dei doveri che abbiamo nei suoi confronti,
per partecipare consapevolmente a quel processo storico che
fa sussistere lo Stato.
Per Montesquieu la storia non è una "collezione di fatti”,
ma è una “connessione di fatti”, una serie di eventi caratterizzata da una continuità e da una
molteplicità di “collegamenti”
da costituirli in una vero e proprio “processo” storico. A questo criterio fondamentale si attiene
Burke nel suo Abridgment
si tratta di rendersi conto della genesi della società politica inglese, cioè del processo di formazione
della “nazione” e del
suo ordinamento politico e del ruolo che vi ebbe la religione
cristiana. “Spirito delle leggi" significa appunto individuare il
nesso che sussiste fra le convinzioni religiose, i costumi, le
tradizioni, le condizioni materiali ed ambientali delle “nazioni” e delle società politiche ed i loro
ordinamenti politici e
legislativi in cui si esprime la loro “personalità storica", il
“proprio” delle loro istituzioni e leggi. Lo “spirito delle leggi”
non rinvia alla ragione fondata sulla sua interna coerenza che, per essere la vera essenza dell’uomo
e del suo operare,
riporta la storia a se stessa per adeguarla ai suoi schemi razionali , ma alla ragione “maturata”
nell’esperienza e nella tradizione storiche, in grado di comprendere le complesse dinamiche
politiche e sociali che promuovono il mutamento e le
riforme degli ordinamenti politici.
L’impegno a precisare la concreta dimensione storica delle
leggi e delle istituzioni si esprime in modo chiaro nel breve
saggio introduttivo all’abridgment, An Esmy towards the History of Laws of England,
particolarmente rilevante per
quanto riguarda la definizione dei principi e dei criteri ai
quali deve corrispondere una corretta interpretazione storica
delle dinamiche della società politica, non astrattamente considerata cioè da un punto di vista
meramente teorico razionale, ma con riferimento alla sua concreta esistenza storica,
Il brevissimo saggio nasce, come sappiamo, dalla profonda insoddisfazione di Burke nei confronti
del metodo d’insegnamento del diritto seguito in Inghilterra. L’osservazione
fondamentale del Nostro si riduce alla constatazione che esso
è eccessivamente formale, astrattamente razionale e quindi assolutamente privo di senso storico. Il
“sistema” delle leggi inglesi, distaccato completamente dal processo storico nel quale
si è venuto a poco a poco costituendo, diventa incomprensibile. L’assurda pretesa, così radicata
nelle menti anguste dei
professori di diritto, dei giudici e degli avvocati, che le leggi,
e relative formalità e procedure, sono le stesse che furono poste al tempo degli Anglosassoni e della
conquista normanna,
senza che subissero l”influenza di principi o di istituti propri
di diritti stranieri, ha come unico risultato quello di mummificare il diritto, facendolo scadere al
rango di una casistica
così complessa da mortificare e spegnere qualsiasi interesse.
D’altro canto, questa sorta d’eternità che si vuol riconoscere al sistema delle leggi inglesi, mentre
pone i suoi sostenitori in gravissimi imbarazzi a causa delle continue contraddizioni in cui cadono,
consente di giustificare dal punto di vista
ideologico-politico tutte le tradizioni giuridiche, che vengono
sistematicamente interpretate solo per dimostrare la validità e
la legittimità di norme e principi che sono le espressioni di interessi politici attuali, misconoscendo
il genuino contenuto
storico delle leggi, alterando e falsificando in tal modo il loro
vero significato. Nonostante il panegirico che i nostri scrittori
di politica e di storia fanno delle leggi “costituzionali” anglosassoni non possiamo fare a meno di
considerarle per quello
che effettivamente sono e cioè un “monumento", una “visibile", chiara testimonianza che ancora
sussistono nella nostra
legislazione, esempi della nostra “antica rozzezza": << quei
scrittori non possono persuaderci che le rudimentali istituzioni di un popolo illetterato avessero già
raggiunto quella
perfezione che solamente gli sforzi uniti della ricerca, dell’esperienza, del sapere e della necessità
sono riusciti a conseguire nel corso di molte età >>. Anche in questo caso vale l’essenziale
avvertimento di Montesqieu: << Bisogna illuminare la
storia con le leggi e le leggi con la storia ».
' Il diritto, inteso proprio come sistema di leggi, alla stessa
stregua della lingua e della cultura (learning), è in definitiva il
“prodotto” di un lungo processo storico, nel quale si fondono
a poco a poco principi e istituti di diversa provenienza, alcuni
propri, originari della società nella quale si esprime quel determinato diritto, altri appartenenti a
legislazioni straniere, a
loro volta modificati, trasformati a seconda delle esigenze,
che, in diverse situazioni storiche, sono state poste dai costumi, dalla religione, dal commercio dei
popoli. Il compito
dello storico consiste nel cogliere la trama complessa ma unitaria nella quale si compongono in un
nuovo sistema concezioni e tradizioni giuridiche diverse, e nel saperne quindi individuare lo
specifico contributo alla formazione della nuova
esperienza giuridica.
Il sistema delle leggi ha in Burke un particolare significato, nel senso che rinvia alla giustizia intesa
come valore che
promuove la loro formazione e il loro coordinamento. La giustizia è l’originaria, istintiva, profonda
aspirazione dell'uomo
ad imitare Dio “in uno dei suoi più gloriosi attributi”, che si
realizza nella storia, attraverso un’esperienza di errori, di incertezze, di debolezze, di superstizioni,
di violenze che costituiscono l’unica condizione per mezzo della quale quell’aspirazione può
diventare consapevole di se stessa e riconoscersi,
ed essere riconosciuta, come il vero fondamento della società
e dell’ordine politico. Così la giustizia in Burke è anima e ragione della storia, vichianamente “idea
umana di vita", comune patrimonio del Gentleman e dello slaving Poor che
conferisce ad entrambi un'autentica, pari dignità civile e poli
tica: è appena il caso di accennare quanto questo concetto
della giustizia sia lontano da quello dì Hume, per il quale la
giustizia ritrovava il suo unico fondamento nella proprietà e
nei diritti a questa connessi, e, priva di qualsiasi valore sostanziale, si riduceva ad un insieme di
formule e di regole mediante le quali risolvere le controversie connesse con la proprietà.
Burke è fuori dell’ottica humiana della “storia naturale
della religione e della società civile". La giustizia non è un'idea nel significato illuministico,
humiano del termine, una mera “in1pressione” determinata dalla sensazione, come consapevolezza
di ciò che ci è utile, ma è un principio meta empirico, che si esprime e si fa valere in un contesto
storico caratterizzato dalla violenza, dal dominio, dall'oppressione, dall'arbitrio, e che consente di
intendere come il contrasto, la lotta fra gli interessi contrapposti si compongano in un processo
storico che per il tramite delle “rivoluzioni”, di radicali e profonde modificazioni degli usi, delle
consuetudini, perviene al riconoscimento ed all’affermazione del diritto e delle leggi. Come si è già
osservato per Burke il diritto, secondo l'espressione vichiar1a, è “un’idea umana di vita”, con la
quale l'uomo, gli uomini fanno la storia, iniziando dai tempi della
barbarie delle menti seppellite nei corpi e nei sensi a quelli
della civiltà e degli Stati propri della ragione tutta dispiegata,
In questa storia la forza, il dominio, la guerra, le oppressioni
e le sopraffazioni sono le occasioni che consentono al diritto
dì manifestarsi nei modi e nelle forme storicamente conformi
ai costumi, alle convinzioni, alla cultura della società di quel
tempo. Il sentimento della giustizia e del diritto in Burke, come
sappiamo, è intimamente connesso all'esperienza religiosa dell’uomo, dalla quale scaturisce
l'impulso e l'orientamento della sua attività pratica. Da questa premessa deriva la convinzione
di Burke che il cristianesimo deve essere riconosciuto come
un’essenziale categoria storiografica della storia medievale,
per studiare la formazione dei nuovi regni e comunità politiche costituitesi dopo la dissoluzione
dell’Impero romano e le invasioni delle genti germaniche e di quelle del nord Europa,
e quella nuova società di regni, principati, ducati, città, di popoli e di genti, che fu l'Europa
medioevale. Di qui la visione europea che Burke ha della storia inglese
che, possiamo dire, è geneticamente connessa con quella dell’Europa, cominciando dal periodo
romano, in cui la Britannia entra a far parte della comune civiltà euro mediterranea.
L’Inghilterra aveva “rinnovato” i suoi rapporti con Roma, non
più potenza mondiale, ma centro della cristianità che conservava significative testimonianze della
civiltà greco-romana un punto di riferimento costante nel processo di formazione
della società inglese -, con la missione dell’abate Agostino,
inviato da Gregorio Magno. La conversione al cristianesimo
del regno sassone è considerata da Burke la premessa di carattere etico - religioso e culturale che
inciderà profondamente
sui costumi, sulle istituzioni della società inglese e che, con la
corrispondente organizzazione ecclesiastica, costituì un fattore determinante della storia medievale
inglese. Il rapporto
con l’Europa assunse maggiore consistenza con la monarchia
normanna: questo rapporto incise profondamente sulla storia
inglese nel senso di promuovere un rinnovamento delle consuetudini, dei modi, delle leggi ed ebbe
un ruolo rilevante negli eventi politici che si conclusero con la concessione della
Magna Carta.
Il riconoscimento del cristianesimo come categoria storica
implica, per Burke, il problema del significato che assume
nell’ambito di questo riconoscimento il rapporto fra la Provvidenza e la storia. L’insediamento dei
Sassoni in Inghilterra
avvenne in un periodo della storia dell’Europa caratterizzata
dalle migrazioni delle popolazioni dell’Europa del nord e dell'est che portarono alla distruzione
dell'Impero romano d’occidente e ad uno stato di anarchia per le lotte continue e feroci, apportatrici
di morte e di miserie per ogni nazione. Nella
considerazione di questa “rivoluzione” totale che distrusse il
mondo e la civiltà antica e che “sorpassò', per l’entità catastrofica dell’evento, ogni comprensione di
carattere razionale,
lo storico Burke confessa di essere distolto dalla ricerca di
cause connesse alle vicissitudini delle grandi trasmigrazioni
dei popoli e di essere invece indotto a riconoscere “la mano
di Dio in queste immense rivoluzioni, con le quali in certi periodi, Egli manifesta la sua suprema
potenza e determina quel
grande sistema di mutamento che è forse così necessario alla
morale come si trova esserlo nel mondo naturale”.
Il richiamo alla Provvidenza intende porre in evidenza
che quel radicale mutamento di carattere catastrofico fu un
“forte sistema di mutamento”, cioè la premessa per la formazione di un nuova società politica, con
caratteri propri rispetto alla società antica greco-romana, corrispondenti per
molti aspetti ai principi e ai valori della nuova religione, il cristianesimo, che avrebbe rappresentato
un costante punto di
riferimento per le “nazioni", i regni, le altre entità politiche
costituitesi a seguito di quel mutamento. L’umanità riesce ad
“uscire” dalla notte della barbarie e della ferocia in cui è
sprofondata perché l’attività dell'uomo determinata dalle passioni, dalla voglia di rapina e dì guerra
e caratterizzata dall'incostanza, dalla mutevolezza e dall’arbitrio, perviene 'ad un risultato che non si
disperde, che tende a durare nel tempo,
perché si tramuta in istituzioni, leggi, e si esprime come potere, cioè come affermazione di un
principio di coesione di
una moltitudine di individui. Quando si studia quel periodo
dì totale disordine e di diffusa anarchia possiamo rilevare
come sono proprio le passioni e i sentimenti più forti che indussero quegli uomini barbari ed
ignoranti a stabilire vincoli
sociali e politici stabili e duraturi, a precisare ed a sancire gli
essenziali doveri e diritti dei consociati, in modo da disciplinare quella naturale libertà, che di solito
sconfinava nell'arbitrio, nella violenza, negli assassini, negli scontri e nelle guerre
continue. Il fine immediato delle invasioni barbariche fu la
rapina e il saccheggio: ma quando quelle popolazioni cominciarono ad insediarsi con la conquista e
il dominio furono in
certo qual modo “costrette” a realizzare un governo “regolare” che comprendesse dominatori e
dominati, un risultato
che esse non avevano previsto.
Nella storia gli effetti delle azioni degli uomini non si
esauriscono nel conseguimento del fine “immediato” perché
quegli effetti si connettono con quelli di tante altre azioni
spesso in radicale contrasto fra loro, per conseguire risultati
non previsti e spesso non voluti nelle intenzioni e dalle previsioni dei singoli: la storia in definitiva
è caratterizzata dal
principio della eterogenesi dei fini, cioè da un processo posto
in atto e realizzato dagli uomini e che ha un suo risultato, che
lo storico è in grado di comprendere proprio perché sa ricostruire quel processo, l’inizio, le sue
varie fasi, la pluralità dei
soggetti che vi hanno partecipato, i rapporti di interdipendenza che si sono istituiti fra di loro,
ponendo in risalto come
i fini particolari pervengano ad un fine che riguarda tutti.
A La Provvidenza, che secondo Burke appare con chiarezza
mirare al continuo “mescolarsi” del genere umano, non lascia
la mente umana senza un principio per realizzare questo fine,
che a volte è conseguito da un “istinto migratorio”, a volte da
uno spirito di conquista; in certe situazioni l'avarizia spinge
gli uomini fuori delle loro case, in altre invece essi sono sospinti da una brama di conoscenza;
quando nessuna di queste
cause può operare, la santità di alcuni luoghi (Gerusalemme,
Roma, la Mecca) induce migliaia di uomini ad intraprendere
lunghissimi viaggi: << Così una comunicazione fu aperta fra
questa remota isola e paesi dei quali essa poi assai raramente
avrebbe udito fare menzione; e così i pellegrinaggi preservarono quei rapporti nel genere umano,
che oggi sono promossi
dalle relazioni, dal commercio e dalla dotta curiosità >>.
La Provvidenza non significa che Burke cerchi dì far intervenire il soprannaturale, il miracoloso
direttamente nella
storia: proprio con riferimento alle fonti ecclesiastiche della
storia inglese, che rappresentano le uniche per il periodo trattato nell’abridgmen, oltre alle raccolte
di leggi, egli tiene a
precisare che non intende esprimere in sede storica un giudizio di merito sui numerosi miracoli che
ricorrono in quelle
cronache, si limita a notare che la convinzione della loro verità contribuì alla rapida conversione dei
Sassoni e alla diffusione del cristianesimo. Nella ricostruzione storica si tratta di
concentrare l'attenzione sulle altre cause tutte << umane e politiche che concorsero indubbiamente a
quell'evento e che in
un periodo dì tempo relativamente breve consentirono al monachesimo di diventare una sorta di
“ordine” dello Stato fra i più stimati >>.
Il compito dello storico è quello di considerare « some of the human and political ways », cioè di
individuare le "vie”, i “percorsi” che gli uomini hanno seguito per pervenire a determinati risultati.
Ciò significa che si tratta di ricostruire questo “viaggio", cioè come fu possibile “mettersi in
viaggio"
(per continuare nella metafora) e continuare a viaggiare e dal
punto di vista storico quali le “origini” dell'aggregazione
umana che iniziò il suo “cammino storico” e la continuità degli eventi che la caratterizzarono.
L'inizio e la continuità pone
il problema della formazione di una unità di intenti cioè di
come una pluralità e diversità di esigenze, di istanze, di speranze, di interessi, di convinzioni spesso
in radicale conflitto
fra di loro riescano a produrre un’azione comune e quindi a
dar vita ad un evento storico che è poi la premessa dei susseguenti che consentono, per l’appunto, di
continuare il “cammino storico”.
La continuità degli eventi storici e lo stesso evento assumono, nella ricostruzione storica di Burke, il
carattere di un
vero e proprio processo storico, nel quale vengono risolte
tutte le azioni di coloro che partecipano e soprattutto vivono
una generale comune situazione storica. Processo storico significa anche comprendere la
connessione dinamica degli
eventi e scoprire nella successione temporale la loro interdipendenza e la loro genesi storica. Sono
principi dinamici del
processo storico la necessità, le passioni, le convinzioni (comprese quelle “storte”, le superstizioni),
gli interessi e quindi i
contrasti, i conflitti, le guerre, il dominio e l’oppressione, il
sentimento della giustizia e quindi la lotta contro l'oppressione. Mediante quest'esperienza storica
gli uomini esprimono
una comunità di intenti e danno vita allo Stato, come l'istituzione che consente alla loro vita di
attuarsi nella totalità delle
sue espressioni. Ma questo “cammino” è lungo, accidentato,
richiede soste per meditare sulla strada percorsa e su quella
che si intende intraprendere, per rendersi conto che proprio
quella scelta continua la precedente. Lo Stato è il risultato di
un lungo processo storico: lo Stato costituzionale inglese è il
“prodotto" in ultima analisi di dieci secoli di storia inglese ed
europea. In occasione della Rivoluzione francese Burke rilevava che i grandi Stati europei non
potevano essere fondati
o ricostituiti in pochi anni di “passione rivoluzionaria".
Si tratta naturalmente di dar conto di come inizia questo
processo storico, che cosa lo promuove e lo “alimenta”, quali
sono gli attori e quali le pretese da far valere. In questa prospettiva si pone il problema della
continuità della storia inglese per indicare come da una serie di eventi, dalle ripetute
incursioni dei Sassoni e delle altre popolazioni nordiche, dalle
lotte continue per rendere stabili ed allargare i primi insediamenti si sia riusciti ad instaurare un
regno, quello anglosassone e poi quello normanno, che rimasero il punto di riferimento delle
vicende storiche inglesi, caratterizzate da una ricorrente anarchia di poteri, il cui esito ultimo, per
quanto riguarda il periodo storico considerato nell’abridgmen, è la
Magna Carta, con cui furono fissati principi essenziali dell’ordinamento costituzionale, che
caratterizza in modo particolare
la storia inglese.
Ha particolare rilievo in Burke il problema delle origini,
della genesi storica delle leggi, delle istituzioni e quindi dei
principi, delle regole fondamentali della vita delle comunità.
Nei costumi, negli usi, nelle consuetudini, nelle convinzioni
comunemente accettate c’è un principio di riposta razionalità
che li ispira in quanto soluzioni dei problemi elementari ed
essenziali della vita delle comunità primitive: come sappiamo,
in Burke la razionalità è anticipata dall’avvertenza emozionale passionale, dal sentimento del
sublime, dall’immaginazione.
L’origine,· pertanto, esprime il principio costitutivo della comunità, del popolo, della “nazione”,
cioè il principio “identitario”, la personalità storica del popolo, inteso come totalità
di tutti i suoi componenti, comprensiva naturalmente di tutte
le sue istituzioni e leggi. Le origini sono le “radici" di un popolo, di una società, di uno Stato, ciò
che continuamente lo
alimenta e ne fa una vivente unità storica.
Ben diversa la concezione del valore e del significato storiografico delle origini in Hume che vi
dedica nella History
poche pagine sbrigative. l’origine in Huine, coincide con la
debolissima e sfigurata “immagine” di una umanità sprofondata nel buio dell’ignoranza, dominata
dal terrore e dalle passioni più selvagge, schiava delle superstizioni più assurde, e
serve unicamente per rendersi conto del progresso compiuto
dalle arti, dalle scienze, in ultima analisi dalla ragione e dalla
civiltà. Per quanto riguarda la “costituzione” inglese è data
dai “remoti indistinti e sfigurati originali” che a mala pena
possono essere riconosciuti nelle “più perfezionate e più nobili istituzioni”. Il costante punto di
riferimento per leggere, comprendere e scrivere la storia è la “ragione illuminata", la ragione che
riconosce come suo fondamento l'esperienza empirica. Questa ragione è il “metro”, la misura di
tutti
i fatti storici. Per tal motivo la storia acquista un senso ed un
significato veramente umano solamente quando è illuminata
dai lumi della ragione. Il problema della continuità degli
eventi storici è considerato da Hume nei termini dei progressi
compiuti dalla ragione empirica, grazie all’inizio e alla diffusione delle arti e delle scienze. `
Il progresso, in Hume, è dato dalla lenta ma continua affermazione della ragione empirica contro
quanto la nega e la
condiziona, soprattutto la superstizione, alimentata dalla religione positiva, il cristianesimo: il
progresso è visto in termini
di maggiore acquisizione della razionalità empirica che automaticamente, possiamo dire
“naturalisticamente”, dispone
con la sua luce gli animi alla simpatia, alla benevolenza, al
buon gusto, alla gentilezza dei modi cioè a quel vivere civile
che è sinonimo di civiltà. Il passato serve solamente a commisurare la distanza che separa i tempi
“civili” da quelli primitivi ed a richiamare la nostra attenzione a non farsi sedurre
dalle superstizioni, sempre in agguato per insignorirsi della
nostra ragione. La storia pertanto acquista un valore ed un significato solamente nel momento in cui
“interviene" la ragione empirica, cioè le arti e le scienze: per quanto riguarda
la storia medioevale Hume ritiene che quel momento storico
deve essere collocato dopo il regno di Gugliemo il conquistatore: nel precedente periodo sassone i
popoli cristiani sprofondarono completamente nell’ignoranza e di conseguenza in
disordini di ogni sorta.
Il progresso ha così un'origine meramente intellettuale: il
contesto in cui si manifesta l’intelletto acquisisce i caratteri
della storicità. Lo stesso criterio vale per tutti gli avvenimenti
successivi che si riferiscono alla formazione e alla vita della
società civile. La storia in ultima analisi acquista un valore
“cognitivo” perché può offrire al filosofo della politica e della
morale numerosi esempi dai quali trarre principi, regole per
la vita privata e per quella pubblica, per la società civile e per
lo Stato: la storia in ultima analisi è il grande gabinetto di
sperimentazione per lo studioso della politica e del diritto. La tradizione, in Hume, si riduce alla
conservazione e
alla trasmissione dei risultati cui è pervenuta la ragione umana
nelle successive situazioni storiche, che acquistano un significato e garantiscono una continuità
storica solo per il loro
contenuto di razionalità e di civiltà. Senza questa tradizione la
storia si riduce all'inf1nita serie di eventi totalmente diversi,
determinati dalle passioni e quindi dall’arbitrio, il cui
"aspetto”, come per i secoli bui del Medioevo, appare « horrid and deformed >>. Perciò l’informe
caos di eventi che sembra caratterizzare ad una prima considerazione la storia deve
essere costantemente riferito al “natural progress of human
thought" affinché ci si concentri sugli avvenimenti e sui relativi periodi storici in cui si verificano
quelle << revolutions of mind >> che promuovono e sostengono i progressi della società
civile.
La storia, in definitiva, ha in Hume un valore strumentale,
consente la necessaria sperimentazione per individuare i principi e le regole sui quali si fonda la
società civile, la civiltà. Per
Burke invece la storia ha un valore di carattere “esistenziale',
nel senso che si riferisce a tutte le manifestazioni della vita
dell’uomo, che sono espressioni delle potenzialità del suo
animo e delle facoltà del suo intelletto. La ragione in Burke,
come sappiamo, ha un deciso esito pratico ed è perciò anticipata, ispirata ed orientata dal
sentimento più profondo quale
si esprime nell'avvertenza e nell'esperienza religiosa, che è
l'originario principio .costitutivo dell'aggregazione e coesistenza umana, il fondamento quindi della
società e della civiltà. Da un punto di vista storiografico e in particolare per la
storia medioevale, nei due autori ha un particolare rilievo il
rapporto religione-superstizione. Burke riconosce l'autonomia
e l'originarietà della religione nelle sue espressioni di culto ed
istituzionali e sa che essa quando viene vissuta e praticata può
esprimersi in forme superstiziose alimentate dalle paure, dal
risentimento, dalle attese, dalle speranze, che la ragione distingue e mantiene separate come forme
corrotte. Hume invece ritiene che la religione per essere espressione del terrore
e della paura equivale senz'altro a superstizione, ad errore,
fonte di ogni fantasia ed arbitrio, strumentalizzata, nell’esperienza storica delle società barbariche,
dall'ordine sacerdotale
per i suoi fini di potere.
Di qui la diversa valutazione storica del ruolo del cristianesimo nella formazione della società
medioevale in Burke e
in Hume: per il primo è il principio di formazione ed unificazione della società inglese ed europea,
per il secondo invece
una superstizione che sancisce l’arbitrio, l'oppressione e il dominio dell’ordine ecclesiastico, che
finisce per legittimare l'ordinamento feudale, cercando di condizionare il potere laico
rappresentato dal monarca. Ciò che risalta ad una lettura
comparativa dell’abridgmen e dei primi due volumi della History sono proprio i giudizi
radicalmente diversi sui personaggi e sugli eventi connessi con la diffusione del cristianesimo, con
l’affermarsi della Chiesa in Inghilterra e con la politica ecclesiastica della monarchia sassone e
normanna. Tre episodi ci sembrano interessanti come testimonianza dei due
diversi orientamenti storiografici del ruolo del cristianesimo e
della Chiesa nella storia medievale inglese ed europea.
Burke considera la conversione dei Sassoni al cristianesimo come la “rivoluzione” più importante
nella storia dell'Inghilterra, con cui essa “nasce” alla civiltà: << Light scarce
begins to dawn until the introduction of christianity; which,
bringing with it the use of letters, and the arts of civil life, affords at once a juster account of things
and facts, that are
more worthy of relation: not is there indeed any revolution so
remarkable in the English story », e dedica un intero capitolo all'essenziale contributo della cultura
ecclesiastica alla
diffusione dei primi “rudimenti” di una società civile fra i
Sassoni. Per Hurne la conversione fu un episodio di un certo
rilievo (mise in contatto l’Inghilterra con gli Stati dell’Europa
più civili), ma non incise in modo sostanziale sui costumi barbari dei Sassoni, ai quali viene
proposta in sostanza una nuova
superstizione, che cercava di soggiogare le coscienze ad una
passiva obbedienza al clero e al vescovo di Roma, premessa di
ogni forma di “corruzione” intellettuale e morale. In effetti
“quel nuovo sapere" (doctrine) per essere passato attraverso i
“corrotti canali di Roma” si trasformò in una “copiosa miscela
di crudeltà e di superstizione egualmente distruttiva dell’intelletto e della moralità" .
Il giudizio sulla Crociata è anch’esso sintomatico per la
diversa valutazione dei grandi eventi del Medioevo in cui il
sentimento religioso rappresentò un fattore decisivo. Per Burke la Crociata è << one of the most
extraordinary events,
which are contained in the history of mankind », che influenzò in modo determinante gli
avvenimenti politici inglesi
e quelli europei per un lungo periodo. Burke ritiene che l'idea di essa nacque dal proposito di
Urbano II di ricostituire
l’unità di intenti fra i cristiani, posta in crisi dal lungo scisma
che aveva diviso l’Europa e intaccato l’autorità del Papato.
`Era radicata e diffusa nella religiosità di quel tempo la convinzione dell’importanza del
pellegrinaggio nei luoghi della
prima predicazione cristiana, in particolare a Gerusalemme, e
di conseguenza altrettanto diffuso lo sdegno suscitato dai racconti dei pellegrini sottoposti ad ogni
forma di angheria da
parte dei Maomettani. Di qui l'entusiasmo che suscitò la predicazione di Pietro l'eremita sulla
necessità di liberare la Terra
Santa dal dominio dei Maomettani e la successiva proclamazione della Crociata al concilio di
Clermont. L’esortazione
“Dio lo vuole” si diffuse rapidamente di villaggio in villaggio,
di città in città, per tutta l’Europa. All’entusiasmo popolare
fece riscontro a livello europeo la devozione e lo spirito di cavalleria della nobiltà, All’inizio,
osserva Burke, si avventurarono nell’impresa moltitudini di persone guidate da sacerdoti
senza alcuna consistente assistenza militare, che furono in
parte massacrare e in parte disperse, si che è “difficile dire,
commenta Burke, se è da lamentare più la distruzione di
quelle moltitudini, o la frenesia che gliela portò addosso".
Ben diverso e soprattutto dal punto di vista storico, il
giudizio di Hume, per il quale il rumore delle “insignificanti
guerre ed agitazioni" inglesi era completamente sovrastato dal
tumulto delle crociate che avevano richiamato l’attenzione
dell'Europa ed “hanno sin d'allora sollecitato la curiosità del
genere umano come la più ragguardevole e la più duratura testimonianza dell’umana follia che sia
apparsa in ogni età o nazione”. Le crociate si spiegano con lo stato di totale ignoranza
e superstizione in cui versava l'Europa, con il dominio incontrastato da parte degli ecclesiastici delle
menti delle moltitudini, che non avvertendo alcun senso dell’onore o del rispetto
della legge si abbandonavano ad ogni sorta di crimini e disordini, nella convinzione che non vi
fossero altre forme di
espiazione se non quelle imposte loro dai loro pastori spirituali, fra le quali in modo particolare la
partecipazione alla
guerra per la liberazione della Terra Santa. A questa “abietta
supestizione” si aggiunse lo spirito guerriero, privo di qualsiasi addestramento e disciplina militare
che era diventato la
passione principale delle nazioni governate dalla legge feudale, e che ebbe un’influenza nefasta
soprattutto nella nobiltà
inglese.
La categoria della superstizione spiega secondo Hume
l'accanita, e per certi aspetti ossessiva, pretesa di Becket di
piegare la volontà di Enrico Il a riconoscere i privilegi che
garantivano l'autonomia e l'indipendenza della Chiesa d'Inghilterra per imporre un vero e proprio
patronato sulla monarchia che la rendeva in sostanza politicamente dipendente
dalla Chiesa e quindi in definitiva succube della “politica” seguita dal Papa, pretesa che fu
all’origine di un conflitto con il
monarca, per molti aspetti unico nella storia inglese e che si
“concluse” con il barbaro assassinio dell’Arcivescovo. La
fede, per Hume, è una convinzione talmente irrazionale
fantastica da trasformare la personalità senza che il soggetto
se ne renda conto, assoggettandone la mente ai suoi fantastici
ideali. L’ambizione, che presuppone una tenace volontà di
dominio, assume la forma della vera virtù, in quanto suprema
dedizione ai valori spirituali ed eterni.
Becker, osserva Hume, era un ecclesiastico << of the most
lofty, intrepid, and infexible spirit, who was able to cover to
the World and probably to himself, the entreprises of pride
and ambition under the disguise of sanctity, and of zeal for
the interests of religion >>. Certo un personaggio straordinario
che doveva rimanere fedele ai suoi precedenti importanti incarichi pubblici ed indirizzare pertanto
la veemenza del suo
carattere nella difesa e nel promovimento del diritto e della
giustizia, invece di farsi coinvolgere dai pregiudizi del tempo
e di sacrificare i suoi impegni privati ed i suoi rapporti pubblici ai vincoli che egli immaginava o
riteneva superiori ad
ogni civile e politica considerazione. Ed in questa convinzione
Becket era assolutamente sincero, perché in effetti egli non
faceva altro che partecipare << to the genius of that age >>, nel
quale lo spirito di superstizione era cosi prevalente che infallibilmente si impadroniva di ogni
incauto pensatore, e soprattutto di quelli che erano sollecitati nei loro pensieri dall’interesse,
dall'onore e dall'ambizione. << Tutta la misera letteratura
di quel tempo non era altro che una “decorazione” della superstizione; i balucinamenti di senso
comune di qualche santo
(o visionario) potevano a volta passare attraverso la spessa
nuvola di ignoranza o, ciò che era peggio, le illusioni dello
“snaturato” che aveva cancellata la sensazione e nascosta la
faccia della natura. La follia si era impadronita di tutte le
scuole come di tutte le chiese e i suoi devoti assumevano il
nome di filosofi, insieme con le insegne della loro dignità spirituale >>. La superstizione assumeva
così un significato epocale e finiva in tal modo per coinvolgere tutto il Medioevo,
come età storica caratterizzata dal magico, dal miracoloso,
dalle fantasie e dalle follie collettive che alimentavano le passioni più cieche, fonte di continue
violenze ed arbitri.
In Burke non vi è alcun accenno al carattere superstizioso
ed esaltato della religiosità e della personalità di Becker, come
spiegazione del conflitto fra la Chiesa ed Enrico II, ma, come
si è accennato, un preciso richiamo alle ragioni storiche di
quel conflitto, e quindi ad una considerazione delle origini
storiche della giurisdizione e delle immunità e privilegi della
Chiesa inglese, per rendersi conto dei motivi per cui la Chiesa
esercitava un così vasto potere, “al fine di non giudicare,
come alcuni hanno fatto inconsideratamente, gli affari di quel
tempo con idee ricavate dalle abitudini e dalle opinioni del
nostro tempo" ma per esprimere una serena e corretta valutazione storica dell'episodio e del
personaggio.
Per le leggi e l’ordinamento politico costituzionale dell’Impero romano la giurisdizione
ecclesiastica non poteva assumere alcun diretto ruolo politico: gli ecclesiastici potevano
far valere solamente un potere di influenza. Ma con i nuovi
regni barbarici la giurisdizione ineriva al possesso della terra,
il che consentì alla Chiesa, grazie alle sue vastissime proprietà,
di diventare uno dei tre “ordini” dello Stato e di svolgere un
vero e proprio ruolo politico: in tal modo il potere spirituale
era strettamente connesso con quello politico: << and all the
orders had their privileges, the Clery had theirs, and were no
less steady, and ambition to extend them >>. Il ruolo politico e
il potere della Chiesa non si spiegano solamente con la devozione, né ovviamente, almeno per
Burke, con la superstizione,
ma con la “necessità dei tempi", cioè con le concrete condizioni storiche della società inglese, che
“elevarono” la Chiesa
a quel potere per molti aspetti eccessivo.
Burke indica le ragioni di questa “grandezza”: la cultura
del tempo era nelle mani degli ecclesiastici e, dato che pochi
fra i laici sapevano appena leggere, solamente il clero poteva
essere impiegato nei pubblici affari; essi erano gli uomini politici, essi erano i giuristi; fra essi erano
spesso scelti i magistrati del re nelle corti signorili, qualche volta gli sceriffi delle
contee, e quasi sempre i Giustizieri del regno. << I re normanni»-continua Burke - sempre gelosi
delle proprie prerogative,
furono spesso costretti ad impiegarli. Nelle abbazie si studiava
il diritto; le abbazie erano il palladio della libertà pubblica
perché custodivano le “carte” reali delle concessioni dei privilegi ai sudditi e la maggior parte degli
atti di governo. In conclusione, essi erano necessari ai grandi per il loro sapere;
venerabili per i poveri per la loro assistenza; temuti da tutti
per il potere di scomunica; la condizione di ecclesiastico era
esaltata sopra ogni altra cosa nello Stato; e non poteva essere
altrimenti in quei tempi, mentre ciò non è possibile ai nostri
giorni >>.
La Chiesa rappresenta per Burke una delle grandi forze
storiche dell'Inghilterra medievale, il cui ruolo deve essere valutato dal punto dì vista storico, nella
prospettiva dell’intero
processo di formazione della nazione e dello Stato inglesi,
della dinamica dei principi e degli ideali e delle forze che
erano espressione delle condizioni politiche, sociali ed economiche determinate dall'ordinamento
feudale. Possiamo così
intendere il ruolo decisivo svolto dall'arcivescovo di Canterbury, Stefano Langton, nelle vicende
politiche che portarono
alla concessione della Magna Carta da parte di Giovanni
senza terra: fu in quegli eventi la guida politica e spirituale
dell’aristocrazia e del popolo, rappresentando il sentimento di
indipendenza dell’intera nazione anche nei confronti della politica di Innocenzo III.
Le forze storiche, l’aristocrazia feudale, la monarchia, la
chiesa, le città e il “popolo” debbono essere considerate come
partecipi di un unico processo torico, che istituisce fra di
esse una serie di interrelazioni, per cui entrano in una molteplicità di rapporti reciproca
interdipendenza da cui scaturiscono tensioni e conflitti: questa è la vera dinamica politico sociale
che modifica dall’interno i rapporti di potere, le istituzioni, le leggi, il sistema giudiziario e quello
tributario fiscale,
creando le condizioni per liberare le categorie sociali asservite
al lavoro della terra e delle arti minori.
Burke cerca sempre di precisare il rapporto dinamico che
sussiste fra il “sistema delle norme giuridiche e politiche”
(l'amministrazione della giustizia e il governo della società) e
le condizioni storiche in cui vivono gli uomini (le loro necessità, i loro costumi, le loro convinzioni
e credenze) per individuare le successive innovazioni e trasformazioni che, pur avvalendosi dì
modelli giuridici più colti che si richiamavano al
diritto romano ed a quello canonico, si svolsero secondo i
principi e le caratteristiche proprie di quell'antico ordinamento giuridico-politico sassone, dal quale
trasse origine il sistema di Common law, come proprio della “nazione” inglese
e delle sue libertà. Burke nel corso dell'abridgmen si
preoccupa sempre di segnalare gli interventi più significativi
dei re sul piano delle riforme legislative e giudiziarie, di richiamare l’attenzione sui motivi politicogiuridici che le avevano determinate, di precisarne l'importanza ai fini di un migliore, cioè di un più
efficiente ordinamento del regno: le
continue invasioni, le guerre con i Danesi, i conflitti fra i
grandi feudatari e fra questi e il re rappresentavano la lotta
politica per fondare una nuova entità politica cui non bastavano le armi per sussistere, come
drammaticamente confermava l'esperienza delle invasioni e delle guerre, ma che doveva essere
consolidata e garantita dalle leggi, dal diritto.
L’esigenza di ordine e di stabilità è intimamente connessa
con l’instaurazione e il riconoscimento di un’autorità e un potere politico: modifiche e innovazioni
si resero necessarie ai
costumi e alle tradizioni sassoni con l’insediamento in Inghilterra e con la scelta di un re. Con la
conversione al cristianesimo, una rivoluzione, precisa Burke, che promosse « still
more essenti al changes in their manners and government », si avvertì l'esigenza di redigere una
raccolta scritta delle leggi,
cioè dei costumi e delle consuetudini. La raccolta, ordinata da
Ethelbert, re del Kent, non fu redatta in latino, come per gli
altri regni “barbarici" ma nella lingua anglosassone: la scomparsa del latino nell'Inghilterra sassone
costrinse i monaci,
unici che sapevano scrivere, ad “adattare” i caratteri latini alla
primitiva lingua inglese, "altrimenti ben pochi avrebbero potuto ricavare vantaggio dalle cose che
intendevano ricordare”.
La “nuova lingua” sancisce così l’originarietà della “common
law" come il diritto che nasce e si esprime con il formarsi
della nuova comunità politica. L’iniziativa di Ethelbert fu seguita dai suoi successori Edric e
Lotario e ripresa da Ina, re del West Saxons “famoso per la sua sapienza e la sua pietà" e
da Offare della Mercia: la continuità dell’opera “legislativa”
dei primi re sassoni attesta che l'esigenza di garantire la “certezza” e la “pubblicità” delle norme
necessarie alla vita comunitaria era intrinseca all’esistenza e alla continuità dell'autorità
politica.
Quest’opera di certificazione delle norme sancite dal costume e dalla consuetudine ebbe la sua
espressione più importante nella raccolta delle leggi promossa e realizzata da Alfredo il grande, che,
secondo Burke, con la sua iniziativa ebbe
il merito storico di affermare il diritto, la certezza del diritto
come una ineludibile esigenza di ordine e di giustizia proprio
nel corso di una “guerra crudele, della quale non vide l’inizio
né visse da vedere la fine; egli riuscì a fare per l'ordine e la
giustizia più di quello che ogni altro principe aveva fatto in
tempo di pace”. Nel preambolo al suo “codice” Alfredo precisa che egli si è limitato a raccogliere
dalle “leggi” di Ina, di
Offa e degli altri suoi predecessori, quanto gli appariva di più
valido, omettendo ciò che gli sembrava erroneo o non adatto
ai tempi. L’opera di revisione e di “ammodernamento” di Alfredo fu continuata dai suoi successori:
“sono pochi (nota
Burke) quelli che non ci hanno lasciato una raccolta di leggi”.
Quando i Danesi riuscirono ad insediarsi stabilmente in Inghilterra, si dimostrarono non “meno
solleciti degli Inglesi a
raccogliere e a rinforzare le leggi, dimostrando così (osserva
Burke) di essere desiderosi di riparare alle ingiurie che avevano commesso nei loro confronti”.
Il codice di Canuto il grande è “il più moderato, equo e
completo di tutte le altre antiche raccolte di leggi". Non vi fu
alcuna modifica sostanziale del sistema normativo anglosassone, il re si preoccupo di abolire molte
delle antiche consuetudini inglesi che effettivamente risultavano odiose. Fra gli ultimi re
anglosassoni Edoardo il confessore promosse una raccolta delle leggi sassoni per rafforzane
l'osservanza, raccolta
che non deve essere confusa, avverte Burke, con il noto codice di S. Edoardo, tanto ricordato dagli
storici del tempo,
che fu redatto più tardi ed attribuito al re. Il “codice” divenne
la testimonianza più autorevole delle “libertà" anglosassoni
alla quale si richiamarono gli Inglesi per denunciare l’oppressiva legislazione “feudale” della
monarchia normanna. Chi consideri il complesso della “legislazione sassone” vi nota un
continuo perfezionamento dovuto soprattutto al “contributo"
dei diritti “stranieri”, il diritto canonico rappresentato dalle
costituzioni ecclesiastiche inserite nelle raccolte e il diritto romano. Il diritto sassone si rifaceva
pertanto a tre fonti: “gli antichi tradizionali costumi delle popolazioni del Nord Europa; i canoni
della chiesa: gli ecclesiastici furono i “legislatori
di fatto”, “che corressero, mitigarono ed arricchirono quelle
rozze istituzioni nordiche"; il diritto civile romano, che ebbe
però una minore rilevanza nel processo di formazione della
legislazione sassone. La conquista normanna, con l’instaurazione della nuova
monarchia, dette un notevole impulso al diritto inglese che fu
letteralmente “riempito di cultura straniera”: si trattò, secondo Burke, di un “incremento di diritto”
imposto dal potere reale, anziché di una vera e propria crescita dovuta ad un
processo di assimilazione e rinnovamento realizzatosi nell’ambito delle precedenti leggi inglesi. Le
leggi di S. Edward e quelle normanne furono considerate in netta contrapposizione fra loro,
opinione radicata nello stato di tensione e di conflitto fra. gli Anglosassoni che cercavano di servirsi
delle prime e i Normanni che imponevano le seconde. Guglielmo
second promise di governare « by St. Edward’s laws a promise extremely grateful and popular to
all parties >>, salvo poi ignorare tale promessa, ma il suo successore Enrico primo ritenne più
saggio per la stabilità delle nuove istituzioni redigere un
nuovo “corpo” di leggi, al fine di contemperare il nuovo ordinamento con il vecchio, cercando di
ridurre al minimo
l'odiosa distinzione di Inglesi e Normanni. L'autorità politica
aveva acquisito la consapevolezza dell'importanza del diritto
ai fini della reale pacificazione ed unità del regno. Di qui le
importanti riforme dell'amministrazione della giustizia attuate
durante il regno di Enrico II, per le garanzie offerte di stabili
istituzioni giudiziarie che offrivano agli Inglesi un importante
mezzo di difesa nei confronti dell’oppressione della feudalità
normanna. In conclusione, secondo Burke la conquista,
la lotta per il potere si tradussero in lotta per il diritto: « The
Norman conquest is the great era of ours Laws >>.
Per Hunie, invece, la lotta politica ha uno scarsissimo rilievo, se non un effetto negativo sul
riconoscimento del diritto
che a suo giudizio comincia ad affermarsi e il suo studio sistematico a diffondersi solamente dopo
l’accidentale scoperta
del Dzgesto avvenuta ad Amalfi intorno al 1130 : la possibilità di poter accedere alla più compiuta
espressione della
ragione giuridica e di potersi avvalere di questa “scienza” e la
sua diffusione ebbero, a suo giudizio, un vero e proprio ruolo
“demiurgico” nel promuovere il primo “incivilimento” della
barbara e rozza società anglosassone, in quanto resero possibile l’inizio di quel progresso delle arti e
delle scienze che si
sarebbe poi delineato con più chiari connotati nel quindicesimo secolo. Il “lume” dell’antica scienza
del diritto, modello
di ragione formata sulla pratica degli affari civili, cominciò a
diradare le tenebre dell’ignoranza e della superstizione per la
sua insita capacità di eliminare l’errore e di convincere le
menti. Per Hume il quadro storico nel cui ambito s’iniziò e si
diffuse lo studio del diritto sembra non avere alcun rilievo,
nessuna influenza se non quella negativa propria di una società barbara e rozza dominata dalla
superstizione che caratterizzò anche il cosiddetto “diritto” della società anglosassone. Burke
nell’abridgment non si avvale del modello di società civile proposto da Voltaire e da Hume per
giudicare circostanze, situazioni, avvenimenti, personaggi della storia medioevale inglese, perché
ritiene che questa storia debba essere
compresa e ricostruita secondo i suoi “authentic monuments”, che esprimono una determinata
condizione umana
che aveva in se stessa i principi e le “ragioni” del suo esistere
storico: ciò significa che gli uomini cercavano di risolvere i
loro problemi secondo le loro storiche necessità, convinzioni
ed esigenze, e con questo impegno ponevano le premesse e
costruivano il loro futuro. La storia dei "tempi oscuri",
dei popoli rozzi e primitivi, delle continue invasioni e insediamenti (Sassoni e Danesi), delle rapine
e dei saccheggi, delle
conquiste (Normanni), come quella degli altri popoli europei
e dell’Europa, ha in se stessa i principi che ne spiegano lo
svolgimento, indipendentemente dal confronto con la ragione
dei lumi, e che la legittimano come un periodo storico epocale. Il Medioevo è la storia della
informazione delle nazioni,
dei popoli europei e dei loro ordinamenti politici e dei loro
comuni principi religiosi e politici.
Non bisogna considerare la storia medioevale con il “sentimento" e la sensibilità culturale propria
dell’illuminista che
tutto riporta ai principi e alle categorie del suo intelletto e che
disconosce ed esclude tutto quello che non vi corrisponde, ma
bisogna comprendere quella storia nella sua interna dinamica,
cioè individuando le necessità, le esigenze, le tradizioni, le
consuetudini, la “cultura” delle popolazioni che formarono le
nuove comunità politiche a seguito delle invasioni e degli insediamenti resi possibili dalla
disarticolazione e dal “crollo”
dell’Impero romano. La dinamica della società medioevale,
secondo Burke, è promossa ed è resa “coerente” dalla religiosità e dalla fede cristiana, che
costituisce un costante punto di
orientamento, dal quale non si può prescindere se intendiamo
ricostruire il corso di quegli avvenimenti ed intenderne il vero
significato storico. Occorre rendersi conto che << a simple religious people >> è il presupposto non
solamente del prestigio
che circonda la Chiesa e della sua influenza, ma anche di
buona parte dei sentimenti e delle convinzioni della società
medioevale, che si esprime in un mondo umano che ha proprie caratteristiche religiose, culturali ed
istituzionali. Queste
hanno un’intrinseca e storica ragion d’essere, una propria legittimità che deve essere riconosciuta
dallo storico di quel periodo per non incorrere nell’errore di appiattire la prospettiva
storica sulle idee e le esigenze del presente.
Il sentimento e le convinzioni religiose non possono essere confinati nella categoria della
“superstizione" perché
esprimono esigenze ed ideali che sovrastano il potere e la regalità ed influenzano l’intero
ordinamento, mantenendo sempre viva l’esigenza di giustizia, di difesa dall’oppressione, di
libertà e di pace. L’intensa religiosità, quando si accompagna
alle responsabilità di chi deve provvedere alla continua difesa
del regno dall’assalto di nemici invasori, a volte attenua quella
stessa responsabilità sostituendovi gli impegni religiosi, ma altre volte rafforza le energie di
governo e le indirizza verso il
bene della comunità. Certo, osserva Burke, la religiosità di
Ethelwolf rinchiuse il re nella sua sfera privata, i doveri religiosi assunsero un’importanza
particolarmente rilevante:
<< era un mite e virtuoso principe, pieno di una timida pietà,
che rende del tutto inadatti a governare; e cominciò a regnare
proprio quando era richiesta la più grande capacità di governo >>. Lascio l’Inghilterra in un
momento particolarmente critico per un lungo pellegrinaggio a Roma, suscitando un generale
scontento che si tramutò al suo ritorno in una ribellione, che egli riuscì a comporre, lasciando il
governo a suo figlio e ritirandosi nel Kent per godere di una << ingloriosa
privacy >>. Edward il confessore « era stato educato in un monastero, nel quale egli apprese la
pietà, la continenza e l’umiltà, ma nulla dell’arte di governo. Egli fu semplice ed ingenuo ma di
vedute molto ristrette, senza alcune capacità
d'iniziativa >>. Ebbe il buon senso di affidare il governo in
mani capaci. Le poche cose che curò personalmente furono
tutte buone: una nuova raccolta di leggi sassoni favorevoli ai
suoi sudditi, l’adozione di un gravoso tributo e la restituzione di quanto era stato ingiustamente
prelevato. << In breve
vi è poco nella sua vita che può mettere in questione il suo titolo di santità; ma non può in alcun
modo essere riconosciuto
fra i grandi re ». Se in Ethelwolf e in Edward i valori religiosi ispirarono
un atteggiamento di sostanziale “disincanto” nei confronti
della politica, in Alfredo il grande la religione invece promosse quella costante energia che
caratterizzò la sua attività di
governo << La religione che nel padre di Alfredo (Ethelwolfl
fu così pregiudizievole agli impegni di governo, senza essere
in lui in alcun modo inferiore nello zelo e nel fervore, fu di
un più comprensivo e nobile genere; lontano da essere di pregiudizio al suo governo appare essere
stato il principio che lo sostenne in così tante fatiche e nutrì come una fonte abbondante le sue virtù
civili e militari ». La storia pertanto è una “ricostruzione partecipativa" del
periodo oggetto degli studi e della ricerca per rendersi conto
del << generale orientamento delle menti degli uomini di quel
tempo », cercando di comprendere la formazione dei loro
convincimenti, sulla base delle necessità, delle esigenze che di
volta in volta li determinarono e li ispirarono. Le passioni e i
sentimenti hanno un'intensità esistenziale che è propria di
quel determinato periodo storico: il primitivismo delle popolazioni, la ferocia, che si esprime nella
volontà di preda e di
dominio, a volte si converte nel terrore religioso per i delitti
commessi, nel pentimento e nel rifiuto ascetico del mondo,
che scaturiscono da un sentimento profondo dell’anin1o ed
esprimono il riconoscimento dell’interiore voce della coscienza. E quindi non è mera superstizione
religiosa.
Le superstizioni hanno un rilievo del tutto secondario
nella ricostruzione storica di Burke che tiene invece in considerazione le credenze e le opinioni
sancite dalle tradizioni,
dagli usi, dai costumi in quanto sapienza riposta dei popoli e
delle nazioni, cioè quella che è stata appresa nell'esperienza
storica vissuta insieme dagli uomini di una collettività, per
“fare”, cioè per organizzare una vita comune. Essi, secondo
Burke, sono intrinsecamente connessi alla storia: gli usi, i costumi, con le convinzioni e le opinioni
che sanciscono, non
possono essere studiati solamente descrivendoli e giudicandoli con il metro della ragione dei lumi,
per distinguere i
buoni dai cattivi, come fa Voltaire. Proprio perché sono una
delle principali testimonianze della storia dei popoli, debbono
essere compresi e valutati sulla base del loro processo di formazione storica, della loro concreta
determinazione storica.
Non ci sono i “moeurs” da una parte e le necessità, le
istituzioni, il potere, i re, le guerre e le battaglie dall’altra: essi
fanno parte di un unico processo storico e sono pertanto intimamente connessi. Il dato filologico,
nel senso più ampio
del termine, attiene alla concreta determinazione storica dei
personaggi, degli avvenimenti, delle situazioni, delle istituzioni e soprattutto delle opinioni e delle
convinzioni perché
attesta la loro esistenza storica con le loro specifiche caratteristiche. Di qui l’impegno dello storico a
prestare particolare
attenzione al dato filologico e a riconoscerlo nella sua intrinseca validità storica per una
ricostruzione degli avvenimenti
che sia quanto più possibile serena ed oggettiva, e che non
pretenda di servirsi delle idee, delle opinioni dei suoi tempi
per interpretare quelle dei tempi passati.
La religiosità medioevale si esprime secondo i principi, gli
ideali, il culto che si richiamano all'insegnamento della Chiesa
di Roma: Burke avverte che la storiografia illuministica (Bolingbroke, Voltaire, Hume) per tanti
aspetti continua la storiografia protestante - il riferimento in particolare è a Rapin Thoyras - che
identifica la storia medievale con il dominio
della Chiesa fondato sulle superstizioni religiose. La storia medioevale si riduce pertanto a “svelare”
i motivi politici
delle invenzioni superstiziose della Chiesa ed a dimostrare le
conseguenze funeste delle convinzioni che a quelle si richiamavano. Si consideri ad esempio la lotta
delle investiture che
è provocata dal desiderio di dominio di Gregorio VII: la sua
memoria per Voltaire << è cara e rispettabile al clero romano
odiosa agli imperatori ed a ogni buon cittadino per gli effetti
della sua ambizione inflessibile. La Chiesa". l'ha messo nel
numero dei santi. I saggi l’han messo nel numero dei pazzi >>.
Non c’è spiegazione storica a quelle guerre, se si eccettua la
considerazione che << il fanatismo dei sudditi conduce i principi alla rovina »: in effetti_ la lotta per
le investiture fu una
« guerra sanguinosa ed assurda ».
Per Burke invece il conflitto ha una sua origine e motivazione storica ben precisa: risiede nella
formazione storica dell’autorità' vescovile e dell’organizzazione ecclesiastica cosi
come fu riconosciuta dagli Imperatori romani e poi dai nuovi
regni che si formarono a seguito degli insediamenti delle popolazioni germaniche e del nord
Europa, il cui ordinamento
politico finì per conferire all’autorità vescovile una “giurisdizione feudale” che la inseriva nel
sistema delle relazioni e
delle dipendenze feudali che facevano capo al re e all’Imperatore. Si ponevano cosi le premesse del
conflitto fra il potere
politico e l’autorità religiosa per la concreta definizione del
modo con cui garantire la reciproca indipendenza e nel contempo precisare gli obblighi cui doveva
corrispondere l”autorità vescovile nei confronti del proprio sovrano. Burke considera naturalmente
la lotta delle investiture con riguardo alla
storia inglese che a suo giudizio consente di cogliere il proponimento del Papato di rendere
indipendenti i vescovi nei confronti dei duchi, dei re e dell'Imperatore, per rafforzare la
loro dipendenza da Roma, rendendo più forte e sicura l’organizzazione ecclesiastica, ed
accentuando una supremazia di
carattere spirituale che finisce per invadere anche l’ambito
proprio del potere politico. Burke critica l’interpretazione
volta ad avvalorare credenze superstiziose, ma riconosce, nel
contempo, che la condanna della Chiesa delle investiture denunciava la pratica diffusa di
subordinare l'incarico vescovile
a fini meramente temporali che si traducevano nella legittimazione della malversazione dei beni
della Chiesa e nella nomina
di persone del tutto impreparate e senza alcun prestigio di carattere spirituale. La lotta delle
investiture è quindi un momento particolarmente importante della dialettica fra l’Impero e la
Chiesa, che rappresenta per tanti aspetti il centro propulsivo e il principio
dinamico della storia medievale. Questa stessa dialettica la ritroviamo all’interno dei singoli Stati,
fra la monarchia e l’ordine ecclesiastico, in modo particolare in Inghilterra: la monarchia trae dalla
concezione ecclesiastica della regalità, come potere impegnato a garantire l’ordine, la pace, la
giustizia una legittimazione che le riconosce un’autonoma sfera di supremo
comando e di indirizzo che la pone al di sopra dì tutti gli ordini, ma nello stesso tempo subisce il
condizionamento della grandissima influenza che la Chiesa esercita nella società e che
essa fa valere in occasione della successione al trono, soprattutto quando questa è contesa fra più
pretendenti. La politica di Enrico II fu informata al principio di
<< spezzare il potere del clero, che ciascuno dei suoi predecessori, sin da Edoardo, aveva cercato di
alzare e di deprimere, prima con lo scopo di guadagnare quel potente ordine ai propri interessi e poi
per preservarsi di diventare soggetti a quella stessa autorità che proprio loro gli avevano conferito. I
vescovi avevano eletto Stefano; essi avevano deposto Stefano ed eletto Matilde; e nelle formule che
essi usarono in quelle occasioni avevano riconosciuto a se stessi il pieno diritto di eleggere i re
d'Inghilterra. Il loro contributo sia nel promuovere che nel deprimere quel principe dimostrò che
essi possedevano un potere che non poteva sussistere con la sicurezza e la dignità dello Stato >>. Il
conflitto scaturiva dall’interno dell'ordinamento politico feudale ed era caratterizzato dalla
contemporanea affermazione e negazione del potere regio e
quindi dalla necessità di trovare una soluzione di carattere
giuridico - istituzionale che potesse garantire la continuità e
l'autonomia del potere monarchico, nel rispetto dei privilegi e
quindi delle libertà, dell’aristocrazia, della Chiesa e del popolo, che cominciava a far valere le sue
esigenze. In questa prospettiva la Chiesa è una forza storica: la considerazione dei suoi
fondamentali motivi ispiratori è indispensabile per intendere la vita politica medioevale, la
consistenza culturale - istituzionale della storia di quel periodo. La storia
medioevale non può essere ricostruita con il criterio proprio
della storiografia protestante, e continuato per tanti aspetti da
quella illuministica, di “svelare” e denunciare le invenzioni
superstiziose della Chiesa per i suoi fini di dominio spirituale
e politico: in tal modo ci precludiamo la conoscenza dei termini reali con cui si svolse il processo
storico e finiamo per far valere anacronisticamente esigenze, idee, convinzioni proprie
del nostro tempo nella storia del passato. La storia rischia in
tal modo di perseguire fini di propaganda religiosa o politica,
invece di cercare di ricostruire gli avvenimenti con uno studio
attento delle fonti. La società medievale, secondo Burke, non è caratterizzata
solamente dal particolarismo proprio dell’ordinamento feudale, ma anche dall’avvertenza di essere
partecipi di una società di gran lunga più ampia, che comprende altri popoli, altre genti, altre città,
altri regni, l’Europa. Il medioevo è il periodo storico in cui si forma una nuova “entità politica”,
cioè una società di popoli, di “nazioni”, di città, di regni che riconosce comuni principi di unione
che si risolvono in due supreme autorità: la Chiesa e l’Impero. L’Europa, esposta agli
attacchi e alle invasioni degli Arabi, disgregata al suo interno
da guerre continue, sembrava condannata ad uno stato di totale anarchia: eppure al suo interno
erano operanti due principi grazie ai quali si sarebbe costituita la nuova società europea:
<<Nondimeno, nel mezzo di questo caos furono attivi
principi che ridussero le cose ad una certa forma e gradualmente espressero un sistema in cui i
principali promotori e le prime cause erano il potere del Papa e quello dell’Imperatore;
L’aumento o la diminuzione dì questi poteri furono la tendenza di quasi tutte le scelte politiche, gli
intrighi e le guerre che impegnarono e sconcertarono l’Europa in quel tempo >>. Il centro
propulsore di questo nuovo ordinamento e di questa nuova società è la Chiesa di Roma, che
rappresenta con la sua dottrina e con il suo sapere il punto di riferimento
del processo storico di formazione dei vincoli religiosi, spirituali culturali e politici dei popoli
europei. La ricostituzione e il rafforzamento della monarchia in Francia con Pipino e Carlomagno,
la vittoria di quest’ultimo sui Longobardi
in difesa della Chiesa furono la premessa per la ricostituzione
dell’Impero da parte del Papa nella persona del vincitore.
L’autorità imperiale, prima appartenuta alla Francia, poi divisa con la Germania ed a questa
definitivamente attribuita,
rappresenta l'unità, la legittimità e l’autonomia del potere
temporale nei confronti di quello spirituale: il conflitto fra
Impero e Chiesa, determinato dalla rispettiva pretesa alla propria supremazia, contrappose la 'forza
delle armi, l'Impero,
alla forza dell’influenza ecclesiastica: poteri che in quel periodo si bilanciavano. Impero e Chiesa
non furono l’espressione del “primitivismo’, dell’ignoranza, della superstizione
dei popoli europei, ma erano due forze storiche che con la
loro dialettica concorrevano alla formazione ed all’organizzazione della società europea.
La divisione e le lotte fra i partigiani dell’Impero e quelli
della Chiesa, per quanto riguarda l’Italia, ebbero come risultato la formazione di liberi ordinamenti
cittadini, come le repubbliche di Venezia, Genova, Firenze, Pisa, che conquistarono ben presto con i
loro commerci (un’attività « abbandonata e disprezzata dalla gente rozza dei governi marziali » « a
considerable degree of wealth, power, and civility >>. L’insediamento dei Danesi in Inghilterra e in
Normandia, che consentì
l'ulteriore “movimento” verso il Sud dell'Europa, con la conquista di Napoli e della Sicilia, per dar
vita ad un nuovo regno, completò nel primo secolo dopo il .mille il quadro politico europeo.
L’Europa delle città, dei comuni, delle repubbliche, dei
regni, dei ducati, dell'Impero e della Chiesa cominciava ad
esprimere un sistema politico in cui le iniziative e gli avvenimenti politici dei singoli soggetti erano
per tanti aspetti caratterizzati da mutua dipendenza o influenza. La guerra delle investiture e le
Crociate avevano creato una generale situazione
europea in cui occorreva tener in conto, per conservare il potere o per assumere con successo
un’iniziativa politica, la politica e gli interessi degli altri soggetti politici. Ciò era valido
soprattutto per l’Inghilterra: la conquista normanna fu preceduta da un’accorta preparazione
diplomatica da parte di Guglielmo per ottenere il consenso dei conti d’Anjou, di Bretagna, di
Ponthieu; << dopo di ciò - precisa ancora Burke -fu egualmente necessario conciliare alla sua
impresa le tre
grandi potenze di cui si è parlato, il cui atteggiamento
avrebbe avuto la più grande influenza sui suoi affari »: il regno di Francia, l’Impero ed infine il
Papa: un consenso praticamene da parte di tutta l’Europa che contava. La politica della monarchia
normanna fu per molti aspetti, soprattutto per quanto riguardo la politica ecclesiastica, strettamente
connessa alle situazioni politiche che si determinavano
a livello europeo. In particolare le vicende politiche inglesi
che portarono alla concessione della Magna Carta, furono influenzate a volte in modo decisivo dal
regno di Francia e dalla
Chiesa di Roma.
Con un sottinteso riferimento alla tesi montesquieviana
sulla diffusione europea del feudalesimo, Burke osserva che
un altro importante vincolo politico, per la società europea era
rappresentato dal consolidamento del sistema feudale nei regni del “continente europeo" e dalla
diffusione dei “modi' e
maniere” della disciplina e del valore militare, dello spirito
marziale, propri dell’istituzione feudale: « The feudal discipline extented itself every where, and
influenced the conduct
of the Courts, and the manners of the people, with its irregular martial spirit ». Si tratta pertanto di
rendersi conto
delle ragioni storiche delle istituzioni feudali e dell'influenza
che esercitarono non solamente sulla “condotta delle Corti”,
cioè sul modo di governare, ma anche sulle “maniere del popolo", sul comportamento e sulle
convinzioni che lo ispiravano.
Burke non partecipa della polemica voltairiana e humiana
nei confronti del feudalesimo e del suo spirito marziale, ritiene invece che la disciplina militare è
una componente necessaria e primaria nella organizzazione delle comunità
umane, e tende ad esprimere una propria etica di comportamento: in questa prospettiva si tratta di
comprendere la “generale disposizione delle menti degli uomini” soggetti a
quella disciplina. I grandi feudatari, i vassalli, i cavalieri, le
categorie che partecipavano al potere feudale, erano subordinati gli uni agli altri da un vincolo di
fedeltà e di lealtà ma i
limiti dell’obbedienza erano fissati dal vassallo e dal cavaliere,
perché nella “generale disposizione delle menti" la professione delle armi parificava tutti i soggetti
del rapporto feudale. Di qui la dialettica interna al sistema feudale che lo caratterizzò e fu' uno dei
motivi della sua trasformazione: al re,
fonte del potere feudale, si contrapponevano spesso i grandi
feudatari, che, nota Burke, pur soggetti alle << complicate leggi
di una varia e rigorosa servitù esercitavano tutte le prerogative
di un potere sovrano >> del quale erano i soli giudici.
Esempi ci sono offerti dalle vicende degli ultimi anni dei
regni di Gugliemo il conquistatore e di Enrico II, che dimostrano come l’investitura feudale
conferiva un senso di autonomia e di indipendenza e nel contempo suscitava un così
forte sentimento di fedeltà nei confronti del signore o re cui
si prestava omaggio da infrangere e sostituire i vincoli tradizionali fondati sull’autorità,paterna;
Così si spiegano, secondo
Burke, le tensioni, i conflitti sino allo scontro armato nella famiglia dei due re Guglielmo ed Enrico
II., che rappresentarono non solamente un pericolo gravissimo per la stabilità del
regno ma anche un’esperienza amarissima e tormentata per i
due re la cui vita era stata coronata da tanti successi e vittorie: avevano conseguito un potere tanto
forte ed esteso quanto
mai conseguito prima in Inghilterra. Guglielmo rischiò di essere ucciso dal figlio Roberto se, per un
caso fortuito, non
fosse stato riconosciuto proprio quando stava per essere sopraffatto; Enrico II, sistemato nella bara
nell'imminenza della
morte e lasciato ai piedi dell'altare della chiesa, morì in totale
solitudine: dopo la morte la salma, depredata e privata degli
stessi vestiti, fu abbandonata per giorni nella chiesa.
La monarchia era impegnata a “far valere” le sue prerogative per garantire la stabilità e l’efficienza
del suo governo,
e finiva per scontrarsi il più delle volte con i suoi feudatari,
che nei loro feudi amministravano a proprio piacimento la
giustizia e suscitavano spesso conflitti con i loro vicini, diventando così in più di un’occasione
arbitri della pace del regno.
Il feudalesimo fu un regime politico che oscillava, come osserva Montesquieu, fra la “norma”, cioè
l’ordine, << con una certa tendenza all’anarchia, e l'anarchia con una certa tendenza all’ordine e
all’armonia ». Secondo Burke questa
contraddizione interna all’ordina mento feudale è .i1 principio
dinamiche spiega gran parte degli avvenimenti politici di
quel periodo e del lento progressivo affermarsi sulla scena
politica delle categorie “popolari”, che sino ai tempi di Guglielmo vivevano in uno stato di
soggezione simile alla servitù.
La contraddizione deve essere compresa nel suo ruolo
storico, per spiegare storicamente l’origine della dialettica ordine-anarchia, come il dominio tende a
tramutarsi in anarchia,
e per individuare i motivi per cui nell’anarchia si esprime la
tendenza all'ordine e all'armonia. L’anarchia di poteri si manifestò in tutta la sua crudezza ed
oppressione durante il regno di Stefano nel corso della guerra civile fra il re e il pretendente al trono
Enrico, nipote di Guglielmo H, fra il 1138
e il 1153. Ed è in questa situazione, osserva Burke, che si manifestò una presa di coscienza del
significato etico della virtù
militare, dell’onore militare come tutela e difesa delle persone
per le quali si esercitava il mestiere delle armi; Si affermò così
e si diffuse lo spirito di cavalleria, la professione delle armi
impegnava a combattere in difesa dei deboli, degli indifesi,
contro coloro che si servivano delle armi per usare violenza,
commettere rapine, uccidere, opprimere.
Era una manifestazione della “tendenza” ad uscire dall’anarchia per cercare di dar vita a un ordine e
un'armonia di
intenti, di cui si rendevano interpreti le classi popolari, che,
grazie ai conflitti che finivano per indebolire la monarchia e i
feudatari, cominciarono a richiedere e poi a pretendere in
quanto soggetti all'obbligo feudale di fedeltà al re la concessione di privilegi inerenti al loro status
di abitanti di città e di
comunità, alle quali si cominciò a riconoscere un'autonoma
giurisdizione di carattere amministrativo, sul modello di
quelle feudali. Lo spirito marziale che caratterizzava l’ordinamento feudale aveva finito per
informare di sé le “maniere” e
`le menti del popolo, sottraendolo ad un stato di mera passività e soggezione ed impegnandolo nella
lotta per la difesa dei
suoi diritti. Con il regno di Enrico I la richiesta e la concessione di carte delle libertà alle città, a
quella di Londra in particolare, ed al "popolo” divennero una condizione necessaria
per il riconoscimento e la consacrazione del successore al
trono d’Inghilterra, il che secondo Burke cominciò a formare
una sorta di prassi costituzionale, che avrebbe avuto il suo
pieno riconoscimento con la Magna Carta e con la Carta delle
foreste, << due memorabili documenti; che per la prima volta
disarmarono la Corona delle sue illimitate prerogative e posero il fondamento della libertà
inglese>>. Burke tiene ad evidenziare la specificità storica delle due
Carte, di documenti che debbono essere interpretati con riferimento all’ordinamento feudale dal
quale in sostanza promanano: essi pertanto non possono essere considerati, come ritengono i nostri
storici (compreso Hume), un ritorno o un
rinnovamento delle leggi di Sant Edward o delle antiche leggi
sassoni.
Le due Carte invece ebbero lo scopo preciso di correggere l'ordinamento politico feudale”, la
“feudal policy” e pertanto si avvalsero di principi, di norme propri dell’ordinamento feudale.
Secondo la consuetudine feudale i baroni richiesero che le “libertà" fossero “garantite a loro ed ai
loro
eredi dal re e dai suoi eredi": ciò dimostra, rileva Burke, che
la dottrina di un possesso feudale inalienabile fu sempre dominante nelle loro menti. Anche la loro
idea di libertà non era
perfettamente libera: essi non rivendicarono i loro privilegi
sulla base di un principio di natura o altro indipendente fondamento, ma, in virtù del possesso delle
loro terre, li pretesero dal re. Secondo la legge feudale, la proprietà della terra
derivava dalla Corona, per concessione immediata o derivata.
La Magna Carta e la Carta delle foreste sono il risultato
dell'interna dialettica del sistema feudale, della “feudal policy”,. o della monarchia feudale inglese.
Esse sono la testimonianza, la prova, chele lotte, i conflitti, persino all'interno
della famiglia reale per la successione al trono dei figli contro
il padre, come nel caso di Enrico II, e poi fra il re e i grandi
feudatari, fra il re e la Chiesa, furono i principi della dinamica
interna della “feudal polìcy”, che ebbe come risultato la prima
“correzione” o riforma del sistema feudale. Si provvide così a
delimitare e definire le prerogative della monarchia, a riconoscere e ad inserire nell'ordinamento
costituzionale i poteri dei
grandi feudatari, a sancire le essenziali garanzie di libertà degli uomini liberi.
I principi fondamentali dello Stato costituzionale inglese
ebbero per Burke una lunga “gestazione” storica che. Durò
circa seicento anni dalla fondazione dei regni sassoni e dalla
loro successiva unificazione sino alla Magna Carta. La monarchia sassone, inizialmente una sorta di
irregolare “repubblica”, costituita dalle tribù che riconoscevano un unico capo,
si trasformò lentamente in una monarchia altrettanto irregolare, in cui non erano, definiti né i poteri
del re né le regole di
successione al trono, e il suo ordinamento politicoamministrativo aveva le caratteristiche di una confederazione
dei “grandi distretti”, borougs. L’autorità e il potere di
governo e di coordinamento della monarchia sassone si affermò a poco a poco nel corso dei quattro
secoli della sua durata quando fu assunta e rafforzata da una più rigida organizzazione feudale da
parte della monarchia normanna. L'istituzione di un potere unitario e della sua organizzazione
politica,
amministrativa, giudiziaria e fiscale procedette con estrema
lentezza secondo i ritmi di un processo storico in cui tutti i
membri della comunità sono “chiamati” a fare la “policy”, lo
Stato, secondo le proprie condizioni, convinzioni e capacità
storiche dal re, all’aristocratico, all’ecclesiastico, al libero, al
servo.
Nell’Abridgment il medioevo è “riscattato” dalla visione
illuministica del “tempo” della barbarie, della inciviltà, della
superstizione, della “notte della ragione”, ma è visto invece
come il periodo storico in cui possiamo intendere le origini
della nuova società europea, dei nuovi popoli e delle diverse
nazioni che lentamente la formarono grazie ai principi, agli
ideali della religiosità cristiana, che richiamarono l’istituzione
tipica di quei tempi, il feudalesimo, ai suoi intrinseci ideali
della lealtà, della fedeltà, della difesa dei deboli, degli inermi,
di quanti, la stragrande maggioranza, non praticavano il mestiere delle armi. Pur con la sua ferocia e
brutalità, con la sua
propensione all’avventura, alla rapina, al dominio, il feudalesimo esprime con la “cavalleria” il
sentimento dell’onore e
dell'impegno disinteressato, insieme alla convinzione che la
forza ha come fine la difesa del debole e` dell'oppresso, e pertanto promuove un rapporto dell’uomo
con il potere fondato
su quei principi e valori che sono per Burke alla base della
vita civile e politica dell’Europa moderna.
Il tema delle origini e della formazione della nazione inglese non può essere scisso, secondo Burke,
da un sentimento
di “venerazione" per l’antichità e quindi da una partecipazione simpatetica ai sentimenti, alle
passioni e soprattutto alla
“religiosità” di quelle popolazioni e di quei tempi, onde poter
intendere il processo di lenta formazione ed integrazione delle
nazioni europee come delle vere e proprie “totalità etiche”
con proprie consuetudini, tradizioni in cui si esprimono le
loro specifiche caratteristiche. Si precisa così ulteriormente il
preromanticismo di Burke, che si era già manifestato nell’estetica con la teoria del sublime:
nell’abridgment si esprime nella
convinzione che la tradizione storica è un insostituibile fonda»mento delle istituzioni e degli
ordinamenti politici di cui lo
storico deve saper riconoscere il profondo contenuto di verità.
Dal punto di vista del pensiero politico la conclusione
dell'abridgment è che lo Stato non si “costituisce” con le delibere di un’Assemblea, né può essere
ricostituito o rifondato
con le rivoluzioni, che possono correggere e innovare nei limiti in cui si inseriscono e continuano il
processo storico da cui promana l’istituzione che si intende riformare. È proprio
questa la premessa essenziale delle considerazioni che saranno
poi svolte nelle riflessioni sulla rivoluzione francese. Con
l’abridgment Burke matura la convinzione che la politica è
intimamente connessa con la storia, rappresenta per molti
aspetti il principio dinamico della storia, ne spiega il movimento che connette le azioni degli uomini
in un processo unitario che garantisce la continuità storica cioè il principio di
identità delle grandi formazioni ed organizzazioni politiche.
Di qui la caratteristica del pensiero politico burkiano di considerare la politica in una prospettiva
storica, cioè di analizzare i fatti e gli eventi politici nel contesto della dinamica storica del suo
tempo, con un preciso richiamo ai precedenti
storici che ne spiegano le origini.
La politica ha nella storia il suo intrinseco completamento: i fini che essa persegue possono essere
compresi nel
loro vero significato e valore solamente in una prospettiva
storica. In conclusione la ragione “concreta” è la ragione storica che si commisura al corso degli
avvenimenti storici per
intendere come le necessità, le esigenze, le aspirazioni, gli
ideali, le ragioni degli uomini si traducono nella realtà, diventano cioè mondo delle istituzioni, delle
leggi, delle relazioni,
del sapere e delle convinzioni umane. Perciò, in Burke, la
realtà, il concreto non è altro che storia: la teoria della società
e della politica non può prescindere dal problema storiografico, cioè dai criteri che presiedono alla
ricostruzione storica
degli avvenimenti e alla loro corrispondente valutazione storica. Alla ragione illuministica Burke
contrappone la ragione
storica, cioè quella che è in grado di comprendere << the necessity of the times », una necessità
anch'essa storica, cioè la
totalità e quindi l’unità delle_ situazioni e delle condizioni dei
tempi.