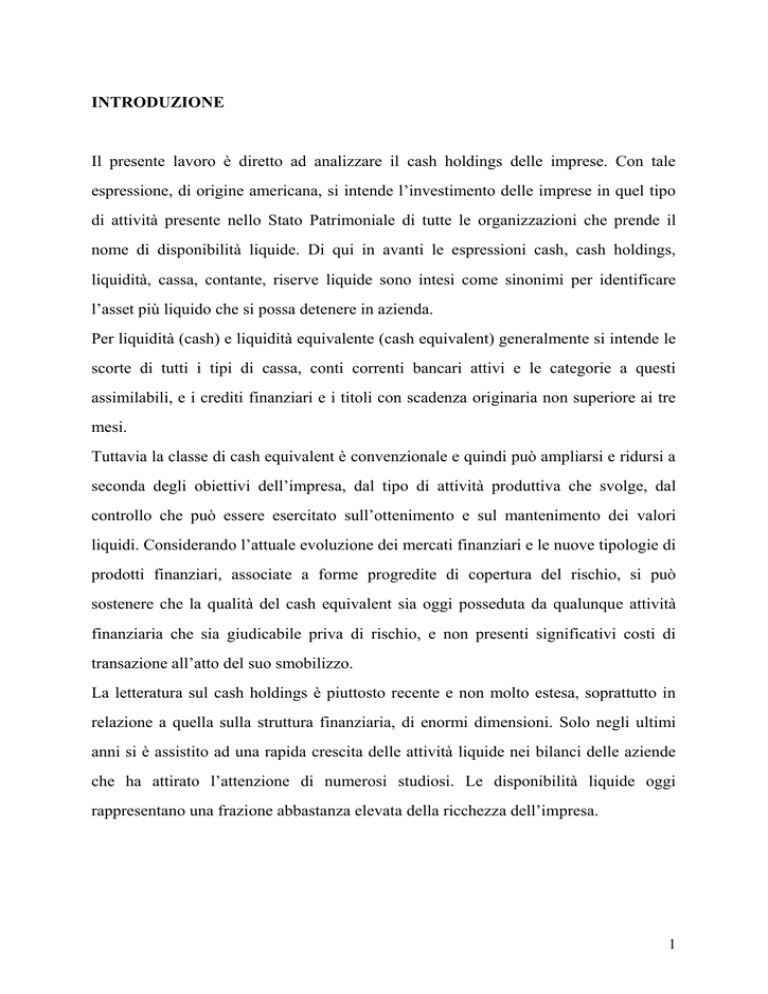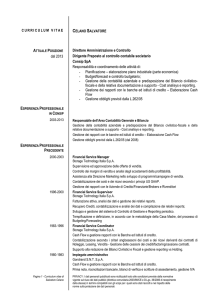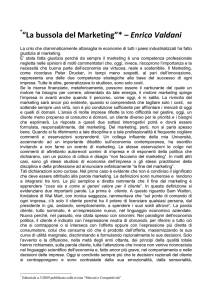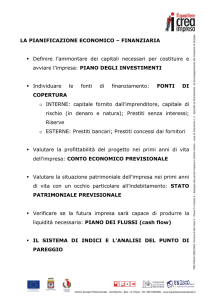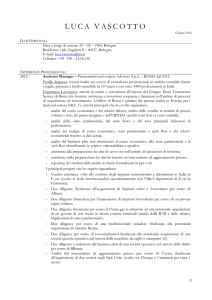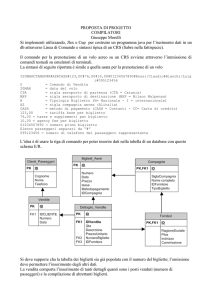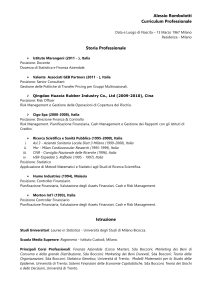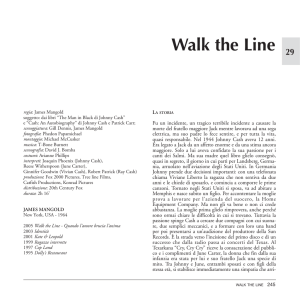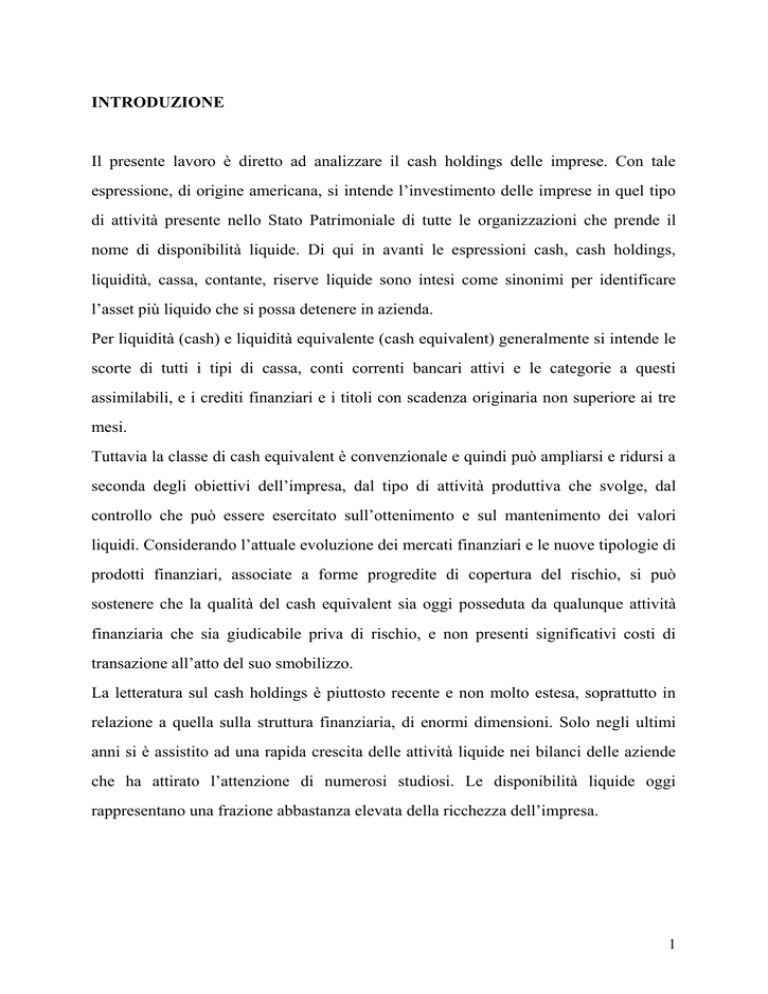
INTRODUZIONE
Il presente lavoro è diretto ad analizzare il cash holdings delle imprese. Con tale
espressione, di origine americana, si intende l’investimento delle imprese in quel tipo
di attività presente nello Stato Patrimoniale di tutte le organizzazioni che prende il
nome di disponibilità liquide. Di qui in avanti le espressioni cash, cash holdings,
liquidità, cassa, contante, riserve liquide sono intesi come sinonimi per identificare
l’asset più liquido che si possa detenere in azienda.
Per liquidità (cash) e liquidità equivalente (cash equivalent) generalmente si intende le
scorte di tutti i tipi di cassa, conti correnti bancari attivi e le categorie a questi
assimilabili, e i crediti finanziari e i titoli con scadenza originaria non superiore ai tre
mesi.
Tuttavia la classe di cash equivalent è convenzionale e quindi può ampliarsi e ridursi a
seconda degli obiettivi dell’impresa, dal tipo di attività produttiva che svolge, dal
controllo che può essere esercitato sull’ottenimento e sul mantenimento dei valori
liquidi. Considerando l’attuale evoluzione dei mercati finanziari e le nuove tipologie di
prodotti finanziari, associate a forme progredite di copertura del rischio, si può
sostenere che la qualità del cash equivalent sia oggi posseduta da qualunque attività
finanziaria che sia giudicabile priva di rischio, e non presenti significativi costi di
transazione all’atto del suo smobilizzo.
La letteratura sul cash holdings è piuttosto recente e non molto estesa, soprattutto in
relazione a quella sulla struttura finanziaria, di enormi dimensioni. Solo negli ultimi
anni si è assistito ad una rapida crescita delle attività liquide nei bilanci delle aziende
che ha attirato l’attenzione di numerosi studiosi. Le disponibilità liquide oggi
rappresentano una frazione abbastanza elevata della ricchezza dell’impresa.
1
Uno studio di JP Morgan1 ha evidenziato come dal 2000 al 2004, nel settore corporate
delle nazioni più ricche, si è assistito ad un incremento del risparmio di più di un
trilione di dollari. Questo fenomeno assume maggiore importanza per il fatto che negli
ultimi quarant’anni non vi è mai stato un tale accumulo di risorse liquide da parte delle
aziende, e inoltre perché parallelamente vi è un forte decremento della propensione al
risparmio da parte delle famiglie.
Un caso particolarmente interessante è stato quello della Microsoft, il gigante
americano del software. Ha destato molto clamore tra gli addetti il notevole cash
savings del colosso di Bill Gates.
Reuters al 2002 riporta che “Microsoft non ha mai pagato dividendi durante i suoi 15
anni di vita da public company e ha invece ammassato la più grande quantità di cash
nella storia industriale:36 miliardi di dollari…”. Sempre al 2002 da una lettera
dell’avvocato Ralph Nader a Bill Gates si apprende che “il cash holdings della
Microsoft sta crescendo ad un tasso impressionante di circa 1,5 miliardi di dollari al
mese nell’ultimo quadrimestre”.
Nel 2004 Microsoft presenta nel suo report annuale una posizione in cash pari a 60,6
miliardi di dollari. La crescente pressione degli investitori ha però costretto l’azienda a
annunciare il pagamento di dividendi pari a 32 miliardi di dollari e il riacquisto di 30
miliardi di dollari di azioni nei successivi quattro anni. A tale annuncio il mercato ha
reagito immediatamente, facendo salire il valore delle azioni del 5,7%.
Viene naturale chiedersi perché le compagnie trattengano al loro interno alte quantità
di cash, che invece potrebbero essere investite in maniera più redditizia. Oppure,
messa in un’altra prospettiva, domandarsi qual è il valore reale della liquidità. Per
Brealy e Myers questo rappresenta uno dei dieci quesiti ancora irrisolti della finanza
d’azienda.
1
“Corporate are driving the global saving glut”, JP Morgan Research, June 24, 2005
2
Per trovare una risposta occorre comunque distaccarsi dall’assunzione di mercati dei
capitali perfetti di Modigliani Miller.
Già assumendo la presenza di costi di transazione, sorge la necessità di determinare un
livello di cash ottimale che bilanci i costi e i benefici dell’accumulo di cash.
Ma è soprattutto la considerazione delle asimmetrie informative che assume maggiore
rilevanza nell’ambito del cash holdings. I fenomeni di moral hazard e di adverse
selection, introdotti da Akerlof nel 1970, con i conseguenti costi di agenzia, ci
mostrano le due facce di una stessa medaglia.
Da un lato il motivo precauzionale del cash, utile per i rainy day, per futuri periodi
possibili di scarsa liquidità, e collegato ai financial constraints, i vincoli finanziari
dovuti ad una differenza elevata nel costo delle finanze esterne rispetto a quelle interne.
In questo senso la liquidità permette di poter sfruttare le opportunità d’investimento
future senza dover sopportare costi troppo elevati o, nella peggiore delle ipotesi, senza
dover rinunciare a tali opportunità. È questo il succo della teoria di Myers e Majluf
(1984): il cash diventa un asset che crea valore per gli azionisti.
Ma, come detto, esistono due lati per ogni cosa. Come afferma Dittmar, “ c’è una linea
sottile tra l’avere abbastanza denaro per fare ciò che devi fare e l’avere abbastanza
denaro per fare ogni cosa tu voglia fare”. Le riserve liquide sono facilmente accessibili
da chi controlla l’azienda ed il loro utilizzo è eccessivamente discrezionale. Entrano
quindi nell’analisi considerazioni di corporate governance, a causa dei conflitti di
interesse tra manager e azionisti e, trasferendoci in un ambito più europeo, tra azionisti
di minoranza ed azionisti di maggioranza. Chi controlla di fatto l’impresa può mettere
in atto comportamenti opportunistici (moral hazard); il cash è sicuramente lo
strumento più semplice per estrarre benefici privati ai danni delle minoranze.
L’investimento in cash in questo caso distrugge valore per gli azionisti.
Quanto detto finora è il contenuto del primo capitolo, dove si passano in rassegna i
vari contributi teorici, a partire da Keynes, che nel 1936 spiega i possibili motivi per
detenere liquidità, continuando con la letteratura sui financial constraints e sui costi di
3
agenzia, per poi concludere dando uno sguardo alla realtà ormai diffusa dei gruppi e
alla possibile formazione di un mercato dei capitali interno sostitutivo del mercato
esterno così come del cash holdings.
Nel secondo capitolo sono invece esaminati i risultati riscontrati in letteratura. Si
analizzano le evidenze della letteratura sui financial constraints tramite i lavori
sull’investment cash flow sensitivity e sul cash cash flow sensitivity. Quindi sono
analizzati tutti i tipi di lavori empirici svolti sul cash holdings: quelli che ne studiano le
determinanti e il livello ottimale, quelli che ne studiano il valore, quelli che infine
esaminano l’utilizzo del cash definito excess cash, ossia il cui impiego è a totale
discrezione degli amministratori.
Nel terzo capitolo è svolta un’analisi empirica su di un campione di circa 4000 imprese
Europee di medio grandi dimensioni, quotate e non quotate. L’analisi si propone di
capire quali siano le determinanti dell’investimento in liquidità attraverso una
regressione del cash holdings sulle caratteristiche economico-finanziarie delle imprese.
Viene inoltre identificato il cash in eccesso per ogni impresa, analizzandolo nella sua
persistenza e nel possibile effetto che tale extra-cash può avere in un’equazione
classica d’investimento.
4
CAPITOLO 1
CONCETTI TEORICI ALLA BASE DEL CASH HOLDINGS
1.1 Motivi dell’accumulo di liquidità
L’essere a corto di liquidità è costoso per l’azienda, per cui essa formerà delle riserve
di liquidità fino al punto in cui i costi eguaglieranno i benefici che derivano dal
detenere cash. Trattenere un’unità addizionale di riserve liquide permette di diminuire
la probabilità che l’impresa si trovi in una situazione di mancanza di liquidità ed
abbassare i costi che ne derivano.
1.1.1 Motivo delle transazioni
Un’impresa che si trova a corto di liquidità deve reperirla sul mercato dei capitali, o
vendere assets, o tagliare i dividendi e investimenti, o infine rinegoziare i contratti
finanziari esistenti. Trovare sul mercato risorse fresche è molto costoso e non è sempre
possibile, ma anche le altre opportunità che si offrono all’impresa risultano tutte più
costose se riferite alle risorse interne prontamente disponibili come il cash. Il problema
di quest’ultimo è che la creazione ed il mantenimento di riserve di cash comportano
degli oneri da sostenere. Si tratta quindi di bilanciare il costo marginale delle riserve
liquide con il costo marginale dell’essere a corto di liquidità.
In letteratura, a partire da Keynes nel 1936, emergono due ragioni importanti per
detenere liquidità: il motivo dei costi di transazione e il motivo precauzionale2. Nel
primo caso si può generalmente affermare che le imprese mantengono in forma liquida
una parte dei loro portafogli per far fronte alle esigenze che derivano dalle transazioni
2
Keynes parla anche di un terzo motivo, quello speculativo. Questo dipende dalla previsione sul livello futuro
del tasso d’interesse.
5
correnti. Alcuni modelli classici della finanza (Baumol 1952, Miller e Orr, 1966)
derivano la domanda ottima per il cash quando un’azienda incorre in costi di
transazione nel momento in cui converte un asset finanziario non liquido in cash ed
utilizza il contante per i pagamenti. I due modelli principalmente riconosciuti sono
quello deterministico di Baumol e Tobin (1952;1956) e quello stocastico di Miller e
Orr (1966). I modelli, presentati nella teoria monetaria, sono consistenti con la teoria
dell’impresa e sono largamente accettati in finanza. E’ opportuno precisare che
entrambi gli approcci si riferiscono alla domanda di moneta delle imprese, quindi alla
liquidità in senso stretto.
Baumol è il primo ad osservare che la gestione dei saldi di cassa è assimilabile alla
gestione delle scorte. Se si suppone di possedere una riserva di liquidità a cui attingere
con regolarità per fare fronte ai pagamenti, quando essa si riduce a zero le si
ricostituisce vendendo buoni del tesoro. Il costo di ordinazione è rappresentato dalle
spese amministrative fisse che ogni vendita dei buoni del tesoro comporta.
L’importanza del modello di Baumol è la messa in luce della scelta fondamentale che
il cash manager deve fare fra i costi che conseguono alla negoziazione dei titoli ed i
costi che conseguono dal mancato investimento della liquidità.
Il modello di Baumol aiuta a capire perché le piccole e le medie imprese tendono a
detenere saldi di liquidità proporzionalmente più consistenti. Per le imprese più grandi
i costi di transazione connessi alla vendita e all’acquisto di titoli sono trascurabili, se
paragonati al costo opportunità di mantenere saldi di cassa eccedenti.
Il modello di Baumol si basa sul fatto che la riserva di liquidità viene creata ed usata
costantemente. Nella realtà però in certe settimane l’incasso di alcune ingenti fatture
può dare origine ad un’entrata netta di cassa, in altre invece si può avere, per effetto ad
esempio dei pagamenti ai fornitori, un’uscita netta di cassa.
Il modello di Miller e Orr (1966) tiene conto proprio dell’incertezza dei cash flows. Il
loro approccio fa si che i cash flows netti fluttuino in modo totalmente stocastico tra
6
un limite superiore ed un limite inferiore di controllo. Quando uno di questi limiti è
raggiunto l’impresa provvede a comprare o vendere titoli scambiabili sul mercato.
Si può affermare che il modello di Baumol e Tobin e quello di Miller e Orr implicano
entrambi che ci sono economie di scala nell’uso della moneta o, detto in altro modo,
che l’elasticità della domanda di moneta rispetto alle transazioni è inferiore all’unità.
In presenza di costi di transazione, un’impresa che massimizza il valore valuta i costi
marginali ed i benefici marginali del cash holdings per determinare un ottimo (tradeoff theory).
Nei modelli precedentemente esaminati il costo dell’investimento in liquidità è un
costo opportunità, dato dalla rinuncia al rendimento dei titoli di stato. Nel caso in cui
l’azienda si indebiti per ottenere denaro, il calcolo del costo fa riferimento al tasso
d’interesse che generalmente è assunto essere più alto di quello a cui si rinuncia
vendendo i titoli. Il calcolo diventa più complicato se si considera l’incertezza del
cash flow, come avviene in Miller e Orr. Si supponga questo esempio: per poter
massimizzare gli interessi percepiti, si vuole mantenere basso il saldo di cassa, ma ciò
comporta una maggiore probabilità di dovere ricorrere all’indebitamento in situazioni
di scarsità di contante. Si supponga che si debba decidere se mantenere liquidità senza
percepire interessi o investire i liquidi in titoli che fruttano il 10%. Il costo della
liquidità in questo caso è pari al 10%. Tuttavia, vendere titoli potrebbe essere difficile
e costoso, soprattutto con un preavviso piuttosto breve. Si può però ottenere un prestito
bancario al 12%. Per massimizzare il risultato atteso, il saldo di cassa deve essere
mantenuto ad un livello tale per cui la probabilità di ricorrere al debito bancario è pari
a 10/12, lo 0,83. Il saldo di cassa dipende quindi dall’indebitamento e dall’incertezza
dei flussi di cassa futuri. Se, rispetto ai titoli, il costo dell’indebitamento è elevato, ci si
deve assicurare che la probabilità di ricorrere a tale forma di copertura sia bassa. Se i
flussi di cassa sono molto incerti, può essere necessario mantenere un saldo di cassa
piuttosto elevato in modo da non dover ricorrere al prestito bancario. Al contrario se la
varianza del cash flow è bassa, si può mantenere un minore saldo di cassa.
7
Come detto prima, questa considerazione di costo della liquidità ha senso nei modelli
di Baumol-Tobin e Miller-Orr, in quanto studiano la liquidità in senso stretto, ossia
come domanda di moneta.
Il concetto di cash holdings invece contiene al suo interno non solo la cassa, il contante,
ma anche titoli di stato, banche c/c attivi e commercial paper, generando comunque un
rendimento, al contrario del semplice contante che non genera interessi. Damodaran
(2000) distingue tra wasting cash e non-wasting cash, dove nel primo caso si tratta di
cash lasciato in conti che non fruttano interessi. Riprendendo l’esempio della
Microsoft, la maggior parte dell’investimento in liquidità è in treasury bills e
commercial paper.
Il costo più rilevante dell’accumulo di liquidità è dato dal suo basso ritorno monetario
risk adjusted, se si assume che i managers massimizzano la ricchezza degli azionisti.
Tale costo è usualmente chiamato cost of carry: rappresenta la differenza tra il ritorno
che si ha dall’investimento in cash e l’interesse che si deve pagare per finanziare un
dollaro addizionale di cash. Infatti le attività liquide, come tutte le altre attività, devono
essere finanziate: coerentemente, il costo della liquidità può essere immaginato come il
differenziale tra l’interesse ricavato dall’investimento dei fondi in attività liquide ed il
costo del loro finanziamento. Se l’impresa potesse indebitarsi ed impiegare allo stesso
tasso di interesse non ci sarebbero costi nel detenere liquidità.
Infine, se si considera che i manager possono non agire in linea con gli interessi degli
azionisti, vi sarà un ulteriore costo rappresentato dai costi di discrezionalità
manageriale. Come vedremo nel seguito del capitolo, i manager tendono ad
accumulare liquidità per ottenere benefici personali a discapito degli altri portatori
d’interesse.
In presenza di costi di transazione il beneficio derivante dell’investimento in liquidità è
quello di poter convertire gli assets in cash evitando (o quanto meno riducendo) i costi
fissi dell’accesso al mercato dei capitali.
8
Il motivo del costo delle transazioni porta a molte predizioni circa l’accumulo di cash
delle imprese. Quella che appare più evidente è la diversità di comportamento delle
imprese in base alla dimensione. E’ già stato visto come la presenza di economie di
scala determini una maggiore propensione a detenere cash da parte delle imprese più
piccole. Tale tesi è avvalorata dal fatto che un’impresa che accumula assets che
possono essere convertiti ad un prezzo equo in cash può trovare fondi a costi bassi
vendendo tali assets. Quindi le imprese con un alto grado di specificità degli assets
tendono ad avere un accumulo di cash più alto. Un’ipotesi correlata è che le imprese
più grandi sono generalmente più diversificate e possono liquidare assets in segmenti
non core, permettendo quindi loro di trattenere meno liquidità.
Un altro modo per mantenere cash all’interno è la riduzione dei dividendi: poniamo il
caso di due imprese che si trovano a corto di liquidità. L’impresa che correntemente
paga dividendi può ottenere fondi a basso costo con la riduzione del pagamento dei
dividendi, evitando quindi di approvvigionarsi sul mercato dei capitali ad un costo
maggiore.
Ancora, il ciclo di conversione in cash3 è collegato al livello di liquidità poichè esso
misura l’ammontare medio di tempo, espresso in giorni, in cui i flussi in uscita relativi
all’acquisto dei fattori produttivi e alle spese rientrano in cassa attraverso i crediti
verso clienti.
Kim, Mauer e Sherman (1998), Deloof (2001) affermano che un’impresa con un ciclo
più lungo dovrebbe avere livelli di cash più bassi, in quanto un più basso livello di
cash significa un più alto livello di scorte e crediti commerciali che possono essere
convertiti in cash velocemente. Al contrario Drobetz (2006) spiega che un ciclo di
conversione più corto migliora il timing dei pagamenti in entrata ed in uscita (dei cash
flows), richiedendo in tal modo posizioni di cassa più modeste.
3
Il ciclo di conversione in liquidità è dato da: ciclo economico (acquisto-produzione-vendita) + ciclo incassi dei
crediti commerciali + ciclo dei pagamenti dei debiti commerciali.
9
Un ciclo più corto è caratteristico delle imprese maggiori, che generalmente
presentano un’elevata forza contrattuale. Alcune imprese presentano cicli addirittura
negativi, con payable maggiori dei valori di inventario e receivables sommati. Ciò vuol
dire avere denaro disponibile per il proprio business, prima ancora di doverne spendere.
Andando ad analizzare i pagamenti dei debiti commerciali, le imprese con più potere
riescono ad avere indici molto elevati, cioè riescono a ritardare i pagamenti ai loro
fornitori per molti mesi. Un esempio estremo è quello della Coca Cola che possiede un
indice pari a 220, cioè paga i creditori dopo sette mesi.
Infine le imprese che operano in mercati finanziari maggiormente sviluppati
manterranno meno liquidità, perché i costi di transazione saranno minori nel momento
in cui l’impresa necessità di risorse liquide.
1.1.2 Il motivo precauzionale
Il motivo precauzionale si collega all’ineliminabile incertezza del futuro. Si tratta di
eventi inattesi, non pianificati, quindi non inseriti in documenti di pianificazione
economico-finanziaria. La mancata disponibilità di liquidità può infatti in molte
circostanze rappresentare un costo notevole. Generalmente si possono verificare due
situazioni base:
mancanza di liquidità, intesa come incapacità dell’impresa di far fronte agli
impegni di pagamento assunti, comunemente associabile ad una situazione di
debito eccessivo o di attivo patrimoniale eccessivamente immobilizzato;
inadeguatezza di liquidità, ovvero carenza di fondi per scopi ritenuti fondamentali
per la normale operatività o per politiche di sviluppo dell’azienda, che non
comportano un rischio immediato di insolvenza, ma che di fatto rallentano la
10
crescita nell’ambito dei programmi previsti e limitano i margini di manovra
disponibili.
La liquidità si pone in questo caso come una sorta di cuscinetto che ha la funzione di
ammortizzare l’effetto di impreviste necessità finanziarie, evitando in tal modo che si
creino difficoltà nel fronteggiare le obbligazioni aziendali, nell’attuare progetti di
sviluppo previsti, nel mantenere le posizioni di mercato. Inoltre essa permette
all’azienda di fornire alla gestione un’idonea flessibilità che le consenta una più ampia
libertà di scelta tra differenti alternative di sviluppo, permettendole di cogliere
improvvise opportunità di crescita.
A conferma di ciò un’interessante survey di
Graham e Harvey (1999) mostra come la flessibilità è un obbiettivo di primaria
importanza nelle scelta della struttura finanziaria delle imprese. In un’altra survey di
Lins, Servaes e Tufano del 2007, viene chiesto alle imprese i motivi dell’accumulo di
cash definito strategico (cioè non legato alle operazioni quotidiane). Le risposte hanno
evidenziato una tendenza delle imprese al motivo precauzionale, visto che la ragione
primaria è quella di prevenirsi contro ammanchi futuri di cash flow.
Possiamo dire che il motivo precauzionale è collegato ai problemi d’informazione e
agli agency cost, o parlando più genericamente, ai cosiddetti financial constraints.
Questi ultimi sono determinati da tutte quelle frizioni, derivanti da imperfezioni del
mercato dei capitali, che non permettono all’impresa di finanziare tutti gli investimenti
desiderati (ad esempio vincoli di credito, incapacità di emettere equity, dipendenza dal
prestito bancario..).
E’ importante comunque specificare la differenza esistente tra financial constraints e
financial distress, ossia dissesto finanziario, sebbene questi due concetti sono
indubbiamente collegati (Lamont, Polk e Saa-Requejo (2001)). Per Whited e Wu
(2001) per distinguere un’impresa in situazione di crisi finanziaria da un’impresa
vincolata finanziariamente può essere utile immaginare la differenza tra un’impresa
sull’orlo della bancarotta ed una giovane impresa che vorrebbe crescere rapidamente
11
ma la cui velocità è frenata a causa di mancanza di finanziamenti. La prudenza nasce
dal fatto che uno shock negativo di cash flow può rendere difficile l’investimento in
progetti profittevoli, essendo il finanziamento esterno eccessivamente costoso o non
disponibile. Risulta evidente il collegamento con il “financial slack” di Myers e Majluf
(1984) della celebre teoria della gerarchia di finanziamento, che verrà approfondita nel
seguito del lavoro.
E’ evidente che, riguardando gli investimenti futuri, il collegamento con le opportunità
future d’investimento è necessario4. Quando un’azienda ha la possibilità di investire in
un progetto d’investimento a NPV positivo5, la liquidità diventa importante quando
l’impresa per varie ragioni non può approvvigionarsi nel mercato dei capitali. In tal
senso i fondi interni sono importanti anche quando non vi è la possibilità di prevedere
con una certa precisione quando tali opportunità arrivano, ed il mercato non è reattivo
nella fornitura di capitale.
In ultimo, le imprese con un grande ammontare di debiti di breve periodo potrebbero
affrontare una maggiore incertezza riguardo il grado di rifinanziamento (Holmstrom
Tirole 2000), che diviene più incerto quando c’è una possibilità che il rollover dei
debiti futuri sia negato.
.
1.2 Modigliani Miller: irrilevanza della struttura finanziaria
In un mondo alla Modigliani Miller vi è perfetta sostituibilità delle fonti di
finanziamento. Il teorema di
Modigliani Miller introduce infatti il concetto di
irrilevanza della struttura finanziaria: in un mercato perfetto e completo, ed in assenza
di arbitraggio, la politica di finanziamento delle imprese è irrilevante. Il teorema,
approfondendo la relazione tra costo del capitale ed investimenti, dimostra che il
Le opportunità future d’investimento sono centrali anche per il motivo speculativo.
E’ il valore atteso dell’investimento (VAN). Esso è dato dalla somma dei cash flow futuri scontati ad un tasso
che riflette il valore temporale della moneta, l’inflazione attesa, ed il rischio associato a tali cash flow.
4
5
12
valore di un’impresa è indipendente dal suo grado d’indebitamento: l’accumulazione
di beni di capitali da parte delle imprese ed il flusso di risorse che questa può
determinare sono dati ed indipendenti dalla struttura finanziaria. La prima
proposizione di Modigliani Miller sostiene che un’impresa non può cambiare il valore
complessivo dei titoli in circolazione modificando la ripartizione tra debito e azioni.
Ciò equivale ad affermare che nessuna struttura finanziaria è migliore di qualsiasi
altra per gli azionisti della società.
Il modello è basato su due ipotesi quali la perfezione del mercato dei capitali ed
assenza d’imposizione fiscale, che appaiono lontane dalla realtà. Quand’è che un
mercato dei capitale è perfetto? Quando le seguenti condizioni sono rispettate:
Non ci sono tasse
I manager interni all’organizzazione hanno lo stesso set d’informazioni degli
investitori esterni
Non ci sono costi di transazione
Gli investitori e il mercato sono razionali
Non ci sono costi di ricontrattazione o di bancarotta
Gli interessi dei managers e degli azionisti sono allineati
La condizione di perfezione del mercato, ed in particolare quella di razionalità degli
investitori, consente di assumere che, se all’imprese indebitate viene attribuito un
prezzo troppo alto, gli investitori (razionali) possono indebitarsi personalmente, al
posto delle società, per acquistare azioni nelle imprese prive di debito; possono cioè
imitare senza costi qualsiasi struttura finanziaria che l’azienda intende scegliere.
Ciascun operatore ha l’opportunità di replicare tutte le combinazioni finanziarie
possibili, dunque di effettuare qualsiasi operazione di arbitraggio. Questa sostituzione
si basa sulla possibilità di indebitamento a livello personale. Finchè gli individui si
indebitano e finanziano alle stesse condizioni dell’impresa, possono riprodurre gli
13
effetti dell’indebitamento aziendale. In tal modo il valore di un’impresa è determinato
esclusivamente dalla sua capacità di produrre reddito e, quindi, proprio dalle sue scelte
d’investimento che si sono considerate date.
Occorre però sottolineare che il risultato di Modigliani-Miller dipende dall’assunzione
fondamentale che gli individui possano indebitarsi allo stesso tasso delle società. Il
concetto, in estrema sintesi, è che l’impresa non è in grado di fare per gli investitori ciò
qualcosa che essi non possano fare di propria iniziativa.
Con le assunzioni di Modigliani Miller (1958) c’è chi afferma che il contante abbia
sempre VAN negativo, essendo il suo costo la perdita di interessi; come detto prima
l’investimento in buono del tesoro hanno si un basso rendimento, ma comunque si
tratta di un rendimento equo. Un investimento in BOT è un investimento a VAN zero,
e perciò non ha un effetto sul valore dell’impresa. Di conseguenza l’investimento in
contante è al di sotto del tasso di rimunerazione di mercato conseguendone un
abbassamento del valore dell’impresa. Damodaran, come già detto, distinguendo tra
wasting cash e non-wasting cash propone un modo semplice per vedere quanto
l’investimento in liquidità, inteso in senso lato, possa distruggere valore. Il metodo
consiste nell’esaminare gli interessi guadagnati da un’impresa sulla posizione di
liquidità durante il corso dell’anno e comparare questo interesse di libro sul cash con il
tasso d’interesse di mercato durante il periodo. Se il cash è investito produttivamente, i
due tassi dovrebbero convergere. Si consideri un esempio: un’impresa ha un saldo di
liquidità di 200 milioni di dollari nel 2004 e guadagna interessi di 4,2 milioni di dollari
da questo investimento. Se il tasso medio dei treasury bill del periodo è stato del
2,25% si può stimare la componente wasting in questo modo:
Interesse guadagnato nel 2004 = 4,2 milioni di dollari
Tasso d’interesse sul saldo di liquidità = 4,2/200 = 2,1%
Tasso d’interesse di mercato dei treasury bill = 2,25%
14
Proporzione di liquidità che è considerata wasting-cash = 1- 0,021/0,0225 = =0,0667
(6,7%)
Perciò il 6,67% di 200 milioni di dollari, pari a 13,34 milioni di dollari, sarà
considerato wasting cash, ossia liquidità che distrugge valore all’azienda.
La liquidità quindi è un elemento che non solo non è in grado di incrementare la
ricchezza dell’azionista, ma, a meno che non è tutta investita in titoli di stato, la sottrae.
Nel 1963 tuttavia gli stessi autori dimostrano che l’esistenza di sussidi fiscali sui
pagamenti degli interessi avrebbero fatto aumentare il valore dell’impresa con
l’ammontare del debito, per una somma pari al valore capitalizzato del beneficio
fiscale. Ma questa linea di argomento non implica che l’impresa potrebbe essere
finanziata solo interamente col debito. Modigliani e Miller stessi infatti commentano
che ciò non significa che l’impresa dovrebbe sempre cercare di usare il massimo
livello di debito, perché ci sono limitazioni imposte dai creditori, così come altri tipi di
costi nei problemi reali di strategie di finanziamento.
Gli autori affiancano ai benefici fiscali del debito i costi del dissesto finanziario che
agiscono in senso contrario allo scudo fiscale, riducendo il valore dell’impresa
indebitata. Essi arrivano all’individuazione di un punto in cui l’incremento del valore
attuale dei costi di dissesto dovuto ad un dollaro addizionale di debito eguaglia
l’incremento del valore attuale dello scudo fiscale; il punto definisce la quantità ottima
di debito, la struttura ottimale del capitale.
Jensen e Meckling (1976) criticano questa teoria in quanto essa implica che nessun
debito sarà utilizzato in assenza di sussidi fiscali se i costi di bancarotta sono positivi.
E’ però risaputo che il debito è stato usato da sempre anche prima dell’esistenza di
sussidi fiscali sugli interessi, per cui la teoria non cattura alcuni aspetti della struttura
del capitale di un’azienda. Inoltre né i costi di bancarotta né i vantaggi fiscali riescono
a spiegare l’utilizzo di warrants o preferred stock che non hanno la possibilità di
usufruire di scudi fiscali.
15
Secondo gli autori, la presenza di costi di agenzia può fornire ragioni più forti per il
superamento della teoria di Modigliani-Miller del 1958, rispetto a quelle della
deducibilità degli interessi passivi o dei costi di bancarotta 6 . I problemi di moral
hazard e di adverse selection (dovute alle asimmetrie informative sugli assets correnti
e sui progetti futuri), gli agency costs, che ne sono una conseguenza, possono essere
raggruppati, tenendo conto anche dei costi di transazione, nel concetto più generale di
imperfezioni del mercato finanziario.
1.2.1 Asimmetrie informative, agency costs ed incompleta specificazione dei
contratti
Il concetto di asimmetria informativa è stato per la prima volta esaminato in Akerlof
(1970). Un mercato è caratterizzato da una situazione di asimmetria informativa
quando alcuni individui possiedono informazioni privilegiate rispetto ad altri e la
utilizzano per il proprio tornaconto, assumendo comportamenti poco corretti (moral
hazard) come, ad esempio offrire prodotti mentendo sulla loro qualità. Tali
comportamenti generano sfiducia e producono un appiattimento del prezzo dei prodotti:
gli operatori non informati non potendo conoscere con esattezza il valore effettivo
della merce disponibile, offriranno un prezzo che rispecchia un livello di qualità medio
(adverse selection). Tale valore medio se da un lato è troppo basso per soddisfare gli
offerenti prodotti di alta qualità, dall’altro lato è sufficientemente alto da incentivare i
proponenti prodotti di qualità scadente, la cui offerta si intensifica rispetto a quella
della merce buona, riducendo gradualmente gli standard qualitativi del mercato,
destinato nel tempo a scomparire.
6
Vi è da notare però che una parte dei costi indiretti di bancarotta è rappresentato dai costi di agenzia.
16
Secondo Holmstrom e Tirole (1998, 2000), le asimmetrie informative tra le imprese e i
mercati finanziari aggravano le difficoltà di reperimento dei finanziamenti esterni,
aumentandone il costo, e quindi creano una domanda precauzionale di liquidità
aziendale.
Le asimmetrie informative causano frizioni, le quali impediscono o quanto meno
complicano la sostituibilità del capitale proprio e di debito. Infatti, proprio a causa di
queste asimmetrie, nascono i cosiddetti agency cost, ossia quei costi che derivano dai
rapporti di agenzia. La teoria dell’agenzia nasce da un’idea introdotta da Adam Smith
già nel 17767 e sviluppata successivamente da Jensen e Meckling nel 1976.
Secondo Jensen e Meckling (1976) la relazione principale-agente avviene
ogniqualvolta un individuo, l’agente, prende decisioni per conto di qualcun altro (il
principale), per le quali egli influenza sia il benessere proprio sia quello di altre
persone. L’agente ha una propria funzione di utilità e di benessere. Se essa coincide
con quella del principale, quindi se la realizzazione degli obiettivi definiti massimizza
l’utilità di entrambe le parti, ci sono buone ragioni per ritenere che l’agente agirà
nell’interesse del principale. Se invece gli obiettivi contrattualmente definiti
massimizzano principalmente l’utilità del delegante, si creano i presupposti per il
manifestarsi di un problema di agenzia, che può compromettere irrimediabilmente
l’efficienza e, quindi, l’efficacia della relazione.
Questo conflitto è chiamato “principal-agent conflict”, e la perdita risultante
dall’azione dell’agente rispetto quella ottimale rappresenta una parte dei cosiddetti
agency costs.
Jensen e Meckling individuano tre tipi di costi di agenzia: i costi di monitoring,
necessari per controllare l’eventuale azione sleale del suo agente; i costi di cauzione
(bonding costs) tramite i quali l’agente offre garanzie e rassicura il principale che non
“Non possiamo aspettarci che i dirigenti di società, chiamati a gestire il denaro di altre persone, si dedichino a
tale attività con la stessa cura con cui agirebbero i soggetti titolari di una partecipazione in una società
nell’amministrazione del proprio denaro (……). Nella gestione di tali attività, pertanto, negligenza e sprechi
saranno sempre presenti.”.
7
17
si comporterà slealmente; la perdita residua (residual loss) definita come “perdita del
valore dell’impresa che sopporta il principale e che deriva dalla delega data all’agente”.
Nei lavori di Jensen e Meckling (1976) e Fama e Jensen (1983) è sviluppata la
cosiddetta visione contrattuale dell’impresa, proposta in precedenza da Coase (1937).
Quest’ultimo caratterizza i confini dell’impresa come lo spazio entro il quale
l’allocazione delle risorse non segue una logica di mercato ma procede in base ai
principi di autorità e di indirizzo. Per Coase l’impresa dovrebbe internalizzare tutti i
processi per i quali l’uso del mercato (che si attua per mezzo dei contratti e quindi
dello scambio) presenta un costo superiore all’esercizio dell’autorità di indirizzo.
L’impresa in tal modo è un organismo che cerca di bilanciare i benefici interni di una
struttura di governo con i benefici esterni delle transazioni di mercato.
Jensen e Meckling (1976), riprendendo i concetti espressi da Alchian e Demsetz 8 ,
affermano che il problema di monitoraggio e quindi dei costi di agenzia esiste per tutti
i tipi di contratto, indipendentemente dal fatto che si realizzi o meno la produzione
congiunta: “l’impresa privata è semplicemente un’invenzione legale che funge da
legame tra le relazioni contrattuali che esistono tra gli individui”. Per la prima volta
emerge la definizione di impresa come nesso di contratti (nexus of contract).
1.3 Corporate governance: introduzione
L’essenza della teoria dell’agenzia è la separazione tra management e finanza, cioè
della proprietà dal controllo. In termini semplicistici, i finanziatori ed i manager
8
Alchian e Demsetz (1972) mettono in risalto il ruolo dei contratti come veicolo per lo scambio anche
all’interno dell’impresa. La definizione contrattuale si traduce, in pratica, nell’implementazione di processi
produttivi congiunti che coinvolgono tutti i fornitori di input di produzione e si sintetizzano nell’esercizio
dell’attività economica. L’esistenza di una produzione congiunta o in team può generare un problema di
asimmetrie informative in termini di non controllabilità della prestazione, che rende necessario il monitoraggio
dei partecipanti al processo produttivo.
18
stipulano contratti che specificano come i manager utilizzano i fondi, e come i ritorni
sono divisi tra loro e i finanziatori.
Idealmente il contratto dovrebbe essere completo, specificando cosa il manager farà in
tutti gli stati futuri del mondo e come i profitti saranno allocati. Nella realtà è
facilmente intuibile che molte circostanze future non possono essere descritte e
previste nel contratto. Emerge allora il problema di allocare i diritti di controllo
residuali, ossia i diritti di prendere determinate decisioni nelle circostanze non previste
dal contratto (Grossman e Hart (1986), Hart e Moore (1990)). Da qui nasce il concetto
di possesso di diritti di controllo residuali: il possessore di un asset ha “residual control
rights” quando ha il diritto di decidere tutti i possibili usi di questo asset nel rispetto
del contratto, del costume o della legge.
Le tematiche lasciate senza specificazione saranno spesso più importanti delle
tematiche oggetto di specificazione all’interno dei contratti. In questo quadro è
evidente che qualcosa deve completare i dettagli. Il diritto di voto assume importanza
in quanto svolge questo compito.
Il diritto di voto è il diritto di prendere tutte le decisioni non altrimenti previste dal
contratto o dalle norme di legge. Secondo Easterbrook e Fischel (1991) il voto dà il
potere di agire (o delegare) quando i contratti non sono esaurienti.
Gli azionisti sono titolari delle pretese sul residuo attivo dell’impresa. I creditori hanno
diritti prestabiliti, mentre i dipendenti di solito concludono accordi retributivi
precedenti alla prestazione. Gli azionisti, come titolari delle pretese sul residuo,
normalmente hanno gli incentivi appropriati per prendere decisioni discrezionali. Gli
altri soggetti attori, invece, mancano degli incentivi appropriati. Chi vanta diritti
prestabiliti sul flusso di cassa può ricevere solo un beneficio impercettibile (nel senso
di una garanzia maggiore) dallo sviluppo di un nuovo progetto. Gli azionisti ricevono
la massima parte dei guadagni marginali e sopportano la massima parte dei costi
marginali. Ciò è in linea con la visione tradizionale della massimizzazione del valore
degli azionisti. Quanto descritto fino ad ora è valido solo in prima approssimazione.
19
Nella realtà vi possono essere situazioni in cui il controllo e quindi le pretese sul
residuo non spettano agli azionisti. Ad esempio quando l’impresa si trova in stato
d’insolvenza, la pretesa sul residuo degli azionisti viene a cadere ed essi perdono
l’incentivo appropriato a perseguire la massimizzazione marginale. Altri gruppi invece,
come gli azionisti privilegiati o i creditori, ricevono i benefici di nuove decisioni e di
nuovi progetti fino a che i loro diritti vengono soddisfatti. Gli azionisti perdono i loro
voti di controllo quando le loro azioni vengono congelate o per contratto o per
l’applicazione delle norme sul fallimento; gli amministratori dovranno quindi
rispondere ad altri investitori.
Sul tema, essenziale è il paper di Aghion e Bolton (1992) i quali introducono il
concetto di allocazione contingente del controllo. Essi costruiscono un modello
intertemporale a tre periodi, dove, in presenza di un contratto di debito incompleto e
nel caso di vincoli di ricchezza dell’imprenditore9, l’allocazione del controllo dipende
dalla realizzazione di un segnale di profittabilità futura che si manifesta nel periodo
intermedio. Nel contratto di debito (rispetto ad altri tipi di relazioni, quali ad esempio
con un contratto di venture capital o di titoli convertibili) l’imprenditore mantiene il
controllo quando il ritorno atteso nel periodo di mezzo è abbastanza alto da coprire le
spese iniziali dell’investitore. Nel caso in cui il segnale è negativo, ossia i ritorni nel
periodo intermedio sono bassi, il controllo passa nelle mani del creditore.
1.3.1 Corporate governance: definizioni
La relazione contrattuale principale-agente è alla base della disciplina della corporate
governance. Secondo Hart (1995) i temi di corporate governance emergono in
un’organizzazione ogni qual volta si verificano due condizioni. In primo luogo quando
In quest’ultima ipotesi Aghion e Bolton si distinguono da Hart e Moore, dove gli agenti sono in grado di
comprare qualsiasi assets loro desiderino.
9
20
si è in presenza di un problema di agenzia, ovvero di un conflitto d’interessi, che
coinvolge i membri dell’organizzazione (siano i proprietari, i manager, i lavoratori, o i
consumatori). In secondo luogo, quando i costi di transazione sono tali che questo
problema di agenzia non può essere risolto attraverso un contratto. In linea con questa
idea la governance è vista da Zingales (1998) come sinonimo di esercizio di autorità,
direzione e controllo. Il principio di autorità nasce proprio da un vuoto contrattuale.
La definizione di Corporate Governance più citata in letteratura è quella di Schleifer e
Vishny (1997): si tratta di quel complesso sistema di regole che devono assicurare un
rendimento adeguato al capitale fornito dagli investitori. E’ una prospettiva basata
chiaramente sul rapporto di agenzia e a volte riferita alla separazione della proprietà
dal controllo.
La distinzione tra diritti di controllo in diritti formali e diritti reali è fondamentale per
la comprensione del meccanismo di governance. Il diritto formale di controllo spetta ai
soci, e non, come si potrebbe pensare, ai manager.
I manager usufruiscono di un diritto di fatto di controllo che scaturisce dalle già note
asimmetrie informative. Essi hanno a disposizione e gestiscono le principali
informazioni che si creano internamente all’azienda. La distribuzione efficiente dei
diritti di controllo che la governance mira ad ottenere consisterà nella soluzione di due
problemi: l’attribuzione efficiente dei diritti formali e la loro possibilità di essere
esercitati, cioè di diventare diritti effettivi.
Nelle imprese generalmente si assiste alla coesistenza di molteplici tipi di securities
con diversi diritti di controllo. Tuttavia, soltanto un gruppo alla volta detiene il
controllo (Easterbrook e Fischel (1991)). Di conseguenza gli investitori che hanno il
controllo non internalizzeranno il benessere degli altri investitori, creando così
esternalità. Si è in presenza di una vera e propria architettura di titoli da parte delle
imprese in cui la liquidità assume un ruolo rilevante mostrando, oltre ai suoi lati
positivi, anche il suo lato oscuro (Myers e Rajan “The paradox of liquidity” (1998)).
21
1.4 Costi di agenzia del debito
Jensen e Mackling (1976) analizzano gli effetti di incentivazione associati al debito in
un’ottica uniperiodale. Questi mostrano come il proprietario-manager, nel caso abbia
la possibilità di emettere titoli di debito prima di scegliere quale investimento
realizzare, possa manifestare un comportamento scorretto nei confronti dei creditori.
Egli infatti promettendo di intraprendere un progetto a bassa rischiosità, dopo aver
raccolto capitale di debito, può investire in un progetto più rischioso trasferendo valore
dai nuovi bondholders ai portatori di equity e quindi a se stesso. Tutto questo è
possibile per le responsabilità limitata (limited liability) di cui gode il proprietario che
detiene azioni e se gli obbligazionisti non prevengono tale comportamento; se loro
percepiscono che il manager ha l’opportunità di intraprendere il progetto più rischioso,
pagheranno un prezzo più basso per i titoli di debito. In questo modo non ci sarà alcun
trasferimento di valore e quindi nessuna perdita di ricchezza. Questo fenomeno è
conosciuto come risk shifting e rappresenta la componente principale degli agency
costs del debito. Un’ altra parte importante, legata al trasferimento del rischio, è il
costo di monitoraggio che viene espressa attraverso dei patti (covenants) inseriti nella
fase di contrattazione, che rappresentano dei vincoli all’effettuazione di operazioni a
danno dei creditori. I costi associati a questi covenants rappresentano i costi di
monitoring. I creditori avranno l’incentivo a monitorare le azioni dei manager fino al
punto in cui il costo marginale nominale di tale attività eguaglia il beneficio marginale
che loro percepiscono sempre dalla stessa. Si parla di costo nominale perché in pratica
i portatori di debito non sopportano tali costi. Come detto prima, gli azionisti scontano
il costo atteso dei possibili effetti redistributivi ed i costi di monitoraggio.
Esempi pratici di covenants possono essere i limiti all’assunzione di nuovo debito,
limiti alla concessione di garanzie, l’obbligo di mantenere alcuni valori finanziari
minimi, o ancora, limiti alla distribuzione dei dividendi.
22
Riguardo quest’ultimo vincolo, è interessante vedere come i dividendi siano utilizzati
come strumenti per modificare il rischio dell’impresa, attraverso una modifica del
rapporto indebitamento/equity. Infatti se l’impresa prima assume debito e poi finanzia
nuovi progetti senza gli utili mantenuti, allora il rapporto scende. Più esso si abbassa
più il rischio diminuisce, e più grande sarà il dono conferito ai creditori. Vi sarà un
trasferimento di ricchezza dagli azionisti ai portatori di debito. Così, come gli azionisti
preferiscono un aumento dei dividendi per evitare che la ricchezza sia trasferita ai
portatori di debito, così i debitori vogliono limitare i dividendi per evitare che gli
azionisti si avvantaggino, una volta che i tassi d’interesse sono stati fissati.
(Easterbrook (1982)).
La teoria di Jensen e Mackling regge sull’ipotesi di decisione singola di investimentofinanziamento. In un modello multiperiodale subentrerebbero dinamiche più
complesse, come ad esempio una questione di reputazione da parte del managerimprenditore. Il suo comportamento influirà negativamente sui termini con cui otterrà
capitale da risorse esterne nel futuro.
Chi spiega gli agency costs del debito con un modello multi periodale è Myers (1977).
Secondo l’autore quando l’azienda è già indebitata, un investimento aggiuntivo
finanziato con equity trasferirà valore dagli azionisti, che intraprendono l’investimento,
ai portatori di debito, che invece non contribuiscono all’investimento. Questo perché il
valore del debito esistente dipende dal valore dell’impresa e dall’incertezza
riguardante il valore futuro della impresa stessa. Ponendo che la volatilità sia uguale a
zero (la classe di rischio dell’impresa non è influenzata dalla decisione che si deve
prendere) la variazione del valore del debito, rispetto alla variazione del valore
dell’impresa, sarà sempre positiva a meno che non si tratti di debiti free-risk. Di
conseguenza si osserverà un trasferimento di valore verso i creditori; se l’investimento
abbassa la volatilità, si ha un trasferimento più alto; se invece l’investimento
incrementa la volatilità il trasferimento potrebbe anche essere negativo, come in
Jensen e Mackling, inducendo l’azienda ad investire anche in progetti a NPV negativo.
23
Si afferma quindi che l’esistenza di debiti rischiosi nel periodo t della scelta
indebolisce l’incentivo ad investire (anche in progetti a NPV positivo) e induce ad una
strategia d’investimento subottimale, riducendo il valore dell’impresa in tutti i periodi
prima di t.
Le asimmetrie informative non incidono solamente sul costo del finanziamento esterno
ma in alcuni casi anche sulla quantità di risorse disponibili. In tal caso si ha a che fare
con fenomeni di credit rationing. Un borrower è detto razionato quando non può
ottenere il prestito che desidera anche se cerca di pagare gli interessi che il creditore
richiede, essendo a volte disposto a pagare anche un interesse più alto.
Stiglitz e Weiss (1981) affermano che se un imprenditore non ottiene credito ed un
altro, indistinguibile dal primo per la banca, lo ottiene, allora sicuramente c’è
razionamento ed il fenomeno è rilevante per il benessere sociale. Gli autori, insieme
con altri economisti quali Russell (1976) e Keaton (1979), arrivano alla conclusione
che il credit rationing sia un fenomeno di equilibrio guidato dalle asimmetrie
informative tra debitori e creditori. Queste, attraverso i fenomeni di selezione avversa
e di azzardo morale, spiegano perché un creditore non voglia alzare i tassi d’interesse
anche se il debitore è disposto a pagare tassi più alti, e perché i mercati sono in
equilibrio nelle quantità (limiti nel credito) così come nei prezzi (tassi d’interesse).
Il tasso d’interesse svolgerà una duplice funzione: avrà un ruolo d’incentivo (azzardo
morale) ed un ruolo selettivo (selezione avversa). Nel primo caso un incremento del
tasso d’interesse indurrà gli imprenditori a scegliere i progetti più rischiosi e di
conseguenza più profittevoli (ovviamente in caso di successo), sacrificando il profitto
atteso 10 . Si avrà selezione avversa quando, in una situazione in cui i creditori non
possono distinguere tra debitori buoni o cattivi, un più alto tasso d’interesse attrarrà
debitori di bassa qualità. I creditori di conseguenza vorranno mantenere bassi i tassi
d’interesse per ottenere un campione migliore di debitori.
10
L’assunzione di base è che i creditori non conoscono la rischiosità del progetto.
24
1.4.1 Costi di agenzia dell’equity
In Jensen e Mackling (1976), il proprietario-manager può entrare in conflitto con i
nuovi azionisti esterni, operando in modo tale da massimizzare la sua utilità. Per
ottenere tale risultato, egli trova un mix ottimale di benefici pecuniari e non pecuniari
(questi ultimi sono i cosiddetti perks: uffici più grandi, migliori assicurazioni, maggior
prestigio e segni del potere in genere) che si ha quando l’utilità marginale che deriva
da un dollaro addizionale di spesa è uguale per ogni voce non monetaria ed allo stesso
tempo uguale all’utilità marginale di un dollaro addizionale di potere d’acquisto dopo
il pagamento delle tasse.
Se il proprietario-manager vende titoli di equity identici a quelli da egli stesso
posseduti (suddivisi proporzionalmente in base ai profitti dell’azienda e aventi
responsabilità limitata), i costi di agenzia saranno generati da una divergenza tra i suoi
interessi e quelli degli azionisti esterni. Questo perché il manager sopporterà solo una
frazione dei costi dei benefici non monetari ma ne riceverà tutti i benefici collegati.
Egli riceverà i benefici totali di questi costi attesi finchè il mercato dell’equity
anticiperà questi effetti. Gli azionisti futuri capiranno che gli interessi dei manager si
discosteranno dai loro; per cui il prezzo (ridotto) che loro pagheranno per le azioni
rifletterà i costi di monitoraggio e gli effetti della divergenza di interessi.
Myers e Majluf (1984) sviluppano un modello in cui i managers agiscono
nell’interesse degli azionisti, in particolare di quelli vecchi. Essi teorizzano che il
fenomeno di selezione avversa può tenere conto della reazione negativa del prezzo
delle azioni associata all’offerta di equity. Tale reazione negativa non è un fenomeno
ovvio. Infatti gli investitori possono capire da un annuncio di offerta di un titolo
stagionato che l’impresa stia per intraprendere opportunità d’investimento nuove ed
attraenti. Una spiegazione logica deriva dal fatto che l’emissione può essere motivata
dal desiderio di partire con assets sopravvalutati. Il manager, infatti, che possiede tutte
25
le informazioni, e che quindi è a conoscenza del fatto che gli assets dell’impresa sono
sottovalutati dal mercato, è riluttante ad emettere azioni in condizioni che potrebbero
essere favorevoli ai nuovi investitori e potrebbe, per difendere gli interessi dei vecchi
azionisti, preferire abbandonare un’opportunità d’investimento profittevole. Gli
investitori interpreteranno l’emissione di azioni come un bad signal, un segnale
negativo riguardo la profittabilità dell’azienda11.
Myers e Majluf trovano che i costi di agenzia dell’equity sono superiori a quelli del
debito. Tale ipotesi è alla base della Pecking Order Theory, secondo la quale l’impresa
preferisce utilizzare i fondi interni (equity iniziale ed utili non distribuiti) per
finanziare i propri investimenti. Se questi sono insufficienti ed è richiesta una forma di
finanziamento esterna, l’impresa prima contrarrà debiti, che sono i titoli più sicuri, poi
emetterà titoli ibridi, come ad esempio le obbligazioni convertibili, ed infine, come
ultima risorsa, si affiderà all’emissione di equity. L’idea che sta alla base è che né i le
fonti interne né i debiti default-free soffrono di asimmetrie informative generalmente
associate alle altre fonti esterne. Per questo l’equity interno è anche chiamato equity
informato. Quando le fonti interne non bastano, l’impresa cercherà di emettere titoli a
bassa intensità di informazione, ossia quei titoli la cui valutazione è meno contaminata
dalle asimmetrie informative.
La gerarchia delle fonti di finanziamento tuttavia non viene sempre rispettata perché
l’informazione asimmetrica non è l’unica forza al lavoro, ma ve ne sono altre che
influenzano le scelte delle imprese. Ad esempio sempre Myers e Majluf introducono la
Pecking Order Theory modificata, che tiene conto dei costi di dissesto finanziario
(oltre che delle asimmetrie informative). Tale modifica permette al finanziamento di
equity di avere un ruolo più importante e significativo. Le imprese possono emettere
equity al posto del debito per mantenere sia assets liquidi che capacità di debito per
futuri investimenti, evitando quindi potenziali problemi di sottoinvestimento ed
Un ragionamento simile si applica al riacquisto di azioni. I segnali sono molteplici: a) l’intenzione del
management di non impegnarsi in acquisizioni o altre spese inutili; b) il fatto che l’azienda non avrà bisogno di
cash per coprire spese future; c) l’assenza di nuove opportunità d’investimento.
11
26
abbassando i costi attesi di bancarotta.(in linea con il motivo precauzionale). In questo
caso l’annuncio di emissioni di azioni non sarebbe affatto una cattiva notizia.
Anche le imprese ad alta tecnologia e ad alta crescita sono credibili emittenti di azioni.
Le attività di queste imprese sono per lo più immateriali, ed il fallimento o il dissesto
sarebbero particolarmente costosi. L’unico modo per crescere e per mantenere un
livello d’indebitamento prudente è emettere azioni.
In effetti le cose sono più complicate rispetto a quanto affermato nel modello della
Pecking Order Theory. Ad esempio l’equity accumulato dai precedenti progetti sarà
sicuramente privo di asimmetrie informative, ma invece gli utili non distribuiti sono
endogeni; il management può avere la necessità di dover convincere gli azionisti a non
distribuire grandi dividendi e a mantenere cash in azienda per reinvestirlo. Gli azionisti
si allineeranno alle raccomandazioni dei manager se avranno fiducia nella profittabilità
scaturente dalla reintroduzione di cash in azienda e dal conseguente reinvestimento.
Per questo motivo la finanza interna non è libera dalle asimmetrie informative. Inoltre
cosa costituisce un finanziamento a bassa intensità di informazione dipende dalle
informazioni che sono in possesso dell’emittente, per cui non si può sempre associare
un finanziamento a bassa intensità di informazione con il debito.
1.4.2 E la liquidità?
In questo quadro la liquidità svolge un ruolo importante. In Jensen e Meckling si
intravede il “dark side” della liquidità che, come vedremo, verrà fuori nei lavori di
Jensen (1986) e Myers e Rajan (1998). Infatti un buon livello di assets liquidi accentua
il problema dell’assets sobstitution da parte dei portatori di equity, . In Myers (1977),
invece, mantenere un alto livello di liquidità riduce la probabilità di dissesto
finanziario, e quindi riduce gli agency costs associati con l’incentivo da parte dei
proprietari al sottoinvestimento.
27
Complessivamente si può notare però che i costi di agenzia del debito, quelli
dell’equity ed il razionamento del credito hanno conseguenze simili che li accomunano,
cioè quelle di portare in ogni caso ad un problema di sottoinvestimento. Il capitale
esterno (nella forma di debito o azioni) viene a costare troppo o (nel caso del credit
rationing) può non essere disponibile. Una buona scorta di liquidità permette di essere
indipendenti dalle fonti più costose di finanziamento e soprattutto di non dover
rinunciare ad investimenti profittevoli.
In letteratura, come si è già detto, si parla di costrizioni finanziarie (“financial
constraints”) che appaiono a causa di imperfezioni dei mercati dei capitali. In tali
mercati il finanziamento esterno non è perfetto sostituto di quello interno e si assiste ad
un “wedge” tra fonti interne ed esterne relativamente al loro costo. A questi vincoli
finanziari è associato il motivo precauzionale della liquidità descritto da Keynes
(1936).
1.5 Investment cash flow sensitivity e cash flow sensitivity of cash
1.5.1. Investment cash flow sensitivity
Il capostipite della letteratura sui financial constraints può essere considerato il lavoro
di Fazzari Hubbard e Petersen del 1988.
In realtà precedenti studi economici avevano già suggerito che le costrizioni
finanziarie tra le imprese erano importanti determinanti degli investimenti aggregati.
Meyer e Kuh (1957) osservano che le considerazioni sulla liquidità interna e la forte
preferenza per le finanze interne sono i primi fattori nel determinare il volume
d’investimento12.
12
John Meyer e Edwin Kuh, The investment decision: an empirical study (Cambridge, Massachussetts: Harvard
University Press, 1957).
28
Fazzari Hubbard e Petersen (1988) studiando la sensibilità dell’investimento al cash
flow cercano di testare la presenza di vincoli finanziari, mostrando come la
disponibilità di fonti finanziare svolge un ruolo importante nelle decisioni reali
d’investimento. Gli autori esaminano l’importanza della gerarchia di finanziamento
creata dalle imperfezioni del mercato dei capitali, in linea con l’argomento della
selezione avversa di Myers e Majluf (1984). L’esistenza di questo premio, legato alle
imperfezioni del mercato dei capitali, fa aumentare il differenziale di costo tra le
finanze interne ed il nuovo equity, e, di conseguenza, aumenta la probabilità che
l’impresa si trovi nel punto di discontinuità dove tutti i profitti sono trattenuti, non si
pagano dividendi e le prospettive future dell’impresa non sono così buone da indurla
ad emettere nuove azioni.
I fondi interni quindi assumono importanza per poter finanziare l’investimento: tale
concetto è sottolineato da una significatività positiva nell’equazione di investimento.
Infatti, qualora l’impresa dovesse riconoscere un premio rilevante per l’ottenimento di
capitale di mercato, senz’altro cercherà di aumentare la sua capacità di generare cassa
e le sue decisioni reali saranno maggiormente sensibili al cash flow disponibile.
Gli autori, utilizzando un campione di 421 imprese americane appartenenti al settore
manifatturiero, stimano un’equazione d’investimento utilizzando il valore del “Q” di
Tobin 13 e aggiungendo, come termine che rappresenta la variabile finanziaria, il
rapporto cash flow/capitale.
Il lavoro di Fazzari, Hubbard e Petersen porta ad un dibattito ancora irrisolto sul tema
della sensibilità dell’investimento al cash flow. Numerosi sono stati gli studi successivi
che hanno confermato i loro risultati così come numerose sono state le critiche
ricevute, a partire dall’articolo di Kaplan e Zingales del 1997.
13
Aggiustato in considerazione delle tasse a livello corporate e a livello personale. Per un approfondimento sul
significato economico del Q di Tobin si veda il capitolo successivo.
29
Kaplan e Zingales di fatto confutano l’ipotesi fondamentale di Fazzari, Hubbard e
Petersen (1988), che vi sia una relazione monotona positiva (monotonicity hypothesis)
fra la severità dei vincoli finanziari e la sensibilità dell’investimento al flusso di cassa.
Kaplan e Zingales, pur constatando la relazione positiva tra investimenti e cash flow,
spiegata dall’evidente maggiore onerosità del capitale di terzi rispetto alle risorse
prodotte internamente, dimostrano che non necessariamente l’intensità della risposta
degli investimenti alla disponibilità di cash flow aumenta all’aumentare del grado di
costrizione finanziaria. Le loro affermazioni sono sostenute attraverso un modello
teorico (uniperiodale) che evidenzia come gli investimenti siano legati positivamente
alla disponibilità di risorse interne, giustificabile dal fatto che l’accesso ai fondi esterni
comporta almeno costi di transazione, ma anche come la sensibilità dell’investimento
al flusso di cassa aumenti all’aumentare dei fondi interni, ovvero al ridursi del vincolo
finanziario.
La replica di Fazzari, Hubbard e Petersen (2000) non tarda ad arrivare. Questi
criticano l’uso dei criteri quantitativi utilizzati da Kaplan e Zingales per la
classificazione delle imprese: stocks di liquidità, linee di credito inutilizzate ed
indebitamento. Le imprese potrebbero infatti avere un basso indebitamento
semplicemente perché non riescono a convincere i creditori a concedere loro ulteriore
finanza, probabilmente per la scarsa disponibilità di garanzie, e pertanto anche imprese
con un basso leverage potrebbero sottostare a notevoli vincoli finanziari. Allo stesso
modo, la presenza di riserve di liquidità non permette di escludere la presenza di
vincoli finanziari. Infatti in caso di una forbice maggiore tra costi del finanziamento
interno ed esterno (maggiori vincoli finanziari), ci potrebbe essere un maggiore
incentivo ad accumulare liquidità o conservare sufficiente capacità di debito al fine di
preservare la possibilità di cogliere le opportunità future di crescita.
Ultimo atto del dibattito è il commento di Kaplan e Zingales del 2000, che, in modo
decisamente provocatorio evidenziano come, in effetti, i risultati di Fazzari, Hubbard e
Petersen (2000) non facciano altro che confermare più che confutare la loro tesi:
30
un’alta sensibilità dell’investimento al cash flow non può essere interpretata come un
segnale di elevata costrizione finanziaria. Inoltre gli autori rispondono alla critica sulle
riserve di liquidità riportando l’esempio della Microsoft, che secondo loro non può
essere classificata come impresa financially constrained14.
In definitiva, Kaplan e Zingales (1997) trovano una relazione non monotona tra cash
flow ed investimento, ma non specificano che tipo di relazione sia.
A questo proposito studi successivi, come quelli di Almeida (1999) e Povel e Raith
(2001), mostrano come la relazione tra fondi interni ed investimenti sia a forma di U
(U shaped), confermando così l’ipotesi di non monotonicità di Kaplan e Zingales.
Ipotesi ulteriormente rafforzate in modelli ancora più recenti che, utilizzando, a
differenza degli studi precedenti, dei modelli multiperiodali (biperiodali), analizzano la
relazione tra cash flow ed investimenti.
Myers (1984) e, più recentemente, Fama e French (2000), hanno notato che modelli
intertemporali possono avere importanti conseguenze sulla scelta della struttura del
capitale, nelle scelte di finanziamento, investimento e cash holdings. Le imprese
possono decidere di mantenere financial slack (definito come cash più capacità di
credito inutilizzata) se hanno opportunità d’investimento nel futuro che sono più
attraenti rispetto a quelle correnti. In altre parole, le imprese, dati i flussi di cassa
derivanti dai progetti correnti e le prospettive sui futuri investimenti, possono allocare
la loro liquidità intertemporalmente. In questo filone rientrano i lavori di Boyle e
Guhtrie (2001), Dasgupta e Sengupta (2001), Lyandres (2007).
La principale conseguenza di questi lavori è che una sensibilità più alta non può essere
interpretata come evidenza della presenza di vincoli finanziari: anche imprese in buona
salute finanziaria possono fare affidamento sulle risorse interne di finanziamento a
14
Kaplan e Zingales mostrano, come secondo i criteri di Fazzari, Hubbard e Petersen del 1988 (nessun payout
agli azionisti) e del 2000 (enormi stock di liquidità), la Microsoft sarebbe dovuta essere classificata come
azienda financially constrained, ipotesi rafforzata dai risultati positivi della sensibilità dell’investimento al cash
flow. Tuttavia Kaplan e Zingales trovano implausibile considerare imprese come la Microsoft (vedi anche la
Hewlett-Packard) come imprese costrette finanziariamente. Infatti, secondo i loro criteri, la Microsoft non è
considerata financially constrained.
31
causa di fattori non collegati solo alla mancanza di disponibilità di finanziamenti
esterni ma anche alle prospettive di investimento future, esibendo quindi un’alta
sensibilità dell’investimento al cash flow.
1.5.1 Cash flow sensitivity of cash
Queste conclusioni spingono alcuni autori a cercare una via alternativa per testare la
presenza di vincoli finanziari. In questo senso Almeida, Campello e Weisbach (2004)
sviluppano un modello teoretico che collega i vincoli finanziari con la domanda di
liquidità dell’impresa. In particolare Almeida, Campello e Weisbach affermano che le
costrizioni finanziarie creano una domanda di liquidità, che quindi nasce perché la
liquidità rappresenta un mezzo per assicurare all’impresa la possibilità d’investire in
un mercato dei capitali imperfetto. Il loro modello formalizza le intuizioni di Keynes15.
In esso un’impresa il cui accesso al mercato dei capitali è limitato dalla natura dei
propri assets, può venire a conoscenza con anticipo del fatto che affronterà costrizioni
finanziarie quando dovrà intraprendere progetti d’investimento nel futuro. Il cash
holding assume valore perché fa aumentare le probabilità che l’azienda sarà capace di
finanziare questi investimenti. Lo studio di Almeida, Campello e Weisbach suggerisce
che i vincoli finanziari potrebbero essere collegati alla propensione dell’impresa ad
accantonare cash dai nuovi flussi di cash flow (la cosiddetta cash flow sensitivity of
cash). Partendo da Almeida, Campello e Waisbach (2004) i lavori basati sulla
variazione di cash in risposta a nuovi cash flow (vedi Han e Qiu (2006)) portano ad un
risultato quasi univoco, spiegando come la propensione all’accumulo di risorse liquide
15
Keynes (1936) affermava che il principale vantaggio della liquidità è che essa permette alle imprese di
intraprendere progetti d’investimento di valore quando essi sorgono e sono disponibili. Tuttavia lo stesso autore
affermava come l’importanza dell’accumulo di liquidità fosse influenzata dalla misura con cui l’impresa aveva
accesso al mercato esterno dei capitali. Se un’impresa ha un accesso senza restrizioni al mercato dei capitali,
allora la liquidità aziendale non ha rilevanza; se invece l’impresa fronteggia frizioni finanziarie la gestione della
liquidità diviene un problema chiave per le politiche a livello corporate.
32
da parte delle aziende derivi da un atteggiamento prudente di queste verso il futuro. Il
motivo precauzionale può essere evidenziato solo se si utilizza un modello teoretico
dinamico, in cui le costrizioni finanziarie che agiscono sulle imprese creano un tradeoff intertemporale tra investimenti correnti e futuri. Grazie alla possibilità di allocare
intertemporalmente la liquidità l’impresa può decidere se portare tale liquidità in stati
futuri in cui vi potrebbe essere il rischio di incontrare vincoli finanziari. In questo
modo si abbassa il rischio che l’impresa non possa essere in grado di intraprendere
progetti nel futuro.
Han e Qiu (2006) propongono un modello molto simile a quello di Almeida, Weisbach
e Campello (2004). L’unica differenza riguarda la possibilità di coprire i guadagni con
strumenti adeguati di copertura. Mentre in Almeida, Campelo e Weisbach è possibile
coprirsi ad un prezzo equo, in Han e Qiu non vi è un mercato esterno perfetto per
coprirsi, lasciando come unica opzione l’investimento in cash ed equivalenti.
Han e Qiu (2006) partono dal modello di Almeida, Campello e Weisbach (2004) e
affermano che, laddove non vi sia la possibilità di coprire totalmente dall’esterno la
rischiosità del cash flow, l’impresa costretta finanziariamente (quelle unconstrained
non hanno lo stesso una politica di cash holdings) tratterrà più denaro di quanto lo
faccia un’impresa constrained del modello di Almeida, Campello e Weisbach, che in
questo modo sottostima il cash holdings ottimale di un’impresa costretta. Questo cash
holdings aggiuntivo rappresenta il vero e proprio motivo precauzionale che sta dietro
le scelte delle aziende con vincoli finanziari..
Altri autori apportano differenze al modello di Almeida, Weisbach e Campello, e, non
come in Han e Qiu, arrivano a conclusioni in alcuni casi contrastanti da quelle di
Almeida, Weisbach e Campello. Infatti, vi è la possibilità di assistere ad una sensibilità
dell’investimento in cash alla variazione di cash flow negativa, un risultato opposto a
quello ottenuto precedentemente in letteratura.
Gli stessi Almeida, Campello e Weisbach in uno studio successivo del 2007
migliorano il modello teorico alla base della cash flow sensitivity of cash.
33
La differenza fondamentale rispetto al precedente modello è che l’impresa può anche
utilizzare l’investimento reale per gestire la liquidità intertemporalmente. Prima il cash
è assunto essere l’unico modo con cui l’impresa può trasferire fondi nel tempo, motivo
per cui gli autori ottengono sempre una sensibilità del cash al cash flow positiva per le
imprese costrette finanziariamente. Nel modello più recente, invece, gli autori
mostrano che in presenza di un investimento liquido alternativo, meno liquido e più
rischioso del cash, la sensibilità può essere negativa.
Il loro modello funziona in questo modo: un aumento del cash flow corrente porta ad
una riduzione dei financial constraints sia correnti che futuri. In questo modo l’azienda
può investire maggiormente in investimenti meno liquidi, più rischiosi. L’incremento
di tali investimenti fa aumentare la domanda corrente di finanziamento esterno, con la
conseguente diminuzione dell’investimento in cash holdings. Questo è il caso che può
portare ad una diminuzione della propensione all’accantonamento di cash dal cash
flow. Rimane la possibilità di trovare una sensibilità positiva poiché l’aumento del
cash flow corrente porta direttamente ad una diminuzione dei financial constraints
correnti. Se questo effetto è forte abbastanza, la sensibilità è positiva.
Tuttavia, in altri studi emergono altri fattori che possono influire sulla positività o
negatività della sensibilità del cash al cash flow. Infatti il cash flow corrente può essere
correlato non solo ai financial constraints, ma anche ai cash flow futuri oppure alle
opportunità d’investimento future.
Ad esempio, l’analisi teorica di Riddick e Whited (2007) si differenzia da quella di
Almeida, Campello e Weisbach (2004) in quanto un incremento del cash flow è
accompagnato da un incremento della produttività di capitale, per cui l’impresa
potrebbe avere l’incentivo a trasformare gli assets liquidi in assets fisici. Questo è ciò
che gli autori definiscono effetto sostituzione (in contrapposizione all’effetto ricavo,
che induce le imprese ad accantonare cash dal cash flow). Quando un’impresa subisce
shocks positivi dei ricavi, il suo cash flow aumenta. Se l’effetto degli shocks non è
troppo transitorio, ossia se gli shocks positivi sono serialmente correlati, la produttività
34
del capitale, sia corrente che futura, aumenta, e tale produttività convergerà ad un
valore medio molto lentamente. L’impresa quindi desidera investire maggiormente in
assets fissi, e per questo trasformerà alcuni dei suoi assets finanziari in asset fisici. Si
assiste ad una diminuzione della propensione dell’impresa all’investimento in cash.
Acharya, Almeida e Campello (2005) creano un modello teoretico nel quale il cash ed
il debito sono congiuntamente determinati all’interno di un problema intertemporale
d’investimento. L’impresa può migliorare le sue disponibilità liquide, o salvando fondi
interni disponibili in quel momento o contraendo ulteriori debiti, o, alternativamente,
l’impresa può salvare la sua capacità di credito usando i cash flow correnti per ridurre i
debiti esistenti o evitando di contrarre ulteriori debiti (i financial slacks di Myers e
Majluf).
Più alti stock di cash e una più alta capacità di debito incrementano la capacità di
finanziamento futura dell’impresa, e quindi l’abilità dell’impresa di intraprendere
nuovi progetti d’investimento. Il cash ed il debito non utilizzato possono essere
entrambi usati per trasferire risorse nel tempo. Gli autori tuttavia mostrano che questi
fondi possono non essere equivalenti quando c’è incertezza riguardo il cash flow
futuro e le future opportunità d’investimento. Il ragionamento è questo: si consideri
un’impresa che contrae debiti rischiosi contro cash flow futuri. Siccome i cash flow
sono incerti, il valore corrente del debito sarà largamente supportato da stati futuri del
mondo nei quali i cash flow sono alti. Contraendo debiti rischiosi oggi l’impresa
trasferisce valore dagli stati futuri con alti cash flow al presente. Successivamente,
mantenendo in azienda la somma derivante dall’emissione del debito, l’impresa
colloca fondi in tutti gli stati futuri, includendo quelli in cui i cash flow ed i valori del
debito sono bassi. In altre parole, contrarre debiti rischiosi e trattenere il ricavato nelle
riserve di cash, significa trasferire risorse da stati futuri con alti cash flow a stati futuri
con bassi cash flow. Ovviamente il ragionamento vale non per i debiti revocabili, ma
per finanziamenti a medio lungo termine.
35
A questo proposito Ferrando e Pal (2006) trovano che solo per le imprese
unconstrained, che sono capaci di ottenere debiti finanziari, i risparmi di cash sono
usati per l’allocazione intertemporale di risorse sia interne che esterne. Le imprese
possono decidere di allocare il debito di lungo termine ottenuto nel tempo e non
investire l’intero ammontare disponibile nel primo anno. Inoltre, un incremento del
leverage dell’impresa risulta in un incremento della liquidità per soddisfare i più alti
interessi e il pagamento del debito nel futuro. Per Acharya Almeida e Weisbach
solamente le imprese soggette a vincoli finanziari, preferiranno accantonare cash
(piuttosto che ridurre i debiti) se le opportunità d’investimento tendono ad arrivare in
stati di cash flow bassi.
In pratica la loro propensione a ridurre il debito e ad
incrementare il cash è fortemente influenzata dalla correlazione tra i loro cash flow e le
loro opportunità d’investimento. Quando tale relazione è bassa (ossia quando esse
hanno un’alta necessità di hedging), le imprese preferiranno mantenere cash dal cash
flow. Altrimenti, quando la relazione è forte (e vi è una bassa necessità di hedging), le
aziende sceglieranno di utilizzare il cash flow in eccesso per ridurre i debiti, mostrando
una bassa sensibilità del cash al cash flow, e di conseguenza comportandosi come
imprese che non affrontano alcun tipo di vincoli finanziari.
Si capisce come, potendo utilizzare politiche finanziarie standard come il cash ed il
debito per trasferire risorse attraverso stati futuri del mondo, il debito ed in particolare
il cash, possono essere utilizzati come strumenti di hedging, suggerendo la possibilità
per l’azienda di coprirsi senza usare direttamente gli strumenti derivati. Anche Arslan,
Florackis e Ozkan (2006) si soffermano sul ruolo del cash holdings come strumento di
copertura dalle variazioni del cash flow e dai financing constraints, che restringono
l’abilità dell’impresa di intraprendere profittevoli opportunità d’investimento. Quando
un’impresa cerca di coprire i suoi cash flow, lo fa essenzialmente facendo una serie di
investimenti che alterano la distribuzione dei cash flow. Froot Scharfstein e Stein
(1993) mostrano che una delle ragioni per cui l’impresa si copre è quella di meglio
allineare i suoi cash flow con le opportunità d’investimento, e per minimizzare i
36
deadweight costs associati con bisogni futuri di copertura. Questi focalizzano
l’attenzione sull’uso delle opzioni e dei derivati finanziari, perché un contratto derivato
può essere pensato come un investimento a zero NPV che trasferisce fondi in stati
futuri del mondo. Invece, nonostante la distorsione dell’investimento possa avere un
costo reale per l’impresa, l’efficacia dei derivati può essere ostacolata dalla difficoltà
di sicurizzazione dei cash flow che non sono presenti su variabili facilmente
verificabili, come i prezzi delle merci (commodities) ed i tassi di cambio delle valute.
Questo spiega il perché le imprese possono utilizzare strumenti alternativi di copertura
che includono strategie finanziarie ed operative (vedi Petersen e Thiagarajan (2000)), e
perché la letteratura abbia fatto sforzi enormi per trovare evidenza sul legame tra
l’hedging ed i vincoli finanziari.
Han e Qiu (2006) dimostrano che il cash holdings e l’hedging esterno (quello con
strumenti derivati, quali options e futures) possono essere visti come sostituti.
L’hedging esterno permette ad un’impresa di poter trasferire risorse da uno stato del
mondo buono ad uno stato cattivo per ridurre la volatilità dei cash flow futuri. Il cash
holdings, invece, incrementa il livello futuro di cash dello stesso ammontare in ogni
stato del mondo futuro,
1.6 Benefici privati del controllo
La letteratura sui financial constraints ci mostra il lato positivo della liquidità, quello
prospettato in primis da Keynes nel 1936. La teoria del motivo precauzionale di
Keynes tuttavia non sembra poter bastare per spiegare cosa ci sia alla base della scelta
di detenere liquidità. Tale scelta è endogena, in quanto espressa dal management o da
chi comunque detiene il controllo, e, come tale, si pensa possa essere influenzata dalle
distorsioni derivanti dalle asimmetrie informative e dalla teoria degli agency. Lo stesso
Myers, il padre (insieme con Majluf), della Pecking Order Theory, è autore di uno
37
studio intitolato “The paradox of liquidity”, che mostra le due facce della medaglia
della liquidità. Egli, in un paper successivo del 2000, spiega che “o troppo presto o
troppo tardi, la teoria della finanza d’azienda deve generalmente occuparsi
dell’interesse privato dei manager…”.
Il raggiungimento dell’interesse privato del manager/agente, visto come la
massimizzazione della sua funzione di utilità, è chiaramente facilitato dal fatto che
questi possiede sempre un vantaggio di informazione riguardo le risorse aziendali
rispetto ai principali. Grossman e Hart (1988) distinguono tra private benefit e security
benefit. I primi sono i benefici che il management attuale o acquirenti futuri di
posizioni di controllo ottengono per loro stessi, ma che la restante parte di investitori
non ottengono. I security benefit si riferiscono al valore di mercato totale dei titoli
dell’impresa. Essi osservano come l’allocazione dei diritti di voto influenza se il
controllo resterà nelle mani della parte che beneficerà di alti benefici privati, o al
contrario nelle mani di chi beneficerà del secondo tipo di benefici.
I benefici privati assumono diverse forme; alcuni li identificano come il valore
psicologico che si attribuisce alla posizione di potere (Harris e Raviv (1988)). Sebbene
questo possa essere un fattore in alcuni casi, è difficile giustificare premi di milioni di
dollari con il puro piacere del comando. Infatti si assiste ad abusi veri e propri ai danni
degli azionisti che non possiedono il controllo mediante pratiche quali, per citarne una,
il self dealing con il quale chi controlla trasferisce dei beni dalla società pubblica che
dirige ad una privata di cui è interamente proprietario.
Qui interessa il legame con la liquidità degli assets che, come spiegano Myers e Rajan
(1998), a causa del rischio di trasformazione, fa aumentare la probabilità di agency
problems. Il punto essenziale del loro lavoro è che una più alta liquidità degli assets
permette di trasformare gli assets così come di alterare la distribuzione dei diritti di
proprietà impliciti a loro favore. Huberman (1984) sostiene che la liquidità di un asset
è collegata alla reversibilità dell’investimento in tale asset. Perciò chi ha il controllo
delle risorse può utilizzare più facilmente e meno visibilmente gli assets più liquidi per
38
ottenere i propri interessi a discapito dei possessori. Anderson e Caverhill (2005) nel
loro modello di corporate liquidity tengono conto di questo ulteriore costo nel detenere
riserve liquide all’interno delle aziende. Infatti queste guadagnano un tasso di ritorno
interno (rin) che sarà minore del tasso fre risk (r) guadagnato sui fondi esterni. La
differenza tra rin e r rifletterà l’azzardo morale di chi detiene il controllo delle risorse.
Gli azionisti di minoranza riconosceranno che gli amministratori cercheranno di
trasformare le riserve liquide per ottenere benefici privati, e ciò si manifesterà con una
riduzione nel tasso al quale la riserva di cassa è assunta accumulare interessi. La
differenza r-rin rappresenta il costo dell’estrazione di rendite da parte di chi controlla
attraverso varie forme di moral hazard.
Il rischio di trasformazione di Myers e Rajan (1998) è dovuto al fatto che:
Il manager-proprietario (più generalmente chi controlla di fatto le risorse)
può direttamente rubare l’asset e mantenerlo ed utilizzarlo altrove. Ci sono
molti modi per impossessarsene; per esempio vendendo ad un prezzo non
equo ad una collegata o ad un’affiliata (transfer pricing). Tali deviazioni dal
prezzo equo potrebbero sembrare leggere (per renderle difficili o impossibile
da provare in giudizio), ma se riferite ad un grande volume di scambio,
possono generare enormi benefici privati. Assets anonimi, facilmente
trasportabili come il cash sono più semplici da rubare di quanto possano
esserlo assets fissi quali equipaggiamenti oppure assets unici quali ad esempio
un quadro di un famoso maestro;
Il manager-proprietario può vendere l’asset e prendersi il cash, o
direttamente o nella forma di benefici o salari eccessivi;
Alcuni assets ritornano in cash nel ciclo ordinario dell’impresa. I managers
possono liquidare capitale circolante semplicemente non reinvestendo
l’ammontare giusto nelle scorte. Un reinvestimento troppo basso nelle scorte
è difficile da contrastare in un contratto, perché le scorte ottime dipendono
39
dalle vendite future, le quali a loro volta possono essere previste meglio dagli
insider che dagli outsider;
I manager-proprietari possono utilizzare assets liquidi usati per la generalità
delle operazioni in assets specifici che hanno un valore più basso senza i
managers. Così facendo i manager riducono la capacità e l’incentivo degli
investitori a minacciare la liquidazione, trasferendo valore lontano dagli
investitori esterni. La liquidità dell’asset iniziale facilita la sostituzione in
asset specifico;
Infine, il famoso risk shifting di Jensen e Meckling (1976). Il managerproprietario sostituisce assets più sicuri con assets più rischiosi, in modo da
trasferire valore a se stesso.
La liquidità facilita la possibilità di moral hazard da parte di chi detiene il controllo, sia
che essi siano manager che azionisti di maggioranza, in ogni punto sopracitato.
Occorre specificare chi, nella realtà, siano gli agenti e chi i principali. In qualsiasi caso
i principali sono gli azionisti di minoranza. L’identità degli agenti dipende dal contesto
in cui si studia il fenomeno aziendale. Nel sistema anglosassone l’agente è il manager,
che è in conflitto con gli azionisti di minoranza. Nel sistema Europeo e anche in quello
dei paesi asiatici in via di sviluppo, il conflitto è tra azionista di maggioranza e
azionista di minoranza.
1.6.1 Conflitto manager - azionista
Il modello di capitalismo anglosassone (presente per lo più in USA, ma anche in Gran
Bretagna) è caratterizzato dal superamento del capitalismo familiare per quanto
riguarda il sistema delle grandi imprese. La public company di stampo anglosassone è
il caso più estremo di separazione della proprietà dal controllo. Si assiste ad una
40
polverizzazione dell’azionariato che risulta essere sostanzialmente anonimo,
fortemente mobile e quasi sempre disinteressato alla gestione dell’impresa. Alla base
vi è un problema di free-riding, secondo cui l’azionista non ha un vantaggio nel
partecipare attivamente e monitorare il management. Egli infatti sopporterebbe tutti i
costi (elevati) di monitoraggio ma i benefici saranno divisi per tutti gli azionisti. (gli
azionisti esistono quasi solo quando combattono per la tutela dei propri diritti nel
momento in cui le imprese sono oggetto di compravendita o sono in pericolo di
esserlo).
Il conflitto risulta essere tra management, che detiene il controllo effettivo
dell’impresa, e gli azionisti (che rappresentano la minoranza). Le cause del conflitto
sono molteplici. La più immediata è che il manager è di per sé avverso al rischio
rispetto all’azionista. In proposito si può notare che ciò che gli amministratori
investono nell’azienda a livello di capitale umano trova la sua valorizzazione proprio
all’interno della stessa. Un azionista, invece, detiene semplicemente una quota della
proprietà, può liquidarla con estrema facilità e trovare un nuovo impiego al suo denaro.
Vi è dunque un diverso atteggiamento nei confronti del rischio, anche perché
l’azionista è sempre in grado di diversificare e ridurre l’impatto di una bancarotta
singola sul ritorno dell’intero portafoglio. A questo riguardo si nota come, mantenendo
costanti gli altri assets, un incremento della liquidità riduce i rischio di insolvenza ed
abbassa la varianza dei ritorni degli altri assets. Infatti, l’equity può essere visto come
un’opzione call (Jensen e Meckling 1976) scritta sugli assets dell’impresa, per cui una
diminuzione del rischio dell’impresa riduce il valore dell’equity. Mantenendo il debito
costante, l’incremento di liquidità riduce il rischio del debito ed induce un
trasferimento di ricchezza dagli stockholders ai bondholders.
Uno degli strumenti utilizzati per cercare di risolvere il conflitto manager-azionista è
rappresentato dai contratti ad incentivi. Questi servono per allineare gli interessi dei
manager a quelli degli azionisti; attraverso un maggiore “equity stake” essi avrebbero
un incentivo a migliorare il loro impegno nella massimizzazione del valore
41
dell’impresa. In questo caso è intuibile che il manager retribuito con un contratto
costituito solo da una base fissa tenderà ad incrementare il valore di mercato del suo
capitale umano, per cui minimizzerà il rischio, a parità delle altre condizioni,
attraverso un aumento di liquidità. Al contrario, se lo schema di compensazione
prevede bonus per il rischio e stock options, allora il manager sarà incentivato a
diminuire la liquidità interna facendo aumentare in tal modo il valore dell’equity.
Nella realtà però può accadere che le stock options non sono in grado di allineare gli
interessi di manager e azionisti, ma a volte fungono da incentivo per comportamenti
opportunistici di questi. I casi Enron, Tyco, Parmalat ci insegnano che attraverso la
manipolazione dei conti si possono incrementare i guadagni apparenti e/o lo stock
price, e quindi il valore della compensazione del manager.
Spesso gli amministratori possono mettere in atto strategie di entrenchment per
mantenere e rafforzare la loro posizione nell’azienda. Vi sono molte strategie in questo
senso. Una di queste è quella, accennata in Myers e Rajan (1998), per cui i managers
investono in linee di attività che li rendono indispensabili. Nell’analisi di Shleifer
Vishny (1989) i managers possono annullare i meccanismi di disciplina esercitati dal
mercato e dai proprietari facendo sì che la valutazione di se stessi cresca nel giudizio
degli azionisti e che un eventuale ricambio manageriale sia costoso da effettuare. Per
perseguire tali fini, la strategia da mettere in atto è quella di scegliere progetti di
investimento altamente specifici, che accrescano non solo la propria ricchezza, nel
caso in cui il manager abbia anche una quota proprietaria dell’impresa, ma soprattutto
generino un differenziale di profittabilità rispetto a quanto ottenibile con managers
alternativi. Tale differenziale, che rende altamente costoso il licenziamento dei top
executives in carica, costituisce il presupposto perché essi si approprino di una parte
significativa dei profitti delle imprese. La perdita per gli azionisti è doppia: si attuano
progetti di investimento non necessariamente volti alla massimizzazione dello
shareholder value (perdita exante ed inefficienza allocativa), e si opera un
42
trasferimento, a favore dei manager, delle quasi rendite generate da tali investimenti
(perdita ex-post nella fase distributiva).
Jensen (1986) introduce un’altra causa di conflitto tra manager-azionisti. Egli espone
la “free cash flow theory” 16 , secondo la quale la maggiore fonte di conflitto tra
manager e azionisti è data dal pay-out da distribuire agli azionisti. Questo pay-out
riduce le risorse sotto il controllo del manager, riducendo quindi il suo potere, ed
aumentando le possibilità di incorrere nel monitoraggio del mercato dei capitali che
avviene quando l’impresa deve ottenere nuovo capitale. Finanziando con
risorse
interne i progetti il manager evita la disciplina del mercato e la possibilità di trovarsi in
situazioni in cui il finanziamento non sia disponibile o che lo sia ma a costi proibitivi.
Il manager è incentivato a far crescere l’azienda oltre il livello ottimale. Questo perché
la crescita fa aumentare il potere del manager, poiché avrà più risorse sotto il suo
controllo. Ciò è anche associato ad incrementi nel suo compenso visto che variazioni
nel compenso sono correlate positivamente alla crescita delle vendite (Murphy 1985).
Il problema del free-cash flow è più acuto per le imprese più affermate. Queste
affrontano una concorrenza limitata grazie alle dimensioni ed ai successi passati.
Inoltre generano un forte flusso di cassa e, con poche prospettive d’investimento
valide, non necessitano di finanziamenti. Si assiste in queste imprese ad una quantità
di valore impressionante che viene distrutta, considerando le risorse di cui dispongono
normalmente queste aziende.
Un esempio di spreco di risorse è dato da un famoso studio di Blanchard, Lopez de
Silanes e Shleifer (1997) che mostrano come si comportano le imprese (i suoi manager)
quando ricevono quello che per le aziende equivale alla manna dal cielo, cioè quando
vincono una causa la cui sentenza dispone il pagamento di una somma al vincitore
senza ulteriori effetti sulle possibilità dell’azienda. Si può facilmente sostenere che
16
Il free cash flow è il cash flow in eccesso rispetto a quello richiesto per finanziare tutti i progetti
d’investimento a NPV positivo.
43
per gli azionisti sarebbe stato meglio se i manager non avessero mai ottenuto quei soldi,
tanto è lo spreco e la distruzione di valore dell’azionista.
Si nota come la teoria di Jensen è all’opposto di quella di Myers e Majluf. Nel primo
caso il manager si affida maggiormente alle fonti interne nella misura in cui esse
permettono l’accumulo di cash. I manager hanno la discrezione sulla liquidità in
eccesso per i propri interessi e benefici personali; in tal modo l’investimento in cash
determina un incremento del costo delle finanze esterne ed effetti negativi sul valore
dell’impresa. Nel caso di Myers e Majluf il free cash fow è usato per costruire liquidità
e capacità di debito (financial slack) utili per intraprendere future opportunità
d’investimento. In questo caso l’investimento in cash è visto come un progetto a NPV
positivo.
Anche il debito ha effetti diversi a seconda delle teorie. In Myers e Majluf le imprese
maggiormente indebitate subiranno maggiormente l’impatto dei vincoli finanziari; in
Jensen (1986, 1988) il ricorso al debito sarà lo strumento per disciplinare il manager e
per allineare i suoi interessi a quelli degli azionisti. Myers (2000) sostiene che i
leverage buy out sono nati come un tentativo per risolvere il problema del free cash
flow di Jensen. Questi sono stati vere e proprie terapie di shock per tagliare gli
investimenti inefficienti, per forzare la vendita di assets sottoutilizzati, e più
generalmente
per
rafforzare
l’incentivazione
del
management
(attraverso
partecipazioni significative al capitale dell’impresa) per massimizzare il valore degli
investitori. Il ruolo del leverage fondamentalmente è quello di spingere i manager a
generare e pagare fuori,agli investitori, contante17.
L’esempio classico studiato in letteratura è il caso RJR Nabisco. Vi erano spese in lussi aziendali e progetti
d’investimento discutibili, basti pensare alla flotta aerea che ad un certo punto comprendeva 10 jet)
17
44
1.6.2 Costi di agenzia azionisti di maggioranza - azionisti di minoranza
Molti motivi che portano il manager a non agire nell’interesse dell’impresa (proprietari)
trovano la loro fondatezza nel sistema di proprietà e controllo vigente nei paesi
anglosassoni. Questo si caratterizza, come già detto, per una netta separazione tra
proprietà e controllo (arm’s lenght) ed un orientamento agli outsiders. La maggior
parte delle imprese sono quotate in borsa e solo in una minoranza di queste un
azionista è in grado di esercitare un’influenza privilegiata.
In Europa continentale (ed in molte economie asiatiche orientate al mercato) la
corporate governance è organizzata su una base di orientamenti al controllo ed agli
insiders. Le imprese quotate sui mercati azionari tendono ad avere azionisti che
compongono i cosiddetti nuclei di controllo e che sorvegliano molto da vicino le
attività aziendali. In questi paesi le imprese quotate manifestano una maggiore
concentrazione della proprietà rispetto alle imprese dei paesi anglosassoni.
Proprio la concentrazione proprietaria è considerata come uno dei principali strumenti
per un migliore monitoraggio dei manager che detengono l’effettivo controllo. Per
esempio l’ownership manageriale (che si ottiene anche attraverso stock options e stock
bonus) serve ad allineare meglio l’interesse dei manager a quelli dell’azionista. O
anche una proprietà maggiormente concentrata al di fuori del management riduce il
classico problema di free-riding dell’azionista americano. Infatti un investitore che
possiede una sostanziale frazione di diritti di cash flow ha un maggiore incentivo ad
incorrere in quei costi che vincolano la discrezionalità dei manager, mitigando così i
costi di agenzia.
In USA e in Gran Bretagna è emerso un particolare meccanismo per concentrare la
proprietà, chiamato takeover ostile (insieme con i leverage buy out costituiscono
quello che viene chiamato market for corporate control) (vedi Jensen e Rubback 1983,
Easterbrook e Fischel (1991)). Jensen (1986,1988) sottolinea come i takeovers
possano risolvere il problema del free cash flow, perché portano ad una distribuzione
45
dei profitti dell’impresa agli investitori. Easterbrook e Fischel (1991) reputano la
scalata ostile come un meccanismo critico di corporate governance, senza il quale la
discrezionalità manageriale non può essere controllata. Il takeover ha due effetti
principali: riduce il grado di radicamento del management (quando la scalata avviene il
manager perde il proprio lavoro) e arricchisce gli azionisti di minoranza, che vendono
le azioni ad un prezzo maggiorato.
La contestabilità del controllo e la concentrazione della proprietà sono i due principali
meccanismi per mitigare i conflitti tra insider e azionisti di minoranza nel modello
capitalistico anglosassone. Può sembrare ideale utilizzare entrambi i meccanismi come
strumento di disciplina. Ma nella misura in cui i voti sono legati ai diritti di cash flow,
i due meccanismi sono inversamente correlati: più azioni danno all’insider più diritti di
cash flow (maggiore allineamento) ma anche più voti (maggiore entrenchment).
Secondo Stulz (1988), l’effetto di allineamento può inizialmente dominare, ma al di là
di un certo livello l’effetto entrenchment prevale.
Vi sono effetti positivi ed allo stesso tempo negativi anche quando si parla di
concentrazione della proprietà in soggetti diversi dai manager. Burkart, Gromb e
Panunzi (1997) parlano di overmonitoring, in riferimento all’eccessivo monitoraggio
svolto dagli azionisti sui manager. Quando vi è un’eccessiva ingerenza degli azionisti
nei processi di scelta dei manager, questi perdono l’incentivo ad effettuare
investimenti specifici (gli autori chiamano questo effetto “iniziative effect”). Se è vero
che la discrezionalità manageriale sia ex-post dannosa per gli azionisti, è anche vero
che essa può essere utile ex-ante in quanto favorisce investimenti specifici. Il manager
è meno incline a mostrare spirito d’iniziativa quando è probabile che l’azionista
interferisca18.
Di qui il passo ai costi di agenzia azionisti di maggioranza- azionisti di minoranza è
breve. Il problema è che gli azionisti di maggioranza rappresentano i loro interessi, che
18
Per alleviare questo problema è preferibile un board con un struttura two-tier che permette ai manager di
decidere senza l’ingerenza degli azionisti.
46
possono non coincidere con quelli degli altri investitori (azionisti di minoranza) o con
gli interessi degli impiegati e dei manager. Questo conflitto è accentuato nel caso in
cui (vedi le public company) i diritti di controllo sono significativamente in eccesso
rispetto ai diritti di cash flow.
Date le elevate quote detenute dagli azionisti di maggioranza, le imprese europee
possono sembrare erroneamente al riparo dai costi di agenzia generati da
un’accentuata separazione tra proprietà e controllo, tipici delle public company
anglosassoni. In realtà la quota azionaria di controllo, a cui si riferiscono le diverse
teorie sui costi di agenzia, non è data dalla percentuale posseduta dalle azioni con
diritto di voto, ma dalla quota dei flussi di cassa spettanti al soggetto controllante. La
quota di costo sopportata dal manager-proprietario per il consumo dei benefici non
monetari non coincide con la quota posseduta delle azioni con diritto di voto, ma è
espressa dal cosiddetto “alfa diluito”, ovvero dalla partecipazione effettiva ai flussi di
cassa dell’impresa. Il problema nasce quando gli azionisti di maggioranza utilizzano
strumenti che permettono la separazione della proprietà dal controllo. Tali strumenti,
sia di natura giuridica che di natura finanziaria, quali le azioni di risparmio, i patti di
sindacato, e soprattutto le strutture piramidali, consentono ad alcuni gruppi industriali
di detenere la maggioranza dei diritti di voto ed il controllo con una quota alquanto
modesta (diluita) del capitale effettivamente detenuto (vi è un allontanamento
sostanziale dello schema one vote-one share). Per cui alla posizione di azionista di
maggioranza sono legati benefici economici privati identificati nella possibilità di
ottenere una ripartizione dei risultati più favorevole all’azionista di controllo di quanto
dovrebbe esserlo in relazione alle quote di capitale sociale detenuto (la cosiddetta
estrazione di benefici privati ai danni degli azionisti di minoranza).
Si nota come lo scarso allineamento degli interessi degli azionisti di minoranza con
quelli degli azionisti di maggioranza, causato dai bassi livelli dell’alfa diluito, potrebbe
portare a costi di agenzia paragonabili a quelli delle public company statunitensi, senza
però contare sul loro contenimento esercitato dalla disciplina del market for corporate
47
control, ovvero dal timore di un’acquisizione ostile stimolata dal basso valore dei titoli
sul mercato. Si può dire che sono concentrati i difetti della proprietà diffusa (chi
controlla ha il potere di disporre dei capitali degli investitori esterni) quanto quelli
della proprietà concentrata (il controllante è esente dalla minaccia di scalate ostili, in
quanto detiene direttamente o indirettamente la quota di maggioranza delle azioni
ordinarie).
In conclusione, la separazione dei diritti di voto da quelli di cash flow fa cambiare il
tipo di relazione fa i due meccanismi della contestabilità del controllo e della
concentrazione azionaria. Se l’insider possiede più voti rispetto al suo interesse
patrimoniale, egli danneggia entrambi i meccanismi, incrementando i suoi incentivi ad
assumere comportamenti opportunistici. Egli è meglio protetto da una possibile scalata
ostile ed è meno allineato con gli azionisti di minoranza. Questo è ciò che accade alle
imprese europee ed in particolare a quelle italiane. In pratica vi è un livello di
entrenchment chiaramente superiore a quello americano. La paura dei manager di
perdere il posto rappresenta un incentivo naturale ad un migliore comportamento. Nel
caso Europeo, gli azionisti di maggioranza esercitano il loro potere decisionale sul
management, dando luogo ad effetti di collusione tra management ed azionisti di
maggioranza. Spesso l’”ultimate owner” è rappresentato dalla famiglia, con la
conseguenza che nella maggior parte dei casi si riscontra la presenza di parenti (in
alcuni casi non capaci!) all’interno del management.
Il problema del costo di agenzia potrebbe in questo senso rivelarsi di maggiore gravità
e di più difficile soluzione rispetto alla situazione statunitense. Si è infatti in presenza
di un mercato del controllo delle imprese dominato pressoché da cessioni volontarie, e
dove i leverage buy-out e le scalate ostili rappresentano eventi eccezionali.
48
1.7 I Gruppi
I gruppi sono ampiamente diffusi nella realtà imprenditoriale di tutto il mondo, ove è
ormai la norma incontrare società persone giuridiche tra loro legate da partecipazioni
nel capitale sociale tali da consentire ad una società (capogruppo) di esercitare il
controllo su tutte le altre.
La giustificazione dell’origine di tale fenomeno sono ricondotte a due fattispecie:
diversificazione dell’attività svolta e deverticalizzazione dei cicli produttivi. Nel primo
caso la capogruppo accoglie all’interno del proprio attivo patrimoniale quote di
controllo di società attive in settori tra loro anche assai lontani, dando luogo ad un
cosiddetto gruppo conglomerato o gruppo finanziario. Nel secondo caso invece la
capogruppo detiene invece le partecipazioni di controllo in società tra loro avvinte da
profondi legami di natura tecnico-economica, dando luogo ad un gruppo corporate o
gruppo economico.
La maggior parte della letteratura si è focalizzata sulle conglomerate USA. Nella realtà
europea invece si parla di holdings, fenomeno in cui rientrano le famose piramidi. Vi
sono due principali differenze tra holding e conglomerata. La prima è che ogni
segmento di business di una holding è organizzato in un’impresa indipendente sia dal
punto di vista giuridico che dal punto di vista amministrativo. La seconda, risaputa,
che i diritti di voto sono separati da quelli di cash flow. Le conglomerate USA in
genere detengono il 100% delle proprie sussidiarie con una politica aziendale ben
definita
Nel panorama europeo i gruppi differiscono nella struttura interna a seconda del
modello di capitalismo vigente. Così in Germania, al capitalismo reniano corrisponde
una struttura di gruppo in cui vi è una forte presenza di intermediari finanziari attivi e
competenti (le grandi banche). Il controllo in questo caso appartiene ad istituzioni
finanziarie, che sono elementi attivi all’interno dei consigli d’amministrazione (lo
stesso avviene in Giappone all’interno dei keiretsu). In Italia invece il ruolo della
49
banca nell’equity è marginale ed è inusuale per i banchieri sedersi al CDA o avere un
ruolo attivo nell’influenzare le decisioni strategiche industriali dell’impresa. La banca
in questo contesto nella maggior parte dei casi fornisce capitale di debito, essendo il
debito bancario per le imprese italiane la più comune forma di finanziamento esterno.
Al di là di queste diversità, vi è da dire che ricorso ad una struttura di gruppo permette
di accrescere la quantità di risorse governate dalla capogruppo e, quindi, a maggior
ragione, dai suoi soci di maggioranza, a parità di risorse direttamente investite.
Costruendo una catena di partecipazioni è infatti possibile sfruttare la cosiddetta leva
azionaria, la cui portata risulta essere maggiormente consistente quanto più, a parità di
altre condizioni,
Numerosi sono i livelli della catena delle partecipazioni;
Pesante è la presenza di azioni a voto limitato, come quelle di risparmio o quelle
privilegiate, non rilevanti di fatto ai fini del controllo;
Elevato è lo sfruttamento della leva finanziaria in ciascuno dei livelli della catena.
Ciò spiega il fenomeno delle piramidi, molto comune in Europa, e degli altri strumenti
utilizzati per la separazione della proprietà dal controllo, quali azioni privilegiate (in
disuso), dual class shares, per finire con i patti di sindacato, che stanno avendo più
successo negli ultimi tempi. Nelle imprese europee si assiste ad un utilizzo congiunto
di questi strumenti. La struttura piramidale si accompagna o con azioni senza diritto di
voto o con patti di sindacato. Un esempio drammatico di separazione della proprietà
dal controllo è la Telecom Italia. Al 2007 (fino ad ottobre) il gruppo piramidale
include tre compagnie quotate e due non quotate. Marco Tronchetti Provera è il
maggior azionista, controllando il 18% dei voti in Telecom Italia sebbene egli possieda
solo lo 0,7% dei diritti di cash flow. Il controllo su una delle imprese nella piramide è
rafforzato da un patto sindacale (o patto parasociale). Con questo patto Tronchetti
50
Provera controlla il 46,1% dei voti in Pirelli: il 25% direttamente posseduto dalla sua
holding Camfin ed il 21% derivanti da altri blockholders “amici”.
L’idea di gruppo (a livello Europeo) come strumento di separazione della proprietà dal
controllo va di pari passo con quella di strumento in mano agli azionisti di
maggioranza per l’estrazione dei benefici privati ai danni degli azionisti di minoranza.
Il mercato interno dei capitali che si genera nel gruppo così come è fonte di possibili
vantaggi così porta ad inefficienze dovuti a comportamenti di moral hazard da parte di
chi controlla le risorse.
1.7.1 Gruppi: aspetti positivi
La fondamentale peculiarità del gruppo a livello di gestione finanziaria corrente risiede
nel fatto che una molteplicità di soggetti giuridici comporta la necessaria esigenza di
trovare un equilibrio tra flussi di cassa in uscita e flussi di cassa in entrata per ciascuno
di essi.
Si può pensare che una filiale non è operativamente autonoma se non può gestire in
proprio gli incassi e i pagamenti; il decentramento amministrativo rappresenta una
causa che ha portato alla proliferazione dei conti correnti bancari.
Per gestire in maniera efficiente la liquidità, però, è necessario un certo grado di
accentramento. La gestione accentrata, o quanto meno coordinata, della tesoreria a
livello
di
gruppo
può
favorire
l’ottimale
utilizzo
delle
risorse
liquide
complessivamente disponibili.
E’ infatti possibile che all’interno del gruppo convivano unità strutturalmente o
temporaneamente in surplus di cassa, con unità strutturalmente o temporalmente in
deficit di cassa. Ciò può dipendere da diversi fattori, quali la contemporanea presenza
di attività:
51
Ad elevata ed asincrona stagionalità delle vendite, le quali determinano nel corso
degli anni dei picchi di fabbisogno di liquidità e di disponibilità di risorse liquide in
capo a specifiche società; Pesante è la presenza di azioni a voto limitato, come
quelle di risparmio o quelle privilegiate, non rilevanti di fatto ai fini del controllo;
Con diversa struttura del ciclo produttivo globale e/o del ciclo monetario, come nel
caso della grande distribuzione organizzata (cash generator) rispetto alle attività
manifatturiere (cash absorber);
In diverse fasi del ciclo vitale (imprese mature o imprese che si trovano ancora in
fase d’introduzione o di sviluppo).
In simili situazioni una gestione accentrata permetterebbe alle imprese che sono in
deficit di cassa il fabbisogno attraverso le risorse in eccesso detenute dalle unità in
surplus. Ne risulterebbe minimizzata la necessità di far ricorso al mercato dei capitali
al quale ci si dovrebbe rivolgere per trovare copertura dei soli saldi non compensabili
internamente al gruppo. I conseguenti effetti positivi a livello consolidato avrebbero
luogo sia in termini di oneri finanziari netti sia di flessibilità finanziaria. I primi
sarebbero più contenuti in quanto sarebbe minimizzata la contemporanea presenza di
saldi bancari attivi e saldi passivi dove il rendimento dei primi può essere anche
significativamente inferiore al costo dei secondi; senza contare poi il positivo impatto
a livello di commissione di massimo scoperto laddove sono contenuti i picchi di
utilizzo delle linee di credito accordate dal sistema bancario. Il più stabile utilizzo delle
linee di credito a disposizione potrebbe accrescere anche la flessibilità finanziaria,
garantendo, a parità di fido accordato, un margine medio più ampio di fido inutilizzato
disponibile per far fronte ad eventi imprevisti.
Una profittevole gestione accentrata di tesoreria si potrebbe avere attraverso il
controllo della dinamica del CCNC. In tal modo si agisce sulle determinanti all’origine
dei fabbisogni finanziari, modificando ex-ante i tratti essenziali della dinamica
finanziaria delle società del gruppo. Occorre però che ci siano stretti legami operativi
52
tra le unità del gruppo, in quanto diviene possibile trasferire risorse finanziare da una
società all’altra agendo su tre diverse variabili:
Le dilazioni contrattuali di incasso pagamento per gli scambi infragruppo;
Il livello dei prezzi praticati per gli scambi infragruppo;
Posizionamento del debito ai diversi livelli della filiera.
Aumentare (diminuire) le dilazioni contrattuali di pagamento determina un
trasferimento a monte (a valle) di CCNC lungo la filiera, comportando di pari passo un
trasferimento di liquidità in direzione opposta a causa dell’impatto che le variazioni
del CCNC producono sul flusso di cassa della gestione corrente commerciale. Così,
per esempio, se la società A acquista dalla società B, semilavorati per un importo
complessivo pari a 420 che paga normalmente dopo 30 gg ottenere una dilazione di
pagamento pari ad esempio a 90 gg equivarrebbe in termini di flussi di cassa per la
società A ad ottenere un finanziamento di 420*2 mesi.
Modificare i prezzi attraverso l’articolazione delle cosiddette politiche di transfer
pricing, agisce invece sulla ripartizione del margine operativo lordo (MOL)
consolidato tra le singole unità giuridiche. Poiché il MOL è la grandezza che
combinata con le variazioni del CCNC determina il flusso di cassa della gestione
corrente commerciale, la sua manovra determina una parallela riallocazione delle
risorse finanziarie all’interno del gruppo dalla società che ne subisce la contrazione
verso quella che ne vede ampliata la dimensione.
Posizionare il debito all’interno di una società significa gravarne l’equilibrio
finanziario delle uscite di cassa connesse al servizio del debito, vuoi per il pagamento
degli oneri finanza rivuoi per l’eventuale rimborso di quote capitale. Dato un importo
complessivo di debito a livello consolidato, concentrare tale debito in una o più unità
ne riduce il free cash flow, a tutto vantaggio di quelle società in tutto o in parte
sgravate dal debito.
53
La diversificazione quindi permette di ridurre le fluttuazioni di cassa complessive,
generando una maggior fiducia negli stakeholder che valutano meno rischiose le
relazioni economiche intrattenute con le società del gruppo che di conseguenza
potrebbero godere di condizioni più favorevoli. Inoltre, se nel gruppo sono presenti
società che generano free-cash flow c’è la possibilità che si crei un mercato finanziario
all’interno del gruppo, dove (molto teoricamente) le unità con le migliori prospettive
di sviluppo possono trovare le risorse necessarie a sostenere la loro crescita, attraverso
i flussi di cassa generati dalle società più mature.
Il legame tra mercato dei capitali che si forma internamente al gruppo e debito è
ambiguo, in quanto il primo può essere visto come sostitutivo o complementare al
secondo. Il primo caso, tipico delle economie emergenti, guarda al gruppo come una
risposta all’imperfetto funzionamento dei mercati finanziari ed alla scarsa protezione
dei diritti dei creditori, e considera il flusso dei capitali tra le imprese del gruppo come
sostitutivo di fonti finanziarie carenti e costose. Il mercato interno dei capitali
produrrebbe un effetto sostituzione per il quale le imprese del gruppo dovrebbero
risultare meno indebitate rispetto alle indipendenti, ciò in misura maggiore quanto più
numerose sono le unità aziendali. Ciò inoltre significa anche un minore accumulo di
riserve di liquidità a scopo precauzionale per difendersi dai costi eccessivi della
finanza esterna.
Si potrà notare lo stesso effetto sulle politiche di cash holdings anche nel caso opposto,
in cui il mercato dei capitali interni riduce la probabilità di dissesto finanziario delle
imprese appartenenti al gruppo. Vi è un effetto assicurativo derivante dal fatto che
quando le banche concedono prestiti ad un’impresa affiliata possono fare affidamento
sulla garanzia esplicita delle altre imprese del gruppo. L’imperfetta correlazione dei
cash flow delle divisioni aumenta la capacità di debito dell’impresa all’interno del
gruppo19.
L’imperfetta correlazione dei cash flow è un possibile obbiettivo per i gruppi guidati dalle famiglie, le quali
sono maggiormente avverse al rischio. Per questo la relazione tra diversificazione dei cash flow e debito non è
detto sia sempre positiva.
19
54
Si può inoltre constatare che l’accresciuta massa di risorse gestite permette di avere un
maggiore potere contrattuale nei confronti degli intermediari creditizi, potendo offrire
come garanzia i pacchetti azionari di maggioranza delle controllate per spuntare
condizioni migliori e dimensione degli affidamenti più consistenti. Ciascuna
consociata verrebbe così a godere dello standing creditizio complessivo del gruppo e
potrebbe di conseguenza beneficiare di prezzi all’ingrosso anche a fronte di
un’operatività individuale da dettagliante.
1.7.2 Gruppi:aspetti negativi
La letteratura sui conglomerati USA si incentra sul dibattito della distruzione di valore
o meno delle imprese diversificate. Un famoso paper di Berger e Ofek (1995)
(confermato anche da Lang e Stulz (1994)) studia il fenomeno di discount di gruppo
riscontrato in numerose verifiche empiriche, per il quale il valore di mercato della
holding di gruppi conglomerati quotate in borse è inferiore alla somma delle società
controllate di una percentuale che oscilla dal 12% al 15%. La letteratura, per dare una
spiegazione a questo sconto di mercato praticato dagli investitori, punta sulle
inefficienze del mercato dei capitali interno. Il problema fondamentale dei mercati
interni è che questi non sono veri e propri mercati, ma una combinazione di decisioni
centralizzate e di contrattazioni interne. I budget degli investimenti delle divisioni
dipendono tanto da fattori economici quanto da fattori politici interni. Divisioni di
grandi dimensioni, molto redditizie, e con ingenti flussi di cassa possono avere molto
più potere di contrattazione che opportunità di crescita; possono ottenere ingenti
disponibilità di capitale a discapito di piccole divisioni con buone prospettive ma
minore potere di controllo.
Gli studi americani parlano di manager rent-seeking, riferendosi in tal modo a
comportamenti opportunistici dei managers. Infatti i managers più influenti
55
eserciteranno il loro potere contrattuale per ottenere allocazioni di risorse più grandi
nelle divisioni da loro amministrate. La cattiva allocazione delle risorse è quindi
dovuta a problemi di agenzia e a considerazioni di potere all’interno del’impresa
(Meyer, Milgrom e Roberts (1992)). Sulla stessa linea si collocano analisi successive
come quelle di Scharfstein e Stein (2000), i quali sviluppano un modello che mostra
come i manager, perseguendo attività rent-seeking, possono accrescere il loro potere di
contrattazione per ottenere un compenso più alto dal CEO. L’assunzione chiave del
loro modello è che vi sono due livelli di agenzia. I manager delle divisioni spendono il
loro tempo nel costruirsi opzioni di uscita, le quali costringono i CEO a compensarli
maggiormente per mantenerli in azienda. Se il CEO fosse solo il principale, rispetto
agli agenti delle divisioni, tale aumento del compenso avverrebbe nella forma di cash
ed il mercato dei capitali interno rimarrebbe efficiente. Invece il CEO è esso stesso un
agente rispetto agli investitori esterni, per cui il compenso extra pagato ai manager
delle divisioni prenderà la forma di un’allocazione preferenziale di capitale piuttosto
che un compenso in contanti, in quanto sarà personalmente meno costoso per il CEO.
In Europa, per le caratteristiche diverse tra conglomerate e holding piramidali, le
dinamiche sono diverse. Così, in molti paesi europei (ma non solo) si ha a che fare con
imprese organizzate in business groups con diverse aziende individuali, controllate
dallo stesso privato o dalla stessa famiglia, le quali sono quotate e scambiano sul
mercato separatamente. Ciò fa si che vi sono molte transazioni infragruppo in conflitto,
ed è quindi più semplice per gli azionisti di maggioranza dar luogo a fenomeni di selfdealing o tunneling, citando Johnson et al.(2000). Quindi, vista la facilità con cui è
possibile travasare margini e risorse finanziarie da una società all’altra, è lecito temere
che l’azionista di controllo tenda a privilegiare le unità in cui maggiore è la
percentuale di capitale che egli possiede.
Le scelte di finanza aziendale potrebbero essere quindi adottate in modo da
determinare trasferimenti di ricchezza dagli azionisti di minoranza agli azionisti di
controllo, per esempio:
56
manovrando i tassi di interesse praticati sui saldi finanziari accentrati della
tesoreria di gruppo, in modo da contenere il costo delle risorse e di accrescerne il
rendimento per le unità dove maggiore è la quota di controllo diretto;
manovrando i prezzi degli assets scambiati lungo la filiera. O con scambi ad un
prezzo più alto dall’impresa che è ad un livello superiore a quella che è ad un
livello inferiore; oppure, viceversa, praticando prezzi più bassi per i beni scambiati
dall’impresa posta al livello inferiore ad un’altra di livello superiore;
privilegiando, nell’ambito della riallocazione dell’autofinanziamento generato dal
gruppo e anche del capitale fresco eventualmente raccolto dalla capogruppo sul
mercato, la realizzazione dei progetti investimento delle medesime unità in luogo
di quelli effettivamente migliori in assoluto per combinazione rischio-rendimento
atteso;
destinando le risorse finanziarie di cui al punto precedente alla realizzazione di
investimenti con profilo i rischio superiore a quello implicito nel costo del capitale
delle società, partecipate anche da terzi, che hanno generato al loro interno il flusso
di cassa disponibile o che hanno raccolto il capitale sul mercato.
57
CAPITOLO 2
LA LETTERATURA EMPIRICA
2.1 Financial constraints
La stima econometrica di modelli rappresenta uno dei metodi impiegati in letteratura
per lo studio dei financial constraints. La presenza di vincoli finanziari porta ad alcune
implicazioni nel comportamento delle imprese che viene testato.
All’interno del metodo di stima econometrico si riscontrano approcci diversi. Uno di
questi è introdotto da Demirguc-Kunt e Maksimovic (1998), e consiste nel comparare i
tassi attuali di crescita delle imprese con il tasso massimo di crescita che le imprese
possono raggiungere senza l’accesso al finanziamento esterno.
Fazzari, Hubbard e Petersen (1988) sono i primi ad introdurre il concetto di investment
cash flow sensitivity. Lo schema di base della loro analisi è ripreso in numerosi lavori
successivi.
La struttura di questi lavori si basa su due pilastri fondamentali:
informazioni a priori della rilevanza dei financial constraints per sottogruppi
d’imprese selezionate a seconda della grandezza, dell’età e dell’accesso ai
mercati finanziari. Alcune caratteristiche osservabili delle imprese sono
correlate alla possibilità di incontrare vincoli finanziari;
le imprese costrette finanziariamente, selezionate secondo le suddette
caratteristiche, rifiutano il modello neoclassico d’investimento perché il loro
accesso limitato alle finanze esterne impedisce loro di investire ottimamente
quando le fonti interne non sono disponibili.
58
Per compiere quest’ultimo punto, la letteratura segue tre metodi:
una stima diretta di una funzione della domanda d’investimento ottenuta dalle
condizioni di primo ordine del modello base dove il valore ombra del capitale
(marginal q) potrebbe essere uno dei regressori ed è approssimato dal Q
medio di Tobin;
un’equazione di Eulero per le imperfezioni del mercato dei capitali le cui
specificazioni empiriche non includono il marginal q di Tobin tra i repressori;
una stima diretta della funzione di domanda degli investimenti, dove la
produttività marginale attesa del capitale è approssimata da una VAR forecast
dei fondamentali dell’impresa osservabile dagli econometrici (vedi Gillchrist
e Himmelberg, 1995 e 1998).
La letteratura si è incentrata maggiormente sul primo modello, come detto introdotto
da Fazzari, Hibbard e Petersen nel 1988. Le ricerche successive hanno, relativamente a
tale metodo, messo in luce due tipi di problemi: il primo legato alla classificazione a
priori delle imprese, il secondo al Q di Tobin come buona approssimazione delle
opportunità d’investimento.
2.1.1 Classificazione a priori delle imprese constrained
Schiantarelli (1995) osserva che in molti lavori l’appartenenza di un’impresa al gruppo
delle financially constrained o unconstrained è fissato durante l’intero periodo di
analisi del campione. E’ tuttavia possibile che le imprese affrontino costrizioni
finanziarie di varia intensità in differenti momenti. Fazzari, Hubbard e Petersen (1996)
affermano che assumere che solo un gruppo particolare d’imprese abbia costi di
finanziamento esterno più alti è conveniente empiricamente ed analiticamente. Sarebbe
59
quindi più giusto permettere alle imprese di transitare tra stati finanziari differenti.
Cleary (1999), ad esempio, classifica le imprese tramite un indice di costrizione
finanziaria calcolato all’inizio di ogni anno (Zfc), per mettere in evidenza che lo stato
finanziario cambia continuamente.
Una seconda osservazione riguarda l’endogeneità del criterio di suddivisione del
campione. Alcuni, se non la maggior parte, dei metodi usati è possibile che siano
correlati con gli effetti specifici dell’impresa, con le componenti invarianti rispetto al
tempo del termine di errore, così come con la componente idiosincratica. Questo è
vero con certezza quando si utilizza come criterio il payout ratio o la grandezza media.
In questo caso la strategia più adeguata consiste nell’usare informazioni
contemporanee per dividere le osservazioni nel contesto di una singola equazione, ed
usare informazioni ritardate come strumenti nel contesto delle procedure IV
(instrumental variables) o GMM (general method of moments) (Arellano e Bond
(1991).
Alternativamente, se si pensa che la forza dei financial constraints varia continuamente
con certe caratteristiche, ad esempio come la grandezza, si può far interagire una
misura della grandezza con il cash flow.. In ogni caso, stime consistenti possono essere
ottenute usando valori appropriatamente ritardati dei termini d’interazione. Se il
modello è first differenced e la componente idiosincratica del termine di errore è white
noise, variabili endogene ritardate due volte potrebbero essere strumenti legittimi.
Infine, il metodo tradizionale di suddivisione assume che il punto esatto di separazione
sia conosciuto. Nella realtà, invece, la misura delle costrizioni finanziarie incontrate da
un’impresa non è direttamente osservabile (l’affiliazione di un’impresa ad un grande
gruppo, vedi Hoshi et al. (1991) può essere un eccezione).
Ciò implica che i risultati della stima delle regressioni d’investimento su diversi
campioni può essere sensibile alla scelta del criterio e ai breakpoints usati per dividere
il campione. Il problema può essere superato utilizzando un modello endogeno di
60
switching regression con separazione non conosciuta del campione20. Tale approccio
fornisce stime di regressioni separate d’investimento evitando una classificazione a
priori delle imprese in constrained e non constrained.
In questo senso è opinione diffusa in letteratura che le differenze tra i risultati di
Fazzari Hubbard Petersen (1988) e quelli di Kaplan e Zingales (1997) dipendano
esclusivamente dal metodo di suddivisione a priori delle imprese.
FHP dividono 421 imprese americane in tre gruppi: le imprese della classe 1 con il
dividend payout ratios inferiore allo 0,1 per almeno 10 anni, le imprese della classe 2
hanno l’indice compreso tra lo 0,1 e lo 0,2, mentre quelle appartenenti alla classe 3
mostrano un payout ratio superiore allo 0,2. Le imprese della classe 1 dovrebbero
essere le più congrue ad incontrare financing constraints.
Kaplan e Zingales (1997) ripartiscono le 49 aziende definite constrained da FHP sulla
base di una combinazione di criteri qualitativi e quantitativi. In particolare, KZ
utilizzano dati provenienti da lettere agli azionisti, da discussioni del management
sulle operazioni e sulla liquidità, da rendiconti finanziari annuali per ogni impresa, e
ratio finanziari provenienti dal database COMPUSTAT. Ciò sembra essere sufficiente
a spiegare i risultati contrastanti tra i due lavori. Ma il campione di 49 imprese
utilizzato da KZ potrebbe soffrire di mancanza di eterogeneità.
Allayannis e Mozoumdar (2001) scompongono dapprima il campione di 49 imprese
constrained di FHP allo stesso modo di KZ, trovando risultati simili, che mostrano una
maggiore sensibilità dell’investimento al cash flow per le meno constrained
Successivamente, escludendo per ogni gruppo delle constrained e delle unconstrained
due specifiche imprese trovano che l’investment cash flow sensitivity non differisce
significativamente tra le imprese costrette e quelle non costrette. Si può arrivare alla
conclusione che la differenza nella sensibilità stimata dell’investimento al cash flow
20
Hu e Schiantarelli (1994) e Hovakimian e Titman (2006)
61
dei due gruppi di imprese è rappresentata dalla differenza di sensibilità solamente di
queste poche imprese.
Moyen (2006) dimostra, attraverso una simulazione numerica, che è difficile
identificare le imprese con vincoli finanziari, e afferma che la sensibilità
dell’investimento al cash flow dipende dalla procedura di classificazione utilizzata.
L’autrice mette a confronto due modelli dinamici, uno che riguarda le imprese
unconstrained, che hanno libero accesso al mercato dei capitali, e l’altro che riguarda
le imprese constrained che non hanno accesso al mercato dei capitali esterno. Entrambi
i tipi di impresa crescono in seguito ad un miglioramento delle opportunità
d’investimento, tuttavia le imprese costrette rimangono più piccole. L’equazione
d’investimento del modello constrained mostra che le imprese vincolate investono fino
al punto in cui il costo di un’unità di capitale eguaglia il prodotto marginale scontato
atteso di capitale del prossimo periodo. Le imprese non costrette, invece, hanno un
ulteriore incentivo ad investire. La loro scelta d’investimento tiene anche conto della
probabilità di default e dei tassi d’interesse richiesti dal debito. Investendo di più
diminuisce la probabilità che l’impresa possa perdere lo scudo fiscale. Grazie a questi
benefici fiscali, il debito è la fonte di finanziamento più a basso costo: le imprese non
costrette, che ricordiamo sono le uniche che possono finanziarsi affidandosi al mercato
dei capitali esterno, contraggono debiti e finanziano più investimenti in periodi di alti
cash flow. Questo genera una sensibilità maggiore dell’investimento al cash flow. Le
imprese costrette, invece, a volte utilizzano il loro cash flow per pagare più dividendi
piuttosto che per investire. Ciò fa decrescere la sensibilità dell’investimento delle
imprese constrained al loro cash flow. Questa condizione è in linea con i risultati di
Kaplan e Zingales. Tuttavia, se i vincoli finanziari sono identificati con bassi dividendi
(o bassi cash flow), nel modello unconstrained alti livelli di debito vanno assieme a
bassi dividendi, per cui accade che le imprese non costrette sono associate a più bassi
dividendi rispetto alle imprese costrette. Le imprese caratterizzate da bassi dividendi,
hanno politiche d’investimento più sensibili alle fluttuazioni del cash flow rispetto a
62
quelle che mostrano un pay-out ratio più alto. In questo modo, le predizioni del
modello di Moyen sono in linea con i risultati di FHP (1988).).
2.1.2 Q diTobin
Il modello d’investimento del Q (Brainard e Tobin 1968, Tobin 1969) può essere visto
come una riformulazione della teoria neoclassica, secondo la quale la domanda
d’investimento è spiegata dal rapporto tra il valore di mercato dello stock di capitali
dell’impresa e il suo costo di sostituzione. Tobin sviluppa un’intuizione di Keynes
secondo il quale la decisione di investire in nuovi beni capitali dipende dalla relazione
tra il valore che i mercati finanziari attribuiscono al progetto di investimento ed il suo
costo di realizzazione. Si pone dunque attenzione sull’importanza delle valutazioni
delle imprese implicite nei prezzi delle azioni quotate sui mercati.
Il ragionamento è questo: per decidere se accrescere lo stock di capitale, le imprese
devono valutare di quanto il nuovo investimento farà crescere il flusso dei profitti
futuri. Diventa quindi rilevante il rapporto tra la variazione del valore attuale dei
profitti ed il costo d’acquisto del capitale. Questa quantità è chiamata q marginale ed è
interpretata come il rapporto tra il valore di una unità di capitale addizionale istallato e
il suo costo d’acquisto. Se l’aumento del valore attuale dei profitti è maggiore del
costo dell’investimento addizionale, ossia se il q è maggiore di 1, l’impresa investirà.
Il q marginale è importante in quanto riassume tutta l’informazione sul futuro che è
rilevante ai fini della decisione dell’investimento dell’impresa. Tuttavia questa
quantità non è direttamente osservabile. Ciò che è osservabile è invece il rapporto tra il
valore del capitale complessivamente istallato, cioè il valore presente scontato dei
profitti, e il costo d’acquisto del capitale. Questo è il Q medio, cioè il rapporto tra la
capacità del capitale esistente di generare profitti ora e in futuro e il suo prezzo.
63
Una misura del Q medio può essere costruita usando, come valore attuale dei profitti,
un indice dei prezzi sul mercato azionario. I prezzi delle azioni incorporano le
aspettative del mercato riguardo la profittabilità futura dell’impresa, costituendo una
misura ragionevole del valore presente scontato dei profitti. Ciò sta a significare che,
quando il rapporto supera 1, gli investitori dei mercati finanziari sanno che i cash flow
in prospettiva sono sufficientemente alti o che i tassi di sconto sono sufficientemente
bassi inducendo in tal modo ad una spesa aggiuntiva di capitale, poiché l’azienda sta
creando valore per gli azionisti.
Hayashi (1982) fornisce la prova che il Q medio (il rapporto tra il valore di mercato
dell’impresa, dato dalla capitalizzazione di borsa più il valore di mercato dei debiti e i
costi di sostituzione dello stock di capitale esistente) è uguale al q marginale sotto le
seguenti condizioni: i mercati degli input e degli output sono competitivi, i costi di
aggiustamento e quelli di produzione sono linearmente omogenei, il capitale è
omogeneo.
Perché è importante il Q di Tobin? Ricordando che il Q di Tobin sintetizza le
aspettative del mercato circa la profittabilità futura dell’impresa, il suo utilizzo è
basato sull’idea che le opportunità d’investimento possono essere catturate dagli
investitori del mercato dell’equity: tali opportunità si rifletteranno nel prezzo dei titoli
e quindi nella valutazione fatta dai mercati finanziari.
Tuttavia il Q di Tobin mostra dei punti deboli relativi ad inconvenienti di natura
tecnica e a problemi di endogeneità del Q. Il problema tecnico più rilevante è il
possibile errore di misurazione che potrebbe portare a stime distorte ed inconsistenti21.
21
Per capire da dove provengono tali errori di valutazione occorre organizzare il discorso specificando tre
diverse quantità: il q marginale, come sappiamo non misurabile; il Q medio, dato dalla valutazione soggettiva del
manager, il Q di Tobin, la valutazione dei mercati finanziari del Q medio.
Una prima fonte di errori si verifica quando c’è discrepanza tra q marginale e Q medio, la quale si riscontra
quando si ha una violazione delle assunzioni o di perfetta competitività del mercato degli output o della linearità
omogenea delle funzioni dei costi di aggiustamento e dei profitti.
E’ possibile che vi sia divergenza anche tra il Q medio ed il Q di Tobin. Le inefficienze del mercato dei capitali
possono causare una diversa valutazione del capitale da parte dei manager rispetto a quella di mercato.
Infine, numerosi problemi sorgono nella stima del Q di Tobin. Riconoscere il valore degli intangible assets è
importante per una corretta misurazione del Q. Mentre può essere più facile valutare gli assets intangibili
acquistati all’esterno, quelli prodotti internamente (come la spesa per ricerca e sviluppo) creano maggiori
64
Per quanto riguarda invece l’endogeneità del Q, poiché il q marginale è il valore
attuale dei profitti futuri e correnti che derivano da un’unità marginale di capitale, uno
shock positivo della funzione dei costi di aggiustamento al tempo t colpirà
direttamente gli investimenti ma provocherà anche un incremento del Q dovuto ad un
aumento della profittabilità futura attesa.
2.1.3. Risultati empirici sull’investment cash flow sensitivity
I risultati empirici di Fazzari, Hubbard e Petersen (1988) confermano il modello
teorico e mostrano come i vincoli finanziari siano una determinante importante del
comportamento d’investimento dell’impresa. Infatti le imprese che dovrebbero avere
maggiori problemi associati alle imperfezioni del mercato dei capitali mostrano un
coefficiente stimato associato al cash flow positivo e significativo. Questi risultati sono
consistenti con l’ipotesi di differenziale di costo tra finanziamento interno ed esterno.
L’importanza economica dei risultati, affermano gli autori, è magnificata dal fatto che
il cash flow è altamente variabile per le imprese in rapida crescita del primo gruppo
(quello constrained), mentre le imprese mature nella terza classe (con un payout ratio
superiore allo 0,2) sperimentano molto meno variazioni nel cash flow.
Fazzari, Hubbard e Petersen (1988) testano inoltre l’ipotesi secondo la quale le
imprese che si trovano di fronte ad un premio per il finanziamento esterno possono
accumulare liquidità come cuscinetto per prevenire fluttuazioni del cash flow. Questa
forma di prevenzione riduce la sensibilità dell’investimento alle fluttuazioni di cash
flow, per cui si presenterà una relazione positiva con l’investimento per le imprese
problemi. Ci sono industrie dove questo tipo di assets superano in valore quelli fisici, quali attrezzature ed
equipaggiamenti. Secondo Chirinko (1993) e Baum e Thies (1997) occorre che queste spese vangano
capitalizzate. Bisogna che siano ridefinite le spese d’investimento e lo stock di capitale, incorporando
rispettivamente le spese e lo stock di intangibles. Infine nella stima del Q di Tobin la discrepanza si può
constatare a causa di asimmetrie informative nel mercato dei capitali (che portano ad un gap nel set di
informazioni a disposizione degli investitori esterni e dei manager) o, ancora, può nascere dalla costruzione del
costo di sostituzione del capitale.
65
costrette. Gli autori applicano tre modelli di investimento, i quali a destra presentano
rispettivamente la variabile cash e marketable securities, la variabile working capital
(capitale circolante netto) ed infine variabili ritardate cash e vendite (sales). I risultati
mostrano che gli stock di liquidità sono significativi per le imprese del primo gruppo,
mentre non significative per quelle del terzo. Inoltre, includendo valori ritardati delle
variabili sales e cash, si è assistito ad una diminuzione del coefficiente associato al
cash flow, mentre tale inclusione non ha portato alcun effetto significativo nelle
variabili stock di liquidità. Questo perché le variabili stock non ci danno alcuna
informazione sulla profittabilità futura, come invece accade per la variabile cash flow.
Come già detto, Kaplan e Zingales prendono le 49 imprese definite constrained da
Fazzari, Hubbard e Petersen e utilizzano dati qualitativi e quantitativi su ognuna di
esse, per classificare ogni anno le imprese costrette e quelle non costrette. Si può
affermare, in sintesi, che le imprese non soggette ai vincoli finanziari per Kaplan e
Zingales, sono quelle che possiedono un alto ammontare di attività liquide, poiché
queste permettono di porre in atto investimenti nonostante il costo elevato del
finanziamento esterno. I risultati ottenuti si dimostrano qualitativamente coerenti ma
quantitativamente opposti a quelli ottenuti da Fazzari, Hubbard e Petersen (1988). In
altre parole, il coefficiente del rapporto cash flow-investimenti, se da un lato risulta
maggiore di zero (totalmente è pari a 0,395), confermando così l’ipotetica relazione
positiva tra flussi di cassa e decisioni d’investimento, dall’altro risulta notevolmente
maggiore per le imprese che non sembrano soffrire di vincoli finanziari. Le imprese
classificate da Kaplan e Zingales come non costrette esibiscono una sensibilità molto
alta (0,702) rispetto a quelle classificate come costrette (0,340).
Tali risultati confutano decisamente i principali riscontri di Fazzari, Hubbard e
Petersen (1988), in quanto dimostrano che la sensitività degli investimenti al cash flow
non è una funzione crescente del grado di costrizione finanziaria.
66
2.2 Cash flow sensitivity of cash
La sensibilità del cash al cash flow è introdotta da Almeida, Campello e Weisbach
(2004) come metodo alternativo di riconoscimento di vincoli finanziari. Secondo gli
autori tale modello supera alcuni problemi di natura tecnica legati all’investment cash
flow sensitivity. In particolare, poiché il cash è una variabile finanziaria (e non reale
come gli investimenti), è difficile dire che il potere esplicativo del cash flow nelle
politiche di cash possa essere ascritto alla sua abilità di prevedere condizioni
economiche future (come la domanda d’investimento). Per le imprese non costrette, le
unconstrained firms, le variazioni nel cash holdings non dipenderanno né dai cash flow
correnti né dalle future opportunità d’investimento, per cui non ci si aspetta
comportamenti sistematici nelle politiche di cash. Il cash cash flow sensitivity quindi
varia sistematicamente con le proxies delle costrizioni finanziarie, molto più di quanto
non faccia l’investment cash flow sensitivity.
Almeida, Campello e Weisbach (2004) utilizzano cinque criteri sotto elencati
alternativi per dividere il campione (che comprende imprese manifatturiere americane)
in imprese costrette e imprese non costrette.
payout ratio: richiama il lavoro di Fazzari, Hubbard e Petersen (1988)
secondo i quali le imprese costrette sono quelle che pagano meno dividendi;
dimensione degli assets: l’argomentazione sulla dimensione come buona
misura osservabile dei financial constraints dipende dal fatto che le piccole
imprese sono tipicamente giovani, meno conosciute, e quindi più vulnerabili
alle imperfezioni dei mercati finanziari;
bond rating: il vantaggio di questa misura rispetto alle precedenti è che essa
misura il gradimento del mercato della qualità di credito dell’impresa;
commercial paper rating: il ragionamento è lo stesso di quello fatto per il
bond rating;
67
KZ index: è un indice basato sui risultati ottenuti da Kaplan e Zingales
(1997), ed è dato da:
KZindex = -1,002 x CashFlow + 0,283 x Q + 3,139 x Leverage – 39,368 x Dividends –
1,315 x CashHoldings
Almeida, Campello e Weisbach (2004) stimano un equazione, utilizzando l’approccio
delle instrumental variables (IV), in cui la decisione dell’impresa di modificare il suo
cash holdings è funzione delle risorse e degli usi di fondi. Per far ciò si rifanno alla
letteratura sull’investment cash flow sensitivity (in particolare da Fazzari, Hubbard e
Petersen) e a quella sul cash management (vedi Opler, Pinkowitz, Stulz e Williamson
et al. (1999) e Kim, Mauer e Sherman (1998)) modellando la variazione annuale di
cash di un’impresa, oltre che come funzione del cash flow, del Q di Tobin e della
dimensione, anche come funzione delle spese di capitale, delle acquisizioni, delle
variazioni nel capitale circolante netto e dei debiti a breve termine:
ΔCashHoldingsi,t = α0 + α1CashFlowi,t + α2Q i,t + α3Size i,t + α4Expenditures i,t
+ α5Acquisitions i,t + α6ΔNWC i,t + α7ShortDebt i,t + ε i,t
I risultati empirici di maggior rilievo trovati da Almeida, Campello e Weisbach
confermano le loro argomentazioni teoriche che vedono la domanda di liquidità
generata dai vincoli finanziari, mettendo in risalto il motivo precauzionale di Keynes:
le imprese definite constrained mostrano una sensibilità positiva del cash
holdings al livello di cash flow;
68
per le imprese invece non soggette ai vincoli finanziari (unconstrained), ossia
quelle che possono finanziare il livello ottimo di investimento, il cash
holdings non ha alcuna rilevanza.
Numerosi sono stati gli studi incentrati sulla sensibilità del cash al cash flow. Alcuni
hanno trovato risultati simili (vedi Khurana (2006)), altri invece all’opposto di quelli
di Almeida et al. (2004).
In particolare, è importante considerare il lavoro di Riddick e Whited (2007). Tenendo
presente la distinzione tra effetto ricavo e effetto sostituzione del loro modello
teorico22, il Q di Tobin e il cash flow, presenti nella parte destra della regressione che
vede come variabile dipendente la variazione del cash, contengono entrambi
informazioni sulla produttività del capitale. Tuttavia Q è la variabile, fra le due, che
più riflette le condizioni future, incorporando in tal modo l’effetto ricavo, che riguarda
il finanziamento degli investimenti futuri. Il cash flow allora detiene l’effetto
sostituzione, mostrando quindi un coefficiente negativo, contrariamente a ciò che si
trova in Almeida, Campello e Weisbach (2004). E’ importante sottolineare che
Riddick e Whited (2007) procedono alla correzione degli errori di misurazione
presenti nel Q di Tobin. Infatti, secondo Almeida, Campello e Weisbach, usando la
sensibilità del cash al cash flow, e quindi una variabile finanziaria al posto
dell’investimento fisico, si è immuni da problemi di errori di misurazione. Essi
spiegano che, sotto l’ipotesi nulla di mancanza di frizioni finanziarie, l’accumulo di
cash potrebbe non dipendere né dal cash flow né dal Q di Tobin, essendo invece
sensibile solo al cash flow in presenza di frizioni finanziarie. Questa spiegazione per
Riddick e Whited non è completa in quanto non si rivolge al segno e alla grandezza
dell’effetto del cash flow. L’errore di misurazione in un repressore viene ad intaccare
tutti i coefficienti in una regressione se i repressori sono collegati. In questo caso sono
22
Vedi I capitolo, paragrafo 5.1.
69
correlati perché l’informazione riguardante le opportunità future d’investimento,
contenute nel cash flow, conduce naturalmente ad una relazione positiva tra il Q di
Tobin e il cash flow. Inserendo la variazione di cash holdings nella parte sinistra della
regressione non si elimina questo problema.
Riddick e Whited (2007) trovano risultati simili a quelli di Almeida, Campello e
Weisbach (2004) quando usano, per i dati di imprese di sei paesi diversi, una stima
OLS, con coefficienti positivi del cash flow e del Q di Tobin. E’ solo quando
utilizzano gli stimatori di Erickson e Whited (2000) per correggere l’errore di
misurazione del Q che i risultati cambiano. In questo caso trovano coefficienti del cash
flow negativi, e metà di questi statisticamente insignificanti. Questo effetto, dovuto al
trattamento degli errori di misurazione, è ravvisabile anche nel coefficiente del Q di
Tobin, la cui grandezza cresce dalle sette alle quindici volte rispetto al coefficiente
stimato attraverso un OLS. Dal punto di vista economico Riddick e Whited affermano
che, utilizzando un’approssimazione errata del Q reale, controllando solo una parte
della sua variazione, il cash flow finisce per inglobare l’effetto ricavo. Infine gli autori
dividono le imprese in constrained e unconstrained sulla base di due dei cinque
indicatori utilizzati da Almeida, Campello e Weisbach (2004) (dimensione e bond
rating), e dimostrano che la sensibilità a risparmiare liquidità aumenta con la
correlazione seriale dei ricavi e diminuisce con la varianza di questi. L’effetto
dell’incertezza sul cash cash flow sensitivity è, da un punto di vista empirico, forte
almeno quanto l’effetto dei financing constraints. Ne discende che la propensione
all’accumulo di cash non può essere usata come misura del costo del finanziamento
esterno. Ad un simile risultato perviene lo studio sulle imprese europee condotto da
Ferrando e Pal (2006). L’analisi empirica si differenzia da quella di Almeida,
Campello e Weisbach (2004) sotto vari aspetti. La suddivisione del campione in
constrained e unconstrained è stata ritenuta dalle autrici non idonea per le imprese
70
Europee. Infatti, la suddivisone tra quotate, grandi e non quotate 23e piccole potrebbe
non essere adeguata in quanto le imprese europee quotate e grandi possono incontrare
le stesse barriere al finanziamento di quelle piccole e non quotate. Mizen e Vermeulen
(2005) trovano, per le imprese anglosassoni e tedesche, che la dimensione non può
essere usata come indicatore di status finanziario; Mizen (2002) dimostra che non si
riscontrano condizioni finanziarie peggiori per le imprese non quotate francesi e
spagnole rispetto a quelle quotate.
Una spiegazione sufficientemente razionale di questo fenomeno è data dal fatto che la
fonte di finanziamento principale delle imprese europee è il debito ottenuto da
istituzioni finanziarie. Per questo i risultati dovrebbero essere diversi da quelli del
sistema americano, dove le grandi imprese quotate si affidano maggiormente al
capitale ottenuto dai mercati finanziari.
Il metodo di classificazione a priori di Ferrando e Paz è molto più preciso ed è basato
sulla relazione esistente tra fabbisogno e fonti di finanziamento (sia interne che
esterne). Le imprese sono divise in tre classi: assolutamente costrette, relativamente
costrette, e non costrette, in base all’interrelazione tra investimenti totali, gap
finanziario, debiti finanziari, emissione di nuove azioni e il pagamento degli interessi
sul debito rispetto al tasso che si trova nel mercato locale.
I risultati ottenuti mostrano come la sensibilità del cash al cash flow è presente in tutti i
tipi di impresa. Non esistono mercati finanziari perfetti, per cui si assiste comunque a
un wedge tra fonti di finanziamento interne ed esterne, in linea con il motivo dei costi
di transazione. Inoltre, la sensibilità dal cash al cash flow mostra un coefficiente in
assoluto maggiore per le imprese non costrette. Ciò è dovuto al fatto che il livello di
sensibilità è influenzato dalle opportunità future d’investimento che è parzialmente
catturato dalla variabile cash flow (nell’equazione si trova che le variabili che
Gli autori sostituiscono i criteri di suddivisione di Almeida, Campello e Weisbach (2004) “bond rating” e
“commercial paper rating” con lo status di quotata. Non avendo i dati a disposizione, l’essere quotata o meno ha
gli stessi effetti sul mercato dei capitali. Sempre per la mancanza di dati, il criterio dei dividendi non viene
inserito
23
71
dovrebbero tener conto delle future opportunità di crescita, ossia la crescita delle
vendite e la variabile ritardata dell’investimento in intangibile assets, sono prive di
significato).
Si può concludere che, mentre le imprese costrette trattengono cash dal cash flow per
coprirsi dalle fluttuazioni del cash flow stesso, le imprese non costrette invece lo fanno
per aumentare gli investimenti futuri. Inoltre per le imprese non affette da vincoli
finanziari, si registra anche un’importante sensibilità al debito a lungo termine, il che
implica che questo tipo di imprese utilizzano più intensivamente risorse esterne
(prevalentemente di lungo termine) per finanziare investimenti addizionali. Il cash
holdings ha dunque un ruolo importante per equilibrare le risorse interne ed esterne di
finanziamento, attraverso una riallocazione intertemporale, e per permettere il
pagamento delle obbligazioni e degli interessi.
2.2.1. Investment cash flow sensitivity vs cash cash flow sensitivity
Il cash flow sensitivity of cash si collega necessariamente all’investment cash flow
sensitivity perché gli investimenti fissi e le variazioni del cash sono due tra i maggiori
utilizzi di fondi concorrenziali. Alcuni economisti hanno analizzato la loro coesistenza
all’interno di uno stesso studio. Chang, Tan, Wong e Zhang (2007) trovano che le
imprese classificate come imprese costrette finanziariamente mostrano una sensibilità
dell’investimento al cash flow più bassa e una sensibilità del cash al cash flow più alta
rispetto a quelle classificate come non costrette.
Ci sono due spiegazioni per questo risultato. La prima per i casi in cui le imprese
costrette hanno cash flow positivi. Queste investono meno in risposta ad un aumento
del cash flow perché sono costrette a costruire delle riserve di liquidità per assicurare
che vi siano fondi disponibili per investimenti futuri. La seconda interpretazione è più
72
rilevante negli anni in cui le imprese constrained incorrono in cash flow negativi,
trovandosi in una situazione di difficoltà finanziaria.
Come sottolineato da Allayannis e Mozumdar, è più facile che queste imprese taglino i
loro investimenti a livelli minimi durante gli anni di cash flow negativo. Un ulteriore
declino nel cash flow non dovrebbe risultare in decurtamenti addizionali degli
investimenti, cosicché la sensibilità dell’investimento al cash flow risulta
relativamente bassa. Allo stesso tempo, affrontando cash flow decrescenti, le imprese
costrette possono coprire l’ammanco di fondi per spese di capitale necessarie con fondi
ottenuti da un ulteriore drenaggio di riserve di cash. In risposta ad un cash flow
crescente, esse cercano di ristorare le disponibilità finanziarie attraverso un aumento
della cassa.
D’altra parte Salma e Bejar (2007), in uno studio sulle imprese tunisine, trovano
risultati contradditori rispetto a quelli di Chang, Tan, Wong e Zhang (2007). Le
imprese tunisine, identificate come imprese soggette a vincoli finanziari, mostrano una
sensibilità dell’investimento al cash flow più alta (questo però solamente in periodi di
cash flow positivi, perché in caso di difficoltà finanziaria, con cash flow negativi i
risultati sono statisticamente poco significativi) e una sensibilità del cash al cash flow
più bassa in relazione alle imprese che non subiscono particolari costrizioni finanziarie.
Gli autori affermano che le imprese fortemente vincolate sul piano finanziario sono
esposte ad alti costi di finanziamento esterno che porta al motivo dei costi di
transazione per la detenzione di cash, implicando l’utilizzo di riserve di cassa per
fronteggiare le spese correnti.
2.3. Studi sul livello di cash holdings
Gli studi empirici sul cash holdings si possono dividere in due tipologie principali:
nella prima rientrano gli studi che analizzano le determinanti del livello di cash
73
holdings delle imprese e la possibile esistenza di un ammontare ottimo, naturalmente
dal punto di vista dell’azionista; nella seconda quelli che si focalizzano sull’impatto
della liquidità sulle performance e sul valore dell’impresa.
Le prime analisi sono dirette ad osservare due teorie di cui si è accennato: la trade-off
theory (è la trasposizione di quella sul leverage nell’ambito del cash holdings), per la
quale, ricordiamo, esiste un livello ottimo di liquidità determinato dall’equilibrio dei
costi e dei benefici del detenere cash; la Pecking Order Theory (di Mayers e Majluf)
secondo la quale invece non vi è un livello ottimale di cash. Si può pensare che non vi
sia un livello ottimale di cash perché esiste un livello di debito netto, ossia al netto del
cash, per cui non importa che livello di cash si abbia. La Pecking Order Theory però è
il caso più estremo dove non esiste nemmeno un livello ottimo di debito netto.
L’equity in Myers e Majluf è la fonte di finanziamento che costa di più a causa delle
maggiori asimmetrie informative, il debito viene contratto quando non vi sono risorse
interne disponibili. Quando queste sono sufficienti per finanziare investimenti in
progetti profittevoli, allora queste vengono usate per ripagare debiti e per ricostituire
una riserva di liquidità precauzionale. Per questo la Pecking Order Theory è
strettamente collegata al motivo precauzionale e ai financial constraints24.
Successivamente, con l’esplosione delle tematiche di governance, a causa dei recenti
scandali, la letteratura si concentra maggiormente sull’aspetto dei costi d’agenzia e sui
conflitti esistenti tra manager e azionisti (studi sulle imprese
americane), e tra
azionisti di maggioranza e azionisti di minoranza.
24
Sarebbe però un errore collegare la Trade Off Theory con il motivo dei costi di transazione e la Pecking Order
Theory con il motivo precauzionale. I confini, sia empiricamente che teoricamente, sono molto sfumati ed è
difficile cogliere una separazione netta.
74
2.3.1. Livello ottimo e determinanti del cash holdings
Mikkelson e Partch (2003) per differenziare le imprese in imprese high-cash (quelle le
cui riserve di cassa sono alte) ed imprese low-cash (al contrario, le aziende con un
basso livello di cassa), si basano su una regola di classificazione fissa, ossia
definiscono cash-rich quelle imprese che detengono più del 25% dei loro assets totali
in cash e cash equivalent.
Oltre questa maniera arbitrale di scegliere il limite del 25%, l’approccio presenta altri
svantaggi che rendono questo metodo di classificazione meno accurato e realizzabile.
E’ ragionevole assumere che l’ammontare di cash mantenuto da un’azienda sia il
risultato della combinazione di una serie di caratteristiche specifiche dell’azienda
stessa. Il metodo di Mikkelson e Partch non considera minimamente la possibilità di
target differenti tra le imprese, come invece avviene, tra gli altri, negli studi di Opler,
Pinkowitz, Stulz e WIlliamson (1999), Kim, Mauer e Sherman (1998). Inoltre, lavori
inerenti la struttura del capitale corroborano l’idea che le imprese abbiano un target di
debito flessibile (Grahm e Harvey (2001); Bancel e Mittoo (2004)), conclusione che si
può applicare ragionevolmente alle politiche di cash.
Per cui, considerando l’approccio con il livello prefissato, si prendano due imprese
considerate cash-rich perché superano il livello del 25%; è possibile che comunque le
due imprese differiscano per il target di cash prefissato endogenamente. Ad esempio,
poniamo che il livello definito da una delle due sia al di sotto del 25%, mentre quello
definito dall’altra sia al di sopra dell’ammontare attuale di cash. In quest’ultimo caso,
non sarebbe corretto definire l’impresa come high cash, perché il suo ammontare di
riserve liquide è al di sotto del target prestabilito. È ovvio come la definizione di un
limite fisso, non implicando l’esistenza di target diversi nelle imprese, non tiene conto
neanche dell’ulteriore possibilità che questi target variano anno per anno.
Opler, Pinkowitz, Williamson, Stulz (1999) e Kim, Mauer, Sherman (1998) sono tra i
primi a trovare risultati che supportano il modello del trade-off del cash holdings.
75
Esiste quindi un target di cash fissato endogenamente dalle organizzazioni al quale
esse tendono continuamente.
Opler, Pinkowitz, Williamson, Stulz (1999) analizzano l’esistenza di un livello
ottimale di cash guardando come prima cosa se il cash holdings può essere visto come
un processo mean reverting. Se non lo è può essere rigettata l’ipotesi secondo la quale
le imprese hanno un livello di cash prefissato25.
Attraverso un modello autoregressivo di primo ordine, gli autori trovano che vi sono
fattori sistematici che portano le imprese a controllare che il livello di cash non salga o
non scenda troppo oltre la media.
Più che l’esistenza di un livello ottimale di cash determinato all’interno di un
organizzazione, ciò che realmente interessa è la velocità di aggiustamento dell’impresa
al livello desiderato di cash da una posizione di non-equilibrio. Il target adjustment
model ci può dire molto di più sull’importanza che il cash holdings ha nelle politiche
finanziarie dell’azienda. Un processo più lento ad esempio può indurre a pensare che
la liquidità sia all’ultimo posto nelle scelte finanziarie, in linea con la teoria della
gerarchia di finanziamento .
Opler, Pinkowitz, Williamson, Stulz (1999) e Kim, Mauer e Sherman (1998)
sviluppano un modello di aggiustamento al target molto seguito in letteratura. Questo
mostra che le variazioni nel cash holdings in t+1 dipendono dalla differenza tra il
livello di cash attuale e il target individuato alla fine dell’anno t.
Vi sono diversi modi per ottenere il target di cash ottimale. Quello più semplice
consiste nell’utilizzare la media del cash holdings di un’impresa negli ultimi cinque
anni (Opler, Pinkowitz, Williamson, Stulz (1999); Bruinshoofd e Kool (2004)).
Si trovano però anche metodi più avanzati: Opler, Pinkowitz, Williamson, Stulz (1999)
ottengono il target ogni anno da valori adattati da una regressione cross-sectional del
25
Tuttavia la Pecking Order Theory non è inconsistente con il processo di mean reversion. Nella Pecking Order
Theory il cash holdings non è gestito attivamente ma dipende dalle variazioni della crescita delle risorse interne.
Se questa è negativamente autocorrelata ( ad esempio a causa di fluttuazioni del ciclo economico) allora anche il
cash holdings sarà auto correlato.
76
cash holdings sulla dimensione reale dell’impresa e sulla volatilità del settore; oppure
ancora Opler et al. (1999) e Harford (1999) utilizzano come target i valori fitted di un
modello cross sezionale alla Fama-MacBeth 26 ; si tratta di un modello stimato
annualmente cosicché tutte le informazioni richieste per stimare il target sono
disponibili nell’anno in cui il target è usato nella regressione. Il target risulta in questo
modo più accurato ed è più direttamente collegato ai fattori specifici dell’impresa.
Bruinshoofd e Kool (2004) ammettono la presenza di un livello ottimo, ma allo stesso
tempo dimostrano come la dinamica del cash holdings dipenda da shock di breve
periodo nei ricavi e nelle spese e dall’aggiustamento verso il target specificato di lungo
periodo.
La teoria del trade off statico può quindi valere nel lungo periodo, ma l’impresa
utilizza il cash holdings anche per assorbire schocks nel breve periodo nei flussi di
entrata ed in uscita. Bruinshoofd e Kohl parlano di teoria della “buffer stock liquidity”,
che si avvicina molto alla Pecking Order Theory. Le imprese possono scegliere
inizialmente di lasciare che le disponibilità liquide assorbano qualsiasi shock, e cercare
solo nel lungo periodo di ritornare ad un livello ottimo di liquidità. Occorre che le
aziende pongano l’attenzione su altri target finanziari almeno nel beve termine, pur
essendo a conoscenza dei costi e dei benefici della liquidità.
Nel loro lavoro sono specificati tre tipi diversi di target. Oltre a quello costruito con la
media degli ultimi cinque anni, presente in Opler, Pinkowitz, Williamson, Stulz (1999),
essi introducono il “sophisticated target” e lo “specific target”. Nel primo sono incluse
più informazioni rilevanti possibili sul livello di target firm-level. Tuttavia è possibile
che questo target non tenga conto dell’eterogeneità inosservata nei livelli di lungo
periodo delle imprese (la parte di liquidità che è motivata dai problemi di informazione
può rimanere opaca). Lo specific target, invece, tiene conto di queste problematiche:
26
Ogni anno si fa una regressione cross-sezionale e si usano le serie temporali dei coefficienti della regressione
per fare le inferenze. Questo metodo permette di evitare i problemi di correlazione seriale nei residui che
potrebbero esserci in regressioni pooled.
77
nella sua espressione vengono catturati tutti i motivi specifici di impresa non catturati
dal sophisticated target.
In Bruinshoofd e Kool l’equazione dinamica di liquidità misura la variazione di
liquidità (yit-yit-1) catturando la pressione di breve termine attraverso un vettore di
variabili esplicative che contiene variazioni delle determinanti di lungo periodo così
come shock di breve periodo nei profitti e nelle spese. Inoltre vengono catturati gli
incentivi all’adattamento al target nella forma di deviazioni di inizio anno dai targets
di lungo periodo (storici, sophisticated e specific).
Per concludere, Ozkan e Ozkan (2004) (e successivamente Drobetz e Gruninger
(2006); Garcia-Teruel e Martinez-Solano (2004); Couderc (2005); Marchica e Mura
(2007)) adottano un modello di aggiustamento al target in cui si tiene conto che
l’aggiustamento possa avvenire in ritardo a causa, ad esempio, di un mancato
pagamento dei clienti dell’azienda, oppure di un incremento inaspettato delle
opportunità di crescita. Tale modello è sicuramente più realistico rispetto ad un
modello statico, in quanto in quest’ultimo il processo avviene immediatamente al
cambiare delle caratteristiche dell’impresa e/o per shock casuali. Questo modello però
non può essere stimato con uno stimatore OLS perché sorgerebbero numerosi
problemi di stima; vi è infatti presenza di endogeneità nella variabile dipendente
ritardata inserita nella parte destra dell’equazione: questa sarà correlata con il termine
di errore, implicando che tale stima possa risultare distorta e inconsistente, rendendo
quindi conveniente avvalersi dello stimatore GMM di Arellano e Bond (1991).
L’impiego di tutti i possibili vettori ritardati delle variabili nella parte destra come
strumenti, comporta l’esistenza delle condizioni di ortogonalità tra queste variabili
strumentali e il termine di errore dell’equazione.
Osservando i risultati ottenuti in letteratura, Ozkan e Ozkan, nel loro studio sulle
imprese non finanziarie inglesi, trovano un coefficiente di aggiustamento abbastanza
elevato (sopra lo 0,6) che mostra come l’impresa aggiusti il suo cash holdings
velocemente nel tentativo di raggiungere il target stabilito. Stesso risultato è ottenuto
78
da Guney, Ozkan e Ozkan (2003) per le imprese britanniche, mentre per quelle
francesi, tedesche e giapponesi il coefficiente è pari allo 0,5. Per le ultime due una
spiegazione può venire dal fatto che queste imprese sono caratterizzate da legami
stretti con le banche e dipendono da loro per i finanziamenti esterni, per cui possono
adeguarsi più lentamente al target senza incorrere in alti livelli di adjustment costs.
Anche Couderc (2005) documenta differenze nei coefficienti di aggiustamento tra
paesi, stimando coefficienti più alti (intorno allo 0,6) per USA e Canada rispetto a
Germania e Francia (0,5). Ozkan e Ozkan spiegano come la velocità di aggiustamento
derivi da un trade-off tra due differenti tipi di costo: il costo di essere lontani dal target
prestabilito e il costo di aggiustamento verso il medesimo target. Questi valori intorno
allo 0,6 dimostrano come sia sì costoso essere distanti dal livello stabilito, ma anche
come sia costoso il processo di aggiustamento. Se i costi di aggiustamento fossero
molto bassi rispetto a quelli dell’essere fuori target allora si avrebbe un valore vicino a
1.
Bruinshoofd e Kool (2004) mostrano un coefficiente di aggiustamento che va da 0,20,
se si utilizza il target basato sui valori medi, a 0,67 se invece si utilizza il target
definito dagli autori “specific target”, che tiene conto delle caratteristiche specifiche
d’impresa. I risultati mostrano anche che, per ogni deviazione del target, solo il 10% di
questa persiste per più di due anni. Infatti anche se si controllano le caratteristiche a
livello d’impresa, una parte considerevole della decisione di detenere liquidità può
rimanere opaca. Tenendo conto di questo si raggiunge un tasso annuale di convergenza
al target specifico pari al 60%. Lo stesso Bruinshoofd, in uno studio successivo del
2006, focalizza l’attenzione sull’aggiustamento non lineare della liquidità verso un
target di lungo periodo. Il suo risultato più significativo è che le imprese reagiscono ad
una mancanza di liquidità più velocemente di quanto lo facciano quando si trovano di
fronte ad un surplus di cassa. Infatti le imprese correggono un surplus di liquidità a un
tasso pari al 45% annuale, mentre rimuovono una carenza di cassa a un tasso del 70%.
Per posizioni di liquidità che scendono troppo rispetto al target vi può anche essere un
79
aggiustamento completo al target definito nell’arco di un anno, ossia ad un tasso
annuale del 100%.
Infine Opler, Pinkowitz, Williamson, Stulz (1999) trovano per le imprese USA un
tasso annuale di convergenza ai target stabiliti di circa il 20%27. E’ un tasso molto
basso, che può riflettere il fatto che questi targets, se stimati accuratamente, non
svolgono un ruolo di primo piano nel management della liquidità delle imprese. Gli
autori nello stesso lavoro testano il modello assumendo che variazioni nel cash
holdings son date da deficit del flusso di fondi, misurato come dividendi più le spese di
capitale più le variazioni nel capitale operativo netto, più la porzione corrente da
pagare di debito a lungo termine, meno il cash flow operativo. Il coefficiente del
deficit del flusso di fondi è pari a 0,2195. Ciò supporta il fatto che la teoria della
gerarchia di finanziamento ha la sua importanza nelle dinamiche della liquidità.
Tab.1. Coefficienti di aggiustamento al target
La tabella mostra i diversi coefficienti di aggiustamento al target rilevati dai vari studi in letteratura
NAZIONALITA’
COEFF. DI
IMPRESE
AGGIUSTAMENTO
USA
0,2
UK
0,605
Guney et al.
UK
0,6025
(2005)
Germania
0,5559
Giappone
0,5615
AUTORI
Opler et al.
(1999)
Ozkan e Ozkan
(2004)
27
Anche Ozkan e Ozkan (2004) stimando un modello di aggiustamento al target simile a quello di Opler et al.
(1999), trovando però un coefficiente pari a 0,54. Ricordiamo che allo stesso modo Bruinshoofd e Kool (2004)
mostrano un coefficiente pari a 0,2, in linea con i risultati di Opler et al. (1999)
80
Bruinshoofd e
Francia
0,5585
Olanda
0,2 (historical target)
Kool (2004)
Bruinshoofd
0,65 (specific target)
Olanda
(2006)
0,45
0,7
Couderc
USA
0,617
(2004)
Canada
0,712
Germania
0,534
Francia
0,477
UK
0,549
Svizzera
0,376
Drobetz e
Gruninger (2006)
2. 3.2 Pecking Order Theory e Trade Off Theory
Opler, Pinkowitz, Williamson, Stulz (1999) trovano quindi supporto per entrambe le
teorie. Ciò è confermato da successive regressioni in cui sia il target adjustment model
sia il modello della gerarchia di finanziamento possono influenzare il livello di cash. In
tutte le regressioni i risultati sono significativi. I due modelli teorici agiscono in
maniera diversa rispetto alle predizioni di Bruinshofd e Kool (2004). Questi ultimi
spiegano la determinazione del target come un obiettivo di lungo periodo, mentre nel
breve periodo ciò che prevale è il modello delle gerarchie. In Opler, Pinkowitz,
Williamson, Stulz (1999) le dinamiche dei due modelli portano a pensare che la
Pecking Order Theory prevalga se l’impresa ha un eccesso di liquidità, dimostrato dal
fatto che i coefficienti del deficit del flusso di fondi sono più alti in assoluto per le
imprese che mostrano un livello di cash più alto di quello prestabilito. Il manager, che
81
è bene ricordare agisce almeno teoricamente nell’interesse degli azionisti, lascerà
accumulare risorse liquide quando l’azienda ottiene buoni risultati.
La coesistenza di entrambe le teorie nella spiegazione del fenomeno dell’accumulo di
liquidità si riscontra anche quando si vanno ad analizzare le singole caratteristiche
specifiche dell’impresa che determinano il livello di liquidità.
Ciò che emerge è una chiara difficoltà nel distinguere empiricamente i due modelli. Vi
sono infatti molte predizioni che appartengono a tutte e due le teorie.
Qui di seguito vengono schematizzate le assunzioni teoriche sulle relazioni che
intercorrono tra le caratteristiche delle imprese e i livelli di cash facendo distinzione,
ove possibile, fra le diverse ipotesi.
Dimensione dell’impresa (SIZE):
La relazione attesa tra il cash holdings e la dimensione è ambigua.
Relazione negativa: Secondo Baumol (1952), Miller e Orr (1966), esistono economie
di scala nel cash management. Ciò implica che le imprese più grandi detengono meno
cash rispetto a quelle più piccole. Inoltre le imprese più grandi mostrano minori
asimmetrie informative e affrontano costi più bassi di finanziamenti esterni (Fazzari e
Petersen (1993)). E’ generalmente accettato che le imprese più grandi, a causa di una
maggiore diversificazione, hanno una probabilità più bassa di trovarsi in una
situazione di dissesto finanziario (Rajan e Zingales 1995). Anche per questo motivo ci
si aspetta una relazione negativa tra cash holdings e size (dimensione).
Relazione positiva: secondo la Pecking Order Theory le imprese più grandi
dovrebbero essere quelle più di successo e potrebbero avere accumulato riserve di
cassa più alte (Myers e Majluf (1984)).
Leverage
Anche il grado di leverage ha un effetto ambiguo sulle politiche di cash. Gli studi
americani non fanno distinzione sulla durate del debito, considerando assieme debito a
82
breve e debito a medio lungo termine (Kim, Mauer e Sherman (1998), Opler et al.
(1999)). Alcuni lavori sulle imprese europee (Ferrando e Pal (2004), Ferreira e Vilela
(2006)), invece, separano il ratio in due indici, uno che approssima il debito a breve, e
l’altro che riflette il debito a medio lungo termine. E’ una scelta ragionevole, visto che
il debito a medio lungo termine ha caratteristiche totalmente diverse da quello a breve.
Il debito a breve drena liquidità, quello a medio lungo termine è più simile all’equity,
tant’è che è spesso proposto, ad esempio nelle regole prudenziali, che una parte del
debito a lungo termine sia considerato alla stregua dell’equity, nonostante siano ben
chiare le differenze di diritti di cash flow e di diritti di controllo con quest’ultimo.
Infine, alcuni lavori, anche in questo caso prevalentemente europei (Ozkan e Ozkan
(2004), Ferreira e Vilela (2006)), studiano la relazione tra debito bancario e cash
holdings. Come già si è detto il debito bancario è la forma di finanziamento esterno più
utilizzata.
Relazione positiva: è generalmente accettato che il leverage incrementa la probabilità
di bancarotta dovuta alla pressione di rigidi piani di ammortamento. Quindi per ridurre
la probabilità di dissesto finanziario ci si aspetta che l’impresa con un alto leverage
mantenga più alti livelli di cassa. Inoltre abbiamo visto che un alto grado di leverage
provoca il problema di underinvestment introdotto da Myers (1977), per cui
mantenendo liquidità all’interno questa minimizza i potenziali agency costs del debito.
Relazione negativa: per la teoria della gerarchia di finanziamento di Myers e Majluf il
debito dovrebbe scendere ogni qualvolta il cash flow eccede la spesa d’investimento.
Infatti in questo caso il cash flow è utilizzato, una volta controllata la spesa
d’investimento, per ridurre il debito esistente e per aumentare la scorta di cash a
motivo precauzionale. Questa relazione tra leverage, investimento e cash holdings
suggerisce che vi sia una relazione negativa tra cash holdings e leverage.
Inoltre, per il fatto che l’indice di leverage agisce come un’approssimazione
dell’abilità dell’impresa di emettere debiti ci si potrebbe aspettare che le imprese con
un leverage più alto trattenga meno liquidità.
83
Opportunità d’investimento
In questo caso le due teorie trovano entrambe un collegamento positivo delle
opportunità d’investimento con le riserve di cassa.
Relazione positiva: la Trade Off Theory suggerisce che il costo dell’incorrere in
situazioni di scarsa liquidità è maggiore quando vi sono elevate opportunità
d’investimento, perché la perdita che deriva dalla non attuazione dell’investimento
profittevole è maggiore. Il confine di separazione dalla Pecking Order Theory non è
netto; secondo Myers e Majluf (1984) infatti, l’impresa accumulerà cash per evitare di
non poter effettuare investimenti in futuro, nel caso i fondi esterni non siano
disponibili a un costo accettabile.
Inoltre, poiché le opportunità di crescita sono intangibili in natura e poiché l’NPV
positivo di questi investimenti scompare (quasi interamente) in caso di bancarotta, le
imprese avranno un costo del dissesto molto alto e cercheranno di evitarlo o di
minimizzarlo, trattenendo una quantità più elevata di risorse liquide (Williamson
(1988), Harris e Raviv (1990), Shleifer e Vishny (1992))
Cash flow
Relazione positiva: di riflesso alle dinamiche del leverage nella Pecking Order Theory,
il cash flow mostra una relazione positiva con il cash holdings, in quanto dopo aver
ripagato il debito esso è usato per aumentare il saldo di cassa.
Relazione negativa: il cash flow è visto nella teoria del trade-off come un sostituto
della liquidità che è possibile utilizzare per finanziare gli investimenti.
Incertezza del cash flow
Relazione positiva: un cash flow altamente variabile aumenta la possibilità di
incappare in una situazione di scarsità di fondi liquidi. Per evitare i costi connessi a
questo stato, l’impresa preferisce accumulare denaro liquido (Trade Off Theory).
84
Rischio di dissesto finanziario
Relazione positiva: l’impresa con un’alta possibilità di dissesto finanziario cerca di
mantenere un livello elevato di cash holdings per alleviare le conseguenze del deficit
finanziario.
Relazione negativa: rispecchia solamente il fatto che un’impresa in situazione di stress
finanziario non possa avere cash in eccesso. Si tratta quindi di differenze nella
direzione di causalità.
Entrambe le relazioni possono sembrare plausibili.
Liquidità diversa dal cash
Relazione negativa: in linea con la Trade Off Theory, essa funge da sostituto del cash.
Dividendi
Relazione negativa: il pagamento dei dividendi comporta un’uscita di contante per
ripagare gli azionisti. Il livello di cash holding diminuisce all’aumentare dei dividendi.
Inoltre la possibilità di poter ridurre il pagamento dei dividendi quando c’è un
problema di liquidità giustifica livelli di cash minori per le imprese che pagano
dividendi.
Relazione positiva: può accadere che le imprese che pagano dividendi sono
particolarmente riluttanti a tagliarli e quindi tendono a mantenere un alto ammontare di
cash.
2.3.3 Risultati principali degli studi sulle determinanti del cash holdings
Di seguito è riportata la tabella che sintetizza le predizioni teoriche esistenti e i
principali risultati ottenuti in letteratura.
85
Tab.2 Risultati letteratura empirica
La tabella mostra i principali risultati degli studi che analizzano le determinanti del livello di cash
holdings. Le colonne riportano le predizioni delle teorie (Trade Off (TOT) e della gerarchia di
finanziamento (POT)) e i risultati ottenuti dai vari autori in letteratura. Il segno + indica una relazione
positiva, il segno - indica una relazione negativa. Il segno / indica che la variabile è mancante. N.s. sta
a significare la non significatività del risultato.
Variabili
POT
TOT
Opler et al.
Kim et al.
Ozkan e
Ferreira e
Ozkan
Vilela
Leverage
-
+/-
-
-
-
-
Dimension
+
-
-
/
n.s.
n.s.
Cash flow
+
-
+
-
-
+
σ Cash
/
+
+
+
-
-
/
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
/
-
/
-
/
/
/
-
-
-
-
-
e
flow
Altra
liquidità
Opp.
Crescita
Bankrupty
cost
Dividendi
86
Variabili
POT
TOT
Bruinshoof Ginglinger
Drobetz
Garcia e
Gruningen
Saddour
Gruninger
Solano
Leverage
-
+/-
-
-
-
+
Dimension
+
-
-
-
-
n.s.
Cash flow
+
-
/
+
+
+
Σ Cash
/
+
+
+
/
/
/
-
/
-
-
-
+
+
/
+
n.s.
+
/
-
/
/
-
n.s.
/
-
/
+
+
/
e
flow
Altra
liquidità
Opp.
Crescita
Bankrupty
cost
Dividendi
E’ utile confrontare le evidenze fornite da Kim, Mauer e Sherman e quelle di Opler et
al. perché i loro lavori sono molto simili tra di loro: entrambi analizzano imprese
manifatturiere americane; il periodo che si va a coprire è più o meno lo stesso (19751994 per i primi; 1971-1994 i secondi). I risultati sembrano essere somiglianti. La
differenza che balza agli occhi è il segno della relazione del coefficiente del cash flow.
87
In Opler et al. il segno positivo è espressione della teoria di Myers e Majluf, per cui
un’azienda con un livello di cash flow alto ne trattiene una parte all’interno. Ciò è in
linea con il comportamento delle imprese finanziariamente costrette di Almeida,
Campello e Weisbach (2004) che dimostrano una sensibilità del cash al cash flow
positiva. Kim, Mauer e Sherman trovano, invece, un coefficiente negativo del cash
flow, che quindi è visto come fonte alternativa di liquidità.
A parte questa differenza i due lavori sembrano spiegare il cash holdings delle imprese
con il motivo precauzionale; in Kim, Mauer e Sherman (1998) le imprese che
detengono maggiormente cash sono quelle che fronteggiano un costo elevato dei
finanziamenti esterni, come si nota dal coefficiente della variabile Market to Book
ratio, che per gli autori rappresenta una proxy del costo del finanziamento esterno.
Opler, Pinkowitz, Williamson e Stulz (1999) trovano che le imprese di piccole
dimensioni, che in teoria dovrebbero essere più affette dai vincoli finanziari e quelle le
cui attività sono più rischiose, trattengono maggiore liquidità. Al contrario le imprese
di grandi dimensioni, quelle che presentano un rating più alto del debito hanno un
livello più basso di liquidità. Pare quindi che le imprese siano guidate dal motivo
precauzionale nelle loro politiche di cash. Infatti, come abbiamo visto prima, il flusso
di fondi ha un forte impatto sul cash holdings, il che è confermato dalla relazione
positiva tra cash flow e cash holdings, che evidenzia come il management mantenga
liquidità appena ne ha la possibilità, ossia appena i cash flow hanno un livello
abbastanza alto.
Tuttavia questo motivo precauzionale, nonostante si presenti una relazione positiva tra
cash e opportunità d’investimento, sembra poco collegato alle spese di investimento.
Infatti gli autori trovano una persistenza del cash holdings piuttosto elevata. Esso non è
speso rapidamente in investimenti, né in acquisizioni (come documenta Harford
(1999)). Il cash in azienda è trattenuto principalmente come cuscinetto per le perdite
operative, come dimostra il fatto che variazioni maggiori nel cash in eccesso, in media,
sperimentano cash flow operativi largamente negativi.
88
Il paper di Opler,Pinkowitz, Stulz e Williamson (in parte anche quello di Kim, Mauer
e Sherman) è diventato un modello da cui prendono spunto molti dei lavori che
studiano il cash holdings. Ferreira e Vilela (2006) lo ripercorrono fedelmente in un
campione di imprese di 12 paesi europei28. La motivazione è chiara, cioè quella di
vedere i risultati di uno studio pressoché uguale su imprese che vivono in ambienti
totalmente diversi, come lo è il contesto europeo rispetto a quello americano. E lo
stesso fa Anderson (2002).
I risultati riportati da Ferreira e Vilela (2006) sono in linea con quelli di
Opler,Pinkowitz, Stulz e Williamson (1999), l’unica differenza è data dalla volatilità
del settore che è collegata negativamente con il cash holdings. Un elemento di novità
che gli autori inseriscono è dato dalla variabile che approssima il debito bancario. E’
già nota la stretta relazione che le imprese europee hanno con gli istituti finanziari, e
infatti anche altri studi sulle determinanti del cash holdings analizzano come questa
relazione agisca sul cash holdings (Ozkan e Ozkan (2004); Guney , Ozkan e Ozkan
(2006)).
Un paper essenziale a riguardo è quello di Pinkowitz e Williamson (2001), i quali
studiano panel di imprese giapponesi, tedesche e americane e dimostrano come le
prime trattengano un livello di cash holding superiore alle altre. La differenza sta nel
maggiore potere delle grandi banche giapponesi le quali detengono un ruolo centrale
nel sistema finanziario locale. Queste spingono le imprese ad aumentare le riserve di
liquidità per estrarre rendite a proprio favore o per diminuire i costi di monitoraggio.
Vi è da dire che nel sistema nipponico le banche rappresentano la maggior parte degli
ultimate owner, per cui non si parla solamente di debito bancario. Allo stesso modo,
però, il sistema finanziario tedesco è molto simile e, in questo caso, uno stretto
rapporto con le banche induce a un cash holdings più basso. Ferreira e Vilela (2006)
trovano che il debito bancario riduce l’accumulo di cash. E’ quindi ragionevole
28
Si tratta di Germania, Francia, Olanda, Italia, Spagna, Finlandia, Belgio, Austria, Irlanda, Lussemburgo,
Grecia e Portogallo
89
pensare che il debito bancario, e quello che ne consegue (un rapporto molto stretto con
la banca), funga da cuscinetto e permetta di avere minori livelli di cash. Inoltre la
relazione negativa tra debito bancario e cash supporta l’idea che la banca sia in una
posizione migliore per valutare la qualità del credito delle imprese e per monitorare le
loro politiche finanziarie, con la conseguenza di diminuire drasticamente i problemi di
asimmetria informativa associati ad altri tipi di debito.
A questi stessi risultati arrivano Ozkan e Ozkan (2004) i quali, per un panel di imprese
inglesi quotate, forniscono forte evidenza del fatto che il debito bancario esercita una
negativa e significativa influenza sul cash trattenuto in azienda. Essi apportano
un’ulteriore spiegazione, ossia che il debito bancario sia più facilmente rinegoziabile,
quindi permette all’impresa di non mantenere cash a scopo precauzionale a causa di
probabili difficoltà di rinegoziazione dei contratti finanziari.
Molti altri studi hanno aggiunto ulteriori specificazioni per quanto riguarda il debito
rispetto ai lavori di riferimento americani. Infatti, Opler,Pinkowitz, Stulz e Williamson
(1999), Kim, Mauer e Sherman (1998), così come Almeida, Campello e Weisbach
(2004), non si focalizzano sulla durata del debito. Essi studiano solo il rapporto
esistente tra grado di leverage e cash holdings, aggregando debiti di tutte le scadenze,
dimostrando una relazione negativa e significativa che vede il debito come una fonte
di liquidità, e quindi un sostituto del asset in cash. Ciò è realistico soprattutto per il
debito a breve, e negli USA i debiti a breve tendono a predominare nelle strutture di
capitale delle imprese. Gli studi europei sono più attenti ad analizzare le differenze di
impatto delle diverse durate del debito sul cash holdings. Anderson (2002) per le
imprese inglesi trova una connessione positiva tra debito a lungo termine e cash
holdings. Questo è in linea con la presenza di un motivo precauzionale, perché le
imprese mantengono un alto leverage che funge da caratteristica durevole della loro
struttura del capitale alla quale altre politiche, quali ad esempio quelle dei dividendi e
quella del cash holdings, sono adattate. Ferrando e Pal (2006) giungono ad un simile
risultato per imprese europee di medio grandi dimensioni, le quali sembra che
90
utilizzino il debito di lungo periodo non per investimenti immediati, ma per una
allocazione nel tempo delle risorse. Bruinshoofd e Kool (2004) trovano invece risultati
opposti per le imprese olandesi. Il debito totale incide negativamente sul cash holdings,
ma osservando la relazione che intercorre tra debito a breve e livello di cassa, questa è
positiva. Questo fenomeno potrebbe
essere
motivato, secondo gli autori,
dall’incertezza della rinegoziazione che impatta sui costi d’informazione del
finanziamento esterno.
Recentemente alcuni autori hanno aggiunto nell’analisi, oltre al leverage, il leverage al
quadrato, per dimostrare la relazione non lineare che vi è tra leverage e cash holdings
(Guney et al. (2006); Ginglinger e Saddour (2007); Drobetz e Ginglinger (2006)). Così,
se l’effetto del leverage è negativo, quello del leverage al quadrato risulta al contrario
positivo. Marchica e Mura (2007) riescono a trovare per le impresi inglesi il punto di
flesso, ossia il punto corrispondente al livello di debito in cui le imprese incominciano
a mantenere cash. Questo corrisponde al 32% di debito delle attività totali. Vi sono
differenti visioni che cercano di spiegare questa relazione non lineare: Ginglinger e
Saddour parlano di costrizioni finanziarie: un’impresa con un alto leverage è probabile
che sia soggetta a vincoli finanziari, e quindi per motivi precauzionali ci si attende che
incrementi le disponibilità liquide. Guney, Ozkan e Ozkan invece spiegano che un
azienda altamente indebitata accumulerà più cash perché è più soggetta al rischio di
dissesto finanziario.
Uno studio di John (1993) analizza la liquidità dell’azienda in rapporto ai vari costi,
diretti e indiretti del dissesto finanziario, e trova che le disponibilità liquide
dell’azienda siano crescenti nelle variabili che approssimano i costi di fnancial distress,
e decrescenti nel valore collaterale degli assets e nella altre risorse di liquidità
disponibili.
Molti lavori successivi contraddicono i risultati di John (1993): Kim, Mauer e
Sherman (1998), Drobetz e Gruningen (2006), tra gli altri, utilizzano l’inverso dello Z-
91
score di Altman (1968)29 e trovano che questo ha un effetto negativo sull’accumulo di
cash. In letteratura sono usati anche altri modi per approssimare i costi di financial
distress. Ad esempio, il market to book ratio rappresenta la perdita di valore collegata
alla vendita degli assets prematura e forzata dovuta alla situazione di dissesto. Il valore
contabile è collegato al valore di liquidazione dall’asset. Le imprese con un alto
rapporto valore di mercato su valore di libro avranno più alti costi di liquidazione.
Quest’indice non è usato solo come proxy per i costi del dissesto finanziario. Per Kim,
Mauer e Sherman (1998), rappresentando le opportunità di crescita, il MTB ratio
approssima il wedge esistente tra costi di finanziamento interno e costi di
finanziamento interno dovuto alle asimmetrie informative, in quanto per le imprese
con un valore alto dell’indice MTB la maggior parte del loro valore proviene
dall’intangible assets che sono più difficili da valutare esternamente. In Opler,
Pinkowitz, Stulz e Williamson (1999), Ferreira e Vilela (2003), Ozkan e Ozkan (2004),
Guney, Ozkan e Ozkan (2005), l’indice invece è visto come approssimazione delle
opportunità d’investimento, presenti e future. I risultati sono quasi unanimi, mostrando
una relazione positiva con il cash holdings. Al contrario, Drobetz e Gruninger (2006)
trovano un coefficiente legato al MTBR insignificante.
C’è da precisare che quest’indice basandosi sul valore di mercato, è utile solo per lo
studio delle imprese quotate. Allo stesso modo il Q di Tobin approssima le opportunità
future d’investimento. Gli studi che si fondano su tutti i tipi di imprese (quotate e non)
usano come proxy del set di opportunità d’investimento, la variazione annuale delle
vendite (Ferrando e Pal (2006)), o anche gli intangibile assets. Il risultato finale è in
molti casi lo stesso, con le opportunità d’investimento che agiscono positivamente
sulla determinazione del livello di cassa adeguato. Dittmar e Marth Smith (2004)
invece spiegano che la relazione positiva tra MTB ratio e cash sia dettata dalla
presenza di endogeneità. Gli autori mostrano come, inserendo nella regressione al
Lo Z-score di Altman è un indice che collega la probabilità di bancarotta di un’impresa al suo capitale
circolante, agli assets totali, ai ricavi, e ad altre variabili finanziarie.
29
92
posto del MTB ratio la crescita delle vendite ritardata di tre anni (è una variabile
strumentale), i risultati sono opposti. La misura della crescita passata è chiaramente
esogena rispetto al cash (per dirla in maniera semplice, il cash corrente non può aver
determinato la crescita delle vendite passate). Il risultato finale è che le imprese con
migliori opportunità di crescita mantengono meno cash all’interno. La spiegazione
economica è che queste imprese spendono prima di accumulare riserve. Da un punto di
vista tecnico la causa di questo risultato contraddittorio è collegata alla correzione del
problema di endogeneità presentato dal MTB attraverso i valori ritardati di tre anni
dalla crescita delle vendite.
Un altro risultato ottenuto comunemente in letteratura è la relazione negativa tra fonti
alternative di liquidità, ossia liquidità che non sia cash. L’approssimazione viene fatta
attraverso la variabile net working capital, corrispondente al nostro capitale circolante
netto.
Sono invece contraddittorie le evidenze riguardanti il rapporto tra cash flow e liquidità,
e tra dimensione e liquidità. Alcuni studi (Opler,Pinkowitz, Stulz e Williamson (1999),
Kim, Mauer e Sherman (1998), Drobetz e Gruningen (2006), Faulkender (2004),
Almeida, Campello e Weisbach (2004)) evidenziano risultati in linea con la teoria di
Baumol, che ammette la presenza di economie di scala; inoltre le imprese più grandi
sono meno affette dalle asimmetrie informative e quindi da possibili vincoli finanziari.
Questa relazione negativa però non è stata riscontrata in molti altri lavori (Ferreira e
Vilela (2004), Kytonen (2005), Garcia-Teruel e Solano (2004), Ozkan e Ozkan (2004),
Guney, Ozkan e Ozkan (2003)): in alcuni di essi vi è una relazione positiva spiegata
dal fatto che le imprese più grandi tendono ad accumulare più cash perché conseguono
risultati migliori sotto l’aspetto del cash flow (e dei profitti).
E’ una visione che si rifà alla teoria della gerarchia di finanziamento, come lo si può
affermare quando si riscontra una relazione positiva tra cash flow e cash holdings. Le
imprese con un più alto cash flow tendono a trattenerne una parte in azienda come
liquidità disponibile. Si è già parlato della discordanza tra i risultati di Kim, Mauer e
93
Sherman (1998) e Opler, Pinkowitz, Stulz e Williamson (1999). Sembra che gli studi
sulle imprese europee manifestano in linea di massima una relazione positiva, in linea
con la POT (Ginglinger e Saddour (2006), Garcia e Solano (2006), Ferreira e Vilela
(2004), Bruinshoofd e Kool (2004)).
Tuttavia la positività può essere dovuta anche al fatto che il cash flow è una misura che
approssima le future opportunità di crescita, che, come già visto, impattano
positivamente sul livello di cash. Gli studi sulle imprese americane e inglesi invece
evidenziano una relazione negativa (Ozkan e Ozkan (2004), Kim, Mauer e Sherman
(1998)). Anderson (2002) trova per le imprese inglesi risultati non significativi che
egli spiega con una relazione non lineare del cash flow con i cash holdings. L’autore
dimostra che per livelli bassi attesi di cash flow (il cash flow è una proxy del cash flow
atteso) vi è un comportamento precauzionale delle imprese che manterranno maggiore
liquidità probabili scarsità future. Al contrario per livelli di cash flow attesi
soddisfacenti l’impresa non sente la necessità di tenere liquidità a scopo prudenziale.
Tale ragionamento si collega alla volatilità del cash flow. Quasi tutti gli studi indicano
una relazione positiva tra incertezza del cash flow futuro e cash holdings (Kim, Mauer
e Sherman (1998), Opler, Pinkowitz, Stulz e Williamson (1999), Ginglinger e Saddour
(2006), Drobetz e Gruninger (2005), Qiu e Han (2006)).
Non mancano però risultati contrari. Ferreira e Vilela (2003) trovano una relazione
negativa: questo risultato deriva dal fatto che una maggiore volatilità del cash flow fa
aumentare il costo del capitale. L’impresa avrà un minore incentivo a trattenere cash
perché questo genera un ritorno molto inferiore al costo con il quale viene finanziato.
È una spiegazione che sicuramente ha la sua logicità, ma è bene osservare che la
misura della volatilità è stata fatta su un periodo di quattordici anni, periodo che risulta
insufficiente per una precisa misurazione della dispersione. Queste considerazioni
possono valere anche per la relazione non significativa trovata da Ozkan e Ozkan
(2004).
94
2.4 Cash level e Corporate Governance
L’ondata di corporate governance risalente alla fine degli anni novanta, ha interessato
molti studi sul cash holdings. Gli approcci seguiti da queste analisi sono due: il primo
è in linea con gli studi precedenti, con i quali vengono studiati gli effetti che alcune
variabili di governance hanno sul livello endogeno di cash delle imprese. Il secondo si
concentra sul valore dell’impresa. In particolare si osserva come la corporate
governance crea o distrugge valore attraverso il canale della liquidità aziendale.
In relazione alla prima tipologia, gli studi affiancano alle determinanti finanziarie
specifiche delle imprese che abbiamo precedentemente esaminato, variabili di
governance, o firm level (a livello impresa) o cross country (a livello paese).
Le prime riguardano maggiormente, per gli studi anglosassoni, la quantità di azioni
detenute dai manager o gli anti-take over provision, per gli studi europei invece la
concentrazione proprietaria, l’ultimate owner, la separazione tra proprietà e controllo.
Le seconde sono riferite a quella che Dennis e Mcconnel (2002) definiscono corporate
governance di seconda generazione.
Questo nuovo filone sulle tematiche di governance nasce con LaPorta, Lopez de
Silanes, Shleifer e Vishny (LLSV). In “Law and finance” (1998) essi ipotizzano che la
misura con la quale le leggi di un paese proteggono i diritti degli investitori è
importante per l’evoluzione della finanza d’impresa e della corporate governance. La
loro evidenza empirica indica che ci sono differenze significative tra i paesi nel grado
di protezione degli investitori, e che quei paesi con un bassa protezione sono
generalmente caratterizzati da un’alta concentrazione della proprietà di equity e da una
mancanza di mercati efficienti dell’equity. Essi hanno costruito alcune misure (la più
usata, anti director rights, e poi creditor rights, rule of law) che caratterizzano i sistemi
istituzionali e legali dei vari paesi.
Prima di addentrarci nell’analisi delle variabili specifiche di governance a livello
impresa e a livello paese, vi è da dire che la teoria del free-cash flow di Jensen, tipica
95
degli studi anglosassoni e in particolare di quelli americani, è individuabile anche
tramite alcune delle variabili finanziarie analizzate precedentemente. Esempio
lampante è il leverage. Esso, si è già detto nel primo capitolo, riduce la discrezionalità
dei manager, sottoponendoli a un maggiore controllo sia per la rigidità dei pagamenti
che si devono effettuare, sia perché inevitabilmente i manager saranno soggetti ad un
maggiore monitoraggio di chi apporta capitale di debito. Inoltre, le variabili che
approssimano le opportunità future di crescita (per le imprese quotate il MTB ratio o il
Q di Tobin, per quelle non quotate la variazione delle vendite) possono mostrare una
relazione negativa con il cash holdings perché i manager di imprese con poche
opportunità di crescita, accumuleranno lo stesso riserve liquide per finanziare
investimenti anche se questi presentano un NPV negativo.
2.4.1.Variabili di governance a livello impresa
Tornando alle variabili specifiche di governance, i primi studi si incentrano sulla realtà
anglosassone e analizzano le politiche di cash delle imprese in relazione ai costi di
agenzia derivanti dal conflitto tra manager e azionisti di minoranza.
Inizialmente si cerca di analizzare quanto un maggior grado di stake dei manager
possa influire sul cash holdings. Opler, Pinkowitz, Stulz e Williamson (1999) per le
imprese americane trovano che il possesso di una quota di azioni che va dallo 0 al 5%
da parte dei manager ha un effetto positivo sul cash holdings. Quote maggiori di
partecipazioni non portano a risultati significativi. La teoria induce a ritenere che una
maggiore partecipazione azionaria dei manager si rifletta su un minore accumulo di
liquidità. I risultati invece dimostrano l’avversione al rischio dei manager quando
detengono quote minime di azioni per proteggere il loro capitale umano. Anche
Papaioannou (1992) trova un risultato simile. L’ownership manageriale non influisce
sul cash holdings; interessano di più le condizioni di competitività del mercato in cui
96
l’impresa opera. Ozkan e Ozkan (2004), per le imprese inglesi, cercano di dimostrare
la relazione non lineare tra managerial ownership e cash holdings. Si analizza come
agisce la variabile associata al grado di shareholdings dei manager, elevandola al
quadrato e al cubo: si vuole in pratica vedere come all’aumentare della partecipazione
si modifica il cash holdings. I risultati sembrano essere in linea con la teoria che vede
prima il passaggio da un effetto allineamento ad un effetto entrenchment, per poi
ritornare all’effetto allineamento. Infatti, sebbene la variabile di managerial ownership
sia negativa ma non significativa, quella elevata al quadrato dimostra una relazione
positiva e significativa, il che pare significare un elevato grado di entrenchment dei
manager che possono disporre delle riserve di liquidità a loro piacimento. Infine la
variabile elevata al cubo influisce negativamente e significativamente sul livello di
cash, suggerendo che l’effetto allineamento domina quello di entrenchment per livelli
elevati di azioni possedute dai manager.
I risultati di Ozkan e Ozkan risultano chiaramente opposti a quelli di Opler, Pinkowitz,
Stulz e Williamson (1999). Per livelli alti di ownership manageriale infatti Opler,
Pinkowitz, Stulz e Williamson (1999) non trovano alcun risultato significativo, e
quindi né un effetto allineamento né un effetto di entrenchment. Ciò può essere
motivato da una più alta discrezione manageriale presente nelle imprese e nel sistema
UK rispetto alla realtà americana.
Nel paper di Ozkan e Ozkan vengono esaminati altri legami possibili della struttura
proprietaria con il cash holdings. Si cerca di cogliere l’aspetto più europeo della
corporate governance. Infatti è analizzata, attraverso una variabile dummy, la
concentrazione proprietaria. Sappiamo che questa è vista nei paesi anglosassoni come
un rimedio al potere di discrezionalità dei manager. Gli autori si aspettano tuttavia una
relazione positiva, in linea con la teoria che vede i grandi azionisti che detengono il
controllo estrarre benefici privati a discapito dei piccoli azionisti. Infine l’inclusione di
una variabile che indica l’identità dell’ultimate owner è una conferma di ciò che si è
detto prima. Gli autori si aspettano che le imprese guidate da una famiglia (l’impresa
97
classica europea) trattengano più cash; vi è più possibilità che vi sia commistione tra
azionisti e management a danno degli azionisti di minoranza. I risultati però non sono
in linea con le aspettative. La presenza di azionisti di controllo esercita un’influenza
positiva, ma non vi è differenza se l’ultimate owner è un’istituzione finanziaria o una
famiglia.
In Gingler e Saddour (2007) , per le imprese francesi, si trova un risultato simile.
Anche se si riscontra un effetto positivo della presenza di grandi azionisti, la famiglia
in sé non ha un impatto positivo sul livello di cash holdings. Al contrario se vi è la
possibilità di usufruire di strumenti anti-take over, chi controlla può emettere nuovo
equity senza perdere il controllo dell’azienda, fungendo in tal modo da fonte
alternativa di flessibilità al posto di riserve elevate di liquidità. Le evidenze empiriche
di Anderson e Hamadi (2002), relative ad un panel di imprese belghe, dimostrano
invece un effetto positivo della presenza di azionisti di maggioranza e in particolare
delle family firms sul livello di cash. Similmente Kalcheva e Lins (2007) trovano, per
imprese di 31 paesi diversi, una relazione positiva tra management group controllanti
(in maggior parte famiglia ed eredi) e cash holdings.
2.4.2. Indagini cross-country
Gli studi più recenti sul legame tra corporate governance e cash holdings si incentrano
sull’analisi a livello-paese, ossia attraverso variabili che variano da paese a paese, ma
che rimangono costanti per tutte le imprese di un stesso paese (Dittmar, Marth-Smith e
Servaes (2003); Pinkowitz, Williamson e Stulz (2003), Dittmar e Marth Smith (2005);
Kalcheva e Lins (2006), per citarne alcuni).
Dittmar, Marth-Smith e Servaes (2003) trovano che i problemi di agenzia sono fattori
influenti per la determinazione del cash holdings. I loro risultati rivelano che le
imprese in paesi con un basso livello di protezione degli azionisti (di minoranza)
98
mantengono al loro interno liquidità pari al doppio rispetto alle imprese di paesi dove
la protezione degli azionisti è più alta. Come variabile di governance gli autori
utilizzano le variabili di LaPorta, Lopez, Shleifer e Vishny (LLSV), non controllando a
livello d’impresa per i problemi di agenzia. Tra queste variabili di LLSV quella che
riscuote maggiormente successo è l’antidirector rights. Si tratta di un indice
determinato da leggi sulla protezione degli azionisti, che quindi rimane uguale per le
imprese all’interno di uno stesso paese. Quest’indice varia da zero a sei, laddove i
valori più alti indicano una migliore protezione a livello paese30.
Lo studio di Kalcheva e Lins (2006) è accomunato a quello di Dittmar, Marth-Smith e
Servaes (2003) in quanto anch’esso è uno studio cross-country e utilizzano entrambi
l’anti-director rights di LLSV (1998). Tuttavia il lavoro di Kalcheva e Lins (2006) può
considerarsi un’estensione di quello di Dittmar, Marth-Smith e Servaes (2003) poiché
includono anche diverse variabili riguardanti il livello impresa, come le varie forme di
controllo di gruppi di management.
I loro risultati rivelano che né l’indice di anti director rights di LLSV (1998), né la
maggior parte delle loro misure di controllo manageriale, sono significativamente
correlate al cash holdings. Gli autori quindi non possono corroborare l’ipotesi che i
problemi di agenzia forniscano una motivazione per mantenere cash in azienda.
Un lavoro molto simile e strettamente collegato a quello di Kalcheva e Lins (2006), è
quello di Hirshvogl (2006). Si tratta di uno studio cross country che, oltre ad impiegare
l’ormai nota variabile anti-director rights,
utilizza come variabile di governance
interna, un indice S&P composto da 98 criteri di trasparenza. Inoltre, similmente a
Dittmar, Marth-Smith e Servaes (2003), gli autori inseriscono nella regressione due
variabili che approssimano il grado di sviluppo dei mercati di capitale. Tale
L’indice è formato aggiungendo uno quando: 1) nel paese è permesso il voto per corrispondenza; 2) non è
richiesto agli azionisti di depositare le loro azioni prima dell’assemblea generale degli azionisti; 3) è permesso in
seno al consiglio dei direttori il voto cumulativo o la rappresentazione proporzionale delle minoranze; 4) esiste
un meccanismo di minoranza oppressa; 5) la percentuale minima di frazione di capitale azionario posseduta da
un azionista per richiedere un’assemblea straordinaria degli azionisti è minore o uguale al 10%; oppure 6) gli
azionisti hanno dei diritti di prelazione che possono essere modificati solo dal voto degli azionisti
Con riferimento all’Italia l’indice è passato da 1 a 5 con l’emanazione del TUF del 1998.
30
99
immissione, oltre a risultare necessaria per uno studio a livello internazionale, è
importante in quanto l’anti-director rights contiene indirettamente informazioni sul
grado di sviluppo dei mercati finanziari. Una buona protezione degli azionisti di
minoranza è collegata a mercati finanziari più efficienti.
I risultati di Hirshvogl (2006) sono enfatizzati proprio da questo fatto; sebbene il grado
di sviluppo del mercato dei capitali è controllato direttamente da apposite variabili,
l’influenza dell’indice di protezione degli azionisti è significativamente negativa. I
problemi di agenzia incidono positivamente sul cash holdings.
L’autore trova che, misurando separatamente le variabili firm-level e country-level, si
ottengono risultati contrastanti. La variabile firm-level ha un effetto positivo sul cash
holdings in contrasto con l’influenza negativa dell’indice di anti-director rights. Inoltre,
quando entrambi gli indici sono inseriti all’interno di un’unica regressione, questi
rimangono dello stesso segno e ugualmente significativi. Sembra che non vi sia un
effetto che prevalga su un altro. In letteratura Harford (1999) trova risultati che
indicano una decisa prevalenza dell’effetto paese su quello impresa.
2.5 Valore del cash
Gli studi sul valore del cash cercano di dare una risposta a un quesito controverso della
letteratura: quale valore assume la liquidità in ipotesi di imperfezione dei mercati
finanziari ?
Faulkender e Wang (2003) generano le stime del valore marginale del cash
esaminando le variazioni dei ritorni in eccesso degli stock durante l’anno. In
particolare stimano una regressione in cui la variabile dipendente è il ritorno in eccesso
degli stock, mentre le variabili indipendenti sono fattori specifici d’impresa che
possono impattare sul valore o che possono essere correlati con il cash holdings.
Inoltre gli autori misurano il valore del cash per le imprese definite costrette e quelle
100
definite non costrette secondo il criterio di ripartizione di Almeida, Campello e
Weisbach (2004). I risultati mostrano che il cash nelle imprese costrette assume un
valore più alto agli occhi degli azionisti rispetto alle imprese non costrette. Pinkowitz e
Williamson (2003) al contrario non riscontrano un maggiore valore del cash nelle
imprese che hanno difficoltà maggiori ad accedere al mercato dei capitali esterno.
Pinkowitz e Williamson impostano lo studio sul modello di regressione di Fama e
French (1998), dove la variabile dipendente è il valore di mercato dell’impresa e dove
nella parte destra dell’equazione vi è il livello di cash, e non la sua variazione.
I modelli differenti visti in Faulkender e Wang (2003) e in Pinkowitz e Williamson
(2003) sono successivamente riproposti in quei lavori che analizzano come la
governance, attraverso il cash, impatta sul valore dell’azienda.
Pinkowitz, Stulz e Williamson (2005) analizzano imprese di 35 paesi per un periodo di
11 anni. Come proxies per la corporate governance utilizzano il celeberrimo indice di
LLSV, l’anti-director rights e un altro indice dell’International Country Risk Guide.
Essi classificano i paesi rispetto alla mediana di questi indici e utilizzano il modello di
Fama e French (1998) per misurare l’impatto sul valore dell’impresa. I loro risultati
mostrano che nei paesi con una protezione bassa degli investitori un dollaro investito
in liquidità vale dai 0,29 ai 0,33 dollari. Hirschvogl (2006) trova risultati molto simili a
quelli di Pinkowitz, Stulz e Williamson (2004) per quanto riguarda la variabile antidirector rights. I risultati non cambiano anche con variabili di governance specifiche
d’impresa.
Dittmar e Mahrt-Smith (2005) si focalizzano sulle imprese americane per il periodo
che va dal 1990 al 2003. Essi utilizzano molte variabili governance: l’indice di
Gompers, Ishii e Metrick (2003) relativo agli emendamenti anti-takeover, l’indice di
Bebchuk, Cohen e Ferrell (2005) che è simile al precedente, e due misure che
approssimano la frazione di proprietà azionaria degli investitori istituzionali. Gli autori
però impiegano il modello di Faulkender e Wang (2003) e inseriscono una variabile di
governance alla volta nella parte destra dell’equazione. Tuttavia, come test di
101
robustezza gli autori utilizzano il modello di regressione di Fama e French (1998). I
principali risultati del loro lavoro ci dicono che per le imprese mal governate un
dollaro di cash investito incrementa il valore di mercato dell’impresa di un valore che
va da un minimo di 0,42 ad un massimo di 0,88 a seconda della variabile di
governance introdotta nel modello. Per le imprese con una buon grado di governance,
un dollaro di cash fa aumentare il valore di mercato dell’impresa di due dollari.
2.6 Come viene utilizzato il cash in eccesso?
Alcuni lavori hanno infine analizzato l’utilizzo che viene fatto da parte delle imprese
(e di chi le amministra) del cash in eccesso, ossia quella parte di liquidità trattenuta in
azienda che supera il target prestabilito da ciascuna impresa 31 . Vedere come
un’azienda spende il proprio cash può essere utile per capire con maggior chiarezza le
motivazioni alla base del cash holdings, laddove le varie analisi sulle determinanti e
sul valore del cash non sono del tutto soddisfacenti.
Opler, Pinkowitz, Stulz e Williamson (1999) esaminano anche questo punto. Come si
è già accennato prima, gli autori tramite questo studio, riescono a dare un’impronta
specifica ai loro risultati. Attraverso lo studio del livello di cash e delle sue
determinanti emerge infatti che l’investimento in liquidità è spiegato dal motivo
precauzionale o transazionale, mentre il motivo del free cash flow ha un impatto quasi
nullo. Guardando come le imprese usano il cash in eccesso essi trovano conferma dei
precedenti risultati. Infatti gli autori trovano una forte persistenza del cash in eccesso
in azienda. Ciò va contro la teoria del free cash flow che vede i manager pronti a
sperperare immediatamente le somme di cash presenti in azienda. Infatti dividendo le
aziende che presentano un eccesso di cassa in quartili, si nota che la percentuale di chi
31
Vedi paragrafo 3.1 del capitolo II.
102
entra nel quarto quartile (dove il cash in eccesso è più elevato) e vi rimane dopo 5 anni,
è del 38%. La percentuale è simile anche per le imprese del primo quartile. La
persistenza è quindi elevata sia nel quartile più alto che in quello più basso.
Successivamente gli autori si soffermano su quelle imprese che in un anno passano dal
quarto quartile al primo quartile di cash in eccesso, analizzando le cause della spesa di
cash. Viene analizzato il legame con il cash flow operativo, con le spese di
investimento, con le acquisizioni e infine con il pagamento agli azionisti. Il risultato è
chiaro e indica che queste imprese che sperimentano una variazione importante delle
disponibilità liquide in eccesso, mostrano mediamente un cash flow operativo
largamente negativo.
Mikkelson e Partch (2003) analogamente dimostrano che l’uso del cash non è
influenzato dalle variabili riferite all’ownership dell’impresa e che la spesa in
acquisizioni è abbastanza nella norma32. Anche nel loro lavoro la liquidità in eccesso33
presente nelle casse dell’azienda serve per un progetto di crescita aziendale e per
cautelarsi verso i costi elevati dei finanziamenti esterni. Essi, riprendendo il modello
d’investimento di Kaplan e Zingales (1997), dimostrano come la presenza di alti livelli
di cash riduce la dipendenza dell’investimento al cash flow, rendendolo immune da
possibili variazioni dei risultati operativi.
In questi due casi si potrebbe pensare automaticamente all’uscita di cash per le
acquisizioni come uno spreco assicurato. Ciò non è detto, o quanto meno bisogna
verificare se queste spese siano tutte dannose per le imprese. Harford (1999) dopo aver
rilevato la forte tendenza delle imprese americane a spendere contante per le
acquisizioni, trovano che l’effetto medio di investimenti in acquisizioni sulla
profittabilità futura è negativo. Questo risultato è amplificato per le imprese con un
La spesa in acquisizioni è alta ed inusuale quando vi è una forte variazione di cash nel tempo. E’ quindi
importante distinguere tra variazioni e livelli del cash holdings quando si deve analizzare la propensione a
spendere riserve di cash in acquisizioni.
33
E’ bene ricordare che Mikkelson e Partch definiscono (molto discutibilmente) le imprese ad alto cash come
quelle imprese che presentano più di un quarto dei loro assets in forma di cash.
32
103
grado di governance piuttosto basso, le cui acquisizioni distruggono valore per gli
azionisti e portano ad una più bassa profittabilità futura.
Dittmar e Mahrt-Smith (2003) sottolineano un forte legame tra corporate governance e
cash sperperato. Specificatamente le imprese con una governance mediocre dilapidano
più cash rispetto a quelle meglio governate.
Non solo, essi mettono a confronto l’influenza della governance sull’uso e
sull’accumulo di cash in eccesso. Ne viene fuori che il governo dell’impresa influenza
le politiche di cash non attraverso la decisione di accumulare ma attraverso quella di
utilizzare il cash in eccesso. Allo stesso risultato perviene che non trova differenze nel
mantenimento di cash in eccesso per le imprese con gradi di governance diversi.
Ciò implica che la governance ha un maggiore impatto sugli investimenti e sulle
decisioni operative, di quanto non lo abbia su politiche finanziarie collegate al cash.
Inoltre ciò è consistente con la nozione che l’accumulo di cash in eccesso è guidato da
fattori esterni (shock nella profittabilità, pressione competitiva, ecc..) mentre la spesa
di cash è una scelta discrezionale legata a problemi di agenzia e alla struttura della
governance.
104
CAPITOLO 3
EVIDENZE EMPIRICHE
3.1 Obiettivi dell’analisi empirica
Il lavoro empirico è diretto a studiare le determinanti del livello di cash holdings di un
panel di imprese industriali europee, sia quotate che non quotate, di dimensioni medio
grandi (con un capitale investito superiore ai 100 milioni di euro nel 2000).
Dopo una parte descrittiva sulle imprese appartenenti al nostro campione, si
verificherà la relazione tra cash holdings e diverse caratteristiche specifiche d’impresa,
attraverso una regressione con un modello ad effetti fissi.
Successivamente, seguendo molti autori in letteratura, tra i quali Opler, Pinkowitz,
Stulz e Williamson (1999); Dittmar e Mahrt-Smith (2005), si intende identificare
tramite i residui della regressione precedente, il cash in eccesso o in difetto per
ciascuna impresa e quindi analizzare la persistenza della liquidità in eccesso, nonché le
politiche finanziarie legate al possesso di un livello anomalo di liquidità.
In particolare, si intende verificare come la posizione di liquidità di un’impresa
influisca sulle politiche d’investimento delle imprese, cercando di capire se una
posizione in liquidità abbastanza forte vada a condizionare in qualche modo
l’investment cash flow sensitivity, come in letteratura è fatto da Marchica e Mura
(2007).
3.2 Sample selection
Per raggiungere gli obbiettivi dello studio, verrà utilizzato il database AMADEUS
(Analyse MAjor Database from EUropean Sources), di Bureau van Dijk.
Esso
contiene dati finanziari di più di 4 milioni di imprese provenienti da più di 30 paesi
105
europei (compresi quelli dell’Europa dell’Est), per un periodo massimo di tempo di
dieci anni. Le informazioni finanziarie provengono da ventidue voci dello Stato
Patrimoniale, ventidue dal conto economico e da ventisei indici finanziari che
riguardano la profittabilità, l’operatività, la struttura ed il personale.
La versione che verrà utilizzata è quella del 2007, per cui si hanno dati che coprono il
periodo che va dal 1995 al 2006.
Il campione comprende imprese dell’Europa continentale: Francia, Spagna, Italia,
Germania, Gran Bretagna e altri paesi minori34.
Il primo passo consiste nel selezionare tutte le imprese manifatturiere, identificate
sulla base dell’industry code 2-digit SIC.
In letteratura è ormai prassi escludere le imprese finanziarie in quanto il loro business
presenta caratteristiche peculiari e inoltre devono sottostare a regole statutarie sul
capitale. Per fare une esempio, un indice relativamente alto d’indebitamento è normale
per le imprese finanziarie, mentre lo stesso indice può, per un’impresa non finanziaria,
indicare una possibile situazione di dissesto finanziario. Allo stesso modo si escludono
le utilities perché il loro cash holding può essere soggetto ad una supervisione
regolatoria in alcuni stati. Le imprese commerciali, infine, non vengono prese in
considerazione per le differenze del ciclo monetario. Come è risaputo le imprese
commerciali presentano un ciclo monetario opposto a quello delle altre tipologie
d’imprese. Esse sono definite cash generator in quanto mostrano un ciclo finanziario
caratterizzato da tempi d’incasso e di magazzino inferiori alle dilazioni che ottengono
dai fornitori. In altre parole questi tipi d’imprese presentano gestioni in cui le uscite di
cassa (i pagamenti) sono posticipate rispetto alle entrate (gli incassi).
Caratteristica importante di Amadeus è che contiene dati di imprese quotate e non
quotate. Tuttavia, in questo lavoro, per rendere sufficientemente omogenea la qualità
dei dati, sono studiate le imprese di dimensione medio grande. Per far ciò si stabilisce
34
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Islanda, Lituania, Norvegia, Svezia, Svizzera, Grecia, Irlanda, Olanda,
Portogallo.
106
un livello minimo relativo alle attività totali, posto pari a 100 milioni di euro, per cui
vengono incluse nel campione quelle imprese con un valore contabile degli assets
totali superiore ai 100 milioni di euro.
Si è ritenuto opportuno utilizzare un campione di imprese unbalanced, nel quale il
numero delle osservazioni annuali non è lo stesso per tutte le imprese. Occorre però
fare attenzione alle distorsioni che sorgono con un panel unbalanced: attriti e entrate.
Le prime si riferiscono al fatto che le registrazioni di dati di alcune imprese possono
perdersi ad un certo punto (ad esempio l’impresa può andare in bancarotta o essere
fusa in un’altra impresa). Le seconde invece riguardano nuove imprese che in un certo
momento entrano nel panel.
Tali distorsioni non hanno effetto sulle stime se il campione risulta unbalanced per
ragioni non collegate al termine di errore. Se invece lo è per cause collegate al termine
di errore allora sorge un problema di endogeneità. L’esempio fatto in precedenza
riguardo l’uscita di un’impresa per bancarotta, o la fusione di due imprese, creano
problemi di stima non consistente.
In questo lavoro si scelgono le imprese che relativamente all’anno 2000 possiedono
assets totali per un valore superiore ai 100 mln. Durante tutto il periodo del panel non
si tiene conto delle possibili variazioni degli assets.
Ci sono due tipi di dati forniti dalle imprese: i dati consolidati e quelli non consolidati.
Per le imprese che possiedono entrambe le tipologie si tiene conto di quelli consolidati;
solo in mancanza di dati consolidati si tiene conto di quelli non consolidati. Perché è
importante questa differenza? Per prima cosa rende più comparabili gli studi europei
con quelli americani visto che Compustat riporta solo dati consolidati. Inoltre, solo con
i dati consolidati si tiene conto dell’assetto dell’impresa che è inserita nell’ambito di
un gruppo; i dati non consolidati possono dare una rappresentazione distorta della vera
natura dell’impresa. Prendendo ad esempio la nostra soglia minima dimensionale per
entrare a far parte del campione, potrebbe accadere che un’impresa superi tale soglia
solo a livello consolidato e non invece a livello di singola impresa. E’ ormai
107
consuetudine che un output di una grande impresa è spesso prodotto attraverso molte
divisioni, ognuna con una propria identità legale ed un proprio conto non consolidato.
Ad esempio BASF AG aveva un turnover consolidato di circa 30 bilioni di euro, e ne
ha uno non consolidato di circa 11.
Le caratteristiche finanziarie dell’impresa dovrebbero essere valutate a livello di
gruppo e non di individual plants, anche perché il cash flow generato da una società
può essere trasferito nell’ambito del gruppo.
Tuttavia non si reputa necessario, come accade in altri lavori, escludere le imprese che
presentano solo dati non consolidati, in quanto il nostro panel è formato da imprese di
medio grandi dimensioni, ed è lecito pensare che le imprese che presentano dati non
consolidati siano realmente indipendenti.
3. 3 Costruzione delle variabili d’interesse
Il lavoro è sviluppato stimando il seguente modello, ispirato ai lavori di Opler,
Pinkowitz, Stulz e Williamson (1999), Ozkan e Ozkan (2002), Arslan, Fbreckis,
Ozkan (2006):
CASHi,t = α + β1SIZEi,t + β2AGEi,t + β3MATURi,t + β4LEVi,t + β5SGROWTHi,t +
β6CCNi,t + β7CASHFLOWi,t + β8BANKi,t + β9INTANGi,t + β10GROUPi,t + β11LISTED
+ εi,t
Questo modello cattura le imperfezioni del mercato dei capitali, e, quindi, è capace di
fornire utili indicazioni sulla capacità di ogni azienda di accedere alle fonti esterne35.
35
Per il significato economico del modello e delle sue variabili si veda il secondo capitolo, paragrafo 2.3.3
108
Variabile dipendente
La variabile dipendente oggetto di analisi è il cash holdings (CASH). In questo lavoro
si seguirà Opler Pinkowitz, Stulz e Williamson (1999), che la misurano col rapporto
dato dal cash e cash equivalente sul totale degli assets al netto del cash e cash
equivalente. La maggior parte dei lavori sul cash holdings segue questo metodo,
utilizzando come test di robustezza la variabile usata da Kim, Mauer e Sherman (1998),
data dal rapporto tra cash e cash equivalente sulle vendite.
Nonostante l’esclusione degli outliers, la distribuzione del cash holdings può non
essere normale. Ad esempio Drobetz e Ginglinger trovano che, in linea con il test di
Jarque e Bera, sia il cash à la Opler et al. che quello di Kim et al. non sono distribuiti
normalmente. Un modo per alleviare questo problema in regressioni con dati panel è
quello di utilizzare il logaritmo in base naturale del cash ratio. È un metodo largamente
utilizzato in letteratura quando ci si occupa di distribuzioni skewed (Dittmar e Mahrt
Smith (2005)).
Variabili esplicative
Per stimare gli effetti delle opportunità d’investimento si utilizza la variazione annuale
delle vendite (SGROWTH). Nell’analisi qualitativa dei dati si è riscontrata una
mancanza di osservazioni riguardanti la voce SALES nelle imprese inglesi e norvegesi.
Tale problema è risolto considerando per queste imprese la voce OPERATIVE
REVENUE, in quanto in molti casi assume lo stesso valore della voce SALES. Per
queste imprese dunque si calcola la variazione annuale del turnover.
Come assets sostitutivi del cash si calcola il capitale circolante netto (CCN). La
variabile è data dal rapporto tra attivo circolante al netto delle passività correnti su
debiti a medio lungo periodo più mezzi propri.
109
Per determinare la variabile cash flow (CASHFLOW), si utilizza direttamente la voce
cash flow che si trova in Amadeus, che equivale alla somma ai profitti (o perdite) più
la quota di ammortamento (depreciation). Questa misura del cash flow è quella più
usata in letteratura, e inoltre meglio rappresenta una misura indiretta di liquidità. Essa
è normalizzata per il totale delle attività nette (al netto del cash).
Per l’indebitamento si utilizzano due variabili: la prima rappresenta il grado di
leverage (LEV), dato dal rapporto tra capitale netto e totale degli assets al netto del
cash. La seconda rappresenta la durata del debito (MATUR): è dato dalle passività
correnti sulle passività totali
Il debito bancario è controllato dalla variabile BANK costruita come il rapporto tra
LOAN e debiti totali.
La dimensione (SIZE) è calcolata con il logaritmo in base naturale dell’attivo totale
dell’impresa. Per l’età (AGE) invece si fa riferimento alla data di costituzione
dell’impresa. La variabile è data dal logaritmo in base naturale del numero degli anni
di vita dell’impresa al 2000.
Si tiene conto poi degli assets immateriali (INTANG). La variabile si costruisce con il
dato direttamente prelevato da Amadeus e si scala per il totale dell’attivo netto.
L’appartenenza dell’impresa ad un gruppo, è rappresentata da un indice di Amadeus,
l’”Independence Indicator”. Questo esprime, attraverso una lettera dell’alfabeto (A, B,
C, D o U), il grado di indipendenza di un’impresa. Se una compagnia è partecipata da
azionisti che detengono totalmente o direttamente più del 50% della proprietà, allora
tale impresa è contrassegnata dalla lettera C. La lettera C è anche assegnata a quelle
imprese le quali sono indicate avere un Ultimate Owner. Quando un’impresa è
considerata avere un Ultimate Owner? Quando un azionista è in possesso di più del
25% di azioni e nessuno detiene una quota superiore al 25%.
110
Se l’ownership diminuisce ad una soglia che va dal 25 al 50%, o a meno del 25%, le
lettere corrispondenti sono B o A36. Quando il grado di indipendenza non è conosciuto
(unknown).
Verranno costruite cinque variabili dummy. La prima sarà uguale a 1 se l’impresa è
del tipo U, la seconda assume valore 1 se è del tipo D, la terza assume valore 1 se è del
tipo C, la quarta che assume valore 1 se è del tipo B. La quinta prende il valore di 1 se
l’impresa è del tipo A.
Come si è già accennato, il database di Amadeus permette di fare distinzione tra
imprese quotate e non quotate. Anche qui verrà costruita una variabile dicotomica
(LISTED) che prende il valore di 1 se l’impresa risulta essere quotata su un mercato
regolamentato.
I dati che compongono le variabili sono stati infine trattati attraverso diverse
operazioni. Le osservazioni mancanti per i “non current liabilities”, “interst paid” e
“current liabilities” sono stati sostituiti con il valore 0. Come già detto in mancanza dei
dati su “sales” si utilizza “Operating Revenue”. Nel caso in cui il dato “Depreciation”,
che riguarda l’ammortamento, manchi, si calcola EBIT- Interest paid per cercare di
ottenere un’approssimazione dell’ammortamento.
Per tutte le variabili in generale (ad eccezione di log(size)) le code sotto il 5° percentile
e sopra il 95° percentile sono omogeneizzate al 5° e al 95° percentile. Infine, se
nell’indice Sales/Current assets stock, il denominatore è uguale a O e le vendite sono
presenti, tale indice sarà uguale al 95°percentile.
Rispetto alle variabili esaminate nel capitolo precedente, largamente utilizzate in
letteratura, il lavoro presenta alcune differenze.
36
Generalmente affianco alle lettere A e B si trovano dei segni che indicano il grado di certezza, riguardo
all’accuratezza, che Amadeus dà alla classificazione (il segno + significa certezza molto alta, al contrario il
segno – indica bassa certezza).
111
La prima è che non è inserita la variabile dividendi. Ciò è motivato semplicemente per
la mancanza di dati in Amadeus, nonostante lo si potrebbe rilevare calcolando MPt-1 +
Utilet - MPt. Se si ha un risultato positivo, si può stimare la distribuzione di dividendo.
Inoltre si sceglie di non utilizzare nella spiegazione del cash holdings una variabile che
approssimi l’incertezza del cash flow. Questa è sicuramente una variabile molto
importante per la descrizione del fenomeno. Tuttavia si ritiene che il periodo di dodici
anni con osservazioni annuali non sia sufficiente per un calcolo significativo della
volatilità del cash flow.
Riepilogo delle variabili d’interesse
CASH: cash and cash equivalent / total assets-cash and cash equivalent
SIZE: log total assets in euro
CF: Profit/loss + Depreciation /total assets-cash and cash equivalent
BANK: Loans/ Total debt
INTANG: intangible assets / total assets-cash and cash equivalent
CCN: Working Capital / Long term debts + Shareholder Funds (Mezzi propri)
LEV: Shareholder funds (Capitale netto) / total assets-cash and cash equivalent
MATUR: current liabilities / total liabilities
AGE: log età di ciascuna impresa al 2000
SGROWTH: ( salest – salest-1 ) / salest-1
GROUP: variabili dummies
QUOTED: variabile dummy uguale a 1 se l’impresa è quotata
112
3.3.1 Ripartizione del campione in imprese constrained e imprese unconstrained
Come esaminato nel capitolo precedente, l’obbiettivo è quello di scomporre il
campione in due sottocampioni. Uno di questi contiene quelle aziende che avranno più
probabilità di incontrare vincoli finanziari (imprese financially constrained), l’altro
contiene le imprese che si suppone non avranno di questi problemi (imprese
financially unconstrained).
In letteratura la divisione inizialmente è effettuata con un criterio unico, come in
Fazzari, Hubbard e Petersen (1988), Schiantarelli e Hu (1991) con il dividend pay out,
Gillchrist e Himmelberg con la dimensione. Successivamente si utilizzano diversi
metodi insieme, come in Kaplan e Zingales (1997), Almeida, Campello e Weisbach.
(2004) tra gli altri.
In questo studio si evitano i metodi che tagliano il campione in due in base ad un
livello di cut-off scelto endogenamente per una specifica variabile. Si utilizza invece
un indice di credit scoring, che valuta l’affidabilità creditizia e quindi il rischio
finanziario dell’impresa.
In letteratura è principalmente impiegato lo Z-score di Altman (1968) 37 . Vi sono
diversi vantaggi derivanti dall’uso di questo criterio. Il primo deriva dalla natura
“forward looking” di questa misura: essendo un indicatore che dovrebbe prevedere il
rischio di incorrere in una crisi finanziaria, potrebbe essere un criterio adeguato per
investigare sull’esistenza di un motivo precauzionale in quelle imprese che prevedono
di incontrare problemi finanziari.
Inoltre questo indice si calcola ogni anno, per cui si permette all’azienda di passare da
un sottocampione all’altro, senza dover rimanere bloccata come accade in criteri più
rigidi. Infine, esso considera un intero profilo di caratteristiche di un’impresa e le
trasforma in una statistica univariata.
37
Vedi Cleary (1999), Calmès (2004)
113
L’indice utilizzato in questo lavoro è un modello di scoring stimato relativamente ad
un campione di imprese industriali italiane di media dimensione (Barontini, 2000).
L’approccio utilizzato presenta alcuni vantaggi rispetto all’indice di Altman, sia in
merito alla dimensione del campione sul quale il modello è stimato (700 imprese
contro le 66 di Altman), sia per la metodologia di stima adottata (logit analysis e non
analisi discriminante) che permette di ottenere in modo diretto una stima della
probabilità di default. I dati si riferiscono inoltre ad un contesto europeo e sono relativi
a imprese non quotate, si può quindi ipotizzare che il modello sia maggiormente adatto
nel cogliere la rischiosità delle imprese contenute nel campione compreso nel presente
studio.
Poiché si tratta di un modello logit non vi è, come nel modello di Altman un punto di
cut-off che consente di discriminare tra imprese sane ed imprese a rischio insolvenza.
Il risultato dell’analisi logit è invece confinato, attraverso una trasformazione
logaritmica, in un intervallo compreso tra 0 ed 1, consentendo di attribuire al valore
numerico un significato di probabilità di insolvenza.
Si ritiene ragionevole classificare le imprese del nostro campione in due gruppi: al
primo gruppo apparterranno quelle imprese che presentano risultati del modello
compresi nel primo 75° percentile della distribuzione. Al secondo gruppo
apparterranno le imprese la cui probabilità di insolvenza è compresa tra il 75° ed il 99°
percentile. Le prime saranno le imprese non costrette, che si suppone non presentino
particolari problemi finanziari. Le seconde sono le imprese che sono soggette a
costrizioni finanziarie (imprese costrette).
114
3.3.2 Statistiche descrittive
La tabella 1 descrive le variabili principali impiegate nell’analisi.
Tab. 1. Descrizione delle variabili dal 1995 al 2007
Statistiche descrittive delle variabili chiave del nostro campione di imprese dal 1995 al 2007. Imprese
quotate e non quotate, con total assets > 100 milioni di euro al 2000. Tutti gli assets al denominatore
sono al netto del cash ed equivalenti. CASH è il rapporto cash and cash equivalent sulle attività nette.
SGROWTH è il tasso di variazione annuale delle vendite. LEV è definito come rapporto tra capitale
netto e attività nette. DEBTMAT è il rapporto passività correnti su totale passività. SIZE è definito
come il logaritmo naturale delle attività espresse in milioni di euro. CF (cash flow) è dato dai profitti
più l’ammortamento su attività nette. CCN, il capitale circolante netto, è dato dalle attività correnti
meno cash and cash equivalent su attività nette. AGE è la data d’incorporazione dell’impresa.
INTANG sono gli assets immateriali sul totale degli assets netti. BANK rappresenta il debito bancario,
dato dai prestiti bancari a breve termine (LOAN) sul totale debiti. SCORE è l’indice di scoring che ci
dà la probabilità di insolvenza per ogni impresa. Le colonne riportano i valori della media, la mediana,
la deviazione standard (DEVST), il 25° percentile (P_25), il 75° percentile (P_75), il 99° percentile
(P_99)
MEDIA
MEDIANA
DEVST
P_25
P_75
P_99
Cash
0,07
0,03
0,11
0
0,09
0,4
CCN
0,44
0,28
0,69
0,03
0,68
2,38
Lev
0,41
0,38
0,25
0,22
0,57
0,91
Score
-3,98
-3,45
3,44
-5,94
-1,55
1,45
Sgrowt
0,05
0,04
0,17
-0,04
0,13
0,43
Matur
0,82
0,97
0,25
0,7
1
1
Age
45,25
37
35,12
19
61
149
Size
12,44
12,2
1,25
11,69
13,01
16,22
Bank
0,25
0,15
0,27
0
0,42
0,99
INTANG
0,05
0,01
0,09
0
0,05
0,31
CF
0,04
0,03
0,09
-0,01
0,09
0,23
115
Le imprese selezionate nel nostro campione mostrano per il periodo di tempo che va
dal 1995 al 2006 un cash ratio medio pari al 7,3%. Si tratta di un risultato molto al di
sotto di quelli riscontrati nei lavori precedenti. Il lavoro di Opler, Pinkowitz, Stulz e
Williamson del 1999 trovava una cash ratio medio del 17%. In campo europeo Ferreira
e Vilela per le imprese definite dell’”EMU country” trovano una media del 14,8%,
cosi come Saddour per le imprese francesi del 15% circa. Ozkan e Ozkan trovano una
media del 12,3%, ma in questo caso si deve considerare che al denominatore
dell’indice del cash ratio le attività non sono al netto del cash.
Lo stesso discorso si può fare per la mediana: il nostro risultato del 2,6% è largamente
inferiore rispetto quelli degli studi precedenti. In Opler, Pinkowitz, Stulz e Williamson
questa corrisponde al 6,5%. Saddour per le imprese francesi osserva una mediana pari
al 9,8%. Ferreira e Vileila trovano per le imprese europee una mediana pari al 9,1%.
Andando a vedere il cash ratio per nazione (vedi Tab. 2), anche qui balzano agli occhi
notevoli differenze con i lavori in letteratura.
Tab.2 Cash ratio per nazione
Statistiche descrittive sul cash ratio per paese per l’intero campione di imprese per gli anni 1995-2007.
Il cash ratio, CASH; è misurato come cash e cash equivalents su attività totali al netto del cash. La
prima colonna riporta i paesi di appartenenza delle imprese del nostro campione: AT (Austria), BE
(Belgio), CH (Svizzera), DE (Germania), DK (Danimarca), ES (Spagna), FI (Finlandia), FR (Francia),
GB (Gran Bretagna), GR (Grecia), IE (Irlanda), IS (Islanda), IT (Italia), LT (Lituania), NL (Olanda),
NO (Norvegia), PT (Portogallo), SE.??????
Le colonne riportano i risultati per: media, mediana, deviazione standard (DEVST), 25° percentile
(P_25), 75° percentile (P_75), 99° percentile (P_99).
Paesi
MEDIA
MEDIANA
DEVST
P_25
P_75
P_99
AT
0,05
0,02
0,07
0,01
0,07
0,39
BE
0,07
0,02
0,11
0
0,09
0,4
CH
0,13
0,08
0,13
0,03
0,18
0,4
116
DE
0,07
0,03
0,09
0,01
0,09
0,4
DK
0,01
0
0,02
0
0,01
0,05
ES
0,11
0,05
0,13
0,01
0,16
0,4
FI
0,08
0,04
0,1
0,01
0,09
0,4
FR
0,07
0,02
0,11
0
0,09
0,4
GB
0,08
0,03
0,11
0,01
0,1
0,4
GR
0,05
0,01
0,09
0
0,05
0,4
IE
0,1
0,04
0,13
0,01
0,13
0,4
IS
0,02
0,01
0,04
0
0,03
0,2
IT
0,05
0,02
0,08
0
0,06
0,4
LT
0,07
0,02
0,12
0
0,06
0,4
NL
0,07
0,03
0,11
0,01
0,09
0,4
NO
0,1
0,04
0,12
0,01
0,14
0,4
PT
0,06
0,02
0,1
0
0,05
0,4
SE
0,05
0,01
0,1
0
0,05
0,4
Grafico 1. Cash ratio medio per maggiori paesi nel periodo 1995-2006
Il grafico mostra il livello di cash per le imprese dei cinque maggiori paesi europei nel periodo che va
dal 1995 al 2006. I paesi presi in considerazione sono: Italia (IT), Gran Bretagna (GB), Spagna (ES),
Francia (FR), Germania (DE).
12
10
Cash %
IT
8
GB
6
FR
4
DE
ES
2
0
Paesi
117
Comparando il nostro lavoro a quello di Ferreira e Vilela, per quattro nazioni tra le più
importanti europee si notano valori che discostano di tanti punti percentuali. Ad
esempio, le imprese italiane del loro campione hanno un cash ratio medio pari al 21%,
mentre nel nostro lavoro l’indice arriva al 4,6%, con una differenza quindi di ben 17
punti percentuali. Continuando, imprese tedesche, francesi e spagnole del lavoro di
Ferreira e Vilela mostrano un cash ratio pari rispettivamente a 14,8%, 15,9%, 8,9%
contro le nostre medie pari a 6,6%, 7%, e 10,5%.
È da rilevare, nel nostro campione d’imprese, la notevole propensione al cash holdings
da parte delle imprese spagnole rispetto a quelle degli altri grandi stati europei. Tra le
altre nazioni, solamente le imprese svizzere mostrano una frazione di cash superiore,
con quasi il 13% del capitale investito.
I nostri risultati differenti, paragonati con i paper esistenti in letteratura, possono
trovare una parziale spiegazione nel criterio dimensionale che utilizziamo per la
selezione. In effetti, i lavori citati in precedenza non mostrano metodi di selezione
simili al nostro, comprendendo tutti i tipi di impresa a partire dalle più piccole. I
risultati ottenuti nel nostro lavoro sono invece in linea con quelli di Ferrando e Pal
(2004), i quali selezionano le imprese che appartengono al campione in base ad un
criterio dimensionale, sebbene superiore al nostro (capitale investito superiore ai 250
milioni di euro, mentre nel nostro caso capitale investito superiore ai 100 milioni di
euro).38
Il forte impatto che il criterio dimensionale dovrebbe avere sul nostro campione è
supportato dalle statistiche che si osservano nella tabella 3. Si è proceduto a dividere le
imprese in sei sottogruppi in base alla dimensione. I gruppi risultano così determinati:
C’è da precisare che il campione di imprese di Ferrando e Pal presenta altre notevoli differenze quali ad
esempio il numero delle imprese il fatto che i paesi europei non sono gli stessi dei nostri (in più vi è un peso
enorme da parte delle imprese olandesi), oppure che al campione appartengono imprese di diversi settori, non
solo manifatturiere come nel nostro caso.
38
118
Gruppo 1. Imprese con attività totali per un valore comprese tra 0 e 100 milioni
di euro;
Gruppo 2. Imprese con attività totali per un valore comprese tra 100 e 200
milioni di euro;
Gruppo 3. Imprese con attività totali per un valore comprese tra 200 e 300
milioni di euro;
Gruppo 4. Imprese con attività totali per un valore comprese tra 300 e 500
milioni di euro;
Gruppo 5. Imprese con attività totali per un valore comprese tra 500 e 1000
milioni di euro;
Gruppo 6. Imprese con attività totali per un valore comprese tra i 1000 milioni e
i 3000 milioni di euro;
Gruppo 7. Imprese con attività totali per un valore superiore ai 3000 milioni di
euro.
Tab. 3. Statistiche descrittive del cash ratio per dimensione
La tabella descrive la variabile Cash and equivalent su attività totali al netto del cash per i diversi
gruppi di imprese selezionate in base alla dimensione per attività totali. Il gruppo 1 comprende le
imprese con attività totali per un valore compreso tra i 0 e i 100 milioni di euro; il gruppo 2 comprende
le imprese con attività totali per un valore compreso tra i 100 e i 200 milioni di euro; il gruppo 3
comprende le imprese con attività totali per un valore compreso tra i 200 e i 300 milioni di euro; il
gruppo 4 comprende le imprese con attività totali per un valore compreso tra i 300 e i 500 milioni di
euro; il gruppo 5 comprende le imprese con attività totali per un valore compreso tra i 500 e i 1000
milioni di euro; Il gruppo 6 comprende le imprese con attività totali per un valore compreso tra i 1000
e i 3000 milioni di euro; Il gruppo 7 comprende le imprese con attività totali superiore ad un valore di
3000 milioni di euro. Le colonne riportano: le classi di imprese ripartite in base alla dimensione
(CLASS SIZE), le osservazioni (OSS), la media, la mediana, la t-statistic delle differenze tra i gruppi,
le differenze percentuali.
119
CLASS
OSS
MEDIA
MEDIANA
T- STAT
DIFF
1
5512
12,949%
7,650%
-
-
2
12214
6,901%
6,096%
28,14
6,05%
3
5146
6,267%
2,572%
3,97
0,63%
4
4434
5,738%
2,276%
2,83
0,53%
5
3818
5,643%
2,162%
0,49
0,10%
6
2706
5,246%
1,942%
1,83
0,40%
7
1482
5,949%
1,857%
-2,68
-0,70%
SIZE
Avendo la possibilità di suddividere il campione in sottogruppi, e conoscendo le medie
e le deviazioni strandard di questi, si può ricorrere al test t per la differenza fra due
medie basate sulle varianze campionarie ponderate. È uno strumento che si utilizzerà
ogni qualvolta si hanno vari gruppi di imprese e se ne vogliano analizzare le differenze
in termini di valori medi.
In questa tabella riportiamo la t-statistic che misura la significatività delle differenze
delle medie rispettivamente tra primo e secondo gruppo, tra secondo e terzo gruppo,
tra terzo e quarto gruppo, tra quarto e quinto gruppo, tra quinto e sesto gruppo e tra
sesto e settimo gruppo.
La tabella evidenzia come al crescere della dimensione diminuisce la liquidità
posseduta dalle compagnie. Si tratta di un trend quasi lineare, in accordo con la teoria
delle economie di scala secondo cui le imprese di maggiori dimensioni detengono
meno liquidità al loro interno, a causa di minori costi di transazione. Il dato che balza
agli occhi è la differenza tra prima e seconda classe. Le imprese più piccole, che
presentano capitale investito per meno di 100 milioni di euro, presentano un livello
120
medio di cash pari quasi al 13%. La t-statistic della differenza tra primo e secondo
gruppo (pari al 6,05%) è altamente significativa (28,14).
Andando maggiormente in profondità nell’analisi descrittiva della variabile cash ratio,
si analizza la sua distribuzione distinguendo per le imprese quotate e non quotate.
L’idea, in linea con i risultati precedenti riguardanti la dimensione, è che le imprese
quotate abbiano un livello medio di liquidità inferiore a quelle non quotate, in quanto
non solo dovrebbero essere più grandi, ma dovrebbero usufruire di un accesso al
mercato dei capitali meno costoso rispetto a quello delle imprese non quotate.
Tab. 4 Cash ratio per imprese quotate e non quotate
La tabella mostra le statistiche descrittive del cash ratio medio per le imprese quotate e non quotate. Il
cash ratio è dato dal rapporto tra cash and cash equivalent e attività nette (al netto del cash). Le
colonne riportano: le classi di imprese ripartite in base alla quotazione (LISTED), le osservazioni
(OSS), la media, la mediana, la t-statistic delle differenze tra i gruppi, le differenze percentuali.
LISTED
OSS
Media
Mediana
t- stat
Diff
No
30749
6,88%
2,21%
-
-
Si
4567
10,15%
5,83%
-18,93
-3,27%
Tuttavia i risultati nella Tab. 4 ci smentiscono ed anzi evidenziano un livello medio di
liquidità per le imprese quotate superiore di più del 70% rispetto a quello delle non
quotate (rispettivamente il cash ratio medio per le quotate e le non quotate è pari a
10,15% e 6,88%). La differenza tra le due classi di aziende è altamente significativa (tstatistic pari a -18,93). Tale evidenza può essere collegata alle statistiche descrittive
della tabella precedente sulla dimensione delle imprese. Infatti si può notare che
l’ultima classe (la più grande) interrompe il trend in discesa del cash ratio medio,
121
aumentandolo rispetto alla classe 5. Si può pensare che in quest’ultima classe siano
presenti per la maggior parte imprese quotate, idea confermata da quest’ultima tabella.
Si tratta di un risultato piuttosto chiaro, che ci induce a pensare che le imprese quotate
ricerchino una posizione forte in cash con l’obiettivo di ottenere quella flessibilità
necessaria per tenere la porta aperta a qualsiasi opzione strategica, in particolare a
favorevoli opportunità di mettere in atto piani di espansione tramite acquisizioni.
D’altra parte l’elevata percentuale di cash delle imprese quotate può essere riferita agli
agency costs, in quanto l’ottenimento dei fondi dal mercato dei capitali è collegato ad
una migliore disciplina delle decisioni di investimento.
Infine, si è proceduto ad analizzare le differenze cash holdings per le imprese in base
al loro grado di indipendenza. Questo ci è fornito direttamente dai dati di AMADEUS
attraverso un indicatore chiamato “Indipendence Indicator”. Se una compagnia è
partecipata da azionisti che detengono totalmente o direttamente più del 50% della
proprietà, allora tale impresa è contrassegnata dalla lettera C. Se l’ownership
diminuisce ad una soglia che va dal 25 al 50%, o a meno del 25%, le lettere
corrispondenti sono B o A39.
Tab. 5 Cash ratio per Independence Indicator
La tabella mostra il livello di cash medio per le imprese raggruppate in base al loro grado
d’indipendenza. L’Indipendence Indicator è fornito direttamente dal database Amadeus, e
contraddistingue le imprese in base a delle lettere dell’alfabeto a seconda del loro grado
d’indipendenza. Se una compagnia è partecipata da azionisti che detengono totalmente o direttamente
più del 50% della proprietà, allora tale impresa è contrassegnata dalla lettera C. Se l’ownership
diminuisce ad una soglia che va dal 25 al 50%, o a meno del 25%, le lettere corrispondenti sono B o A.
Generalmente affianco alle lettere si trovano dei segni che indicano il grado di certezza, riguardo
all’accuratezza, che Amadeus dà alla classificazione (il segno + significa certezza molto alta, al
contrario il segno – indica bassa certezza).
39
Generalmente affianco alle lettere A e B si trovano dei segni che indicano il grado di certezza, riguardo
all’accuratezza, che Amadeus dà alla classificazione (il segno + significa certezza molto alta, al contrario il
segno – indica bassa certezza)
122
Ind.
Indicator
OSS
Media
Mediana
A
29
0,09
0,06
A+
2367
0,11
0,07
A-
969
0,08
0,05
B
10
0,17
0,06
B+
1770
0,09
0,05
B-
311
0,09
0,04
C
1190
0,06
0,02
C+
225
0,09
0,05
D
24063
0,07
0,02
U
4380
0,06
0,03
t- stat
Diff
t-statistic A-B
4,16
Differenza
(1,37%)
t-statistic B-C
5,5
Differenza
(2,22%)
t-statistic C-D
-0,32
Differenza
(-0,09%)
t-statistic D-U
2,52
Differenza
(0,4%)
I risultati della tabella 5 delineano una tendenza di fondo delle imprese maggiormente
indipendenti a detenere un livello di cash holdings medio maggiore rispetto alle altre
imprese. Per evitare di farci ingannare su alcune rilevazioni, come ad esempio il 17%
di cash medio per le imprese del gruppo B, che però corrispondono solamente a 10
osservazioni, si è proceduto al calcolo di una media ponderata dei risultati,
raggruppando le imprese in base alle lettere in 5 gruppi. Dal nostro calcolo (che non
riportiamo in tabella) emergono risultati abbastanza chiari: le imprese appartenenti al
gruppo A (le più indipendenti) mostrano un cash holdings medio pari al 10,8%, quelle
del gruppo B arrivano al 9,03%, mentre le imprese appartenenti agli altri gruppi C, D e
U denotano un cash ratio più o meno simile, rispettivamente pari a 6,81%, 6,9% e
6,49%. La t-statistic conferma la forte significatività delle differenze tra il gruppo A e
B, e tra il gruppo B e C (pari a 4,16 e 5,5).
Il fatto che le imprese che appartengono ai gruppi conservano una quota minore di
liquidità in azienda può essere spiegato dalla possibile esistenza di un canale di
finanziamento interno ai gruppi, oppure dalla maggiore facilità con cui un’impresa
123
appartenente ad un gruppo riesce ad ottenere fondi nel mercato dei capitali esterno,
grazie alle maggiori garanzie e alla maggiore forza contrattuale che si ha a livello di
gruppo.
Imprese finanziariamente costrette e non costrette
L’analisi descrittiva prosegue dividendo il nostro campione di imprese in due
sottocategorie: le imprese finanziariamente costrette (da qui in poi imprese constrained)
e quelle non costrette (unconstrained). La ripartizione avviene, come ampiamente
spiegato nei paragrafi precedenti, attraverso un modello di scoring (Barontini 2000),
che ci permette di stimare la probabilità di dissesto finanziario delle imprese
appartenenti al nostro campione. Nella tabella successiva sono riportate le statistiche
descrittive delle variabili per le imprese constrained e unconstrained. Il grafico
successivo ci mostra l’andamento nel tempo del cash ratio medio per il campione di
imprese costrette e non costrette.
Tab 6. Statistiche descrittive per imprese constrained e non constrained
Statistiche descrittive delle variabili chiave del nostro campione di imprese dal 1995 al 2007. Il
campione originale di imprese è diviso, in base ad un modello di scoring (Barontini 2000), in due
sottocampioni: imprese unconstrained e le imprese constrained. Al primo appartengono quelle imprese
il cui risultato del modello di scoring rientra nel 75° percentile della distribuzione. Al gruppo delle
constrained appartengono invece le imprese che evidenziano uno scoring compreso tra il 75°
percentile ed il 99°percentile della distribuzione.
CASH è il rapporto cash and cash equivalent sulle attività nette. SGROWTH è il tasso di variazione
annuale delle vendite. LEV è definito come rapporto tra capitale netto e attività nette. DEBTMAT è il
rapporto passività correnti su totale passività. SIZE è definito come il logaritmo naturale delle attività
espresse in milioni di euro. CF (cash flow) è dato dai profitti più l’ammortamento su attività nette.
CCN, il capitale circolante netto, è dato dalle attività correnti meno cash and cash equivalent su attività
nette. AGE è la data d’incorporazione dell’impresa. INTANG sono gli assets immateriali sul totale
degli assets netti. BANK rappresenta il debito bancario, dato dai prestiti bancari a breve termine
(LOAN) sul totale debiti. Le colonne riportano i valori della media, la mediana e deviazione standard
(DEVST) per le imprese constrained e uncostrained.
124
CONSTRAINED
UNCONSTRAINED
MEDIA
MEDIANA
DEVST
MEDIA
MEDIANA
DEVST
Cash
5,5%
2,0%
0,09
8,0%
3,1%
0,11
CCN
47,0%
26,5%
0,8
45,0%
29,7%
0,65
Lev
22,8%
18,6%
0,2
46,1%
44,1%
0,23
Score
-2,1%
-19,4%
1,04
-530,1%
-449,8%
2,91
Sgrowt
1,0%
0,3%
0,19
5,8%
5,1%
0,16
Matur
77,1%
88,6%
0,27
85,0%
98,6%
0,22
Age
3963,5%
3100,0%
29,79
4738,4%
3700,0%
36,19
Size
1240,6%
1218,8%
1,17
1246,9%
1220,2%
1,2
Bank
32,4%
28,4%
0,29
21,3%
11,7%
0,24
INTANG
5,5%
0,9%
0,09
4,9%
0,8%
0,08
CF
-4,6%
-3,9%
0,05
7,7%
6,2%
0,07
I risultati evidenziano un cash ratio medio più alto per le imprese non costrette (8%
contro il 5,5% delle imprese costrette). È una statistica importante, in quanto va contro
alcuni lavori in letteratura che spiegano livelli di cash molto alti con il motivo
precauzionale. Almeida, Campello e Weisbach (2004), Ferreira e Vilela (2005),
Ferrando e Diaz (2005), tra gli altri, trovano risultati opposti ai nostri, mostrando
livelli di cash superiori per quelle imprese che fronteggiano costrizioni finanziarie.
Una spiegazione può essere data dal fatto che il modello di scoring ci indica la forza e
la stabilità finanziaria di un’impresa, per cui le imprese non costrette sono quelle che
hanno più elevati cash flow medi (7,7% contro -4,6%), una variazione annuale delle
vendite positive maggiore rispetto alle imprese constrained (5,8% contro 1%). È
quindi presumibile, in linea con le argomentazioni di Opler, Pinkowitz, Stulz e
Williamson (1999), che le imprese più forti, con profitti maggiori, sono quelle che
trattengono maggiormente cash al loro interno. Inoltre, come asseriscono Ferrando e
125
Diaz (2005), il sistema finanziario europeo funziona in maniera diversa da quello
americano. Poiché le risorse esterne sono ottenute da intermediari finanziari più che
dal mercato dei capitali, un ritardo nel pagamento del debito corrisponde a tassi
d’interesse elevati, per cui è più costoso per le imprese con un leverage elevato essere
a corto di assets liquidi.
Nelle nostre statistiche troviamo che le imprese non costrette hanno un grado di
leverage medio che supera il doppio di quello delle costrette (46,1% contro 22,8%). Il
risultato è in linea con l’ipotesi di maggiore stabilità da parte delle imprese non
costrette.
3.4 Statistica del cash ratio per quartili della distribuzione
La tabella successiva presenta comparazioni univariate delle variabili chiavi descrittive
per quartili della distribuzione del ratio cash su assets. I quartili sono costruiti ogni
anno. Il campione è suddiviso per livelli di cash per analizzare, a livello esplorativo, se
le variabili presentano valori significativamente diversi tra i gruppi formati. In
particolare è interessante notare le differenze che sussistono tra imprese del primo
quartile e quelle del quarto quartile.
In pratica si vuole analizzare se le caratteristiche delle imprese che mantengono un alto
livello di cash, come quelle del quarto quartile, si differenziano da quelle delle imprese
che trattengono meno liquidità, come quelle del primo quartile. È usato un t-test per
testare la significatività di queste differenze tra primo e quarto quartile.
Tab. 7. Caratteristiche dell’impresa per quartili della distribuzione cash/assets
Confronti univariati di medie e mediane delle misure delle caratteristiche. I valori mediani sono tra
parentesi. Gli assets al denominatore sono tutti al netto del cash holdings. CASH è il rapporto cash and
cash equivalent sulle attività nette. SGROWTH è il tasso di variazione annuale delle vendite. LEV è
definito come rapporto tra capitale netto e attività nette. DEBTMAT è il rapporto passività correnti su
126
totale passività. SIZE è definito come il logaritmo naturale delle attività espresse in milioni di euro. CF
(cash flow) è dato dai profitti più l’ammortamento su attività nette. CCN, il capitale circolante netto, è
dato dalle attività correnti meno cash and cash equivalent su attività nette. AGE è la data
d’incorporazione dell’impresa. INTANG sono gli assets immateriali sul totale degli assets netti.
BANK rappresenta il debito bancario, dato dai prestiti bancari a breve termine (LOAN) sul totale
debiti. SCORE è l’indice di scoring che ci dà la probabilità di insolvenza per ogni impresa. La t di
Student è per il test delle differenze delle medie dal primo al quarto quartile.
Primo
Secondo
Terzo
Quarto
t di Student
quartile
quartile
quartile
quartile
CCN
0,59
0,62
0,5
0,11
47,46
Lev
0,36
0,35
0,38
0,52
-41,05
Score
-3,6
-3,5
-3,75
-5,08
27,07
Sgrowt
0,04
0,04
0,05
0,04
-0,41
Matur
0,85
0,82
0,79
0,86
-1,38
Age
41,71
46,04
47,31
46,61
-9,72
Size
12,52
12,55
12,54
12,2
17,91
Bank
0,25
0,28
0,25
0,19
15,63
INTANG
0,03
0,05
0,06
0,05
-16,94
CF
0,03
0,03
0,04
0,07
-29,14
Tuttavia, come si può notare dalla tabella le caratteristiche delle imprese non variano
tutte monotonicamente con il cash holdings, per cui comparare le imprese nel primo e
nel quarto quartile non è sufficiente per descrivere la relazione tra le caratteristiche
d’impresa e il cash holdings. A questo scopo si rendono necessari i test di regressione.
Trend che differiscono monotonicamente si notano per le variabili SIZE e Cash Flow.
Le differenze di media tra primo e quarto quartile sono molto significative. Le imprese
con maggiore cash tendono ad essere quelle con cash flows alti e di dimensioni minori.
Altre differenze significative tra medie del primo e del quarto quartile si riferiscono al
leverage. Le imprese del quartile più alto mostrano un grado di leverage pari quasi al
127
doppio (0,52 contro 0,36) delle imprese del primo quartile (t-statistic pari a -41,05).
Anche per quanto riguarda il debito bancario si nota una differenza importante, con le
imprese con maggiore liquidità che mostrano un debito bancario considerevolmente
minore rispetto alle imprese del primo quartile (0,19 contro 0,25, con t-statistic pari a
15,63). Infine, le imprese che detengono meno cash evidenziano un capitale circolante
netto cinque volte superiore le imprese del quartile più elevato, in linea con la tesi che
vede il CCN come sostituto della liquidità (t = 47,46).
3.5 Modello ad effetti fissi
Data la natura del nostro data-set, può sembrare riduttivo stimare l’equazione di
regressione solamente con un OLS. Si utilizza quindi una delle tecniche di studio dei
dati panel, il modello ad effetti fissi. Un limite di questa tecnica è che spesso la durata
del panel sia troppo breve perché si raggiungano risultati significativi. Il nostro
campione contiene dati di impresa per un massimo di dodici anni. Questo periodo si
considera sufficiente, anche in base ai lavori in letteratura, a rendere questa tecnica di
stima potenzialmente interessante.
Si tratta di una stima di un modello di cash holding statico, in cui si cerca di
controllare per gli effetti specifici d’impresa (firm-heterogeneity term) che
generalmente risultano inosservabili ma che hanno un impatto significativo sul cash
holdings. Sono effetti che dunque cambiano per ogni impresa ma che rimangono
costanti nel tempo. Per il fatto che esistono questi effetti specifici, i coefficienti stimati
in una regressione cross-sezionale risulterebbero distorti, a causa della correlazione
generata tra i repressori ed il termine di errore.
Dittmar e Mahrt Smith. (2005) aiutano a capire questo concetto tramite un esempio: si
supponga che Microsoft mantenga consistenti riserve di cash le quali sono più elevate
rispetto alle altre imprese e più grandi di quanto qualsiasi modello di regressione
128
predica (gli autori chiamano tale effetto “Bill Gates” effect). A causa della presenza di
questi effetti come il “Bill Gates” effect, stimare una regressione di cash ottimale con
OLS sui dati senza gli effetti fissi d’impresa può portare a stime distorte di altri
coefficienti, come nel caso della Microsoft nel coefficiente collegato alla dimensione
dell’impresa.
Il nostro modello statico di cash holdings risulta il seguente:
CASHi,t = α + β1SIZEi,t + β2AGEi,t + β3MATURi,t + β4LEVi,t + β5SGROWTHi,t +
β6CCNi,t + β7CFi,t + β8BANKi,t + β9INTANGi,t + β10GROUPi,t + β11LISTED +
β12YEARi + β13INDUSTRY + β14COUNTRY + εi,t
dove YEAR, INDUSTRY e COUNTRY rappresentano rispettivamente gli effetti fissi
costanti nel tempo. Questi dunque cambiano per ogni impresa ma sono fissi per una
data impresa nel tempo.
Si stima il modello statico controllandogli effetti fissi d’industria, quelli degli anni e
quelli di paese. Il modello ad effetti fissi permette di controllare per questi effetti non
osservati che rimangono relativamente stabili nel tempo. Con una cross-sectional
regression, ciò non è possibile in quanto questi effetti fissi che rimangono costanti nel
tempo porterebbero a stime di coefficienti distorte dovute alla correlazione generata
tra i repressori ed il termine di errore.
La tabella seguente mostra l’output della regressione.
Tab.8 Regressione del cash holdings sulle caratteristiche d’impresa
Regressione della variabile dipendente CASH (cash and equivalent su attività nette) sulle
caratteristiche d’impresa per il nostro campione d’imprese ottenuto dal database AMADEUS per il
periodo che va dal 1995 al 2006. Le imprese appartenenti al campione presentano total assets > 100
milioni di euro nell’anno 2000. SGROWTH è il tasso di variazione annuale delle vendite. LEV è
definito come rapporto tra capitale netto e attività nette. MATUR è il rapporto passività correnti su
totale passività. SIZE è definito come il logaritmo naturale delle attività espresse in milioni di euro. CF
(cash flow) è dato dai profitti più l’ammortamento su attività nette. CCN, il capitale circolante netto, è
dato dal working capital su debito a m/l termine più mezzi propri. AGE è la data d’incorporazione
129
dell’impresa. INTANG sono gli assets immateriali sul totale degli assets netti. BANK rappresenta il
debito bancario, dato dai prestiti bancari a breve termine (LOAN) sul totale debiti. GROUP sono le
dummy variable per il grado d’indipendenza. LISTED è una dummy variable di valore 1 se l’impresa
è quotata. YEAR sono gli effetti fissi per l’anno, rappresentati da una variabile dummy per ogni anno
dal 1995 al 2006. Le variabili COUNTRY dummy includono una variabile dummy per ogni paese del
nostro campione. Le dummy INDUSTRY sono costruite per ogni settore della classificazione SIC 2.
Le t-statistics sono in parentesi, corrette per l’eteroschedasticità con il metodo di White (1980).
StdError è l’errore standard; DF sono i gradi di libertà. ***, **, * indicano i livelli di significatività dei
coefficienti: rispettivamente 1%, 5% e 10% .
Variabili
Coefficienti
DF
Intercetta
0,23 ***
(24,05)
28235
CCN
-0,05 ***
(-52,19)
28235
Lev
0,06 ***
(23,39)
28235
Sgrowt
-0,01
(-1,57)
28235
Matur
0,04 ***
(14,09)
28235
0,00004 ***
(2,9)
28235
Age
Size
-0,01 ***
(-29,06)
28235
Bank
-0,02 ***
(-6,85)
28235
INTANG
0,003
(0,44)
28235
CF
0,15 ***
(20,59)
28235
GROUP A
0,01 **
(1,96)
28235
GROUP B
0,004
(1,57)
28235
GROUP C
0,004
(-1,36)
28235
130
GROUP D
-0,01***
(-3,41)
28235
GROUP U
0
0
LISTED
0
0
NON LISTED
-0,3 ***
(-12,18)
28235
La regressione presenta risultati pressoché simili rispetto alla regressione fatta con solo
gli effetti fissi per gli anni, e per quella fatta solo con gli effetti fissi per gli anni e per
l’industria. Per questo non si è ritenuto necessario trascrivere i risultati delle altre due
regressioni.
Analizzando gli output della regressione si nota la forte influenza, a parità di
condizioni, del cash flow sul cash holdings. È un risultato in linea con le aspettative
forniteci dalle statistiche descrittive. In letteratura risultati simili sono trovati da Opler,
Pinkowitz, Stulz e Williamson (1999), Ferreira e Vilela (2005) per le imprese europee,
Ginglinger e Saddour (2006) per le imprese francesi. Allo stesso modo Almeida,
Campello e Weisbach (2004) con la loro celebre cash flow sensibility of cash arrivano
alle stesse conclusioni. Al crescere del cash flow viene trattenuta una porzione di cash
più elevata. Tale tendenza è in linea con la Pecking Order Theory di Myers e Majluf
(1984) che prevede una relazione positiva tra cash holding e cash flow, in quanto le
aziende tendono a trattenere una parte di questo in azienda sotto forma di liquidità,
dopo aver ripagato i debiti. Ciò è confermato dalla relazione tra MATUR, l’indice che
misura i debiti a breve sui debiti totali, e cash holdings. La relazione è positiva e
significativa, il che sta a significare che la liquidità è utilizzata per ripagare il debito a
breve, che quindi a differenza di quello a medio lungo termine, assorbe in maggior
misura liquidità. Il rapporto debito bancario (BANK)-cash holdings è invece negativo.
Si tratta di un risultato in linea con la maggior parte dei lavori in letteratura (Ferreira e
131
Vilela (2005), Ozkan e Ozkan (2004))40. Una spiegazione può essere data dal fatto che
i debiti bancari sono ricontrattabili con maggiore facilità (ad esempio aprendo un conto
corrente bancario); il motivo precauzionale non sussiste perché vi è un rischio molto
basso di problemi nella rinegoziazione dei contratti finanziari con gli enti creditizi.
Sarebbe interessante in questo senso potere analizzare la capacità di debito delle
imprese e la possibilità che una maggiore capacità di debito funga da sostituto per le
politiche conservative di cash. È da aggiungere che una diminuzione del motivo
precauzionale a detenere liquidità è spiegabile col fatto che le banche si trovano in una
posizione migliore per giudicare la qualità del cliente e controllare le sue politiche
finanziarie. In questo modo le asimmetrie informative e gli agency cost diminuiscono,
così come diminuiscono le difficoltà nel reperire risorse sui mercati finanziari.
Le imprese di maggiori dimensioni trattengono meno cash, effetto più che
sufficientemente anticipato nelle statistiche descrittive sul cash. Allo stesso tempo vi è
una forte influenza dell’AGE sul cash holdings, a parità di altre condizioni. La
relazione positiva e statisticamente significativa ci dice che le imprese più mature
trattengono maggiormente cash; è un risultato che può essere spiegato con i problemi
di agenzia e con la teoria del free-cash flow di Jensen (1986). Le imprese più mature
trattengono cash in eccesso per motivi di agenzia anche perché non vi sono
opportunità d’investimento profittevoli. Tale teoria può essere confermata dal
coefficiente negativo che presentano le imprese non quotate. Le imprese quotate
quindi sono quelle che, fermo restando le altre condizioni, detengono più elevati livelli
di cash al loro interno. Queste sono anche quelle che presentano maggiormente costi di
agenzia. È però forse più ragionevole pensare che aziende mature e quotate
trattengono cash in quanto semplicemente hanno una solidità finanziaria e forza
competitiva superiore agli altri tipi di imprese. Guardando il coefficiente del cash flow
infatti le imprese sembrano fortemente profittevoli, inoltre il coefficiente del leverage
40
È opportuno osservare che vi potrebbe essere una forte correlazione tra debito a breve e debito bancario (in
quanto questo è analizzato tramite i LOANS).
132
mostra una forte significatività e segno positivo, il che sta a significare che si tratta di
imprese molto forti, con poco capitale di terzi impiegato e quindi con una maggiore
stabilità finanziaria.
Il risultato appare molto significativo. In letteratura vari sono gli studi che prevedono
una forte relazione tra cash holdings e cash flow. Altrettanto vero è, a partire da
Almeida, Campello e Weisbach (2004), che sono molti quei lavori che attribuiscono
alle imprese maggiormente costrette (quindi quelle imprese che si trovano a dover
fronteggiare vincoli finanziari) una relazione più forte tra cash holdings e cash flow, in
quanto le costrizioni finanziarie accrescono il motivo precauzionale per detenere
liquidità. Le imprese vorranno avere disponibilità liquide per evitare di dover
rinunciare a investimenti profittevoli.
Noi crediamo che tale motivo precauzionale esista, ma i nostri risultati sono più in
linea con quelli di Opler, Pinkowitz, Stulz e Williamson (1999), i quali sebbene
trovano contrariamente a noi che le imprese di maggiori dimensioni detengano
maggiormente cash, queste sono per lo più le più ricche, quelle che producono profitti
e che hanno una forte stabilità finanziaria. Il motivo precauzionale sta nella ricerca di
quella flessibilità che permetta di poter far fronte a qualsiasi evenienza futura, sia che
siano perdite registrate nel cash flow, sia che siano opportunità di investimento
profittevoli, come potrebbe esserlo un progetto di espansione tramite acquisizioni.
Il motivo precauzionale non sembra sia possibile da perseguire per quelle imprese che
invece sono più deboli e che presentano una situazione economico finanziaria non
eccessivamente positiva.
Per analizzare questo effetto abbiamo effettuato la regressione con il metodo ad effetti
fissi scomponendo il campione nei due sottogruppi in base al modello di scoring di
Barontini (2000).
133
Tab.9 Cash holdings e caratteristiche d’impresa per aziende constrained e non constrained
Regressione della variabile dipendente CASH (cash and equivalent su attività nette) sulle
caratteristiche d’impresa per il nostro campione d’imprese ottenuto dal database AMADEUS per il
periodo che va dal 1995 al 2006. Le imprese appartenenti al campione presentano total assets > 100
milioni di euro nell’anno 2000. Le imprese sono suddivise in due gruppi sulla base di un modello di
scoring che ne stima la probabilità di dissesto finanziario (Barontini 2000). Il gruppo delle constrained
rappresentano quelle imprese la cui probabilità di dissesto rientra nel primo 25° percentile della
distribuzione. Le non constrained sono quelle imprese le cui probabilità di insolvenza superano il 25°
percentile. SGROWTH è il tasso di variazione annuale delle vendite. LEV è definito come rapporto tra
capitale netto e attività nette. MATUR è il rapporto passività correnti su totale passività. SIZE è
definito come il logaritmo naturale delle attività espresse in milioni di euro. CF (cash flow) è dato dai
profitti più l’ammortamento su attività nette. CCN, il capitale circolante netto, è dato dal working
capital su debito a m/l termine più mezzi propri. AGE è la data d’incorporazione dell’impresa.
INTANG sono gli assets immateriali sul totale degli assets netti. BANK rappresenta il debito bancario,
dato dai prestiti bancari a breve termine (LOAN) sul totale debiti. GROUP sono le dummy variable
per il grado d’indipendenza. LISTED è una dummy variable di valore 1 se l’impresa è quotata. YEAR
sono gli effetti fissi per l’anno, rappresentati da una variabile dummy per ogni anno dal 1995 al 2006.
Le variabili COUNTRY dummy includono una variabile dummy per ogni paese del nostro campione.
Le dummy INDUSTRY sono costruite per ogni settore della classificazione SIC 2.
Le t-statistics sono in parentesi, corrette per l’eteroschedasticità con il metodo di White (1980).
StdError è l’errore standard; DF sono i gradi di libertà. ***, **, * indicano i livelli di significatività dei
coefficienti: rispettivamente 1%, 5% e 10%
Imprese constrained
Intercetta
SGROWT
Leverage
Matur
Bank
Age
Intang
CF
SIZE
CCN
GROUP A
GROUP B
Coefficienti
0,2***
(11,83)
-0,01
(-1,6)
0,02***
(4)
0,03***
(6,25)
-0,03***
(-7,23)
0,00005
(1,48)
0,01
(1,01)
-0,01
(-0,66)
-0,01***
(-10,05)
-0,03***
(-19,4)
-0,0004
(0,81)
0,0002
(0,97)
Imprese unconstrained
DF
Coefficienti
0,21***
DF
7110
(18,27)
21066
7110
7110
7110
7110
7110
7110
7110
7110
7110
7110
7110
0
(0,28)
0,08***
(22,25)
0,04***
(12,47)
-0,01***
(-3,22)
0,00005***
(2,82)
-0,01
(-1)
0,25***
(26,04)
-0,02***
(-25,21)
-0,06***
(-46,72)
0,01***
(2,61)
0,01***
(2,72)
21066
21066
21066
21066
21066
21066
21066
21066
21066
21066
21066
134
GROUP D
0,004
(-0,74)
-0,01**
(-2,35)
GROUP U
Listed
GROUP C
Non listed
7110
-0,002
(-0,73)
-0,005**
(-2,1)
0
0
0
0
0
0
0
0
7110
-0,02***
(-10,26)
21066
-0,03***
(-7,68)
7110
21066
21066
La tabella non evidenzia particolari differenze, se non quella ravvisabile facilmente nel
coefficiente del cash flow. Infatti, se per le imprese definite non costrette con il nostro
modello di scoring l’incidenza è positiva e statisticamente significativa, nel caso
opposto, quello delle imprese costrette, si ha a che fare con un coefficiente non
significativo, per di più con segno negativo. Ciò conferma la tesi precedente, secondo
cui sono le imprese maggiormente profittevoli a destinare parte del cash flow come
riserva di liquidità. Se torniamo sulle tabelle descrittive (vedi Tab. 6), si nota come le
imprese costrette presentano un livello di cash flow medio negativo. Le imprese che
son definite costrette attraversano sicuramente un periodo di scarsa solidità finanziaria.
Ciò può portare ad un aumento del costo del capitale, per cui non si capisce perché mai
un’impresa debba mantenere al suo interno riserve di liquidità che andrebbero a fare
aumentare ulteriormente il costo del capitale.
Infine vi è da notare come vi sia incidenza per le imprese non costrette della
condizione di appartenenza ad un gruppo sul cash holdings. Fermo restando tutte le
altre condizioni, pare che un’impresa maggiormente indipendente trattenga al suo
interno un livello più alto di cash. Ciò sta a significare che le imprese appartenenti al
gruppo possano detenere livelli più bassi di cash and equvalent (come confermato dal
coefficiente negativo per il gruppo D, sebbene significativo al 5%), probabilmente
perché condizionati da un mercato dei capitali interno che funge da sostituto del
mercato esterno e della liquidità aziendale. È anche probabile che le imprese
appartenenti al gruppo abbiano alle spalle maggiori garanzie che le permettono di
135
ottenere più facilmente fondi dall’esterno, riducendo così l’incentivo precauzionale del
cash holdings.
3.6 Misurare il cash in eccesso
Per misurare il cash in eccesso si fa riferimento alla metodologia utilizzata da Opler,
Pinkowitz, Stulz e Williamson (1999), ripresa in numerosi studi successivi, quali tra
gli altri quelli di Dittmar e Mahrt Smith (2005), Simone Hirshvogl. Essa si compone di
due step: il primo è stato già compiuto stimando la regressione sulle determinanti
specifiche del cash. Ciò porterà alla stima di un livello di cash definito normale,
necessario per le aziende in relazione alle loro caratteristiche espresse nell’equazione
di regressione.
Il secondo step consiste nella misurazione del cash in eccesso: quest’ultimo è quindi
definito come la differenza tra cash attuale e l’esponenziale del target prestabilito nello
step precedente, ossia è dato dai residui della regressione sui livelli di cash.
3.6.1 Un passo indietro. Esiste un livello ottimo di cash?
L’extra cash presuppone dunque che le imprese definiscano un livello target di cash.
La possibile esistenza di un livello obiettivo di cash che bilanci i costi ed i benefici del
detenere cash è studiata in letteratura dapprima attraverso un modello autoregressivo
di prim’ordine che indica se il cash holdings è un fenomeno mean reverting. In breve,
la mean reversion è quel fenomeno, in una serie storica, per cui i valori oscillano
attorno ad una media: quando sono più alti della media essi tendono ad abbassarsi, e
quando sono più bassi della media essi tendono ad alzarsi.
Seguendo in particolare il lavoro di Opler et al. stimiamo il seguente modello:
136
Δ(Cash/Assets)t = α + βΔ(Cash/Assets)t-1 + εt
dove εt è il termine di errore i.i.d. con media zero. Δ è un operatore di differenze prime.
Come dice il nome stesso, si tratta di un modello di regressione in cui le variabili
esplicative sono i valori passati della variabile dipendente.
Tab. 10 Modello autoregressivo del cash holdings
La tabella riporta le stime del modello di auto regressione per ogni impresa del nostro campione. Sono
poi riportate le stime per ogni impresa a seconda dello status di constrained o non constrained, quotata
o non quotata. Il CASH è la variabile cash and equivalents su attività nette.
Le t-statistics sono in parentesi, corrette per l’eteroschedasticità con il metodo di White (1980).
StdError è l’errore standard; DF sono i gradi di libertà. ***, **, * indicano i livelli di significatività dei
coefficienti: rispettivamente 1%, 5% e 10%.
Variabili
TUTTE
Intercetta
Delta cash
NON COSTRETTE
Intercetta
Delta Cash
COSTRETTE
Intercetta
Delta Cash
NON QUOTATE
Intercetta
Delta Cash
QUOTATE
Intercetta
Delta Cash
Coefficienti
0,02
(0,52)
-0,16***
(-41,81)
0
(0,92)
-0,5***
(-78,27)
-0,02
(-1,16)
-0,0041***
(-4,96)
0,03
(0,66)
-0,16***
(-38,88)
0
(-0,81)
0,18***
(10,83)
DF
25560
25560
18531
18531
6196
6196
22096
22096
3462
3462
137
I risultati in tabella ci dicono che generalmente le imprese hanno un livello di target
prestabilito, cui tendono nel medio lungo termine. Da notare è il coefficiente delle non
costrette, che potrebbe portare a pensare ad un livello di cash come obbiettivo più a
lungo termine.
Confermata l’ipotesi di esistenza di un target di cash, si dovrebbe andare più in
profondità analizzando la velocità di aggiustamento al target da parte delle imprese del
nostro campione. L’aggiustamento al target è dato dalla differenza tra il livello stimato
del target e il livello degli anni precedenti. Tale analisi non è stata fatta per non
appesantire troppo il lavoro empirico.
3.6.2 Statistiche descrittive sull’cash in eccesso
La tabella seguente mostra le statistiche descrittive del cash in eccesso ottenuto dai
residui della regressione svolta nel paragrafo ….
Tab. 11 Statistiche descrittive sull’excess cash
Media
Extra cash neg
Mediana
Extra cash pos
Extra cash neg
Extra cash pos
CASH
0,02
0,15
0,01
0,11
LEVERAGE
0,42
0,38
0,41
0,32
CCN
0,36
0,57
0,28
0,27
SCORE
-4,13
-3,61
-3,69
-2,9
SGROWT
0,04
0,05
0,04
0,04
MATUR
0,83
0,82
0,96
0,96
138
AGE
46,41
46,18
37
37
SIZE
12,46
12,56
12,23
12,23
BANK
0,24
0,25
0,15
0,15
CF
0,05
0,04
0,04
0,03
Intang
0,05
0,05
0,01
0,01
Constrained
Extra cash neg
Unconstrained
Extra cash pos
Extra cash neg
Extra cash pos
CASH
0,02
0,1
0,03
0,17
LEVERAGE
0,26
0,19
0,46
0,46
CCN
0,2
0,76
0,41
0,49
SGROWT
0,01
0,01
0,06
0,06
MATUR
0,77
0,77
0,84
0,85
AGE
39,58
41,05
48,36
48,42
SIZE
12,16
12,25
12,25
12,22
BANK
0,27
0,31
0,13
0,11
CF
-0,05
-0,05
0,07
0,08
Intang
0,05
0,05
0,05
0,05
SCORE
3.6.3 Persistenza del cash in eccesso
L’extra cash detenuto dalle imprese pare essere quindi la liquidità all’interno
dell’azienda trattenuta per motivazioni che vanno oltre le necessità dettate dalle
caratteristiche aziendali e dalle future opportunità d’investimento. Proprio per questo
139
sono numerosi gli studi che, cercando di trovare una relazione tra cash holdings e
corporate governance, analizzano il cash in eccesso. Infatti esso è visto come la
liquidità derivante da una scelta discrezionale del manager, e come tale, ci si aspetta
che questa liquidità, a causa dei comportamenti opportunistici di chi controlla
l’azienda, venga sperperata in modo molto rapido in investimenti a zero NPV ed in
acquisizioni che distruggono valore. Ciò trova conferma nei paper di Dittmar et al;
Harford (1999), Hirschvogl (2007) tuttavia esistono lavori che dimostrano come
l’excess cash è utilizzato in maniera utile. Uno di questi è quello di Opler et al. in cui
gli autori trovano che il cash in eccesso è utilizzato per coprire le perdite del cash flow
operativo.
Il nostro lavoro cerca di analizzare il cash in eccesso partendo dallo studio della
persistenza di questo fenomeno. Esaminare la persistenza è importante perché ci
permette di capire se il cash in eccesso viene rapidamente speso dal management.
Naturalmente non si deve commettere l’errore di associare automaticamente un veloce
utilizzo di questo cash con uno spreco assicurato. Per questo la persistenza ci può solo
fornire un indizio del comportamento delle aziende.
Per esaminare la durevolezza dell’extra cash si suddividono le osservazioni annuali
delle imprese del nostro campione in quartili di excess cash. Si mostra il
comportamento delle imprese negli anni successivi la loro prima entrata nel quarto
quartile (il quartile più alto) del cash in eccesso.
Tab. 12 Persistenza del cash in eccesso
Persistenza dei livelli di extra cash per le imprese selezionate in base alla prima volta che entrano nel
quartile più alto del cash in eccesso. Il cash in eccesso è l’antilogaritmo di residui derivanti dalla
regressione utilizzata per predire il logaritmo naturale del cash diviso le attività totali al netto del cash.
Le imprese sono seguite per i successivi 5 anni per determinare il quartile al quale appartengono negli
anni seguenti. Il quarto quartile è il quartile più alto di cash in eccesso. L’anno 0 è l’anno di
misurazione. I numeri mostrati rappresentano le percentuali. In parentesi troviamo i numeri delle
osservazioni annuali in ogni quartile, ogni anno.
140
T
0
Quarto
Terzo
Secondo
Primo
quartle
quartle
quartile
Quartile
70,16
18,15
7,28
4,41
(4291)
(1110)
(446)
(270)
61,94
20,93
9,86
7,27
(3211)
(1085)
(511)
(377)
56,88
22,16
11,1
9,86
(2418)
(942)
(472)
(419)
53,69
22,59
12,27
11,46
(1790)
(753)
(409)
(382)
50,06
23,85
13,69
12,4
(1247)
(594)
(341)
(309)
100
(6118)
1
2
3
4
5
Prendendo in prima istanza tutte le 6116 osservazioni cerchiamo di analizzare i
movimenti delle imprese che per 5 anni o si muovono all’interno dei quartili di extra
cash, oppure escono al di fuori di questi.
Alla fine dei 5 anni, il 50,6% rimane nel quarto quartile. È un valore abbastanza
significativo poichè mostra una forte persistenza del fenomeno. Opler, Pinkowitz,
Stulz e Williamson (1998) trovano una percentuale pari al 38% per le imprese
americane. Si potrebbe pensare che il livello di excess cash così tanto elevato e
persistente sia dovuto all’effetto delle imprese quotate (e quindi a considerazioni di
governance) che non sono state inserite nella regressione da cui derivano i residui. Un
dato ancora più significativo è che alla fine del primo anno il 70,16% delle imprese
rimane nel 4 quartile (in Opler tale dato era pari al 55%), confermando il cash holdings
come un fenomeno non affatto transitorio.
La forte persistenza non subisce notevoli differenze se si scompone il gruppo delle
6116 osservazioni in imprese costrette e non costrette sulla base del modello di scoring.
141
Tab. 13 Persistenza dell’excess cash per le imprese costrette e per le imprese non costrette
T
0
1
2
3
4
5
T
0
QUARTO
TERZO
SECONDO
PRIMO
QUARTILE
QUARTILE
QUARTILE
QUARTILE
100
(1730)
/
/
/
66,47
20,06
8,5
4,97
(1150)
(347)
(147)
(86)
58,56
23,76
10,49
7,18
(865)
(351)
(155)
(377)
54,62
24,53
11,61
9,24
(668)
(300)
(142)
(113)
48,86
25,62
13,46
12,05
(450)
(236)
(235)
(111)
45,76
27,11
14,55
12,56
(299)
(177)
(95)
(82)
QUARTO
TERZO
SECONDO
PRIMO
QUARTILE
QUARTILE
QUARTILE
QUARTILE
100
-
-
-
71,61
17,4
6,79
4,20
(3141)
(763)
(298)
(184)
63,29
19,8
9,6
7,31
(2346)
(734)
(356)
(271)
57,79
21,2
10,9
10,11
(1750)
(642)
(330)
(306)
55,53
21,43
11,81
11,23
(1340)
(517)
(285)
(271)
51,58
22,69
13,38
12,35
(948)
(417)
(246)
(227)
(4386)
1
2
3
4
5
142
Per le imprese non costrette, delle 4186 imprese che rientravano nel quartile più alto in
t = 0, si nota una persistenza pari al 51%. Per le imprese costrette la percentuale è
invece pari al 45%. Vi è una leggera differenza, ma il valore talmente alto non
permette di fare distinzioni.
3.6.4 Cash in eccesso e variazioni negli investimenti, nelle vendite e nel cash flow
Il risultato di forte persistenza ci induce a pensare che le imprese che si trovano ad
avere tra le mani una grossa quantità di cash generalmente non lo spendono nell’arco
dell’anno successivo. Dai risultati delle tabelle precedenti circa il 70% delle imprese
non utilizza il cash in eccesso, ma lo mantiene in azienda.
È perciò interessante, cercare una conferma di questo fenomeno, andando ad
analizzare, attraverso studi descrittivi, i valori medi delle variazioni delle spese
d’investimento, delle variazioni delle vendite e di quelle del cash flow (si tratta in tutti
i casi di variazioni annuali).
Tab. 14 Excess cash e DeltaV, DeltaCF, DeltaCI
La tabella mostra i valori medi e mediani delle variazioni annuali delle vendite, dei cash flow e del
capitale investito, delle imprese suddivise in base ai quartili della distribuzione del Excess cash. T+1,
T+2, T+3, T+4, T+5 sono i periodi temporali successivi alla rilevazione delle imprese in base ai
quartili. ΔCI rappresenta la variazione di capitale investito, Δ CF la variazione annuale el cash flow,
Δ V la variazione annuale delle vendite. 1, 2, 3 e 4 sono i quartili della distribuzione del cash in
eccesso.
T+1
Δ
Media
T+2
T+3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
0,03
0,02
0,03
0,05
0,02
0,02
0,01
0,03
0,01
0,01
0,01
0,02
143
CI Mediana
0,02
0,02
0,02
0,04
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,0
0,01
0,02
DEVST
0,17
0,16
0,17
0,19
0,17
0,17
0,17
0,17
0,16
0,16
0,16
0,18
Δ
Media
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
V
Mediana 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Δ
DEVST
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,15
0,15
0,15
0,15
Media
0,05
0,04
0,03
0,05
0,05
0,04
0,03
0,05
0,05
0,04
0,03
0,05
0,05
0,03
0,03
0,04
0,04
0,03
0,03
0,04
0,04
0,03
0,03
0,04
0,09
0,08
0,08
0,09
0,09
0,08
0,08
0,09
0,09
0,08
0,08
0,09
Cf Mediana
DEVST
T+4
T+5
1
2
3
4
1
2
3
4
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,01
0,02
DEVST
0,16
0,16
0,16
0,18
0,16
0,16
0,16
0,17
Δ
Media
0,03
0,03
0,02
0,02
0,03
0,04
0,04
0,03
V
Mediana 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03
Δ
Media
CI Mediana
Δ
DEVST
0,15
0,15
0,15
0,17
0,15
0,15
0,15
0,16
Media
0,05
0,04
0,04
0,05
0,05
0,04
0,04
0,05
0,04
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,03
0,04
0,09
0,08
0,08
0,09
0,09
0,08
0,08
0,09
Cf Mediana
DEVST
I risultati nelle tabelle sembrano però andare contro quelli ottenuti sulla persistenza.
Infatti si nota da parte delle imprese del quartile più alto della distribuzione, una
variazione del capitale nettamente superiore quella delle imprese appartenenti agli altri
quartili. Nel primo anno la differenza è pari quasi al doppio, e solo nell’ultimo anno
questa si appiattisce, facendo registrare livelli simili per tutti i gruppi d’imprese.
144
Ci si aspetterebbe che il comportamento di spesa sia accompagnato con maggiori
entrate e con un maggiore cash flow complessivo. Ma le variazioni delle vendite e del
cash flow non risultano particolarmente significativi per le imprese del quarto quartile.
Anzi, le imprese del primo quartile sperimentano maggiori variazioni del cash flow
rispetto alle imprese che appartengono al quartile più alto.
Ciò quindi sembra non supportare l’eclatante risultato ottenuto sulla persistenza, anche
se è bene ricordare che si tratta di una statistica a livello esplorativo. La variazione di
capitale può essere finanziata (e ciò sembra ragionevole) con fondi esterni, come ad
esempio un debito bancario; in conclusione non si può leggere la tabella come se esista
un rapporto unico tra cash holdings e investimenti, ma occorre essere consapevoli che
entrano di sicuro in gioco altre variabili di cui in queste tabelle non si tiene conto.
3.6.5 Extra cash e investment cash flow sensitivity
Per concludere, è analizzata la relazione tra cash in eccesso ed investment cash flow
sensitivity. Si vuole studiare l’impatto che l’extra cash (che ricordiamolo è il cash in
eccesso rispetto ad un livello ritenuto ottimale) ha sulla relazione cash flow –
investimento.
In letteratura sono pochi i lavori che inseriscono nell’equazione dell’investment cash
flow una variabile che tenga conto del livello di cash. Ciò è stato fatto da Fazzari,
Hubbard e Pteresen (1988) nel loro lavoro principale che mostra come la liquidità
interna iniziale porti ad una diminuzione della sensibilità dell’investimento al cash
flow per le imprese, che loro definiscono constrained. Ultimamente studi simili sono
stati fatti da Marchica e Mura (2007) e da Arslan, Ozkan e Ozkan (2005). Questi
ultimi utilizzano il livello di cash in eccesso per dividere le imprese in due
sottocampioni e stimare su entrambi i sottocampioni l’equazione d’investimento
classica. Noi invece ripercorriamo il lavoro di Marchica e Mura, inserendo
145
nell’equazione d’investimento una variabile dummy che assume valore 1 se vi è cash
in eccesso (quarto quartile della distribuzione di excess cash) e utilizzando una
variabile di interazione in cui la variabile dummy interagisce con la variabile cash flow.
La nostra equazione d’investimento risulta così determinata:
I/Kit = αi,t + β1 I/Kit-1 + β2SGROWT + β3CF/Ki,t + β4EXC + β5CF/Ki,t * EXC + εi,t
Dove:
I/Kit è la variazione annuale degli assets + ammortamento, scalato per il totale degli
assets.
I/Kit-1 è la variabile dipendente ritardata, inserita nella parte destra del’equazione.
CF/Ki,t è la variabile Cash flow su total assets.
SGROWTH è la variazione annuale delle vendite (delta sales)41
EXC è la variabile DUMMY che assume valore 1 se
CF/Ki,t * EXC è il termine d’interazione tra Cash Flow e la variabile dicotomica del
cash in eccesso (EXC)
Tab. 15 Excess Cash e Investment cash flow sensitivity
La tabella presenta l’output della regressione dell’equazione d’investimento. La prima colonna è
riferita a tutto il nostro campione d’imprese. La seconda colonna contiene la regressione effettuata con
la dummy dell’excess cash e con la variabile d’interazione CF/Ki,t * EXC su tutto il campione. La
terza e quarta colonna mostrano i coefficienti della regressione effettuata sui sottocampioni d’imprese
costrette (COSTR) e non costrette (NON COSTR) suddivisi in base alla probabilità d’insolvenza. La
quinta e la sesta colonna mostrano i risultati per le imprese ripartite in base al loro status di quotata
(LISTED) o non quotata (NON LISTED). Interceept è l’intercetta; CF/K misura il cash flow sul totale
degli assets; CF/Ki,t * EXC è la variabile d’interazione tra Cash flow e Excess cash; EXC è la dummy
che prende valore pari a 1 …..; SGROWT è la variazione annuale delle vendite; I/K i,t-1 è la variabile
dipendente ritardata inserita nella parte destra della regressione. In parentesi è riportata la t-statistics,
aggiustata con il modello di White (1980) per i problemi di eteroschedasticità. ***, **, * indicano la
significatività dei coefficienti rispettivamente all’1%, 5% e 10%. N alla prima colonna è pari a
28291.
41
La variazione annuale delle vendite è inserita per ovviare alla mancanza di dati di mercato che permettono di
calcolare il Q. In questo senso SGROWTH dovrebbe controllare per le opportunità future d’investimento.
146
Effetti
Tutte
Tutte con
Non costr
Costr
EXC
***
Intercetta
CF/K
0,008
(7,253)
0,165***
(14,673)
CF/K*EXC
SGROW
0,436***
(75,167)
EXC
I/Ki,t-1
0,022***
(4,065)
***
0,011
(8,958)
0,189***
(13,893)
-0,066***
(-2,815)
0,435***
(75,178)
-0,014***
(-5,885)
0,021***
(3,818)
Non
Listed
Listed
***
0,022
(12,702)
0,048***
(2,677)
-0,046
(-1,459)
0,456***
(66,579)
-0,014***
(-3,810)
0,003
(0,440)
***
0,034
(10,210)
0,809***
(15,827)
-0,163*
(-1,830)
0,378***
(34,852)
-0,014**
(-2,228)
0,045***
(4,158)
0, 011***
(8,209)
0,171**
(11,775)
-0,079*
(-3,076)
0,413***
(66,318)
-0,016***
(-5,933)
0,010**
(1,662)
0,012***
(3,296)
0,308***
(7,751)
-0,106*
(-1,861)
0,582***
(37,948)
-0,008
(-1,401)
0,053***
(3,901)
I risultati in tabella evidenziano innanzitutto una sensibilità elevatamente significativa
del cash flow sull’investimento. È un risultato in linea con i lavori empirici in
letteratura, a partire da Fazzari, Hubbard e Petersen (1988). Il cash flow a parità di
altre condizioni influenza in maniera forte il comportamento d’investimento. Da notare
anche l’alto coefficiente e l’alta significatività del coefficiente della variazione delle
vendite, che influisce, a parità di condizione, per quasi il 44%. È un valore che si
ripresenta nelle successive regressioni, il che indica come non solo le vendite, il
ricavato, ma anche le opportunità d’investimento che tale indice può cogliere,
influiscano positivamente sull’investimento.
Quando inseriamo nella regressione la variabile dummy sull’excess cash e la variabile
congiunta, si nota un influenza negativa del cash in eccesso sull’investimento. Tuttavia,
ciò che ci preme vedere è il comportamento della variabile CF e CF*EXC. Notiamo
che la variabile CF da sola rimane ai suoi livelli di significatività, ma di contro la
variabile d’interazione influisce negativamente e significativamente sull’investimento.
Per avere un quadro generale occorre tener presente entrambi i coefficienti, e nel
nostro caso si può affermare che il cash in eccesso faccia diminuire la sensibilità
147
dell’investimento al cash flow. Le quotate sembrano subire maggiormente l’influenza
del cash in eccesso,
Guardando le imprese costrette e non costrette, la variabile d’interazione sembra non
avere un significativo effetto per entrambi i sottocampioni (per le costrette si riscontra
una sensibilità al 10%), i quali mostrano valori opposti di sensibilità al cash flow. Le
non costrette evidenziano un coefficiente molto basso, che, se guardato globalmente
con il coefficiente d’interazione (tuttavia non significativo), arriva ad essere nullo. Le
imprese costrette invece fanno registrare un coefficiente del cash flow pari all’81%. È
un risultato significativo che sembra dirci che le imprese in difficoltà finanziaria,
dipendano fortemente dal cash flow per mettere in atto investimenti, non potendo
contare su finanziamenti esterni. Specularmente le imprese non costrette sembrano non
aver problemi di reperimento di finanziamento.
Gli ultimi risultati vengono però ribaltati se si va a guardare i coefficienti delle imprese
suddivise per quotate e non quotate. Le quotate mostrano una sensibilità pari al doppio
di quella delle non quotate. Per queste ultime tuttavia il cash in eccesso sembra influire
maggiormente sull’investimento, ma non tanto da abbassare il coefficiente del cash
flow. Ciò smentisce i risultati precedenti in quanto le imprese quotate godono di un
accesso al mercato dei capitali migliore rispetto a quello delle non quotate.
Per cercare di chiarire questi risultati all’apparenza contrastanti, si è proceduto alla
regressione dell’equazione d’investimento per le imprese costrette e non costrette,
suddivise a loro volta in quattro sottocampioni, in base al loro status di impresa
quotata o non quotata.
Tab. 16 Excess Cash e Investment cash flow sensitivity per imprese costrette e non costrette,
suddivise in quotate e non quotate
La tabella mostra le stime della regressione sull’equazione d’investimento per le imprese definite
costrette e non costrette sulla base del criterio di scoring (Barontini 2000), suddivise a loro volta a
seconda dello status di quotata o non quotata. La seconda colonna è riferita alle imprese non costrette e
no quotate (Nono costr Non listed); la terza alle imprese non costrette e quotate (Non costr, Listed); la
148
quarta alle imprese costrette e quotate (Costr, Non listed); l’ultima colonna è riferita alle imprese
costrette e quotate (Costr, Listed). Interceept è l’intercetta; CF/K misura il cash flow sul totale degli
assets; CF/Ki,t * EXC è la variabile d’interazione tra Cash flow e Excess cash; EXC è la dummy che
prende valore pari a 1 …..; SGROWT è la variazione annuale delle vendite; I/K i,t-1 è la variabile
dipendente ritardata inserita nella parte destra della regressione. In parentesi è riportata la t-statistics,
aggiustata con il modello di White (1980) per i problemi di eteroschedasticità. ***, **, * indicano la
significatività dei coefficienti rispettivamente all’1%, 5% e 10%.
Effetti
Non costr
Non costr
Costr
Costr
Non listed
Listed
Non listed
Listed
***
Intercetta
CF/K
CF/K*EXC
SGROW
EXC
I/Ki,t-1
0,021
(11,151)
0,041**
(2,163)
-0,062*
(-1,802)
0,429***
(57,781)
-0,016***
(-3,953)
-0,010
(-1,500)
0,031
(6,411)
0,091*
(1,772)
-0,059
(-0,760)
0,610***
(35,430)
-0,007**
(-0,844)
0,030*
(1,992)
***
0,035
(10,050)
0,786***
(14,690)
-0,104
(-1,077)
0,365***
(31,919)
-0,011**
(-1,636)
0,035***
(3,048)
0,030**
(2,593)
1,100***
(6,358)
-0,661**
(-2,761)
0,482***
(14,479)
-0,034*
(-1,893)
0,118***
(3,708)
La tabella mostra che le imprese non costrette mostrano un coefficiente del cash flow
molto basso, poco significativo. Si può notare una maggiore sensibilità
dell’investimento al cash flow per le imprese non quotate, in quanto si riscontra una
maggiore significatività. Anche la variabile del cash in eccesso influisce
maggiormente sulle non quotate.
Tra le imprese costrette, quelle quotate mostrano una sensibilità molto forte, con una tstatistic pari a 14,690, più di due volte e mezza quella delle imprese quotate. Il
coefficiente combinato CF*EXC ha un effetto maggiore per le quotate.
Quest’ultimo risultato pare quindi confermarci che le imprese costrette e non quotate
sono quelle che maggiormente si affidano al cash flow interno per il finanziamento
degli investimenti, non trovando facilmente risorse esterne da impiegare per le spese
d’investimento.
Infine, è interessante notare la differenza della sensibilità al variare del grado
d’indipendenza dell’impresa. La tabella seguente ci mostra i risultati delle regressione
149
per i sottogruppi d’imprese identificati in base all’Independence Indicator fornitoci da
Amadeus.
Tab. 17 Exces cash e investment cash flow sensitivity per le imprese suddivise per grado
d’indipendenza
La tabella mostra i risultati della regressione per i 5 sottogruppi d’impresa delineati in base alle lettere
A, B, C, D, U dell’Independence Indicator di Amadeus. Se una compagnia è partecipata da azionisti
che detengono totalmente o direttamente più del 50% della proprietà, allora tale impresa è
contrassegnata dalla lettera C. Se l’ownership diminuisce ad una soglia che va dal 25 al 50%, o a meno
del 25%, le lettere corrispondenti sono B o A. U si riferisce ad un grado di conoscenza non conosciuto.
Interceept è l’intercetta; CF/K misura il cash flow sul totale degli assets; CF/K i,t * EXC è la variabile
d’interazione tra Cash flow e Excess cash; EXC è la dummy che prende valore pari a 1 …..;
SGROWT è la variazione annuale delle vendite; I/Ki,t-1 è la variabile dipendente ritardata inserita nella
parte destra della regressione. In parentesi è riportata la t-statistics, aggiustata con il modello di White
(1980) per i problemi di eteroschedasticità. ***, **, * indicano la significatività dei coefficienti
rispettivamente all’1%, 5% e 10%.
Effetti
Intercetta
CF/K
CF/K*EXC
SGROW
EXC
I/Ki,t-1
A
0,004
(0,936)
0,412***
(9,432)
-0,157**
(-2,434)
0,569***
(32,945)
-0,005
(-0,750)
0,050***
(3,162)
B
C
***
0,018
(3,456)
0,235***
(3,724)
-0,154*
(-1,647)
0,537***
(22,147)
0,003
(0,313)
0,033
(1,537)
0,009
(1,283)
0,172*
(2,474)
-0,190
(-1,576)
0,444***
(15,146)
-0,001
(-0,099)
0,009
(0,340)
D
U
***
0,011
(6,952)
0,165***
(10,113)
-0,052*
(-1,794)
0,405***
(56,941)
-0,017***
(-5,726)
0,005
(0,784)
0,015***
(4,509)
0,184***
(4,691)
-0,166**
(-2,419)
0,454***
(29,388)
-0,015**
(-2,334)
0,046***
(2,991)
I risultati in tabella evidenziano una sensibilità maggiore per le imprese all’aumentare
del grado d’indipendenza. Le imprese etichettate con A in Amadeus, fanno registrare
un forte e significativo impatto del cash flow sulle politiche d’investimento. Ciò
significa che le imprese più indipendenti non possono fare affidamento su un mercato
dei capitali interni, come avviene per quelle imprese invece inglobate nei gruppi. Una
gestione accentrata della tesoreria permette infatti di travasare flussi di cassa tra
un’impresa e l’altra all’interno del gruppo a seconda del fabbisogno.
150
CONCLUSIONI
Il presente studio si pone l’obiettivo di analizzare il fenomeno del cash holdings, ossia
dell’investimento delle imprese in liquidità. Viene svolta un’accurata indagine
empirica su un campione di più di 4000 imprese europee per un periodo che va dal
1995 al 2006.
Prima di presentare il lavoro empirico, nel primo capitolo vengono evidenziate le
teorie che si trovano alla base del cash holdings. Partendo da Keynes (1936), il quale
sostiene l’esistenza di due motivi fondamentali per l’accumulo di cash, il motivo dei
costi di transazione e quello precauzionale, l’analisi teorica si sofferma sul fenomeno
dei financial constraints (Fazzari, Hubbard e Petersen (1988) e Almeida, Campello e
Weisbach (2004)). Gli studi sulle costrizioni finanziarie sono basati sulla teoria che
vede l’esistenza di una gerarchia di finanziamento, introdotta in letteratura da Myers e
Majliuf (1984). Le imprese secondo gli autori preferiscono liquidità interna e capacità
di credito per finanziare le opportunità future d’investimento rispetto alle fonti esterne.
Nel primo capitolo è inoltre riportata la teoria degli agency, e i conflitti tra chi
controlla l’impresa e gli azionisti di minoranza. Gli studi teorici ammettono una
notevole influenza di questi problemi nelle scelte d’investimento, tra cui anche la
scelta relativa l’investimento in liquidità.
Il secondo capitolo riporta invece la letteratura empirica in tutte le sue dimensioni: è
analizzata la maggior parte dei metodi empirici utilizzati in letteratura per
comprendere a fondo le ragioni per cui un’impresa investe in liquidità e per rispondere
ad un quesito comune in letteratura: se tale investimento incrementi o meno valore per
chi lo mette in atto.
Il terzo capitolo rappresenta il fulcro del lavoro, in quanto viene svolta un’analisi
empirica su un panel di imprese europee. La selezione del campione avviene
principalmente attraverso un criterio dimensionale. Vengono incluse solamente le
imprese che possiedono nell’anno 2000 total assets per un valore superiore ai 100
151
milioni di euro. Si tratta di imprese industriali europee, quotate e non quotate, reperite
mediante il database AMADEUS, che ci fornisce i dati economico finanziari delle
medesime imprese.
Nel corso del lavoro si provvede alla suddivisione del campione sulla base di un
modello di scoring (Barontini 2000), in modo da poter discernere tra imprese
finanziariamente costrette e imprese non costrette. Il motivo di questa ripartizione è
quello di poter osservare le politiche di cash differenti a seconda dei sottogruppi.
L’analisi inizia con un meticoloso studio descrittivo. Viene innanzitutto analizzata in
tutte le sue componenti e in tutte le sue sfaccettature la variabile dipendente del nostro
modello di regressione, il cash ratio, data dal rapporto cash and equivalent su attività al
netto del cash. I risultati di questa parte esplorativa rendono subito l’idea di quello che
sarà l’output della regressione.
Attraverso il metodo degli effetti fissi si stima una regressione del cash holdings sulle
caratteristiche d’impresa. Il quadro che ne viene fuori è piuttosto chiaro: le imprese
che fanno registrare livelli di cash holding maggiori sono quelle più forti, più
profittevoli e con una maggiore stabilità finanziaria. Ciò viene spiegato da una forte
influenza positiva della variabile cash flow, della variabile capitale proprio su capitale
investito. Inoltre le imprese quotate, a parità di altre condizioni, mostrano livelli di
cash elevati. Infine, suddividendo il campione, in base al rischio d’insolvenza, in
imprese costrette e imprese non costrette, si nota un coefficiente del cash flow
negativo e non significativo per le imprese che presentano un rischio di credito
maggiore (imprese costrette). Si suppone che tali imprese presentino un costo del
capitale molto elevato, e dunque non ritengono conveniente detenere liquidità in
azienda, poiché una tale politica determinerebbe un aggravio del costo del capitale.
I risultati sono in linea con la teoria di Myers e Majluf (1984): le imprese detengono
cash al loro interno, trattenendolo in larga parte dal cash flow dopo aver ripagato i
debiti a breve termine (si registra un coefficiente negativo e significativo). Tale
dinamica è spiegabile con il motivo precauzionale; le aziende più forti ricercano una
152
maggiore flessibilità per poter mettere in atto in futuro investimenti profittevoli, come
un progetto di acquisizione, o per coprire possibili perdite.
Interessanti sono poi i risultati sul debito bancario: questi incidono negativamente, a
parità di altre condizioni, sul livello di liquidità delle imprese. Il debito bancario infatti
non è rischioso dal punto di vista della ricontrattazione e inoltre riduce le asimmetrie
informative, facendo venir meno il motivo precauzionale a detenere liquidità.
Il lavoro poi prosegue con l’analisi del cash in eccesso. Dopo aver avuto la conferma,
attraverso un modello autoregressivo, che esiste all’interno delle imprese un livello
target di cash, questo viene individuato mediante una regressione simile a quella
utilizzata in precedenza. Nell’equazione si controllano gli effetti fissi, ma non sono
inserite le variabili che controllano lo status di quotata e l’appartenenza al gruppo (le
variabili dummy inserite invece nella regressione originale).
Il cash in eccesso è dato dai residui della regressione. Questo viene analizzato nella
sua persistenza, con risultati davvero molto forti. Delle imprese che entrano nel quarto
quartile della distribuzione dell’excess cash (il quartile più alto), circa il 75% si
mantiene all’interno di quel quartile un anno dopo, il che significa uno scarso utilizzo
del cash in eccesso da parte delle imprese.
Viene successivamente studiato l’impatto del cash in eccesso sul investment cash flow
sensitivity. La variabile d’interazione con il cash flow impatta negativamente
sull’investimento, il che induce a pensare che un alto livello di cash allenti la
sensibilità dell’investimento al cash flow.
Infine, sono stati ottenuti riscontri importanti per quel che riguarda la realtà dei gruppi.
I nostri risultati evidenziano, dapprima attraverso le statistiche descrittive, poi
attraverso la regressione che le imprese maggiormente indipendenti, a parità di altre
condizioni, detengano maggiormente liquidità. Inoltre nell’analisi sull’investment cash
flow sensitivity, le imprese indipendenti mostrano un fortissimo impatto del cash flow
sulle politiche d’investimento. Questi risultati portano alla conclusione che le imprese
che appartengono ad un gruppo possono usufruire di un mercato dei capitali creatosi
153
all’interno, in cui i flussi di liquidità circolano tra le divisioni a seconda del fabbisogno
che ciascuna unità all’interno del gruppo presenta.
154
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Acharya V., Almeida H., Campello M., 2005, Is cash negative debt? A hedging
perspective on corporate financial policies, London Business School IFA Working
Paper Series 2005
Akerlof G., 1970, The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market
Mechanism, Quarterly Journal of Economics, 3, 488-500
Allayannis G., Mozumdar A., 2004, The investment-cash flow sensitivity puzzle: can
negative cash flow observation explain it?, Journal of Banking and Finance 28, 901–
930
Blanchard O., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A. 1994, What do firms do with cash
windfalls?, Journal of Financial Economics 36, 337-360
Almeida H., Campello M. 2001, Financial Constraints and Investment-Cash Flow
Sensitivities: New Research Directions, Mimeo, New York University
Almeida H, Campello M., 2006, Financial constraints, asset tangibility, and corporate
investment, NBER Working Paper No.12087
Almeida H., Campello M., Weisbach M. S., 2004, The cash flow sensitivity of cash,
Journal of Finance, 59, 1777-1804
155
Barontini R., La valutazione del rischio di credito. I modelli di previsione delle
insolvenze, Il Mulino, 2000
Bates T.W., Kahle K.M., Stulz R.M., 2006, Why Do U.S. Firms Hold So Much More
Cash Than They Used To?, NBER Working Paper No. 12534
Bebchuck L., Cohen A., Ferrell A., 2004, What matters in corporate governance,
Harvard Law School working paper
Bebchuck L., Kraakman R., Triantis G., 2000, Stock Pyramids, Cross-Ownership, and
Dual Class Equity: The Creation and Agency Costs of Separating Control from Cash
Flow Rights, in Concentrated Ownership, Randall Morck ed. University of Chicago
Press
Bianchi M., Bianco M., Enriques L.,1999, Pyramidal Groups and the Separation
Between Ownership and Control in Italy, Mimeo
Blanchard O, Macroeconomia, Il Mulino, 2006
Boyle G. W., Guthrie A. G., 2003, Investment, uncertainty, and liquidity, Journal of
Finance 58, 2143-2166
Brealey R. A., Myers S. C., Sandri S, Principi di finanzia aziendale, Mc Graw Hill,
2003
Brennan M. J., The theory of corporate finance, 1996
156
Burkart M., Gromb D., Panunzi F., 1997, Large shareholders, monitoring, and the
value of the firm, Quarterly Journal of Economics 112, 693-728
Chiang Alpha C., Introduzione all’economia matematica, Bollati Boringhieri, 2000
Cleary S., 1999, The relationship between firm investment and financial status, Journal
of Finance, 54, 673-692
Cleary S., Povel P. E. M., Raith M, 2004, The U-shaped investment curve: theory and
evidence, Working Paper, CEPR
Dallocchio M., Salvi A, Finanzia aziendale, EGEA, 2005
Damodaran A., On Valuation, John Wiley, 2006
Dasgupta S., Sengupta K., 2002, Financial constraints, investment and capital
structure: Implications from a multi-period model, Working Paper, Hong Kong
University of Sience and Technology
Deloof, M., 2001, Belgian intragroup relations and the determinants of corporate
liquid reserves, European Financial Management, 7, 375-392
Demsetz H., Lehn K., 1985, The structure of corporate ownership: Causes and
Consequences, Journal of Political Economy 93, 1155-1177
Denis K., McConnell J. J., 2002, International corporate governance, Journal of
Financial and Quantitative Analysis
157
Dittmar A., Marth-Smith J., Servaes H., 2003, International corporate governance and
corporate cash holdings, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 38, 111-133
Dittmar A, Marth-Smith J., 2007, Corporate Governance and the Value of Cash
Holdings, Journal of Financial Economics, forthcoming
Easterbrook F., 1984, Two agency-cost explanations of dividends, American Economic
Review, 74: 650-659
Faccio M., Lang L., 2002, The separation of ownership and control: an analysis of
ultimate ownership in western European corporations, Journal of Financial
Economics, 65, 365- 395
Fama E., MacBeth J. 1973, Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests, Journal of
Political Economy 81, 607-636
Faulkender M.W., Wang R., 2006, Corporate Financial Policy and the Value of Cash,
Journal of Finance, 64, 1957-1990
Ericson T., Whited T., 2000, Measurement error and the relationship between
investment and Q, Journal of Political Economy, 108, 1027-1057
Fama E. F., Jensen M. C., 1983, Separation of Ownership and Control, Journal of Law
and Economics, 26, 301–325
Fazzari S. M., Hubbard R. G., Petersen B. C., 1988, Financing constraints and
corporate investment, Brookings Paper on Economic Activity, 1, 141-195
158
Fazzari S. M., Hubbard R. G., Petersen B. C., 2000, Investment-cash flow sensitivities
are useful: A comment on Kaplan and Zingales, Quarterly Journal of Economics, 115,
695-705
Ferrando A., Pal R. , 2006, Financing constraints and firm’s cash policy in the Euro
area, Working Paper Series N. 642
Ferreira M. A., Vilela A. S., 2004, Why do firms hold cash? Evidence from EMU
countries, European Financial management, 10, 295-319
Gilchrist S., Himmelberg C. P., 1995, Evidence on the role of cash flow in reduced
form investment equations, Journal of Monetary Economics 36, 541–572
Graham J., Harvey C., 2001, The Theory and Practice of Corporate Finance:
Evidence From the Field, Journal of Financial Economics, 187-243
Harford J., 1999, Corporate cash reserves and acquisitions, Journal of Finance, 19691997
Harford J., Mansi S., W. Maxwell, 2004, Corporate Governance and Firm Cash
Holdings, Working Paper, University of Washington
Hart O., Firms, Contract and Financial Structure, Oxford University Press, 2002
Hoshi T., Kashyap A., Scharfstein D., 1991, Corporate structure liquidity and
investment: evidence from Japanese panel data, Quarterly Journal of Economics 106,
33–60
159
Hubbard R. G., 1998, Capital market imperfections and investment, NBER Working
Paper, 599
Huberman, G.,1984, External financing and liquidity, Journal of Finance, 895-908
Jensen M.C., 1986, Agency costs of free-cash-flow, corporate finance, and takeovers,
American Economic Review 76, 323-329
Jensen M. C., Meckling W. H. 1976, Theory of the firm managerial behavior agency
costs and ownership structure, Journal of Financial Economics 3, 305–360
John T.A., 1993, Accounting measures of corporate liquidity, leverage, and costs of
financial distress, Financial Management, 91-100
Kalcheva I., Lins K., 2005, International Evidence on Cash Holdings and Expected
Managerial Agency Problems, Working Paper, University of Utah
Kaplan S. N., Zingales L., 1997, Do investment-cash flow sensitivities provide useful
measures of financing constraints?, Quarterly Journal of Economics, 112, 169-215
Kaplan S. N., Zingales L., 2000, Investment-cash flow sensitivities are not valid
measures of financing constraints, Quarterly Journal of Economics, 115, 705-712
Kim C. S., Mauer D., Sherman A., 1998, The determinants of corporate liquidity:
theory and evidence, Journal of Financial and Quantitative Analysis 33, 335–359
La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., 1999, Corporate Ownership Around the
World, Journal of Finance, 54(2), p. 471-517
160
La Porta, R., Lopez-de Silanes F., Shleifer A., Vishny R. W. 1998, Law and Finance,
The Journal of Political Economy, 106, 1113–1155
Mikkelson W., Partch M., 2003, Do persistent large cash reserves hinder performance,
Journal of Financial and Quantitative Analysis 38, 275-294
Mizen P., Vermeulen P. 2005, Corporate investment and cash flow sensitivity. What
drives the relationship?, ECB Working Paper, 485
Minton B., Schrand C., 1999, Does Cash Flow Volatility Affect Firm Value: Its Impact
on Discretionary Investment and the Costs of Debt and Equity Financing, Journal of
Financial Economics 54, 432-460
Modigliani F., Miller M. H., 1958, Cost of Capital, corporation finance and the theory
of investment, The American Economic Review, 48, 261-297
Moyen N. 2004, Investment-cash flow sensitivity: constrained versus unconstrained
firms, Journal of Finance, 59, 2061-2092
Myers S. C., Stewart C., 1977, Determinants of Corporate Borrowing, Journal of
Financial Economics 5, 147-175
Myers, S. C., 1984, The capital structure puzzle, Journal of Finance, 39, 575-592
Myers S. C., Majful N. S., 1984, Corporate financing decisions when firm have
investment information that investors do not have, Journal of Financial Economics,
13,187-221
161
Myers S.C., Rajan R. G., 1998, The Paradox of Liquidity, Quarterly Journal of
Economics, 113, 733-771
Opler T., Pinkowitz L., Stulz R., Williamson R., 1999, The determinants and
implications of corporate cash holdings, Journal of Financial Economics, 52, 3-46
Ozkan A., Ozkan N., 2004, Corporate cash holdings: An empirical investigation of
UK companies, Journal of Banking and Finance, 28, 2103–2134
Papaioannou G. J., Strock E., Travlos N. G., 1992, Ownership structure and corporate
liquidity policy, Managerial and Decision Economics, 13, 315-322
Pinkowitz L., Stulz R., Williamson R., 2003, Why do firms in countries with poor
protection of investor rights hold more cash?, Working Paper, NBER No.10188
Pinkowitz L., Williamson R., 2001, Bank power and cash holdings: Evidence from
Japan, Review of Financial Studies 14, 1059-1082
Pinkowitz L., Williamson R. 2004, What is a dollar worth? The market value of Cash
Holdings, Georgetown University working paper
Povel P., Raith M., 2002, Optimal Investment Under Financial Constraints: the Roles
of Internal Funds and Asymmetric Information, Mimeo, University of Minnesota and
University of Chicago
Rajan G., Zingales L., Salvare il capitalismo dai capitalisti, Einaudi, 2004
162
Roe M. J., Manager forti azionisti deboli, Il Sole 24 Ore Pirola, 1997
Ross S., Westerfield R., Jaffe J., Corporate Finance, Irwin, 1993
Saddour K., 2006, Why do French firms hold cash?, Universitè Paris Dauphine
Schiantarelli F., 1995, Financial constraints and investment: a critical review of
methodological issues and international evidence, Boston College Working Paper, 293
Scharfstein D. S., Stein, J.C., 2000, The Dark Side of Internal Capital Markets:
Divisional Rent-Seeking and Inefficient Investment, Journal of Finance, 2537–2564.
Schnure C. 1998, Who holds cash? And why?, Federal Reserve Board Working Paper
98-13
Shleifer A., R. Vishny, 1997, A survey of corporate governance, Journal of Finance 52,
737-783
Stein J., 2003, Agency, Information and Corporate Investment, Handbook of the
Economics of Finance, Vol. 1A, G. Constantinides, M. Harris and R. Stulz, eds.
Amsterdam, New York: Elsevier
Stiglitz J., A.Weiss, 1981, Credit rationing in markets with imperfect information,
American Economic Review, 71, 393–410
Tirole J., The theory of corporate finance, Princenton Univeristy Press, 2006
163
Vermeulen, P., 2002, Investment and Financing Constraints: What does the data tell,
EIFC Working Paper, 25
Whited T., 1992, Debt, liquidity constraints, and corporate investment: evidence from
panel data, Journal of Finance 47, 1425–1460
164