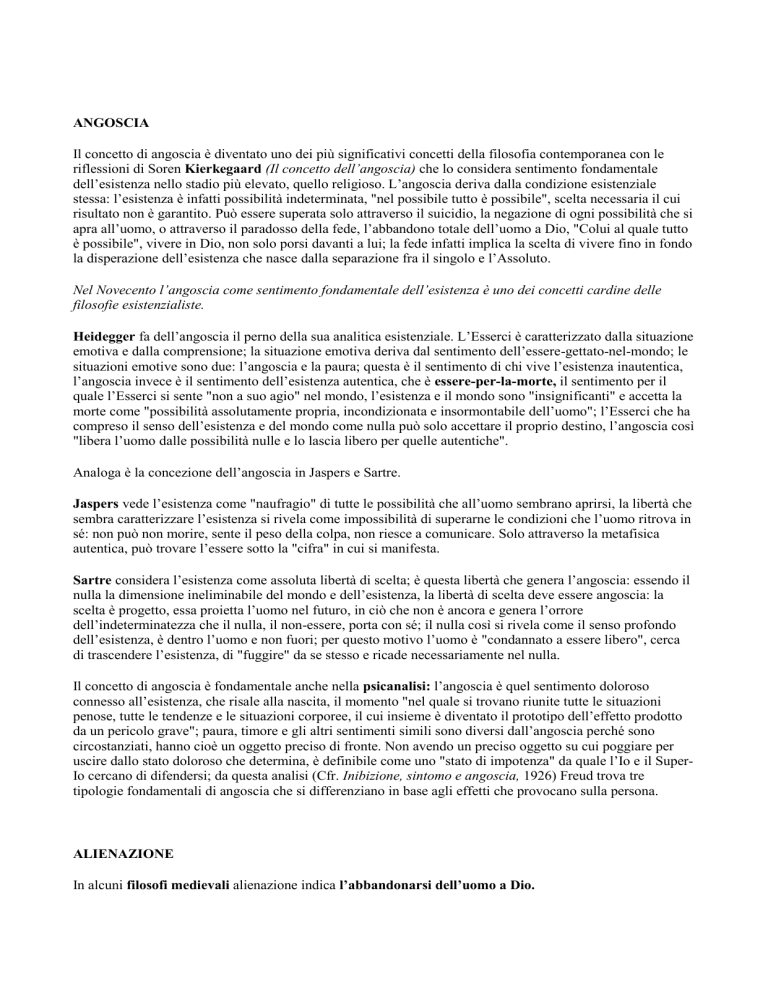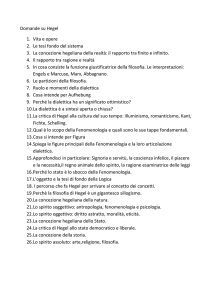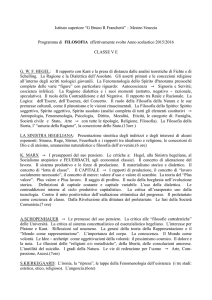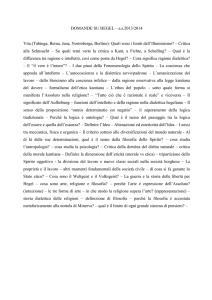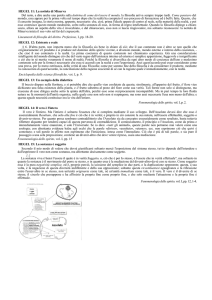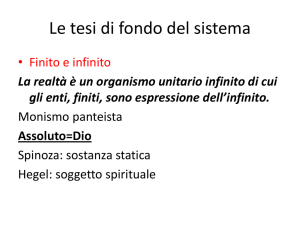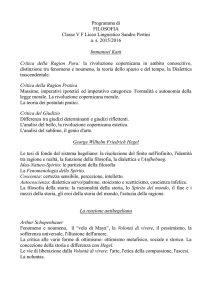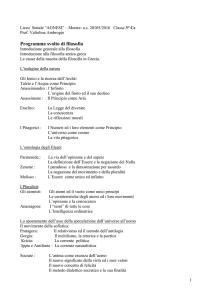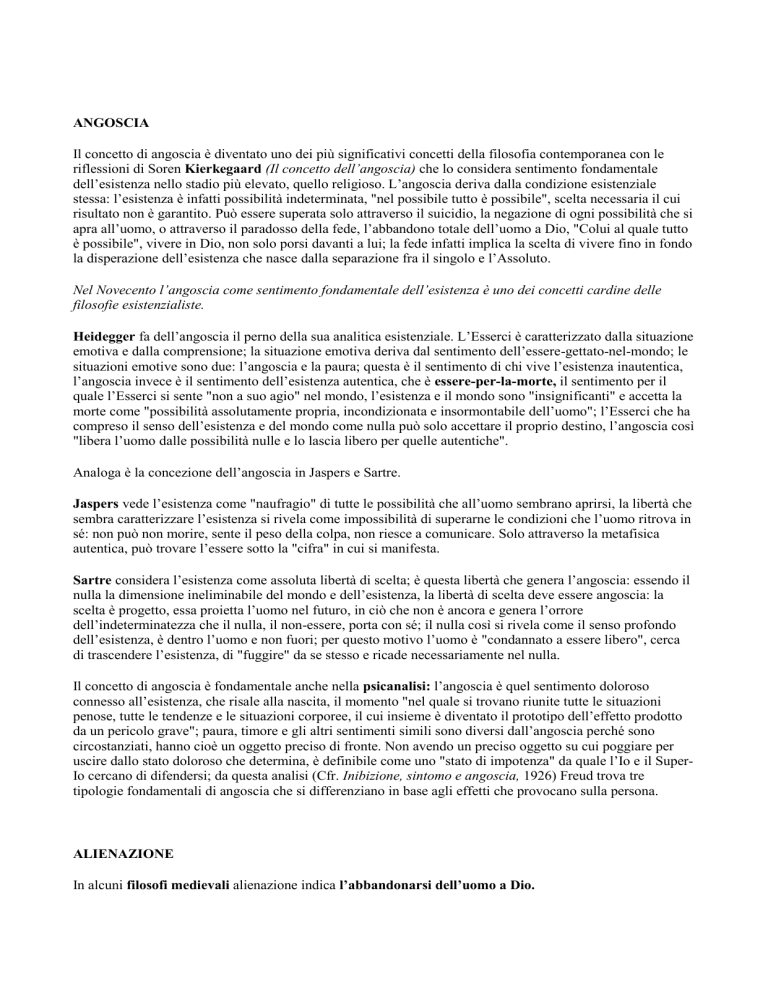
ANGOSCIA
Il concetto di angoscia è diventato uno dei più significativi concetti della filosofia contemporanea con le
riflessioni di Soren Kierkegaard (Il concetto dell’angoscia) che lo considera sentimento fondamentale
dell’esistenza nello stadio più elevato, quello religioso. L’angoscia deriva dalla condizione esistenziale
stessa: l’esistenza è infatti possibilità indeterminata, "nel possibile tutto è possibile", scelta necessaria il cui
risultato non è garantito. Può essere superata solo attraverso il suicidio, la negazione di ogni possibilità che si
apra all’uomo, o attraverso il paradosso della fede, l’abbandono totale dell’uomo a Dio, "Colui al quale tutto
è possibile", vivere in Dio, non solo porsi davanti a lui; la fede infatti implica la scelta di vivere fino in fondo
la disperazione dell’esistenza che nasce dalla separazione fra il singolo e l’Assoluto.
Nel Novecento l’angoscia come sentimento fondamentale dell’esistenza è uno dei concetti cardine delle
filosofie esistenzialiste.
Heidegger fa dell’angoscia il perno della sua analitica esistenziale. L’Esserci è caratterizzato dalla situazione
emotiva e dalla comprensione; la situazione emotiva deriva dal sentimento dell’essere-gettato-nel-mondo; le
situazioni emotive sono due: l’angoscia e la paura; questa è il sentimento di chi vive l’esistenza inautentica,
l’angoscia invece è il sentimento dell’esistenza autentica, che è essere-per-la-morte, il sentimento per il
quale l’Esserci si sente "non a suo agio" nel mondo, l’esistenza e il mondo sono "insignificanti" e accetta la
morte come "possibilità assolutamente propria, incondizionata e insormontabile dell’uomo"; l’Esserci che ha
compreso il senso dell’esistenza e del mondo come nulla può solo accettare il proprio destino, l’angoscia così
"libera l’uomo dalle possibilità nulle e lo lascia libero per quelle autentiche".
Analoga è la concezione dell’angoscia in Jaspers e Sartre.
Jaspers vede l’esistenza come "naufragio" di tutte le possibilità che all’uomo sembrano aprirsi, la libertà che
sembra caratterizzare l’esistenza si rivela come impossibilità di superarne le condizioni che l’uomo ritrova in
sé: non può non morire, sente il peso della colpa, non riesce a comunicare. Solo attraverso la metafisica
autentica, può trovare l’essere sotto la "cifra" in cui si manifesta.
Sartre considera l’esistenza come assoluta libertà di scelta; è questa libertà che genera l’angoscia: essendo il
nulla la dimensione ineliminabile del mondo e dell’esistenza, la libertà di scelta deve essere angoscia: la
scelta è progetto, essa proietta l’uomo nel futuro, in ciò che non è ancora e genera l’orrore
dell’indeterminatezza che il nulla, il non-essere, porta con sé; il nulla così si rivela come il senso profondo
dell’esistenza, è dentro l’uomo e non fuori; per questo motivo l’uomo è "condannato a essere libero", cerca
di trascendere l’esistenza, di "fuggire" da se stesso e ricade necessariamente nel nulla.
Il concetto di angoscia è fondamentale anche nella psicanalisi: l’angoscia è quel sentimento doloroso
connesso all’esistenza, che risale alla nascita, il momento "nel quale si trovano riunite tutte le situazioni
penose, tutte le tendenze e le situazioni corporee, il cui insieme è diventato il prototipo dell’effetto prodotto
da un pericolo grave"; paura, timore e gli altri sentimenti simili sono diversi dall’angoscia perché sono
circostanziati, hanno cioè un oggetto preciso di fronte. Non avendo un preciso oggetto su cui poggiare per
uscire dallo stato doloroso che determina, è definibile come uno "stato di impotenza" da quale l’Io e il SuperIo cercano di difendersi; da questa analisi (Cfr. Inibizione, sintomo e angoscia, 1926) Freud trova tre
tipologie fondamentali di angoscia che si differenziano in base agli effetti che provocano sulla persona.
ALIENAZIONE
In alcuni filosofi medievali alienazione indica l’abbandonarsi dell’uomo a Dio.
Nella filosofia moderna acquista un significato del tutto diverso; Rousseau usa il termine per indicare il
trasferimento dei diritti naturali dell’individuo alla società attraverso il contratto sociale.
Nella filosofia contemporanea il significato dominante è quello hegeliano di "essere altro da sé"; indica il
processo per il quale l’uomo perde ciò lo caratterizza, i prodotti della sua attività gli diventano estranei.
Feuerbach aveva abbandonato il significato speculativo hegeliano per considerare l’alienazione come
creazione di Dio da parte dell’uomo che proietta in una visione sublime i propri bisogni nell’illusione di
liberarsi dei problemi che la vita necessariamente porta con sé.
Legata alla visione della relazione fra uomo e merce nella società capitalistica è la lettura marxiana dove
alienazione significa processo che porta l’uomo a perdere il proprio valore di persona e a ridursi a quello
delle merci prodotte; l’alienazione dell’uomo nella società capitalistica può essere superata solo attraverso il
riconoscimento del valore umano delle merci, dove quindi il possesso non sia l’unico rapporto fra l’uomo e
gli oggetti che produce.
Nella filosofia del Novecento il concetto di alienazione è stato estremamente fecondo nel pensiero marxista
e in quello esistenzialista. Nel pensiero di Giorgy Lukàcs alienazione è sinonimo di reificazione, il farsi
cosa dell’uomo. Il valore del concetto di alienazione nella visione marxista è negato da Louis Althusser: egli
vede in esso un residuo idealistico che impedisce l’analisi rigorosa dell’uomo come "funzione" dei rapporti
di produzione; nella visione di Althusser il marxismo è antiumanismo. Particolarmente significativo il
concetto di alienazione si rivela nel pensiero esistenzialista. Sartre riprende il concetto hegeliano e intende
alienazione come "oggettivazione", come rapporto dell’uomo con le cose, rapporto che crea sempre uno
stato di disagio e di infelicità. Questo carattere dell’alienazione è stato il motivo di fondo della concezione di
Marcuse dell’uomo a una dimensione, la condizione per cui nella moderna società tecnologica l’uomo viene
schiacciato dalla logica di una organizzazione sociale tollerante solo in apparenza; essa infatti è riuscita a
integrare anche la classe operaia nella propria logica e la speranza di liberazione sta solo nella carica eversiva
dei ceti emarginati e dei popoli colonizzati.
ARTE
In Platone il concetto rappresenta l’insieme delle regole che devono essere seguite per compiere nel modo
migliore una qualsiasi attività; l’arte è genericamente tekné; arte è la poesia, la dialettica, la politica, la
guerra, la medicina, la pesca, ecc. Seguendo questa concezione anche la scienza diventa arte: il conoscere è
arte giudicativa e l’agire determinato dalla conoscenza è arte imperativa. L’arte non è espressione
dell’esperienza estetica: il bello è espressione della presenza dell’idea nella natura, l’arte è solo imitazione
della natura, di una copia dell’idea; per questo deve essere condannata, allontanando l’uomo dalla visione
dell’idea.
Aristotele distingue l’arte dalla scienza; divide il sapere in scienze teoretiche, pratiche e poietiche, l’arte
riguarda solo quest’ultimo campo: ciò che viene prodotto dall’attività dell’uomo appartiene all’arte, ciò che
classifichiamo come scienza (la matematica, la logica, la fisica ecc.) non può essere definito arte. Dell’arte
come esperienza estetica Aristotele tratta nella Poetica, di cui ci è rimasta solo la parte che tratta della
tragedia. Anche secondo Aristotele l’arte è imitazione e la tragedia è l’espressione più elevata di arte; essa
"mediante casi di pietà o di terrore produce la purificazione delle passioni". La funzione dell’arte è dunque
positiva, rappresentando la realtà umana "come potrebbe essere" e non come effettivamente è, educa alla
conoscenza. A partire dal I secolo d.C. si afferma il concetto di "arti liberali", le arti dell’uomo libero, in
contrapposizione alle "arti manuali", che contraddistinguono le classi inferiori per le quali il lavoro è
necessità. Nove sono le arti liberali che Varrone elenca: grammatica, retorica, logica, aritmetica, geometria,
astronomia, musica, architettura, medicina. Nel V secolo Marziano Capella riduce a sette le "arti liberali"
eliminando dall’elenco di Varrone l’architettura e la medicina perché non riguardano lo spirito; il nuovo
modello di Capella, diviso nella arti del trivio (grammatica, dialettica, retorica) e del quadrivio (aritmetica,
geometria, astronomia, musica) diventa l’asse degli studi per tutto il medioevo.
Oggi il termine arte ha rimasto il significato di "regole e procedure per svolgere un compito nel modo
migliore" soprattutto nel linguaggio burocratico. Comunemente indica i prodotti delle arti figurative, della
letteratura, del teatro, del cinema e fa riferimento alle teorie estetiche che riflettono i diversi concetti di
"bello" e di "gusto"
Le moderne concezioni estetiche hanno la loro origine nella Critica del giudizio. Kant intende l’arte non
come imitazione ma come attività creativa. Il bello è per Kant l’oggetto di un piacere libero da ogni
interesse, un piacere universale che non ha la sua fonte nel concetto, manifesta una finalità senza suscitare la
rappresentazione di uno scopo, viene riconosciuto come oggetto di un piacere necessario. Esso è suscitato
dallo "stato d’animo del libero gioco della fantasia e dell’intelletto" che nasce "dall’accordo della libertà
dell’immaginazione con la legalità dell’intelletto".
Dall’elaborazione kantiana si sviluppa la concezione romantica dell’arte come creatività e conoscenza.
Per Schelling l’arte è il vero "organo della filosofia" in quanto in essa sono tutt’uno l’attività inconscia e
quella cosciente dell’intelletto e proprio per questa ragione è assolutamente libera. La creatività del Genio
rappresenta la prosecuzione dell’attività creatrice dell’Assoluto.
Anche in Hegel l’arte è attività creativa e conoscitiva a un tempo e perciò manifestazione dello spirito
assoluto; si differenzia dalla religione e dalla filosofia solo per il modo, maggiormente legato alla sensibilità,
di rappresentare l’assoluto. La filosofia quindi rappresenta anche il superamento dell’arte, che è destinata alla
morte.
Schopenhauer riprende la concezione platonica del bello come rivelatore dell’idea che si nasconde nel reale
e l’arte diventa strumento di contemplazione ideale attraverso il quale l’uomo può cominciare a liberarsi
della volontà di vivere sottraendo la propria rappresentazione ai vincoli della causalità che caratterizzano il
principio di ragione.
Grande importanza, per certi sviluppi contemporanei, ha anche l’estetica positivista per la quale l’opera
d’arte deve rappresentare la realtà così come essa è, nella sua crudezza, nella sua violenza; la ricerca artistica
è un mezzo che si deve avvalere dei risultati delle scienze per rappresentare, capire la realtà e l’uomo che in
essa agisce. L’arte non è solo un momento di conoscenza, è anche strumento di denuncia, in alcuni casi, Zola
ad esempio, utile a modificare la società.
La stessa valutazione va fatta per la concezione nietzschiana dell’arte che ripropone il carattere pratico
dell’esperienza estetica. L’arte è lo strumento di liberazione dell’uomo perché "è un’esaltazione del
sentimento della vita e uno stimolante della vita"; l’arte, in quanto espressione del sentimento, è
assolutamente libera e perciò superiore alla ragione che lentamente uccide la vitalità dell’uomo e perciò
espressione dell’ebbrezza dionisiaca.
Nel Novecento la riflessione sui problerni estetici ha una rilevanza enorme, anche perché è questo il secolo
della "società di massa", della società in cui l’istruzione si è diffusa capillarmente e in cui il prodotto
artistico ha dato origine a una vera e propria industria culturale. L’Europa, che fino alla prima guerra
mondiale era stata il vero teatro della politica internazionale, diventa una regione del mondo in contatto con
le altre; la cultura europea si confronta con le altre culture e mette in discussione il valore dei suoi risultati;
ne deriva la perdita di una precisa identità culturale e la coscienza di una profonda crisi. Il confronto
interculturale e lo sviluppo dei mezzi di comunicazione rendono sempre più complesso il dibattito sul ruolo
dell’artista e sui fini dell’arte; emergono posizioni contrastanti: alcuni vedono la ragion d’essere dell’arte
nell’impegno politico-sociale, altri nel completo disinteresse per questi problemi, altri ancora cercano
nell’intimità della propria coscienza il senso dell’esistenza.
Va ricordato prima di tutto il pensiero di Benedetto Croce che ha, soprattutto in Italia, condizionato
largamente la critica estetica almeno fino a tutti gli anni 50. Per Croce l’arte è intuizione che si fa
espressione, è cioè un atto conoscitivo non concettuale che si fonda sul sentimento espresso in una sua
forma originale. L’arte è fondamentalmente linguaggio: estetica e linguistica, sotto questo profilo diventano
un’unica cosa e, di conseguenza, sono arbitrarie tutte le classificazioni dei generi artistici. Ogni opera d’arte,
in quanto espressione di un sentimento, deriva dalla fantasia e non dalla volontà, volontaria è solo
l’estrinsecazione dell’espressione, mai l’espressione in sé e ogni linguaggio è solo una tecnica che l’artista
usa per esprimere la propria intuizione. In questo senso l’arte è per Croce una manifestazione necessaria
della vita umana che si sviluppa autonomamente attraverso categorie proprie.
Anche per John Dewey il momento estetico può essere scoperto in ogni esperienza e essere proposto come
oggetto "percepibile come bene immediato" che è fine a se stesso; l’arte infatti è un’attività che nasce
direttamente dall’esperienza umana, la danza ad esempio è la rappresentazione artistica dell’armonia dei
movimenti del corpo nella quale questa armonia è diventata fine a se stessa e momento di fruizione
autonoma.
La concezione dell’arte come momento di impegno politico-sociale è caratteristica delle filosofie marxiste.
Giorgy Lukács sostiene che un’arte che esprima veramente la realtà rappresentandone le dinamiche sociali
favorisce il progresso e la rivoluzione contribuendo alla formazione della coscienza di classe.
Ernst Bloch sostiene che l’arte è espressione fantastica del fine che guida la storia verso l’emancipazione
dell’uomo.
All’arte come impegno critico Jean Paul Sartre dedica un saggio importante, Che cos’è la letteratura
(1947); in questo scritto analizza la responsabilità che lo scrivere comporta, "noi non vogliamo aver
vergogna di scrivere e non abbiamo voglia di scrivere senza dir niente"; l’artista ha la responsabilità delle
parole e delle verità che esse contengono, il fine dell’arte è perciò essenzialmente critico e per questo ha
bisogno di una precisa scelta di campo; l’arte non può mai essere neutrale; senza una precisa scelta politica
l’artista è condannato al silenzio, nel senso che quello che scrive non può essere inteso.
Una posizione molto simile ha avuto in Italia Elio Vittorini, che nella polemica con Togliatti sul senso
dell’impegno dell’artista e dell’intellettuale scrive: "il diritto di parlare non deriva agli uomini dal fatto di
"possedere la verità". Deriva piuttosto dal fatto che "si cerca la verità". E guai se non fosse così soltanto!
Guai se si volesse legarlo a una sicurezza di "possesso della verità" ! Lo si legherebbe alla presunzione del
possedere la verità e non parlerebbero che i predicatori, i retori, gli arcadi, tutti coloro che non cercano".
Il rapporto arte-politica non è patrimonio esclusivo di che cerca la liberazione del proletariato; anche chi ha
fatto la scelta dell’adesione al fascismo, ha creduto nella necessità della guerra, nell’opportunità
dell’antisemitismo e nel mito della razza ha cercato di usare l’arte come strumento di lotta politica, si pensi ai
futuristi italiani, a Papini, Prezzolini, allo stesso D’Annunzio e, nel dopoguerra a Céline, Pound, Benn che
aderiscono al nazismo.
Una concezione fondamentalmente intimistica dell’arte è quella di Martin Heidegger; l’esperienza estetica è
espressione dell’essere-per-la-morte e la poesia riesce a esprimere adeguatamente il bisogno dell’uomo di
rientrare nell’Essere, perché la poesia non ha il dovere di informare o argomentare, è pura espressione del
sentimento.
Importanti, soprattutto in quest’ultimo scorcio di secolo, sono quelle teorie estetiche che pretendono di
analizzare scientificamente l’opera d’arte; in questo caso l’estetica sfocia facilmente nella psicologia
dell’arte, nella sociologia dell’arte e nella linguistica. Va inoltre rilevato che lo sviluppo di queste discipline
ha influito sia sui contenuti che sulle forme dell’espressione artistica e è alla base del grande movimento di
ricerca estetica che ha prodotto i tanti -ismi che hanno caratterizzato questo secolo dagli anni trenta ad oggi.
CONCETTO
Il significato comune e generico di "contenuto del pensiero" contiene i due ordini di problemi che sono
stati dibattuti in tutto il corso storico della filosofia occidentale: la natura del concetto, la sua origine e la sua
funzione nel processo di conoscenza.
Per quanto concerne il primo punto Aristotele vede in Socrate lo "scopritore" del concetto, "due sono le
cose che si possono a giusta ragione attribuire a Socrate: i ragionamenti induttivi e la definizione universale:
scoperte queste che costituiscono la base della scienza". Esso è logos, è il risultato del dialogo, che cerca
l’essenza per arrivare alla verità. Platone, riprendendo l’intuizione socratica e cercando di eliminare
definitivamente il pericolo della relatività del vero, lo definisce come eidos, che è insieme essenza
dell’oggetto e condizione per cui esso può venire pensato. Aristotele inserisce questo stesso significato,
concetto come sostanza, in una teoria più articolata e complessa che nasce dalla riflessione sui nomi e sul
linguaggio nel quale esprimiamo i giudizi e i sillogismi.
Per tutto il Medioevo la natura del concetto è stata dibattuta nella questione degli universali.
Nella filosofia moderna razionalismo ed empirismo hanno pensato diversamente il senso del "concetto",
mantenendo comunque uno stretto collegamento fra entità ideale e realtà.
Nel razionalismo concetto e oggetto reale coincidono, "il circolo esistente nella natura e l’idea del circolo
esistente, che è anche in Dio, sono una sola e medesima cosa che si manifesta per diversi attributi" (Spinoza,
Ethica) nell’empirismo il concetto è solo una generalizzazione dell’intelletto che dà un significato
universale a una percezione particolare, "quando dimostro una qualsiasi proposizione sui triangoli, devo
supporre di avere l’idea universale di un triangolo che non sia né equilatero, né scaleno ecc., ma solo che
quel triangolo particolare che io considero rappresenta un qualsiasi triangolo, ed è in questo senso che è
universale" (Berkeley, Trattato sui principi della conoscenza umana).
Anche in Kant il concetto è una rappresentazione universale, un concetto empirico, prodotto dalle categorie,
funzioni dell’intelletto che sono concetti puri, per mezzo dei quali l’intelletto unifica il molteplice sensibile e
stabilisce conoscenze oggettive; la relazione fra concetto e realtà è così profondamente modificata: i concetti
empirici sono rappresentazioni della realtà perché i concetti puri rendono possibile la rappresentazione del
mondo reale, sono la condizione della sua rappresentabilità e sono pertanto l’elemento costitutivo della realtà
che percepiamo; il concetto non è più identico alla realtà, sia pure nei diversi modi esaminati, ma è solo il
suo ordine necessario perché del reale si possa avere conoscenza scientifica.
Nell’idealismo i due aspetti della concezione kantiana ritornano, senza il limite che Kant aveva determinato:
il mondo fenomenico.
In Hegel il concetto è oggetto logico e universale; nella prima accezione è la forme della riflessione
attraverso la quale raggiungiamo il livello della comprensione della verità: la totalità; come universale non è
una mera generalizzazione dell’esperienza, non potrebbe in questo caso condurci alla verità, è l’universale
concreto, l’intelletto che comprende in sé tutti gli atti di pensiero, è pensiero che pensa, "il concetto nella
sua oggettività è la stessa cosa che è in sé e per sé" (Hegel, La scienza della logica).
In Husserl il concetto è l’essenza, condizione del sapere scientifico e perciò forma a priori, essendo una
forma a priori non può in nessun modo essere considerata una pura e semplice generalizzazione empirica, è
un momento inseparabile del fenomeno e può esser colta attraverso un’intuizione originaria; il concetto non
può pertanto essere ridotto alla rappresentazione di un oggetto, questa varia da individuo a individuo, da
momento a momento mentre il concetto resta sempre identico a se stesso.
La riflessione della natura del concetto determina anche l’analisi della sua origine che la psicologia
contemporanea ha indagato sotto le diverse prospettive.
Le correnti di pensiero che hanno posto l’accento sulla funzione che ha il concetto nella costruzione della
conoscenza hanno influito, nell’epoca contemporanea, sugli studi psicologici che hanno considerato la
percezione un problema da studiare; la fenomenologia husserliana, ad esempio, ha un grande peso nella
origine e in alcuni sviluppi della psicologia della Gestalt, basti pensare alla scuola di Graz; lo studio della
percezione conduce i gestaltisti a ricercare le "leggi di organizzazione" delle percezioni e di conseguenza dei
modi in cui conosciamo concludendo che il tutto trascende le parti e le organizza secondo norme proprie
determinando il modo in cui percepiamo una cosa: uno stesso oggetto viene percepito diversamente da due
persone o da una stessa persona in momenti diversi perché esso viene considerato in totalità diverse,
l’essenza che percepiamo dà senso all’esperienza in atto.
Le correnti di pensiero che in qualche modo si rifanno alla funzione dell’esperienza nel processo conoscitivo
vedono l’origine del concetto nella percezione intesa come astrazione riflessa della realtà o come
impressione catalettica. In questo ambito particolare importanza, per le sue applicazioni analitiche e
comportamentali, ha la teoria transazionale che considera la percezione una transazione, una relazione tra il
soggetto e l’oggetto il cui risultato non può essere ridotto a uno o all’altro elemento della relazione o anche
alla loro interazione, è una percezione che si fonda sull’esperienza passata e anticipa aspettative future,
"sappiamo che ci sono due tipi di
conoscenza: la conoscenza delle cose e la conoscenza sulle cose; la prima è la consapevolezza che ci viene
dai sensi; (...). Se dunque la consapevolezza dei sensi si può definire conoscenza di primo ordine, il secondo
tipo di conoscenza (la conoscenza su un oggetto) è conoscenza di secondo ordine, è conoscenza sulla
conoscenza di primo ordine e quindi metaconoscenza. (...) L’uomo non smette mai di cercare di conoscere
gli oggetti della sua esperienza, di capire che significato hanno per la sua esistenza e di reagire ad essi a
seconda di quello che capisce. Infine, dalla somma totale dei significati che ha dedotto dai contatti con
numerosi oggetti singoli del suo ambiente si sviluppa una visione unitaria del mondo in cui si trova gettato
(per usare un termine esistenzialista), e questa visione è di terzo ordine" (Watzlawick, Beavin, Jackson,
Pragmatica della comunicazione umana).
Gli studi sull’origine della conoscenza hanno anche risposto al terzo problema sulla funzione del concetto nel
processo di conoscenza. Dal punto di vista più propriamente filosofico l’argomento va trattato insieme alla
questione del metodo necessario per formare i concetti e per metterli in relazione tra loro. Le questioni del
metodo inteso come insieme di regole definite per costruire una conoscenza rigorosa hanno avuto un
importante capitolo nello sviluppo della logica matematica e nella epistemologia; da una parte si è sviluppata
la teoria della dimostrazione come branca specialistica della matematica, e dall’altra si è cercato di arrivare a
una sempre maggiore conferma empirica delle ipotesi teoriche; in questa logica particolare rilievo ha la
posizione di Popper che, presupponendo l’impossibilità di arrivare a verificare completamente tutti i casi
possibili che la teoria prevede, enuncia il principio di cercare piuttosto il caso che falsifichi l’ipotesi data; la
possibilità della falsificazione e non la verificazione è la caratteristica della teoria scientifica.
COSCIENZA
Nella storia della filosofia il termine "coscienza" ha assunto diversi significati spesso molto lontani da quello
comune di "consapevolezza", che è consapevolezza del proprio sentire, del proprio agire e del proprio
essere.
Platone definisce il pensare "il dialogo che l’anima per sé instaura con se stessa su ciò che sta esaminando"
(Teeteto), ma questo pensare resta legato al dialogo come momento di ricerca comune; il riferimento
fondamentale non è l’introspezione, ma la comunicazione che si avvale necessariamente del linguaggio; la
coscienza è l’insieme delle facoltà conoscitive, è intelligenza, memoria, scienza e opinione vera, "senza
possedere né intelligenza, né memoria, né scienza, né opinione vera, non avverrebbe necessariamente che tu
ignori innanzi tutto proprio questo, se godi o non godi, che tu saresti vuoto di ogni pensiero?" (Filebo).
Aristotele riduce il valore della coscienza alla consapevolezza del contenuto delle sensazioni, "i contenuti di
un’indagine sono precisamente uguali, ai contenuti del sapere. La nostra indagine può rivolgersi in quattro
direzioni per stabilire: che un oggetto è qualcosa; perché un oggetto è qualcosa; se un oggetto è; che cosa è
un oggetto" (Analitici secondi); anche in questo caso la coscienza nulla ha a che fare con l’introspezione,
resta un elemento del processo di conoscenza.
Con le filosofie ellenistiche il termine coscienza acquista anche il significato di ricerca interiore, di
introspezione; saggio è colui che è distaccato dal mondo e dalle proprie passioni, il mezzo per conquistare
tale distacco è il colloquio interiore dell’anima con se stessa che la filosofia favorisce. Questa concezione,
pur nei diversi significati che assume nell’epicureismo e nello stoicismo, viene assunta anche dal pensiero
cristiano delle origini, "ritorna in te stesso, la Verità abita nell’interiorità dell’uomo" dice Agostino;
coscienza è meditazione personale sul senso dell’uomo e del suo rapporto con Dio, il significato meramente
gnoseologico esaminato sopra si perde e il valore concettuale fondamentale è quello etico-religioso.
Nella filosofia moderna cruciale è l’elaborazione cartesiana: il colloquio dell’anima con se stessa acquista
nuovamente un valore gnoseologico: attraverso la coscienza di sé, l’uomo fonda ogni sua conoscenza, "con
"pensiero" intendo tutto ciò che avviene in noi con coscienza, in quanto ne abbiamo coscienza. Così non solo
intendere, volere, immaginare, ma anche sentire è lo stesso che pensare" (Princ. fil.). La coscienza,
espressione di tutte le "facoltà spirituali", è il principio autoevidente che sta a fondamento di ogni
conoscenza rigorosa, "cogito ergo sum".
Molto simile è la posizione empirista; Locke concepisce la coscienza come certezza del proprio esistere del
proprio pensare; per questa ragione coscienza è insieme esperienza, la fonte della conoscenza, e criterio di
verità, cioè dell’accordo fra le idee e la realtà delle cose. Nella concezione cartesiana il dubbio è il metodo di
conoscenza e la coscienza ne è il fondamento; nella concezione empirista la conoscenza resta sempre e
necessariamente un fatto interno alla coscienza e per questa ragione può sempre essere rimesso in
discussione.
In Leibniz la coscienza è la caratteristica della monade che determina la capacità di percepire; nell’uomo
questa capacità è più elevata e le percezioni sono "chiare e distinte", la loro consapevolezza è l’appercezione.
In Kant coscienza contiene sia il senso etico che quello gnoseologico.
Nella Critica della ragion pratica coscienza è l’elemento che garantisce il valore assoluto della legge
morale. Nella Critica della ragion pura viene distinta una coscienza empirica, diversa in ogni uomo dalla
"coscienza in generale", l’Io penso, in cui l’unità del conoscere non si riduce alla totalità delle
rappresentazioni della coscienza empirica, ma si aggiunge ad esse, ne rappresenta la sintesi; la coscienza in
generale è pertanto una funzione conoscitiva, identica in tutti gli uomini, è attività che si realizza attraverso
le categorie.
Dalla concezione kantiana si sviluppa quella idealistica: la coscienza non è l’Io, è invece il tratto distintivo
di ciò che deriva dall’Io, alla concezione kantiana della coscienza come funzione viene sostituito il concetto
di coscienza come sostanza.
In Fichte coscienza è l’io empirico, il prodotto dell’opposizione fra Io e Non io; l’Io, che può essere colto
solo attraverso la riflessione, resta oltre la
coscienza, è Autocoscienza, fondamento della possibilità per il pensiero umano di arrivare a possedere la
verità. In Schelling coscienza e natura procedono parallelamente, man mano che la coscienza emerge e si
avvicina alla piena coscienza di sé dell’Assoluto anche la natura diventa un sistema più complesso.
Hegel ha una teorizzazione molto più complessa. Coscienza è l’attività conoscitiva dell’uomo che non ha
ancora raggiunto il sapere assoluto, che è ancora prigioniero dell’opposizione soggetto-oggetto, che è
prigioniero dell’esteriorità. L’emergere dello spirito coincide col progresso della coscienza verso il sapere
assoluto, cioè verso la comprensione delle "pure essenze" di cui la realtà è manifestazione; il sapere che la
coscienza produce è quindi lo stadio prelogico della conoscenza. L’opera in cui Hegel affronta tutto il
cammino della coscienza dall’esteriorità del sapere empirico alla verità è la Fenomenologia dello spirito, la
"storia dell’esperienza di coscienza". I vari momenti del manifestarsi dello spirito nella realtà e dell’elevarsi
della coscienza verso i gradi più alti del sapere sono le "figure" della coscienza. Il primo grado è la certezza
sensibile che considera l’oggetto come una realtà a sé stante; il secondo è la coscienza intuitiva che distingue
fra l’oggetto e le sue proprietà e infine la coscienza riflessiva, che scopre la necessità dello sdoppiamento fra
il fenomeno e il suo fondamento. Quest’opposizione è alla base della figura successiva, l’autocoscienza, per
arrivare infine alla ragione e allo spirito, la cui manifestazione più alta è appunto il sapere assoluto.
Nella Fenomenologia particolare rilievo ha la Coscienza infelice: la coscienza divenuta consapevole di sé,
divenuta autocoscienza, scopre nella libertà il suo carattere peculiare; nel cammino verso la libertà la
coscienza rappresenta la scissione fra l’uomo e l’assoluto, Dio, operata dall’ebraismo prima e poi dal
cristianesimo medievale. L’infelicità che tale scissione produce deriva dal fatto che la coscienza si sente
"inessenziale" di fronte a Dio e cerca di annullarsi in lui attraverso la propria mortificazione, atteggiamento
tipico del misticismo medievale. L’emergere dell’autocoscienza è quindi il progressivo manifestarsi della
libertà nell’individuo e nella società, il primo esempio storico della libertà conquistata è il conflitto servopadrone, tipico delle società antiche.
Nel Novecento il concetto di coscienza è fondamentale. Una prima elaborazione è quella husserliana e
esistenzialista, centrale in autori come Jaspers e Sartre.
Per Husserl la coscienza ha sempre un contenuto che è esperienza vissuta la cui conoscenza è riferita
all’intenzionalità, alla capacità di cogliere l’essenza nel fenomeno che è oggetto di esperienza vissuta e di
riportare tutte le esperienze nell’unità della coscienza che è pertanto una "corrente di esperienze vissute". La
rappresentazione che ne deriva non è un fatto "psicologico", ma trascendentale. Husserl distingue quindi una
"percezione trascendente" e una "percezione immanente". La prima l’esperienza degli oggetti che sono
presenti nella coscienza solo in quanto vissuti, in quanto possibilità, non come oggetti in sé reali; per questa
ragione la conoscenza dei fenomeni richiede l’epochè fenomenologica, la sospensione del giudizio che
nasce dalla messa in dubbio. La seconda è la percezione delle esperienze vissute, il pensare, l’immaginare
ecc., è il "cogito" di Cartesio, una percezione immediata il cui carattere è assoluto, "la percezione
dell’esperienza vissuta è la visione diretta di qualcosa che si dà o che può darsi nella percezione come
assoluta e non come l’identità delle apparenza che l’adombrano"(ldee, 44), non ha bisogno di nulla per
esistere in quanto è solo una relazione della coscienza.
L’esistenzialismo rielabora soprattutto la concezione husserliana della coscienza come percezione
immanente. Per Jaspers la coscienza è l’essenza dell’esserci, dell’uomo, "io ci sono in quanto coscienza e
solo come oggetti di coscienza le cose sono per me"; la coscienza mentre percepisce il mondo esterno,
percepisce sé stessa, è autocoscienza; in quanto tale è il campo in cui l’uomo può andare alla ricerca della
verità. Anche per Sartre la coscienza è il momento fondamentale che caratterizza l’uomo, essendo
percezione della propria esistenza essa si proietta nel futuro, è progetto, è libertà; in quanto tale essa si
scontra con l’essere, che invece è necessità; la coscienza pertanto si rivela come "non essere" e poiché il
mondo è in sé privo di senso, senso che riceve solo dalla coscienza, per la quale esso è nulla; la coscienza è
"l’essere per cui il nulla viene al mondo".
Il riconoscimento di una realtà esterna diversa da quella interna è il motivo fondamentale anche della
filosofia di Bergson, per il quale la coscienza è la capacità di introspezione che l’evoluzione creatrice ha
raggiunto nell’uomo, è, sotto un certo aspetto, l’effetto della capacità evolutiva; ma, sotto un altro aspetto,
"la vita, cioè la coscienza lanciata verso la materia fissa la sua attenzione o sul suo proprio movimento o
sulla materia che attraversa e si orienta o nel senso dell’intuizione o nel senso dell’intelligenza"
(L’evoluzione creatrice), in questo modo la coscienza è il principio che crea la realtà e ne rivela il senso
nell’interiorità dell’uomo.
Le concezioni di Husserl e Bergson hanno la loro matrice, e a loro volta l’hanno influenzato profondamente,
nel dibattito che è emerso nella logica, nella filosofia del linguaggio e nella psicologia. Wittgenstein nel
Tractatus vede il mondo come la totalità dei fatti e il linguaggio come lo strumento che li esprime; le
proposizioni che esprimono i fatti hanno senso, quelle che vanno oltre i fatti sono prive di significato; la
conclusione che ne ricava è: "di ciò di cui non si può parlare si deve tacere"; la riflessione successiva, che
appare nelle Ricerche filosofiche, propone invece la concezione di una molteplicità di linguaggi, ognuno
caratterizzato da regole proprie suscettibili di modificazioni, che hanno la loro fonte nell’interiorità
dell’uomo; per questa ragione alcuni interpreti hanno visto nel cosiddetto secondo Wittgenstein il recupero
della dimensione metafisica.
DIALETTICA
Il termine deriva dal verbo greco dialéghesthai che significa "discutere insieme, ragionare insieme".
Nella filosofia platonica la dialettica ha un’importanza centrale, è il metodo che consente di raggiungere la
verità, prima come dialogo, lo strumento della ricerca filosofica, della ricerca che tende alla verità; poi, col
precisarsi della dottrina delle idee, nella convinzione che la verità possa solo essere universale, la dialettica
diventa il metodo che consente di arrivare alla definizione dell’idea attraverso la divisione.
Nella filosofia aristotelica dialettica acquista il valore di un procedimento razionale non dimostrativo,
che rende legittima la diversità d’opinione; accanto alle proposizioni vere o false, vanno considerate anche
quelle probabili: "dialettico è il sillogismo che deduce qualcosa partendo da premesse fondate sull’opinione.
(...) Fondate sull’opinione sono le cose che appaiono accettabili a tutti, o alla grande maggioranza, o ai
sapienti e tra questi o a tutti, o alla grande maggioranza o ai più noti e famosi". Secondo questa definizione si
capisce perché Aristotele abbia visto in Zenone di Elea il fondatore della dialettica: i suoi paradossi si basano
su una convinzione del movimento e della molteplicità accettata dalla maggioranza.
Con le filosofie ellenistiche, in modo particolare con lo stoicismo, dialettica è "la scienza del discutere
rettamente su argomenti posti in forma di domanda e di risposta; e perciò danno di essa anche un’altra
definizione: scienza di ciò che è vero e di ciò che è falso e di ciò che non è né vero né falso".. Sulla base
della concezione stoica nel Medioevo la dialettica coincide con la logica formale e si contrappone alla
retorica.
Con Kant il termine "dialettica" indica la critica delle idee della ragione (anima, mondo, Dio) attraverso le
quali l’uomo cerca di comprendere delle totalità al di là di ciò che può sperimentare: è la dialettica
trascendentale. In questa sezione della Critica della ragion pura Kant esamina i diversi sofismi che la
ragione produce nel tentare argomentazioni razionali su tali idee. La dialettica è pertanto una particolare
"sofistica" alla quale deve porre rimedio il criticismo dimostrandone l’illusorietà. Particolare rilievo hanno le
antinomie della cosmologia razionale, ragionamenti che concludono legittimamente in maniera opposta,
attraverso i quali la ragione cerca di superare i limiti dell’esperienza sensibile unificando aspetti opposti della
realtà.
La presenza di tali opposizioni e la necessità di superarle in una visione sintetica è l’elemento su cui si fonda
la concezione idealistica della dialettica: la contraddizione è la struttura fondamentale della realtà e anche del
pensiero che deve comprenderla, come afferma Hegel, "tutto ciò che è razionale è reale e tutto ciò che è
reale è razionale". In questa fondamentale unitarietà delle filosofie idealistiche vanno però precisate le
diversità dei vari filosofi: per Fichte dialettica designa sia l’opposizione Io Non-io, sia il metodo
dell’indagine filosofica che deve comprendere il valore fondamentale della libertà; in Schelling designa
l’identità degli opposti nell’infinito, l’opposizione determina la tensione che genera il continuo farsi della
natura l’arte diventa lo strumento intellettuale più adeguato alla comprensione dell’infinito; in Hegel designa
il progressivo realizzarsi dell’assoluto attraverso la contraddizione; è metodo di indagine e essenza
dell’assoluto e contiene pertanto sia le varie determinazioni della natura, dell’uomo e della storia, tre sono i
momenti fondamentali in cui si articola: il porsi del concetto astratto, il negarsi di tale concetto nel suo
opposto, la sintesi dei due momenti contraddittori in cui permane "ciò che vi è di affermativo nella loro
soluzione e nel loro trapasso".
In Marx la dialettica hegeliana subisce una trasformazione materialistica, "la mistificazione che la Dialettica
subisce nelle mani di Hegel non impedisce in alcun modo che egli per primo abbia descritto le sue forme
generali di movimento in modo comprensivo e consapevole; in Hegel la dialettica poggia sulla testa. Bisogna
rimetterla sui piedi per scoprire il nocciolo razionale nell’involucro mistico"; la dialettica diventa quindi
metodo di indagine della storia umana come "storia di lotte di classe" (materialismo storico).
La concezione hegeliana di dialettica ha un ruolo importante nella filosofia del Novecento: oltre alle
concezioni del neoidealismo italiano di Giovanni Gentile e di Benedetto Croce va ricordata la dialettica
negativa di Theodor Wiesegrund Adorno e della Scuola di Francoforte: con questo concetto viene
designata la concezione negativa delle società borghese, ma anche di quelle socialiste asservite dai
meccanismi alienanti della produzione tipici delle "società di massa"; a questa visione Adorno contrappone
l’ideale di un’arte capace di salvare l’uomo dall’alienazione e dalla disumanizzazione. Per molti aspetti
simile è la concezione di Jean Paul Sartre per il quale la dialettica è "attività totalizzatrice; essa non ha altre
leggi che le regole prodotte dalla totalizzazione in corso e queste concernono evidentemente le relazioni
dell’unificazione con l’unificato, cioè i modi della presenza efficace del divenire totalizzante nelle parti
totalizzate".
DUBBIO
Il dubbio, che nel significato comune è l’opposto della certezza, presenta nella storia della filosofia tre
significati diversi e interdipendenti: nella filosofia antica e medievale è mancanza di certezza e
problematicità dell’assunto, nella filosofia moderna e contemporanea è soprattutto metodo di ricerca.
Il primo significato è derivato dalla constatazione che la conoscenza ha fonti diverse, la sensazione, incerta
e discutibile, e la ragione la cui caratteristica fondamentale è la dimostrazione che determina conoscenze
assolutamente certe. I primi grandi esempi di questa concezione sono la filosofia eleatica e soprattutto la
teoria platonica, descritta nella Repubblica attraverso il "mito della caverna", della conoscenza che si
perfeziona per gradi a partire da quello più basso, la conoscenza sensibile che genera l’opinone, per arrivare
attraverso la conoscenza razionale, dimostrativa, a quello intuitivo che è visione delle idee.
La riflessione sulla possibilità dell’uomo di raggiungere la verità si lega con la riflessione sulla natura del
linguaggio attraverso il quale necessariamente l’uomo si esprime. Da tale riflessione emergono due
teorizzazioni che Platone descrive nel Cratilo: se il significato dei nomi è tale per natura o per convenzione.
La tesi del linguaggio come convenzione, argomentata con la constatazione del carattere polisenso di molti
nomi, col fatto che nomi diversi
designano in realtà una stessa cosa e si modificano nel tempo, conclude nelle diverse forme di scetticismo
con l’impossibilità di raggiungere una certezza assoluta. L’origine naturalistica del linguaggio viene
sostenuta con l’argomento che i nomi riflettono l’essenza delle cose; il linguaggio è sostanzialmente identico
al pensiero e consente di raggiungere la conoscenza delle idee, dell’Essere, di ciò che è oltre la realtà; in
questo modo permette di raggiungere la verità certa. L’ulteriore riflessione platonica come emerge nel
Parmenide e nel Sofista tende a distinguere il nome dalla proposizione e la verità dal significato.
La riflessione aristotelica sul linguaggio, collegata alla problematica logica, approfondisce il discorso
platonico e, sostenendo l’inutilità delle idee come condizioni della conoscenza vera, afferma che solo nella
proposizione il nome acquista un valore conoscitivo che rende possibile definire vera o falsa una conoscenza
e che questo carattere va attribuito solo alle proposizioni "apofantiche", alle proposizioni dichiarative. La
distinzione aristotelica è funzionale alla considerazione dei diversi modi di ragionare e ricercare la verità; per
cui si deve distinguere il sillogismo scientifico, deduttivo la cui conclusione è certa e il sillogismo dialettico,
la cui conclusione è solo probabile legato all’opinione che non dà certezza.
Se una conoscenza non dà certezze, il suo carattere è problematico: ci possiamo trovare di fronte a
ragionamenti che hanno conclusioni contrarie e sono ugualmente validi. La problematicità della conoscenza
ha caratterizzato l’empirismo moderno che ha visto in essa la condizione della ricerca arrivando a
considerare le proposizioni universali come la somma di tutte le esperienze individuali.
Secondo significato. La concezione del dubbio come metodo caratterizza invece la filosofia
contemporanea, nella quale la filosofia si presenta essenzialmente come ricerca e progressiva messa in
discussione delle certezze raggiunte. Le premesse di questa concezione possiamo trovarle in Agostino per il
quale "chiunque sappia di dubitare sa la verità e di questa cosa sa che è certa: dunque sa la verità" (De vera
religione), ma soprattutto in Cartesio per il quale il dubbio è fonte e fondamento di ogni conoscenza
rigorosa, "già da qualche tempo avevo mi sono accorto che, fin dai miei primi anni, avevo accolto una
quantità di false opinioni, onde ciò che poi ho fondato su principi così mal sicuri, non poteva essere che assai
dubbio e incerto, e dovevo necessariamente disfarmi di tutte le opinioni alle quali avevo creduto se volevo
stabilire qualcosa di fermo e durevole nelle scienze (...). La meditazione che feci ieri m’ha riempito lo spirito
di tanti dubbi che non posso più dimenticarli (...). Nondimeno mi sforzerò e seguirò a capo la stessa via in
cui ero entrato ieri, allontanandomi da tutto quello in cui potrò immaginare il minimo dubbio proprio come
farei se lo riconoscessi assolutamente falso; e continuerò sempre su questa strada finché non incontrerò
qualcosa di certo" (Meditazioni metafisiche, I, II).
Su questa via Cartesio trova la prima certezza assoluta: "Io penso, dunque sono".
Sulla base della riflessione cartesiana Husserl riprende la concezione del dubbio come metodo che deve
portare all’epochè fenomenologica, alla sospensione del giudizio sul mondo per lasciare spazio alla pura
descrizione fenomenologica che ha la sua origine nella intenzionalità della coscienza; attraverso l’epochè il
pensiero può così cogliere le essenze ideali che sono la base del mondo della vita e di ogni sapere non
dogmatico.
Anche il pragmatismo vede nel dubbio l’origine di ogni conoscenza. Peirce lo considera come la messa in
crisi, da parte dell’esperienza, di quanto si crede certo; il dubbio e la credenza sono gli elementi che
costituiscono la conoscenza che è teoria e regola dell’agire e proprio per questo può essere in qualsiasi
momento messa in discussione.
MORTE
Della morte non sappiamo nulla e quindi non potremmo parlarne, l’esperienza della morte è sempre
esperienza della morte di un altro. La medicina ne ha fatto oggetto di studio avendo trovato l’oggetto che può
essere analizzato, il cadavere; nella vita dell’uomo, nel pensiero che può essere comunicato, la morte è paura,
angoscia, riconciliazione; su questi concetti si è incentrata la riflessione filosofica.
Il concetto di morte ha sempre avuto e continua ad avere due valenze: una culturale e una biologica che si
intersecano e si influenzano a vicenda nelle varie epoche determinando anche profondi cambiamenti morali.
Dal punto di vista culturale la morte è una sorta di complemento della vita: ne rappresenta l’origine e la
fine e segna il passaggio alla pienezza della vita. Nella cultura greca tutto ciò è espresso nel mito di
Persefone: Core rapita da Ade viene per ordine di Zeus restituita alla madre Demetra, la dea della feritilità,
ma avendo mangiato il frutto dei morti dovrà passare tre mesi all’anno come regina del Tartaro col titolo di
Persefone, colei che porta la distruzione, e i rimanenti nove mesi con la madre insieme agli altri immortali. Il
senso del mito è palese: la morte è il passaggio essenziale del ciclo della vita: il seme che resta sepolto nei
mesi invernali nasce con la primavera e porta con sé una vita rinnovata; il rinnovamento perenne della vita è
il senso dell’immortalità che viene raggiunta proprio attraverso la comprensione del mistero della morte
nell’unione mistica con l’infinito, rappresentato nei misteri eleusini dall’assunzione del kykeón, una bevanda
densa e profumata che permette all’uomo di partecipare alla vita della divinità.
Alla morte come elemento connaturato alla vita si rifanno anche le teorie della trasmigrazione delle anime.
La cultura ebraica vede la morte come negazione della vita, condanna che deriva dalla colpa di Adamo,
"col sudore della fronte ti procaccerai il pane finché tornerai alla terra dalla quale sei stato cavato, perché
polvere sei ed in polvere ritornerai" (Genesi, 3). Il cristianesimo poi recupera il significato positivo della
morte attraverso il mito della redenzione: con la sua morte Cristo ha reso nuovamente possibile il
ricongiungimento dell’uomo con Dio e la morte dell’uomo è divenuta la condizione necessaria per il
raggiungimento della vera vita.
Sia la tradizione classica che quella ebraico-cristiana vedono quindi la morte come evento legato alla vita
"l’uomo libero a nulla pensa meno che alla
morte; la sua riflessione è sapienza di vita e non di morte" (Spinoza, Etica, IV, 37)
Il fatto che la morte sia un evento necessariamente intrecciato alla vita non significa che non possa essere
vissuta con terrore; la paura della morte è un’esperienza comune sul cui significato i filosofi si sono
interrogati in ogni tempo. Particolare rilievo ha l’argomentazione di Epicuro "la morte, il più atroce di tutti i
mali non esiste per noi; quando ci siamo noi la morte non c’è quando c’è la morte noi non ci siamo; non è
nulla né per i vivi, né per i morti" (Epicuro, Lettera a Meneceo); liberarsi dalla paura della morte è una delle
vie attraverso le quali l’uomo può raggiungere la felicità.
All’argomentazione di Epicuro, sulla cui falsariga si muovono tutte le filosofie materialiste, che riduce la
morte a un fatto meramente biologico alcune correnti della filosofia moderna, e soprattutto contemporanea
hanno contrapposto una concezione della morte come ricerca dell’Essere, aspirazione all’infinito. In queste
filosofie la morte è espressione della finitezza dell’uomo, che cosciente di tale limite aspira all’infinito.
Per Spinoza la mente e il corpo sono due modi finiti che nell’uomo sono un tutt’uno, la mente è il modo
attraverso il quale egli può comprendere l’infinito, il trascendente, l’incondizionato attraverso un atto
intuitivo. La capacità intuitiva è un processo che si acquisisce, un processo nel quale "uno passa da una
minore a una maggiore perfezione e viceversa"; in questo processo si incontra la morte, "la rottura del
rapporto di quiete e di moto che le parti del corpo hanno tra loro", il corpo allora si distrugge ma "bisogna
innanzitutto notare che quando dico che uno passa da una minore a una maggiore perfezione, e viceversa,
non intendo dire che egli si trasformi da un’essenza o forma ad un’altra. Infatti il cavallo è per esempio
distrutto sia che si trasformi in un uomo, sia che si trasformi in un insetto: intendo dire invece che la potenza
di agire di quell’individuo, intesa secondo la sua natura, aumenta o diminuisce" (Spinoza, Etica, IV, Pref.); la
morte è un aumento di potenza della natura umana, un evento lontano quanto lontana è la perfezione che
l’uomo vuole raggiungere: l’evento biologico non può essere separato da quello intellettuale e morale.
Il pensiero della morte nella filosofia contemporanea caratterizza tutte le filosofie che pongono al centro
della riflessione l’individuo e l’esistenza. Schopenhauer riprende il concetto di colpa, "la morte stessa prova
che la nostra esistenza implica una colpa" (Parerga, II, 164). L’esistenza è dolore la cui origine è nella
volontà di vivere che I uomo può superare raggiungendo quel grado di perfezione che è l’ascesi. La rinuncia
al dolore non può mai esser però la rinuncia all’esistenza che si attua col suicidio; il suicidio infatti non
estingue la causa del dolore, la volontà, pone fine solo al suo fenomeno, l’esistenza. Se la vita è
necessariamente dolore, vivere significa morire continuamente, ma nonostante sia dolore l’uomo resta
attaccato alla vita e ha il terrore della morte, "ma bisogna infine che la morte trionfi, poiché siamo divenuti
sua preda per il solo fatto di essere nati; la morte si permette un momento di giocare con la sua preda, ma non
aspetta che l’ora di divorarla. Rimaniamo nondimeno affezionati alla vita e spendiamo ogni cura per
prolungarla quanto più possiamo; proprio come che si sforza di gonfiare quanto più e quanto più a lungo è
possibile una bolla di sapone, pur sapendola destinata a scoppiare" (1I mondo, IV).
Kierkegaard pone l’accento sul concetto di "passaggio", "dal punto di vista cristiano la morte è un
passaggio alla vita"; la "malattia mortale" non è quella che porta alla morte, è la disperazione, la struttura
fondamentale dell’esistenza e "il tormento della disperazione è proprio quello di non poter morire". La
contraddizione vita-morte rispecchia la contraddizione dell’esistenza e l’impossibilità di risolverla entro i
termini della razionalità, solo la fede può porre il singolo nella condizione di superare l’esistenza e unirsi
all’assoluto, essere in Dio.
Sulla stessa lunghezza d’onda la riflessione di Heidegger, per il quale la morte è una dimensione insita
nell’esistenza al punto che ogni autentica esistenza non può che "essere-per-la-morte": l’esistenza è
possibilità e la possibilità implica la scelta, la decisione con la quale l’esserci fa proprio il progetto
dell’esistenza che si ritrova, del suo "essere-gettato-nel-mondo" e esce dalla impersonalità del "si dice" che
invece fonda la "chiacchiera", l’esistenza inautentica. Fra tutte le possibilità che caratterizzano l’esistenza la
morte è la sola necessità ineludibile e pertanto il momento più propriamente costitutivo dell’esistenza, della
sua finitezza; la morte come "decisione anticipatrice" è la scelta che riporta l’uomo, l’esserci che è "esserenel-mondo" nell’essere da cui l’esistenza (ex-sistere, farsi altro da ciò che si è) l’ha separato.
La morte è elemento centrale anche nel pensiero di Sartre che la considera priva di significato intrinseco,
"un puro fatto, come la nascita; essa viene a noi dall’esterno e ci trasforma in esteriorità. In fondo essa non si
distingue in alcun modo dalla nascita ed è l’identità della nascita e della morte che noi chiamiamo fatticità"
(L’essere e il nulla). La morte è per Sartre fatticità che, come tutti gli altri elementi esteriori, la coscienza,
nella contrapposizione fra Essere e Nulla, tende a superare continuamente per realizzare il proprio progetto,
le proprie possibilità.
Il concetto di morte come struttura della vita ha in questo secolo una argomentazione originale nella
psicanalisi freudiana; "se possiamo considerare come un fatto sperimentale assolutamente certo e senza
eccezioni che ogni essere vivente muore (ritorna allo stato inorganico) per morivi interni, ebbene, allora
possiamo dire che la meta di tutto ciò che è vivo è la morte e, considerando le cose a ritroso, che gli esseri
privi di vita sono esistiti prima di quelli viventi" (Il principio di piacere). La morte, in quanto struttura stessa
della vita, è una delle pulsioni, delle forze conservatrici dell’esistenza che si accompagna alle pulsioni
sessuali, che determinano la conservazione delle specie; la vita altro non è che un cammino verso la morte
che viene continuamente deviato da pulsioni di senso opposto; "si determina così il paradosso che
l’organismo vivente si oppone con estrema energia a eventi (pericoli) che potrebbero aiutarlo a raggiungere
più in fretta lo scopo della sua vita (per così dire grazie a un corto circuito)" (Il principio di piacere). La
riflessione sulla morte e sul suo significato è destinata a modificare
profondamente gli atteggiamenti e la cultura umana grazie ai progressi della medicina. Fino a qualche
tempo fa la morte era considerata un evento istantaneo, il momento in cui l’anima si separa dal corpo: in quel
momento tutto il corpo dell’uomo muore, la vita terrena non esiste più. Le possibilità dei trapianti d’organo
hanno ora modificato profondamente il concetto di morte: la morte è il momento in cui cessa l’attività
elettrica del cervello, ma i singoli organi sono ancora vivi e possono continuare a funzionare nel corpo di
un’altra persona. Queste conquiste della medicina hanno un impatto giuridico e etico evidente: giuridico
perché gli stati hanno modificato la legislazione sul riconoscimento della morte, etico perché la cosa viene
ancora in molti casi vissuta in maniera contraddittoria.
STATO
"Con la parola "Stato" si designa modernamente la maggior organizzazione politica che l’umanità conosca,
riferendosi tanto al complesso territoriale e demografico su cui si esercita la signoria (potere politico),
quanto al rapporto di coesistenza e di coesione di leggi e di organi che su quello imperano" (Enc. Italiana,
Stato). Secondo questa definizione gli elementi costitutivi dello Stato sono il potere politico sovrano, il
territorio e la popolazione. Essa comprende tutte le forme di aggregazione politica che si sono avute in
Europa dalla polis greca ad oggi, non considera la differenza fra i diversi rapporti che storicamente si sono
determinati fra il potere, il popolo e il territorio e che sono stati, in epoche e regioni diverse, molto difformi
fra loro. La riflessione sul modo di essere ideale o reale di questi rapporti ha caratterizzato le diverse filosofie
politiche. Machiavelli è stato il primo filosofo della politica a usare il termine "Stato" nel concetto odierno
precedentemente "status" indicava il grado di un individuo o di un gruppo nella società; "Repubblica" era il
termine che indicava lo Stato.
La prima concezione organica dello Stato come struttura necessaria della convivenza umana la troviamo
nella Repubblica di Platone che con la "teoria delle idee" cerca di dare un fondamento saldo alla polis ormai
in crisi. La ricerca del concetto di giustizia non può ignorare l’origine e la formazione dello Stato,
l’organismo che garantisce la giustizia all’uomo giusto e la pena all’ingiusto. Lo Stato nasce dalla necessità
di soddisfare i bisogni dell’uomo che, da solo, non sarebbe autosufficiente. Lo Stato infatti altro non è che un
organismo identico all’uomo, ma più grande, e come nell’uomo tutte le diverse parti dell’organismo
contribuiscono al soddisfacimento del bisogno così nello Stato tutti i componenti dovranno contribuire al
bene comune. Da questo presupposto nasce la divisione dei compiti fra i cittadini, fondata sulle attitudini di
ognuno, per la realizzazione del fine comune, la giustizia, il bene. Sono queste le condizioni del cosiddetto
"comunismo platonico" e della repubblica ideale al cui governo devono stare i filosofi, coloro che
possiedono la saggezza.
Aristotele sviluppa la sua riflessione quando la crisi della polis è irreversibile e la Grecia viene conquistata
da Filippo di Macedonia. Aristotele non cerca un modello ideale di Stato, vuole esaminare le costituzioni
esistenti al fine di valutarne la maggiore o minore rispondenza al bene comune. Non ha senso cercare di
costruire un modello ideale perché, nel campo della politica, l’uomo opera a partire da situazioni specifiche e
da opinioni discutibili; non può quindi dedurne principi razionali universali e assolutamente certi, la politica
è scienza "di ciò che accade per lo più". Anche Aristotele, in questo segue Platone, vede nello Stato
l’organismo che consente il pieno sviluppo delle qualità di ogni uomo che per natura è socievole, "lo Stato
esiste per natura ed è anteriore all’individuo, perché, se l’individuo di per sé non è autosufficiente, sarà
rispetto al tutto nella stessa relazione in cui sono le altre parti. Perciò chi non può entrare a far parte di una
comunità o chi non ha bisogno di nulla in quanto basta a se stesso, non è membro di uno Stato, ma è una
belva o un dio" (Politica, I, 2, 1253 a 18).
Nel Medioevo lo Stato è espressione dell’autorità divina, una società è ben ordinata solo se rispecchia al
proprio interno la volontà divina e, dal momento che Dio è l’unico reggitore dell’universo, anche la società
umana deve essere retta da un’unica autorità: il concetto è espresso chiaramente da Hibernicus Exul, uno
degli intellettuali della corte di Carlo Magno: "Uno è colui che signoreggia nel tetto del cielo, il Tonante.
Questo vuol dire che sulla terra Uno solo deve regnare e tutti gli uomini devono guardare a Lui come al
giusto modello". Nel bisogno di un’unica autorità è possibile vedere la causa ideologica della lunga serie di
conflitti fra papato ed impero dal momento che ognuno rivendicava il ruolo di rappresentante di Dio sulla
terra. Conseguenza di questo conflitto sono stati il disordine l’anarchia feudali contro i quali già Dante
afferma, con la teoria dei "due soli", la necessità di separare autorità politica e autorità religiosa.
Con l’inizio dell’età moderna si assiste a un processo di trasformazione dello Stato: dallo Stato feudale,
caratterizzato dall’assenza di un potere centrale e dalla forte autonomia di città e gruppi sociali, si passa
gradualmente allo Stato moderno, caratterizzato da un ampio territorio, dal diritto esclusivo del sovrano di
controllare l’esercito per garantire l’ordine interno, di trattare con gli altri stati e di amministrare direttamente
i sudditi attraverso un apparato burocratico. La consapevolezza della profondità della trasformazione in atto,
della storicità delle tipologie di Stato e della necessità di esaminarne le diverse strutture giuridicoamministrative è espressa da Machiavelli: "Tutti li stati, tutti e’ dominii che hanno avuto et hanno imperio
sopra li uomini sono stati e sono o repubbliche o principati. E’ principati sono, o ereditarii, de’ quali el
sangue del loro signore ne sia suto lungo tempo principe, o e’ sono nuovi. E’ nuovi, o sono nuovi tutti, come
fu Milano a Francesco Sforza, o sono come membri aggiunti allo stato ereditario del principe che li acquista
come è el regno di Napoli al re di Spagna. Sono questi dominii così acquistati, o consueti a vivere sotto uno
principe, o usi a essere liberi; e acquistonsi o con le armi d’altri o con le proprie, o per fortuna o per virtù" (Il
Principe, I).
La teorizzazione più completa dello Stato moderno è di Thomas Hobbes. Hobbes ritiene che sia possibile
applicare anche alla politica il metodo deduttivo per ricavare leggi universali sulle quali fondare la
convivenza degli uomini. I principi fondamentali su cui si basa la sua teoria dello Stato sono universalmente
accettati dagli uomini sulla base della loro esperienza e perciò assolutamente sicuri:
1. ogni uomo ha per natura il desiderio di usare per sé le cose comuni a tutti (cupidatas naturalis)
2. ogni uomo per natura teme la morte violenta come il peggiore dei mali (ratio naturalis).
Lo "Stato di natura", lo Stato nel quale nessuna legge vincola l’uomo, è necessariamente caratterizzato dalla
"guerra di tutti contro tutti" perché l’uomo, desiderando per sé le cose comuni, si pone in situazione
conflittuale con gli altri; nello Stato di natura dunque "l’uomo è lupo per l’altro uomo" e teme per la propria
incolumità. Da ciò deriva la necessità di realizzare un accordo fra gli uomini che superi la forza della legge
naturale e garantisca l’incolumità di ognuno. Lo Stato nasce da questo contratto fra gli uomini secondo il
quale ognuno rinuncia ai propri diritti di natura e cerca la pace per salvare la vita. Per ottenere questo
risultato è necessario istituire un potere a cui affidare la difesa della propria vita infatti "l’autorità e non la
verità fa la legge". Il contratto da cui nasce lo Stato viene quindi stipulato fra i singoli individui che
rinunciano individualmente al loro diritto di natura- lo Stato è "il grande Leviatano", il "Dio mortale"
attraverso il quale gli uomini si sottraggono alla legge di natura e si sottomettono alla legge del sovrano. Per
queste ragioni Hobbes può esser considerato il teorico dello Stato assoluto. Nello Stato di Hobbes la legge
naturale non ha alcuna rilevanza, il sovrano è l’unica fonte della legge. Hobbes in questo modo si
contrappone alle teorie giusnaturalistiche del tempo che vincolavano l’attività legislativa del sovrano al
rispetto dei "diritti naturali", i diritti che l’uomo possiede per natura e il cui disconoscimento trasforma la
legge in arbitrio. Secondo le dottrine giusnaturalistiche il sovrano è vincolato al rispetto dei diritti naturali
(diritto alla vita, alla libertà, alla proprietà) perché il contratto che sta alla base dello Stato non vincola solo il
suddito, come sostiene Hobbes, ma anche il sovrano; lo Stato nasce per tutelare i diritti del singolo, non per
violarli. n giusnaturalismo in questo modo pone le basi teoriche dello Stato liberale moderno. I più
significativi teorici di questa idea di Stato sono Locke e Spinoza che sostengono apertamente il valore della
tolleranza come elemento essenziale della convivenza sociale.
Un ulteriore e più precisa teorizzazione dello Stato liberale avviene durante l’Illuminismo, che non solo
riafferma i vincoli del sovrano, ma sostiene la legittimità della "difesa" popolare contro i soprusi. Denis
Diderot alla voce Autorità politica dell’Enciclopedia scrive: "Nessun uomo ha ricevuto dalla natura il potere
di comandare agli altri. La libertà è un dono del cielo e ogni individuo della stessa specie ha diritto di
goderne non appena ha l’uso della ragione. (...) Il principe riceve dai suoi stessi sudditi l’autorità che ha su di
loro, e tale autorità è limitata dalle leggi della natura e dello Stato. (...) Le condizioni del patto sono diverse
nei differenti Stati. Ma dappertutto la nazione ha il diritto di difendere di fronte a tutti il contratto che ha
stipulato; nessun potere può cambiarlo; e quando esso non ha più valore, la nazione torna a godere del diritto
di stipularne un altro con chi e nei termini che più le piacciono" . Per la cultura illuminista il diritto alla
libertà è il più importante fra i diritti naturali; Rousseau afferma che rinunciare alla propria libertà significa
rinunciare alla propria qualità di uomo e Kant pone come imperativo categorico la considerazione dell’uomo
sempre come fine e mai come mezzo. Per questa ragione la cultura illuminista è uno dei cardini del moderno
pensiero liberale.
La teorizzazione della sovranità popolare, del diritto del popolo alla rivolta caratterizza il pensiero politico
dell’Ottocento e l’idea dello Stato come fatto naturale o storico anima le diverse filosofie.
L’idealismo sostiene la naturalità dello Stato, anzi lo Stato è necessario all’esplicazione della libertà
dell’individuo. Per Fichte lo Stato nasce da un contratto sociale e il suo fine è l’educazione alla libertà: un
potere è legittimo se mette i cittadini nella condizione di essere autonomi, sia sul piano culturale che su
quello materiale. Se il governo mantiene il patto su cui si fonda lo Stato il cittadino deve sottomettersi ad
esso: "nella nostra età, più che in ogni altra epoca precedente ogni cittadino con tutte le sue forze è
sottomesso alla finalità dello Stato, è completamente penetrato da esso e è divenuto suo strumento" (Tratti
fondamentali dell’epoca presente, X); se invece il patto non viene rispettato, allora diventa cogente la legge
morale. L’idea dello Stato etico, dello Stato che assicura la libertà ha la sua teorizzazione più importante in
Hegel: dovere supremo del singolo è essere parte dello Stato, perché solo nello Stato l’uomo può avere una
esistenza razionale, "l’eticità è l’idea della libertà (.. .) è il concetto di libertà divenuto mondo esistente. (. ..)
Lo Stato è la realtà dell’idea etica" (Hegel, Lineamenti di Filosofia del diritto, 142, 257).
Con la sconfitta della Restaurazione determinata dalle rivoluzioni dell’Ottocento la teorizzazione dello Stato
liberale matura definitivamente: compito dello Stato è garantire giuridicamente le libertà individuali e
collettive, esercitare il potere entro norme precise, fare partecipare le rappresentanze della società alla
elaborazione delle leggi e delle decisioni di governo. L’affermazione del primato della legge e del diritto di
voto come strumento di partecipazione e legittimazione popolare delle rappresentanze politiche sono il
fondamento di queste teorizzazioni: Stato liberale e Stato di diritto diventano sinonimi. Le prime
teorizzazioni dello Stato liberale pongono l’accento sulla libertà personale che, nella nascente società
industriale è prima di tutto libertà economica; lo Stato deve porsi al di sopra dei singoli e limitare il proprio
intervento in economia perché sarebbe una limitazione della libertà individuali. John Stuart Mill e Herbert
Spencer possono esser presi a modello di questo liberalismo. Mill teorizza la necessità di leggi che
garantiscano la rappresentatività dei gruppi politici e riforme tese a realizzare una migliore distribuzione
delle ricchezze avendo di mira una maggiore
giustizia, lo Stato deve essere "il governo di tutti per tutti". Spencer sostiene che l’intervento dello Stato
frena il progresso della società perché ostacola l’individuo nella sua ricerca del massimo utile possibile. E’
facile notare come la concezione dello Stato liberale sia caratterizzata tanto da una visione democratica che
da una moderata e conservatrice.
Contro le idee liberali si afferma, grazie al suo radicarsi fra i nuovi ceti operai urbani, la concezione dello
Stato socialista. L’analisi dello Stato accompagna tutta l’evoluzione del pensiero socialista e assume varie
connotazioni in epoche e in regioni diverse, a volte estremamente distanti fra loro; Lenin ad esempio chiama
Kautsky "rinnegato" e questo dimostra la distanza fra le loro posizioni teoriche. Senza fare la storia dell’idea
socialista di Stato vale la pena soffermarsi sull’analisi marxiana. Per Marx lo Stato è un prodotto storico
destinato a modificarsi con l’evoluzione della società, "lo Stato non esiste dall’eternità. Vi sono società che
ne hanno fatto a meno e non avevano alcuna idea di Stato e di potere statale. In un determinato grado dello
sviluppo economico, necessariamente legato alla divisione della società in classi, proprio a causa di questa
divisione lo Stato è diventato una necessità" (Engels, L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello
Stato). L’esame storico delle diverse forme statuali mette in evidenza come esse siano sempre state lo
strumento del dominio della classe dominante sulle altre e se le differenze di classe sono determinate dal
sistema economico, allora è necessario agire sull’economia per modificare la società anche se, va detto,
l’economia è determinante per la definizione dei rapporti di classe solo in ultima istanza, "secondo la
concezione materialistica della storia il fattore che in ultima istanza è determinante nella storia è la
produzione e la riproduzione della vita reale. Di più non fu mai affermato né da Marx, né da me" (Engels,
lettera a J. Bloch). L’avvento di una società senza classi diventa perciò immediatamente superamento dello
Stato come forma di oppressione di classe. Quando il proletariato assume la direzione della società ma non
ha ancora realizzato la società comunista, per realizzare il proprio fine, la società senza classi, deve usare
contro la borghesia gli strumenti del dominio di classe, dello Stato, deve esercitare la dittatura del
proletariato finché "le differenze di classe saranno sparite e tutta la produzione sarà concentrata nelle mani
degli individui associati, il potere pubblico perderà il carattere politico. (...) Al posto della vecchia società
borghese con le sue classi e coi suoi antagonismi di classe, subentra un’associazione nella quale il libero
sviluppo di ciascuno è la condizione per il libero sviluppo di tutti" (Marx, Manifesto del Partito comunista
del 1848). L’estinzione dello Stato è l’obiettivo del movimento socialista.
Nel mondo attuale, che qualcuno ha cominciato a definire post-industriale, l’organizzazione sociale è
diventata molto più complessa. La grave crisi economica del 1929 aveva indotto i governi a intervenire
nell’economia per mantenere il controllo delle tensioni sociali che la disoccupazione poteva generare. Sulla
base delle teorie di Keynes che mirano a mettere l’accento sugli elementi dinamici dell’economia per
favorire lo sviluppo, si viene formando lo Stato sociale. Il controllo delle dinamiche sociali è diventato
essenziale nella società odierna e i pensatori politici hanno elaborato la nozione di sistema politico (T.
Parsons, Sistema sociale, 1951) comprendendo in questo concetto l’insieme delle azioni e delle istituzioni
sociali che si propongono di dirigere una società verso un fine condiviso dai suoi membri. Nella odierna
società che è caratterizzata dalla partecipazione di tutti i cittadini attraverso le loro rappresentanze politiche e
le loro associazioni al governo della cosa pubblica, il problema del consenso è diventato fondamentale.