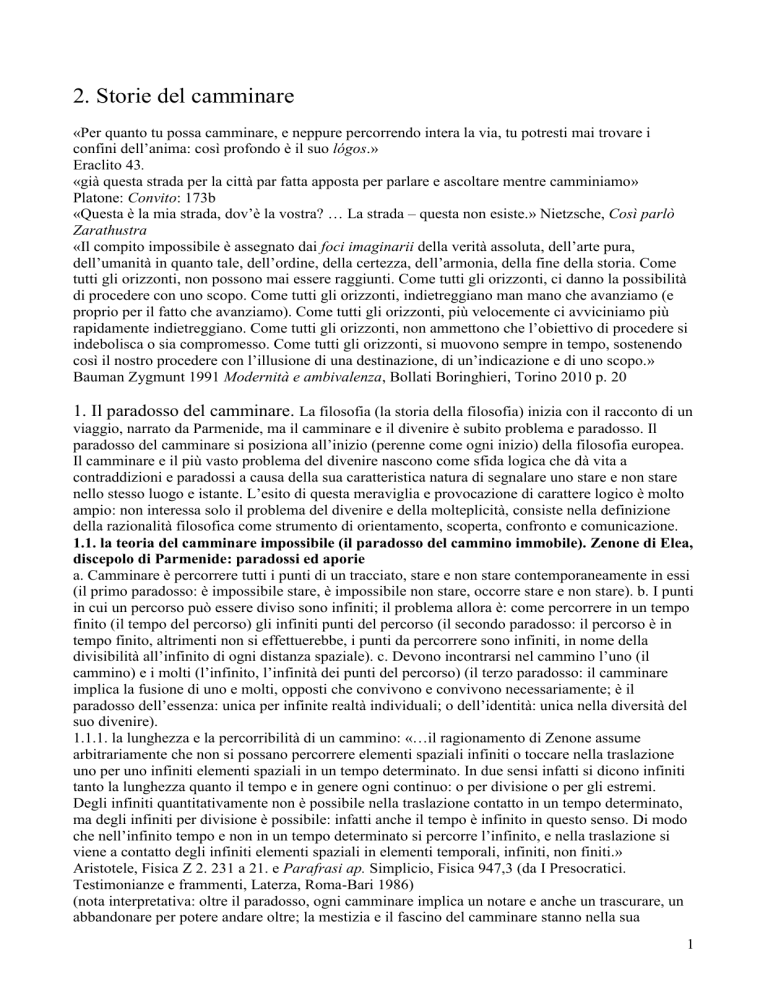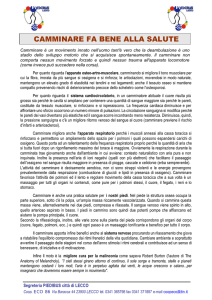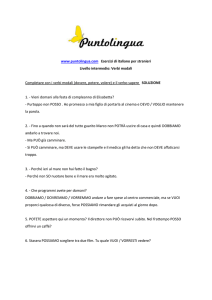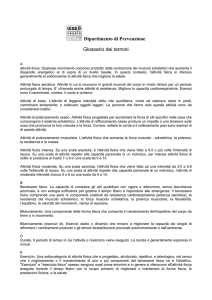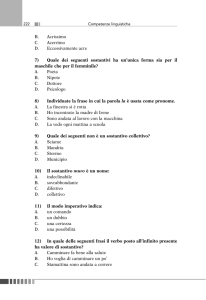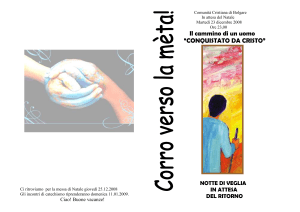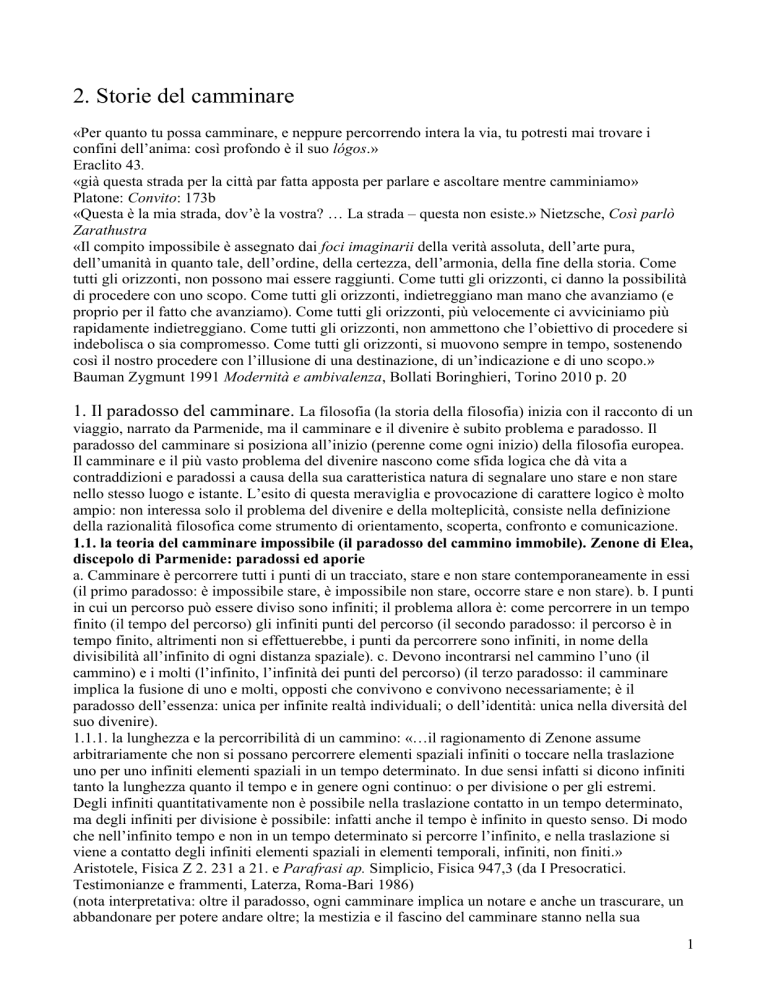
2. Storie del camminare
«Per quanto tu possa camminare, e neppure percorrendo intera la via, tu potresti mai trovare i
confini dell’anima: così profondo è il suo lógos.»
Eraclito 43.
«già questa strada per la città par fatta apposta per parlare e ascoltare mentre camminiamo»
Platone: Convito: 173b
«Questa è la mia strada, dov’è la vostra? … La strada – questa non esiste.» Nietzsche, Così parlò
Zarathustra
«Il compito impossibile è assegnato dai foci imaginarii della verità assoluta, dell’arte pura,
dell’umanità in quanto tale, dell’ordine, della certezza, dell’armonia, della fine della storia. Come
tutti gli orizzonti, non possono mai essere raggiunti. Come tutti gli orizzonti, ci danno la possibilità
di procedere con uno scopo. Come tutti gli orizzonti, indietreggiano man mano che avanziamo (e
proprio per il fatto che avanziamo). Come tutti gli orizzonti, più velocemente ci avviciniamo più
rapidamente indietreggiano. Come tutti gli orizzonti, non ammettono che l’obiettivo di procedere si
indebolisca o sia compromesso. Come tutti gli orizzonti, si muovono sempre in tempo, sostenendo
così il nostro procedere con l’illusione di una destinazione, di un’indicazione e di uno scopo.»
Bauman Zygmunt 1991 Modernità e ambivalenza, Bollati Boringhieri, Torino 2010 p. 20
1. Il paradosso del camminare. La filosofia (la storia della filosofia) inizia con il racconto di un
viaggio, narrato da Parmenide, ma il camminare e il divenire è subito problema e paradosso. Il
paradosso del camminare si posiziona all’inizio (perenne come ogni inizio) della filosofia europea.
Il camminare e il più vasto problema del divenire nascono come sfida logica che dà vita a
contraddizioni e paradossi a causa della sua caratteristica natura di segnalare uno stare e non stare
nello stesso luogo e istante. L’esito di questa meraviglia e provocazione di carattere logico è molto
ampio: non interessa solo il problema del divenire e della molteplicità, consiste nella definizione
della razionalità filosofica come strumento di orientamento, scoperta, confronto e comunicazione.
1.1. la teoria del camminare impossibile (il paradosso del cammino immobile). Zenone di Elea,
discepolo di Parmenide: paradossi ed aporie
a. Camminare è percorrere tutti i punti di un tracciato, stare e non stare contemporaneamente in essi
(il primo paradosso: è impossibile stare, è impossibile non stare, occorre stare e non stare). b. I punti
in cui un percorso può essere diviso sono infiniti; il problema allora è: come percorrere in un tempo
finito (il tempo del percorso) gli infiniti punti del percorso (il secondo paradosso: il percorso è in
tempo finito, altrimenti non si effettuerebbe, i punti da percorrere sono infiniti, in nome della
divisibilità all’infinito di ogni distanza spaziale). c. Devono incontrarsi nel cammino l’uno (il
cammino) e i molti (l’infinito, l’infinità dei punti del percorso) (il terzo paradosso: il camminare
implica la fusione di uno e molti, opposti che convivono e convivono necessariamente; è il
paradosso dell’essenza: unica per infinite realtà individuali; o dell’identità: unica nella diversità del
suo divenire).
1.1.1. la lunghezza e la percorribilità di un cammino: «…il ragionamento di Zenone assume
arbitrariamente che non si possano percorrere elementi spaziali infiniti o toccare nella traslazione
uno per uno infiniti elementi spaziali in un tempo determinato. In due sensi infatti si dicono infiniti
tanto la lunghezza quanto il tempo e in genere ogni continuo: o per divisione o per gli estremi.
Degli infiniti quantitativamente non è possibile nella traslazione contatto in un tempo determinato,
ma degli infiniti per divisione è possibile: infatti anche il tempo è infinito in questo senso. Di modo
che nell’infinito tempo e non in un tempo determinato si percorre l’infinito, e nella traslazione si
viene a contatto degli infiniti elementi spaziali in elementi temporali, infiniti, non finiti.»
Aristotele, Fisica Z 2. 231 a 21. e Parafrasi ap. Simplicio, Fisica 947,3 (da I Presocratici.
Testimonianze e frammenti, Laterza, Roma-Bari 1986)
(nota interpretativa: oltre il paradosso, ogni camminare implica un notare e anche un trascurare, un
abbandonare per potere andare oltre; la mestizia e il fascino del camminare stanno nella sua
1
impossibilità di notare e stare negli infiniti punti che costituiscono e giustificano il camminare
stesso; anche Simplicio, citando e commentando Aristotele, sottolinea come la possibilità di un
contatto con gli infiniti punti di un cammino si realizza solo in forza di un altro infinito: il tempo
infinito; situazione, questa, ideale che genera mestizia e fascino per le temporalità finite del vivere e
del camminare individuali.)
1.1.2. il caso della freccia lanciata verso un bersaglio: «Ciò che si muove non si muove né nel luogo
in cui è, né in quello in cui non è». Una freccia scoccata dall’arco che l’opinione comune crede sia
in movimento verso il bersaglio, in realtà è ferma. Infatti in ciascuno degli istanti in cui è divisibile
il tempo del percorso la freccia occupa uno spazio determinato, la freccia è in riposo in ogni istante
e in ogni punto del tracciato. Quindi il movimento è… la somma di istanti di riposo, di immobilità.
1.1.3. una strana e ben nota gara podistica: Achille e la tartaruga
«Secondo è l’argomento detto Achille. Questo sostiene che il più lento non sarà mai raggiunto nella
sua corsa dal più veloce. Infatti è necessario che chi insegue giunga in precedenza là di dove si
mosse chi fugge, di modo che necessariamente il più lento avrà sempre un qualche vantaggio.
Questo ragionamento è lo stesso di quello della dicotomia, ma ne differisce per il fatto che la
grandezza successivamente assunta non viene divisa per due. Dunque il ragionamento ha per
conseguenza che il più lento non viene raggiunto ed ha lo stesso fondamento della dicotomia
(nell’un ragionamento e nell’altro infatti la conseguenza è che non si arriva al termine, divisa che si
sia in qualche modo la grandezza data; ma c’è di più nel secondo che la cosa non può essere
realizzata neppure dal più veloce corridore immaginato drammaticamente nell’inseguimento del più
lento), di modo che la soluzione sarà, per forza, la stessa.» Aristotele, Fisica Z 9. 239 b 14.
Note preliminari: il paradosso è tra l’evidenza del dato fisico, che indica con chiarezza come una
distanza finita possa essere percorsa, che Achille raggiunge e supera la tartaruga, che la freccia
colpisce il bersaglio, e l’evidenza del dato logico matematico sulla divisibilità infinita delle
traiettorie. Il paradosso è, più fondamentalmente, interno al ragionamento di Zenone ed evidenzia il
problema e la natura del divenire.
Nota interpretativa: l’uscita dal paradosso è consegnata alla distinzione tra una divisione
matematica, operazione ideale e non fisica, e divisione empirica reale. Uscita che non annulla il
paradosso del camminare fonte di irrinunciabili significati e proposte culturali; sulla base del
paradosso infatti, l’insolita gara fa emergere il teorema della irraggiungibilità; rimanda di
conseguenza ad un ben altro noto paradosso, indispensabile per definire un qualsiasi modello ideale
ed un fine espresso in termini di completezza: il fine, l’ideale è necessario perché il camminare
prenda l’avvio, è irraggiungibile perché il camminare continui ad esistere, ad essere giustificato, ad
avere senso. Fin dall’inizio del pensiero filosofico europeo, nelle antinomie logiche generate dal
problema dell’essere, della sua unità e della sua molteplicità, del suo permanere e del suo divenire,
è presente l’ambivalenza del camminare e del viaggiare, la sua mestizia e il suo fascino, l’esigenza
di abbandonare per raggiungere.)
1.2. Nietzsche: elogio delle brevi abitudini a cui consegnare la propria unità in cammino e
oltrepassamento (l’oltreuomo); «tu sei sempre un altro» (Gaia scienza § 307).
La posta in gioco contenuta nei paradossi del divenire non si ferma alla sfida logica e matematica
che essi lanciano, ma si colloca in sede metafisica e quindi generale; diventa il modo di considerare
la natura di ogni realtà nella sua essenza propria e nel suo divenire. In sede antropologica si
trasforma nella domanda del divenire e del mutamento che ogni singolo vive, dei livelli e del diritto
al proprio essere in mutamento.
«296 La salda reputazione. Una volta la salda reputazione era una cosa estremamente utile, e
ovunque, almeno laddove la società continua sempre a essere dominata dall’istinto del gregge, è
ancor oggi quanto mai consono al fine di ogni individuo far passare per inalterabili il proprio
carattere come la propria occupazione, anche se questi, in fondo, non lo sono. «Si può fare
assegnamento su di lui, egli è sempre coerente a se stesso»: questa è, in tutte le contingenze
pericolose della società, la lode che deve considerarsi maggiormente significativa. La società sente
2
con soddisfazione di avere nella virtù di questo, nell’ambizione di quello, nella riflessione e nella
passione di quell’altro, uno strumento fidato, pronto ad ogni momento: essa tiene in sommo onore
questa natura strumentale, questa costante fedeltà a se stessi, questa irremovibilità nelle opinioni,
nelle aspirazioni e anche nelle non virtù. Un siffatto apprezzamento che è e fu in auge ovunque,
unitamente all’eticità del costume, educa «caratteri» e getta il discredito su ogni cambiamento, su
ogni diverso orientamento, su ogni autotrasformazione. Per quanto grande possa essere del resto il
vantaggio di un tal modo di pensare, si, tratta comunque per la conoscenza della forma di giudizio
universale più nociva di tutte: infatti proprio la buona volontà dell’uomo della conoscenza, di
dichiararsi intrepidamente, in ogni tempo, in antitesi alla sua preesistente opinione e di nutrire in
generale diffidenza per tutto quanto in noi voglia stabilizzarsi — è qui condannata e sottoposta al
discredito. I sentimenti dell’uomo della conoscenza, in quanto sono in contraddizione con la «salda
reputazione», sono considerati come disonorevoli, mentre la pietrificazione delle opinioni ha per sé
ogni onore: in balìa d’un siffatto criterio di valore dobbiamo vivere ancor oggi! Come è difficile
vivere, quando si sente contro e intorno a sé il giudizio di molti millenni! È probabile che per molti
millenni sia gravato sul conoscere il peso dalla cattiva coscienza, e che debbano esserci stati nella
storia dei più grandi spiriti molto disprezzo di sé e molta segreta miseria.»
Nietzsche Friedrich 1886 La gaia scienza, A. Mondadori, Milano 1878
«105. L’egoismo apparente. La maggior parte degli uomini, qualunque cosa possano ognora
pensare e dire del loro « egoismo », ciononostante, in tutta la loro vita, non fanno nulla per il loro
ego, bensì soltanto per il fantasma dell’ego, che si è formato, su di essi, nella testa di chi sta intorno
a loro, che si è loro trasmesso; in conseguenza di ciò vivono tutti insieme in una nebbia di opinioni
impersonali e semipersonali, e di arbitrari, quasi poetici, apprezzamenti di valore; ciascuno di
costoro vive sempre nella testa di un altro e questa testa ancora in altre teste: un curioso mondo di
fantasmi che sa darsi, in tutto questo, un’aria cosi assennata! Questa nebbia di opinioni e di
abitudini si sviluppa e vive quasi indipendentemente dagli uomini che essa avvolge; risiede in essa
l’enorme influsso dei giudizi generali sull’uomo, — tutti questi uomini sconosciuti a se stessi
credono nell’esangue entità astratta « uomo », vale a dire in una finzione; e ogni trasformazione
introdotta in questa astratta entità attraverso i giudizi di singoli potenti (come principi e filosofi)
influisce straordinariamente ed in misura irrazionale sulla grande maggioranza: tutto questo per la
ragione che ogni singolo, in questa maggioranza, non è in grado di contrapporre un reale ego, a lui
accessibile e da lui scrutato fino in fondo, alla pallida finzione universale, e non può, quindi,
annullarla.»
Nietzsche Friedrich 1886 Aurora, A.Mondadori, Milano 1981
Rainer Maria Rilke: “La nostra vita scorre trasmutando” Elegie duinesi, 7, 51
1.2.1. una questione e un’abitudine percettiva: il camminare e la visione: la percezione cinestetica,
la visione-cinema e la “teoria” propria del camminare e dello spostarsi dell’orizzonte
«Alla vigilia dell’invenzione del cinema, una rete di forme architettoniche ha prodotto una nuova
spaziovisualità. Luoghi come le gallerie, le stazioni ferroviarie, i grandi magazzini, i padiglioni
espositivi, le serre e i giardini d’inverno incarnavano la nuova geografia della modernità. Erano tutti
luoghi di transito. L’essenza di queste nuove architetture era la mobilità — una forma di cinema.
Modificando il rapporto tra percezione spaziale e movimento corporeo, le nuove architetture del
transito e la cultura del viaggio preparavano il terreno per l’invenzione del cinema, vera epitome di
modernità. (Bruno, o.c. p.17)
1.3. alle radici logiche (gli strumenti logici e filosofici, di filosofia prima) del camminare: il
tema degli opposti, il ruolo del paradosso e della contraddizione nella immagine logica del divenire.
1.3.1. nel camminare è presente il tema logico fondamentale e primario dell’incontro tra unità (il
continuo del camminare, l’essenza che definisce le realtà particolari secondo natura e ad incastro,
viventi, animali, uomini, cittadini, individui…) e la molteplicità indeterminata (i momenti per
definizione senza fine del camminare, le realtà singolari le uniche reali); il tema della identità nel
divenire; dell’unità nell’infinito/indeterminato. Si tratta del “cammino delle essenze”. L’essenza che
3
definisce le realtà è una (ad esempio l’umanità), ma essa non esiste come una realtà in sé o una
sostanza, si presenta in realtà e forme sempre individuali (gli uomini), in numero, per definizione
infinito; diversi e incomparabili nell’individualità identici e in relazione nella propria essenza. Si
impone il problema di come possa avvenire questa unità dell’essenza nella e della molteplicità
infinita. Solo nell’unità dell’essenza universale il particolare trova la propria natura e la propria
ragione. Trovare la ragione di ciò che accade diventa la condizione per gestire il fatto secondo
consapevolezza e volontà, collocare il proprio esistere e divenire in processi storici reali e
sostenerne l’accadere.
Ad occuparsi con particolare accanimento a livello logico del problema è Platone quando, nei
dialoghi “dialettici” (o “metafisici”), ricerca e presenta la nuova dialettica in grado di gestire la
molteplicità indeterminata dell’esperienza senza perdere la necessità logica del pensiero che si
orienta nel molteplice individuando e organizzando i dati secondo unità (secondo idee, concetti,
termini universali).
1.3.1.1. Una logica che evidenzia la natura e il movimento sia del pensiero che della realtà, la
dottrina degli elementi o dei principi “uno” e “indeterminato” costituisce l’essenza prima della
logica, della ragione, del linguaggio, della comunicazione nella estrema varietà delle loro forme
possibili. Platone la presenta in toni ispirati; essa è destinata a costituire il nucleo portante della
filosofia aristotelica, è infatti il cuore della sua “metafisica” o “filosofia prima” e, per trasmissione
culturale, il fondamento irrinunciabile del pensiero.
La tesi: « risultando dall’unità e dalla molteplicità le cose che sono, le cose che sempre sono state
dette e saranno dette ‘cose che sono’, esse portano in sé connaturato finito ed infinito»
Dal dialogo Filebo: «SOCR. Intendo il discorso che proprio ora ci è capitato davanti, che è per
natura sua, direi, straordinario. È infatti una proposizione straordinaria questa ‘i molti sono uno’ e
così quest’altra ‘l’uno è molti’, ed è facile obiettare a chi pone l’una o l’altra.» Filebo 14c
«SOCR. La prima questione è se bisogna assumere che alcune di tali unità realmente siano; e poi
vedere in che modo si deve intendere che ciascuna di queste essendo sempre identica, immune sia
da nascita che da corruzione, può appunto rimanere saldamente tale, una. E dopo di ciò bisogna
ciascuna di queste unità anche considerarla presente nelle infinite cose che divengono, o dilacerata,
e divenuta essa stessa in tal modo molteplice, oppure nella sua interezza e totalità, separata così da
se stessa, il che potrebbe apparire come l’impossibilità più assoluta, che essa cioè sia in una e
insieme in molte cose sempre una ed identica.» Filebo 15 ab
«SOCR. …Ma non v’è in verità strada migliore, né vi sarà mai, di quella ch’io sempre amo e spesse
volte sfuggendomi nel passato mi lasciò solo in mezzo alle difficoltà. PROT. Quale è questa? Non
ha che da esser detta. SOCR. Non è proprio difficile dire quale è, difficilissimo è invece farne uso;
tutte le scoperte relative alle arti che in ogni tempo furono raggiunte sono venute alla luce per
merito suo. Guarda di quale via parlo per il nostro ricercare. PROT. Non hai che da dirlo. SOCR.
Un dono degli dèi agli uomini, così almeno mi pare, da un punto del cielo divino un giorno sulla
terra fu gettato, per mezzo di un Prometeo, insieme ad un fuoco d’una chiarezza abbagliante e gli
antichi (che erano più valenti di noi e vivevano più vicino agli dèi) ce l’hanno tramandata questa
rivelazione e cioè che risultando dall’unità e dalla molteplicità le cose che sono, le cose che sempre
sono state dette e saranno dette ‘cose che sono’, esse portano in sé connaturato finito ed infinito. Di
conseguenza, essendo appunto le cose ordinate così, noi dobbiamo sempre ammettere e sempre
ricercare ovunque una nota caratteristica unitaria (e noi sempre in tutto la ritroveremo poiché vi è) e
come allora l’abbiamo colta, sono sempre essi che lo dicono, bisogna cercarne e esaminarne, dopo e
subordinatamente alla prima, altre due, se in qualche modo ce ne sono due, e se no tre o un qualche
altro numero e poi rifare l’operazione per ciascuna di queste ultime unità, finché la prima unità non
solo si veda che è unità e pure molteplicità e anzi infinita molteplicità, ma si veda anche la sua
struttura numerica. Non bisogna riferire il carattere di infinità alla molteplicità prima che si sia vista
tutta la complessiva struttura numerica di questa, struttura che sta nell’intervallo fra la sua unità e la
sua infinità. Solo a questo punto possiamo ormai lasciare che ciascuna unità, fra tutte quelle che
sono, si moltiplichi per suddivisione all’infinito. Così gli dèi, ciò che ho detto, affidarono a noi
4
uomini il compito di condurre questo tipo di analisi, di imparare in tal modo, di istruirci l’un l’altro
in base ai suoi risultati. Ma gli uomini dotti del nostro tempo unificano come capita e così
moltiplicano, in modo più rapido o più lento del dovuto, anzi subito dopo aver unificato
moltiplicano improvvisamente all’infinito. A loro sfugge però ciò che sta in mezzo fra l’uno e
l’infinito, proprio ciò per cui si distinguono i due modi, dialettico e, ciò che è il contrario, eristico,
del condurre i nostri discorsi tra di noi.» Filebo 16b – 17a
1.3.1.2. Una seconda coraggiosa ammissione logica necessaria a fornire la sede razionale filosofica
al camminare e, quindi, alla tensione presente nella sua specifica struttura tra ciò che è e ciò che non
è, consiste nell’ammissione del genere del “non-essere” (dell’altro) tra i generi sommi che
definiscono razionalmente la realtà e la sostengono nel suo reale divenire. Si tratta del noto
passaggio del dialogo di Platone, Sofista, in cui, contrastando clamorosamente e drammaticamente
le tesi di Parmenide (“venerando e terribile”) annovera tra i generi sommi dell’essere il non-essere,
accettando la contraddizione come condizione per aprirsi al camminare: al divenire e alla
molteplicità della realtà. «Abbiamo dimostrato che il non-essere è».
L’idea è introdotta con ripetuta titubanza, nel dialogo Sofista: «FORESTIERO E non s’ha a dire con
fiducia che il non essere ha sicuramente una sua propria natura; e, come il grande era grande, il
bello bello, e il non grande non grande e il non bello non bello: così anche allo stesso titolo il non
essere era ed è non essere, annoverabile, come una forma tra le molte che sono? O rispetto a ciò,
Teeteto, abbiamo tuttora qualche diffidenza? TEETETO Oh! nessuna. FOR. Ma sai dunque che
abbiamo disobbedito a Parmenide al di là del suo divieto? TEE. E perché? FOR. Perché, proceduti
con la nostra indagine anche oltre, noi gli abbiamo dimostrato più di quello che egli ci aveva
interdetto di esaminare. TEE. E come? FOR. Difatti egli, se non erro, dice: «Perché questo non può
venire mai imposto: che le cose che non sono siano: ma tu da questa via di ricerca allontana il
pensiero». TEE. Così difatti egli dice. FOR. E noi invece non solo abbiamo dimostrato che il non
essere è, ma del non essere abbiamo chiarito anche la forma che lo costituisce, perché dopo di aver
dimostrato che la natura del diverso è, e si trova sminuzzata per tutti quanti gli esseri nei rapporti
reciproci; di ciascuna particella di essa, che si contrapponga all’essere abbiamo avuto l’audacia di
dire che questa per l’appunto è realmente il non essere.» Sofista 258 b-d
Il nulla, il negativo, non come nulla assoluto, fa il proprio ingresso nella filosofia e nella logica
come condizione indispensabile per operare e definire.
Commenta Paul Ricoeur: «La parola stessa “altro”, che non abbiamo omesso di pronunciare
nell’introduzione, è stata oggetto, in un’epoca del pensiero che risale ai presocratici, di una
dialettica tagliente cui Platone dà nuovo respiro nella serie dei cosiddetti dialoghi metafisici, ossia
Filebo, Parmenide, Teeteto, Sofista. A noi, lettori sconcertati e prostrati, non resta altra risorsa se
non quella di considerare questa dialettica platonica come ciò a cui io mi permetto di attribuire,
sulla scorta di Stanislas Breton, la funzione meta- della più alta speculazione. Il filosofo vi propone
una ontologia di secondo grado, che sovrasta la teoria delle “Forme” o delle “Idee”. In questa
cornice, Platone designa delle entità da lui qualificate come i “generi sommi”. Da questa ontologia
di grado superiore derivano non soltanto le nozioni di essere e di non essere, che si installano nel
discorso platonico a partire dalla polemica con i sofisti, ma anche vari altri “generi sommi”
implicati nelle operazioni di “partecipazione” tra generi di primo grado. Non è irrilevante il fatto
che la rievocazione di questi “generi sommi”, e anzitutto dell’essere e del non-essere, offra
l’occasione di considerevoli aporie che suscitano la dialettica più tagliente, come quella del
Parmenide, e il relativo seguito di temibili “ipotesi”. E a questo stesso ciclo di “generi sommi”
appartengono anche le idee dell’uno e del molteplice, dello stesso e dell’altro, i quali danno luogo a
una serie di operazioni di congiunzione e di disgiunzione soggiacenti alla benché minima
operazione di predicazione, nella misura in cui predicare un termine di un altro significa far
“partecipare una idea di un’altra”. Il dialogo Sofista accentua ulteriormente la reduplicazione dei
livelli di discorso proponendo un ordine di derivazione tra qualcuno di questi “generi sommi”; così,
la polarità del medesimo e dell’altro si rivela embricata nella dialettica dell’essere nella misura in
cui il medesimo deve definirsi al tempo stesso tramite il “relativamente a sé” e il “relativamente ad
5
altra cosa”.
Siamo qui condotti alla radice della nozione di identificazione, in quanto questa mira al
“relativamente a sé del medesimo” congiunto alla distinzione del “relativamente ad altra cosa dal
medesimo”. Ed ecco che veniamo trasportati a notevole distanza dall’ingenuo essenzialismo degli
“amici delle Forme”, che troppo spesso è servito da paradigma del sedicente platonismo e di tutta la
sua discendenza attraverso i secoli.
Il nostro problema, il problema moderno del giudizio, si presenta sotto svariati aspetti come l’erede
di questa alta speculazione. Come si è visto, per Platone il problema consisteva nel replicare
all’interdetto pronunciato da Parmenide nei confronti del collegare a un soggetto-medesimo un
epiteto-altro; l’interdetto insomma nei confronti della predicazione. Il filosofo rispondeva a questa
sfida con la teoria della “comunanza dei generi”, chiamata anche “partecipazione”, in altri termini la
reciproca combinazione dei generi. Non è esagerato pretendere che il nostro problema del
riconoscimento-identificazione sia il lontano erede, in un’altra epoca del pensiero, del problema
platonico della “comunanza dei generi”. È forse possibile parlare di identificare senza richiamare la
formula ispirata dal commento al Sofista di Auguste Diès: “Ciò che si pone si oppone in quanto si
distingue e niente è sé senza essere altro dal resto”?» Ricoeur Paul 2004 Percorsi del
riconoscimento (Parcours de la reconnaissance), Raffaello Cortina, Milano 2005 pp. 31-33
1.3.2. Hegel: la natura dialettica della logica e l’ontologia del camminare. Collocata nel finito, nel
determinato, la logica deve affrontare contemporaneamente il tema del limite (della finitudine) e del
divenire (dell’alterità e del rapporto essenziale e necessario tra qualcosa ed altro). L’attenzione è sia
di carattere fenomenologico, sia di tipo logico. La descrizione puntuale e analitica del divenire
(descrizione fenomenologica), nella mestizia del suo transitare, si deve aprire alla scoperta della
logica del suo movimento: essa consiste nella sua interna tendenza a rimandare ad altro, quindi alla
propria negazione ma anche al superamento, drammatico e appassionante, della negazione stessa. In
questa tensione prende forma logica il camminare e diventa contesto in cui si delinea la natura
dialettica della logica, dell’esistenza e della realtà. Si tratta di un procedimento per contraddizione e
paradossi sostenuto dalla tensione di una sintesi che supera e conserva gli elementi antitetici
(molteplicità, contraddizione e unificazione).
Hegel: il tema del finito nella logica dialettica del determinato e del suo camminare. Il determinato,
il finito, ha nella propria logica (di tipo dialettico) l’estinguersi e il perire; ma il finire è anche il
rimandare ad altro; quella mestizia del limite in cui ci si colloca, poiché attraverso il confine e il
termine si acquisisce una propria determinatezza, dà vita anche al togliersi della mestizia della
propria finitudine nella relazione che, avviata, non trova ragioni per il proprio arresto e diventa un
reciproco rimandare (sintesi) infinito tra finitudini; diventa quindi relazione, rimando e
comunicazione, un perenne camminare.
«La finità. L’esserci è determinato. Il qualcosa ha una qualità, e in questa qualità non è soltanto
determinato, ma ha un limite. La sua qualità è il suo limite, come affetto dal quale esso riman
dapprima un esserci affermativo, quieto. […] Quando delle cose diciamo che son finite, con ciò
s’intende che non solo hanno una determinatezza, che non solo hanno la qualità come realtà e
determinazione che è in sé, non solo son limitate, così da avere poi un esserci fuor del lor limite, —
ma che anzi la lor natura, il loro essere, è costituito dal non essere. […] Il pensiero della finità delle
cose porta con sé questa mestizia, perché una tal finità è la negazione qualitativa spinta al suo
estremo, perchè alle cose nella semplicità di cotesta determinazione, non è più lasciato un essere
affermativo distinto dalla lor destinazione a perire. La finità […] è la categoria cui sta più
ostinatamente attaccato l’intelletto. […] L’intelletto persiste in questa mestizia della finità, facendo
del non essere la destinazione delle cose e prendendolo insieme come imperituro e assoluto. […] Se
non che tutto sta a vedere se in questo modo ci si ferma all’essere della finitezza, se la caducità,
cioè, persiste, oppure se la caducità e il perire perisce. Ora che questo non avvenga, ciò si ha di fatto
appunto in quella veduta del finito, la quale suppone che il finito abbia il perire per suo ultimo. È
affermazione espressa che il finito sia incompatibile e incongiungibile coll’infinito, che il finito sia
6
assolutamente opposto all’infinito. […] Se il finito non deve persistere di fronte all’infinito, ma
perire, allora, come già fu detto, l’ultimo è appunto il suo perire, e non l’affermativo, che sarebbe
solo il perire del perire. […] Questo è da portare alla coscienza; e lo sviluppo del finito fa vedere
che, essendo questa contraddizione, il finito si distrugge in sé, ma risolve effettivamente la
contraddizione, non già ch’esso sia soltanto caduco e che perisca, ma che il perire, il nulla, non è
l’ultimo, ossia il definitivo, ma perisce.» Hegel G.W.F. 1812-1816 Scienza della logica, ed. Laterza,
Bari 1968, pp. 128-130 (passim)
Osserva Marcuse «Il continuo morire delle cose è dunque anche una continua negazione della loro
finitudine. Questa è l’infinità. … L’infinito è dunque proprio l’intrinseca dinamica del finito
compreso nel suo significato reale. Esso consiste solo nel fatto che la finitudine “esiste solamente
nel suo passare oltre”» (H.Marcuse, Ragione e rivoluzione, 166).
Questa è l’ontologia del camminare.
1.3.3. nota di metodo e di primo bilancio: la funzione del paradosso per camminare nella logica;
un camminare che mira ad indagare e allargare i confini e le potenzialità della realtà e della mente.
La nota di metodo dovrebbe tener presente la natura complessa dei due elementi che ricorrono nel
paradosso e lo costituiscono: antinomia, dicotomia, contrasto, contraddizione, ambivalenza,
ambiguità, complementarità, rimando … e forse altro.
«…ora io ho in mano le due estremità dell’arco, ma non ho ancora la forza per tenderlo» Walter
Benjamin (in Desideri Fabrizio, Baldi Massimo 2010 Benjamin, Carocci editore, Roma p. 154)
«I paradossi entrano in contrasto con le idee ricevute e danno al buon senso un aspetto imprevisto.
Essi esaltano tuttavia l’intelligenza proprio là dove l’assurdo sembra regnare indisturbato. … Il
paradosso rappresenta per il logico ciò che l’esperienza è per lo scienziato. Dal paradosso prototipo,
quello del mentitore, è nata, nel XX secolo, una nuova logica, sotto l’impulso di matematici come
Gödel, Tarski, Brouwer, Russel, Whitehead. E la potente elaborazione tedesca ha saputo, con
Cantor, Hilbert e altri, sviscerare i paradossi dell’infinito posti dai filosofi di Elea (da Parmenide,
Zenone e seguaci). Achille riuscirà a raggiungere la tartaruga? Si tratta di una domanda ancora
angosciante dopo quasi trenta secoli? Nessun quesito ha sollevato tanti commenti, un così grande
stupore e disperazione di trovarne la soluzione e, anche, un gran divertimento nel notare lo
smarrimento, il disorientamento e il balbettio dell’interlocutore. Il paradosso, contestazione del
preteso ordine logico del mondo, lo spiega e lo porta a perfezione. Non si risolve un paradosso
ragionando all’interno di un quadro noto: bisogna indietreggiare, decrittare nuove verità, offrire una
scappatoia, forgiare nuovi concetti. … Tipiche delle nostre cadute logiche quotidiane sono frasi
paradossali che esplodono come bombe ritardate quando la loro caduta annulla l’esordio: «I razzisti
sono esseri inferiori» (da un manifesto antirazzista)… «Io non sono superstizioso, perché porta
male» (Alphonse Allais) … Agente doppio, della logica e dell’umore, il paradosso racchiude una
doppia capacità e suscita spesso una interpretazione che arricchisce, rimasta di primo acchito
inavvertita: mettendo in scacco le idee ricevute del nostro conforto intellettivo, il paradosso fa
opportunamente ripartire il pensiero verso più larghi orizzonti.»
Boulanger Philippe, Cohen Alain 2007 Le trésor des paradoxes, Belin, Paris, (p. 8-11)
Occorre una gestione logica del paradosso (e sarà il paradosso a dare forma alla logica). Occorre
una gestione psicologica del paradosso (e sarà il paradosso a sostenere la risoluzione psicologica)
Osserva D. Winnicott, in contesto psicanalitico e psicoterapeutico, (con riferimento agli oggetti
transizionali): « Il mio contributo è quello di chiedere che un paradosso venga accettato, tollerato, e
rispettato, e che resti non risolto. Con un rapido passaggio a un funzionamento intellettuale scisso si
potrebbe risolvere il paradosso, ma il prezzo di ciò sarebbe la perdita del valore del paradosso
stesso. Questo paradosso, una volta accettato e tollerato, ha valore per ogni individuo umano che sia
non soltanto vivo e vitale in questo mondo ma che sia anche capace di arricchirsi infinitamente
mediante la utilizzazione del legame culturale con il passato e con il futuro. […] Il paradosso deve
essere tollerato» Winnicott W. Donald 1971 Gioco e realtà, Armando editore, Roma 1995 p. 18,
185)
7
“La vita alle prese con i paradossi della vita quotidiana” è espressione con cui si presenta la
riflessione filosofica di Maurizio Ferraris sugli oggetti e gesti ordinari e per lo più ritenuti
irrilevanti: Ferraris Maurizio 2008 Il tunnel delle multe. Ontologia degli oggetti quotidiani, Einaudi,
Torino
2. cammini di fondazione (e tre miti “archetipi”)
2.01. Una introduzione ontologica e pedagogica. « Per comporre di senso il tempo. Quando ci si
trova a pensare il proprio essere si scopre che «è un essere inconsistente», nel senso che la
condizione ontologica è quella per la quale a ogni istante ci si scopre esposti al nulla (Stein, 1999b,
p. 64). Viviamo nel tempo e il tempo è la nostra materia, ma su di esso non abbiamo alcuna
sovranità; solo il presente ci appartiene, ma il presente è l’attuazione fugace di un attimo che subito
sfugge. Il nostro essere è il divenire, e il divenire è il prorogarsi di istante in istante, ma ogni istante
in cui si diviene si porta via una goccia di essere. Siamo dunque mancanti d’essere e non c’è nulla
nella condizione umana che dia garanzia di diventare il proprio poter essere; siamo una serie di
possibilità, ma il possibile non è già l’essere.
Ma nel mentre in cui ci si scopre mancanti d’essere, prorogati di momento in momento e sempre
esposti alla possibilità del nulla, ci si trova anche chiamati alla responsabilità di dare forma al
proprio essere possibile, una responsabilità fermentata dal desiderio incoercibile di vivere una vita
buona. È questo il paradosso dell’esistenza: sentire il proprio essere inconsistente, fragile, fugace,
senza che si disponga di alcuna sovranità sul proprio divenire, e allo stesso tempo sentirsi vincolati
alla responsabilità di rispondere alla chiamata ad attuare il proprio essere possibile, quel faticoso
lavoro ontogenetico in cui consiste il mestiere del vivere e che chiede di mettere tra parentesi il
nostro vivere di momento in momento per pensare nel tempo lungo. Si nasce dunque gravati da un
compito che altri viventi, come le betulle o le api, non hanno: quello di dare forma al proprio tempo,
ossia di disegnare di senso i sentieri dell’esistere. Si tratta di imparare ad aver cura dell’esistenza;
detto in altre parole di imparare l’arte di esistere, quella sapienza delle cose umane (anthropìne
sophìa), di cui parla Socrate (Apologia di Socrate, 20d), che ci farebbe trovare la buona forma del
vivere. L’arte di esistere è quella sapienza che lavora sul tempo per farne una composizione di
senso. […] Se l’educazione non può insegnare direttamente quella sapienza essenziale e primaria
che è l’arte di esistere, può tuttavia guidare il soggetto educativo ad apprendere quei metodi di
ricerca ontogenetici — cioè che danno forma all’essere — praticando i quali si va in cerca del
sapere essenziale. Quell’aver cura dell’anima dei giovani, in cui consiste l’essenza dell’educazione
(Platone, Lachete, 185d), e che va intesa come l’aver cura che l’altro si prenda cura della sua anima,
si attualizza dunque non nel passare all’altro un sapere già dato, perché nessuno lo possiede per
intero e solo i saggi ne possiedono frammenti, ma nel guidare l’altro alla consapevolezza della
primarietà esistentiva della ricerca di tale sapere; tale consapevolezza costituisce, infatti, condizione
essenziale affinché il soggetto risponda alla chiamata ontologica di attivarsi per divenire proprio
essere possibile. Anche se il sapere più vivo ed essenziale, quello delle cose della vita, non può
essere trasmesso, è possibile fare sperimentare ai giovani quei percorsi di ricerca che, alla luce
dell’esperienza, sono risultati significativi da intraprendere per far fiorire di senso il tempo del
vivere. L’educazione, quindi, va intesa come l’aver cura di offrire ai giovani quelle esperienze che
muovono il desiderio di apprendere le pratiche necessarie alla ricerca di ciò che è irrinunciabile per
autenticare il proprio tempo.» Mortari Luigina 2009 Aver cura di sé, Bruno Mondadori, Milano,
p.1,2.
2.02. Una esperienza universale: «Scoprire l’ignoto non è una specialità di Simbad, di Erik il Rosso
o di Copernico. Non c’è un solo uomo che non sia uno scopritore. Inizia scoprendo l’amaro, il
salato, il concavo, il liscio, il ruvido, i sette colori dell’arcobaleno e le venti e più lettere
dell’alfabeto; continua coi volti, le mappe, gli animali e gli astri; conclude col dubbio o con la fede
e con la certezza quasi totale della propria ignoranza.» Jorge Luis Borges 1984 Atlante, il Totem, in
Tutte le opere, II, A.Mondadori, Milano 1987, dal Prologo p. 1313.
8
Tre miti.
2.1. La scoperta di essere nudi e l’uscita dall’Eden: l’inizio dell’esistenza umana come
consapevolezza di assenza, storia di rischio e di possibilità.
«Si aprirono allora gli occhi di ambedue e conobbero che erano nudi; perciò cucirono delle foglie di
fico e ne fecero delle cinture» (Genesi 3,7) «E ad Adamo disse: “…Maledetto sia il suolo per causa
tua! Con affanno ne trarrai il nutrimento, per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi farà spuntare
per te, mentre tu dovrai mangiare le graminacee della campagna. Con il sudore della tua faccia
mangerai pane, finché tornerai nel suolo perché da esso sei stato tratto, perché polvere sei e in
polvere devi tornare!» (Genesi 3,17-19).
2.1.1. Nota strutturale sugli eventi delle origini e il tempo del mito. Si tratta di eventi ai quali si
riconosce il carattere di fondazione di una nuova realtà. Sono fatti dell’origine e, come tali, essi
vengono riconosciuti nel loro ruolo da uno sguardo storico retrospettivo, eziologico, teso alla
ricerca di un principio che serva a connettere e porre in sequenza i fatti che, collocati in questa
linearità, acquistano senso, vengono definiti e individuati come storici (la storia, infatti, non è
l’insieme di tutti i fatti che materialmente accadono, ma di quelli che si collocano all’interno di una
linearità discorsiva legata e, in qualche modo, consequenziale). I fatti posti all’inizio non sono, in
senso stretto, storia ma ne costituiscono l’origine; è solo il tempo successivo, storico, che da essi
dichiara di prendere avvio, ad attribuire loro il carattere di origini. Il tempo che li caratterizza
corrisponde alla loro natura di fondamento. Mentre i fatti storici si susseguono secondo una certa
linearità (diversificata secondo il variare delle visioni della logica storica), hanno una data precisa,
un inizio e una fine, i fatti delle origini invece sono accaduti “una volta per tutte” (il termine greco
che indica una simile temporalità è “ephapax”), o, come afferma Plutarco, non sono mai accaduti
perché accadono sempre. Sono questi fatti a costituire l’oggetto del mito e per definizione il mito è
discorso delle origini. Ricompare nel mito la natura paradossale del camminare, riportata al
massimo della sua essenzialità. Il fatto delle origini, del mito, accade sempre: 1. è cioè unico e in
ciò dotato di massima stasi e stabilità, 2. è presente nell’intera durata di un camminare e lo regge
unitariamente, in ciò dotato della massima infinità storica (di una eternità temporale). La
temporalità propria del mito è quella appunto di essere sempre presenti secondo una temporalità
strutturale che è insieme esterna e immanente al tempo storico. Riti collettivi e narrazioni epiche
richiamano i fatti del mito e diventano il modo per riattualizzarne nel richiamo e nel ricordo
l’efficacia fondativa storica.
2.2. Il viaggio di Edipo: un cammino prima di fuga dalle sventure vaticinate e poi di agnizione,
rallentato e straziante, conclude il viaggio in quelle stesse sventure e nell’accecamento; una volontà
di conoscere che assume la forma di un cammino di ubris autodistruttiva.
«Edipo: Mio padre era Pòlibo, di Corinto; e mia madre, Mèrope, della Dòride. E io ero considerato
il più notabile dei cittadini del luogo: finché capitò un incidente del quale, sì, era naturale ch’io
rimanessi sorpreso, non però credo, che me ne dessi la pena che poi me ne diedi. Un tale, in un
convito, — aveva bevuto troppo ed era ubriaco, — così, tra il vino, mi insolentisce dicendo che io
non sono figlio genuino di mio padre. …. di nascosto dal padre e dalla madre, vado a Delfi. Alle
domande che ero venuto a fargli, Febo mi rimandò via senza risposta; ma altro mi annunciò, cose
orrende, obbrobriose, sciaguratissime: e che io avrei dovuto congiungermi con mia madre, e che
avrei messo al mondo una prole intollerabile agli occhi degli uomini, e che sarei stato l’uccisore di
mio padre, del padre che mi aveva generato. Udito ciò, io, misurando ormai dalle stelle il mio
cammino, abbandonai la terra di Corinto, e venni in luogo dove non avessi mai veduto compiersi le
vergogne che le voci maligne dell’oracolo avevano profetato. E così, seguitando il mio viaggio,
arrivo a quei luoghi dove tu dici che questo re morì. Ora io, o donna ti dirò tutta intiera la verità.
Quando nel mio andare mi trovai vicino a quel tale incrocio delle tre strade, ecco che quivi mi vedo
davanti un araldo e, sopra un carro tirato da cavalli, un uomo quale or ora tu mi descrivevi:
venivano in senso contrario al mio. Il conduttore del carro e, per la sua parte, anche il vecchio, mi
9
sforzano con violenza a uscir fuori della mia strada; cosicché io, preso da collera, quello che aveva
tentato spingermi fuori, il carrettiere, lo percuoto. …» Sofocle, Edipo re, 774 - 805
Nella tragedia di Sofocle prendono forma tutti i cammini della ironia tragica (e paradossale): la
strada intrapresa per sfuggire alla sventura è quella che vi porta; la caparbia volontà di sapere per
portare a salvezza diventa un cammino di autodistruzione; il bando lanciato contro il cieco-vate
Tiresia è una condanna di sé all’esilio e all’accecamento; il discredito gettato sugli oracoli in nome
della ragione ne favorisce l’adempimento; la volontà di annullare il destino fatale lo realizza…
2.3. Migrazioni fondative: umanità in movimento
2.3.1. Abramo: «Vocazione di Abramo. Yahweh disse ad Abram: «Vattene dalla tua terra, dalla tua
parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti mostrerò, cosicché faccia di te una grande
nazione e ti benedica e faccia grande il tuo nome, e tu possa essere una benedizione. Benedirò
coloro che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te acquisteranno benedizione tutte le tribù
della terra ». Allora Abram partì, come gli aveva detto Yahweh, e con lui partì Lot. Abram aveva
settantacinque anni quando lasciò Carran. Abram prese Sarai, sua moglie, e Lot, figlio di suo
fratello, e tutti i loro beni che avevano acquistato e le persone che avevano comprate in Carran, e
s’incamminarono verso la terra di Canaan. Abram attraversò il paese fino al santuario di Sichem,
presso la Quercia di More. Allora nel paese si trovavano i Cananei. Yahweh apparve ad Abram e gli
disse: «Alla tua discendenza io darò questa terra ». Sicché egli costruì colà un altare a Yahweh che
gli era apparso. Poi di là andò verso la montagna, ad oriente di Betel e rizzò la sua tenda, avendo
Betel ad occidente ed Ai ad oriente. Ivi costruì un altare a Yahweh Signore ed invocò il suo nome.
Poi Abram sloggiò, levando, tappa per tappa, l’accampamento, verso il Negheb.» (Genesi 12, 1-9)
2.3.2. Gesù. Migrazioni senza accoglienza: «In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et
mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperunt» (Gv. 1,10-11);
« non erat eis locus in diversorio» (Lc. 2,7). Si deve sempre ricordare che i fatti narrati nei Vangeli,
anche quelli che risultano alla prima lettura di portata minima, sono sempre “fatti del vangelo”, fatti
storico-salvifici, eventi di salvezza, eventi teologici. I Vangeli (il Nuovo Testamento) annunciano,
nelle proprie parole e nei fatti che narrano, l’avvento dei tempi messianici. Nella nascita di Gesù e
nel suo non trovare posto, nella non accoglienza che gli accade non è presente un problema di
logistica alberghiera, magari contingente e di semplice cronaca vista la mobilità creata dal
censimento, ma il problema dell’aprirsi o meno degli uomini all’annuncio e all’avvento di una
nuova era e la loro radicale conversione (metànoia).
2.3.3. (attuali flussi migratori e politica dei respingimenti come vicende di fondazione,
rifondazione, origini, nuove origini … possibili o negate; il prendere corpo della distinzione tra
luogo e spazio nel vissuto personale) vedi 3.4.2.
Ghardaia, in Algeria, nel mondo
Ci sono persone che nascono, crescono, invecchiano, muoiono rimanendo sempre, per tutta la vita,
nello stesso posto. Senza conoscere niente di diverso da quello che hanno intorno. Quella strada,
quella piazza, quel muro. Quella casa, la loro, quella dove sono nate, cresciute, invecchiate e dove
quasi certamente moriranno.
Possiamo dire che ormai in larga parte del mondo questo succede sempre più raramente?
Tutto questo stava sicuramente succedendo a Omar Abdenour, ma accadde qualcosa negli ultimi
anni della sua vita, per cui Omar Abdenour è a pieno titolo da considerare uscito dal gruppo e non
sarà più uno che è nato, cresciuto, invecchiato e morto nello stesso posto.
Viste le premesse, poteva sembrare proprio che nulla di differente potesse accadere.
Vitale Amedeo 2009 24 racconti e mezzo, Iacobelli, Roma, p. 23
3. camminare, contesto e definizione di emozioni, memoria, teoria
10
Emozioni, memoria e teoria sono, nella loro essenza dinamica, forme e definizione del camminare.
Il loro movimento si accompagna e si appoggia su tre elementi: il metodo, la mappa, la visione
cinestetica. Si crea una circolarità di reciproca generazione e definizione (ed è un nuovo
camminare) tra questi tre momenti del camminare, tra le sue strategie (metodo, mappa, visione
cinestetica), i suoi esiti (emozioni, memoria, teoria).
3.01. lo stimolo che mette in evidenza il problema è “archeologico”; i primi documenti storici della
filosofia identificano metodo con cammino: il metodo (metà odos) e la via, il cammino (odos)
linguisticamente coincidono e tematicamente si richiamano: «Orbene io ti dirò e tu ascolta
attentamente le mie parole, quali cammini di ricerca sono i soli pensabili». Quel metodo – cammino
è presentato come luogo di emozioni iniziatiche (espresse soprattutto nei primi drammatici versi del
poema di Parmenide fr.1), di fedele ascolto, custodia e memoria (fr. 2,4,8), di accesso al vero: «è il
sentiero della Persuasione giacchè questa tien dietro alla Verità» (fr.2)
3.1 emozioni
3.1.1. Due avvertenze: 1. cogli lo spunto fornito dall’etimologia; 2. cogli il significato performativo
della parola (parola come atto linguistico). L’etimologia, in generale, può condurre al senso della
parola e il senso della parola è più ampio del suo significato se con la parola si intende un atto
linguistico, se si fa riferimento al linguaggio come all’insieme di quegli atti linguistici che risultano
performativi. Non si tratta di semplici termini (suoni o segni scritti) stipati alfabeticamente in un
vocabolario; le parole negli atti linguistici diventano fatti, creano situazioni. Il linguaggio va qui
considerato «come azione piuttosto che come struttura o risultato di un processo conoscitivo». Si
tratta di una prospettiva posta all’attenzione della filosofia dai contemporanei autori della scuola
analitica di cui John Austin può considerarsi uno dei fondatori e interprete autorevole. Al centro
dell’attenzione analitica si pongono gli “atti linguistici” (gli “speech acts”) e il loro carattere
performativo: enunciati (soprattutto quelli alla prima persona del presente indicativo) che non
descrivono un atto, ma servono a compierlo, cioè «alcuni casi o sensi (solo alcuni, per amore del
cielo!) in cui dire qualcosa è fare qualcosa; o in cui col dire o nel dire qualcosa noi facciamo
qualcosa.» Austin J.L. 1962, 1975, Come fare cose con le parole. Le «William James Lectures»
tenute alla Harvard University nel 1955, Marietti, Genova 1987
«Per troppo tempo i filosofi hanno assunto che il compito di una « asserzione » possa essere solo
quello di «descrivere» un certo stato di cose, o di «esporre un qualche fatto», cosa che deve fare in
modo vero o falso. Gli studiosi di grammatica, in realtà, hanno regolarmente fatto notare che non
tutte le frasi sono (usate per fare) asserzioni: ci sono, tradizionalmente, oltre alle asserzioni (degli
studiosi di grammatica), anche domande ed esclamazioni, e frasi che esprimono ordini o desideri o
concessioni. E sicuramente i filosofi non intendevano negare ciò, nonostante qualche uso impreciso
di “frase” per “asserzione”». (Austin, ivi)
Così come una dichiarazione di matrimonio nelle parole crea una situazione giuridica e storica
nuova, una narrazione, formalmente adeguata, suscita emozioni ed esperienze.
3.1.2. In applicazione alcune etimologie di parole che si scoprono forme e atti del camminare.
3.1.2.1. L’etimologia di errare, la sua ambivalenza e il camminare. «Errare significa abbandonare
la retta via; la semiotica del termine porta con sé il concetto di erranza, o vagabondaggio. L’errore –
la diversione dal cammino, un abbandono dei principi – è strettamente legato a un simile
vagabondaggio. Come un atto di navigazione su un corso tortuoso, implica deviazioni, digressioni e
persino la possibilità di smarrirsi.» Bruno Giuliana 2002 Atlante delle emozioni. In viaggio tra arte,
architettura e cinema, B. Mondadori, Milano, p.15 (da questa ricca e analitica opera sono ricavate
per lo più le suggestioni di questo passaggio sul camminare)
3.1.2.2. L’etimologia di emozione rimanda ad un autentico camminare. «Significa prendere la
parola emozione nella sua accezione storica di “uscire da sé” — un’accezione che, lo si è già notato,
include le migrazioni e i trasferimenti da un luogo all’altro — e misurarsi pertanto con la
componente affettiva di questa delocalizzazione nella storia: misurarsi, cioè, con l’itinerario dello
“spazio-affezione”.» (Bruno Giuliana 2002 p.241-242) «L’emozione — come abbiamo osservato —
11
si rivela una faccenda itinerante: una mobile forma di passione epistemologica e di forza storica. Il
suo etimo ne indica il percorso: un andarsene, una migrazione, un trasferimento da un luogo
all’altro. L’effetto fisico dello strappo dell’emozione si inscrive nell’esperienza stessa del transfert e
dello spaesamento spaziale e, in tal modo, assicura la fabbricazione del viaggio culturale.
L’immagine in movimento, con la sua personale versione psicogeografica del transito dell’emovere,
si è modellata proprio in questa emozione.» (Bruno 2002 p. 236) «La nostra indagine riguarderà la
psicogeografia e le sue dislocazioni storiche in varie mappe nelle quali il moto dell’emozione si
ripresenta come una geografia intima.» (Bruno Giuliana 2002 p. 223); una esplorazione e una
scoperta, in cammino, dell’anima.
3.2. memoria: «… l’arte mnemonica era una sistematizzazione del ricordo.»; la «relazione
profonda esistente fra movimento e memoria» (Bruno Giuliana 2002 p. 9, 237): memoria come
possibilità di operare legami e sintesi.
Cammino, memoria, mappe e cinestesia: «Continuiamo ad associare il moto all’emozione, tanto
nella scienza quanto nell’arte. La neuroscienza contemporanea ripropone questa relazione come
nostra mappa epistemica basilare. Nell’Invenzione della memoria Israel Rosenfield osserva la
«relazione profonda esistente fra movimento e memoria». I gruppi neuronali, ad esempio, sono
organizzati in mappe e in tale forma comunicano tra loro, parlandosi e rispondendosi al fine di
tradurre in idee cose ed eventi. In questo senso le mappe sono il vero e proprio tessuto di cui siamo
fatti. Rosenfield afferma inoltre che «tutti gli atti di riconoscimento, tutti gli atti di richiamo alla
memoria richiedono una qualche sorta di attività motoria. Noi perveniamo a percepire e a capire il
mondo fisico esplorando con le mani, con gli occhi e con i movimenti del nostro corpo; i nostri
ricordi e riconoscimenti del mondo sono intimamente connessi a quegli stessi movimenti che
usiamo per esplorarlo. […] In effetti noi tutti “rifacciamo” il passato». Ed è proprio nel rifare il
passato che ci rivolgiamo al cinema per registrare l’esperienza e rimapparne le emozioni. Il cinema
diventa la memoria riproducibile della nostra visione cinestetica dello spazio, e dell’esplorazione
tattile che inventa la storia intima della nostra sfera emozionale.» (Bruno Giuliana, o.c.p. 237)
3.2.1. Il doppio luogo della memoria e del camminare:
3.2.1.1. il corpo: «“Il movimento … espande la coscienza dell’esistenza in tutte le parti e fa …
godere del corpo in tutta la sua estensione” E.B.De Condillac 1777 Trattato delle sensazioni.»
(Bruno Giuliana o.c. p. 227). In particolare: il ruolo cumulativo, e quindi mnemotecnico, del vedere
(vediamo cumulativamente): «In un saggio dedicato alla percezione delle mappe, Arnheim sviluppò
l’interpretazione estetica che aveva messo a punto nella sua teoria dell’arte, la quale insisteva sulla
funzione cumulativa della percezione. Per lo studioso, l’atto percettivo non è mai isolato, ma fa
parte di una serie; tale movimento incorpora il passato e si incide nella memoria.» (Bruno Giuliana,
o.c. p.245)
3.2.1.2. i luoghi del vissuto e del camminare proprio di ciascuno: «La Storia — come la microstoria
personale — “ha luogo” nei luoghi. Non è scandita cronologicamente, ma è vincolata alla durata
attraverso lo spazio. La vita mnemonica perdura nello spazio e può, dunque, essere mappata. Il
nostro passato non risiede nella mera presenza del tempo, ma negli spazi in cui il tempo è stato
vissuto: nelle scuole che abbiamo frequentato, nel paesaggio dei luoghi di ritrovo che abbiamo
occupato e visitato, nelle panchine dei parchi che abbiamo usato come sedili. Il passato vive nella
vita pubblica di strade, caffè, palestre e sale per riunioni. Si reinventa nelle case che abitiamo, negli
hotel … In questo senso le mappe, luoghi dove la memoria è in scena, accolte e accumulate in un
atlante, creano un archivio storico di immagini emozionali, legate alla parete architettonica e allo
schermo filmico.» (Bruno Giuliana o.c. p.233, 251)
E guardando i luoghi osserviamo il tempo. David Malouf, presentando Achille accovacciato sui
ciottoli della spiaggia, intento a fissare il mare quasi in attesa della madre, segnala: «È il tempo, non
lo spazio, che sta fissando» (Malouf David 2009 Io sono Achille, Frassinelli 2010 p. 8
12
3.3. teoria: L’arte del camminare costruendo mappe e servendosi di mappe; mappe costruite da
viaggiatori per viaggiatori fino ad una visione completa e mobile (teoria) della realtà in esperienza.
Teoria nella sua derivazione etimologica e metodologica da vedere «orào»: un vedere scientifico.
«Quando si esercitano le capacità di classificazione, allora il vedere semplice si trasforma in un
altro tipo di esperienza che Dretske chiama “vedere epistemico”». (Calabi Clotilde 2009 Filosofia
della percezione, Laterza, Roma-Bari, p. 86)
Ogni camminare ha bisogno di orientamento e ogni camminare conclude in mappe, in “teorie”,
visioni complessive, sistemi in bozza e in sequenze logiche ma aperte…in “mappatura tenera”..
«Andando al di là dell’idea di mappa cognitiva, la teoria contemporanea può “attivare” l’impulso a
disegnare mappe al fine di sostenere pratiche di mappatura intersoggettiva e domare così le angosce
e le resistenze che hanno circondato la cartografia.» (Bruno Giuliana o.c. p.242)
La teoria è una redazione dell’Atlante, di una visione del mondo composta secondo coordinate di
orientamento e di riconoscimento. Alla mappa, come ad ogni teoria considerata dal punto di vista
del suo nascere allo scopo di garantire orientamento, è richiesta la capacità di sostenere la doppia
componente del camminare:
3.3.1. orientare secondo direzioni partecipate e condivise. «… raffigurazione e mappatura
coincidevano ed esprimevano una comune idea di conoscenza.» (Bruno Giuliana o.c. p.217)
3.3.2. avvertire e leggere le trasformazioni e i nuovi incontri. Si tratta, proprio per questo scopo e
per la sua flessibilità nell’avvertire e ospitare il cambiamento, di una mappatura “tenera”.
«Nell’arte della mappatura di Scudéry, come nell’arte cinematografica, il racconto si configura
geograficamente, e la sua mappa, di converso, fa più posto allo spazio vissuto e al suo evolversi.
Come abbiamo visto in questo capitolo, nelle sue molteplici configurazioni narrative la mappatura
tenera non riproduce il principio ordinatore del sapere analitico, bensì cerca di registrare le
trasformazioni.» (Bruno Giuliana o.c. p.220)
3.3.3. Un fondamentale (fondante) e classico piano filosofico la cui struttura (metodo) è affidata al
camminare, raccogliere, osservare, catalogare e quindi afferrare concettualmente o conoscere; tutto
il lavoro porta a redigere mappe di orientamento, definire piani di ricerca e concludere con una
specifica teoria scientifica o dar vita alla scienza, ai saperi teoretici di una enciclopedia o di un
atlante totale. Aristotele: il piano di studi e l’enciclopedia.
3.3.3.1. Le direzioni di cammino: il cammino della teoria in intersezione con tradizione, metodi e
logica.
3.3.3.1.1. Aristotele tende a organizzare la propria ricerca filosofica componendo due movimenti:
quello orizzontale, a vasto raggio, per una ricerca applicata ai campi più svariati della realtà
nell’intenzione di metterne in luce e rispettarne l’autonomia, e il movimento verticale teso a
costruire un disegno complessivo del sapere, una teoria, un “mondo” percorribile con mappe,
concetti e leggi.
3.3.3.1.2. Un secondo tratto costante della razionalità aristotelica è costituito dal continuo confronto
dialettico con la tradizione e da un costante camminare nel tempo accompagnato da una tecnica
particolare di osservazione, raccolta, definizione e uso. La riflessione di Aristotele prende sempre
avvio da un esame critico delle teorie formulate nel corso della storia dagli autori precedenti
riguardanti il tema in esame: discutendo le diverse teorie filosofiche, Aristotele esplicita i molteplici
significati di un termine, chiarisce ambigue omonimie, introduce sottili distinzioni. Opinioni
filosofiche e scientifiche precedenti, confutate o emendate, riprese e rimodellate, si mostrano
scientificamente produttive e diventano parte integrante del processo argomentativo con cui
Aristotele costruisce la propria filosofia.
3.3.3.1.3. Un terzo principio che Aristotele pone a fondamento di tutta la sua indagine è quello della
corrispondenza tra oggetto e metodo della ricerca; un cammino paziente e ininterrotto dai concetti
ai dati e viceversa. Le diverse forme del sapere, i differenti metodi di indagine e il relativo grado di
rigore scientifico sono infatti sempre definiti dalla specifica natura dell’oggetto da indagare. Si
tratta di un metodo e di una mappatura adatta e flessibile (“tenera”): non è possibile elaborare e
utilizzare un solo modello e un unico metodo di razionalità per i diversi oggetti indagati; a ciascun
13
campo del sapere deve corrispondere uno specifico metodo di ricerca, un adeguato modello di
esposizione. Non solo, proprio a garantire il contatto e il passaggio tra realtà e teoria è opportuno
prendere in considerazione una diversità di metodi utili a compiere il viaggio di ricognizione,
scoperta e mappatura nel modo più efficace possibile.
3.3.3.2. Un esempio emblematico: le ricerche naturalistiche esposte nell’opera Le parti degli
animali.
Aristotele eredita probabilmente dalle attività dell’Accademia platonica il progetto di catalogare le
varie specie viventi (vegetali e animali), avviando un ampio processo di raccolta di dati che si
avvale di fonti disparate e talora disomogenee. Aristotele e i ricercatori del Liceo fondavano infatti
le loro indagini su di un’ingente quantità di materiale raccolto con pazienza interrogando pescatori,
allevatori, cacciatori, macellai, contadini, di cui riportavano sia le osservazioni empiriche sia le
convinzioni comuni e i racconti, esaminando e dissezionando animali e vegetali, studiando le opere
degli esperti delle scuole mediche e naturalistiche. Sul materiale raccolto Aristotele, nel Liceo, attua
una cernita e progetta un’organizzazione sistematica. In questo contesto, affronta il tema
preliminare e imprescindibile dei criteri di metodo che guidano la ricerca e la classificazione del
vivente e fornisce la motivazione di fondo che alimenta la continua espansione dell’indagine
biologica.
3.3.3.2.1. L’impulso alla ricerca prende forma in termini di una emozionata e motivata meraviglia
di fronte alla realtà, senza preclusioni; meraviglia e ammirazione che sorregge il cammino
dell’osservazione e della ricerca: «E perfino circa quegli esseri che non presentano attrattive
sensibili, tuttavia, al livello dell'osservazione scientifica, la natura che li ha foggiati offre
grandissime gioie a chi sappia comprenderne le cause, cioè sia autenticamente filosofo. Sarebbe del
resto illogico e assurdo, dal momento che ci rallegriamo osservando le loro immagini poiché al
tempo stesso vi riconosciamo l'arte che le ha foggiate, la pittura o la scultura, se non amassimo
ancor di più l'osservazione degli esseri stessi così come sono costituiti per natura, almeno quando
siamo in grado di coglierne le cause. Non si deve dunque nutrire un infantile disgusto verso lo
studio dei viventi più umili: in tutte le realtà naturali v'è qualcosa di meraviglioso.
E come Eraclito, a quanto si racconta, parlò a quegli stranieri che desideravano rendergli visita, ma
che una volta entrati, ristavano vedendo che si scaldava presso la stufa di cucina (li invitò ad entrare
senza esitare : «anche qui — disse — vi sono dèi»), così occorre affrontare senza disgusto
l'indagine su ognuno degli animali, giacché in tutti v'è qualcosa di naturale e di bello. Non infatti il
caso, ma la finalità è presente nelle opere della natura, e massimamente: e il fine in vista del quale
esse sono state costituite o si sono formate, occupa la regione del bello. Se poi qualcuno ritenesse
indegna l'osservazione degli altri animali, nello stesso modo dovrebbe giudicare anche quella di se
stesso; non è infatti senza grande disgusto che si vede di che cosa sia costituito il genere umano:
sangue, carni, ossa, vene, e simili parti.» Aristotele De partibus animalium I,( A), 5, 645 a
3.3.3.2.2. Tutto il materiale (dell’osservazione diretta della natura e delle tradizioni precedenti) è
rielaborato secondo un meditato impianto metodologico e descritto variando opportunamente la
prospettiva dell’analisi; variazioni che lo stesso Aristotele, in apertura all’opera presenta e discute
come strade percorribili, in vista di mappe e teorie; si tratta di vere e proprie ipotesi di viaggio di
osservazione, scoperta accompagnato da strumenti (un kit concettuale) di raccolta e catalogazione.
« … è chiaro che anche nella ricerca naturale devono esservi criteri tali che riferendosi a essi si
possa valutare la forma delle esposizioni, a prescindere dalla questione se la verità stia in quel modo
o in un altro. Intendo dire, ad esempio: occorre prendere ogni singola realtà e definirla per se stessa
(esaminando cioè specificamente la natura dell’uomo o del leone o del bue o di qualsiasi altro
animale), oppure assumere come base gli attributi che tutti gli animali hanno in comune secondo un
punto di vista comune? Molti attributi identici infatti appartengono a vari generi diversi l’uno
dall’altro: così ad esempio il sonno, la respirazione, l’accrescimento, il decadimento, la morte, e
ancora tutte le altre funzioni e condizioni di tal genere … È anche chiaro, però, che trattando
separatamente i diversi gruppi ripeteremo spesso le stesse cose: infatti ai cavalli e ai cani e agli
uomini appartiene ognuno degli attributi citati, sicché se si descrivono questi attributi specie per
14
specie, si sarà spesso costretti a ripetere le stesse cose, ogni volta che essi appartengano identici a
specie diverse di animali, non presentando però in sé alcuna differenza. …
Occorre dunque non restare nell’incertezza sul modo di condurre la ricerca, se si debba cioè partire
da osservazioni comuni, secondo i generi, e poi da ultimo venire alle particolarità specifiche, oppure
iniziare subito con l’indagine specie per specie.
Questo problema, in effetti, non è stato finora risolto, e neppure quest’altro che sto per formulare:
deve lo studioso della natura al modo stesso dei matematici nelle loro esposizioni sull’astronomia
— osservare prima i fenomeni relativi agli animali e le parti di ognuno di essi, per poi spiegare il
perché e le cause, oppure procedere in qualche altro modo?
Inoltre, poiché vediamo più cause concernenti i processi naturali di formazione, come quella
esprimente «il fine in vista del quale» e quella esprimente «ciò a partire da cui» è il principio del
mutamento, occorre definire anche a riguardo di esse quale per natura sia prima, quale seconda. […]
… non a tutti i fatti della natura inerisce in modo simile quel fattore della necessità, al quale quasi
tutti cercano di ricondurre le loro spiegazioni, non distinguendo in quanti sensi si parli di
«necessario». La necessità incondizionata appartiene a ciò che è eterno, quella condizionale invece
anche a tutto ciò che è soggetto al processo della formazione naturale e a quello della produzione
tecnica per esempio una casa o qualsiasi altro oggetto di tal genere. … La forma della
dimostrazione e della necessità nella scienza della natura è però diversa da quella delle scienze
teoretiche. […]
Non si può però trascurare la questione se convenga esporre, al modo delle ricerche condotte dai
nostri predecessori, come ogni animale si è formato nella genesi naturale, o piuttosto come esso è:
l’un procedimento differisce davvero non poco dall’altro. Sembra che il punto di partenza debba
consistere, come anche in precedenza abbiamo detto, nel raccogliere i fenomeni relativi a ciascun
genere, e che si debbano poi esporre le loro cause e trattare della generazione. […] Similmente
accade anche per ciò che sembra il risultato di un processo spontaneo allo stesso modo che per i
prodotti delle tecniche: infatti alcuni risultati di processi spontanei sono identici a quelli della
tecnica, come ad esempio la salute. Ma ai prodotti della tecnica preesiste il fattore creativo che è
loro simile, come l’arte statuaria: non v’è quindi produzione spontanea. La tecnica poi consiste nel
concetto dell’opera concetto che sussiste senza la materia. […] Ora gli antichi, che per primi
indagarono filosoficamente intorno alla natura, rivolsero le loro ricerche al principio materiale e alla
causa dello stesso.» (Aristotele, Parti degli animali, V).
3.4. camminare ed esercizi di mappe ricognitive in mutamento
3.4.1. mappe di catalogazione e conoscenza per orientamento e teorie. Se ogni camminare conclude
in mappe, queste sono più o meno provvisorie, più o meno sgangherate, più o meno aperte. Le
mappe, spesso e con una certa prosopopea, vengono chiamate sistemi o teorie “scientifiche” (del
mondo).
3.4.1.1. Premetti: la catalogazione “sgangherata” dell’enciclopedia cinese intitolata Emporio celeste
di conoscimenti benevoli di cui parla Luis Borges in una delle sue novelle: «una certa enciclopedia
cinese: nelle sue pagine remote è scritto che gli animali si dividono in: a) appartenenti
all’Imperatore, b) imbalsamati, c) addomesticati, d) lattonzoli, e) sirene, f) favolosi, g) cani randagi,
h) inclusi nella presente classificazione, i) che si agitano follemente, j) innumerevoli, k) disegnati
con un pennello finissimo di peli di cammello, l) et caetera, m) che fanno l’amore, n) che da
lontano sembrano mosche.» (Borges J. Luis, L’idioma analitico di John Wilkins, in Altre
inquisizioni, Feltrinelli, Milano 1963) Commenta Foucault citandola: «Nello stupore di questa
tassonomia, ciò che balza subito alla mente, ciò che, col favore dell’apologo, ci viene indicato come
il fascino esotico d’un altro pensiero, è il limite del nostro, l’impossibilità pura e semplice di
pensare tutto questo.» Foucault Michel 1966 Le parole e le cose, Rizzoli, Milano 1988
3.4.1.2. Premetti: camminare con l’ossessione dell’orientamento identitario e la conseguente
catalogazione dell’altro. « L’ossessione feticista dell’identità e la deriva xenofoba. «Al centro del
mondo», dicono certi vecchi di Rialto, «ghe semo noialtri: i venessiani de Venessia. Al de là del
15
ponte de la Libertà, che porta in terraferma, ghe xè i campagnoli, che i dise de esser venessiani e de
parlar venessian, ma no i xè venessiani: i xè campagnoli. Al de là dei campagnoli ghe xè i foresti:
comaschi, bergamaschi, canadesi, parigini, polacchi, inglesi, valdostani... Tuti foresti. Al de là
dell’Adriatico, sotto Trieste, ghe xè i sciavi: gli slavi. E i zingani: gli zingari. Sotto el Po ghe xè i
napo’etani. Più sotto ancora dei napo’etani ghe xè i mori: neri, arabi, meticci... Tutti mori.» Finché
a Venezia, restituendo la visita compiuta secoli prima da Marco Polo, hanno cominciato ad arrivare
i turisti orientali. Prima i giapponesi, poi i coreani e infine i cinesi. A quel punto, i vecchi veneziani
non sapevano più come chiamare questa nuova gente. Finché hanno avuto l’illuminazione. E li
hanno chiamati: «i sfogi». Le sogliole. Per la faccia gialla e schiacciata.
Questa idea di essere al centro del mondo, in realtà, l’abbiamo dentro tutti. Da sempre. Ed è in
qualche modo alla base, quando viene stravolta e forzata, di ogni teoria xenofoba. Tutti hanno
teorizzato la loro centralità. Tutti. A partire da quelli che per i veneziani vivono all’estrema periferia
del pianeta: i cinesi. I quali, al contrario, come dicono le parole stesse «Impero di mezzo», sono
assolutamente convinti, spiega l’etnografo russo Mikhail Kryukov da anni residente a Pechino e
autore del saggio Le origini delle idee razziste nell’antichità e nel Medioevo, non ancora tradotto in
Italia, che il loro mondo sia «al centro del Cielo e della Terra, dove le forze cosmiche sono in piena
armonia». È una fissazione, la pretesa di essere il cuore dell’«ecumene», cioè della terra abitata.»
Stella Gian Antonio, Negri Froci Giudei & Co. L’eterna guerra contro l’altro, Rizzoli, Milano
2009, p. 11 [al contrario pensava e teorizzava Giordano Bruno nella propria cosmologia fondata
sull’infinito]
3.4.2. «Ci sono amici e nemici. E ci sono stranieri.» (Bauman Zygmunt 1991 Modernità e
ambivalenza, Bollati Boringhieri, Torino 2010 p. 66)
3.4.2.1. «Amici e nemici sono in opposizione reciproca. Gli uni sono la negazione degli altri, e
viceversa. Ma ciò non è prova della loro condizione di parità. Come quasi tutte le altre opposizioni
che regolano al tempo stesso il mondo in cui viviamo e la nostra vita nel mondo, anche questa è una
variante dell’opposizione principale tra dentro e fuori. Il fuori nega la positività del dentro. Il fuori è
ciò che non è il dentro. I nemici negano la positività degli amici. I nemici sono ciò che non sono gli
amici. I nemici sono amici imperfetti; sono la desolazione che viola l’intimità domestica degli
amici, l’assenza che nega la loro presenza.» (Bauman 1991 p.66)
3.4.2.1.1. «Apparentemente, c’è una simmetria: non ci sarebbero nemici se non ci fossero amici, e
non ci sarebbero amici se non in virtù dell’abisso di ostilità che si spalanca fuori. Ma la simmetria è
un’illusione. Sono gli amici che definiscono i nemici, e la parvenza di simmetria è di per sé
testimonianza del loro asimmetrico diritto di definire. Sono gli amici che controllano la
classificazione e l’assegnazione a una delle due categorie. L’opposizione è una conquista e un atto
di autoaffermazione degli amici. È il prodotto e la condizione della loro egemonia narrativa, ovvero
della loro dimensione narrativa come fattore di egemonia. Nella misura in cui dominano la
narrazione, fissano il suo vocabolario e lo completano di significati, gli amici sono realmente a casa,
tra amici, a loro agio.» (Bauman 1991 p.66-67)
3.4.2.1.2. «Seguendo Simmel, potremmo dire che amicizia e inimicizia sono le uniche forme di
socialità; e anzi, sono le forme archetipiche di ogni socialità, e insieme costituiscono la sua matrice
biforcuta. Creano la cornice all’interno della quale è possibile la socialità; esauriscono il ventaglio
di possibilità dello «stare con gli altri». Essere un amico ed essere un nemico sono le due modalità
in cui l’Altro può essere riconosciuto come un altro soggetto, interpretato come soggetto dotato di
una propria individualità analoga alla nostra, ammesso nella sfera della vita interiore, essere
contato, diventare e rimanere rilevante. Se non in virtù dell’opposizione tra amico e nemico, niente
di tutto questo sarebbe possibile. Senza la possibilità di spezzare il vincolo di responsabilità,
nessuna responsabilità si imprimerebbe come dovere. Se non fosse per i nemici, non ci sarebbero
amici. Senza la possibilità della differenza, dice Derrida, «il desiderio di presenza in quanto tale non
avrebbe respiro. Questo significa allo stesso modo che il desiderio è intrinsecamente destinato a non
essere soddisfatto. La differenza produce ciò che vieta, rendendo possibile proprio ciò che rende
impossibile». (Jacques Derrida, Della grammatologia, Jaka Book, Milano 1969) » (Bauman 1991 p.
16
68)
3.4.2.2. «Contro questo rassicurante antagonismo, contro questa conflittuale collusione tra amici e
nemici, lo straniero si ribella. La minaccia che rappresenta desta più orrore di quella che possiamo
temere dal nemico. Lo straniero minaccia la socialità in sé, la possibilità stessa che ci sia una
socialità. Smaschera l’opposizione tra amici e nemici, rendendo manifesta la sua natura di compleat
mappa mundi, di differenza che annulla tutte le differenze e pertanto non lascia niente al di fuori di
sé. Dal momento che quell’opposizione è il fondamento su cui riposano la vita sociale nella sua
totalità e tutte le differenze che la rappezzano alla meglio e la tengono insieme, lo straniero mette in
pericolo i fondamenti stessi della vita sociale. E tutto questo perché lo straniero non è un amico né
un nemico; e perché potrebbe essere entrambe le cose. E perché non sappiamo, e non abbiamo
modo di saperlo, se sia l’una o l’altra cosa.
Lo straniero è un membro (forse il membro principale, archetipico) della famiglia degli indecidibili,
quelle unità sconcertanti ma onnipresenti che — citando ancora le parole di Derrida — «non
possono più essere incluse all’interno di un’opposizione filosofica (binaria), poiché le resistono e la
disorganizzano, senza mai costituire un terzo termine, senza mai lasciare spazio per una soluzione
in forma di dialettica speculativa». (Bauman 1991 p. 68) «Indecidibile è tutto ciò che non è né
questo né quello; in altre parole, rema contro tutto ciò che è questo o quello. La sottodeterminazione
degli indecidibili è la loro potenza: non essendo niente, potrebbero essere tutto. Mandano all’aria il
potere ordinatore dell’opposizione, ovvero il potere ordinatore dei narratori dell’opposizione. Le
opposizioni permettono la conoscenza e l’azione; gli indecidibili le paralizzano. Gli indecidibili
smascherano brutalmente l’artificio, la fragilità, l’inganno della più vitale delle separazioni. Portano
dentro ciò che è fuori, e turbano la serenità dell’ordine con il presentimento del caos.
Questo è esattamente ciò che fanno gli stranieri.» (Bauman 1991 p.69)
«Difficilmente esiste un’anomalia più anomala dello straniero. Questi sta tra l’amico e il nemico, tra
l’ordine e il caos, tra il dentro e il fuori. Rappresenta l’inaffidabilità dell’amico, la scaltra
simulazione del nemico, la fallibilità dell’ordine, la vulnerabilità del dentro.» (Bauman 1991 p. 75)
3.4.2.3. « Potremmo concludere che definire l’estraneità come un fenomeno culturale è il punto di
partenza di un processo che conduce inesorabilmente a una «rivelazione»: non si può desiderare che
l’ambivalenza esca dalla nostra esistenza; e l’estraneità ha fondamenti molto più solidi e molto
meno manipolabili delle differenze di opinione e stile di vita create dall’uomo, transitorie e
«meramente culturali».» (Bauman 1991 p. 89) (segue: 5.01.)
4. camminare e orizzonti, essenza del racconto filosofico / conte philosophique.
Carico di emozioni, memoria e teorie il camminare è la trama del racconto filosofico. Nei racconti
filosofici non si fa che viaggiare e camminare.
È un tratto di origine della filosofia: quello che solitamente viene letto come primo testo della
filosofia occidentale europea è il racconto di un viaggio: «Le cavalle che mi trascinano, tanto lungi,
quanto il mio animo lo poteva desiderare / mi fecero arrivare, dopo che le dee mi portarono sulla via
molto celebrata / che per ogni regione guida l’uomo che sa.», opera di Parmenide.
Il racconto filosofico come cammino ed esplorazione diventa un genere, moltiplicato in tipologie
interne e molto consumato in termini di mercato dei libri, nel secolo dell’Illuminismo. Roland
Barthes introduce i racconti filosofici di Voltaire (in Voltaire 1964, Romans et contes, Préface de
Roland Barthes, Gallimard 1972) con queste parole: «Il XVIII secolo non è solo una grande epoca
di viaggi, quella in cui il capitalismo moderno, allora a prevalenza inglese, organizza
definitivamente il suo mercato mondiale, dalla Cina all’America del Sud; è soprattutto il secolo in
cui il viaggio accede alla letteratura e genera una filosofia. È noto il ruolo dei gesuiti, con le loro
Lettere edificanti e curiose, per la nascita dell’esotismo. Fin dall’inizio del secolo, questi materiali
sono trasformati e forniscono rapidamente una vera tipologia dell’uomo esotico: il Saggio egiziano,
l’Arabo maomettano, il Turco, il Cinese, il Siamese e, più prestigioso di tutti, il Persiano. Tutti
questi orientali sono maestri di filosofia; ma prima di dire quale, bisogna notare che al momento in
cui Voltaire incomincia a scrivere i suoi racconti, che devono molto al folclore orientale, il secolo
17
ha già elaborato una vera retorica dell’esotismo, una sorta di digest le cui figure sono così ben
delineate e conosciute che vi si può ormai attingere liberamente come in una riserva algebrica senza
l’incombenza delle descrizioni e delle meraviglie. Voltaire non è da meno, egli infatti non si è mai
preoccupato di essere “originale” (nozione del resto tutta moderna); l’orientale non è per lui, come
per nessuno dei suoi contemporanei, l’oggetto, il destinatario di un attenzione in vista della verità; è
semplicemente una cifra usuale, un segno comodo per comunicare.
Il risultato di questa concettualizzazione, è che il viaggio di Voltaire non ha alcuno spessore; lo
spazio che Voltaire percorre a marce forzate (perché nei suoi Racconti non si fa che viaggiare) non
è uno spazio di un esploratore, è lo spazio di un agrimensore, e ciò che Voltaire prende a prestito
dall’umanità allogena dei Cinesi e dei Persiani è un nuovo limite, non una nuova sostanza; nuove
cabine di pilotaggio sono affidate all’essenza dell’uomo, essa così rifiorisce, dalla Senna al Gange,
e i romanzi di Voltaire più che indagini sono giri di un proprietario che viene orientato senza una
grande ordine, perché si tratta sempre dello stesso recinto, e che viene interrotto capricciosamente
con fermate continue dove si discute non di ciò che si vede ma di ciò che si è.»
4.1. L’intenzione culturale degli “illuministi” era di risveglio e non di sistema o di
indottrinamento: «Se ora si domanda: — Viviamo noi attualmente in una età illuminata? —
dobbiamo rispondere: — No, bensì in un’età di illuminismo —. Come stanno ora le cose, la
condizione in base alla quale gli uomini presi in massa siano già in grado, o anche solo possano
esser posti in grado di valersi sicuramente e bene del loro proprio intelletto nelle cose della
religione, senza la guida di altri, è ancora molto lontana. Ma abbiamo evidenti segni che essi
abbiano aperto il campo per lavorare a emanciparsi da tale stato e che gli ostacoli alla diffusione del
generale illuminismo o all’uscita da una minorità a loro stessi imputabile diminuiscano a poco a
poco.» Così Kant, nella Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo. E D’Alembert, riferendosi
all’Encyclopédie: «Niente di più lodevole della decisione dell’Accademia delle scienze di vedere,
osservare, annotare nei suoi registri le osservazioni e le esperienze, e di lasciare alla posterità la
preoccupazione di mettere insieme un sistema completo quando si avrà sufficiente materiale per
farlo, ma un tale tempo è molto lontano, ammesso che giunga mai.»
4.2. Nuove forme del testo filosofico. L’obiettivo illuministico si traduce anche nella
moltiplicazione delle forme del testo a cui la filosofia, nella seconda metà del ‘700, si affida:
periodici, brevi saggi, dizionari, libri tascabili, racconti di viaggi, favole, romanzi epistolari,
volantino, pamphlet, enciclopedia, quadri d’insieme, manifesti come proclami, lettere aperte…
4.3. Il racconto filosofico “conte philosophique”. Al racconto gli illuministi, soprattutto Voltaire,
Diderot, Montesquieu, affidano il compito di impostare in forma innovativa, con essenzialità e
rigore, la riflessione su temi filosofici fondamentali. Il racconto che viene così prodotto è filosofico
per lo stile, è filosofico per il tema, è filosofico per la struttura.
4.3.1. tratti di stile. È lo stile a rendere filosofico un racconto. In primo piano spicca l’essenzialità
della narrazione capace di rimandare, che rimanda oltre se stessa: eliminati aggettivi di decorazione,
descrizioni d’ambiente, passaggi introspettivi, il tema che regge e sta dietro la vicenda narrata balza
per riprese e improvvisamente in primo piano fino alla conclusione che, in forma enigmatica e
imprevedibile, chiude il racconto lasciando aperto il quesito; lo stesso Voltaire fornisce la chiave di
lettura del racconto filosofico avvertendo che «esso dice più di quanto non sembri dire».
4.3.2. elementi tematici. È filosofico per il tema. Al centro della narrazione si collocano in modo
problematico e dibattuto questioni fondamentali per la filosofia finora ospitate in ben altri contesti
(trattati e saggi): esistenza di Dio e problema del male, leggi consuetudini e relazioni sociali,
aspirazioni progetti e infelicità umana, giustizia ingiustizia e senso della storia, validità e funzione
delle cosmologie e delle filosofie della natura ecc.
4.3.3. elementi strutturali. È filosofico per la struttura; e qui massimamente si esplicita il
camminare. Proprio l’individuazione delle scelte compositive strutturali, e si tratta di strutture di
18
rimando, permette di cogliere il racconto filosofico come atteggiamento e metodo della filosofia.
Sulla scorta delle osservazioni di Jean Starobinski, si possono notare tre elementi di struttura:
4.3.3.1. la doppia contestualizzazione: il racconto sceglie di collocare l’azione in contesti esotici
(come in un viaggio di andata; verso Oriente, America…) esplicitamente richiamati e descritti con
tratti essenziali (anche per l’utilizzo di tipologia allora ben diffuse), ma che, per la sobrietà dei
richiami oltre che per il tema dominante, risultano fittizi e ottengono l’effetto di rimandare (fanno
compiere un viaggio di ritorno) ad un altro contesto, implicito e non narrato ma reale: la società in
cui vivono autore e lettore, questa il vero oggetto di osservazione ed esame.
4.3.3.2. il viaggio e lo sguardo: il doppio mondo, esotico e quotidiano, esplicito e implicito
presuppongono l’esperienza di un viaggio in paesi lontani, spesso svolto in vorticose peripezie che
stravolgono ogni classica unità di tempo e spazio; un camminare continuamente e bruscamente
(spesso casualmente e senza senso proprio) interrotto e altrettanto incessantemente ripreso (senza
meditate e precise direzioni, come accade alla storia dell’uomo) in forza del quale si è obbligati
sempre a prendere le distanze, raggiungere una postazione osservativa che restituisce lo sguardo e la
capacità di provare stupore e meraviglia di fronte a situazioni assurde inaccettabili, che la vicinanza
e l’abitudine ci portavano a considerare norma (legge e normalità) e destino; «è ciò che passa ogni
giorno sotto i vostri occhi e che voi non vedete mai» (Diderot).
4.3.3.3. il romanzo antiromanzo: il racconto rispetta le caratteristiche strutturali del romanzo, quelle
aristoteliche, con “fabula” e “intreccio”, ma la paradossalità dell’intreccio, ripetuto in rapida
iterazione, destruttura la fabula e la rende non più credibile; il caso più noto è forse quello del
racconto di Voltaire, Candide: l’amore e l’ottimismo nel Candido, consegnati al ripetersi di una
loro paradossale ricerca, si negano nel momento finale della loro realizzazione.
Osserva Jean Starobinski 1989 Il rimedio nel male. Critica e legittimazione dell’artificio nell’età
dei lumi, Einaudi, Torino1990, nel capitolo intitolato Il fucile a due colpi di Voltaire. Sullo stile
filosofico di Voltaire: «Un racconto? Sicuramente. Ma ancor più, il simulacro di un racconto.
Intendo dire: la sua parodia, il suo riflesso attenuato. Il romanzesco, in Candide, è la caricatura del
romanzesco, la sua versione esagerata, che mescola tutte le convenzioni del genere — siano esse
quelle del romanzo d’avventura (di matrice ellenistica), quelle del romanzo picaresco, o quelle della
novella, ancor più aperte all’inverosimile. Dovendo proprio attribuire una genealogia a Candide,
scegliamo pure quella che fa capo a Luciano e a Petronio, passando per Rabelais e Cyrano. Gli
avvenimenti, in Candide, e soprattutto il modo in cui si susseguono, non sono soltanto una sfida ad
ogni verosimiglianza. Con il loro carattere eteroclito, ci fanno sapere che non si appellano alla
fiducia del lettore, che lo lasciano libero: morti apparenti, ricongiungimenti insperati,
concatenazioni rapidissime, paesi favolosi, ricchezze sconfinate — tutto ci avverte che non
dobbiamo dedicare seria attenzione neppure alla trama, tutto rinvia a modelli letterari arcinoti, di cui
la derisione dispone a suo piacimento deformandoli l’uno dopo l’altro, in una parabola che insegna
a diffidare degli insegnamenti. Un gioco, allora? Certo. Ma un gioco in cui, attraverso la parodia,
nessuna delle situazioni descritte è fuori dalla realtà del momento contemporaneo: in Germania, si
fa la guerra, si massacra, si violenta; in Portogallo, si bruciano gli eretici; tra i selvaggi
dell’America, si mangiano i prigionieri; a Parigi, i viaggiatori ingenui vengono spennati al gioco e
derubati in camera. Sotto molti aspetti, Candide è soltanto il nome fittizio, l’identità minimale che
occorre attribuire ad un personaggio la cui funzione essenziale è quella di scontrarsi col mondo così
come va, e con ciò rivelarlo qual è. La formula di Candide è dunque il composito e il “pot-pourri”.»
4.3.4. In conclusione, il racconto così strutturato crea la disposizione filosofica: il lettore è coinvolto
nella vicenda narrata, il pathos e il ritmo creano partecipazione, ma il paradosso e la non
verosimiglianza dell’intreccio hanno, programmaticamente, l’effetto di svelare l’artificio, espellere
il lettore dal mondo narrato e ricollocarlo nella posizione di osservatore esterno (a renderlo
straniero), coinvolto ancora ma in quanto è colui che deve interrogarsi, notare e prendere posizione.
In breve sintesi è possibile richiamare la doppia direzione dell’effetto di apertura d’occhi creato dal
racconto filosofico (ed è ciò che rende filosofico un racconto) per la sua capacità di catturare nella
narrazione e espellere dalla narrazione il lettore.
19
4.3.4.1. L’esotico restituisce lo sguardo e la visione sulle abitudini; si tratta di sguardo e
consapevolezza, di presa d’atto, di critica, di denuncia … un guardare vedendo. I lettori catturati ed
espulsi non solo guardano ma vedono, contrariamente alla prassi diffusa dei molti che guardano ma
senza vedere, senza essere in grado di vedere.
4.3.4.2. la curiosità per le differenze mostrate in molte declinazioni: culture, religioni, etnie, generi,
identità e l’esito del meticciato e delle combinazioni come naturale sviluppo del vivere e camminare
(combinazioni di culture, di genere, di stili del vivere [alimentazione, moda, abitare…]) restituisce
all’uomo la possibilità, la decisione, l’iniziativa. Anzi il racconto filosofico si presenta, in generale,
come una formula in grado di proporre alla riflessione e alla decisione del lettore, con leggerezza ed
efficacia, tutti i temi centrali della filosofia, dunque è un modulo e un metodo. Della sua
potenzialità applicativa è ben consapevole Montesquieu: «un’opera originale ne fa quasi sempre
nascere cinque seicento altre, queste servendosi della prima all’incirca come i geometri si servono
delle loro formule»; così come è dichiarato sostenitore della sua funzione di cammino e di apertura:
«Sebbene nati in un regno prospero, non abbiamo ritenuto che i suoi confini dovessero segnare
anche i limiti della nostra conoscenza, e che ci dovesse illuminare solo la luce dell’Oriente.»
4.4. Passaggi – brani – piccoli sguardi di racconti
4.4.1. Voltaire Zadig ovvero il Destino. Storia orientale. «Ai tempi del re Moabdar c’era a
Babilonia un giovane chiamato Zadig, la cui indole, buona per natura, era stata fortificata
dall’educazione. Benché ricco e giovane, sapeva moderare le sue passioni; non ostentava nulla; non
pretendeva di aver sempre ragione, e sapeva rispettare le debolezze degli uomini. Ci si meravigliava
che, per quanto spiritosissimo, non si facesse mai beffe di quei discorsi così vaghi, così
frammentari, così tumultuosi, di quelle maldicenze temerarie, di quei giudizi ignoranti, di quegli
scherzi grossolani, di quel vacuo rumore di parole che a Babilonia si chiama conversazione…».
4.4.2. Voltaire Candido ovvero l’Ottimismo. (l’inizio) « C’era in Vestfalia, nel castello del signor
barone di Thunder-ten-tronckh, un giovane a cui la natura aveva conferito i costumi più miti. Il suo
aspetto ne rivelava l’anima. Possedeva un giudizio abbastanza retto, unito a una grande semplicità;
per questo, credo, lo chiamavano Candido. I vecchi domestici del castello sospettavano fosse figlio
della sorella un signor barone e di un onesto e buon gentiluomo delle vicinanze che madamigella
non volle mai come marito perché non aveva potuto provare che settantun quarti: il resto del suo
albero genealogico era stato distrutto dalle ingiurie del tempo.» (la conclusione) «“Tutti gli
avvenimenti sono concatenati, nel migliore dei mondi possibili: perché insomma, se non t’avessero
cacciato da un bel castello a gran calci nel sedere per amore di madamigella Cunegonda, se non
fossi caduto nelle mani dell’inquisizione, se non avessi corso l’America a piedi, se non avessi dato
un bel colpo di spada al barone, se non avessi perduto tutte le tue pecore del buon paese d’Eldorado,
non saresti qui a mangiare cedri canditi e pistacchi». «Ben detto,» rispose Candido «ma dobbiamo
coltivare il nostro giardino.»
4.4.3. Diderot Jacques il fatalista e il suo padrone. « Come si erano incontrati? Per caso, come tutti.
Come si chiamavano? E che ve ne importa? Da dove venivano? Dal luogo più vicino. Dove
andavano? Si sa dove si va? Che dicevano? Il padrone non diceva niente; e Jacques diceva che il
suo capitano diceva che tutto ciò che quaggiù ci accade di bene e di male, sta scritto lassù. …»
4.4.4. Montesquieu Lettere persiane. Prefazione dell’autore: «… I persiani che scrivono abitavano
con me, passavamo le giornate insieme. Non mi nascondevano nulla, perché mi consideravano un
uomo di un altro mondo. In verità, persone trapiantate da un luogo tanto lontano non avevano più
ragione di aver segreti: mi lasciavano leggere la maggior parte delle loro lettere, ed io le copiavo.
Me ne sono anche capitate tra le mani alcune che si sarebbero ben guardati dal confidarmi, tanto
erano mortificanti per la vanità e la gelosia.
«Lettera I. Usbek all’amico Rustan, a Ispahan. Ci siamo fermati a Com un giorno solo. Una volta
fatte le nostre devozioni sulla tomba della vergine che mise al mondo dodici profeti, ci rimettemmo
in cammino; e ieri, venticinque giorni dopo la partenza da Ispahan, arrivammo a Tauris. Tra i
persiani Rica ed io siamo forse i primi ad uscire dal nostro paese per desiderio di apprendere,
20
rinunciando alle dolcezze di una vita tranquilla per andare con fatica in cerca della saggezza.
Sebbene nati in un regno prospero, non abbiamo ritenuto che i suoi confini dovessero segnare anche
i limiti della nostra conoscenza, e che ci dovesse illuminare solo la luce dell’Oriente. …»
«Lettera XCVII Usbek ad Hassein, derviscio della montagna di Jaron. O tu, saggio derviscio, il cui
spirito alacre splende di tante conoscenze, ascolta ciò che vengo a dirti. Ci sono qui dei filosofi che
in verità non hanno attinto il vertice della saggezza orientale: essi non sono stati rapiti fino al trono
luminoso, non hanno udito le parole ineffabili che risuonano nei concerti degli angeli, né sentiti i
tremendi accessi di un furore divino; ma lasciati a se stessi, privi del sacro meraviglioso soccorso,
seguono in silenzio le tracce della ragione umana. Tu non crederesti fino a dove li ha condotti
questa guida. Essi hanno decifrato il Caos, e con una semplice meccanica hanno spiegato l’ordine
dell’architettura divina: l’autore della natura ha dato alla materia il movimento: non c’è stato
bisogno d’altro per produrre questa prodigiosa varietà d’effetti che vediamo nell’universo.»
4.5 per chiudere il cerchio del cammino (un camminare ermeneutico, quindi secondo circolarità
virtuose, nella forma dei circoli ermeneutici)
Nel camminare dei Racconti filosofici, nello stile, nella struttura e nei temi che li caratterizzano,
ritorna e riemerge il paradosso del camminare così come è stato formulato da Zenone: un passare
attraverso i luoghi in cui si sta e uno stare nei luoghi che si abbandonano; uno stare passando, stare
e non stare, una mobile immobilità.
4.5.1. Proprio come accade nel paradosso della freccia formulato da Zenone, presentato da
Aristotele: «Terzo è questo argomento: che la freccia in moto sta ferma. Esso poggia
sull’assunzione che il tempo sia composto di istanti: se infatti non si concede questo il
ragionamento non corre.» Aristotele Fisica Z 9. 239 b 30. Simplicio commenta spiegando: « Il
ragionamento di Zenone, assumendo che tutto ciò che è lungo uno spazio uguale a sé o si muove o
è in quiete, e che nulla si muove nell’istante, e che sempre il mosso è lungo uno spazio uguale a sé
in ogni istante, pare che proceda così: la freccia che si muove, che è in ogni istante lungo uno spazio
uguale a sé, non si muove dal momento che nulla si muove nell’istante; ma ciò che non si muove è
in quiete, dal momento che tutto o si muove o è in quiete; allora la freccia che si muove finché si
muove è in quiete per tutto il tempo della traslazione.» Simplicio Fisica 1011, 19.
4.5.2. Proprio come sembra accadere nei racconti filosofici e nelle storie (possibili, infinite) del
camminare. Osserva ancora R. Barthes presentando i Racconti di Voltaire: «Questo è il paradosso
del viaggio voltairriano: manifestare una immobilità. Esistono certamente altri costumi, altre leggi,
altre morali al di là delle nostre, ed è proprio questo che il viaggio insegna; ma questa diversità fa
parte della natura umana e trova di conseguenza molto in fretta il suo punto di equilibrio; basta
riconoscerla per esserne liberati: quando l’uomo (l’uomo occidentale) si moltiplica un po’, quando
il filosofo europeo si duplica in saggio cinese, in Urone ingenuo, allora sarà creato l’uomo
universale. Crescere per confermare se stessi, non per trasformarsi, questo è il senso del viaggio
voltairriano.» (Barthes, o.c. p. 15) Si tratta di uno stare dell’umanità dentro il cambiamento;
un’essenza che ha nel divenire la propria realizzazione; una umanità che conferma e potenzia la
propria natura nella varietà dei modelli (delle proprie “brevi abitudini”) in cui sta camminando.
4.5.3. Proprio come accade ad alcuni modelli in apparenza estremi, in contesto sociologico, del
raccontare: un estremo è quello della filosofia critica trascendentale, il secondo estremo è quello
delle telenovele (soap opere) “popolari”: lo sviluppo dell’immobilità, a priori nel primo caso, a
posteriori nel secondo. Il racconto della teoria critica: la ricognizione critica delle forme della
mente, condotta da una prospettiva trascendentale, con l’obiettivo della completezza, certezza,
chiarezza (I. Kant, le tre critiche); quindi opera introduttiva alla mente, ma concepita come
definitiva. Il racconto nella forma della “soap opera”, della telenovela: la rappresentazione delle
forme del vivere, da una prospettiva empirica (a specchio), nelle forme della semplificazione (dei
problemi, delle riflessioni), nella ricorrenza (e perciò senza una fine prevedibile e utile) delle
situazioni, nella prevedibilità degli sviluppi e degli esiti, fino ad un confortevole happy end, a
bandire ogni domanda critica (sviluppo nell’immobilità).
21
[nota di cronaca: in un’intervista televisiva in occasione della puntata n° 3.000 di una telenovela
italiana “Un posto al sole”, alla domanda «Avete una idea di come possa finire la storia
rappresentata?», la risposta: «Non finirà mai». 09.04.2010]
5. in appendice ipotesi di sviluppo (in disordine): camminare e orizzonti per la
filosofia o il destino (lieto o triste) del camminare e dei suoi orizzonti possibili quando viene
consegnato alle forme e il ruolo sociale del viaggiare. Fenomenologia contemporanea del
camminare, all’insegna del teorema della irraggiungibilità.
5.01. un bilancio preliminare: il compito dello straniero, del viaggiatore, del cammino.
«L’autocostruzione dell’ambivalenza. La responsabilità di risolvere l’ambivalenza ricade, in ultima
istanza, sulla persona confinata nella condizione ambivalente. Anche se il fenomeno dell’estraneità
ha una struttura sociale, assumere lo status di straniero, con tutta l’ambiguità che lo accompagna,
con tutta la sua gravosa sovra- e sottodefinizione, comporta degli attributi che alla fine sono
costruiti, sostenuti e dispiegati con l’attiva partecipazione dei loro portatori: nel processo psichico di
autocostituzione. Come tutti gli altri ruoli (forse anche un po’ di più degli altri ruoli) quello dello
straniero richiede apprendimento, acquisizione di conoscenze e abilità pratiche.
Essere uno straniero significa, prima di tutto, che niente è naturale; niente è dato di diritto, niente è
gratis. L’unione primordiale tra l’io e il mondo, propria del nativo, è stata spezzata. Ogni elemento
di quest’unione è stato messo al centro dell’attenzione, come un problema e come un compito. Sia
l’io sia il mondo sono chiaramente visibili. Entrambi richiedono un esame costante, entrambi
necessitano di un «intervento» urgente, devono essere «maneggiati» e amministrati. Sotto tutti
questi aspetti la posizione dello straniero si discosta drasticamente dallo stile di vita nativo, con
conseguenze di vasta portata.» (Bauman 1991 p. 91) « Lo straniero è stato definito a priori una sfida
alla chiarezza del mondo e dunque all’autorità della ragione. Ora la definizione a priori è
confermata dalla sua azione. Il suo sguardo solidifica, rende tangibile quello stile di vita che è
efficace solo nella misura in cui rimane trasparente, invisibile, non codificato. … Non si può
bussare a una porta, a meno che non si sia fuori; ed è l’atto di bussare alla porta che mette in guardia
i residenti sul fatto che chi bussa è in effetti fuori. «Essere fuori» mette lo straniero in una posizione
di oggettività: il suo è un punto di vista esterno, distaccato e autonomo dal quale è possibile
guardare, esaminare e criticare coloro che sono all’interno (con la loro visione del mondo, inclusa la
loro mappa degli amici e dei nemici). Proprio la consapevolezza di questo punto di vista esterno
(personificato dalla condizione dello straniero) rende i nativi inquieti e insicuri delle loro usanze e
verità domestiche.» (Bauman 1991 p. 93)
«Si sono invertiti i ruoli. Ora è lo straniero che può scoprire la verità che i nativi cercano invano.
Lungi dall’essere un marchio d’infamia, l’incurabile estraneità dello straniero è ora un segno di
distinzione. Il potere dei padroni di casa non è che un inganno. L’impotenza di chi non ha casa è
solo un’illusione.» (Bauman 1991 p. 98) « Se la realtà è fatta di tanti appezzamenti privati recintati
e messi sotto stretta sorveglianza, le rivendicazioni di verità rimangono solo scuse per gli ordini di
esclusione e di sfratto. Bisogna prima abbattere i recinti. … Quello che i gruppi ben radicati non
riescono a mandar giù è la capacità degli intrusi «di legarsi alle classi cui non appartenevano in
origine», di «adattarsi a qualunque concezione del mondo», e il fatto che «soltanto essi erano in una
posizione tale da operare una scelta consapevole». «Forse che dovremmo considerare la capacità di
acquistare una più ampia prospettiva come una semplice forma di responsabilità? Non è piuttosto
essa una missione?» ( Karl Mannheim, Ideologia e Utopia)» (Bauman 1991 p.99)
«È stata l’ebraicità tormentata e sofferta di Franz Kafka che ha permesso ad Albert Camus o a JeanPaul Sartre di cogliere nella sua opera una parabola della condizione universale dell’uomo moderno.
Ha dato modo a Camus di leggere l’opera di Kafka come uno sguardo penetrante nell’assurdità
della vita moderna, nell’«estraneità di un vita umana»; ha permesso a Sartre di trovare in Kafka la
definizione stessa dello Straniero: «Lo straniero è l’uomo di fronte al mondo […] Lo straniero è
anche l’uomo tra gli uomini […] E infine sono io in relazione a me stesso». … L’universalità della
mancanza di radici» (Bauman 1991 p.102, 112)
22
«Secondo Niklas Luhmann, con il passaggio da una società stratificata premoderna a quella
moderna, caratterizzata dalla differenziazione delle funzioni (ovvero una società in cui le divisioni
trascendono le collocazioni sociali dei singoli), « la singola persona può collocarsi non più in un
solo sottosistema, bensì la si deve presupporre dal punto di vista sociale come addirittura senza
luogo». Tutti gli individui sono «senza luogo», e in modo permanente, sul piano esistenziale,
dovunque si trovino in un dato momento e qualsiasi cosa stiano facendo. Sono stranieri ovunque,
nonostante i loro sforzi nella direzione contraria. Non c’è un singolo luogo della società in cui si
sentano davvero a casa e che possa donare loro un’identità naturale. L’identità individuale diventa
dunque qualcosa da conquistare (e presumibilmente da creare) per l’individuo in questione,
qualcosa che non si possiede mai in maniera salda e definitiva, poiché è costantemente messa in
discussione e deve essere sempre negoziata da zero.» (Bauman 1991 p. 221)
5.1. Viaggi filosofici: tra utopia, etno-antropologia, sociologia; viaggi con dettagliate carte
geografiche dell’immaginario e utopistiche mappe urbanistiche, sociali, politiche e culturali per
nuovi mondi: Moro, Bacone, Swift, Abbott Edwin, Orwell, Calvino…
5.2. Camminare e fuga: i desideri impossibili della colomba lieve in Kant diretti ad abbattere il
propri limiti.
5.2.1. in questo contesto: viaggi di trascendenza (trascendimento) a carattere religioso teologico:
risurrezione, ascensione, assunzione al cielo (Elia, Cristo, Maria), viaggi nell’al di là con relativi
racconti / mappe….o da tali viaggi: mappe per una cosmologia religiosa (la sua funzionalità)
5.3. Fare filosofia per strada, come per il teatro di strada, così come è richiamato da Guido
Ceronetti, Insetti senza frontiere, Adelphi 2009 e con performances, teatro, arte, corse sociali,
manifestazioni …
5.4. Camminare e le forme della meditazione: Demetrio Duccio 2005 Filosofia del camminare.
Esercizi di meditazione mediterranea, Raffaello Cortina editore, Milano
5.4.1. Camminare e musica oltre l’handicap. Tenere il ritmo camminando: a Roma il primo gruppo
di percussionisti sordi
Non sentono la musica, ma riescono a suonare ascoltando le proprie vibrazioni e riproducendo i
passi di una camminata. Si chiamano «Deaf drums road»
ROMA – A vederli dal vivo i «Deaf Drums Road», travolgenti e divertiti nell’esibizione, nessuno
potrebbe immaginare che loro in realtà il suono della musica non lo sentono, e che tengono il ritmo
soltanto con le vibrazioni del corpo. Eppure è proprio così. Nel Convitto per sordi della capitale è
nato, infatti, il primo gruppo di percussionisti sordi. Quasi un ossimoro si direbbe, in realtà
un’esperienza unica nel campo musicale che fonde insieme tecnica raffinata di insegnamento ed
efficacia nella realizzazione. Ma come si fa a insegnare il senso del ritmo a chi ha perso l’udito?
«Una persona sorda dalla nascita non può avere un riferimento ritmico regolare non avendo mai
avuto la possibilità di ascoltare e seguire un brano musicale, se non sottoforma di percezione di
alcune frequenze-vibrazioni» sottolinea Sergio Quarta, musicista professionista, maestro di musica
e ideatore del laboratorio del convitto di Roma. «Lavorando con i ragazzi sordi, mi sono
concentrato sul quadro dei movimenti quotidiani e spontanei, in particolare sul camminare. Una
persona sorda, camminando, riproduce in maniera spontanea, una sequenza ritmica regolare, come
fa una persona udente. Tenendo in grembo un tamburo e cercando di sostenere una camminata
naturale, abbiamo fatto corrispondere, a ogni passo, un colpo prodotto con la mano per ottenere un
effetto all’unisono, quindi lo sviluppo e la costruzione di un ritmo regolare, grazie anche allo studio
della tecnica dei vari strumenti».
Corriere della sera 06 aprile 2010
5.5. Fenomenologia del camminare contemporaneo
5.5.1. i viaggi di esplorazione e la bugia: viaggiatori bugiardi in nome dello stupore (per esprimerlo
e suscitarlo): Waugh, Graham Greene, Jsherwood: generazioni di scrittori inquieti e cosmopoliti che
lasciarono splendidi libri di impressioni, memorie e testimonianze da ogni parte del mondo. Peccato
23
che gran parte di ciò che raccontarono non fosse vero. La realtà veniva sacrificata a ideali più alti: il
bisogno distupire e, soprattutto, di fare letteratura (la Repubblica 20.09.2009)38-39
5.5.2. i viaggi senza meta, di libertà indefinita (On the road, Kerouac; modello e ora genere in
rivisitazione continua)
5.5.3. i viaggi impacchettati confezionati delle agenzie turistiche: il tema del turismo di massa, dei
suoi luoghi ricorrenti, della loro architettura ad hoc o … del viaggio e del camminare annullati nella
loro realizzazione. (Uno sguardo di divertita riflessione critica in una specie di “dizionario della vita
contemporanea” Ferraris Maurizio 2008 Il tunnel delle multe. Ontologia degli oggetti quotidiani,
Einaudi, Torino)
5.5.4. i viaggi virtuali nei mondi della second life e degli avatar. Osserva il regista James Cameron
in occasione del suo ultimo film Avatar: «Raccontano (Titanic e Avatar) viaggi geografici ed
esistenziali. Al centro c’è una storia d’amore tra esseri che appartengono a mondi diversi. Mondi
sociali, per Jack e Rose in Titanic, spaziali per l’umano Jake e l’aliena Neytiri di Avatar…
Viaggiare nel passato o nel futuro è un modo per raccontare l’arroganza tecnologica della razza
umana, convinta di poter dominare la natura. …Oggi Avatar, il film più tridimensionale più
avanzato mai realizzato, ci convince della necessità di vivere in armonia con la natura. Non volevo
fare un film che informasse sui pericoli del pianeta, avevo bisogno di una storia che coinvolgesse il
pubblico, lo facesse immedesimare nei protagonisti trasportandoli dentro una metafora
ambientalista.» 1138 (venerdì di Repubblica) 08.01.2010,51.
5.5.4.1. L’immenso archivio, diario – memoria, ad uso collettivo, del camminare contemporaneo (o
viaggiare senza camminare), basi, il mezzo e le opportunità dei viaggi contemporanei.
«La nuova forma simbolica dell’età contemporanea, o più precisamente dell’era dei computer, stava
nel principio del database, come in tempi più recenti ha chiaramente sottolineato Lev Manovich: «I
CD-ROM e gli altri media che si basano sull’archiviazione dei dati si sono dimostrati
particolarmente idonei a generi tradizionali come l’album fotografico e hanno anche ispirato nuovi
generi di database, come la biografia-database». Tutto il fotografato si configura quale immenso
repertorio visivo cui attingere come da un’estesa e sconfinata memoria collettiva. Selezionando,
ricombinando, riportando a nuova vita e dignità estetica. Rimettendo in moto i meccanismi della
concettualità fotografica, ripristinando i fili interrotti della memoria, riannodando il tessuto delle
emozioni. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Hal Foster, che individua come assolutamente
operativo nell’arte contemporanea un “archival impulse” che trova nel mega-archivio di Internet il
suo medium ideale, e che fonda la sua architettura di sistema in un metodo di combinazioni
ramificate o rizomatiche e dunque, nella definizione di Deleuze e Guattari, aperte alle connessioni e
alle libere giustapposizioni piuttosto che legate le une alle altre secondo alberi e ordini prefissati e
ordinati. Sarebbe interessante, ma ci porterebbe troppo lontano dall’oggetto di questa riflessione,
indagare sul fatto che per Foster l’Archival art è un’espressione della paranoia che affligge il nostro
tempo, frustrante esito di un’utopia mancata e disattesa. Ancora Manovich suggerisce un
interessante sviluppo cinematografico del principio del database nell’ Uomo con la macchina da
presa di Dziga Vertov. Vertov, che Manovich considera (insieme a Peter Greenaway per la verità) il
“grande regista del database”, è ritenuto colui che è riuscito a girare un film che trova il significato
più pieno nel metodo stesso con cui è stato realizzato. L’ambizione di raccontare e riprodurre la
percezione della moltitudine dei fenomeni visivi catturati dal kino-eye di Vertov si poggia sull’idea
dell’archiviazione d’infiniti dati (le scatole piene di materiale filmato, archiviato e nominato, che
compaiono nella sala di montaggio) messi poi a disposizione del regista affinché da quelli
costruisca la trama visiva grazie a un ventaglio pressoché esaustivo di tecniche e manipolazioni
filmiche. Muzzarelli Federica 2009 L’immagine del desiderio. Fotografia di moda tra arte e
comunicazione, Bruno Mondadori, Milano p.8-10 (cfr. come analoga proposta: Jasper Fforde, Il
pozzo delle trame perdute, Marcos y marcos, Milano 2007)
6. tornare e restare al tema: la filosofia del camminare
6.1. «Ma chi ci ha rigirati così
24
che qualsia quel che facciamo
è sempre come se fossimo nell’atto di partire? Come
colui che sull’ultimo colle che gli prospetta per una volta ancora
tutta la sua valle, si volta, si ferma, indugia _,
così viviamo per dir sempre addio.»
Rainer Maria Rilke, Elegie duinesi, 8, 70-75
6.2. Senso fondativi del paradosso di Zenone e le radici filosofiche (originarie e originanti) del
camminare.
6.2.1. Il paradosso di Zenone è il teorema dell’irraggiungibilità.
L’irraggiungibilità è lo schema che definisce l’ideale e ne mette in luce la natura, il destino e la
funzione. Per una corretta nozione di ideale è opportuno agire sulla differenza prima tra “concetto”
e “idea”, poi tra “idea” e “ideale”. Gli strumenti filosofici vengono forniti da Kant (Critica della
Ragion pura) e da Schopenhauer (Il mondo come volontà e come rappresentazione).
Kant: «… prego coloro ai quali sta a cuore la filosofia (ciò che si dice più che comunemente non
avvenga) che … prendano sotto il loro patrocinio l’espressione “idea” nel suo significato originario
acciò d’ora innanzi essa non vada confusa tra le altre espressioni, con cui comunemente si designa
ogni sorta di rappresentazione, in un negligente disordine, e non ne venga a scapitare la scienza.
…il “concetto puro”, in quanto ha la sua origine unicamente nell’intelletto (non nella immagine
pura della sensibilità), dicesi notio. Un concetto derivante da nozioni, che sorpassi la possibilità
dell’esperienza, è un idea o concetto razionale. … le idee sono dalla realtà oggettiva ancor più
remote che non le categorie; giacchè non è dato trovare alcun fenomeno, in cui esse si possano
rappresentare in concreto. Contengono esse una certa completezza, a cui nessuna possibile
conoscenza empirica perviene, e la ragione vi mira soltanto a una unità sistematica, alla quale essa
cerca di avvicinare l’unità empirica possibile, senza mai raggiungerla perfettamente. Ma, anche più
dell’idea, pare che sia lontano dalla realtà oggettiva quello che io dico “ideale”, e per cui intendo
l’idea non semplicemente in concreto, ma in individuo, cioè come una cosa particolare,
determinabile o a dirittura determinata soltanto mediante l’idea.» (Critica della Ragion pura 1781,
Laterza, Roma-Bari 1971, p.303-304, 451-452)
Schopenhauer: «Il concetto è astratto, discorsivo: pienamente indeterminato nella sua sfera, non è
determinato che nei suoi confini; afferrabile e concepibile da chiunque possieda la ragione;
comunicabile senz’altro mediante la semplice parola, esauribile per intero dalla propria definizione.
L’idea invece, che si può a rigore definire come il rappresentante adeguato del concetto, è
assolutamente intuitiva, e, sebbene rappresenti un’infinità di cose particolari, è perfettamente
determinata. L’individuo come tale non può conoscerla: per arrivare a concepirla è necessario
elevarsi al di sopra di ogni volere, di ogni individualità, ed assurgere a puro soggetto di conoscenza.
L’idea non è dunque accessibile se non al genio oppure all’uomo che, grazie ad una elevazione
della sua facoltà di conoscenza pura (provocata il più delle volte dalle opere del genio), si trova in
una disposizione geniale.» (Schopenhauer Arthur 1818 Il mondo come volontà e rappresentazione,
Supplementi)
6.2.2. Il paradosso di Zenone è il paradosso dell’infinito.
6.2.2.1. Escluso dalla logica delle relazioni causali (andare all’infinito equivale a non spiegare, cioè
non fornire una causa); escluso dalla realtà fisica empirica: ci è data l’esperienza di qualcosa di non
definito, ma non di infinito. (Del resto sappiamo con evidenza visiva che sia la tartaruga che Achille
arrivano al traguardo e quest’ultimo con ampio margine di anticipo).
6.2.2.2. Definisce il campo generale delle operazioni logiche destinate all’indagine e alla
misurazione, e lo definisce all’insegna della possibilità e dell’apertura: l’infinito enuncia qui la
consapevolezza del carattere sempre aperto e possibile di ogni indagine che abbia a che fare con
l’esperienza e non con la sola logica.
25
6.2.2.3. Si trasforma allora in procedura di metodo: di sguardi teoretici, valutativi e pratici. La realtà
è quella che vediamo; il nostro sguardo può coglierla in quanto la colloca nel campo aperto e
infinito delle possibilità di definizione. L’infinito è il camminare.
«Ma noi sappiamo anche che il mondo ha un orizzonte aperto e infinito: il mondo nel senso attuale
di mondo circostante delle cose. Il mondo delle cose che sta di fronte a me e al mio prossimo, alla
mia comunità umana, in quanto mondo circostante “obiettivo” è infinito, corrispondentemente al
senso dell’apprensione del mondo delle cose. Ma anche lo stesso mondo delle persone, l’insieme
delle persone che stanno e che vanno poste con me in una relazione personale, è infinito.
L’ambiente personale è aperto, nella nostra esperienza possono presentarsi sempre nuove persone,
altre possono uscirne, e in definitiva nulla impedisce che in essa si presentino anche dei marziani,
ecc.; abbiamo quindi, nell’ordine delle possibilità ideali, delle “infinità”. In questo senso non si può
che mirare, quindi, a penetrare in questo orizzonte.» Husserl Edmund 1952 Idee per una
fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, Einaudi, Torino 2002, vol II p. 365
6.2.3. Il paradosso di Zenone e il paradosso della identità intrinsecamente diversa.
6.2.3.1. distingui tra idem (numericamente) e ipse (storicamente, personalmente).
«A tali condizioni, l’identità personale, considerata nella durata, può essere definita come identità
narrativa, all’incrocio tra la coerenza conferita dalla trama e la discordanza suscitata dalle peripezie
dell’azione raccontata. L’idea di identità narrativa dà a sua volta accesso a un nuovo approccio del
concetto di ipseità che, senza il riferimento all’identità narrativa, non è in grado di dispiegare la
propria specifica dialettica, la dialettica del rapporto tra due tipi di identità, l’identità immutabile
dell’idem, del medesimo, e l’identità mobile dell’ipse, del sé, considerata nella sua condizione
storica. Nell’ambito della teoria narrativa, la concreta dialettica di medesimezza e ipseità raggiunge
un primo manifestarsi, in attesa di culminare definitivamente con la teoria della promessa.» Ricoeur
Paul 2004 Percorsi del riconoscimento (Parcours de la reconnaissance), Raffaello Cortina, Milano
2005 p. 119)
6.2.3.2. qui ha sede la sfida del “poter raccontare e raccontarsi” come tratto essenziale dell’“uomo
in quanto capace”.
« Ora, l’identità narrativa non elimina questo tipo di identità [idem], ma lo mette in relazione
dialettica con l’identità ipse. Si può assegnare al personaggio questa prima sorta di identità
intendendo con ciò tutti i tratti di permanenza nel tempo, dall’identità biologica firmata dal codice
genetico, individuata dalle impronte digitali, cui si aggiunge la fisionomia, la voce, l’andatura,
passando per le abitudini stabili o, come si dice, contratte, sino ai segni accidentali attraverso i quali
un individuo si fa riconoscere, nel caso della grande cicatrice di Ulisse. L’identità-ipse invece
appartiene alla finzione di produrre una moltitudine di variazioni immaginative grazie alle quali le
trasformazioni del personaggio tendono a rendere problematica l’identificazione del medesimo. Ci
sono dei casi estremi in cui la questione dell’identità personale diventa così ingarbugliata, così
indecifrabile, che il problema l’identità personale si riduce alla domanda nuda e cruda: chi sono? Al
limite, il non identificabile diventa l’innominabile, con la perdita del nome proprio, ridotto a una
iniziale. L’ipseità scomparirebbe totalmente solo se il personaggio riuscisse a sottrarsi a ogni
problematica di identità etica, nel senso di capacità di considerarsi responsabile dei propri atti. A
questo livello, l’ipseìtà trova nella capacità di promettere, il criterio della sua differenza estrema
dall’identità medesimezza. L’esperienza ordinaria, meno sollecitata dai modelli narrativi che
provengono dalla finzione o dalla storia che dalla pratica quotidiana, oscilla tra i due poli della
medesimezza e dell’ipseità. MacIntyre, percorrendo tutti i livelli di narrativizzazione della pratica
quotidiana, dalle azioni di corta portata attraverso le pratiche professionali, i mestieri, i giochi, i
progetti di vita, propone la nozione di “unità narrativa di una vita”. Secondo lui, l’idea di un
montaggio della vita in forma di racconto è solo suscettibile di fornire un punto di appoggio
all’intenzione della vita “buona”, chiave di volta della sua etica, e del resto anche della mia. Come
potrebbe infatti un soggetto di azione dare alla propria vita una qualificazione etica, se questa vita
non potesse essere montata in forma di racconto?» (Ricoeur 2004 p. 120)
Si tratta di una doppia dialettica (in relazione interna):
26
6.2.3.2.1. la dialettica idem-ipse: «la rischiosa gestione dell’ipseità; si tratta insomma di mantenere
il proprio sé senza la sicurezza della medesimezza.» (Ricoeur 2004, 121)
6.2.3.2.2. la dialettica io-altro (privato – pubblico; individuale - collettivo): «Porteremo a termine
questo giro di orizzonte del problema riguardante l’identità narrativa richiamandoci a una dialettica
diversa da quella di idem e ipse, ossia la dialettica dell’identità a confronto con l’alterità.» (Ricoeur
2004, p. 121).
6.2.3.2.3. la prima dialettica si inserisce e vive nella seconda: Percorsi di riconoscimento… Sé
come un altro. « Diversamente da un alieno o da un forestiero, lo straniero non è semplicemente un
nuovo arrivato, una persona temporaneamente fuori posto. È un vagabondo eterno, sempre e
dovunque senza casa, uno che non ha mai speranza di “arrivare”» (Bauman 1991 p. 94). «Come ha
osservato e dimostrato persuasivamente Niklas Luhmann, «nella differenziazione funzionale, la
singola persona può collocarsi non più in un solo sottosistema, bensì la si deve presupporre dal
punto di vista sociale come addirittura senza luogo». Vale a dire, il singolo è un «senza luogo» per
definizione: proprio il fatto di non poter essere inquadrato pienamente in nessuno dei numerosi
sottosistemi funzionali che solo nel combinarsi costituiscono l’integrità del suo sistema di vita (in
altre parole, il fatto che non appartenga completamente a nessuno di questi sottosistemi e che
nessun sottosistema possa rivendicare la sua obbedienza esclusiva) lo rende un individuo. In
relazione a ognuno dei sottosistemi, l’individuo è un’unità costituita di molti significati, un
composto ambivalente: è sempre uno straniero parziale. In relazione a nessuno dei sottosistemi è
completamente un nativo. A livello biografico, l’individuo contemporaneo attraversa una lunga
sfilza di universi sociali molto divergenti (nel migliore dei casi, scoordinati tra loro; nel peggiore,
contraddittori). In ogni singolo momento della sua vita, l’individuo abita molti di questi universi
divergenti allo stesso tempo. Il risultato è che è «sradicato» da ciascuno di essi e in nessuno è «a
casa». Potremmo dire che è lo straniero universale. Saremmo tentati di dire che è «completamente
a casa» solo con se stesso. […] E tuttavia questo «essere a casa con se stessi» è molto problematico.
Può essere, semmai, solo il risultato di uno sforzo prolungato e tortuoso. Lo scarso coordinamento
tra i sottosistemi si riflette nell’eterogeneità dell’io. Le estraniazioni parziali sono incorporate e
sperimentate come una resistenza individuale all’integrazione. L’individuo è gravato del compito
impossibile di ricostruire la perduta integrità del mondo; o, più umilmente, del compito di sostenere
la produzione di identità individuale, facendo da solo quello che una volta era affidato alla comunità
nativa. In effetti, è ora all’interno dell’individuo che deve essere costruita questa «comunità nativa»,
che funge da struttura di riferimento per l’identità individuale. Ed è solo all’interno del lavoro di
immaginazione individuale che questa comunità gode di una sua esistenza, necessariamente
precaria.» (Bauman 1991, 112-113)
6.2.3.2.4. non stare in questa dialettica plurima (idem/ipse [medesimezza/ipseità], io/altro,
privato/pubblico) significa avviare appiattimenti identitari che nell’intenzione di promuovere forti
unità distruggono sistematicamente e con ignoranza proterva persone e potenzialità. «E su questo
terreno minato prospera la tentazione identitaria, che consiste nel ripiegarsi, da parte dell’identitàipse, sull’identità-idem.» (Ricoeur 2004, p. 122).
Due citazioni:
Priamo, di ritorno dal campo greco con il corpo del figlio Ettore, in vista delle mura di Troia,
immagina «Guardate, vuole urlare, io sono ancora qui, ma l’io è diverso» Malouf David 2009 o.c. p.
210.
«Non vi è ragione alcuna perché tutta l’esistenza umana si articoli secondo uno o pochi schemi. Se
una persona è dotata di un minimo tollerabile di buon senso ed esperienza, il suo modo di formare
la propria esistenza è il migliore, non perché lo sia di per se stesso, ma perché è il suo.» John Stuart
Mill in Nussbaum C. Martha 2004 Nascondere l’umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge, ed.
Carocci, Roma 2005 p. 384
27