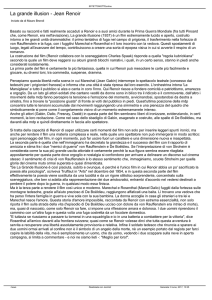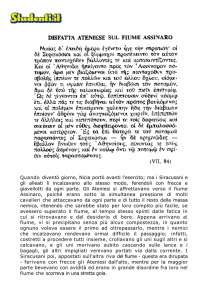Stefano Beccastrini
LA VARIEGATA BELLEZZA
E L’INEVITABILE DRAMMATICITA’ DELLA VITA
JEAN RENOIR E IL FIUME (1950)
Le Fleuve,
che parrebbe uno dei miei film più ricercati,
in realtà è il più vicino alla natura.
Se non ci fosse una storia basata su forze ineluttabili
come l’infanzia, l’amore, la morte,
sarebbe un documentario
1. INTRODUZIONE. IL CINEMA E I FIUMI
E’ a tutti noto come i quattro elementi – la terra, l’acqua, l’aria, il fuoco - che, secondo le più
antiche tradizioni filosofiche dei molti popoli del Pianeta, costituiscono la materia prima di cui è
fatto il mondo, rappresentano anche, nelle diverse mitologie e religioni di quegli stessi popoli,
complessi simbolici di straordinaria forza evocativa. Tutto ciò ha trovato profonda eco, nei
secoli, nelle diverse forme artistiche con le quali l’umana creatività si è, appunto
simbolicamente, espressa. L’acqua, uno di tali quattro elementi fondamentali, si è fatta così,
attraverso le proprie incarnazioni più significative e per esempio i fiumi, simbolo ricorrente
della poiesis espressiva sia figurativa (si pensi, tanto per fare un solo esempio, alla Fontana dei
quattro fiumi del Bernini in Piazza Navona) sia letteraria (da Omero a Ungaretti, i fiumi sono
stati protagonisti di larga parte della poesia d’ogni tempo) sia, ormai da oltre un secolo,
cinematografica. Mi piacerebbe un giorno, se avessi tempo e salute a sufficienza, scrivere un
libro su Il cinema e i fiumi. Mai argomento fu più ricco di poesia, denso di simbologia, foriero
di variegate risonanze filosofiche e religiose. In esso parlerei del Po, sulle cui sponde è
ambientata buona parte del miglior cinema italiano - qui mi limito a ricordare Roberto
Rossellini e l’ultimo episodio di Paisà, 1946, nonché Michelangelo Antonioni e il suo Gente del
Po, 1947 - e nelle cui acque spesso gonfie di piena si è rispecchiata nella propria coraggiosa
sofferenza un bel pezzo di storia d’Italia. Parlerei poi dei grandi fiumi americani. A cominciare
dal Mississippi, sulle cui sponde Mark Twain ambientò l’indimenticabile Le avventure di
Huckleberry Finn (così dando origine, secondo l’autorevole opinione di Ernest Hemingway, a
tutta quanta la moderna letteratura americana) e sono stati girati tanti indimenticabili film
hollywoodiani (per esempio, Show Boat, 1951, di quel maestro della danza e dell’avventura che
fu George Sidney), e dal Missouri (a proposito del cui rapporto con il cinema vorrei ricordare
almeno Il cacciatore del Missouri di William Wellman, anch’esso del 1951). M ricorderei
anche il fiume senza nome – di cui si sa soltanto che era senza ritorno e che simboleggiava
1
l’amore – sulla cui impetuosa corrente Otto Preminger tenne a galla la zattera di La magnifica
preda (titolo originale River of No Return, 1954) e mi intratterrei commosso sulle acque che,
scorrendo nell’Oregon fino alla città di Portland, sono costantemente presenti in Là dove scende
il fiume (titolo originale Bend of the River, 1952) di Anthony Mann. Immergendosi in esse, in
esse lottando per la vita e così purificandosi, Glyn McLyntock/James Stewart riscatta il proprio
passato banditesco e diventa un uomo onesto e generoso. Una particolare attenzione poi –
tornando in Europa e non trascurando i film girati sul Tamigi (per esempio, Il ponte di
Waterloo, 1940, di Mervin LeRoy) e sul Volga (per esempio Volga, Volga, 1939, di Grigorij
Aleksdandrov) e sul Douro (per esempio Porto della mia infanzia, 2001, di Manoel De
Oliveira) e così via – la dedicherei alla Senna. Lungo le sue acque navigava infatti, un po’
stancamente per il proprio carico di toccante umanità oltre che di merci, la chiatta de
L’Atalante, 1934, di Jean Vigo, giovane geniale e ribelle, il Rimbaud del cinema. Film sublime,
(non scorderò mai, molti anni fa, la sera in cui, in un cinema nei pressi del Jardin de
Luxembourg, ne vidi l’edizione restaurata), sul finire del quale il protagonista si tuffa appunto
nella Senna quasi come nelle oscure profondità di un inconscio misterioso e proteiforme e vi
incontra, dopo che ella gli è apparsa luminosa e ridente nella più bella sequenza in
sovrimpressione della storia del cinema, la forza per recarsi a rintracciare la moglie, delusa e
fuggita. A questo punto però, interrompendo il mio introduttivo divagare e venendo allo
specifico argomento dell’articolo, accentrerò la mia attenzione sul Gange, il fiume sacro
dell’Induismo, che scorre dai capelli di Shiva ed è venerato come una dea salvifica. Sulle sue
sponde è stato girato il più bel film “fluviale” mai visto sullo schermo. Esso si intitola,
semplicemente, Il fiume (titolo originale, The River, 1950) e ne è autore Jean Renoir.
2. IN INDIA, IN CERCA DI COSA?
Per gli indù, l’universo è Dio e siccome Dio è ovunque
per essi è naturale adorare un albero o una pietra o un fiume,
poiché ogni cosa testimonia la presenza dell’Essere Supremo
Jean Renoir si recò in India, per girarvi uno dei suoi film più solenni, nel 1950. Egli era fuggito
dalla natia, e sempre adorata, Francia all’inizio della II guerra mondiale, quando i soldati nazisti
giunsero a marciare con le loro lugubri svastiche lungo gli Champs-Élysées. Altri grandi cineasti
europei lo avevano preceduto, per sfuggire al nazismo, nell’esilio americano: Fritz Lang, per
esempio. Narra la leggenda, ma forse è addirittura storia, che, di fronte alla proposta fattagli da
Hitler di diventare il direttore della cinematografia di stato tedesca, egli prese tempo e scappò negli
Stati Uniti. Sia Renoir che Lang, forse quest’ultimo con maggior capacità di adattamento alla
macchina di produzione hollywoodiana, furono tutt’altro che artisticamente inattivi durante l’esilio
americano: Lang rimase in USA circa vent’anni e vi girò una ventina di film (alcuni dei quali
restano tra i suoi massimi capolavori), Renoir vi rimase invece circa dieci anni e vi girò soltanto
sette film (tutti più belli di quel che abbiano pensato, in genere, la critica e il pubblico ma
certamente nessuno dei quali, se non quello di cui tratta questo articolo ossia l’ultimo, può essere
annoverato tra le sue opere cinematografiche più belle). Un evento ha accomunato Lang e Renoir:
entrambi hanno girato infatti il proprio film di addio all’America, prima del ritorno in Europa,
sentendo il bisogno di recarsi a filmare in India. Renoir lo fece nel 1950, proprio per girare Il fiume,
2
Lang nel 1959, per girare il dittico de Il sepolcro indiano e La tigre di Eschnapur. La coincidenza
appare significativa o almeno tale da destare la legittima curiosità di noi amanti del cinema (e di
Renoir e di Lang). Tanto più se pensiamo al fatto che anche Roberto Rossellini, nel 1959, in un
momento di crisi e di svolta del proprio cinema e della propria vita personale e culturale, si recò in
India e vi girò, oltre al reportage televisivo in dieci episodi L’India vista da Rossellini, lo
straordinario India (in realtà il titolo originale era India. Matri Bhumi, India Humus della Terra).
Non è questa l’occasione per mettersi a indagare sulle affinità e sulle differenze tra i tre film. Basti
dire che tutti e tre i loro autori hanno cercato in India una nuova ispirazione, una nuova visione del
mondo, una nuova saggezza con la quale affrontare il proprio successivo “ritorno a casa” ossia ad
essere cineasti europei. In Renoir prevalse il fascino della religione indù, della sua capacità di
accettare la vita e la morte, il mutamento e la stasi, l’eternità e l’incessante rinnovarsi delle cose. In
Lang, quello dell’ambiente esotico, dell’avventura, dell’incontro di due civiltà, due culture, due
atteggiamenti verso il mondo tra loro difficilmente dialoganti. In Rossellini, infine, quello per la
sapienza indù, per la diversa – rispetto a quella occidentale - epistemologia cognitiva del popolo
indiano, per la differente concezione dell’idea di conoscenza e di progresso. Ma parliamo
finalmente, e solamente, del film indiano di Renoir. Esso gli venne in mente quando lesse, sul New
Yorker, una recensione del romanzo The River della scrittrice inglese (lei, che colà visse a lungo in
India, si definiva anglo-indiana) Rumer Godden. Incuriosito, acquistò il libro, lo lesse e gli piacque,
gli apparve subito quale una bella storia da trasformare in un film che fosse a un tempo di qualità
ma anche accettabile dall’industria hollywoodiana e dal grande pubblico. Le prime reazioni dei
produttori furono, però, piuttosto fredde. L’India, sullo schermo, doveva significare per forza
elefanti e caccia alla tigre e né gli uni né l’altra erano presenti nel soggetto proposto da Renoir
(furono poi ben presenti invece, seppur in maniera diversa da quella dei film d’avventura
hollywoodiana girati in un’ India di cartapesta, nei film indiani di Lang e di Rossellini). Finalmente
Renoir, come racconta in La mia vita, i miei film (Renoir, 1992), trovò il produttore disposto a
finanziare il film tratto dal romanzo della Godden: si trattava di un fiorista di Beverly Hills che
“Adorava il cinema, adorava l’India e si adoperava in favore dei suoi due amori con dinamismo
incredibile “ (Idem). Grazie a lui, la storia del cinema fu arricchita anche della “tenera e semplice
storia” (Idem) de Il fiume.
2. IL FIUME
.
Il vero mondo è quello dei bambini. Loro sono più vicini alla natura.
Sono come gli scoiattoli, liberi come gli uccelli. E come gli animali sono senza falsi ritegni.
Loro sanno cos'è importante.
Durante la rituale, ed autunnale, festività di Diwali, la “festa delle luci” che simboleggia la vittoria
del bene sul male e durante la quale è usanza accendere candele e lampade tradizionali, un giovane
indù consegna alle acque del fiume una barchetta illuminata, appunto, da una lampada. Una voce
fuori campo avverte “Per gli indù, l’universo è Dio e siccome Dio è ovunque per essi è naturale
adorare un albero o una pietra o un fiume, poiché ogni cosa testimonia la presenza dell’Essere
Supremo “. Si tratta di una suggestiva sequenza, quasi documentaristica, de Il fiume. La festa ha
luogo in un villaggio bengalese, situato lungo il Gange, ove vive anche una borghese famiglia
inglese composta dal padre, che dirige una fabbrica per la produzione della juta, dalla madre, da tre
3
figlie adolescenti, la maggiore delle quali si chiama Harriett, e da un figlio di dieci anni, di nome
Bogey, che ama suonare il flauto – gli insegna un coetaneo, e affezionatissimo, bambino indù - e
sogna di apprendere ad incantare, con tale magico suono, i serpenti. Harriett è la voce narrante del
film, che in fondo è costituito sa un unico e lungo flash-back – il cui inizio e la cui fine restano però
nella voce fuori campo - in cui ella, ormai adulta, racconta le proprie esperienze giovanili.
Ragazzina romantica e fantasiosa, che ama scrivere poesie e inventare favole, possiede due amiche
del cuore: Valérie, la figlia di un vicino e ricco proprietario terriero, e Melanie, la quale è di sangue
misto in quanto sua madre, precocemente morta, era una indiana. Frequenta spesso la casa di
Harriett un cugino del padre di Melanie, il capitano John, che ha perso una gamba in guerra ed è
piuttosto depresso. Harriett, Melanie e Valérie ne sono affascinate e, con acerbo ed ingenuo
entusiasmo, gareggiano nel cercare di attrarre la sua attenzione e conquistare la sua amicizia,
finendo così con lo scoprire in sé stesse i primi palpiti dell’amore. Harriet apre al capitano il proprio
mondo fantastico, gli mostra il nascondiglio segreto ov’ella custodisce i propri tesori nascosti, gli fa
leggere le proprie poesie e gli racconta le favole da lei inventate. Valerie, più smaliziata, lo
corteggia apertamente e con sfacciata intraprendenza, riuscendo alla fine a strappargli persino un
bacio. Melanie, invece, manifesta un comportamento più ritroso e pudico, frutto della propria
identità orientale e del proprio legame con la millenaria tradizione del proprio popolo. La vita
scorre, lenta e serena come il grande fiume sacro, ma una tremenda disgrazia - narrata tuttavia da
Renoir senza alcuna melodrammaticità - viene a turbare la famiglia di Harriett: morso da un cobra
che stava cercando di incantare, il piccolo Bogey muore nel lussureggiante giardino, durante un
caldo pomeriggio estivo che ha fatto appisolare, quasi a simboleggiare la fatale ineluttabilità del
destino, tutti gli altri abitanti della casa. La scena del funerale, con la piccola bara di legno chiaro
che si avvia verso il fiume seguita da un piccolo e fiorito corteo, è commovente ma sobria,
silenziosa, straziantemente saggia. Dopo la cerimonia, il capitano brinda ai bambini: “Il vero mondo
è quello dei bambini. Loro sono più vicini alla natura. Sono come gli scoiattoli, liberi come gli
uccelli. E come gli animali sono senza falsi ritegni. Loro sanno cos'è importante”. La nascita, di lì a
poco, di una nuova vita, una femminuccia che sostituisce Bogey nel ruolo di più giovane membro
della famiglia, riporta in essa un po’ di gioiosa serenità, a testimonianza del fatto che il grande
fiume della vita scorre ancora, incessantemente. Salutando il capitano che fa ritorno in Inghilterra,
Harriett gli promette che continuerà a scrivere poesie ed inventare favole: anche lei, come Renoir,
sa che l’arte è la sola chiave per comprendere da vicino la natura del mondo.
3. DOVE PORTA “IL FIUME”? CONCLUSIONI
Il fiume scorre, il mondo va ruotando,
alba e tramonto, mezzanotte e giorno,
il sole al dì, gli astri alla notte intorno,
il giorno è andato, la fine sta iniziando
Il film, alla sua uscita, fu accusato di essere un documentario mancato, di andare in cerca di esotici
panteismi e di astratti misticismi, di tacere sui misfatti del colonialismo inglese e altre scemenze del
genere. Renoir continuò ad andare, come aveva sempre fatto, per la sua strada (che, comunque,
4
portò Il fiume a ricevere un premio a Venezia e a piacere molto a Francois Truffaut, il quale lo
definì, ma forse citando un altro esegeta, un film-cerchio, Truffaut, 1978). Renoir ha affermato: “La
fleuve è una sorta di resoconto della vita di una famiglia inglese in Bengala Nel racconto non c’è né
inizio né fine. E’ come se si fosse prelevato un pezzo della vita di un gruppo umano senza cercare di
farne la storia. E’ la cornice a delimitare la dimensione del soggetto. Il principale problema per me
era essere autentico. Io conoscevo l’India attraverso i libri… ma mi mancava il contatto dal vivo…
La divina provvidenza venne anche questa volta in mio soccorso” (Renoir, 1992). Dal soccorso
della divina provvidenza nacque un film sublime. Maestoso, pur nel suo scorrere lento come il
fiume che ne è, così come gli animali e le piante, protagonista al pari dei personaggi umani.
Solenne, pur nel proprio narrare vicende di vita e di morte, di amore e di pianto, assolutamente
quotidiane, prive di enfasi e di melodrammaticità. Un’opera esteticamente e filosoficamente
eccelsa: il ritrarre personaggi che il costante trascorrere del tempo muta e matura, nonchè l’infinito
e instancabile fluire del fiume che fa da testimone della vicenda di uomini e cose, colloca il film in
una visione di saggezza universale, cosmica. Narrando le vicende d’una famiglia europea che vive
in India da molti anni nonché assumendo il suo punto di vista – incuriosito e stupito ma poi anche,
soprattutto nei bambini, ammirato e desideroso di capire - sugli usi, i costumi, i riti millenari e
moderni a un tempo del popolo indù, Renoir definisce una propria, persino nuova, filosofia della
vita: tollerante, misurantesi con la complessa unità del Tutto, saggia nel proprio accettare la vita e la
morte, il caso e la necessità, la variegata bellezza e l’inevitabile drammaticità del mondo. Il film omaggio poetico allo splendore delle molteplici apparenze del Kharma. - lasciò tracce perenni sia
nel successivo cinema di Renoir sia in quello indiano. In India Renoir, che non aveva fino ad allora
mai girato un film a colori, scoprì proprio la bellezza priva di sfumature e la levità del colore del
Bengala, la sua capacità di trasformarsi quasi naturalmente in immagine cinematografica. Da buon
intenditore di pittura, definì quei colori addirittura matissiani. Tornato in Europa, creò sulla base
dell’esperienza bengalese una vera e propria teoria del colore cinematografico, che lo porterà a
realizzare opere variopinte quali La carrozza d’oro, 1953, e French Can Can, 1955, ed a girare a
colori tutti i propri film successivi. Quanto alle tracce lasciate nella cultura indiana dalla presenza, e
dal modo di filmare, di Renoir, esse furono indubbiamente importanti e durevoli. Non a caso
Satyajit Ray, il più grande cineasta dell’India del XX secolo, imparò il proprio mestiere di regista
cinematografico proprio facendo l’assistente di regia, per Renoir, sul set de Il fiume. Come ha
scritto Gianni Amelio, uno degli uomini di cinema italiani che stimo di più (anche nelle sue vesti di
critico dei film altrui): “Satyajit Ray…(è)…il più grande regista che l’India abbia mai avuto, regista
di Calcutta, la città orientale lontana dalle produzioni più popolari del resto del paese…Quando
avevo dodici anni, vidi nello stesso giorno due volte di seguito Aparijito (che significa L’invitto) e
mi sembrò che parlasse di casa mia. Da allora ho cercato di non perdere mai i film e gli scritti di
Satyajit Ray. Ma in Italia di lui conosciamo poco o niente e questa ò, oltre che una perdita, una
colpa” (Amelio, 2004).
Riferimenti bibliografici
Amelio G. Il vizio del cinema, Vedere, amare, fare un film, Einaudi, Torino, 2004
Renoir J. La mia vita, i miei film, Marsilio, Venezia, 1992
Truffaut F., I film della mia vita, Marsilio, Venezia, 1978
5