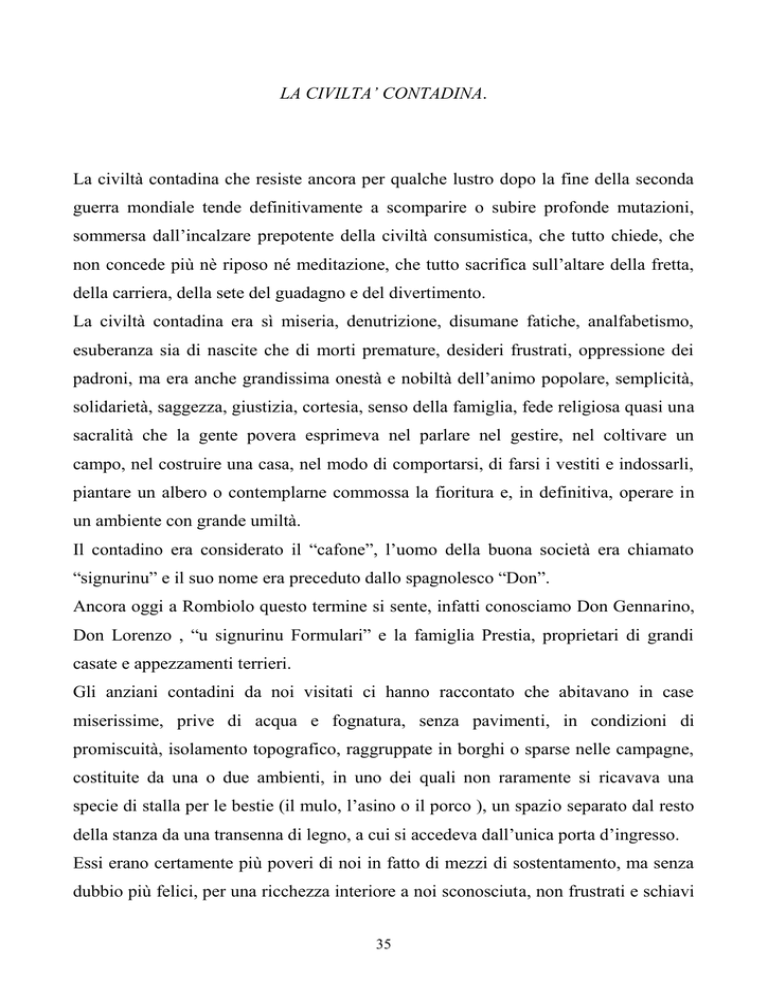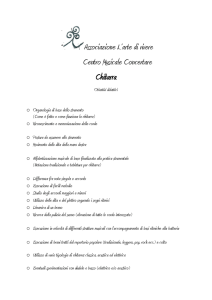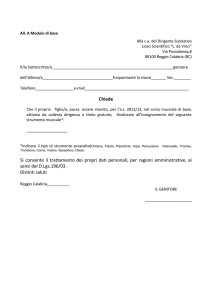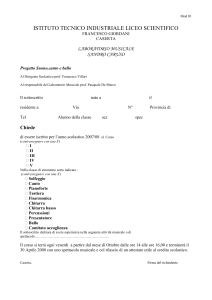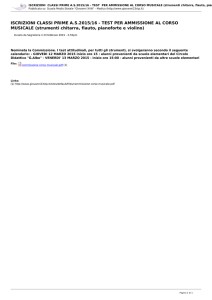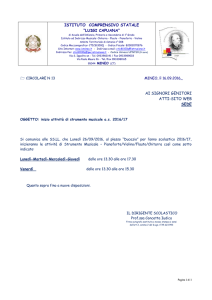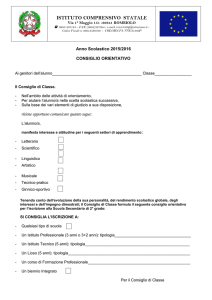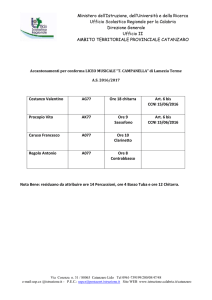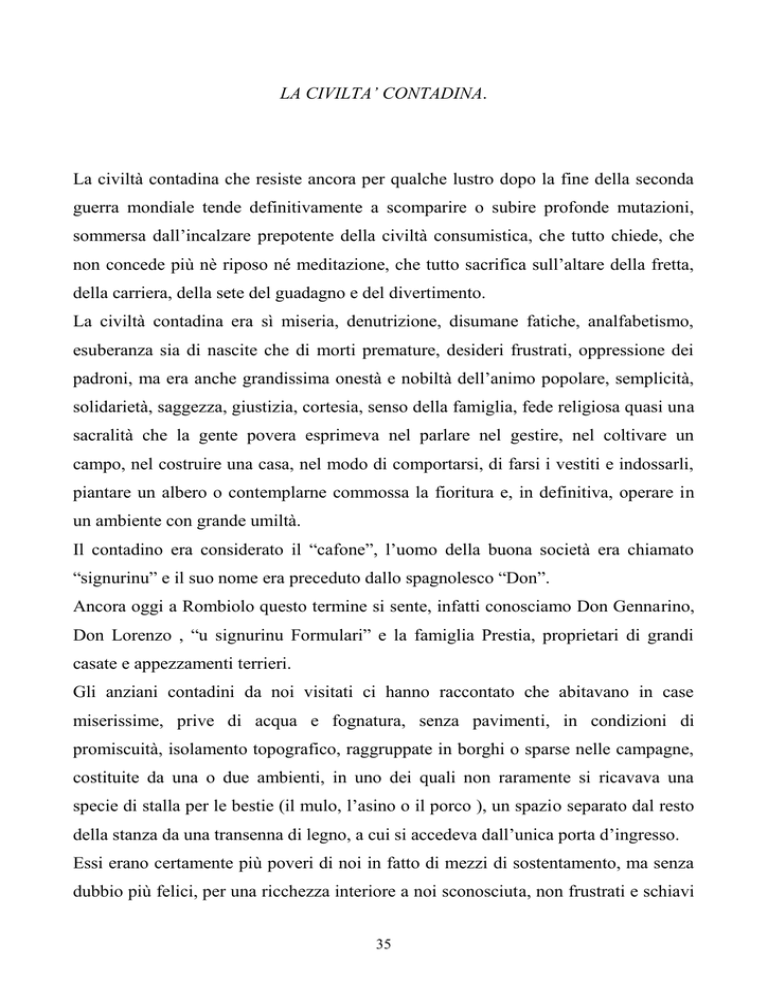
LA CIVILTA’ CONTADINA.
La civiltà contadina che resiste ancora per qualche lustro dopo la fine della seconda
guerra mondiale tende definitivamente a scomparire o subire profonde mutazioni,
sommersa dall’incalzare prepotente della civiltà consumistica, che tutto chiede, che
non concede più nè riposo né meditazione, che tutto sacrifica sull’altare della fretta,
della carriera, della sete del guadagno e del divertimento.
La civiltà contadina era sì miseria, denutrizione, disumane fatiche, analfabetismo,
esuberanza sia di nascite che di morti premature, desideri frustrati, oppressione dei
padroni, ma era anche grandissima onestà e nobiltà dell’animo popolare, semplicità,
solidarietà, saggezza, giustizia, cortesia, senso della famiglia, fede religiosa quasi una
sacralità che la gente povera esprimeva nel parlare nel gestire, nel coltivare un
campo, nel costruire una casa, nel modo di comportarsi, di farsi i vestiti e indossarli,
piantare un albero o contemplarne commossa la fioritura e, in definitiva, operare in
un ambiente con grande umiltà.
Il contadino era considerato il “cafone”, l’uomo della buona società era chiamato
“signurinu” e il suo nome era preceduto dallo spagnolesco “Don”.
Ancora oggi a Rombiolo questo termine si sente, infatti conosciamo Don Gennarino,
Don Lorenzo , “u signurinu Formulari” e la famiglia Prestia, proprietari di grandi
casate e appezzamenti terrieri.
Gli anziani contadini da noi visitati ci hanno raccontato che abitavano in case
miserissime, prive di acqua e fognatura, senza pavimenti, in condizioni di
promiscuità, isolamento topografico, raggruppate in borghi o sparse nelle campagne,
costituite da una o due ambienti, in uno dei quali non raramente si ricavava una
specie di stalla per le bestie (il mulo, l’asino o il porco ), un spazio separato dal resto
della stanza da una transenna di legno, a cui si accedeva dall’unica porta d’ingresso.
Essi erano certamente più poveri di noi in fatto di mezzi di sostentamento, ma senza
dubbio più felici, per una ricchezza interiore a noi sconosciuta, non frustrati e schiavi
35
di un edonismo consumistica che dilaga sempre più nelle nostre città, dove tutto si
trova tranne che il calore umano e alle cui porte il contadino ha consumato la
decisione più grave della sua storia, sacrificando la sua terra sull’ara di un benessere
prevedibilmente più facile e più sicura.
Il loro linguaggio era semplice, colorito ed espressivo, dotato di una sapienza e di un
rigore logico che avrebbe fatto invidia a un filosofo, era ricco di proverbi incisivi e di
grande utilità nell’assolvere una funzione moraleggiante e didattico attraverso cui si
cercava di impartire insegnamenti, lezioni di comportamento nella società.
Ricordano ancora i loro punti di ritrovo: le botteghe del falegname, del calzolaio, del
sarto, del fabbro, del salone, del barbiere. Tutti questi mestieri si praticano ancora a
Rombiolo anche se i mezzi da lavoro non sono più quelli di una volta.
FOTO…
L’antico mondo contadino stenta a sopravvivere, ragion per cui è bene non ignorare
quanto è rimasto di quella civiltà.
“Il presente sarebbe un deserto terrificante senza le tracce del nostro passato”…
36
LA CULTURA DEL MAIALE
Che il maiale fosse tenuto in grande considerazione per le provviste alimentari che
garantiva per tutto il corso dell’anno, è dimostrato dal fatto che ancor oggi, nelle
famiglie rombiolesi , non è scomparsa la consuetudine di ammazzare il porco nei
mesi invernali per farne salsiccia, soppressate , capicolli e la ‘nduja. In Calabria
l’uccisione del maiale costituiva un vero e proprio rito, che si protraeva per almeno
tre giorni necessari per la lavorazione , nelle sue varie fasi, avvalendosi della
collaborazione prestata nell’occasione dalle comari e dai parenti che, invitati ,
accorrevano per dare una mano d’aiuto e brindare in allegria con vino generoso e
genuino. C’è un detto popolare , di antica memoria ; “ Cu si marita è cuntentu nu
jornu, cu ammazz u porcu è cuntentu n’annu”.
Non v’è dubbio che partecipare ad un banchetto può deliziare un giorno, ma
ammazzare un maiale vuol dire avere provviste per un anno. Infatti niente del maiale
viene scartato.
Il maiale, una volta ammazzato, veniva sezionato per preparare dalla carne magra gli
insaccati, e dal grasso lo strutto che, un tempo, era sostitutivo dell’olio e financo
utilizzato per ricavarne il sapone con l’aggiunta di potassio e cenere.
‘NDUJA
Tra i prodotti tipici di Rombiolo la ‘nduja occupa un posto singolare nella
gastronomia, con un nome, la cui origine è grecanica o araba, come a prima vista
potrebbe credersi, “Nduja” deriva piuttosto dal francese (andouille) e significa
salsiccia.
37
Della salsiccia, tuttavia, ha solo l’aspetto, ma non gli ingredienti e soprattutto il
sapore.
La sua produzione, pur conservando peculiari caratteristiche familiari, si è
trasformata in artigianale raggiungendo alti livelli di qualità nel comprensorio del
Poro ed a Spilinga in particolare.
E’ confezionata con carne di maiale, con pezzetti di grasso in modica quantità,
aromatizzata con pepe rosso, a volte in misura considerevole, che, per il sapore
piccante conferitole, ha incontrato il gusto dei consumatori della genuinità. Tutti i
componenti, compreso il pepe rosso, vengono macinati col tritacarne. L’ impasto, a
cui si aggiunge il 3% di sale, viene omogeneizzato in madie di legno ed insaccato in
involucri naturali (intestino tenue e cieco di suino e bovino), per essere affumicato
per qualche giorno con legna resinosa ed aromatica e stagionato poi in soffitte a
climatizzazione ottimale.
Si può mangiare dopo 15/20 giorni di stagionatura ed anche dopo un anno.
La ‘nduja ha colorito rossastro, consistenza pastosa che non diventa mai dura anche
dopo la stagionatura e sapore piccante. La si trova in tutti i ristoranti della zona.
Spalmata su fette di pane integrale ed accompagnata da un buon bicchiere di vino dà
un gusto ed un sapore particolare, che ricorda la vecchia cucina della tradizione
contadina.
Su di essa si sono fatte ricerche a livello storico e scientifico…
LA PANIFICAZIONE
II pane di casa, che era il risultato di un lungo ed intelligente lavoro della famiglia
contadina, si faceva, a quel tempo e tutt’oggi, con il forno a legna. La farina
proveniente dal mulino era ancora mescolata alla crusca, per cui bisognava
setacciarla col crivu o crivello. Era questa una operazione che comportava un abile
movimento delle braccia e delle mani. Vi erano due crivi: uno per la farina di grano e
l'altro per la farina di granturco. Si prendevano 4 o 5 Kg di fior di farina e si
mescolavano col lievito. Il tutto si lasciava lievitare fino al mattino, dopo averlo ben
38
coperto. La farina lievitata, all'indomani si impastava e si amalgamava con la quantità
di farina collocata nella madia.
Ultimato l'impasto si preparavano i panetti (pani) o forme di pane rotondeggianti che
si ponevano in fila su un tavolo e si, ricoprivano con un lenzuolo e una coperta in
estate e con più coperte in inverno.
Mentre i pani riposavano una o due ore, o più se faceva freddo, si accendeva il forno
con frasche e tralci secchi di viti e si aumentava il fuoco per un'ora o un'ora e mezza,
fino a quando i mattoni del forno non fossero diventati ben arrossati. Si raccoglievano
poi le braci col sirtu o tirabrace, ammassandole sulla bocca del forno e coprendole
con una ciaramida (tegola). Si puliva il pavimento del forno col cajipu o fruciandolo e
si deponevano i pani con la pala di legno, chiudendo poi la bocca del tomo con la rota
o porta di chiusura rotondeggiante, in ferro.
Il tempo necessario per la cottura era di un' ora per il pane di grano e di circa due ore
per quello di granturco. Spesso la mamma faceva la pitta, un panetto con dentro carne
di maiale o cicciole, di sapore squisito. Alla riapertura del forno, i pani erano riportati
sul tavolo, e il fragrante profumo del pane fresco si diffondeva per tutta la stanza. Per
avere il pane-biscotto, si faceva, invece, rimanere nel forno per due giorni, ben
protetto dai topi e dal freddo. Era consuetudine, quando si faceva il pane, regalare u
panettu a parenti stretti e a vicini, che acquistava il significato di un gesto squisito di
solidarietà tra poveri. Non sempre era possibile fare il pane con farina di grano o di
granturco; alcuni usavano l'orzo oppure mescolavano orzo e granturco. In tempi di
carestia si usava anche l'avena o addirittura la castagna trasformata in farina, che per
secoli ha svolto un ruolo centrale nell'economia del Mezzogiorno e della Calabria in
particolare. Le famiglie contadine della Calabria conoscevano bene l'importanza del
pane, e la regola per gustarlo ancora meglio, che era rispettarlo come dono di Dio. Da
noi, un pezzo di pane che cadeva a terra si raccattava e si baciava.
Ancora oggi a Rombiolo, molte sono le famiglie che fanno il pane di casa.
39
OLIO
LA RACCOLTA E LA MOLITURA DELLE ULIVE IN CALABRIA…
Viene il rigido inverno, d’alti olivi ondeggiano i campi,
e tutta la pianura nereggia di piccole bacche.
Già le solite ceste preparano liete i coloni,
S’alzano, ai primi albori, forosette e teneri bimbi
E, per l’ombrose vie, affrettano celere il passo.
E, succinte le vesti, le madri pel bruno sentiero
Raccolgono le ulive: ne le ceste il tesoro ripongono,
esultano; e giuliva la villica innalza il suo canto,
mentre recano piene d’ulive il canestro i garzoni.
Di Sicione la bacca degli unti trappeti s’accumula,
e la mola ivi infrange le ulive purgate; e la molle
Massa, chiusa in graticci, già premono i rudi coloni
E col peso del torchio stringono tutti e con forza.
Ferve l’opra, e un villano con acqua fervente le gabbie
Irriga, e scorre intorno la pingue rugiada d’olivo.
Ma, nella fredda notte, s’assidono al fuoco gli agricoltori,
ricreando a la fiamma crepitante le torbide membra
e cospargono il cibo di biondo e liquido olivo.
E passano la notte tra le coppe colme di bacco…
F.S.A.
40
I TRAPPETI
Nei tempi passati le olive si raccoglievano ad una ad una,
nelle campagne, con le mani e deposte nei panara venivano vuotate in sacchetti o in
grosse sporte, che per la molitura, erano portate al tappeto sulla testa delle donne, a
dorso di asini o mulo o sul carro trainato da buoi.
Le olive rimaste sulla pianta venivano curramate o abbacchiate con lunghe pertiche
per farle cadere sul terreno. Le donne, col dorso ricurvo e con la testa china fino a
terra passavano la giornata all’aperto sotto la pioggia ed il vento, la brina ed il gelo, a
raccogliere le olive, dalla fine di settembre fino a tutto il mese di marzo.
Oggi la raccolta è facilitata dall’uso delle reti.
Il trappeto era costituito da due mole o grosse ruote di pietra appaiate da un asse
trasversale come quelle di un carro.
Queste due mole si mettevano a ruotare in una grande coppa entro cui erano state
versate le olive, con la forza motrice generata non da energia elettrica ma una vacca o
da un bue che, pungolati facevano il giro intorno alla coppa.
A forza di ruotare le olive venivano ridotte in poltiglia profumata e grondante olio
che il macchinista insaccava poi nelle “sportine” o contenitori simili ai copertoni
delle auto, aperti, però, all’interno e piene di forellini da ambo le parti. Le sportine si
collocavano, una sopra l’altra sotto il torchio e iniziava da questo momento la
torchiatura. La piastra superiore scendeva lentamente verso la piastra inferiore
comprimendo la pasta che si liberava dell’olio.
Questa operazione si chiamava “pressa”.
Le sportine cominciavano a sudare e a grondare da tutti i pori un liquido verdastro
che andava a riversarsi nella vasca semipiena di acqua, a guisa di un ruscelletto
rallegrando il volto delle raccoglitrici di olive che ammiravano compiaciute il frutto
delle loro lunghe fatiche. Quando le sportine non sudavano più, si spruzzavano
abbondantemente con acqua, affinché nessuna goccia di olio andasse perduto. Il
41
macchinista, quindi, con un piatto di alluminio raccoglieva l’olio nei cafisi che i
padroni provvedevano a svuotare in contenitori.
L’olio, portato a casa, finiva nelle giare, e a tempo debito sarebbe stato venduto.
L’olio d’oliva costituiva, a quel tempo, un alimento salubre e una fonte di reddito per
le famiglie.
Ancora oggi a Rombiolo molte sono le famiglie che raccolgono le olive non certo
per fonte primaria di reddito ma per bisogni alimentari, infatti considerato uno dei
costituenti principali della dieta mediterranea.
Ovviamente la lavorazione delle olive non si effettua più come un tempo essendoci
diversi frantoi modernizzati che consentono una lavorazione più veloce e facilitata.
Diverse sono le famiglie rombiolesi che svolgono questo mestiere, alcuni di questi
tramandati da generazioni.
Diverse ore abbiamo trascorso in compagnia dei nonnini di Rombiolo, i cosiddetti
“maestri di vita”, ci hanno raccontato i loro divertimenti, le loro paure nei tempi di
guerra, le loro fatiche che spesso si trasformavano in allegria come per esempio la
mietitura-trebbiatura e la vendemmia…Andiamo ora a conoscere come, avveniva un
tempo, la mietitura.
Ci racconta il sig Marturano Francesco che, la vita del contadino era scandita
dall’avvicendarsi delle stagioni e dal tempo meteorologico, del cielo, dell’aratura,
della semina e del raccolto e dal riprodursi degli armenti.
Si prestava una cura meticolosa nell’eseguire le operazioni colturali nei campi.
Il “maggese” ad esempio consisteva nell’arare più volte il terreno. L’aratro di legno,
con manico e vomero di un sol pezzo, veniva trascinato da una coppia di buoi.
L’aratura richiedeva un notevole sforzo fisico anche da parte dell’uomo, il quale
doveva guidare col pungolo e la voce le bestie e nello stesso tempo doveva mantenere
l’aratro ben fermo nel solco col vigore delle proprie braccia.
Prima veniva la semina, dopo aver preparato per tempo tutti gli attrezzi necessari,
primo fra tutti l’aratro, poi la sarchiatura e ai primi accenni della primavera la
42
potatura e la insolfatura. Al sopraggiungere dell’estate la mietitura e poi la trebbiatura
sull’aia precedentemente preparata e, a metà settembre, la vendemmia che era la festa
dell’allegria. E poi, daccapo, il metodico ripetersi delle stesse operazioni agricole.
La trebbiatura si effettuava sull’aia “a calpestio” ; paglia e pula venivano separate
dal grano con il soffio del vento. I contadini lavoravano alacremente, a piedi nudi,
rivoltando le spighe o muovendo il crivello a vento e, quando il vento si calmava o
cessava talvolta di soffiare, con il crivello nelle mani aspettavano che tornasse di
nuovo a soffiare, per ultimare la ripulitura.
Le operazioni di trebbiatura avevano tempi di lavorazione variabili anno per anno per
essere strettamente dipendenti dalla ventilazione naturale. Sul grano ripulito veniva
deposta la stessa croce di canne…
Tutte queste operazioni si svolgevano allegramente, cantando e ripetendo diversi
proverbi…
Oggi tutto è cambiato, per fortuna ci sono i macchinari per facilitare il lavoro
dell’uomo; a Rombiolo ci sono molte persone che svolgono questo mestiere.
LA VENDEMMIA
Per quanto riguarda la vendemmia, è l’operazione che si effettua, di consueto, alla
fine di settembre di ogni anno, nei campi coltivati a vigneti, per la raccolta dell’uva
giunta a maturazione.
I contadini raccolgono allegramente il frutto meritato delle loro fatiche, dopo aver
prestato, nell’avvicendarsi delle stagioni, cure particolari alla coltivazione della vite,
preservandola dalle insidie della peronospera e dell’oidio, le due malattie, che si
combattono, irrorando la pianta con la mistura bordolese (latte di calce e solfato di
rame).
Un altro nemico della vite , ancora più terribile è la filossera.
E’ una pianta che ama il calore e la luce. Teme l’umidità eccessiva, la brina, la neve e
soprattutto la grandine, che è il maggiore flagello della vite.
43
I terreni molto umidi non si prestano alla coltura della vite. Essa ama i terreni sciolti,
perché più asciutti, aerati e perciò più caldi.
Rombiolo non ha una grande produzione di uva ma, molte sono le persone che
riescono a portarla avanti, e ad assaggiare nel periodo giusto il vino fatto con le
proprie mani.
Nel pieno dell’estate i pampani della vite utilizzano il calore solare e la trasformano
nei dolci grappoli. E quando poi in autunno, la vite inizia il suo periodo di riposo, si
tinge di rosso e giallo…
La vendemmia era ed è considerata la festa dell’allegria .
Un tempo i più giovani vendemmiatori, accompagnati dal suono di un flauto e di un
tamburino ballavano la tarantella e i più anziani si lasciavano andare a canti
improvvisati.
Anche oggi in molte famiglie rombiolesi si canta, si balla, s’invitano parenti ed amici
per mangiare e bere tutti assieme…
L’arte di fare il vino è radicata nella nostra storia millenaria.Una tradizione che in
Calabria è stata, e lo è tuttora, anche un’importante voce dell’economia locale.
L’uva raccolta in ceste viene portata al palmento per la pigiatura e successiva
torchiatura. Il vino è il prodotto finale della fermentazione alcolica del mosto ricavato
da uve fresche.
Vino, oblio degli affanni – cantava Alceo nel cantico immortale – che non l’ha mai
tradito e che lo ha sorretto nei momenti più tristi: “ Beviamo! Perché dobbiamo
aspettare la sera?”! “ Riempi il corpo di vino, che già l’astro si volge”. All’amico
più caro il poeta non sa dare consiglio migliore; non piantare nessun’altra pianta
prima della vite; artisti e poeti in ogni tempo non hanno mancato di lodarne le virtù…
………………………………….
Sulle balze di pietra
dure a maturare
vendemmia ancora
il vecchio contadino
44
che riapre il palmento
rilava nel mosto
l’usitato piede
alla fatica
lasciato nudo
dal fustagno
rimboccato
quest’anno
ormai volge alla fine
la raccolta di ulive
non vedrò al mio ritorno
molte donne chine
a sfidare le intemperie
roteando fra le mani
il crivo
screpolato al vento
al gelo
pena e gioia
con la mia gente.
di Ignazio Schinella
45
L’ALLEVAMENTO DEL BESTIAME…
Rilevante era, ed è ancora in molte campagne rombiolesi,
l’allevamento del
bestiame. Un tempo danneggiato dalle razzie e dalle epidemie. Fino a poco tempo fa,
a Rombiolo si svolgeva, nel mese di luglio, la fiera del bestiame. Molti erano i
contadini, che si recavano dai paesi vicini. Il bestiame trovava largo impiego non solo
nell’ alimentazione umana, ma serviva anche per le vesti, per il trasporto e come
fornitore di forza motrice nelle operazioni agricole (come già accennato nella
mietitura). Per arare la terra i buoi. L’allevamento ovino serviva più per la lana che
per la carne.
Oggi invece trova largo impiego nell’alimentazione umana, molte sono le famiglie
che allevano da sé , i vitelli, le caprette, il maiale, per poi mangiare carne genuina…
Nelle nostre parti si produce e si confeziona un ottimo formaggio, le ricotte.
Foto….
Siamo andate a farci raccontare da un pastore i diversi processi per arrivare poi al
formaggio…
Il latte prodotto dalla mungitura delle pecore e delle capre, effettuata due volte al
giorno, si raccoglie in catini e si versa poi nei culaturi, dove si lascia mezz’ora per
coagulare, dopo aver aggiunto il caglio o pezzo di carne ricavato dallo stomaco di
animali lattanti.
Il latte una volta rappreso si rompeva con la nocca o arnese di legno a forma di
conocchia.
Raccolto con le mani ben pulite, veniva deposto sul tavolo da legno, munito di una
scanalatura che andava a finire nel caccamu o caldaia.
Dalla mastreia il latte rappreso passava nella fascea o forma, fatta di giunchi e
diventava formaggio.
46
Quanto cadesse nel caccamu, si riscaldava a fuoco lento per qualche minuto, per
raccogliere i frammenti sparsi che assieme al latte rappresso, formavano le ricotta che
si depositava in altre piccole forme, chiamate custigne. La ricotta si mangia subito
mentre per il formaggio si aspetta qualche giorno, anche mesi dipende dal tipo di
formaggio che si vuole formare esempi, duro, morbido, cremoso ecc…
Il liquido giallastro, che rimaneva al fondo della caldaia ricco di minuscoli pezzetti di
ricotta che costituisce un’ottima bevanda per i cani, per i maiali, e anche per le
persone se bevuto caldo e subito.
ARTIGIANATO
Oggi parlare di arti e mestieri del passato è difficile, specialmente nei confronti di
quelle generazioni che non hanno fatto in tempo ad assaporare la validità, come
accade alla generazione attuale che vive sotto l'incalzare della meccanizzazione.
I giovani, affascinati dai miti della modernizzazione, non sanno più i nomi delle cose
che hanno accompagnato la travagliata esistenza dei nonni e dei padri e distruggono,
a volte, con incosciente baldanza suppellettili, attrezzi di lavoro, che hanno dato
senso e valore alla vita quotidiana delle generazioni passate. Nel Vibonese,
l’artigianato ha avuto una larga diffusione ed è stato fonte di vita e di guadagno per la
numerosa collettività, arricchitasi anche, con l'andar del tempo, di arti e mestieri che
hanno fatto da supporto alla civiltà contadina. Ma nel dialetto, ancora amorosamente
coltivato e parlato, sono scomparse già - o sono prive di senso per i più giovani - le
parole indicanti antichi mestieri sommersi impietosamente dal progresso: chi ricorda
più “u smatraturi” (il castratore di maiali), “u pettinare” (il venditore di pettini per i
telai ma anche colui che aggiustava i pettini), “u stagnarli” (colui che aggiustava
pentole), “u cangiaturi” (commerciante a baratto), “u capiaru” (il compratore di
cappelli)?.
47
Ma come non ricostruire anche il ruolo di sarti, intagliatori di pregio, con un gran
numero di lavori effettuati, dove non si sa se ammirare di più l'originalità del disegno
o la finezza dell'esecuzione, calzolai, barbieri, sellai, vasai, maniscalchi, fabbri,
costruttori di carri che, facendo parte costitutiva di quel mondo ormai in declino,
svolgeva il suo lavoro quotidiano con pazienza e dedizione, svelando ingegno e
passione alla creazione di cose belle e utili al servizio della collettività? Nessuno ha
mai ricordato tanti anonimi bravissimi artisti ed artigiani che presso le cave di pietra
o in miseri tuguri, al chiarore di una lucerna, hanno avuto per generazioni le loro
botteghe o hanno lavorato nella costruzione dì Chiese, monasteri, torri, palazzi
costruendo arconi di granito, colonne, capitelli, volte a tamburi ed a botte, cupole,
lavori di gesso, mattoni, tufo dando solidità tecnica, finezza di stile, armonie dì linee
che ancora ammiriamo estasiati.
PESI E MISURE
Misure per aridi
Per gli aridi ossia per grano, granturco, legumi etc. si usa come unità di misura il
"Tumanu" (tomolo) o frazioni di esso. Il tumano è circa 50 kg.
La "Menzarola" corrisponde alla metà del tumano.
Un'altra misura è lo "Stuppejo" che è l'ottava parte di un tomolo o la quarta parte
della menzarola.
A queste misure si aggiunge anche il "Quartu" che è la quarta parte del tomolo,
quindi la metà della menzarola ed il doppio dello Stuppejo.
Per la misura degli aridi vi sono dei contenitori, per lo più in legno, di forma troncoconica, che sono la "menzarola", lo "stuppejo" e il "menzu (mezzo) Stuppejo".
Misura di capacità per liquidi
48
Per l'olio la misura è la ''malaina", che equivale a 12 litri. Il cafiso equivalente a litri
12.26 e anche la "Litra" che equivale al litro.
Misura di peso
II "Rotulo" rappresenta un kg circa; la"unza" o oncia equivale a 27 grammi circa ed
infine la "Libbra" rappresenta un quarto del chilogrammo.
Misure agrarie
Le misure agrarie sono la "Tumanata" che è circa un terzo dell' ettaro, da noi
lievemente inferiore. Segue la "menzarolata" che è la metà della tomolata e la
"quartucciata", poi, che è la quarta parte della tomolata e la metà della menzarolata.
Ed infine la "stuppejata" che è l'ottava parte di una tomolata.
Tradizioni, artigianato, risorse.
Nel 1996 è nata la “Mostra Mercato” relativa ai prodotti agricoli e artigianali
dell’area del Poro. E’ un tentativo di valorizzazione delle produzioni locali, una “tre
giorni” alla quale partecipano artigiani e produttori della zona. E’ un evento che si
cercherà di incrementare ogni anno , sperando di richiamare sempre di più operatori
del settore e visitatori interessati ai prodotti. Oltre ai prodotti alimentari sono presenti
realizzazioni artigianali in legno, ferro battuto, marmo e anche in cemento.
Altre manifestazioni estive si svolgono nelle frazioni: a Presinaci c’è la “sagra del
maiale” , tradizione nata poiché c’era l’ usanza di ammazzare il maiale fuori dai
49
tempi normalmente previsti e cioè a settembre, periodo in cui si svolge appunto la
sagra. C’è poi la “sagra della patata”, a Pernocari.
Per quanto riguarda l’aspetto gastronomico, accanto al già citato formaggio pecorino
e ai salumi, vi è la produzione di dolci tipici con i caratteristici “ancinetti”, dei
prodotti tipo ciambelle o a forma di bastoncino, fatti con le uova e ricoperte da una
glassa di zucchero. Un altro tipo di biscotto è invece fatto con la pasta di pane ed i
finocchi.
Una tradizione molto importante a Rombiolo
è quella dei telai, che un tempo
lavoravano la canapa, la lana, il cotone ed il lino. Erano specializzati nella tessitura di
lenzuola, copriletti e tovaglie per il tavolo. I copriletti venivano poi ricamati,
contribuendo a dare valore al prodotto finito. E’ una produzione che continua ancora,
secondo le procedure di tipo tradizionale, ma che meriterebbe di essere incentivata.
Rombiolo è stata un po’ la culla dei mulini. Attualmente si possono osservare i resti
di cinque mulini ad acqua per macinare il grano, situati lungo i fiumi presenti e che
risalgono a circa il 1700. Un tentativo di restauro e di rivalutazione sotto il profilo
architettonico-ambientale, più che produttivo-funzionale, non è stato ancora portato a
termine.
Le risorse produttive del paese sono prevalentemente agricole e legate al territorio del
Monteporo. Le attività praticate riguardano la pastorizia e l’allevamento. Tali attività
venivano, una volta, realizzate in due aree diverse e distinte. La parte del Monteporo
era dedicata alla pastorizia, mentre alla parte più bassa, quella più vicina a S.
Calogero
e Limbadi, vi erano i “massari”, possessori o gestori di stalle ed
allevamenti bovini. Adesso quest’ultima attività si è diffusa per tutto il Monteporo,
con la costituzione di grandi aziende agricole di allevamento di bestiame.
Tra Rombiolo e Spilinga ci sono allevamenti di mucche e pecore , condotti secondo
tecnologie e standard moderni.
Un determinato quantitativo di latte è destinato alla trasformazione in formaggio e
derivati, connotando i prodotti secondo le caratteristiche del luogo, mentre un’altra
parte del prodotto è destinata alla centrale del latte di Calabria.
50
Una struttura che costituirà senz’altro il fiore all’occhiello di Rombiolo sarà la
realizzazione dell’Auditorium, per il quale sono stati già avviati i lavori.
Sarà una struttura polivalente adibita a teatro e a sala riunioni in cui si potranno
svolgere manifestazioni di vario genere.
Una realizzazione di questo tipo può rappresentare un elemento di crescita per il
paese, nonché un centro propulsore per diverse iniziative, rafforzando ed offrendo
opportunità di sviluppo di tipo sociale e culturale.
Esiste anche un Club per gli amanti del volo ultraleggero, situato per metà nel
comune di Rombiolo e metà nel comune di Spilinga, in una zona pianeggiante in cui
è stata realizzata una pista per consentire a questi veicoli leggeri a motore di poter
prendere quota.
LA SAGGEZZA CONTADINA NEI PROVERBI ROMBIOLESI
II proverbio è una breve frase che esprime un'elementare intuizione o una massima
desunta dall'esperienza. I proverbi sono in costante relazione con le epoche e le
civiltà in cui nascono e si sviluppano e, se messi in pratica, fanno menare una vita
saggia.
La gente del popolo, nei rapporti verbali con i propri simili, è più propensa ad usare
un linguaggio sobrio, conciso, concreto, che possa ottenere il suo scopo con
immediatezza ed efficacia, evitando di impelagarsi in lunghi discorsi che oltretutto
sarebbero noiosi. Non si preoccupa di partire da premesse per arrivare a delle
conclusioni, ma si affretta a venire al dunque direttamente, sorvolando sui termini
51
intermedi e senza ricorrere all'uso di troppe parole. E' ovvio che in un siffatto modo
di esprimersi trovino largo impiego i proverbi che si configurano, appunto, come
discorsi condensati in poche parole, da considerarsi come i prodotti più caratteristici
delle parlate volgari. Come tutti i detti popolari in scarne parole riassumono
esperienze di generazioni e schematizzano i lunghi ed inviluppati ragionamenti dei
cosiddetti pensatori. Nella sfera intellettiva i proverbi sono, come dice il Croce: "II
monumento parlato del buon senso"; e tanta è la loro forza persuasiva che talvolta
servono a concludere indagini critiche e filosofiche, pur perdendo l'antica e comune
essenza. Parecchi proverbi sono filiati dall'ambiente contadino e si tramandano per la
loro intrinseca saggezza. Eccone alcuni, di frequente uso:
-Cu nesci tundu no pò muriri quadru.
(Ognuno ha segnato sin dalla nascita il proprio destino, chi è nato fortunato rimarrà
sempre tale, lo sfortunato non potrà mai riuscire a cambiare la sua triste sorte).
-U sazzìu no canusci u dijunu.
(Chi ha la pancia piena difficilmente si metterà nei panni di uno che ha fame).
-Cu paga avanti mangia pisci ritenti.
(Chi paga avanti mangia pesci cattivi; chi paga prima ottiene sempre cose
mediocri).
-Cu i gatta nasci surici pigghia.
(Chi nasce da gatta è destinata a pigliare sempre sorci. Se la madre ha fatto in
gioventù la malafemmina, si può essere certi che presto anche la figlia ne seguirà
l'esempio poco edificante).
-L'omu gilusu mori comutu. (L'uomo geloso è destinato a morire cornuto.
Infatti la moglie poco virtuosa ha piacere di piantare le coma proprio al marito
geloso).
-A megghiu parola è chija chi no nesci da vucca. (E' assai apprezzabile chi parla
poco).
52
-L'omu si pigghia pa parola, u voi pi corna. (L'uomo si riconosce per la parola data ed
il bue dalle corna. L'uomo è tanto più apprezzato quanto più tiene fede ai suoi
impegni).
-A troppa bontà scianca a vertula.
(Come la soverchia carità fa bucare la bisaccia del monaco di cerca, così il
troppo far bene alla fine è destinato a degenerare).
-Megghiu l'ovu oggi ca gajina dumani.
(Bisogna senz'altro accettare e prendere quanto ci viene offerto oggi. Il miraggio di
un dono migliore domani deve farci riflettere su quanto scioccamente vorremmo
lasciare).
-Pratica cu i megghiu i tia e fanci i spisi.
(Scegli bene la tua compagnia. Pratica sempre con i migliori di te, a costo di
fare loro anche le spese).
-Quando ti cridi ca godi o crcpi o mori.
(Non c'è mai una felicità nella vita. Quando pensi di poter godere, o arrivano
i guai, o addirittura la morte).
-U cani muzzica sempri o sciancatu. (La mala sorte perseguita sempre lo sventurato).
-Quandu u ciucciu no 'bboli u mbivi, hai vogghiamu frischi!
(Quando una persona non vuole fare una cosa o concederti un favore, è
inutile che continui a pregarla).
-L'homu struitu non mori mai di fami.
(La persona colta non è destinata a morire di fame: perché riesce sempre a
trovare i mezzi per vivere).
-Non è villanu cù villanu nesci; ma è villanu cu u villanu faci.
(Non è veramente villano chi è tale per nascita, bensì quello che da tale si
comporta).
-Mali non fari e paura non aviri.
(Non far male a nessuno e non aver paura che qualcuno ne faccia a te).
-Quandu u diavulu t'aliisela, è signu ca voli l'anima.
53
(Quando qualcuno ti coccola troppo, è segno che da te pretende qualcosa di
grosso).
-Paijsi chi vai, usanza chi trovi.
(Quando vai in un paese diverso dal tuo, abituati alle usanze del nuovo ambiente,
perché hanno anche per te valore di legge).
-I cunsighii d'autri dassa e pigghia; ma i toi ne dassàri mai.
(I consigli degli altri accettali quando ti conviene; fidati, invece, sempre della
tua testa).
-U pisci randi, si mangia'u picciriju.
(Il pesce grande inghiotte il piccolino. Il prepotente fa sempre sua preda il
debole: da quando si è creato il mondo è stato sempre così!).
-L'arburu a m'addrizzi quando è tenneru, ca quandu è duru non s'addrizza
cchiù.
(L'uomo si educa sin da ragazzo, perché è solo in questo peculiare periodo
formativo che tutti i suoi incipienti difetti possono venire stroncati o almeno
corretti). Eccone altri ancora in uso nel vibonese e più specificatamente sulF amicizia, che talvolta è più utile e più preziosa di un rapporto di parentela:
-fimi c'a parenti veni, 'a vicina ti sumbèni (fin quando la parente viene la vicina ti ha
già guarita).
-mègghju aviri 'na bona vicina ca centu ducati (è preferibile avere una buona vicina e
non cento ducati).
Perché
-punì a regina havi bisognu d'a vicina (anche la Regina ha bisogno della vicina). Non
sempre, però, la vicina si comporta lealmente, ed allora, per accertare se il suo
comportamento è soltanto finzione e ipocrisia, basta metterla alla prova nel momento
del bisogno:
54
-l'amicu 'ntò bisognu si vidi s'è nu bonu amicu (l'amico, se è vero amico, si riconosce
nel momento del bisogno). Ed allora quale è il comportamento da tenersi se ci si
accorge che l'amicizia della vicina non è sincera?
-A parenti che non ti duna e 'a vicina che non ti presta, fuj ili comu 'a pesti (la parente
che non ti da e la vicina che non ti impresta, foggile come se si trattasse di peste).
L'amicizia si è, infine, trasformata in odio:
-di l'amici mi guarda Dio, cà d'i nimici mi guardu io (degli amici mi guardi Iddio,
perché dei nemici mi so guardare da solo). Era normale che si invitasse qualche
amico a casa propria, specialmente nelle lunghe e rigide sere d'inverno, o nelle serate
d'estate, nei momenti di riposo dopo le pesanti giornate passate nei campi, per stare
un pò assieme mangiando e bevendo, ma era altrettanto normale che l'amico non
dovesse approfittare, presentandosi al "convivio" "cu na mami davanti e natra
d'arredu" cioè senza portare nulla, per cui era giusto parlare con chiarezza: "ah"
amicu toi pàrranci chjàru, pàrranci davanti e no d'arredu, cà d'arredu ti senti u culu".
Ecco il chiarimento;
- cani cumpari, si voi mu ti 'mbitu,.menti tu 'a carni ca' io menni 'u spini; menti tu u
pani cau mio èmucatu; mentita 'uvinucàu mio è acitu". (Caro compare, se vuoi che io
ti inviti, metti tu la carne perché io metto l'ospitalità; metti tu il pane perché il mio è
ammuffito; metti tu il vino perché il mio è aceto).
Si chiude questa breve rassegna di proverbi calabresi sulla amicizia con la spiritosa
immagine di un signore che vuole sganciarsi di una visita poco gradita:
-chjòvi, cumpari, e mali tempi fa, 'nt'a casa i l'atri mali si sta (Piove, compare, e fa
cattivo tempo, nella casa degli altri non si sta bene). E l'altro di rimando:
-no, cumpari, chjòvi e mali tempi fa, ma dint'a casa 'i l'atri borni si sta.(No, compare,
piove e fa cattivo tempo, ma dentro la casa degli altri si sta bene). E' necessario
recuperare questo patrimonio d'inestimabile valore, frettolosamente disperso dal
vento impetuoso della cosiddetta civiltà industriale, sul quale si resse, nel corso dei
secoli, la saggezza della civiltà contadina, incolta non per sua colpa, ma vivacemente
attenta e sensibile nel cogliere tutto quanto girava attorno ad essa.
55
Non possiamo assolutamente rinnegare il nostro passato e la cultura da esso
emergente, senza dovere conseguentemente rinnegare anche la nostra calabresità, in
quanto cultura di vita.
IL PERIODO PASQUALE A ROMBIOLO.
Nel nostro paese le funzioni pasquali creano un’atmosfera particolare con i suoi riti
tradizionali.
Il periodo quaresimale è inaugurato dalle funzioni del mercoledì delle ceneri,giorno
in cui si benedicono e si impongono le ceneri, simbolo della caducità di ogni creatura.
Partecipano nella chiesa di San Michele tante persone.
La settimana santa inizia con la domenica delle Palme, come
dappertutto,
caratterizzata dai ramoscelli di ulivo e dalle palme, intrecciate ed adornate con dei
nastri da persone esperte.
Grandi e piccini gioiosamente portano le palme in processione, a ricordo della entrata
solenne di Gesù in Gerusalemme.
IL lunedì, il martedì e il mercoledì santo, le nostre chiese rimangono aperte per
l’esposizione Eucaristica;
in questi giorni si celebrano i Precetti Pasquali dei bambini e degli uomini.
Questi sono, anche i giorni dedicati alle confessioni, poiché con il Giovedì Santo si
entra nel nucleo centrale delle funzioni.
La mattina del Giovedì Santo i parroci della nostra diocesi, si recano in cattedrale per
la messa degli olii.
Durante il pomeriggio, si celebra la messa in Coena Domini, la lavanda dei piedi,
(rappresentazione dell’ultima cena, con i dodici apostoli scelti tra i capo famiglia del
paese). In questa occasione, proprio per ricordare l’ultima cena, vengono distribuiti i
panini benedetti ; inoltre, è usanza preparare delle ceste contenenti l’uovo di pasqua,
l’agnello, e “i campanari” (pagnotta o dolce pasquale guarnito di uova), per essere
benedetti e portate sulle nostre tavole giorno di pasqua.
56
Nella messa sono consacrate due ostie grandi, oltre le piccole per la comunione dei
fedeli; l’una serve per la comunione del celebrante, l’altra è portata con solenne
processione ad una cappella, addobbata in modo speciale, dove col calice che la
contiene viene deposta in un tabernacolo, al quale si dà il nome di sepolcro, allestito
con i giardini di Adone (vasi nei quali si fanno germogliare al buio grano, legumi
diversi, innaffiati ogni due giorni). Le piante crescono rapidamente, se ne legano
insieme i germogli con dei nastri e si mettono i vasi sulla tomba di Gesù morto, il
venerdì santo.
In questo giorno, non si celebra la messa propria ma si ha solo una cerimonia, che
vien detta messa dei presantificati, cioè dell’ostia consacrata il giovedì santo,
comunemente detta “a missa a storta”, in cui si fa l’adorazione ed il bacio della croce.
Il venerdi santo è caratterizzato da un’atmosfera particolare, in effetti in questo
giorno le nostre chiese hanno dei segni particolari (non sono illuminate, sono senza
fiori, non si trova l’acqua santa nelle acquasantiere, non si suonano le campane, ma
per le vie del paese si passa con la cosiddetta “troccula” ( battola di legno usata in
sostituzione delle campane).
In serata viene fatta la via crucis per le strade del paese, accompagnata da diversi
canti pasquali, tra i quali “la passione del Signore” , “Evviva la croce”.
Nelle frazioni di Moladi e Pernocari si svolge la cosiddetta “chiamata della Beata
Vergine Maria Addolorata”.
Ogni anno nelle diverse frazioni viene fatta la Passione vivente, rappresentazione
sacra delle ultime ore di vita di Gesù.
Le prime ore del Sabato, sono scandite dal suono del tamburo scordato, che
preannuncia l’accompagnamento al calvario di Gesù morto posto sulla varetta ,
assieme a Maria , e San Giovanni.
La sera del sabato santo viene fatta la solenne veglia in “Resurrectione Domini”, col
canto del “Gloria” e il suono delle campane che annunciano con toni di giubilo che il
Signore è risorto.
57
Il giorno più atteso è la domenica, dopo la solenne messa si svolge la “affruntata” ,
ovvero una cerimonia religiosa, che avviene nel seguente modo: la statua del Cristo
Risorto , parte dalla chiesa madre, portata a spalla da alcune persone vestite di bianco
, e seguendo un percorso prestabilito, si avvia verso la chiesa del Rosario. Di qui
coperta da un velo nero, esce la statua della Madonna per andare incontro a Gesù ,
avendo saputo da S. Giovanni , che suo figlio era risorto. Il ruolo di S. Giovanni è
importante, in effetti è colui che fa si, che avvenga questo incontro faccia a faccia tra
madre e figlio, da qui appunto il nome “affruntata”.Tale incontro avviene in via della
Repubblica. I tempi vengono calcolati e controllati in modo che, non appena appare
la statua di Gesù, quelli che portano la statua della Madonna e quella di S. Giovanni
,si mettono a correre. Appena di fronte, alla distanza di pochi passi, viene strappato il
velo alla Madonna, la statua viene abbassata in segno di ossequio a Gesù, volano le
colombe; poi con le statue affiancate si procede alla processione per le vie del paese
con la banda del paese che suona a festa.
Caratteristiche sono anche le tradizioni culinarie del pranzo pasquale: si cucina
l’agnello al sugo,e soprattutto i dolci tipici come le pie, (dolce casareccio fatto con
una sfoglia di pasta dolce, adattata a contenere un impasto di mosto cotto denso, noci
trite e uva passa fatti poi, cuocere al forno), oltre alle colombe e alle uova di pasqua.
Le feste pasquali si concludono con il lunedì di pasquetta o Galilea, scampagnata in
luoghi turistici della zona con amici e parenti.
Le diverse associazioni.
Associazione culturale “Musica insieme”.
L’associazione culturale Musica insieme è sorta il 16 luglio 2001 per iniziativa di un
gruppo di persone che hanno a cuore l’arte Musicale in ogni sua espressione; in
particolar modo quella della nostra terra di Calabria.
58
Attraverso di essa, quindi, si propone la valorizzazione del patrimonio artisticomusicale del nostro territorio e, allo stesso tempo, la diffusione della musica
sinfonica, operistica e corale polifonica.
Complesso bandistico “G. VERDI”
Città di Rombiolo
Il complesso bandistico Città di Rombiolo è il risultato di una evoluzione iniziata nel
1856, anno in cui mosse i primi passi.
Oggi si presenta con una rinnovata e coesiva organizzazione che gli permette di
ottenere apprezzabili risultati artistici.
Il messaggio di questo complesso si inserisce, con un nuovissimo cliché, nel contesto
bandistico generale, con l’esecuzione di coinvolgenti musiche moderne, classiche,
sinfonico-operistiche.
La direzione artistica è affidata al maestro Crudo Domenico, che con il suo carisma
ha saputo conservare la tradizione bandistica rimandatagli dai suoi predecessori.
A Rombiolo , la musica e l’arte in genere sono molto sentite, infatti come abbiamo
accennato ci sono due complessi bandistici, che animano le nostre feste patronali.
Importante è la presenza dei cori polifonici di “San Sebastiano”, e di “Don Raffaele
Lagadari”.
Il coro polifonico “SAN SEBASTIANO” di Pernocari si è costituito nel febbraio del
1996. La concertazione e la direzione sono state affidate fin dall’inizio, al maestro
Francesco Arena, ancor oggi guida del complesso vocale.
36
Inizialmente la struttura del coro era suddivisa in tre voci miste (soprani contralti e
baritoni)e si proponeva principalmente di eseguire i canti liturgici della Santa Messa,
nelle occasioni solenni.
In un secondo tempo, tramite la partecipazione di nuove voci (particolarmente
determinanti quelle maschili), l’organico ha potuto introdurre nel repertorio canti
“standard” a quattro e più voci. Il coro si è esibito con successo in pubbliche
esecuzioni in occasione di ricorrenze religiose e civili.
Il repertorio oggi consta di un cospicuo numero di brani, che spaziano dal sacro al
profano e dal popolare al folcloristico.
LA SCHOLA CANTORUM “Don Raffaele Lagadari” è una realtà, presente già da
oltre quarant’anni, sul nostro territorio.
Don Lagadari, il fondatore del coro , che porta appunto il suo nome, nel corso della
sua missione pastorale, ebbe modo di costituire diversi cori in parecchie città d’Italia.
L’ultima aggregazione è stata questa di Rombiolo, che ora è guidata dal nipote,
maestro Gregorio Lagadari , docente al conservatorio musicale di Vibo Valentia.
L’attuale formazione è composta da oltre trenta elementi. Il repertorio della Schola
Cantorum, spazia dal canto religioso per celebrazioni eucaristiche, agli spirituali ,
molto graditi dal pubblico dei concerti a cui partecipa, riscuotendo notevoli consensi
dalla critica. Numerosissimi sono i trofei e gli attestati di cui si fregia questa che è
ormai diventata un’associazione appartenente all’O.C.C. (organizzazione cori
calabresi).
Spesso si è esibita in concerto con l’orchestra d’archi dal conservatorio di Vibo
Valentia.
Oltre allo scopo culturale ed artistico riveste notevole importanza nella vita sociale
della nostra comunità.
FANFARA FIORITA detta pure “Banda pilusa”
36
Gli unici musicisti popolari pienamente in attività della zona, la famiglia Crudo di
Rombiolo, pur lavorando in modo continuativo per tutto l'anno e specialmente in
periodo estivo, con la loro Fanfarra, esplicano il grosso della loro attività
principalmente fuori provincia, nella zona della Piana e ancora verso Reggio Calabria
o Lamezia. La Fanfarra Fiorita si presenta anche esteticamente come una piccola
banda, con i componenti vestiti in un'unica uniforme, composta semplicemente da un
abito blu con berretto a visiera e camicia
celestina.
Anche
questa
cura
dell'abbigliamento è una innovazione rispetto alla normale pratica del suonatore.
Tuttavia, appare in ogni caso preferibile ai «vestiti da pastore», con ciocie e pelli di
pecora, con i quali alcuni zampognari effettuano la novena in periodo natalizio e con i
quali, purtroppo, vengono a volte richiesti «perché è più scenografico»!
I Crudo, inoltre, hanno provveduto a modificare sensibilmente tanto l'organico
tradizionale - composto da zampogna a chiave, pipita, cassa, rullante e piatti attraverso l'inserimento dapprima del clarinetto e poi del sassofono tenore, che
richiama parecchio una sonorità più «bandistica», quanto il repertorio con
l'introduzione di numerose marcette, melodie e temi di diversa origine, soprattutto dal
liscio e da canzoni del primo dopoguerra, e dai nomi improbabili.
Anche questo è un segno, da una parte, di una crisi, nel senso che non esiste più una
cultura musicale tradizionale diffusa in grado di giudicare la sonorità - i Crudo
adoperano delle zampogne campane, costruite in provincia di Salerno, dalla fattura e
dalla timbrica alquanto diverse da quelle «serresi», tradizionalmente in uso nella zona
- o la qualità delle sonate, del repertorio o della semplice accordatura, dall'altro, del
tentativo, peraltro legittimo, di rispondere ad essa attraverso una “modernizzazione”
dell’impasto sonoro e della proposta musicale.
Tutta l'area del Poro, secondo documentazioni e testimonianze, fino agli anni '40 si
presentava molto ricca di strumenti, di suonatori, di repertori e di stili di canto con un
panorama musicale articolato e diffuso in cui, grosso modo, sarebbe stato addirittura
possibile tracciare una «elettività» fra occupazione e strumenti: la lira per i mugnai, la
37
zampogna per i pastori, la chitarra e il mandolino per gli artigiani, nonché fra contesti
e repertori, con i vari canti di vendemmia, di mietitura, di ritualità, religiosi, etc.
Di tutto ciò oggi non rimane che qualche vago ricordo, per cui una ricerca rivolta
all'esistente e non al passato deve fare i conti con le trasformazioni intervenute e le
forme di sostituzione attuate. Premesso che tale evoluzione è da noi considerata del
tutto naturale e, in alcuni casi, addirittura necessaria, prima di vedere se e in quali
forme e contesti sia possibile una «ripresa» dell'attività musicale e, più in generale,
della cultura agro-pastorale nella zona, resta da risolvere una questione. Occorre,
cioè, capire perché il processo di trasformazione, avvenuto un po' ovunque, in alcuni
paesi o zone della Calabria non ha provocato nessuna dispersione, o solo
limitatamente, mentre nel Poro si è accompagnato ad una tanto radicale mutazione
del paesaggio sonoro che, in alcuni tratti, appare ormai come una vera e propria
tabula rasa.
In alcuni di questi paesi una minima continuità è stata affidata alle bande, alcune
delle quali di antica tradizione: quella di Rombiolo risale al 1856 e utilizzava, tra
l'altro, alcune rielaborazioni di materiale folklorico, mentre si sa che a Zaccanopoli la
banda ha in repertorio, da oltre cinquant'anni, una pastorale di attribuzione incerta,
anche se certamente d'autore, che viene regolarmente eseguita nel periodo natalizio.
A partire dal dopoguerra, poi, una consistente quantità di orchestrine, alcune delle
quali attive già dagli anni trenta e formate per lo più in ambiente artigiano, hanno
preso piede in quasi tutti i paesi del Poro, diventando protagoniste di gran parte degli
spazi e delle occasioni della socialità musicale e provocando un rinnovamento tanto
nel repertorio, con canzoni e balli «moderni» in voga nell'epoca, quanto nelle
sonorità,
con
l'adozione
di
strumenti
più
armonico/melodico e funzionali al nuovo gusto.
IL NEOCANTASTORIE DANILO MONTENEGRO
(Tratto dal libro “TRACCE”)
38
versatili
dal
punto
di
vista
Sono nato il 21/10/46 a Moladi di Rombiolo. La mia famiglia era una famiglia di
contadini vissuti sempre in campagna, e tanto mio padre quanto mio nonno erano
cantori popolari e suonatori di chitarra battente, inoltre mio nonno suonava la lira e la
sapeva anche costruire. All'epoca loro erano più o meno i "cantori" del paese, molto
richiesti per le serenate. Io ho parzialmente vissuto questa situazione accompagnando
mio padre; ricordo quando gli amici venivano a casa a chiamarlo per andare a
suonare o fare una serenata, lui era sempre disponibile. Aveva un certo talento
musicale e una bella voce, per questo era sempre al centro del gruppo, mentre gli altri
l’accompagnavano al canto facendo "u terzu" come si dice, ossia la terza voce e il
controcanto.
Oggi è praticamente impossibile trovare delle situazioni di polivocalità, ma ricordo
che all'epoca si cantava in modo diverso, con interventi di una seconda voce o con
momenti corali. Mia mamma cantava pure, ma i repertori erano diversi: le donne
cantavano principalmente in chiesa, oppure in alcuni momenti del lavoro in
campagna, dove la coralità era più sviluppata, mentre nel canto maschile c'era anche
l'elemento strumentale.
Questi miei ricordi risalgono agli anni cinquanta e sono legati alla mia infanzia, a
momenti vissuti con papà e nonno e a racconti della loro vita. Papà mi diceva che da
Calimera, paese dove è nato e vissuto per tutta la sua gioventù, si spostava in altri
paesi per lavoro fino a raggiungere, nel periodo estivo, zone del Crotonese e di questi
luoghi lui conosceva altri canti e modi di cantare.
Naturalmente il tempo per cantare e suonare, per loro, era durante il lavoro oppure la
sera tardi quando andavano a fare le serenate, ma spesso succedeva che venivano
sorpresi dai carabinieri e dovevano scappare poiché era vietato fare le serenate. Per
questa ragione erano perseguitati e una volta presi venivano portati in caserma e
picchiati duramente. Non riesco a capire questo accanimento repressivo per una
serenata, forse per evitare la comunicazione?. Fatto sta che nella vita pubblica di
allora esistevano questi divieti e per non subire gravi conseguenze o si evitava la
serenata oppure, alla vista dei carabinieri, si scappava a gambe elevate.
39
In questo ambiente mi sono cresciuto, assimilando la vocalità e la musica popolare,
imparando anche gli strumenti della tradizione. Di strumenti musicali a casa mia ne
circolavano diversi, dalla chitarra battente a quella francese, dall'organetto diatonico
alla fisarmonica ecc. La chitarra francese spesso veniva usata come la battente a
quattro corde e questa chitarra, la battente, mi ha molto affascinato dall'inizio per la
sua particolare sonorità. Per questa singolare attrazione decisi di impararla per cui
mio padre mi insegnò l'accordatura, gli accordi e in particolare l'uso della mano
destra che era determinante per il ritmo e il suono continuo. All'inizio mi era diffìcile
l'uso della mano destra ma piano piano e col tempo sono riuscito non solo ad
acquisire il meccanismo ma a creare una tecnica personale adatta alle mie creazioni
musicali sviluppando, inoltre, altri accordi che nell'uso popolare non esistevano
poiché i suonatori di chitarra battente, come anche mio padre e mio nonno, ne
conoscevano due o tre; insomma sapevano gli accordi che permettevano loro di
accompagnare serenate e tarantelle.
E' stato talmente forte il fascino verso la chitarra battente che decisi di utilizzarla
come strumento principale nel mio lavoro sulla musica popolare e dopo un pò di
tempo me ne sono costruita una, anzi due: una a fondo piatto, l'altra a fondo bombato
e con dieci corde (cinque doppie). Non conoscevo le tecniche di falegnameria né
tantomeno quelle specifiche della liuteria, tuttavia, alla fine, i risultati sonori, per quel
periodo, mi sono apparsi soddisfacenti, tant'è che una la usai normalmente per le mie
ballate durante i concerti.
A questo punto cominciai a studiare molto seriamente lo strumento, a sperimentarlo,
e vista l'esigenza mia professionale riguardo la resa tecnica dello strumento stesso,
pensai di farmi costruire una chitarra battente a dieci corde dai fratelli De Bonis.
Da questa esperienza famigliare mi è nato il desiderio di conoscere meglio e
approfondire il campo musicale ma in particolare capire l'aspetto sociale e politico
della cultura contadina, le condizioni, le amarezze e le sofferenze che venivano
esternate attraverso il canto, la musica e il ballo.
40
Erano i primi anni settanta quando cominciò la mia ricerca personale e la produzione
come autore di canti e musiche legati all'ambiente contadino e alle tematiche sociali
del mio tempo storico.
All'inizio nel repertorio c'erano anche dei pezzi imparati da mio padre, quelle che qui
chiamavano "canzoni ad aria", cioè un modulo sul quale venivano cantate la maggior
parte dei testi, anche se mio padre, avendo lavorato nella zona del crotonese, aveva
appreso lì dei moduli diversi, sotto alcuni aspetti più impegnativi, e me li faceva poi
ascoltare, provare, dandomi dei suggerimenti su come usare la voce e la chitarra
battente.
Nel settantasei ebbi la cattedra all'Istituto Statale D'Arte di San Giovanni in Fiore-CS
(dove poi nel 1981 mi sposai) e da qui cominciò la mia ricerca musicale più
determinante. Andavo nei paesi della zona ( Verzino, Savelli, Campana, Caccuri ecc.)
dove ho fatto alcune registrazioni e ho potuto meglio apprezzare le particolarità di
ogni stile diverso e tutto ciò è stato di notevole stimolo per me e la mia scelta
artistica, che in un certo senso è stata "una scelta di vita".
A questo punto decisi di iniziare la mia attività di cantastorie (con precisione di
neocantastorie), figura un po' atìpica nel panorama calabrese, a differenza di quello
siciliano. Premetto che né mio padre né mio nonno, pur svolgendo un ruolo sociale
per alcuni versi simile, erano cantastorie.
Io credo che non fosse proprio concepita, a livello culturale, la possibilità di fare il
cantante di mestiere, di vivere di musica come, per l'appunto, i cantastorie siciliani
che ogni tanto venivano anche qui da noi a farsi ascoltare. Allora si cantava durante il
lavoro, nella festa o nelle serenate, in situazioni più o meno "canoniche" in cui
l'attività del cantare e suonare era collettivamente condivisibile (salvo, ripeto,
incappare nei carabinieri), ma si trattava di spazi e momenti delimitati. In fin dei
conti quello che andava in giro con la chitarra e il carretto era considerato uno che
non voleva lavorare veramente, uno scansafatiche, e la sua una "occupazione" per
vagabondi.
41
Questa scarsa considerazione per la musica e per il musicista, in qualche modo
interna alla cultura popolare del Monteporo, credo abbia pesato anche nell'abbandono
di alcuni strumenti: la lira, ad esempio, che era presente a casa mia ma della quale
non avevo avuto notizia fino a circa venti anni fa, in quanto mio nonno non l'aveva
più adoperata. Infatti un giorno mi disse: «Sai, su' venuti certi 'i Catanzaru, ca vonnu
fatta a lira». Al che gli dissi: «Come, nonno, tu sai costruire la lira e non mi dicevi
niente! Ora la devi fare prima a me, e poi a loro!». Lui me ne promise una, ma poi
dopo pochi mesi morì. Sono venuto, quindi, a conoscenza di questa cosa in modo del
tutto fortuito, non per informazione diretta. Credo che sia abbastanza emblematico il
fatto che lui, pur essendo un "professionista" del canto popolare, non ritenesse
necessario comunicare a me, che ero estremamente interessato a tutto il suo sapere,
una conoscenza così importante. Purtroppo non ho mai più avuto il tempo di
approfondire questo aspetto con mio nonno, né con mio padre che nello stesso
periodo si trasferì in un altro paese più distante dal mio, con poche occasioni per
vederci.
L’atto di nascondere uno strumento musicale arcaico come la lira e di non dire
neanche di saperlo suonare, mi ha spinto a pensare che tale rifiuto venisse dal fatto
che usare uno strumento del genere significasse per loro, i suonatori, appartenere ad
un ceto sociale sottosviluppato, per cui si vergognavano di suonare uno strumento del
genere. Penso, quindi, che ciò è successo anche fra me e mio nonno.
Un discorso analogo si potrebbe fare anche per la zampogna, strumento usato soltanto
a Natale e suonato solo da "i pecurari", i quali in questa festività andavano in giro a
raccogliere soldi eseguendo, per le strade dei paesi, musiche natalizie: pastorali, nenie
ecc..
Io stesso sono stato molto ostacolato in famiglia quando decisi di dedicarmi in modo
quasi professionale alla musica. «Ma pensa a studiare, invece di perdere tempo!....»,
questo era l'incoraggiamento che mi veniva dagli stessi suonatori con i quali mi ero
cresciuto. La stessa cosa avveniva a scuola; infatti quando il direttore del collegio
dove ero stato mandato per studiare, (mio padre si era infortunato sul lavoro, e per tali
42
ragioni lo stato mi aveva concesso di stare in collegio gratuitamente per continuare
gli studi) si accorse che mi ero iscritto ad un concorso canoro, "D Cantagiro", venne a
farmi la stessa predica (combinazione, per tale concorso mi aveva preparato il
maestro Scalzo della banda musicale del collegio stesso). Ricordo solo un insegnante,
alle scuole medie, che avendo notato la mia predisposizione per il disegno e le arti
visive, mi incoraggiò a proseguire gli studi in ambito artìstico.
Infatti dopo le scuole medie andai a Reggio Calabria, e superati gli esami di
ammissione mi iscrissi al Liceo Artistico. Qui mi ritrovai quasi subito a cantare con i
complessi di musica leggera dell'epoca, e in qualche modo, con i guadagni di feste e
matrimoni, riuscivo quasi a mantenermi.
Ad una maturazione culturale artistica, coincisa con il passaggio prima all'Università
di Roma, facoltà d'architettura, dopo all'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria
sezione scenografia, ha corrisposto, poi, una maturazione anche musicale; per tale
motivo abbandonai la musica leggera "riscoprendo" la musica popolare. Mi sono così
riavvicinato a mio padre, stavolta proprio per apprendere e ho quindi ripreso a
studiare a fondo la chitarra battente, e l'armonica a bocca che ha la stessa scala dell'
organetto diatonico e in più potevo suonarla contemporaneamente alla chitarra, etc.
In questo senso il mio percorso non è stato lineare e diretto, alla musica popolare
sono "ritornato" dopo avere subito una maturazione umana ed artistica e soprattutto
dopo una presa di coscienza sociale e politica che mi hanno spinto a "rivendicare" la
cultura e la musica delle classi subalterne, e particolarmente del mondo contadino dal
quale provenivo.
Da questo punto di vista nel mio lavoro c'è sempre stato ben poco "folk revival", la
riproposta dei canti che avevo imparato sul campo, ma da subito ho sentito la
necessità di elaborare, comporre e quindi esprimere la rabbia e l'indignazione che
sentivo dentro (quando pensavo che una raccoglitrice di ulive, anno 1965, per una
giornata fatta di dieci ore circa prendeva massimo millecinquecentolire, so io cosa
scattava dentro di me).
43
La figura del cantastorie era quella che mi consentiva di mettere a frutto e di fondere
insieme le mie conoscenze nel campo artistico, visivo e quelle musicali.
Di non secondaria importanza è stata l'esperienza teatrale e anche di teatro popolare,
condotta a Cosenza sotto la regia di Ennio Scalercio, che mi ha intuito e quindi
stimolato molto a riprendere il canto popolare. La compagnia si chiamava "II
Quartiere - Gruppo Teatrale di Intervento Politico", che non ebbe vita troppo facile
proprio a causa dell'impegno molto marcato, ma ha rappresentato, per me, una spinta
molto forte all'avvio della mia carriera. Con loro ho collaborato come attore-cantante,
componendo delle musiche che venivano integrate nello spettacolo teatrale, sempre
caratterizzato da una forte connotazione sociale. Contemporaneamente iniziai a
mettere insieme un mio programma di canti, tra quelli che avevo raccolto sul campo e
quelli miei, ma questa forma parziale di riproposta durò solo un anno in quanto, da
subito, preferii indirizzarmi sulla figura del cantastorie che mi dava maggiore libertà
espressiva e di contenuti.
Cominciai a girare per le piazze dei paesi per le feste dell'Unità, ma un po' per
praticità e un po' per sperimentazione, cominciai a sostituire i quadri con le
diapositive dei quadri stessi perché molto più funzionale per mettere insieme il visivo
e il sonoro. Di questo periodo, prima metà anni settanta, sono i miei primi testi e non
saprei dire cosa nasceva prima, se l'immagine che poi diventa quadro e poi la ballata,
o viceversa.
Credo di essere stato all'avanguardia, perlomeno in Calabria, nell'affrontare
determinati temi, non solo di carattere politico, sociale, ecologico, ma anche umano,
esistenziale. Canzone come "Palumbelli mei", "Oh figghju mio", che affrontano il
tema dei condizionamenti nell'infanzia, o del senso della vita stessa, sono in parte
autobiografiche e mi sono state ispirate anche dall'esperienza personale (ricordo
questa mia nonna patema, vestita di nero, cantare sempre sulla mala sorte dei figli)
quanto dalla riflessione anche sul modo in cui a livello popolare veniva affrontato il
senso del destino, dello stare nel mondo e di porsi nei confronti delle difficoltà e delle
44
avversità. E assieme a questi canti ce ne sono tanti altri come "Vogghju gridari, " 'Nu
jornu", "Mani tosti", "Sciogghji lu gruppu", "Cercu largu", ecc., dove emergono temi
sociali come l'emigrazione, l'ecologia, o il condizionamento e la limitazione dello
spazio psico-fisico dell'uomo.
Il mio modo di dipingere riflette la stessa tensione e lo stesso impegno che metto
nella musica. Ho rifiutato la strada del commerciale e delle gallerie d'arte perché
avrei dovuto accettare i compromessi e le imposizioni del mercato stesso, limitando e
condizionando molto la mia libertà di espressione, esattamente come mio padre e mio
nonno che mal sopportavano i soprusi dei padroni o chi per loro, spesse volte
pagando di persona con il licenziamento, le persecuzioni. E' vero, avrei preferito fare
il musicista di professione, ma purtroppo in Calabria è praticamente impossibile
riuscire a vivere e a mantenere una famiglia solo di questo. Insegnare arte nella
scuola è stata certamente una scelta piacevole perché mi tiene a contatto con centinaia
di giovani in una attività comunque creativa e non separata dai miei interessi
fondamentali, ma soprattutto perché mi da una tranquillità economica e quindi una
sicurezza per il sostegno della famiglia. Inoltre mi permette di mantenere
integralmente tutto ciò che intendo creare e proporre con la pittura, la musica e la
parola, senza nessun tipo di condizionamento o imposizione.
La scelta di fare questa musica, di cantare il mondo popolare è stata ad ogni modo
una scelta difficile, controcorrente. Per tanti anni ho fatto il cantastorie solitario,
ascoltato solo da poche persone ma sensibili e interessate a questo tipo di
personaggio. Oggi invece mi propongo anche con un gruppo composto da ottimi
musicisti pure professionisti, provenienti da altri generi musicali, la classica, il jazz, e
fra questi musicisti spesso c'è anche mia figlia Ilaria che per me è l'orgoglio più
grande. Segno questo che il messaggio è in qualche modo passato e quindi c’è una
maggiore attenzione e consapevolezza verso quelle tematiche e quei suoni che per
tanto tempo erano stati sottovalutati, tenuti volutamente in disparte.
L'ascolto, oggi, verso la mia musica è molto più attento ed interessato, sia dalle
persone adulte che dai giovani, anzi mi capita spesso di sentire proprio dai giovani,
45
dopo aver assistito ad un mio concerto, valutazioni e condivisioni molto positive. E
pareri positivi, per questa mia musica, anzi per questa proposta di spettacolo
musicale, mi vengono anche dalla critica, soprattutto da quella straniera. Oggi, infatti,
riesco a fare più concerti all'estero che qui in Italia o da noi in Calabria, nonostante i
diversi premi ricevuti e una tesi di laurea scritta su di me da un allievo
dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Massimo Lopez nel 1997, dal titolo
"Etnicità ed innovazione nel neocantastorie calabrese Danilo Montenegro".
46