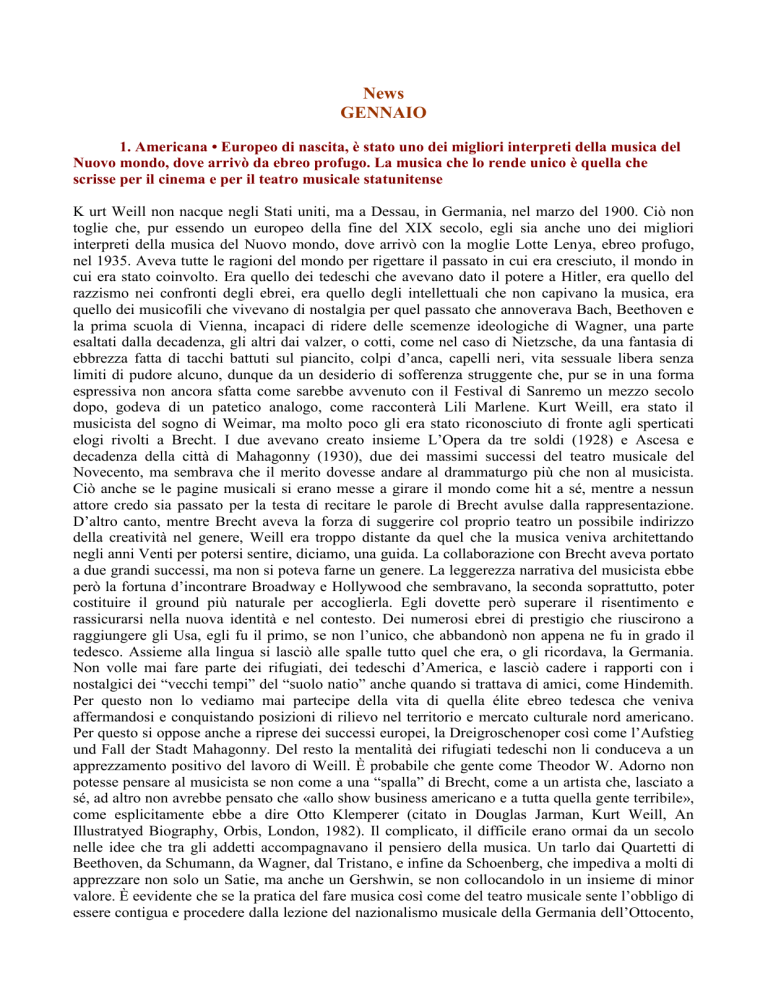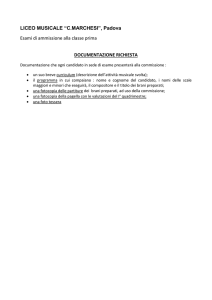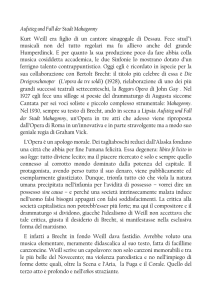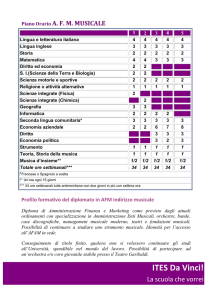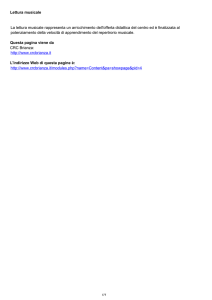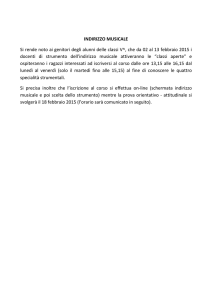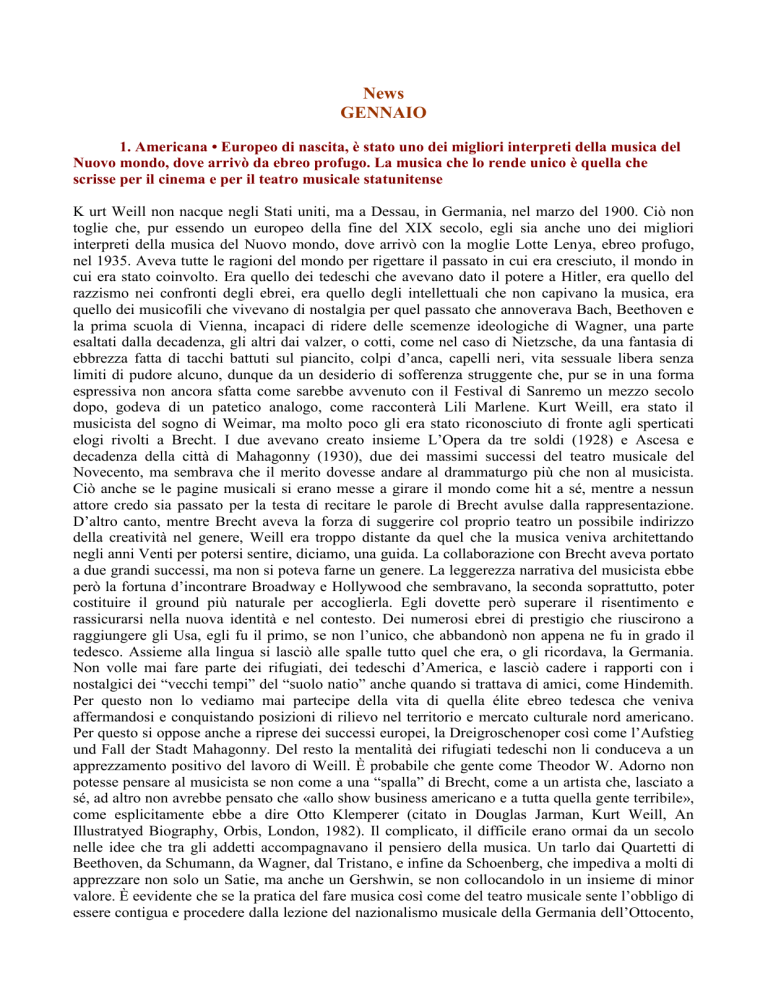
News
GENNAIO
1. Americana • Europeo di nascita, è stato uno dei migliori interpreti della musica del
Nuovo mondo, dove arrivò da ebreo profugo. La musica che lo rende unico è quella che
scrisse per il cinema e per il teatro musicale statunitense
K urt Weill non nacque negli Stati uniti, ma a Dessau, in Germania, nel marzo del 1900. Ciò non
toglie che, pur essendo un europeo della fine del XIX secolo, egli sia anche uno dei migliori
interpreti della musica del Nuovo mondo, dove arrivò con la moglie Lotte Lenya, ebreo profugo,
nel 1935. Aveva tutte le ragioni del mondo per rigettare il passato in cui era cresciuto, il mondo in
cui era stato coinvolto. Era quello dei tedeschi che avevano dato il potere a Hitler, era quello del
razzismo nei confronti degli ebrei, era quello degli intellettuali che non capivano la musica, era
quello dei musicofili che vivevano di nostalgia per quel passato che annoverava Bach, Beethoven e
la prima scuola di Vienna, incapaci di ridere delle scemenze ideologiche di Wagner, una parte
esaltati dalla decadenza, gli altri dai valzer, o cotti, come nel caso di Nietzsche, da una fantasia di
ebbrezza fatta di tacchi battuti sul piancito, colpi d’anca, capelli neri, vita sessuale libera senza
limiti di pudore alcuno, dunque da un desiderio di sofferenza struggente che, pur se in una forma
espressiva non ancora sfatta come sarebbe avvenuto con il Festival di Sanremo un mezzo secolo
dopo, godeva di un patetico analogo, come racconterà Lili Marlene. Kurt Weill, era stato il
musicista del sogno di Weimar, ma molto poco gli era stato riconosciuto di fronte agli sperticati
elogi rivolti a Brecht. I due avevano creato insieme L’Opera da tre soldi (1928) e Ascesa e
decadenza della città di Mahagonny (1930), due dei massimi successi del teatro musicale del
Novecento, ma sembrava che il merito dovesse andare al drammaturgo più che non al musicista.
Ciò anche se le pagine musicali si erano messe a girare il mondo come hit a sé, mentre a nessun
attore credo sia passato per la testa di recitare le parole di Brecht avulse dalla rappresentazione.
D’altro canto, mentre Brecht aveva la forza di suggerire col proprio teatro un possibile indirizzo
della creatività nel genere, Weill era troppo distante da quel che la musica veniva architettando
negli anni Venti per potersi sentire, diciamo, una guida. La collaborazione con Brecht aveva portato
a due grandi successi, ma non si poteva farne un genere. La leggerezza narrativa del musicista ebbe
però la fortuna d’incontrare Broadway e Hollywood che sembravano, la seconda soprattutto, poter
costituire il ground più naturale per accoglierla. Egli dovette però superare il risentimento e
rassicurarsi nella nuova identità e nel contesto. Dei numerosi ebrei di prestigio che riuscirono a
raggiungere gli Usa, egli fu il primo, se non l’unico, che abbandonò non appena ne fu in grado il
tedesco. Assieme alla lingua si lasciò alle spalle tutto quel che era, o gli ricordava, la Germania.
Non volle mai fare parte dei rifugiati, dei tedeschi d’America, e lasciò cadere i rapporti con i
nostalgici dei “vecchi tempi” del “suolo natio” anche quando si trattava di amici, come Hindemith.
Per questo non lo vediamo mai partecipe della vita di quella élite ebreo tedesca che veniva
affermandosi e conquistando posizioni di rilievo nel territorio e mercato culturale nord americano.
Per questo si oppose anche a riprese dei successi europei, la Dreigroschenoper così come l’Aufstieg
und Fall der Stadt Mahagonny. Del resto la mentalità dei rifugiati tedeschi non li conduceva a un
apprezzamento positivo del lavoro di Weill. È probabile che gente come Theodor W. Adorno non
potesse pensare al musicista se non come a una “spalla” di Brecht, come a un artista che, lasciato a
sé, ad altro non avrebbe pensato che «allo show business americano e a tutta quella gente terribile»,
come esplicitamente ebbe a dire Otto Klemperer (citato in Douglas Jarman, Kurt Weill, An
Illustratyed Biography, Orbis, London, 1982). Il complicato, il difficile erano ormai da un secolo
nelle idee che tra gli addetti accompagnavano il pensiero della musica. Un tarlo dai Quartetti di
Beethoven, da Schumann, da Wagner, dal Tristano, e infine da Schoenberg, che impediva a molti di
apprezzare non solo un Satie, ma anche un Gershwin, se non collocandolo in un insieme di minor
valore. È eevidente che se la pratica del fare musica così come del teatro musicale sente l’obbligo di
essere contigua e procedere dalla lezione del nazionalismo musicale della Germania dell’Ottocento,
continuando a osservarne i principi, essa non potrà partire dalla constatazione che tutto è ormai
cambiato poiché si è già sulla strada tracciata dagli strumenti della democrazia e delle
comunicazioni di massa. Hitler sa come rivolgersi al popolo, Adorno no. Ciò implica che Hitler ha
un seguito che Adorno non ha. Ciò non significa che quel che dice Hitler sia più sensato di quel che
dice Adorno, ma non significa nemmeno l’opposto, in linea di principio almeno, anche se il
giudizio pratico, cioè quello sintetico, afferma che è così. Senza somigliare in alcunché al criminale
nazista, Kurt Weill ha al pari di quello il senso di quel che piace alla massa. Anzi lo ha in maniera
autentica, perché mentre l’altro è costretto a imporre alla generalità la scelta che egli vuole, il
musicista non impone assolutamente nulla: va a segno perché convince con l’immediatezza. Ci
mette un po’ di tempo, ce lo dice la sua biografia, a scoprire come scrivere Speak low o The Saga of
Jenny, ma quando coglie il segno fa piovere sullo spettatore magiche canzoni che s’incastonano
splendidamente nel teatro o nei film per cui le scrive. Per sé, per la sua arte egli ha risolto un
problema che né Aldo Clementi, né Luciano Berio sono riusciti a risolvere, che consiste nello
scrivere una canzone irresistibile. Nella musica erede della vecchia Europa musicale sembra sia
stato difficilissimo, se non impossibile, cogliere la bellezza nell’immediato. Eppure è forse l’unica
vera bellezza, come sanno gli scienziati che appunto dicono “bella” o “elegante” una soluzione che
si offre come ovvia, che si palesa. È la bellezza della tragedia, quando accade quel che non poteva
che succedere così, ma è la bellezza anche di Rio Bo di Palazzeschi che risponde in questo modo al
pompierismo della passion rhétorique, ma anche alla poesiola con lacrimuccia incorporata. Se si
vuole un’analogia musicale, quanto detto suggerisce che si possano rivedere i certificati di qualità
ipotizzando che Kurt Weill con Listen to My Song, presa tra le tante come campione eccellente
della musica gebrauch, avesse voluto fronteggiare i wagneriani del primo Novecento oppure, perché
no?, Puccini. Il costume (o il malcostume?) del “latinorum” può essere una sonda per valutare la
conversazione epistolare tra Cage e Boulez, soprattutto diciamo a proposito del Quartetto
dell’ineffabile John, chiedendosi se un trattato di scienza della costruzione spieghi l’arte solo perché
il costrutto è senza scopi apparenti. Il riferimento a Kant è evidente, ma che cos’è «un fine senza
scopi»? Cos’è perseguirlo? Lo sgocciolamento di Pollock non ha certo complicazioni tecniche,
come non l’ha scrivere «…l’urlo dei manipoli… l’onda dei cavalli…», anziché «…il vento odo
stormir tra queste piante…», oppure «ma bouche s’accouple souvent à sa ventouse…».
Comunque le scienze non cercano il difficile; distinguono, se vogliono, tra quello che s’è capito e
quel che ancora resta oscuro, in quel che s’è capito fin dove e cercano cosa ostacoli, oggettivamente
o nelle ipotesi usate, l’ulteriore progresso della conoscenza. Nell’arte non c’è conoscenza, ma forse
ai taumaturghi piace metter lì difficoltà per chi voglia penetrare le loro cose. Magari anche la
difficoltà dell’apparente semplicità, di ciò che apparentemente è già del tutto risolto: Bach per
esempio. Il quale del resto è tutto risolto, sicché i problemi nascono dalle ipotesi del fare le sue cose
un po’ più così o cosà, magari con strumenti elettronici o con un ensemble di armoniche a bocca. In
definitiva è come con qualsiasi musica baciata dall’immediatezza. Quanto al resto, la cui presenza si
ritiene d’avvertire nelle opere d’arte, è quello di cui, se il fine è di conoscere, non si può dire nulla;
se poi si tratti di quelli che sono comunemente pensati come valori trascendentali, se la loro
svalutazione sembrasse qui in atto, chi avesse a rammaricarsene pensi alle offese per mano
dell’integralismo e si chieda se il tema le giustifica. Una questione che è ancora tutta da discutere:
se gli eredi di Beethoven siano i Bang on a Can o gli alchimisti di Darmstadt.
In fondo, anche Weill è stato vittima di un integralismo, quello del primato della krante musika
tetescha, la cui traccia si scorge persino in chi lo apprezza per quel po’ di musica da concerto e le 2
Sinfonie scritte negli anni Venti, qualcosa di ancor prima che si mettesse a studiare composizione
con Busoni. Non è questa la musica che fa di lui un compositore unico, ma quella per il cinema e
per lo strano mondo del teatro musicale americano. Due generi che a Broadway e Hollywood hanno
finito col rigettare le basi individualistiche e personali della creatività allo spettacolo quale era stata
in Europa; due generi nei quali l’autore può anche perdersi, non ottenere la visibilità che conduce al
pubblico riconoscimento. Cenni a liberarsi dal peso e dall’autorità del compositore si manifestarono
col melodramma anche nell’Ottocento, ma non più che cenni; e un melodramma aperto, non tanto
privo di testo quanto tale per cui non sia mai questione di fedeltà o infedeltà al testo, non l’abbiamo
ancora visto. Naturalmente, la macchina industriale è la meno interessata a realizzarlo. Ma
allorquando le opere (i melodrammi) cominciano a dar segno di volersi ridurre agli hit che
contengono, quando la registrazione ci dà un’esecuzione che si limita ai punti salienti, perché
ostinarsi a non voler capire un compositore che si orienti a scrivere soltanto questi? Come non
capire Kurt Weill e con lui Waxman o Kosma o il Miles Davis di Ascensore per il patibolo? Il sopra
e il sotto non esistono più, se non funzionalmente o per violenza. Il sole allo zenith è sopra le nostre
teste, ma non sappiamo se queste siano più in alto del pavimento su cui stiamo, o più in basso.
Oltre a tutto ciò, è però necessario dire che Weill è stato acutamente sensibile a un problema che
chiameremmo tecnico. È un problema che un italiano nato nella prima metà del Novecento potrebbe
anche non aver mai avvertito ed è quello costituito dallo scontro con il realismo che è nei modi
d’espressione funzionali al melodramma. Chi non avverte come ridicolo che si percorra la vita
cantando, tra cene, duelli, discussioni anche banali, che cantando si derida qualcuno, lo si preghi, ne
si contrastino gli atti, è assuefatto al modo espressivo irreale del melodramma. Lo schema della
narrazione vuole che ciò fosse possibile perché in scena c’erano supereroi e divinità, ma ben presto
ci sono saliti pescatori e servette, ragion per cui, se non ci fosse una complicità, un’accettazione
dell’uso, dovrebbe scaturirne un rifiuto. Puccini non ha nessun problema: sulla sua scena salgono
anche i suoi simili; Wagner non è così temerario, ha bisogno di mantenere le distanze del
leggendario, dell’eroico, del mitico. Kurt Weill, arrivato negli Usa con alle spalle già un gran
bagaglio di cose fatte, quando mette mano a quel che diventerà Lady in the Dark, il suo vero primo
successo nel Nuovo mondo, discutendone con Moss Hart, nel vecchio linguaggio il librettista, e può
darsi anche con Ira Gershwin, coinvolto come specialista nei testi delle canzoni (è un prodotto della
divisione del lavoro e della rifinitura specialistica che orienta al lavoro di équipe per produrre uno
show, come se Rossini e gli altri avessero potuto giovarsi di un cabalettista), arriva alla conclusione
che il mondo dei sogni di Liza Elliot, la Lady, non è in dark perché veste di nero – anche se può
farlo – ma perché la sua mente è nell’oscurità per cui ella ricorre allo psicoanalista, e che questo
mondo sia quello contornato e immerso nella musica, mentre quello della commedia, in situazioni
che diciamo normali, sarà un mondo nel quale si parla, più o meno come comunemente avviene.
Ci si può domandare se in ciò ci sia una nascosta ipotesi sulla malvagità della musica, sulla sua
invasione ottenebrante, come chiaramente dichiarato da Platone un venticinque secoli fa. Sta di
fatto che qui la musica non è terapia al dolore, com’era in Rossini, in Donizetti, almeno per quel che
riguardava la scena. Funziona benissimo il marchingegno weilliano per questo testo. Ma non si
tratta sempre di avere di fronte a sé personaggi scissi tra realtà e fantasia, o delirio, o sogno.
Tornando a un lavoro in due atti, un’altra opera, Street Scene, questa volta con libretto di Elmer
Rice e canzoni di Langstone Hughes (guarda dove vanno a finire le Sputacchiere d’ottone), non gli
offre la stessa possibilità di separare due mondi, sicché Weill se ne torna verso la tradizione,
giocando con gli strumenti teatral-musicali ch’erano stati a disposizione anche per Carmen e per
Porgy and Bess, ricavandone un insieme nel quale i pezzi solistici s’integrano benissimo nel
tessuto, ma s’avvalgono di situazioni particolarmente favorevoli all’artificio, come per esempio il
ballare. Ne esce per esempio un boogie cantato e ballato, che è alla chiusura del primo atto, che
stranamente soffre della poca distanza, non scorre liscio come i balletti rosa, o della sfumatura di
colore che preferite, del duca di Mantova o di altri manichini del teatro d’opera. Bene! A quanto
pare per la Lady Weill s’era dato in seguito questa giustificazione: “un dramma parlato, interrotto
da tre opere in un atto di circa 2 minuti l’una di durata”. Qui non trova il grimaldello, ma non c’è
niente da giustificare. Si è tranquillamente scivolati in quello che per molti è un altro genere, la
commedia musicale o musical, col che si accoglie lo iato che rende incommensurabile una sinfonia
dell’Ottocento europeo con una della metà del Novecento Usa. È una questione che è tutta ancora
da discutere: se gli eredi di Beethoven siano i Bang on a Can oppure gli alchimisti di Darmstadt.
Dopo Street Scene (1947), Weill farà a tempo a darci soltanto la modesta Love Life (1948) e
l’appassionante Lost in the Stars (1949). L’anno successivo morirà all’inizio di aprile, all’età di 50
anni, 1 mese e 1 giorno. Sua moglie e l’interprete di tanti suoi personaggi, Lotte Lenya, la
rivedremo nella scena dell’albergo veneziano in Dalla Russia con amore.
2. Oggi sembra essere politically correct superare la distinzione tassonomica tra i generi
leggera/pesante, classica/contemporanea e così via, in nome della buona musica. Ma, si chiede
lo studioso Edward Docx, «come si fa a distinguere la spazzatura da ciò che non lo è?»
È una ovvietà affermare che stiamo vivendo un periodo di grande mutamento: nel giro di pochi anni
le tecnologie informatiche hanno completamente modificato le nostre vite, le modalità di
comunicare e di lavorare, e nel campo più specifico della cultura e delle arti è in corso una profonda
rimessa in discussione dei valori. Da tempo si è assistito all’insorgenza di un fenomeno che i
sociologi hanno definito Post-modernismo, i cui primi segnali erano chiari già all’inizio degli anni
’60, ma che oggi è divenuto globale, anche se qualcuno già ne intravede il tramonto, come lo
studioso Edward Docx in un suo importante articolo dal titolo “Postmodernism is dead”. L’autore
vi sostiene che il Postmoderno «(…) ha cercato di eliminare ogni sorta di privilegio (…) e di
sconfessare il consenso del gusto», di «(…) destabilizzare le pietre miliari moderniste dell’identità,
del progresso storico e della certezza epistemica», e che «(…) di conseguenza, svanisce
completamente il concetto di una visione unica del Mondo, di una visione predominante (…) tutte
le interpretazioni convivono, e sono tutte su uno stesso piano». Per quello che riguarda le arti, Docx
giunge alla conclusione che «Col passare del tempo (…) una mancanza di fiducia (…) ha permeato
la cultura e pochi si sono sentiti sicuri o esperti a sufficienza da riuscire a distinguere la spazzatura
da ciò che non lo è. Pertanto, in assenza di criteri estetici attendibili, è diventato sempre più
conveniente stimare il valore delle opere in rapporto ai guadagni che esse assicuravano».
Partiamo dunque da queste parole di Edward Docx per una riflessione inevitabilmente sommaria e
personale: anch’io, come tutti, osservo la vicenda mentre si svolge, e solo in futuro si potrà avere
una visione chiara dell’orizzonte nel quale ci troviamo in questo momento storico. Ma è legittimo
almeno porsi la domanda: cosa sta cambiando nel nostro modo di fruire la musica? Come «riuscire
a distinguere la spazzatura da ciò che non lo è»? Oggi, grazie alla tecnologia che riduce al minimo o
annulla le distanze temporali e spaziali, siamo immersi in una pluralità di linguaggi musicali, dai
più semplici ai più complessi, tutti contemporaneamente ed ugualmente disponibili. È un fatto
enormemente positivo che mette a disposizione di tutti, come mai prima nella storia, un patrimonio
di molti secoli di musica, dall’antichità alle mille espressioni della contemporaneità. E non è solo
questo: chiunque, con poca spesa, può acquistare le tecnologie con le quali farsi egli stesso
compositore, e diffondere poi la sua musica in rete, senza passare dai canali istituzionali
dell’educazione e della distribuzione musicale. Credo che oggi vi siano al mondo più compositori
attivi (professionisti e non) che in tutta la storia precedente. Ma questo diluvio di musica – lo ripeto,
molto positivo – porta forse con sé anche un certo appannamento nei criteri di giudizio, e una certa
confusione nel discernimento tra linguaggi più specificamente centrati sulla “ricerca” e linguaggi
più market oriented. La distinzione tra musicisti di professione e musicisti per passione si è fatta più
labile: i secondi sono infinitamente più numerosi dei primi, ma non meno presenti in rete, a volte
con esiti ben più interessanti dei primi. Mille ibridazioni (contaminazioni, dicono alcuni con brutto
neologismo) di ogni genere nascono, spesso senza tener conto dell’origine e della struttura
intrinseca dei linguaggi interessati, dando luogo nella maggioranza dei casi – è la mia personale
opinione – a clonazioni senza vere radici né senso profondo. Chi fruisce della musica con maggiore
consapevolezza o interesse avverte perciò la necessità di elaborare strumenti di giudizio più aderenti
al nuovo contesto, e cerca come può di tracciare nuovi confini per orientarsi in un territorio
musicale che sembra averli persi (ah, la mappa e il territorio!). La tassonomia ritorna quindi
d’attualità, innanzitutto nella distinzione tra “generi” musicali. Come si distingue la musica
“d’Arte” (o Colta, o Forte, secondo la lezione di Quirino Principe) dalle altre musiche? Ha ancora
senso parlare di musica Classica riguardo a composizioni per orchestra o per ensemble (con archi,
fiati etc.) scritte oggi? È sufficiente aggiungervi l’aggettivo Contemporanea? E dall’altro lato, ha
senso definire Leggera, Commerciale, di Consumo tutta la musica non sinfonica o cameristica,
mettendo così nella stessa cesta prodotti raffinati, frutto di ricerca pura, insieme a merci concepite
industrialmente in serie per il grande mercato del consumo di massa? Già Leonard Bernstein, nei
suoi famosi Young People’s Concerts con la New York Philarmonic Orchestra, si era posto alcune
di queste domande: e dopo aver preso atto che ogni definizione di musica “seria” o “d’arte”
risultava imprecisa (inclusa quella di musica Esatta, per indicare quella scritta in ogni dettaglio in
partitura dall’autore) si limitava prudentemente a circoscrivere tra la metà del XVIII e la metà del
XIX secolo quella parte del repertorio che si può definire con pertinenza musicologica Classica.
In questo quadro già complesso si inserisce poi la querelle intorno alle musiche di oggi, in tutte le
diverse accezioni e correnti che conosciamo, tra reciproche accuse di snobismo intellettuale versus
appiattimento sul gusto di massa e logiche commerciali. Così, mentre qualcuno considera ancora
contemporanee delle composizioni scritte all’inizio del secolo scorso (la Seconda scuola di Vienna,
per capirci!), basta visitare uno qualsiasi dei social networks o dei siti di interesse musicale per
accorgersi che l’aria è veramente cambiata: le nuove generazioni, nate con lo smartphone e l’Ipod in
mano e musicalmente onnivore, vedono ormai l’esperienza delle Avanguardie del XX secolo come
un dato ampiamente storicizzato. Lontane anagraficamente da quella temperie culturale, lo
giudicano senza alcun timore reverenziale, apprezzando le opere che sembrano poter resistere
all’ingiuria del tempo ma anche condannando, a volte con grande asprezza, l’eccessivo
intellettualismo di altre e la loro distanza dal dato propriamente musicale e dalle possibilità di
apprezzamento da parte di un più vasto pubblico. Va detto che quello dell’Avanguardia era, pur con
tutte le sue contraddizioni, senza dubbio un pensiero forte, nato da particolari condizioni
storico/sociali: e non stupisce che oggi subisca il logoramento conseguente all’avvento del
postmodernismo (che io considero in qualche modo un Pensiero debole). Ma è giusto che le cose
evolvano, e ha torto chi di fronte a tale fenomeno si attarda nella acritica ripetizione di esperienze
ormai al tramonto (..Signora mia, non ci sono più le avanguardie di una volta!). Ogni generazione
tende a preservare i valori entro i quali si è formata, ed è comprensibilmente umano tracciare
confini a difesa del proprio territorio conosciuto; ma è indispensabile anche avventurarsi in acque
meno sicure per poter intravvedere i semi di possibili futuri capolavori. La disputa si svolge, oggi
come 60 anni fa, intorno a categorie risorgenti ciclicamente, quali “comunicazione”,
“comprensibilità”, “Bellezza”: parola, quest’ultima, che le avanguardie della metà del ’900 si
astenevano tutto sommato saggiamente dal pronunciare riguardo ai propri obiettivi estetici, facendo
tesoro della lezione di Ludwig Wittgenstein secondo il quale “Su ciò di cui non si può parlare, si
deve tacere”; mentre oggi torna in auge e viene rivendicata da alcuni Laudatores temporis acti come
se fosse un diritto socialmente garantito: il “diritto alla Bellezza”. Non che io abbia qualcosa contro
la Bellezza, ovviamente, e non intendo assolutamente polemizzare: ma mi pare che sia un concetto
troppo soggettivo, e che ispirarsi a queste vaghe categorie del Romanticismo per farne un manifesto
un po’ revanscista “di opposizione” sia intellettualmente arrischiato: del resto, nessuno desidera
ascoltare musica “brutta”, nemmeno chi si stordisce di decibel nei Rave parties. Poi ci sono i
problemi creati, consapevolmente o meno, dalla Politica che nell’inseguire il consenso
dell’elettorato accresce la confusione: non possiamo dimenticare che nel nostro paese – capace di
scelte assai “originali” nel campo delle politiche culturali! – è stata proprio la Politica, nella
persona del Ministro dei Beni Culturali del primo Governo Prodi, a conferire dignità istituzionale
alla sé-dicente Musica Contemporanea Popolare, un universo di “generi” musicali – dai più
schiettamente commerciali fino a quelli con propensione verso una allure classicheggiante o “colta”
– che in precedenza erano genericamente catalogati come musica “leggera”, “canzone d’autore”,
“pop” e così via. Ho avuto modo di toccare con mano l’incompetenza e la superficialità della
visione della nostra politica in materia musicale quando ho sentito uno di loro affermare
pubblicamente con sicumera che «Non esistono i generi musicali, ma soltanto buona musica o
cattiva musica. Claudio Abbado e Bruce Springsteen per me sono uguali». Con tutto il rispetto per
Springsteen, una simile banalità lascia senza fiato, ammetterete. Ed eccoci quindi al punto
conclusivo, che mi pare decisivo. Rileggiamo la frase finale di Docx: «in assenza di criteri estetici
attendibili, è diventato sempre più conveniente stimare il valore delle opere in rapporto ai guadagni
che esse assicuravano». In altre parole, molte volte pare che il metro di giudizio di un’opera
musicale dipenda oggi più dal consenso popolare che essa è capace di suscitare, in termini di fans
affezionati, biglietti e dischi venduti, piuttosto che dal suo intrinseco valore compositivo.
L’influenza delle logiche di marketing (mediatico ed economico) ha pervaso ormai capillarmente
ogni settore della musica, modificandone in profondità le attitudini. Già prevedo la giusta
obiezione: anche Puccini e Verdi scrivevano per riempire i teatri, non certo (non solo) per delle
élites intellettuali, e ciò è certamente vero. Ma credo che possiamo trovarci tutti d’accordo almeno
sull’eccelso magistero artistico di questi due grandi. Comunque, se mai è esistita, è oggi forse
definitivamente avviata al tramonto la figura romantica dell’Artista che, chiuso nella sua bottega,
crea l’Opera seguendo esclusivamente il proprio bisogno creativo, senza alcun condizionamento
esterno. Rimangono ancora alcune enclaves che godono di protezione e sostegno statale, e
garantiscono ad alcuni happy few tale “immunità dal mercato”, ma ho l’impressione che tra 10 o 20
anni saranno riassorbite, anche se non glielo auguro affatto, beninteso. Ciò detto, non intendo
concludere con rassegnazione che siamo destinati a un futuro musicale senza qualità, prono
esclusivamente ai bisogni del Mercato. I nuovi grandi Maestri sono già qui tra noi, e stanno
lavorando mentre scrivo queste righe, ognuno col proprio stile e i propri strumenti intellettuali, per
preparare le opere e le interpretazioni che passeranno alla storia domani. Diamo loro fiducia,
ricordandoci sempre che quando «grande è la confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente».
3. ovvero come le Università americane scelgono i docenti di musica. Breve guida di un
insegnante italiano presso la Grand Valley State University, Michigan….
Il sistema universitario statunitense è disegnato in modo da equiparare tutte le lauree, che sono tre:
il baccalaureato, il master, ed il dottorato. La prima è di norma un corso di quattro anni, che consiste
in corsi di cultura generale e corsi specifici; la seconda è un approfondimento tecnico generalmente
della durata di due anni, alla quale segue il livello teoretico, chiamato dottorato, della durata
compresa fra i tre ed i cinque anni. È pertanto possibile conseguire una laurea di qualsivoglia livello
in ogni disciplina: dalle tradizionali, quali medicina, legge, ingegneria, alle professionali, quali
nursing (la laurea che gli infermieri devono possedere), a quelle artistiche: danza, pittura e scultura,
e musica. La democratizzazione delle discipline permette alla società americana di essere più
amalgamata, e di attribuire un valore al livello raggiunto piuttosto che alla percezione soggettiva
dell’utilità di una disciplina rispetto ad un’altra. Pertanto un musicista, un’infermiera ed un
ingegnere possono completare un qualunque gradino del corso di studi a seconda delle necessità e
degli obiettivi personali, arrivando anche a fregiarsi del titolo di dottore. Non sempre il mercato del
lavoro richiede la laurea di livello massimo. Il dottorato è però indispensabile in campo accademico
per ottenere il ruolo, e perché finalizzato alla ricerca e all’insegnamento universitario.
Le istituzioni di alta cultura offrono lauree di diverso livello. Ovvero, non tutte le istituzioni offrono
le stesse lauree. I Community College per esempio offrono l’Associate Degree, cioè il
completamento dei primi due anni di Baccalaureato. È tipico per i College offrire il Baccalaureato,
chiamato anche undergraduate degree. Esiste poi un numero più ristretto di università che offre i
corsi chiamati graduate, cioé il Master ed il Dottorato. Queste università tradizionalmente
completano la propria offerta con i corsi di Baccalaureato. Vi sono università statali e private. La
distinzione non si basa necessariamente sulla provenienza dei fondi, e varia da stato a stato. Ogni
istituzione segue una propria filosofia. Vi sono istituzioni di ricerca, istituzioni di arti liberali,
istituzioni affiliate a varie denominazioni religiose ed altre ancora. Le istituzioni determinano
liberamente il settore o settori nei quali essere piu’ presenti sul mercato, sviluppando corsi di laurea
sulla base di fattori storici, geografici, sociali, ed economici, e scegliersi il personale docente
autonomamente, secondo le proprie specifiche esigenze didattiche. Ecco come funziona la ricerca
del personale docente. Una volta stabilita la necessità di dover assumere un insegnante di
strumento, l’istituzione pubblica il bando su giornali specializzati. Nel bando sono descritte le
qualifiche e l’esperienza che il candidato deve possedere, i corsi che il candidato dovrà insegnare, le
caratteristiche che il candidato può non possedere ma che sarebbero desiderabili, e la procedura per
presentare domanda. Nel bando viene anche chiarito se la cattedra è temporanea, annuale,
rinnovabile, su percorso di ruolo (tenure-track), ed il massimo rango offerto. Questi ultimi elementi
sono fattori di non poco conto perché possono influenzare, anche se parzialmente, il compenso ed il
rango iniziale. I candidati interessati devono presentarsi attraverso una cover letter indirizzata alla
commissione esaminatrice, nella quale rispondono al bando e spiegano come la propria esperienza
didattica, artistica e professionale, sia tale da raccomandare la propria candidatura per la cattedra
disponibile. Spesso alla domanda deve essere allegato un transcript, cioé un certificato di laurea;
delle lettere di referenze o una lista di referenze; una registrazione recente; ed un curriculum vitae,
cioé un elenco della propria attività professionale. La commissione esaminatrice è formata da
docenti del dipartimento; è possibile che il direttore ne faccia parte; a volte comprende uno o più
membri dell’unità gerarchicamente superiore a quella del dipartimento o della scuola di musica, per
esempio il college. La procedura di selezione è monitorata dall’ufficio delle risorse umane
dell’università che verifica che tutte le leggi in materia di ricerca del personale siano state rispettate:
fra queste quelle sulle pari opportunità delle minoranze, quelle relative a discriminazioni su basi
diverse, quelle relative alle procedure. Una volta esaminate tutte le domande, per verificarne la
rispondenza ai requisiti minimi richiesti, la commissione restringe la propria attenzione ad un
numero selezionato di candidati, creando una short list. Le università sono interessate alla diversità
ed alla varietà. Pertanto il gruppo selezionato di candidati, pur essendo rispondente alle necessità
dell’istituzione, è rappresentativo delle varie realtà. Si pensi ad esempio ad un candidato giovane e
promettente, ma con poca esperienza didattica; e ad un candidato meno giovane i cui allievi già
insegnino in altre istituzioni. Non vi è nulla che vieti alla presenza di entrambi nella short list.
A questo punto la commissione procede con una serie di interviste telefoniche. A ciascun candidato
vengono sottoposte una serie di domande che mirano a comprendere meglio come questi saprà
inserirsi all’interno della struttura, con quali iniziative vorrà contribuire alla crescita dell’istituzione,
e con quale interesse si accinge ad iniziare il proprio lavoro presso l’istituzione dove ha presentato
domanda. Nella fase immediatamente successiva la commissione verifica le referenze, e seleziona
un gruppo molto ristretto di candidati, quelli le cui caratteristiche li rendano piu’ adatti alla cattedra
che dovranno ricoprire. Per un’intervista in loco è tipico invitare presso l’università due o tre
candidati finalisti. L’università si assume le spese di viaggio, vitto, e alloggio. Per il candidato è il
momento di verificare di persona se l’istituzione presso la quale potrebbe insegnare risponde alle
proprie aspettative. Normalmente la visita, della durata di un paio di giorni, prevede un incontro con
il direttore del dipartimento ed uno con il decano; un incontro informale con i docenti; un incontro
con gli studenti; un’intervista formale con la commissione selezionatrice, il direttore, ed altri
rappresentanti dell’istituzione. La parte tecnica prevede l’esecuzione di un concerto pubblico al
quale sono presenti la commissione, i docenti, gli allievi, e chiunque altro desideri partecipare. La
parte didattica normalmente consta di una masterclass, cioé una lezione pubblica a due o tre allievi,
e talvolta l’insegnamento di una lezione in un corso offerto dall’istituzione. Una serie di pranzi,
cene, e colazioni di lavoro con colleghi e membri della commissione, completa il programma della
visita. Durante queste interviste la commissione valuta le varie abilità del candidato, ed anche la
capacità di questi nel sapersi relazionare con studenti e colleghi. Terminate tutte le fasi della
selezione, la commissione esprime il proprio parere tecnico, viene trasmesso per via gerarchica a
chi ha il potere di prendere la decisione finale relativa all’assunzione. L’università a quel punto
invia una offerta di assunzione al candidato, delineando il salario, i benefici, ed il rango iniziale, che
sono negoziabili. Puo’ anche dichiarare la ricerca infruttuosa se nonostante tutto non si è trovato il
candidato ideale. O decidere di invitare un ulteriore candidato se nessuno dei precedenti si è rivelato
idoneo. Di norma il docente così assunto non passa automaticamente ed immediatamente di ruolo, a
meno che non sia specificato nel bando, cosa assai rara. Sulle cattedre tenure-track di norma vi è un
periodo di prova di sei anni. Durante questo periodo il docente, al quale viene offerto il rango di
Assistant Professor deve dimostrare di aver portato avanti attività didattica, professionale e di
servizio secondo i criteri stabiliti dall’università. Pazienza, lavoro di buona qualità, e perseveranza,
vengono puntualmente riconosciuti e premiati, con grande beneficio per la scuola e per gli studenti.
Questa procedura è meritocratica ed anche pratica. In questo modo si seleziona il candidato
migliore e più adatto alle esigenze dell’istituzione, eventualmente incontrandolo di persona,
sentendolo parlare, suonare, insegnare; ed osservandolo nell’interazione con gli allievi.
Per paragone, l’esatto opposto accade nei conservatori italiani. Nella maggioranza dei casi il
docente è selezionato sulla base di un esercizio di pura burocrazia. Il candidato deve fare domanda
utilizzando l’apposito modello, allegando uno specifico numero di documenti in originale o copia
autenticata, ovvero autocertificazioni. Egli deve poi spedire il tutto utilizzando determinati servizi
postali. La commissione non ha la possibilità di conoscere personalmente il docente e si deve
limitare ad assegnare un punteggio sulla base della documentazione allegata. Per alcuni tipi di
prestazioni o titoli il valore è prestabilito. Ad esempio, la commissione non ha discrezionalità nel
valutare un anno di insegnamento presso una prestigiosa universita’ estera o un piccolo
conservatorio di provincia, ed è obbligata ad assegnare il punteggio previsto dalle tabelle
ministeriali. I candidati acquistano il diritto di essere chiamati nell’ordine stabilito in graduatoria. È
il candidato a chiedere specifica inclusione nelle graduatorie locali, operando una scelta sulla scuola
o sulla sede. Per graduatorie nazionali la sede dove si svolgerà l’insegnamento è quella disponibile
al momento della nomina sull’intero territorio nazionale. Alcune graduatorie sono ad esaurimento, e
permettono l’assunzione di personale anche a molti anni di distanza; altre sono a termine, ed
impediscono l’assunzione di coloro che si trovano in posizione utile allo scadere.
Tutti i docenti assunti di ruolo ottengono il ruolo dal primo giorno di lavoro, senza alcun periodo di
prova come invece succede in altri ambienti di lavoro. Per questi docenti i trasferimenti fra le varie
sedi sono possibili, e hanno la precedenza sulle nuove assunzioni. Così con grave disagio per gli
studenti, i Conservatori italiani vedono alternarsi docenti che non conoscono, che non sanno come
suonano, che non sanno come insegnano, e che non sanno se garantiranno continuità didattica.
L’America è ancora così lontana?
4. Capodanno a colpi di share
Fenice batte Vienna. Ma a che pro?
Cominciamo il nuovo anno (a proposito, che sia un un buon anno per tutti!) citando la locuzione
latina cui prodest? (lett. "a chi giova?", reso anche come Cui bono?) che deriva dalle parole
pronunciate da Medea nell'omonima tragedia di Seneca. E la applichiamo alla "numerologica"
querelle di alcuni resoconti musicali dei concerti che hanno aperto il 2013. Eccovi i fatti e il relativo
commento che bolla i medesimi di "insostenibile leggerezza".
Se Gardiner che dirigeva a Capodanno dalla laguna veneziana l'Orchestra del Tetaro la Fenice ha
battuto Welser-Möst (un paio d'ore dopo con i Wiener Philharmoniker) 4381mila spettatori a
3072mila, fra i critici musicali si è levata una voce, quella autorevole di Quirino Principe, per dire
basta. "Occuparsi di queste cose di fronte alle vicende tragiche della cultura musicale in Italia è non
solo frivolo, ma anche colpevole", ha detto, "questa è una controversia da sfaccendati che non
percepiscono la gravità del momento storico che sta vivendo la nostra eredità culturale...". Posizione
estrema, certo, non da tutti condivisibile, anche. Rispettabile però sì. Dopo tutto Quirino Principe lo
conosciamo (che lo si legga o no mensilmente su "Classic Voice" nel Blog in fondo al giornale a
pagin 82): dietro alle sue prese di posizione forti come la musica che ama definire tale, c'è sempre
un distillato di saggezza che merita di non essere dimenticato nel "valzer" delle frenesie quotidiane.